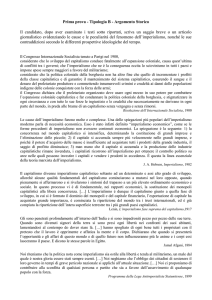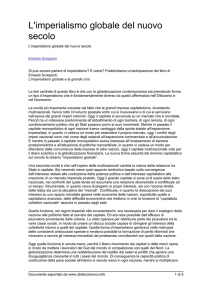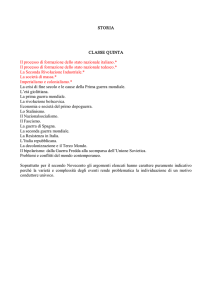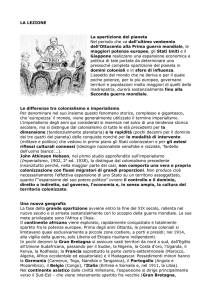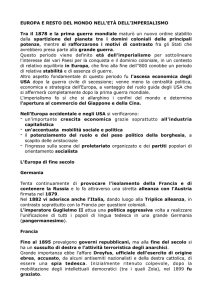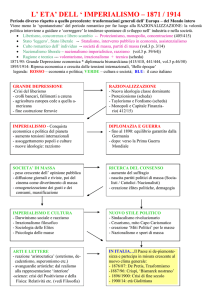gfp.84 – Politica e classe, 9, Roma 1991
IL NUOVO ORDINE IMPERIALISTICO MONDIALE
1989: anno zero del comunismo
__________________________________________________
Il concetto di lotta di classe può indurre in errore.
Essa non è una prova di forza in cui si decide la questione:
chi vince, chi perde; non è una lotta dopo la quale
tutto andrà bene per il vincitore e male per il vinto.
Chi pensa in tal modo non fa che travestire romanticamente i fatti.
Poiché, che la borghesia vinca o soccomba nella lotta,
essa è condannata a perire dalle contraddizioni interne,
che diventano mortali nel corso dello sviluppo.
Il problema è solo se perirà di mano propria o per mano del proletariato.
La permanenza o la fine di un’evoluzione millenaria
dipendono dalla risposta a questa domanda.
La storia ignora la cattiva infinità dei gladiatori eternamente in lotta.
Il vero politico ragiona a base di scadenze.
Se la liquidazione della borghesia non si compie entro un termine
quasi esattamente calcolabile dell’evoluzione economica e tecnica,
tutto è perduto.
Prima che la scintilla arrivi alla dinamite,
bisogna tagliare il filo che brucia.
[Walter Benjamin, Senso unico]
L’attualità delle determinazioni dell’imperialismo
È trascorso quasi un secolo da quando il vecchio capitalismo di maniera, basato sul lavoro del piccolo
proprietario privato indipendente e sulla libera concorrenza, ha lasciato il suo posto a un sistema mondiale di
oppressione finanziaria, esercitata da un pugno di paesi “sviluppati” sulla grande maggioranza delle nazioni.
Questo nuovo sistema di dominio economico e politico mondiale fu denotato come moderno imperialismo.
Va subito ricordato - per evitare i fraintendimenti che caratterizzano l’economia politica - che il primo studioso a definire e affrontare sistematicamente la questione fu un liberale inglese. Si sa che questi fu John A.
Hobson. Ma a molti fa comodo dimenticare codesto aspetto della faccenda, dal momento in cui la tematica
dell’imperialismo fu assunta dal marxismo come questione centrale dell’antagonismo di classe sul piano
internazionale.
Col passare del tempo, questa colpevole dimenticanza si è via via trasformata in silenzio e
demonizzazione, al punto che la stessa parola “imperialismo” non viene più usata dal pensiero dominante (e
ormai neppure più da quello dominato e falsamente critico, nella sua subalternità e nel suo pentimento
autocensorio). Corollario di ciò è l’impedimento ideologico a impiegare tali concetti e i termini
corrispondenti, che nei fatti si vuole imporre a chi provi a ripercorrere oggi la strada di quell’analisi
scientifica delle relazioni storiche ed economiche del capitalismo moderno nel mercato mondiale. Ciò non
manca di tradursi in discriminazione culturale e politica. Ma ciò non sorprende affatto, qualora lo si inquadri
correttamente nei rapporti di forza antagonistici della lotta teorica.
Al di là della convenzione nominalistica, nell’accettazione delle definizioni, anche il recente “cambiamento di nome” dell’imperialismo in nord-sud rientra nel medesimo quadro. Spaziando dal solidarismo
caritatevole all’anodino colpevolismo dei ricchi verso i poveri, dallo storicismo eternizzante e asettico della
cosiddetta economia-mondo alle ricadute tardive di un improbabile terzomondismo, fino alle allucinazioni
dell’interdipendenza globale per un mistificante governo mondiale, tutto ciò è servito solo per occultare
ancora una volta il carattere di classe del modo di produzione capitalistico su scala mondiale. La teoria
marxista dell’imperialismo parla dei rapporti di proprietà fondati sullo sfruttamento di classe, analizza le
determinazioni storiche internazionali con le categorie del valore e del plusvalore, spiega le crisi con le
contraddizioni immanenti al processo di accumulazione. Il rabbassamento alla questione del nord e del sud
del mondo cancella tutto ciò, riproponendo contrapposizioni naturali geografiche nazionali etniche religiose
&%PAGINA&
al posto delle contraddizioni intrinseche al rapporto di capitale come classe, pur di rimuovere dalle
coscienze l’antagonismo e la lotta di classe.
Al fine di ristabilire, dunque, un minimo di riferimento storico culturale, è giusto rammentare, a quanti se
ne fossero dimenticati, alcune delle determinazioni teoriche dell’imperialismo, almeno nella lezione del
liberale Hobson - a cominciare dalla sua segnalazione, anche, delle “contraddizioni dell’imperialismo” e
delle “ricorrenti crisi del capitalismo, allorché la sovraproduzione si manifesta nelle principali industrie”.
Basterà qui soffermarsi su tre ordini di problemi.
In linea generale, Hobson non nasconde che il nuovo imperialismo capitalistico, sebbene sia “un cattivo
affare per la nazione”, è “un buon affare per certe classi”; se è “irrazionale” per la prima, “esso è
sufficientemente razionale dal punto di vista di certe classi” i cui “ben organizzati interessi d’affari sono
capaci di sopraffare il debole diffuso interesse della comunità”, e di “usare le risorse nazionali per i loro
guadagni privati”. D’altronde, già sulla questione del debito internazionale, Hobson osservava che “i termini
creditore e debitore, applicati ai paesi, oscurano la principale caratteristica di questo imperialismo. Giacché,
se i debiti sono pubblici, il credito è quasi sempre privato”. Egli vedeva dietro codeste classi il grande
“capitale cosmopolita”, a cominciare dall’industria pesante (e relativi servizi - “ingegneri, speculatori,
missionari”, ecc.), direttamente e indirettamente interessato alle spese per gli armamenti. “L’imperialismo
aggressivo, che costa caro al contribuente, è fonte di grandi guadagni per l’investitore che non trova
all’interno un impiego profittevole per il suo capitale” - aggiungendo che “è inutile ciurlare con la politica se
non si riconosce chiaramente questo fatto centrale”. Insomma, il liberale Hobson sapeva benissimo che le
“radici profonde dell’imperialismo” - “la cui essenza consiste nello sviluppo dei mercati per l’investimento, e
non per il commercio”, e tanto meno in “missioni di civilizzazione” e “manifestazioni del destino” - stanno
nell’“eccesso di capitale in cerca di investimento” e nelle “ricorrenti strozzature del mercato”, e non in
accidentali “errori di direzione”.
Merita anche ricordare alcune considerazioni di Hobson sulle tendenze dell’imperialismo europeo, capace
di trasformare l’Europa in un’area dominata da “un piccolo gruppo di ricchi aristocratici, che traggono le
loro rendite e i loro dividendi dal lontano [o vicino?!, ndr] oriente, accanto a un gruppo alquanto più
numeroso di impiegati e commercianti e a un gruppo ancora maggiore di domestici, lavoratori dei trasporti e
operai delle industrie manifatturiere. Allora scomparirebbero i più importanti rami industriali, e gli alimenti e
i semilavorati affluirebbero come tributo dall’Asia e dall’Africa”. Hobson riteneva che una simile prospettiva
di “federazione europea”, allora, “non solo non spingerebbe avanti l’opera della civilizzazione mondiale, ma
presenterebbe il rischio gravissimo di un parassitismo occidentale, sotto il controllo della nuova aristocrazia
finanziaria”.
Un’altra osservazione di Hobson che oggi è doveroso citare riguarda il nuovo imperialismo giapponese.
All’inizio di questo secolo, già era chiara la percezione del fatto che la crescita della potenza imperialistica
del Giappone avrebbe inciso profondamente sul corso della storia, con proprie caratteristiche specifiche e
ben al di là delle più convenzionali considerazioni militaristiche o ideologiche. “Riflettendo su questo nuovo
capitolo della storia mondiale - scriveva Hobson - molto dipende dalla capacità giapponese di mantenere la
propria indipendenza finanziaria”. Superata una prima fase di dipendenza, “la grande potenza industriale
dell’estremo oriente può rapidamente gettarsi sul mercato mondiale come il più grande e più valido
concorrente nella grande industria meccanica, conquistando prima il mercato asiatico e del Pacifico, e poi
invadendo i mercati occidentali - spingendo così queste nazioni a un più rigido protezionismo, come
corollario di una diminuita produzione”.
I nuovi processi produttivi e le classi
Analisi teoriche compiute da un liberale all’inizio del secolo, oggi sono misconosciute (nonostante il sia
pur parziale apprezzamento per Hobson, espresso in tempi assai meno insidiosi per il capitale, da un
in\sospettabile santone come lord Keynes) e di fatto proibite. Questo è un altro segno dei tempi bui di
dominio contraddittorio dell’imperialismo, anche sulla cultura.
Così, nel 1989 il bicentenario della rivoluzione francese è stato celebrato nella maniera più adeguata. Al
di là della mera scadenza simbolica, la borghesia trionfante ha potuto salutare l’apoteosi del mercato
mondiale, unificato per la prima volta nella storia dell’umanità. L’inevitabile crisi di reversibilità delle
economie pianificate e di comando dei regimi del realsocialismo orientale, in Europa e Asia, ha coronato con
successo l’assedio della merce protrattosi per oltre mezzo secolo. Le contraddizioni interne a quei regimi
hanno fatto il resto, mentre la crisi capitalistica internazionale degli ultimi decenni ha lanciato il segnale per
l’assalto finale.
Epperò il risultato dell’unificazione del mercato mondiale del capitale è da considerare solo come l’avvio
dell’ultimo atto del dramma, se non si vuole che questo si muti in tragedia. Il 1989 è dunque in senso
proprio, oggettivamente, l’anno zero del comunismo. Non si fraintenda: tutto quanto è stato fatto da 141 anni
&%PAGINA&
in qua - da Londra a Parigi, da Pietroburgo a Shangai - nelle lotte dei proletari di tutto il mondo, è nostro
patrimonio storico e culturale irrinunciabile. Le voci profetiche urlanti nel deserto capitalistico hanno
segnato la preistoria del comunismo, annunciando il compimento delle sole condizioni oggettive possibili per
la sua futura realizzazione: quelle insite nell’unificazione del mercato mondiale, appunto. In questo senso
oggettivo è da intendere la data di nascita dell’era possibile del comunismo
Dopo quasi cinque secoli dall’inizio della storia moderna della vita del capitale, comincia dunque ora la
storia del suo compimento, del suo lungo atto finale appunto. Solo sul mercato mondiale, nella massima
fluidità mobilità e universalizzazione, il capitale si adegua al suo concetto. Ma così facendo, e saturando tutti
gli spazi disponibili, esso crea anche le condizioni del suo deperimento, del suo superamento dialettico. Che
sia questo il senso della storia è evidente a chiunque non si rinchiuda nell’apologia di un modo di produzione
e di una forma sociale ritenuta eterna - come invece da oltre un secolo predica l’economia politica
dominante. Qualunque realtà prodotta dagli uomini, come nasce, è destinata a perire: il capitale, come forma
di relazione storica sociale, è una di codeste realtà. Non si vede perché molti si ostinino a far credere che,
nell’economia, non debba essere così. Il problema è cercare di capire quale sistema - tra i tanti possibili, di
cui nessuno ha il crisma dell’ineluttabilità - possa seguire al deperimento e alla fine del capitalismo, e di
agire di conseguenza, affinché non si giunga all’esito tragico del dramma, con l’autodistruzione della società
umana. “Prima che la scintilla arrivi alla dinamite, bisogna tagliare il filo che brucia”.
La comprensione delle profonde ristrutturazioni in atto da qualche anno a questa parte - con la seconda
grande rivoluzione industriale dell’automazione del controllo - serve a codesto scopo. Capire il come perché
e quando dei vari momenti di questa fase di trasformazione epocale - in relazione alle potenzialità offerte
dallo sviluppo della scienza, delle macchine e delle altre forze produttive del lavoro sociale, alle condizioni
della reale socializzazione dei processi produttivi e vitali messi in moto dal capitale, e alla necessità del
tempestivo ristabilimento degli equilibri demografici e ambientali per un organico ricambio con la natura dovrebbe essere un compito minimo per chi vuole interessarsi di questioni economiche e sociali.
Il chiarimento delle determinazioni teoriche, che aiutino a fornire spiegazioni sempre più scientificamente
credibili, è parte essenziale di tutto ciò. I nuovi processi produttivi e lavorativi sono il risultato della proiezione delle conoscenze tecniche e scientifiche su un predefinito riassetto dei rapporti di classe e di proprietà,
dopo la vittoria di fase della borghesia tuttavia “condannata a perire dalle contraddizioni interne”. La pesante
sconfitta inferta al proletariato mondiale, dopo l’ultimo “biennio rosso” 1968-69, ha preparato il terreno per
il tentativo del capitale finanziario multinazionale di ristrutturarsi in forma adeguata all’epoca del mercato
unico mondiale.
Dianzi è stato rammentato, nelle antiche parole di Hobson, il ruolo ascendente dell’imperialismo
giapponese. L’annientamento bellico per mano americana negli anni quaranta e l’azzeramento sanguinario
dell’opposizione di classe negli anni cinquanta hanno lì creato prematuramente i presupposti oggettivi per la
ristrutturazione produttiva moderna. La flessibilità della forza-lavoro è il cardine intorno al quale ruotano i
nuovi processi produttivi: non è questa una novità, il principio è quello universale del modo di produzione
capitalistico. Gli elementi innovativi vanno ricercati, da un lato, nella specificità della determinazione storica
giunta a piegare l’antagonismo di classe in una organica subordinazione corporativa, dall’altro, nella peculiare funzionalità della parallela flessibilità raggiunta dalle macchine automatiche della seconda rivoluzione
industriale. In codesta doppia flessibilità risiede l’evoluzione rivoluzionaria dell’ohnismo rispetto al
taylorismo.
Sul piano del processo di lavoro e valorizzazione [cioè dell’uso della forza-lavoro] la multifunzionalità
del lavoratore ha reso possibile l’impiego delle macchine a controllo automatico, con la condensazione della
giornata lavorativa senza tempi morti - “un’ora di sessanta minuti di lavoro” è lo slogan nipponico - e con
ritmi spinti alla massima intensità - “mettere il fuoco al culo dei lavoratori” è l’altro amabile slogan
manageriale. Siffatte condizioni di produzione, con la combinazione del lavoro collettivo, sono in grado di
imporre anche il prolungamento della durata della giornata di lavoro. Il plusvalore relativo si combina col
plusvalore assoluto, secondo scrittura.
Sul piano del rapporto di occupazione e salario [cioè dello scambio della forza-lavoro] la medesima
flessibilità riesce a manifestarsi innanzitutto nella precarietà dell’attività lavorativa stessa, con la
riproduzione di massa delle forme latenti e stagnanti, oltre a quelle normalmente fluttuanti, dell’esercito
industriale di riserva. In tali condizioni, l’erogazione salariale rimane sempre più subordinata ai risultati
della prestazione lavorativa - individuale, collettiva e aziendale - nella forma classica, opportunamente
aggiornata e generalizzata, del cottimo sotto la specie e il falso nome di partecipazione. Nella “riforma del
salario” la parte sicura e garantita della busta paga può scendere al di sotto della metà, il resto è a rischio.
Nella ristrutturazione del processo di produzione capitalistico, tutte le principali determinazioni teoriche
marxiane continuano a inverarsi, adeguandosi mirabilmente al concetto. Il tempo di lavoro tende a coincidere
col tempo di produzione, per minimizzare la necessaria negatività del tempo di circolazione. La crescita
planetaria del dominio imperialistico fa sì che la vita della popolazione mondiale si riproduca su scala
crescente nella forma del lavoro salariato dipendente dal capitale, per quanto attiene alla sostanza, al di là
&%PAGINA&
dell’apparenza istituzionale del rapporto. Il proletariato mondiale come classe in sé è ben lontano dalla sua
estinzione, presentando al contrario caratteri sempre più diffusi e omogenei. Lo sviluppo di nuove figure
lavorative connesse alla seconda rivoluzione industriale si inserisce compiutamente nella ridefinizione del
proletariato in rapporto alle altre classi sociali.
Tra esse emergono - in conformità con l’analisi marxista più attenta - le nuove classi medie [non
proprietarie e distinte dalla vecchia piccola borghesia] funzionali al dominio del grande capitale finanziario
multinazionale, appunto per la mediazione oppressiva del proletariato. Ciononostante, entro tali classi medie
si annida il germe della contraddizione dello sviluppo della scienza, del sapere collettivo (l’intelletto
generale) espropriato. La rinnovata attualità del nesso tra lavoro produttivo e improduttivo è capace di gettare luce sulla percezione della dinamica sociale del processo produttivo e vitale, nell’era della transizione.
Il nuovo ordine imperialistico corporativo
Per collocare con consapevolezza critica codesta dinamica, qui si richiama sommariamente la breve storia
recente del capitale mondiale. Essa ebbe inizio circa un quarto di secolo fa. Alla metà degli anni sessanta si
può fare risalire la svolta più importante della storia economica e politica contemporanea - l’avvio dell’ultima crisi di un’epoca - allorché cominciarono a invertirsi le principali tendenze del capitalismo Usa. Gli
avvenimenti successivi - nel mondo intero, fino al rammentato crollo del realsocialismo e ai minacciosi vènti
di guerra - hanno tutti le loro lontane radici, la cause causanti, in quegli anni: le motivazioni successive sono
solo cause emergenti, occasionali se non pretestuose. La saturazione del mercato mondiale a cagione della
sovraproduzione incombente, l’interruzione del ciclo di metamorfosi e di accumulazione del capitale
internazionale, la disoccupazione di massa, l’inflazione generalizzata, la pletora di capitale monetario con
la crisi del credito internazionale e i palliativi monetaristici, la caduta del tasso di profitto col conseguente
inasprimento della concorrenza sul mercato mondiale fino a esiti protezionistici - sono tutte conseguenze
di quella svolta.
Quali siano stati gli accadimenti internazionali nel biennio 68-69 ognuno sa. Nel 70-71 il dollaro venne
dichiarato inconvertibile e poi svalutato, aprendo la strada inizialmente incerta e controversa all’affermazione dello yen e del marco. In codesta situazione, la crisi del capitalismo mondiale, ancora guidato dagli
Usa, impose nel 72-73 l’aumento indiscriminato dei prezzi di tutte le materie fondamentali. Si cominciò dalle
materie prime e dai prodotti agricoli. Contrariamente a quanto troppo spesso si ripete, la crisi delle fonti di
energia e il cosiddetto shock petrolifero fu solo l’ultimo passo compiuto in quella gestione della crisi che
avrebbe dato il via al processo di inflazione.
Le condizioni per una nuova spartizione del mercato mondiale erano appena poste. Le manovre sono
ancora in corso; le armi usate sono di ogni genere; l’esito è tuttora incerto. Fu a partire dagli anni 74-75 che
il capitale multinazionale, per bocca del segretario di stato Usa, Henry Kissinger, cominciò a discutere di
nuovo ordine economico internazionale. La controffensiva dei paesi imperialisti [quelli che con un tortuoso
giro di parole sono detti economie industrializzate a capitalismo maturo] era solo alle prime mosse, cariche
di contraddizioni interne tra i protagonisti. Liquidato l’antagonismo che le classi lavoratrici e popolari
avevano manifestato nei precedenti anni caldi - attraverso la coppia di disoccupazione e inflazione,
nell’unico brodo di coltura sempre adeguato, quello recessivo [talché la cosiddetta stagflazione lungi
dall’essere una stranezza va considerata la norma in siffatte circostanze] - l’agone mondiale era pronto per
accogliere la ridefinizione della proprietà e dell’assetto finanziario e la ristrutturazione industriale del capitale multinazionale. Contraddittoriamente, la tendenza all’unificazione del mercato mondiale e alla
transnazionalità del capitale, però, doveva e deve fare ancora i conti con i superstiti tortuosi percorsi di
interessi e privilegi, più o meno lobbistici, vincolati alle entità nazionali, rappresentate ancora dalle antiche
strutture statuali riadeguate nel neocorporativismo.
In codesto quadro si determinò e si sviluppo la crisi del credito internazionale, rovesciatasi in tragedia
economica e sociale per i paesi debitori, e l’avventura dell’economia di carta con la speculazione borsistica e
monetaria, espressasi attraverso la precaria prevalenza teorica e pratica del neo-monetarismo. Negli anni 80
la sovrabbondanza di credito monetario favorì la sublimazione del capitale col predominio delle banche sull’industria, del denaro sulla merce, della speculazione sulla produzione. Il debito - privato e pubblico - è la
denominazione speculare del credito. La spirale credito-debito pubblico portò all’aumento abnorme degli
interessi passivi, sotto l’egida del neo-liberismo monetarista trionfante: una vittoria di Pirro, per il colpo di
coda di un dollaro agonizzante, che è servita però a spostare verso la sfera privata la precedente attenzione
sociale della spesa, per molti anni a venire. La cosiddetta terziarizzazione delle economie capitalistiche
mature - con il connesso falso mito del post-industriale, generato da una effettiva parziale
deindustrializzazione dell’economia Usa - nacque essa stessa su tale terreno. Anche se si tende sovente a
dimenticarlo, l’intero svolgimento di questi fatti fu messo im moto quindici anni prima.
&%PAGINA&
Tutto ciò non fu che il preludio del drastico processo di razionalizzazione economica, sociale e
istituzionale, che ognuno ha potuto sperimentare. Codesta razionalizzazione ha il suo fulcro nella ricordata
ristrutturazione del processo di produzione industriale, sul piano internazionale. Soltanto negli ultimi anni la
rivoluzione tecnologica ha potuto cominciare a restituire alcuni suoi frutti al capitale mondiale. Ciò è ovvio,
in quanto essa può sviluppare la sua capacità di valorizzazione solo dopo che il capitale abbia riassestato il
processo di lavoro e la divisione internazionale di codesto lavoro. Ma proprio in tale riassetto, non tutti i
comparti settoriali e nazionali del capitale mondiale hanno potuto o possono cogliere i medesimi risultati.
Nonostante l’apoteosi del mercato mondiale, celebrata alla fine degli anni 80 con la provvisoria ma
necessaria cancellazione dalla faccia della terra di aree economiche finora sottratte al dominio pieno e
incondizionato del capitale, la nuova spartizione economica del mondo è ancora tutt’altro che definita. La
conflittualità interimperialistica tra le tre aree dominanti - americana-Usa, asiatica-Giappone, europeaGermania - è tuttora viva e, si direbbe, latente in quanto non giunta a completa, incerta e rischiosa, maturazione. Ancora dopo venticinque anni la crisi è irrisolta.
Spesso l’insufficiente comprensione o il fraintendimento degli accadimenti quotidiani dipende dall’acquiescenza alla banalità del senso comune e alla acriticità dell’accettazione di spiegazioni superficiali e
fenomeniche, che per la maggior parte non costituiscono spiegazioni ma giustificazioni dell’esistente. Un
cambiamento di prospettiva teorica può far scoprire realtà misconosciute.
Così, l’ultima guerra - non quella, ma questa che c’è - può aver risvegliato alcuni, magari per paura, dal
torpore in cui sono sprofondate le masse sottomesse all’ideologia quotidiana del capitale. Questo sarebbe l’unico lato buono della guerra, purché tale risveglio durasse. Ma già sembra di riavvertire cupi sintomi del
grande sonno. Per restare all’erta occorre guardare con coscienza critica scientifica a tutte le cause di crisi del
capitalismo contemporaneo e a tutte le occasioni di sue contraddizioni possibili. Anche l’ordinaria follia
della guerra era annunciata a chiare lettere con grande anticipo. Bastava solo vederla, nell’anteguerra
imperialistico: e le masse non l’hanno vista. Questa sgradevole sensazione di déjà vu è, di nuovo, ben evocata da un brano scritto da Hobson per la decadenza dell’imperialismo britannico, nel 1903: o per gli Usa del
1991?
“Gli effetti politici, reali e necessari, del nuovo imperialismo, così come si mostrano nel caso della più
grande potenza imperialista, possono essere riassunti in questo modo. Esso è una minaccia costante alla pace,
fornisce continue tentazioni di ulteriori aggressioni su terre occupate da “razze inferiori” e fomenta la
discordia tra la nostra nazione e le altre nazioni con ambizioni imperialistiche rivali; all’acuto pericolo di
guerra aggiunge il pericolo cronico e la degradazione del militarismo, che non guasta solo le concrete risorse
fisiche e morali delle nazioni , ma blocca il corso stesso della civiltà. Consuma in modo illimitato e
incalcolabile le risorse finanziarie di una nazione con i preparativi militari, bloccando la spesa delle entrate
correnti dello stato per progetti pubblici produttivi e gravando la posterità con pesanti carichi di debito.
È, invero, una nemesi dell’imperialismo che le arti e i mestieri della tirannia, acquisite e esercitate nel
nostro impero illiberale, siano rivolte contro le nostre libertà in patria. Coloro che sono stati còlti di sorpresa
dalla totale noncuranza o dall’aperto disprezzo mostrato dall’aristocrazia e dalla plutocrazia di questo paese
per l’infrazione delle libertà del cittadino e per l’abrogazione dei diritti e delle usanze costituzionali non
hanno considerato a sufficienza il costante riflusso del veleno dell’autocrazia irresponsabile dal nostro
impero illiberale, intollerante e aggressivo.
L’imperialismo sta solo cominciando a mettere in pratica tutte le sue risorse e a fare del governo delle
nazioni un’arte raffinata: la larga concessione del diritto di voto, controllato da un popolo la cui istruzione ha
raggiunto lo stadio della capacità di leggere carta stampata [che avrebbe detto Hobson se avesse conosciuto
la potenza della tv! – ndr] senza esercitare alcuna critica, favorisce immensamente i disegni degli astuti
politici affaristi che, controllando la stampa, la scuola, e se necessario la chiesa, impongono l’imperialismo
alle masse nella forma attraente di un patriottismo sensazionale”.
* Questo testo è stato presentato come relazione scritta al convegno Cipec sul tema:
Il comunismo dei movimenti e la rifondazione del comunismo, tenuto il 27 maggio 1991, presso il
Dipartimento di Sociologia dell’Università di Roma “La Sapienza”, via Salaria 113.
L’intervento orale è stato esposto in forma molto ridotta rispetto alla relazione scritta.
&%PAGINA&