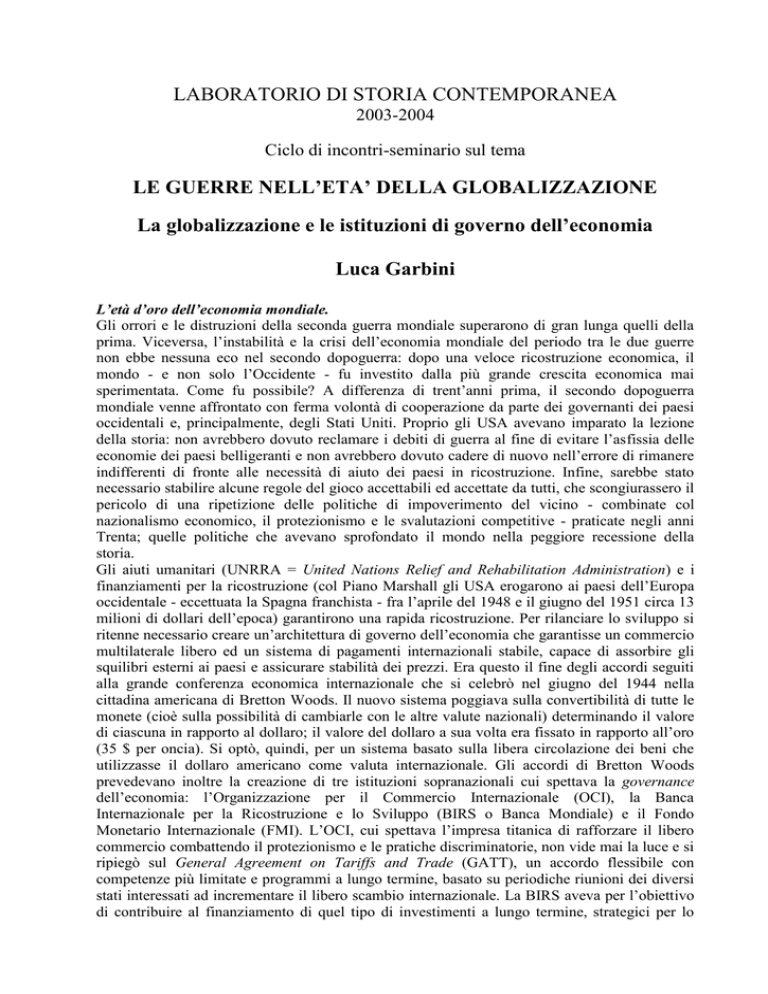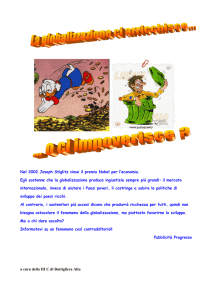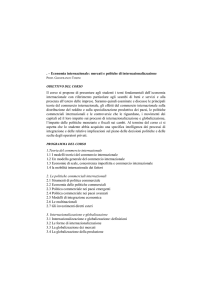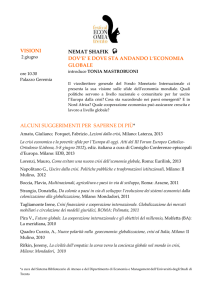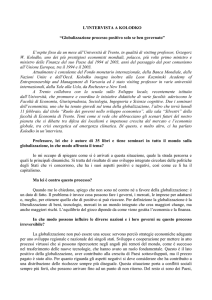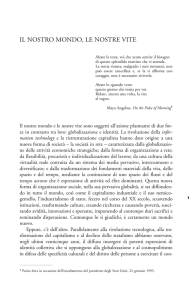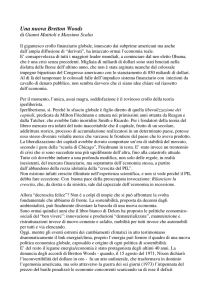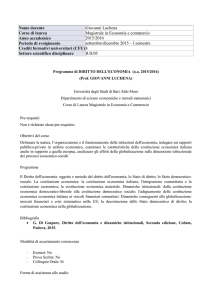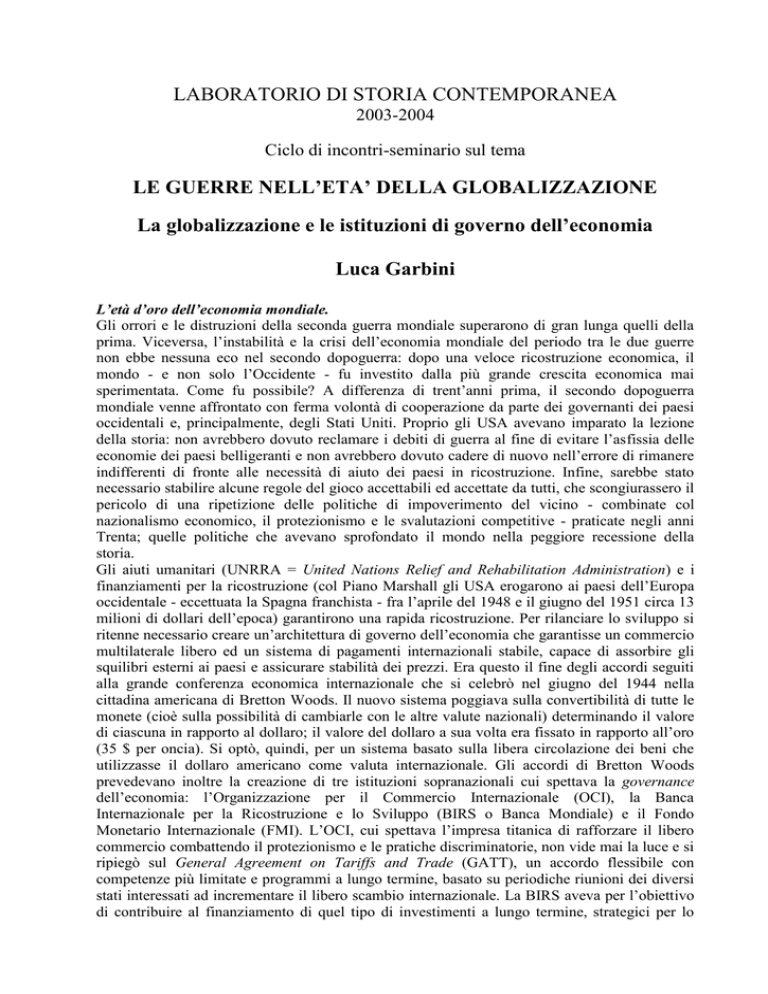
LABORATORIO DI STORIA CONTEMPORANEA
2003-2004
Ciclo di incontri-seminario sul tema
LE GUERRE NELL’ETA’ DELLA GLOBALIZZAZIONE
La globalizzazione e le istituzioni di governo dell’economia
Luca Garbini
L’età d’oro dell’economia mondiale.
Gli orrori e le distruzioni della seconda guerra mondiale superarono di gran lunga quelli della
prima. Viceversa, l’instabilità e la crisi dell’economia mondiale del periodo tra le due guerre
non ebbe nessuna eco nel secondo dopoguerra: dopo una veloce ricostruzione economica, il
mondo - e non solo l’Occidente - fu investito dalla più grande crescita economica mai
sperimentata. Come fu possibile? A differenza di trent’anni prima, il secondo dopoguerra
mondiale venne affrontato con ferma volontà di cooperazione da parte dei governanti dei paesi
occidentali e, principalmente, degli Stati Uniti. Proprio gli USA avevano imparato la lezione
della storia: non avrebbero dovuto reclamare i debiti di guerra al fine di evitare l’asfissia delle
economie dei paesi belligeranti e non avrebbero dovuto cadere di nuovo nell’errore di rimanere
indifferenti di fronte alle necessità di aiuto dei paesi in ricostruzione. Infine, sarebbe stato
necessario stabilire alcune regole del gioco accettabili ed accettate da tutti, che scongiurassero il
pericolo di una ripetizione delle politiche di impoverimento del vicino - combinate col
nazionalismo economico, il protezionismo e le svalutazioni competitive - praticate negli anni
Trenta; quelle politiche che avevano sprofondato il mondo nella peggiore recessione della
storia.
Gli aiuti umanitari (UNRRA = United Nations Relief and Rehabilitation Administration) e i
finanziamenti per la ricostruzione (col Piano Marshall gli USA erogarono ai paesi dell’Europa
occidentale - eccettuata la Spagna franchista - fra l’aprile del 1948 e il giugno del 1951 circa 13
milioni di dollari dell’epoca) garantirono una rapida ricostruzione. Per rilanciare lo sviluppo si
ritenne necessario creare un’architettura di governo dell’economia che garantisse un commercio
multilaterale libero ed un sistema di pagamenti internazionali stabile, capace di assorbire gli
squilibri esterni ai paesi e assicurare stabilità dei prezzi. Era questo il fine degli accordi seguiti
alla grande conferenza economica internazionale che si celebrò nel giugno del 1944 nella
cittadina americana di Bretton Woods. Il nuovo sistema poggiava sulla convertibilità di tutte le
monete (cioè sulla possibilità di cambiarle con le altre valute nazionali) determinando il valore
di ciascuna in rapporto al dollaro; il valore del dollaro a sua volta era fissato in rapporto all’oro
(35 $ per oncia). Si optò, quindi, per un sistema basato sulla libera circolazione dei beni che
utilizzasse il dollaro americano come valuta internazionale. Gli accordi di Bretton Woods
prevedevano inoltre la creazione di tre istituzioni sopranazionali cui spettava la governance
dell’economia: l’Organizzazione per il Commercio Internazionale (OCI), la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS o Banca Mondiale) e il Fondo
Monetario Internazionale (FMI). L’OCI, cui spettava l’impresa titanica di rafforzare il libero
commercio combattendo il protezionismo e le pratiche discriminatorie, non vide mai la luce e si
ripiegò sul General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), un accordo flessibile con
competenze più limitate e programmi a lungo termine, basato su periodiche riunioni dei diversi
stati interessati ad incrementare il libero scambio internazionale. La BIRS aveva per l’obiettivo
di contribuire al finanziamento di quel tipo di investimenti a lungo termine, strategici per lo
sviluppo economico, che non sono di solito presi in considerazione dal capitale privato; a ciò si
aggiungeva la finalità di cooperare alla ricostruzione economica delle nazioni devastate dalla
guerra e sostenere lo sviluppo dei paesi membri. L’elemento fondamentale dell’impalcatura di
Bretton Woods era il FMI che si occupò della difesa del sistema dei tassi di cambio fra le
monete. Perciò, il FMI poteva prestare, in forma condizionata, assistenza finanziaria ai paesi che
soffrissero deficit nei loro conti con l’estero, per evitare così il facile ricorso all’alterazione del
tasso di cambio per guadagnare immediata competitività all’estero e migliorare, attraverso
l’aumento delle esportazioni, le bilance commerciali e di conto corrente. L’architettura
istituzionale di Bretton Woods non funzionò secondo le previsioni (a causa si una serie di
complessi motivi che in questa sede non possiamo analizzare); tuttavia, senza il FMI e le altre
istituzioni il mondo avrebbe conosciuto una crescita economica minore durante la seconda metà
del XX secolo. Le relazioni economiche internazionali sarebbero state più incerte ed instabili,
colpendo negativamente i movimenti internazionali di beni, servizi e fattori produttivi.
D’altra parte, nel nuovo sistema delle relazioni internazionali, era assolutamente utopico
pensare che gli USA rinunciassero ad esercitare la loro leadership e resistessero alla tentazione
di piegare le istituzioni di governo dell’economia ai loro interessi particolari. Il FMI era (ed è)
una sorta di istituto finanziario mondiale dotato di capitale proprio, costituito da oro, dollari e
valute depositate da ogni paese aderente secondo quote differenziate, in rapporto alle quali i vari
paesi detengono i diritti di voto. Poiché gli USA versarono una quota superiore a quella di Gran
Bretagna e Unione Sovietica insieme (l’URSS poi si ritirò ben presto dal FMI) essi si
garantirono da subito il controllo operativo del Fondo. I prestiti che il FMI concedeva (e
concede), come si diceva sopra, sono condizionati, legati cioè all’obbligo di osservanza delle
direttive che esso impone in materia di politica economica e finanziaria, per cui gli USA ebbero
(ed hanno) in mano un potente strumento di pressione e di controllo sui paesi economicamente
più deboli.
Nel primo ventennio del dopoguerra, gli USA esercitarono la loro dominance esportando non
solo capitali, ma un intero modello di sviluppo, basato sui consumi di massa e sulla crescita del
reddito disponibile per ogni classe sociale (che quei consumi doveva alimentare). Stabilità
monetaria e occupazione furono gli obiettivi primari di ogni paese industriale. Tutti costruirono
o rafforzarono il cosiddetto Stato sociale (Welfare State = Stato del benessere): sistemi
previdenziali, sanità e istruzione pubbliche e sostanzialmente gratuite, sostegno
dell’occupazione e sussidi di disoccupazione, politiche sociali di assistenza (in ciò, accanto alla
crescita delle risorse, ebbero un ruolo determinante anche le lotte operaie e lo sfida al modello
sovietico). Fu questa sorta di “salario in natura e servizi”, più che l’aumento dei salari reali, a
rendere disponibile alla massa dei lavoratori un non trascurabile reddito residuo da spendere per
consumi un tempo impensabili per la classe operaia (automobili, elettrodomestici…), che dilatò
ulteriormente la domanda di articoli industriali. Nello stesso tempo però la “spesa sociale”
caricò i bilanci statali di oneri che a lungo andare si riveleranno insostenibili.
Fino al 1973 si registrarono tassi di crescita senza precedenti: fu la cosiddetta “età d’oro” del
capitalismo. Anche i paesi del blocco sovietico crebbero in misura paragonabile a quelli ad
economia di mercato, ma lo sviluppo assunse caratteri qualitativamente assai diversi (ad
esempio, non riguardò se non in minima parte i beni di consumo di massa, né, soprattutto, i
servizi) e lo statalismo comunista non riuscì a dotare le proprie economie di un efficiente grado
di organizzazione. Anche i cosiddetti paesi in via di sviluppo (PVS) e alcune regioni
tradizionalmente povere, ma ricche di materie prime, compirono buoni progressi.
Crisi e ripresa. Dagli anni Settanta all’età della globalizzazione
Il sistema di Bretton Woods andò in frantumi il 15 agosto 1971, quando il presidente Nixon
decise la sospensione della convertibilità del dollaro. Di fronte all’opprimente deficit pubblico,
conseguenza della guerra del Vietnam, gli USA avevano bisogno di libertà di svalutare come
risposta alle crescenti difficoltà di bilancio e commerciali. In un panorama economico
internazionale dominato dal riapparire dell’incertezza, si abbatté lo shock petrolifero del 1973: il
prezzo del greggio quadruplicò per decisione dell’OPEC (l’organizzazione dei paesi produttori),
ufficialmente come ritorsione verso l’atteggiamento pro-israeliano dei paesi occidentali nella
guerra dello Yom Kippur. Si aprì una crisi economica terribile per i paesi industriali importatori
(solo gli USA grazie alle lo scorte riuscirono a superare abbastanza bene la crisi operando un
grosso sforzo di risparmio energetico), disastrosa per quelli importatori del Terzo Mondo, per i
quali la decisione dell’OPEC fu un brusco colpo contro il progresso dei livelli di vita. In Europa
apparve lo spettro della “stagflazione”: l’insieme combinato di stagnazione produttiva (quindi
disoccupazione, contrazione dei redditi, ecc.) e inflazione, mai registrato in nessuna delle crisi
strutturali precedenti. La stagflazione fu il principale rompicapo di politici ed economisti,
poiché non era prevista nei modelli di politica economica tradizionali; le ricette “keynesiane”,
che facevano leva sulla spesa pubblica a sostegno dell’occupazione, erano con tutta evidenza
improponibili. Le risposte alla crisi furono, pertanto, assai diverse, ma centrate quasi tutte sulla
flessibilità dei cambi che rendeva possibile le svalutazioni competitive (la lira, ad esempio, fu
svalutata sul marco per favorire le esportazioni orientate nell’area CEE, e rivalutata sul dollaro
per rendere meno care le importazioni). Comunque, le risposte alla crisi furono inefficaci:
inflazione e disoccupazione continuarono ad aumentare, in più aumentava l’incertezza degli
scambi internazionali. Quando il prezzo del greggio sembrava stabilizzato arrivò, nel 1979, il
secondo shock (il prezzo del greggio fu moltiplicato per 2,5) il che provocò un ulteriore
impoverimento dei paesi importatori e una nuova dura recessione fra il 1981 e il 1983. Questa
volta al panico che ne seguì (ci fu pure nel 1980 l’inizio della guerra fra Iran e Iraq) le reazioni
furono più uniformi. I governi si convinsero che occorreva lottare insieme contro l’inflazione e
mettere in atto strategie comuni di cooperazione: si ripropose la necessita di costruire un nuovo
ordine economico internazionale, seppure diverso da quello precedente. Inoltre, lo stato di
necessità aveva favorito una nuova politica di intensa ricerca tecnologica e nel campo delle
strutture organizzative dei processi produttivi volta al risparmio di energia e alla riduzione dei
costi di produzione.
Per quanto riguarda le politiche economiche mutò radicalmente l’atteggiamento dei principali
paesi industriali. Dato il fallimento delle risposte classiche alla crisi, mutò profondamente
l’atteggiamento di governi ed economisti. Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna si misero in
pratica le ricette proposte dall’ultraliberista “scuola di Chicago”: Ronald Reagan e Margaret
Thatcher puntarono allo smantellamento del Welfare e alla drastica riduzione del ruolo dello
Stato. La filosofia di fondo di queste politiche era che le aziende dovevano essere libere di agire
al fine di ridurre al minimo i costi ed aumentare il più possibile i profitti e la remunerazione
degli investimenti. Sei sono i punti fondamentali del progetto:
investimenti senza alcun vincolo
deregulation (liberalizzazione normativa: no ai vincoli burocratici, legislativi, sindacali, etc.)
conti pubblici in pareggio (drastica riduzione delle spese dello stato per consentire un’ampia
riduzione delle imposte)
bassa inflazione
privatizzazione delle imprese pubbliche
libertà di commercio
Quest’ultimo punto, in particolare, implicava la libertà delle imprese di dislocare le loro
operazioni in qualsiasi parte del mondo sulla base dell’unico criterio della convenienza in
termini di costi delle operazioni stesse. In questa ottica, il libero scambio globale si accompagna
alla libertà di investimento e alla deregulation dei mercati finanziari: in pratica libera
circolazione a livello planetario delle merci e dei capitali. Il fatto veramente nuovo è che
banche, compagnie di assicurazione e società di investimenti (la cui attività era stata sino ad
allora generalmente limitata ai confini nazionali) iniziano a spostare capitali e ad investire nelle
borse di tutto il mondo.
Su queste si riaprì negli anni Ottanta una nuova fase di intensa crescita, trainata dalla
“locomotiva” degli USA ben assecondata dai paesi dell’area del Pacifico. Ottima anche la
performance dell’Europa, lanciata verso l’unificazione monetaria. Lo sviluppo è avvenuto quasi
ovunque nel segno del neoliberismo ed è parso a molti che, in questa fase storica, il mercato
lasciato alle sue leggi fosse capace di garantire lo sviluppo molto meglio dell’intervento
pubblico di stampo keynesiano. Quattro i fattori della ripresa dopo gli anni terribili delle crisi
petrolifere:
la caduta dei prezzi delle materie prime
la rivoluzione informatica e telematica
le politiche neoliberiste
la globalizzazione
La nuova fase di espansione presenta però alcuni problemi. Nei paesi avanzati, infatti, alla
crescita della produzione non segue una parallela crescita dell’occupazione: le nuove tecnologie
garantiscono elevati standard di efficienza produttiva con pochissimi addetti. La crescita
dell’interdipendenza tra i diversi paesi ha coinciso con processi di più forte differenziazione
nell’economia internazionale che hanno accentuato il divario fra paesi sviluppati e quelli ancora
sottosviluppati. Le aree escluse dall’influenza dei processi di globalizzazione produttiva sono
piombate in una spirale di povertà particolarmente acuta.
Proprio la globalizzazione può essere una grande opportunità di crescita mondiale. Per adesso
sembra solo un’opportunità per i ricchi di diventare ancora più ricchi.
Questo dipende dal fenomeno globalizzazione in sé o dal suo coincidere di fatto con
l’americanizzazione del globo?
La globalizzazione dei mercati
È quella che si definisce anche “globalizzazione mercantile” → libera circolazione delle merci
(intese come l’insieme dei beni e dei servizi) in aree sempre più ampie e più omogenee.
La basi vengono poste nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale
con l’applicazione degli accordi di Bretton Woods e con l’accordo generale sui dazi doganali e
il commercio (GATT = General agreement on tariffs and trade) siglato a Ginevra il 30 ottobre
1947 dai rappresentanti di 23 paesi. Obiettivo del GATT era favorire l’espansione del
commercio internazionale attraverso la progressiva riduzione delle barriere doganali e la
creazione di una zona sempre più vasta di libero scambio. Con la stipula del trattato venne
negoziata una riduzione delle tariffe in sette tappe successive; l’ultima tappa, l’Uruguay round,
ha avuto inizio nel 1986 e si è conclusa nel marzo del 1994 con un grande accordo generale
sulla completa liberalizzazione degli scambi non solo nel settore manifatturiero, ma anche in
quello agricolo e, in prospettiva, in quello finanziario. Ad esso ha fatto seguito l’istituzione
dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO = World Trade Organization) che
persegue gli stessi obiettivi, ma con poteri di condizionamento sui singoli stati molto maggiori
di quelli del GATT. Gli stati membri del WTO sono 146; 30 quelli che aspettano di entrare
ufficialmente nell’organizzazione, altrettanti quelli ammessi ai lavori come “osservatori”.
Tappa fondamentale di questo processo è stata il crollo dei regimi comunisti e l’apertura della
Cina all’economia di mercato.
Il progressivo abbattimento dei dazi doganali non ha favorito solo la libera circolazione delle
merci, ma ha anche indotto un processo di omologazione dei consumi, del gusto, degli stili di
vita. Veicoli di tale processo sono stati (e sono) il cinema hollywoodiano, la pubblicità e,
soprattutto, i grandi network televisivi. Una serie di beni di consumo sono ormai da ritenersi
prodotti mondiali e chi li produce compete in un mercato globale. Di qui, la crescita della
componente internazionalizzata delle economie dei singoli paesi che si caratterizzano sempre di
più come economie export oriented.
La globalizzazione della produzione
Questo è l’aspetto su cui c’è maggiore confusione nell’opinione pubblica, confusione alimentata
dai mass media e da una pubblicistica ben poco attenta ai dettami della storia e della scienza
economica. Si tende infatti ad identificare le imprese che operano un decentramento produttivo
in luoghi del pianeta anche assai distanti tra loro con le imprese note come multinazionali: ne
consegue l’errata identificazione tra tali imprese e il fenomeno della globalizzazione. Il risultato
è che si perde di vista sia la natura delle multinazionali, sia quella della globalizzazione.
In effetti, l’esigenza di alcune grandi imprese (inizialmente britanniche) di darsi una struttura
multinazionale nasce già prima della prima guerra mondiale e si sviluppa in una cornice
istituzionale e di mercato opposta a quella che caratterizza l’attuale fase dell’economia
mondiale. La scelta della struttura multinazionale fu dettata alle imprese dalla presenza di forti
restrizioni al commercio dovute principalmente agli elevati costi di trasporto, ai dazi doganali e
ad ostacoli di vario genere (normativo oltre che fiscale) che le economie nazionali frapponevano
alle importazioni. Ad esempio, le aziende automobilistiche americane negli anni Venti del
Novecento scelsero di produrre auto nei vari paesi europei dati gli alti costi di trasporto (nave +
treno) per unità di prodotto, i diritti di transito e le tariffe protezionistiche che innalzavano
artificiosamente i prezzi sui mercati di esito. Piuttosto che potenziare gli stabilimenti negli Stati
Uniti diventava così più conveniente aprire in altri paesi nuove unità produttive: l’impresa
diventata multinazionale cessava di essere impresa esportatrice, ma una delle imprese del paese
ospitante per cui i suoi prodotti non erano più soggetti a dazi doganali e diritti d’ingresso.
D’altra parte, il paese ospitante poteva compensare la diminuzione del gettito derivante dai dazi
d’importazione con nuove entrate fiscali derivanti dalla tassazione dei profitti realizzati dalla
filiale dell’impresa multinazionale. Inoltre, l’ingresso della multinazionale aumentava la
concorrenzialità del mercato a vantaggio dei consumatori, sviluppava occupazione e produceva
“esternalità” positive in termini di afflusso di nuove tecnologie, nuovi criteri di organizzativi,
informazioni e addestramento della forza lavoro. Pur trattandosi di un fenomeno portatrice di
crescita e di sviluppo economico (e quindi di aumento della disponibilità di reddito) non si può
tacere il fatto che la continua espansione delle multinazionali ha avuto (in particolare fra gli anni
Cinquanta e Settanta del secolo scorso) anche una ragione politica, giacché esse hanno
rappresentato il mezzo attraverso il quale i paesi avanzati (e in particolare gli USA) hanno
stabilito rapporti di dominanza con quelli più arretrati o in via di sviluppo.
La globalizzazione produttiva (in senso proprio) trae origine da due fattori diversi, l’uno di
natura tecnica ed economica, l’altro più squisitamente politico. I progressi nella tecnica dei
trasporti e delle comunicazioni sono stati imponenti. Si calcola che il costo di un miglio aereo si
sia ridotto a un settimo di quello che era sessant’anni or sono, il costo di tre minuti di
conversazione telefonica da 240 a 3 dollari. Satelliti per le telecomunicazioni, computer e reti
telematiche consentono la circolazione delle informazioni in “tempo reale” e creano un rapporto
di simultaneità tra eventi prodottisi in luoghi diversi del pianeta. Oggi la grande industria può
frammentare il ciclo produttivo in una molteplicità di fasi distinte, collocare ciascuna in un
ambito geografico diverso a seconda della convenienza, procedere al montaggio in un luogo
ancora distinto, concentrando le attività direttive (elaborazione tecnologica, progettazione, etc.)
nel paese dove l’impresa ha la sua sede centrale. Questa concentrazione manageriale e
finanziaria accoppiata alla più grande frammentazione produttiva permette di ottenere due
vantaggi: tutte le possibili economie di costo consentite nelle cinque parti del mondo vengono
pienamente sfruttate e al tempo stesso le tecnologie elaborate dalla grande impresa vengono
imposte a tutti i mercati. Alla fine degli anni Novanta, Kenichi Ohmae, “consulente globale”,
consigliava alle grandi corporations di aprire la sede legale a Singapore (non c’è impaccio
burocratico di alcun genere per chi voglia avviare un’impresa), svolgere la progettazione del
prodotto in India (ci sono tecnici di altissimo livello che costano 7-8 volte di meno di quelli
europei o americani), localizzare i servizi finanziari a Hong Kong (è un discreto paradiso
fiscale), appaltare la produzione a fabbriche cinesi (il lavoro in Cina ha un costo orario 80 volte
inferiore a quello europeo) e vendere infine i prodotti in Europa o negli Stati Uniti.
Questa strategia così complessa è possibile a patto di poter contare non solo su un sistema di
trasporti e di comunicazioni di alta efficienza, ma anche sulla piena libertà nei movimenti di
merci e di capitali finanziari. Qui entra in gioco il secondo fattore della globalizzazione, quello
politico: è evidente che la piena liberalizzazione commerciale e finanziaria necessita della
collaborazione delle autorità di governo cui spetta di prendere misure consone a queste
esigenze. Così come hanno bisogno di utilizzare la forza-lavoro là dove essa costa meno, le
imprese transnazionali devono poter operare sui mercati finanziari più convenienti senza che gli
Stati dove operano (nessuno escluso) drenino i capitali disponibili (attraverso il prelievo fiscale
o il pagamento di diritti di vario genere) per coprire eventuali disavanzi nei conti pubblici.
Qui entrano in gioco le istituzioni internazionali, come il FMI, il cui ruolo sarà analizzato più
avanti.
La globalizzazione finanziaria
È forse l’aspetto più affascinante e al contempo più inquietante della globalizzazione: la libera
circolazione di masse sempre più ingenti di denaro nei mercati finanziari dell’intero pianeta.
Azioni, bond, titoli di stato, in breve l’insieme dei titoli negoziabili in borsa passa di mano in
mano nel giro di pochi secondi da un capo all’altro del mondo; gli scambi sono dettati spesso da
fini puramente speculativi: realizzare, cioè, profitti immediati in un mercato globale che si
muove a velocità sempre maggiore grazie alle tecnologie telematiche. Una piccola variazione
percentuale della quotazione di un titolo può produrre grandi guadagni ai grandi investitori in un
“gioco” in cui si possono vincere o perdere milioni di euro in pochi minuti. Non sfugge il grosso
pericolo per le economie più deboli di simili manovre speculative; così come gli investitori
stranieri possono far affluire rapidamente grandi capitali nelle borse locali, altrettanto
rapidamente possono ritirarli con conseguenze dirompenti sull’economia reale.
Ancor più spettacolari sono i movimenti sulle valute, che generano scambi per un valore che si
stima assai prossimo ai duemila miliardi di euro al giorno. Non essendoci più un sistema di
cambi fissi dopo il crollo del regime di Bretton Woods, il valore di ogni moneta rispetto alle
altre è fissato solamente dal mercato, sulla base della legge della domanda e dell’offerta. Ciò
può generare grandi ricchezze, ma può sottoporre l’economia internazionale a fortissime
tensioni.
È il caso della crisi delle borse asiatiche del 1997, dovuto al grande rialzo del dollaro. Per i paesi
del sud-est asiatico, cha avevano ancorato le loro valute al dollaro americano, ciò ha comportato
una rivalutazione inattesa (del 40% e oltre) e non voluta delle proprie rispetto allo yen e alle
valute europee, con effetti disastrosi sulla competitività delle loro esportazioni. Il FMI,
prontamente intervenuto, ha consigliato una politica di liberalizzazione immediata dei mercati
valutari e di piena libertà nei movimenti di capitali. Ciò ha provocato una fuga di capitali verso
mercati più remunerativi che ha prodotto drastiche svalutazioni delle monete nazionali. Quando,
però, uno dopo l’altro quei paesi hanno sganciato la loro valuta dal dollaro ed effettuato
drastiche svalutazione, imprese e banche che si erano indebitate in dollari o in yen hanno visto
improvvisamente raddoppiare il peso del debito. Hanno avuto così inizio crolli di borsa e
fallimenti a catena, che hanno aperto la strada ad acquisizioni di imprese locali da parte di
capitali stranieri, incoraggiate dal FMI col fine “ufficiale” di favorire la rapida ripresa di quelle
economie. L’intervento del FMI, con i suoi consigli e le sue imposizioni, ha limitato
l’autonomia di quei paesi nelle scelte di politica economica, con l’effetto che dei potenziali e
pericolosissimi concorrenti dell’industria statunitense, sembrano avviati a diventare fertili
mercati aperti alle importazioni di prodotti e capitali americani. Sarà un caso?
Bisogna cercare di capire come e quando il FMI ha mutato i suoi compiti originali, quelli
assegnategli a Bretton Woods, per diventare lo stabilizzatore dell’economia mondiale sulla base
degli interessi del capitale made in USA.
La crisi del debito e il nuovo ruolo delle vecchie istituzioni di Bretton Woods
Il secondo shock petrolifero (1979) combinato con i cambiamenti della quotazione del dollaro
sul libero mercato delle valute ha lasciato gravissime conseguenze. In pratica, qualcuno ha
pagato moltissimo la crisi prima, la ripresa poi. I paesi produttori di petrolio negli anni Settanta
hanno accumulato enormi fortune. Questi “petrodollari” (i dollari ricavati dalla vendita del
petrolio) sono stati in gran parte reinvestiti nelle borse europee da parte di molti paesi arabi.
Altri paesi produttori (quelli più popolosi come l’Iran, l’Iraq, l’Indonesia, il Venezuela, il
Messico) hanno tentato di sviluppare una forte industria nazionale con programmi di
investimento giganteschi. Contando sulle prospettive di sviluppo legate all’esportazione del
petrolio, si sono anche fortemente indebitati sul mercato dei capitali per ottenere una
realizzazione più rapida dei loro progetti ed entrare quanto più rapidamente possibile nel club
dei paesi industriali. Diversi paesi poveri, poi, sono stati costretti a contrarre debiti con i paesi
più avanzati - direttamente o indirettamente per il tramite del FMI e della BIRS - al fine di
sostenere gli accresciuti costi delle importazioni. Con l’arrivo di Ronald Reagan alla presidenza
nel 1981, gli USA intrapresero una politica di alti tassi di interesse per frenare l’inflazione, che
si combinò con un’altra di intenso riarmo, per la quale occorreva che il governo si indebitasse
molto. Gli investitori, a quel punto, si rivolsero all’acquisto di titoli del debito pubblico
americano (attratti dagli interessi elevati), scommettendo su una immediata forte ripresa
dell’economia USA. Il risultato fu che la quotazione del dollaro cominciò a salire in modo
inarrestabile almeno fino al 1985, colpendo tutti quegli operatori economici che si erano
indebitati in dollari. Fu il caso di molti paesi produttori di petrolio, Messico in testa, e,
soprattutto, di molti paesi del Terzo Mondo, in particolare dell’Africa e dell’America Latina. Da
qui sorge la crisi del debito. Esplose dapprima in Messico, agli inizi del 1982, quando il petrolio
cominciava a ribassare e il dollaro a crescere vertiginosamente. Il peso messicano si svalutò in
modo fulminante, vanificando i piani governativi di rientro dal debito contratto. Il circolo
vizioso sembrò irrefrenabile e la comunità finanziaria internazionale fu presa dal panico quando
si rese conto che i suoi investimenti in molti paesi potevano correre dei rischi. Banchieri e
finanzieri cominciarono così a reclamare i loro crediti, senza accettare gli abituali rinnovi. Le
pressioni delle banche costrinsero molti paesi a decretare la sospensione del pagamento del
debito estero. Per anni si discusse di come rinegoziare il pagamento del debito. I protagonisti
delle negoziazioni erano americani. Tali erano le principali banche interessate, come pure
americane erano le regole, che obbligavano a registrare come moroso qualunque credito con un
ritardo di più di tre mesi. Americana era la diplomazia che tentò di ottenere accordi di
rifinanziamento. Tutto americano era il problema del dollaro. Ed a Washington avevano sede i
due grandi organismi chiamati in causa per stabilizzare l’economia mondiale: la Banca
Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. Da qui il nuovo ruolo e l’immagine negativa
oggi sempre più accreditata di entrambi gli istituti. Essi non si dovettero dedicare al semplice
finanziamento di investimenti (la BIRS) ed al semplice finanziamento di deficit transitori nei
conti esteri (il FMI), ma furono obbligati ad occuparsi della stabilizzazione e dello sviluppo
dell’economia internazionale, come conseguenza delle azioni che gli USA avevano avviato
unilateralmente. In pratica, sono gli strumenti con i quali gli USA scaricano sul resto del mondo
le conseguenze delle loro scelte di politica economica.
Con la fine di Bretton Woods, il FMI, privato ormai del proprio ruolo di gestore della politica
dei tassi di cambio, ha volto la propria attenzione sempre più al Terzo mondo, insistendo sulla
necessità di prestiti mirati a favorire un’espansione del ruolo delle forze di mercato nelle
economie delle nazioni in via di sviluppo. Oggi il FMI continua ad essere il solo a credere
ancora che le forze del mercato siano la panacea per l’economia del pianeta. Ha concesso ai
paesi più poveri forti sgravi sul debito e ha sostenuto quelli a medio reddito (come la Corea, il
Brasile o l’Argentina) in crisi con “pacchetti di salvataggio” internazionali. In cambio però ha
preteso da tutti il rispetto di precise condizioni, tra cui austerità, tagli delle spese sociali,
privatizzazioni e riforme strutturali che tentassero di modernizzare quelle economie sul modello
del capitalismo anglosassone. Gli effetti sociali di tali scelte sono stati devastanti per i paesi del
Terzo mondo; per di più, come la crisi asiatica e quella argentina stanno a dimostrare, le ricette
del Fondo si sono rivelate anche totalmente sbagliate sul piano delle previsioni. Che sia poi un
organismo sempre più asservito agli interessi americani (del resto le stesse riunioni del G7 e G8
sono in realtà riunioni del G1!) lo dimostra un semplice esempio: fra le condizioni unite al
pacchetto di salvataggio per la Corea nel 1997 ce n’era una che imponeva l’apertura del paese
alle importazioni di pezzi di ricambio per auto, proprio quello che le imprese americane
avevano cercato di ottenere senza riuscirvi in una serie di negoziati commerciali bilaterali.
Alla luce di tutto ciò è giusto chiedere l’abolizione del FMI? A mio avviso no: in un mondo
dominato dai mercati globali è necessari una istituzione internazionale con funzioni di
regolazione e di controllo. A patto, ovviamente, che sia davvero internazionale e non una
dependance del Tesoro americano.
Probabilmente è un’utopia pensare che il FMI possa essere riformato (si potrebbe cominciare
col principio “un paese un voto” invece dell’attuale “un dollaro un voto”) o sostituito da
un’istituzione globale paritaria, democratica e aperta alle istanze della crescita sociale diffusa,
ma quale potrebbe essere un’alternativa credibile e - soprattutto - praticabile?
Un’ultima considerazione
La globalizzazione dell’economia mondiale viene utilizzata come argomento per invocare la
flessibilità dei salari, in quanto una più ampia liberalizzazione del mercato del lavoro sarebbe
necessaria per consentire all’industria europea di affrontare la concorrenza nei mercati mondiali
e tenere testa alla nuova industria dei paesi asiatici. Questa argomentazione non riflette la
complessità del problema. I paesi di nuova industrializzazione attraggono le imprese non solo
per il basso costo del lavoro, ma anche per la tolleranza in materia di norme di sicurezza e per
l’assenza di norme a tutela dell’ambiente. Se si vuole davvero competere con le nuove realtà,
non si dovrebbe solo reagire sul fronte salariale, ma anche smantellare le tutele e i diritti
conquistati in due secoli di lotte sociali e del movimento operaio: nonostante alcuni segnali
politici poco rassicuranti, è difficile pensare che qualcuno voglia intraprendere realmente tale
strada. Piuttosto, i paesi avanzati dovranno puntare sempre più sulla ricerca scientifica e
tecnologica, sull’alta qualificazione della produzione di beni e servizi, sulla formazione
continua e sui sistemi scolastici; soprattutto, non potranno aspettare i tempi lunghi della
maturazione sociale e civile dei paesi di nuova industrializzazione: occorre ottenere da questi
paesi il rispetto delle medesime norme di tutela dei lavoratori e di rispetto dell’ambiente [i rischi
per l’ambiente e i problemi dello sviluppo sostenibile meritano un discorso a parte che non è
stato possibile affrontare in questa sede] che i paesi avanzati applicano al loro interno.
Globalizzare i diritti quindi, non solo i capitali. Può essere possibile, a patto che cambino
radicalmente le forme e le istituzioni del governo mondiale dell’economia e si abbatta l’attuale
“monopolarismo” americano a vantaggio di una governance globale e realmente multipolare.
L.G.
Bibliografia
AA.VV., Dall’espansione allo sviluppo. Una storia economica d’Europa, Giappichelli Editore, Torino, 2002
W. Ellwood, La globalizzazione, Carocci, Roma, 2003.
J. Foreman-Peck, Storia dell’economia internazionale dal 1850 a oggi, Il Mulino, Bologna, 1999.
R. Romano e M. Soresina, «Homo faber». Economia, industria e società dal medioevo alla globalizzazione,
Mondadori Università, Milano, 2003.
G. Schlizter, Il Fondo Monetario Internazionale, Il Mulino, Bologna, 2000.
G. Soros, La crisi del capitalismo globale. La società aperta in pericolo, Ponte alle Grazie, Firenze, 1998.
J. E. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, Torino, Einaudi, 2002.
J. Tobin, Policies for Prosperity: Essay in a Keynesian Mode, The Mit Press, Cambridge (Mass.), 1987.