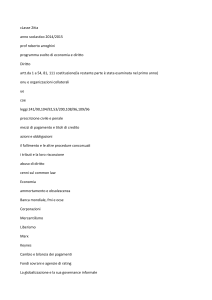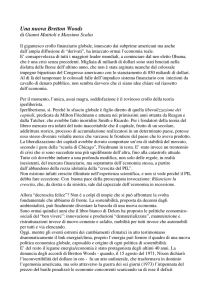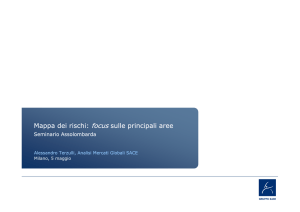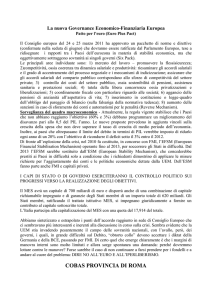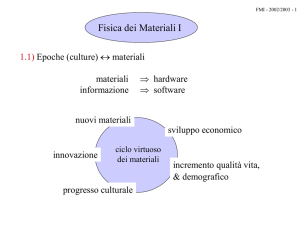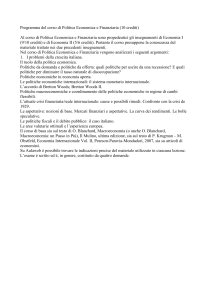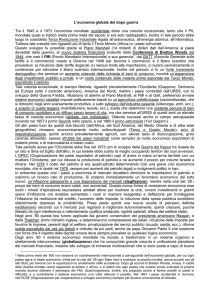gfp.169 – Laboratorio politico, Napoli 1996
IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE
il centro operativo dell’imperialismo transnazionale
__________________________________________________
Nel sistema capitalistico ciò si presenta nella forma
più clamorosa e grottesca di assurda contraddizione e controsenso,
perché, con lo sviluppo del sistema creditizio, la produzione capitalistica
tende continuamente a sopprimere questa barriera metallica,
al tempo stesso concreta e fantastica, della ricchezza e del suo movimento,
ma continuamente sbatte la testa contro di essa.
[Karl Marx, Il Capitale]
Introduzione
La “barriera metallica, al tempo stesso concreta e fantastica” - di cui parla Marx nel Capitale a proposito
di metallo prezioso e corso dei cambi - il controsenso grottesco e assurdo dello sviluppo della ricchezza nella
sua forma capitalistica, è costituita dal denaro: denaro come capitale, ovviamente, dalla sua forma monetaria
a quella creditizia. E quando Marx osserva che la peculiare forma capitalistica storica della produzione
sociale “continuamente sbatte la testa contro di essa”, vuol mostrare che questo è il segno più evidente
dell’incapacità di vederne genesi, trasformazioni, limiti. Codesto atteggiamento ideologico è tale da mettere
coloro che ne seguono la superficialità nelle condizioni di restare invischiati nell’angustia dell’“orizzonte
borghese, in cui il concludere affarucci occupa tutta la mente, di non vedere nel carattere del modo di
produzione il fondamento del modo di traffico a esso corrispondente, ma viceversa”.
I fenomeni economici, che nell’era contemporanea - quella dell’imperialismo, in particolare nella sua fase
transnazionale - appaiono sempre più, al primo impatto, nella loro forma monetaria, hanno un ben diverso
fondamento. E che i fatti monetari si pongano alla ribalta delle questioni internazionali che si svolgono sul
mercato mondiale è fuor di dubbio: sia nei termini della superficiale informazione di massa, e sia pure in
quelli degli organismi sovranazionali, alla cui testa sono il Fondo monetario internazionale [Fmi] e la Banca
internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo [Birs] (o, più brevemente, Banca mondiale [Bm]). Ma
siffatta prevalenza non deve trarre in inganno.
A proposito delle questioni monetarie vi era, già dalla metà del secolo scorso, una tendenza teorica al
loro fraintendimento da parte degli economisti “monetaristi” dell’epoca. Marx, parlando del principio della
circolazione monetaria e della legislazione bancaria inglese, avvertiva che “non si trattava più di fenomeni
economici isolati, come il deprezzamento dei metalli preziosi nel XVI e XVII secolo, di cui si occupò Hume,
o il deprezzamento della carta-moneta durante il XVIII e all’inizio del XIX secolo, di cui si interessò
Ricardo, ma delle grandi tempeste del mercato mondiale, in cui si scatena il conflitto di tutti gli elementi
della produzione borghese, la cui origine, e i mezzi per fronteggiarla, venivano ricercati nella sfera più
superficiale e astratta di questo processo, la sfera della circolazione monetaria. La premessa puramente
teorica da cui parte la scuola di questi meteorologi economici non è altro in realtà se non il dogma secondo il
quale Ricardo ha scoperto le leggi della circolazione puramente metallica. Ciò che ad essi rimaneva da fare
era di sottomettere a queste leggi il credito e la circolazione delle banconote”. Quella rappresentazione
dogmatica “giungeva quindi straordinariamente a proposito, poiché essa dava a una tautologia l’apparenza di
un rapporto di causa a effetto. Una volta ammessa la trasformazione della tautologia in un rapporto di causa a
effetto, tutto il resto procede facilmente”.
I moderni “meteorologi dell’economia” non sono da meno dei loro predecessori, e pensano ancora di
poter risolvere i problemi seri del mondo aggirandosi nella sfera superficiale della circolazione monetaria.
Dato che quando le cose fluiscono regolarmente quel loro agire sembra proficuo, essi continuano alla stessa
maniera anche nelle fasi della crisi. Ma, inevitabilmente, così facendo i sottostanti problemi reali non si
risolvono, semmai si aggravano. È per tale insieme di ragioni che le gravi contraddizioni dell’economia
mondiale, che si trascinano anzi ormai da più di un quarto di secolo, non possono certo essere superate per
“via monetaria”, come quei “meteorologi” pretenderebbero.
Proprio della stessa risma sono gli “esperti” che oggi occupano gli uffici dei ricordati organismi sovranazionali e siedono ai tavoli dei vari gruppi del potere imperialistico internazionale - come i cosiddetti “G”
&%PAGINA&
con un numero appresso. [Si sa che quanto più grande è quel numero tanto meno in alto il corrispondente
gruppo è situato nell’appropriato ordine gerarchico; cfr. documentazione]. Si è dunque di fronte a una patente
e curiosa incongruenza teorica e pratica: mentre da un lato, in ultima analisi, i tentativi “meteorologici”
monetaristici di spiegare e sanare i guasti del modo di produzione capitalistico sono vani perché sbagliati,
d’altro lato, in prima istanza, l’espressione conoscitiva e l’incidenza politica provenienti dai consessi del
sistema monetario internazionale sono di grande rilevanza e di primaria importanza. E ciò è vero - e sarebbe
bene che maggiore ne fosse la consapevolezza - anche per chi da “sinistra” pretenda di opporsi seriamente al
sistema di potere imperialistico. Del resto, proprio dai meteorologi del sistema monetario viene sempre più,
nei fatti, dato rilievo ai problemi della cosiddetta economia reale, dello sviluppo, dell’accumulazione e della
loro crisi: è da lì che muovono, con sempre maggior frequenza, nei tempi di crisi, i provvedimenti e gli
interventi guidati dagli organismi sovranazionali di cui si sta parlando. Provvedimenti e interventi che, al di
là del loro potere condizionante, offrono sempre più dei comodi alibi per le politiche coercitive dei governi
nazionali [si pensi solo ai balletti messi in atto dai diversi e successivi governi italiani al proposito].
“Le strutture finanziarie svolgono un ruolo molto più ampio di quello usualmente attribuito loro, mobilizzando il risparmio e indirizzandolo agli investimenti per l’industrializzazione; in effetti, definiscono l’utilizzazione delle risorse e funzionano come "cervello" dell’intero sistema economico”. Parole di questo tenore
provengono dagli atti di una delle tante conferenze della Banca Mondiale sull’economia dello sviluppo. Non
solo vi è questa consapevolezza - per così dire “marxista” a contrario - ma essa si estende anche alle
funzioni classiste dello stato, cioè a questo imposte dalla classe capitalistica dominante in quanto sua propria
emanazione politica istituzionale. Ormai i funzionari degli organismi economici sovranazionali sono
preoccupati di definire “il grado e l’intensità appropriati di presenza dello stato nel contesto della generale
liberalizzazione, il ruolo pubblico nei mercati finanziari e (al di là della deregolamentazione) la soluzione per
una regolamentazione meglio definita, anche perché la regolamentazione pubblica può farli funzionare
meglio e migliorare altresì i risultati complessivi dell’economia”. Per riuscire a ottenere che “un alto livello
di investimenti nel settore privato sia rilevante al fine di sostenere lo sviluppo economico” è essenziale che
“l’assistenza pubblica ufficiale svolga un ruolo complementare ma cruciale”.
Gli accordi di Bretton Woods
22 luglio 1944: accordi di Bretton Woods. La cittadina americana del New Hampshire è uno dei più antichi insediamenti Usa “english style”, che forse proprio per codeste sue caratteristiche ambientali fu scelta,
con buona dose di ironia più o meno voluta, quale sede per addivenire a una soluzione negoziata della “guerra fraterna”, occulta e non dichiarata, ma condotta e vinta dagli Usa contro il Regno unito. Si trattava di
portare a compimento quel confronto a due - già avviato con la I guerra mondiale e protrattosi per tutti gli
anni ‘20 (pagamento dei “danni” di guerra, piano Dawes-Young) e gli anni ‘30 (grande crisi, suoi sviluppi e
implicazioni fino al new deal) - che avrebbe dovuto definire il passaggio di consegne alla guida
dell’imperialismo mondiale. Tuttavia, in quella sede, tale confronto fu posto al solito modo “meteorologico”,
ossia limitatamente alle forme monetarie - dando implicitamente per scontata l’acquisita supremazia “reale”
dell’apparato produttivo Usa - in termini di un “aggiustamento”, come si suol dire, relativo alle questioni di
finanza, liquidità e fiducia. Il rispettabile e rispettato lord Keynes fu mandato a trattare con White, il
negoziatore americano, per cercare di difendere i residui interessi britannici.
La proposta keynesiana, nella consapevolezza della definitiva perdita di supremazia britannica nel mondo
moderno, prevedeva una banca che fosse effettivamente il più possibile internazionale - ossia, non prioritariamente assoggettata al sopraggiunto dominio unipolare Usa. A essa si sarebbero dovuti dare reali poteri
decisionali e una sorta di vera e propria moneta (che Keynes avrebbe voluto chiamare bancor). Tale
soluzione istituzionale sovranazionale avrebbe dovuto garantire finanziamenti abbondanti (30 mrd $), per
indurre lo sviluppo della produzione e un aumento di occupazione, con una certa inflazione controllata. Un
simile sistema, per l’appunto, avrebbe consentito una maggiore autonomia nazionale rispetto all’egemonia
Usa [il Regno unito aveva ancora da gestire 4 mrd £ di posizioni debitorie, contratte durante la guerra e
dichiarate inconvertibili].
Il progetto Usa di White, viceversa, si limitava a un “fondo di stabilizzazione”, senza alcun potere bancario operativo, senza una “moneta” comune ma solo con una “unità di conto” (che gli americani avrebbero
denominato unitas), naturalmente ancorata al dollaro. In tale contesto, i finanziamenti del Fondo si sarebbero
configurati semplicemente come intervento di aggiustamento delle bilance dei pagamenti. In effetti, i
finanziamenti inizialmente previsti e attuati dal Fmi furono solo di 8 mrd $, un quarto rispetto alla richiesta
inglese. Così il mercato mondiale dei capitali rimaneva di fatto affidato agli investimenti diretti all’estero
degli Usa: il piano Marshall - 13 mrd $ - e gli altri piani similari nelle diverse parti del mondo coprirono la
differenza dei finanziamenti mancanti, che naturalmente furono tutti in conto Usa, sotto il dominio del
dollaro.
&%PAGINA&
Cosicché si giunse alla parvenza di un compromesso tra i due piani, tradotto in norme formali nell’articolato di Bretton Woods, per Fmi, Bm e Gatt [quest’ultimo “trattato generale per il commercio e le tariffe”
venne predisposto in sostituzione dell’Ito, organizzazione internazionale per il commercio, varata e
trasformata in Wto, organizzazione per il commercio mondiale, solo cinquant’anni più tardi, nel 1994, dopo
la chiusura dell’ultimo round del Gatt]. La soluzione fu una reale centralizzazione del capitale mondiale
intorno all’imperialismo Usa. La lotta comunque non era ancora del tutto finita: per la regolazione delle
questioni monetarie, e in particolare per imporre la convertibilità delle valute europee in funzione del dollaro
e a sostegno delle sue operazioni sul mercato mondiale, essa si protrasse fino al 1958, quando le economie
europee raggiunsero quello stadio di sviluppo sufficiente a non rimanere schiacciate dalla supremazia del
dollaro stesso.
Intanto, comunque, Fmi e Bm furono sempre più poste sotto l’effettiva direzione Usa, al di là dell’articolato formale e in direzione concreta del progetto White. E se, come si vedrà, già a partire dal 1970 - giusto
a metà del primo cinquantennio della storia del Fondo - l’egemonia assoluta da parte degli Usa fu messa in
mora, ancora fino a tutto il 1991, in forza del meccanismo di votazione previsto dagli accordi di Bretton
Woods sulla base delle quote sottoscritte, gli Usa (con il 18,31% delle quote stesse) erano di fatto l’unico
stato che potesse esercitare da solo il diritto di veto (attribuito appunto al 15% delle quote). Gli altri paesi
dovevano essere almeno in tre! [Ora per porre veti occorre il 30% delle quote, cosicché, conformemente
all’ancora incerta ridefinizione dei rapporti di forza internazionali, serve l’accordo almeno di quattro stati cfr. documentazione].
Tornando al primo esito dei negoziati del New Hampshire, dunque, Keynes stesso se ne dichiarò sostanzialmente insoddisfatto, ammettendo di fatto, in séguito, la “sconfitta” britannica dopo la II guerra mondiale.
La storia ha mostrato che quella guerra fu condotta per definire la gerarchia dell’egemonia capitalistica sul
mondo da parte degli Usa. Fino ad allora, era l’imperialismo inglese, pur se nella sua fase ormai declinante, a
dominare sui mercati finanziari del capitale; la sconfitta dell’impero di sua maestà britannica fu peggiore di
quella subita da Germania e Giappone - che approfittando della contesa avevano ancora una volta cercato di
insidiare le mire yankees a raccogliere l’eredità inglese.
Alla luce degli avvenimenti più recenti, un riferimento alla breve “storia dell’oro” in questo secolo può
essere particolarmente istruttivo, in particolare con riguardo agli sviluppi degli assetti postbellici del potere
internazionale. Non è per caso che l’oro dominasse incontrastato come misura internazionale degli scambi
valutari, col cosiddetto gold standard, solo fino al 1913, ossia alla vigilia della I guerra mondiale
imperialistica. Poi, dopo quella guerra, la grande instabilità economica e politica che seguì, si tradusse in un
sistema di cambi fluttuanti (tra il 1919 e il 1925), ripiegando provvisoriamente e precariamente sul
cosiddetto gold exchange standard, laddove l’“exchange” astutamente frapposto rimandava a una misura
basata su una sterlina non più certo sovrana indiscussa, pur se ancorata all’oro (tra il 1926 e il 1931). Dopo la
grande crisi - le cui cause reali di arresto dell’accumulazione e crollo dell’occupazione furono ben più
profonde e radicate di quanto il “venerdì nero” di Wall street potesse illustrare - gli effetti monetari portarono
alla dichiarazione di inconvertibilità della sterlina, dal settembre 1931. Il protezionismo degli anni ‘30 (con
tutte le vicissitudini economiche del periodo, su cui qui non serve soffermarsi oltre) fu rappresentato da una
flessibilità controllata dei cambi, fino alla II guerra (1939). Era questo il quadro d’anteguerra in cui
Roosevelt cominciò ad attaccare il dominio britannico, che nel frattempo si era arroccato nel sistema di
“preferenze imperiali” stabilito a Ottawa (1931) per cercare di resistere al proprio dissolvimento.
Il potere Usa impose perciò, nel secondo dopoguerra, un regime di cambi fissi, sollecitando con eccessiva
precipitazione la dichiarazione ufficiale di “parità” fisse col dollaro, esso stesso ancorato all’oro, da parte dei
più importanti 32 paesi del mondo (18 dicembre 1946). Così facendo, per gli scambi internazionali multilaterali, il dollaro si pose sùbito, fin dal 1946, come unica moneta effettiva, al posto dei fittizi “bancor” o “unitas” [a titolo di confronto è istruttivo pensare oggi alla politica del marco tedesco rispetto alle proposte di
moneta unica europea, il presunto Euro, e al ruolo marginale dell’Ecu]. Formalmente fu confermato
(ripristinandolo) un regime di gold exchange standard, ancorato però stavolta anche al dollaro oltre che alla
sterlina: ma per quest’ultima, chiaramente ormai in discesa, si trattava di un contentino in vista del prossimo
abbandono. Si andava direttamente verso il dollar standard - apogeo, trionfo e morte del dollaro, con l’oro
come sua appendice.
L’impegno per azioni dirette a garantire la stabilità dei cambi, tuttavia, richiesto e imposto troppo precipitosamente dagli Usa agli “alleati” sudditi, non poteva essere affrontato immediatamente nelle fragili condizioni economiche dei paesi la cui ricostruzione postbellica impediva loro di determinare con sufficiente autonomia la propria politica economica. Ciò ebbe due effetti, in parte contrastanti, nella costruzione della
tipologia che andava assumendo l’egemonia del dollaro. Da un lato, come accennato, dal 1946 al 27
dicembre 1958 la convertibilità internazionale riguardò solo la valuta Usa, per tutto il periodo cioè durante il
quale durò una sorta di “resistenza” europea contro l’accelerazione dei tempi del dominio americano. Solo
alla fine di quel periodo, con sistemi economici ormai consolidati nei “boom” degli anni ‘50, le valute
europee stabilirono la loro convertibilità nelle transazioni internazionali, per affiancare il dollaro in affanno a
&%PAGINA&
causa della richiesta di liquidità internazionale, onde ridurre la pressione su quest’ultimo. D’altro lato, in
quel decennio è più di ascesa dell’“impero americano d’occidente” (1946-1958) - che fu relativamente
oneroso per la liquidità mondiale in dollari - gli Usa consolidarono definitivamente il loro monopolio sul
mercato mondiale dei capitali. Entrambi i protagonisti di Bretton Woods intendevano ripristinare la
multilateralità degli scambi, contro il bilateralismo e il protezionismo che caratterizzò gli anni ‘30, anni di
crisi. Ma il problema effettivo non riguardava solo il riaggiustamento congiunturale delle bilance dei
pagamenti [come scritto nei documenti ufficiali di Bretton Woods], bensì precisamente il controllo del
mercato mondiale dei capitali. Qui si pose la “questione di fiducia” nel dollaro.
La fiducia nel dollaro
Senza minimamente pretendere di rifare la storia economica del secondo dopoguerra, è quanto meno utile
rammentare i caposaldi stabiliti nell’immediato avvio di quel periodo, giacché in quell’avvio si rappresenta
la totalità delle condizioni di un’epoca, a partire dallo sviluppo qualitativo della ricostruzione, per poi attraversare il consolidamento dell’egemonia dell’imperialismo Usa. [Si osservi unicamente, pro memoria, che
gli Ide (investimenti diretti esteri, per il controllo o almeno la partecipazione, diretta per l’appunto, relative
ad attività produttive) del capitale a base Usa nel mercato mondiale, che erano ancora solo 12 mrd $ nel 1950
(dal miliardo di inizio secolo agli appena 4 subito dopo la prima guerra mondiale), sono balzati a 124 nel
1975 e a 327 nel 1988; considerando anche gli investimenti di portafoglio (ossia quelli generalmente a
carattere finanziario di tipo prevalentemente speculativo, operazioni di borsa su capitale fittizio) ormai si
superano di parecchio i 1000 mrd $ - forse più del Pnl annuo italiano]. Alla luce delle prime considerazioni
fin qui svolte, si può allora meglio inquadrare il significato dell’accordo siglato a Bretton Woods.
Si noti bene che il 22 luglio 1944 la II guerra mondiale non era ancora ufficialmente finita: il cosiddetto
D-day, lo sbarco angloamericano in Normandia, avvenne il 6 giugno di quell’anno ma l’offensiva finale del
gen. Patton cominciò il 25 luglio 1944, cioè tre giorni dopo l’inizio della conferenza di Bretton Woods. La
Germania era ormai spacciata e, per gli “alleati” occidentali, si trattava perciò di bloccare l’avanzata
travolgente dell’“armata rossa” per impedire la conquista di gran parte dell’Europa da parte sovietica; così
come le bombe atomiche scaricate poi sull’ormai capitolato Giappone, 6 e 9 agosto 1945, rappresentavano in
realtà piuttosto l’avvertimento minaccioso contro Urss e Cina per ostacolare l’espansione comunista in Asia
(la guerra di Corea, dal 1950 al 1953, non fu che la successiva conferma di ciò, dopo la rivoluzione cinese).
La “guerra fredda”, dall’Europa all’Asia, contro quello che veniva considerato il “comunismo” mondiale, era
già subentrata a quella combattuta con gli eserciti. Gli scontri per il controllo del mercato mondiale erano già
passati per la conferenza di Teheran, fine novembre 1943 (occupazione americana dell’Europa continentale,
con esclusione della regione balcanica); l’avvio della conferenza di Bretton Woods precedette di poco quella
di Dumbarton Oaks, agosto-ottobre 1944 (varo dell’organizzazione delle “Nazioni Unite” nella lotta contro
l’asse Germania-Italia-Giappone, e cancellazione del piano Morgenthau di smembramento agricolo della
Germania, in vista della sua ricostruzione industriale), in preparazione di Yalta, febbraio 1945 (definizione
delle zone di influenza e dei “blocchi”) e dell’accordo di Potsdam, agosto 1945 (spartizione della Germania).
Dunque, mentre altrove i generali ancora sparavano e definivano gli assetti territoriali da imporre agli altri
paesi, alleati nella vittoria bellica o sconfitti, quello siglato a Bretton Woods fu il “trattato di pace” tra gli
Stati Uniti d’America, il vero unico vincitore, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, il vinto, nel
passaggio di consegne alla guida dell’imperialismo mondiale. Come ricordato, lo stesso lord Keynes ammise
la sconfitta subita. Fu appunto in quelle circostanze - all’apogeo di quello che da più parti è stato chiamato il
secolo americano - che venne disegnato, in un confronto a due, l’ordine mondiale dell’epoca della “guerra
fredda”. Del resto, nel complessivo disegno statunitense, che ricomprende piano White e piano Marshall per
l’Europa (e piani omologhi nelle altre regioni del mondo), erano previste due basilari scelte anticomuniste:
l’una, definiva l’esclusione a priori dal consesso internazionale dell’Urss “dove una crudele disciplina dello
stato elimina nettamente la libertà individuale”, al contrario del “nostro” sistema “nel quale i diritti
individuali e le libertà sono affermate, dove esse sono protette da guarentigie costituzionali fondamentali e
dove lo stato è il servo del popolo” (rapporto Harriman sul piano Marshall, luglio 1947); l’altra, conseguente
alla precedente scelta e alle spartizioni politiche stabilite nelle conferenze sopra menzionate, era concepita
per evitare che “se i paesi dell’Europa medio-occidentale e mediterranea cadono, sotto il peso della
disperazione, e diventano comunisti, la Scandinavia cadrà nello stesso campo; i paesi dell’Africa
settentrionale e del Medio oriente, strategicamente ed economicamente vitali, seguiranno” (rapporto
Harriman): ovverosia, citando il commento di Molotov, delegato sovietico, “i crediti americani non
serviranno a ricostruire l’Europa sul piano economico, ma a opporre una parte dei paesi europei agli altri pesi
europei, come sembrerà vantaggioso a certe grandi potenze che aspirano a dominare gli altri paesi”
La pax americana, in termini di potere economico mondiale, fu posta con riferimento - anche come parole chiave - ai problemi di aggiustamento finanziario, liquidità, fiducia. Sotto la parvenza di un
&%PAGINA&
compromesso tra le due potenze contendenti, la soluzione emersa a Bretton Woods consolidò definitivamente per l’intera fase in questione, pur con il rammentato contenzioso in materia di convertibilità
delle monete europee forti, che si protrasse fino al 1958 - il processo di centralizzazione intorno al capitale
Usa. In conformità con il progetto White, le istituzioni “sovranazionali” di Bretton Woods (Fmi e Bm) erano
ormai di fatto in mano agli Usa. Con il controllo del mercato mondiale dei capitali preso dagli Usa, tutta la
storia dell’economia mondiale in quella fase fu determinata da quell’egemonia americana. Ciò ebbe un
particolare significato anche per l’economia dell’Italia, in prospettiva del reinserimento del capitale
finanziario a base italiana nel contesto internazionale, in forme funzionali agli interessi Usa.
L’epoca del pieno dominio Usa fu quella compresa tra la fine della II guerra mondiale e gli ultimi anni
‘60: l’epoca della guerra fredda e del funzionamento originario del Fmi e degli altri organismi sovranazionali
postbellici (i loro primi venticinque anni su cinquanta), l’epoca che Victor Perlo ebbe a definire l’“economia
di guerra in tempo di pace”. Non è per caso, dunque, che le tappe e i mutamenti del sistema di Bretton
Woods coincidano con le fasi di questo periodo. Meglio si comprendono le trasformazioni del sistema
sovranazionale se le si affiancano agli avvenimenti che hanno segnato la storia recente del potere Usa.
Il capitale americano cominciò, appunto, a sviluppare la pienezza della sua capacità egemonica con l’economia di guerra, avviata e protetta dal nuovo corso di Roosevelt, alla fine degli anni ‘30. Con il riarmo
rooseveltiano, tra il 1939 e il 1944 gli acquisti pubblici presso l’industria privata crebbero di sette volte: fu
quello l’atto di nascita di ciò che lo staff di Eisenhower chiamò poi - a guerra finita, con l’imposizione della
pax amerikana - il complesso militare-industriale. L’intersettorialità dell’apparato industriale era ed è tale da
rovesciarsi sull’intera economia. Si dispiegava così il ruolo dello stato federale americano a sostegno dei monopoli a base Usa, per la loro occupazione dello spazio mondiale.
Si andava in tale maniera affermando la concezione di un mercato mondiale come spazio di esistenza,
specifico e perfettamente integrato, dei monopoli multinazionali prima e transnazionali poi. Il piano Marshall - come le altre simili iniziative yankees nei continenti extraeuropei, a integrazione del sistema di
Bretton Woods, nella sua definizione statunitense - fu il sigillo dell’egemonia Usa. [Ancora oggi, con il 5%
della popolazione mondiale, il capitale Usa controlla il 25% della produzione mondiale; un 2‰ di yankees ne
controlla più del 10% (poiché la concentrazione del reddito Usa è tale che il 5% della popolazione ne
possieda quasi la metà, e ben il 90% del fatturato industriale sia concentrato soltanto nelle 13 maggiori
imprese)]. Quella strategia portò il capitale transnazionale a base Usa a controllare tutti i settori chiave
dell’industria manifatturiera (non solo quelli energetici, e petroliferi in particolare, che ne rappresentano una
parte, certo molto importante, ma la cui incidenza non è stata così assolutamente determinante come invece
la propaganda ideologica del potere ha fatto apparire).
Fu in siffatto quadro economico politico che si pose, in tutto il mondo, la “questione di fiducia” nel dollaro. Alla date del 27 dicembre 1958 il trionfo Usa era compiuto: ma “compiuto” in ogni senso, giacché
essendo completato era necessariamente anche concluso. Raggiunto l’apogeo si intravede la discesa. Il
trionfo odora di morte. Così, se il successivo periodo 1959-1967 segnò la fase di massima affermazione Usa,
esso vide praticamente solo la celebrazione di quel trionfo, come compimento del ciclo ascendente prima
della crisi. La fiducia “coatta” nell’egemonia Usa fu rappresentata dalla garanzia che l’economia americana
dava alla stabilità dei prezzi internazionali. Nonostante qualche avvisaglia fin dagli inizi degli anni ‘60 - per
problemi di liquidità che, come detto, la contrastata e tardiva ammissione di convertibilità delle valute
europee non riuscì a sanare adeguatamente - quella garanzia fiduciaria tenne sostanzialmente fino al 1965.
Fu allora che si avviò lentamente, ma decisamente, quel processo di inflazione che esplose poi visibilmente
solo nel passaggio al decennio successivo.
Ma le condizioni della crisi Usa - e quindi della crisi mondiale che ancora oggi si protrae irrisolta, anche
in Italia - erano già tutte poste a quella data, a partire dalla seconda metà degli anni ‘60. Non si può qui soffermarsi sull’analisi della lunga ultima crisi (altrove ampiamente discussa). Basti qui rammentare che a
partire da quel periodo le condizioni di accumulazione del capitale, a partire da quello a base Usa,
cominciarono ad affievolirsi. Il mercato mondiale andava rapidamente saturandosi, la sovraproduzione
eccedeva le possibilità di reinvestimento, il plusvalore non trovava più condizioni per essere prodotto e
realizzato e il profitto cominciava la sua caduta ciclica. I principali indici dell’economia statunitense
invertivano la tendenza fino ad allora seguita. Cosicché, anche alla superficie monetaria, la crisi di liquidità,
che si andava sempre più evidenziando alla fine del grande sviluppo postbellico, mise in luce la mancanza di
“fede” nel capitale Usa. “Al momento della crisi si ha la pretesa che tutte le cambiali, i titoli, le merci
debbano essere a un tratto e contemporaneamente convertibili in moneta bancaria e tutta questa moneta
bancaria a sua volta in oro. Come carta l’esistenza monetaria delle merci ha soltanto un’esistenza sociale. È
la fede che rende beati: la fede nel valore monetario come spirito immanente delle merci, la fede nel modo di
produzione e nel suo ordine prestabilito” - scriveva già Marx, nel Capitale, in polemica contro i
“monetaristi” della sua epoca.
E i moderni “meteorologi” dell’economia monetaria tornarono a scoprire la “causa” degli inizi della crisi
Usa addirittura e proprio nell’insufficienza di oro. Essa - non già come causa occulta ma come effetto visibi-
&%PAGINA&
le - fu particolarmente evidente e forte a partire dal 1966: e, in realtà, il susseguirsi degli eventi di quel
periodo, pur se lungi dal costituire le cause causanti dei fenomeni in corso, segnarono tuttavia, e
cominciarono a palesare, l’inizio della fine del bluff cartaceo del dollaro Usa. Fu appunto tra il 1961 e il
1967, nella fase del loro massimo predominio, che gli Usa misero in campo grandi manovre a protezione
delle riserve auree e della loro quotazione, con la costituzione del cosiddetto pool dell’oro, che ebbe vita
breve.
Tutto ciò svela l’innalzamento dell’oro a mero feticcio, denota l’incomprensione dell’oro stesso come
merce universale e della sua trasformazione in capitale e in capitale-merce. Si conferma così, indirettamente,
l’incomprensione borghese della crisi da sovraproduzione. È inutile cercare altre parole per descrivere ciò
che Marx, nella medesima polemica antimonetarista dianzi citata, spiegò compiutamente, a proposito di
questo “bel dualismo teorico” borghese: “in quanto si occupa del "capitale" ex professo l’economia
illuminata guarda dall’alto in basso, con il massimo disprezzo, l’oro e l’argento, come se si trattasse in realtà
della forma più indifferente e più sterile del capitale. Ma non appena si occupa del sistema bancario, tutto si
capovolge, e l’oro e l’argento diventano il capitale par excellence, alla cui conservazione qualsiasi altra
forma di capitale e di lavoro deve essere sacrificata”.
Il declino Usa
In quelle avvisaglie di crisi sono presenti i prodromi del crollo del vecchio ordine mondiale costruito a
Bretton Woods: e costì dunque sono pure i prodromi della crisi da cui, anche in Italia, esperti economisti si
propongono di uscire. Il quadro del declino Usa, nelle fasi dell’ultima crisi, inquadra agevolmente le
mutevoli vicende del Fmi e dei “vertici” a esso collegati. Per quanto riguarda gli organismi sovranazionali
dell’imperialismo contemporaneo (cosa che qui specificamente interessa), come si dirà, un punto d’approdo
di tale crisi corrisponde al varo del G.7, che risale al 1986, in una fase particolarmente critica dell’avanzato
declino degli Usa al quale si accompagnò la loro resistenza da superpotenza (fino a sfociare negli
avvenimenti del 1989).
È infatti proprio dall’avvio dello sviluppo dell’ultima crisi che già si cominciò a evidenziare meglio come
la struttura eisenhoweriana del complesso militare-industriale fosse rimasta la base dello stato Usa. Il suo
ruolo a sostegno del grande capitale finanziario in difficoltà è stato esaltato ogni oltre evidenza, con la
maschera del “libero-mercato”, soprattutto da Reagan. Sotto il suo governo, nel nome di un “privato”
presuntivamente contrapposto a un falso “meno stato”, è stato favorito il “più mercato” attraverso il più alto
intervento mai registrato di spesa pubblica a favore dell’industria e degli affari connessi: le sole spese
militari sono aumentate del 100% in dieci anni, superando i livelli record delle due “guerre in tempo di
pace”, Corea e Vietnam.
L’altra faccia di questa economia di guerra in tempo di (crisi della) pace è stata l’erosione continua, che
ora è sostanziale demolizione, dell’assistenzialismo pubblico al salario per conto del capitale, ossia il
cosiddetto stato sociale: è il warfare state contro il welfare state, per dirla secondo l’uso della polemica
pubblicistica americana. Siffatta connessione consente anche di comprendere ciò che le illusioni riformiste
rifiutano ostinatamente di vedere: ossia, che l’andamento della spesa pubblica sociale è strettamente
correlato (con un ovvio sfasamento temporale) con le fasi del ciclo di accumulazione del capitale, in quanto
spesa organica e funzionale alla produzione e circolazione del plusvalore. Il capitale è costretto - certo,
anche sotto le pressioni delle contraddizioni di classe - ad allargare tale spesa nelle fasi di espansione del
ciclo, per le sue stesse necessità di realizzazione del plusvalore e di allargamento della sua riproduzione: è
ovvio, dunque, che essa venga parimenti e corrispondentemente ristretta nelle fasi di recessione e
stagnazione. Ed è anche ciò che puntualmente prescrive il Fmi per garantire il flusso di finanziamenti agli
stati membri che ne necessitano.
Il problema della scelta strategica della spesa pubblica in disavanzo è quasi sempre impropriamente attribuito alle politiche keynesiane: ma quella pratica fu già anticipata dal dr. Schacht, prima governatore della
banca centrale tedesca e poi super-ministro dell’economia nazista, nel passaggio dalla repubblica di Weimar
al “Terzo Reich”, che lo vide protagonista, gestore della “continuità” degli interessi del grande capitale
finanziario tedesco. Quel problema - con tutte le sue eventuali difficoltà emergenti - viene nutrito proprio
dalla politica statale di spesa a sostegno del capitale, con particolare incidenza per l’”economia di guerra”. È
conseguenza ovvia, pertanto, che la formazione del disavanzo sia regolarmente accompagnata da sgravi
fiscali verso le classi medio-alte e il capitale stesso. La grande borghesia si dispone a usare il proprio stato
per i propri bisogni, soprattutto nelle fasi di difficoltà: la privatizzazione dei profitti di contro alla
socializzazione delle perdite, rammentava Grifone. Tuttavia - proprio allorquando l’autoriproduzione del
capitale ha difficoltà ad allargarsi e rallenta, e l’accumulazione perciò ristagna - la mancata copertura del
disavanzo stesso per la carenza di nuovo plusvalore si avvolge in una spirale crescente e la crisi di liquidità
impone le sue leggi.
&%PAGINA&
Le considerazioni sulla dinamica interna dei rapporti economici tra stato e capitale (qui con particolare
riferimento alla crisi Usa) non rappresentano una divagazione, come a un’osservazione superficiale
potrebbero perfino apparire. È infatti attraverso tale percorso che il disavanzo interno Usa ha raggiunto il
livello da primato di mezzo mlnmrd di lire [basti pensare, più in piccolo, all’Italia, col suo disavanzo di quasi
200 mmrd e col suo debito pubblico superiore ai 2 mlnmrd!]. D’altronde, la dimensione internazionale del
capitale Usa - della sua espansione e delle sue contraddizioni - ha fatto sì che con quel disavanzo interno
fosse parallelamente cresciuto il disavanzo “gemello” con l’estero. Esso, che fu dovuto primariamente al
finanziamento internazionale di capitali per investimenti all’estero, si è rovesciato poi anche sulla bilancia
commerciale, a causa dell’aumento delle importazioni di merci (in connessione con le esigenze di acquisto di
un’economia imperialistica, con l’accresciuta concorrenza internazionale e con le conseguenti tendenze
protezionistiche).
La gestione e il controllo di tali disavanzi - e qui interessa più direttamente soprattutto quello internazionale - caratterizzano dunque le diverse fasi dell’ultimo mezzo secolo di storia dell’imperialismo
transnazionale. Proprio per cogliere la peculiarità degli accadimenti economici del secondo dopoguerra, in
cui si colloca l’azione del Fmi, risulta dunque significativo il sintetico confronto fatto con le fasi
corrispondenti della “storia” del dominio Usa. Questo è perciò il quadro adeguato di riferimento entro cui
valutare le condizioni operative degli organismi finanziari sovranazionali [Fmi, Bm, G.7, ecc.].
La temperie della fine dello sviluppo postbellico, col suo sistema di Bretton Woods, e dell’avvio della
grande ultima crisi, si cominciò dunque a fare sempre più minacciosa tra il 1967 e il 1969. Fino al 1967,
come si è visto, una contraddittoria carenza di liquidità aveva segnato i problemi del mercato mondiale:
contraddittoria, dacché da un lato derivava dalla strategia monopolistica del dollaro come mezzo di
pagamento universale, mentre dall’altro essa si incancreniva per la mancata tempestiva integrazione delle
altre valute forti europee sotto l’egida del dollaro stesso. Il primo esito di tale contraddizione si ebbe appunto
nel 1967 con la prima svalutazione della sterlina inglese. A fronte di quella crescente carenza di liquidità,
perciò, il potere Usa provò a rispondere con l’economia di carta. Dal 1968 - sotto i colpi della crisi reale da
sovraproduzione - l’abbandono delle restrizioni monetarie, l’aumento del volume di moneta circolante, lo
sviluppo dei mercati valutari (prima eurodollari, poi petrodollari, ecc.), rappresentarono l’avvio
dell’attuazione di tale strategia “cartacea”. Ciò fece sì che la liquidità, prima carente, divenne eccessiva: ma
si trattava di una liquidità inquinata, sempre più fittizia e nominale, come d’altronde è caratteristico per le
fasi di crisi.
Il 15 marzo 1968 fu la data del ricordato attacco finale all’oro: fu sancita la fine del “pool” dell’oro, la demonetizzazione dell’oro e il passaggio - peraltro breve, solo tre anni - alla fase detta del doppio livello (oro e
dollaro) dei pagamenti internazionali ammessi. Parallelamente a codesta fine smussata dell’egemonia
monopolistica del dollaro - nell’ambito del sistema di Bretton Woods, ormai in necessaria trasformazione furono introdotti i cosiddetti diritti speciali di prelievo [Sdr - ossia, una sorta di moneta di conto, riconosciuta
per scopi di transazione e di riserva internazionale, determinata come media ponderata delle valute più forti;
cfr. documentazione]. Nella calura del ferragosto 1971 fu dichiarata improvvisamente anche l’inconvertibilità
in oro del dollaro: ma “improvvisamente” per quanti si rifiutavano di vedere la crisi (non era stata ancora
mandata in scena la nuova “commedia del petrolio”! - come si potrebbe dire per aggiornare Lenin) e il
declino dell’egemonia Usa. Era l’ultimo atto dovuto. La crisi era ormai nel suo pieno sviluppo da alcuni
anni.
La crisi dell’imperialismo
Ma le vicissitudini del “metallo maledetto” - il “feticcio che abbaglia l’occhio” - non facevano che rispecchiare, deformandolo, l’esito prossimo della contesa intorno allo sviluppo postbellico. Era la fine di una
fase, la fine del sistema di Bretton Woods (il declino dell’impero Usa), degli assetti definiti dai trattati di
Yalta (lo smembramento dell’est europeo) e di Teheran (la nuova balcanizzazione), e di tutta l’epoca della
“guerra fredda”. Henry Kissinger ha recentemente affermato che se, da un lato, in quel primo periodo poco
più che ventennale del dopoguerra gli Usa avevano ormai raggiunto tutti i loro principali obiettivi
internazionali, d’altro lato, ora erano costretti a darsi un ruolo del tutto nuovo, entro la molteplicità dei centri
di potere che caratterizza l’attuale dopo-guerra-fredda. Fu quella nuova fase che segnò l’inizio della grande
ultima crisi. Il mercato mondiale - quello “rilevante”, come lo chiamerebbero gli aziendalisti, ossia quello
conosciuto in quanto efficacemente operante - era ormai in via di assoluta saturazione.
Con l’uscita dalla latenza della crisi mondiale - con la ricordata inconvertibilità del dollaro, ferragosto
1971, dopo tre anni di incertezze - e di fronte alle contraddizioni del capitale a base Usa, in tutto il mercato
mondiale, e perciò anche in Italia, si passò alla controffensiva strategica per la ripresa di pieno comando
sulla forza-lavoro. La linea iperinflazionistica - partita dalla crisi di liquidità provocata dall’egemonia Usa
sul mercato mondiale dei capitali, gestito tramite gli ultimi guizzi del sistema di Bretton Woods - doveva
&%PAGINA&
essere selettiva, colpendo in misura e grado diverso secondo le diverse classi sociali. La prima fase culminò,
nel giro di pochi anni, nella politica delle multinazionali a base Usa che praticarono un aumento massiccio
dei prezzi internazionali [materie prime e prodotti agricoli (1972) e, solo dopo, petrolio (1973)].
Ciò servì per intensificare la guerra commerciale tra i tre poli - le tre grandi aree imperialistiche:
America-Usa, Europa-Germania, Asia-Giappone. Gli Usa riuscirono così provvisoriamente a respingere il
primo attacco del marco e dello yen al dollaro, e favorirono l’inserimento subalterno nel mercato mondiale di
alcune macroregioni di aree dominate [paesi esportatori di petrolio, Opec, e di nuova industrializzazione,
Nic], isolandone altri. Ma il monopolio del dominio Usa era stato messo in discussione; anche l’Italia, fino a
quel momento fortemente determinata dall’egemonia Usa, si trovò a operare immersa nell’area imperialistica
europea a guida tedesca, con le conseguenze contraddittorie che si sarebbero viste nei decenni successivi.
Tuttavia, nonostante che l’unificazione europea, prevista per il 1972, dovette subire uno slittamento quasi
ventennale, pur se preparata dallo Sme, i giochi dei successivi anni ‘80 e ‘90 furono organizzati in quella
fase.
Di nuovo, la specificità nazionale era scavalcata dalla crescente sincronizzazione della crisi e della strategia di risposta dell’imperialismo transnazionale. Nondimeno, questa procedeva di pari passo con l’acuirsi
delle contraddizioni interimperialistiche, più tra le diverse frazioni del grande capitale monopolistico
finanziario che tra paesi. Questi ultimi non facevano altro - e così hanno continuato a fare - che rappresentare
le mediazioni tra quelle diverse frazioni di capitale, secondo il rispettivo peso specifico territoriale e
“nazionale” di provenienza. Fu in quei frangenti che si cominciò a parlare del progetto di Nuovo Ordine
Mondiale [Kissinger, 1974-75].
La linea Usa - dopo il piano Kissinger del 1974-75 - si sviluppò nel vertice di Kingston (Jamaica, gennaio
1976) tra i “cinque paesi più industrializzati” - ovverosia, tra i cinque centri dell’imperialismo transnazionale, Usa, Giappone, Germania, Regno unito e Francia - che di lì in poi fu meglio conosciuto come gruppo
dei 5, ovvero G.5. Fu in quella occasione che venne stabilita la già ricordata definitiva eliminazione dell’oro
come riferimento dei pagamenti internazionali (cioè, la soppressione del gold da qualsiasi standard) e la
costituzione di un fondo, vincolato pertanto prevalentemente al dollaro, per l’accensione di prestiti
internazionali. Furono appunto quei prestiti - inventati per dare sbocco alla pletora di liquidità cartacea, di
cui il capitale mondiale ormai soffriva da anni - che crearono il problema ambiguamente etichettato come
debito estero, essendo sostanzialmente invece posto dal suo corrispettivo capitalistico, il credito estero.
Gli Usa cercavano per tal via di resistere alle contraddizioni interimperialistiche che prendevano corpo
con l’offensiva di Giappone e Germania. Ma in un famoso e successivo “segreto” vertice del G.5 - in realtà
la presunta segretezza fu dovuta alla prevalenza di fatto di un informale G.3 (Usa, Giappone, Germania) - del
settembre 1985 all’hotel Plaza di New York, fu decretata, col riconoscimento ufficiale, la già iniziata discesa
del dollaro. Ciò al fine di pilotarla in maniera più attenuata rispetto al rischio di un crollo, che sarebbe stato
dannoso per tutti i contendenti, non solo per gli Usa declinanti. Le potenze imperialistiche in ascesa non
volevano più continuare ad assorbire dollari di “carta straccia”, ma d’altronde rimanevano ancora legati alle
conseguenze del sistema messo in piedi dagli americani, non solo a Bretton Woods, ma a Dumbarton Oaks,
Teheran, Parigi e Yalta, fino alla costituzione degli organismi militari (Nato, Seato, ecc.) solidamente
impugnati dalle mani dei generali yankees. La totale rovina Usa non avrebbe rappresentato immediatamente
una vittoria, ma una grave recessione economica e un grosso rischio politico militare per Giappone e
Germania.
Il balletto delle trattative - i cui esiti erano scarsamente rispettati dalle parti, ma che servivano ugualmente
per misurare la forza reciproca dei contendenti - ebbe inizio a colpi (spesso mancati) di do ut des. Da un lato,
si ricercava il pareggio reciproco delle opposte bilance dei pagamenti; dall’altro, si prospettava un’inversione
dello sviluppo trainante, dagli Usa verso gli altri due poli. Ciò fu sottoscritto - ogni volta più come finte
buone intenzioni che come impegni concreti, stante la guerra commerciale in corso - nel corso del vertice di
Tokyo del maggio 1986. Fu quella l’occasione in cui si ebbe anche il passaggio al G.7, quasi a definitiva sanzione simbolica del tramonto del monopolio imperialistico Usa e del necessario rimpasto degli organismi di
Bretton Woods. Le grandi manovre sull’aggiustamento delle bilance dei pagamenti continuarono nella “lotta
tra fratelli nemici” a Parigi (vertice del Louvre), nel febbraio 1987.
Il problema del “doppio disavanzo” Usa si poneva così ormai al centro della crisi. Codeste specifiche
conseguenze del sistema di Bretton Woods, volute dagli Usa, si mostravano appieno nel loro dispiegarsi: dire
che la “liquidità” mondiale era stata resa dipendente dal disavanzo della bilancia dei pagamenti Usa, non
vuol dire altro - tradotto dal linguaggio “meteorologico” - che l’intero mercato mondiale dei capitali e l’intera economia e produzione della ricchezza mondiale era sottoposta agli Usa, nel “bene” e nel male. [All’inizio
degli anni ‘90 le cosiddette “passività” Usa sull’estero ammontavano a più di 1mlmd di lire!]. Per tal via tutti
i paesi connessi al sistema “statunitense” di Bretton Woods sono rimasti vincolati a processi di
aggiustamento interno - economico, e quindi sociale e politico - riversati nelle forme delle politiche
monetarie e fiscali dettate dal Fmi. A tale linea, infatti, corrispondono le forme vessatorie, in vigore da anni,
delle direttive del Fmi indirizzate ai paesi “beneficiari” degli interventi di finanziamento internazionale:
&%PAGINA&
l’antico proverbio cinese, ricordato da Lu Hsün – “accetta un pasto e riceverai ordini” - veniva dunque
tradotto nelle moderne forme del capitale finanziario.
Il nuovo ordine neocorporativo
Attraverso il suddetto “piano Kissinger” fu formulata la sostanza neocorporativa planetaria della fase a
venire. In quel quadro, in cui era posta la necessità della trasformazione funzionale degli organismi
sovranazionali nati a Bretton Woods, si sviluppò lo svolgimento internazionale della crisi da
sovraproduzione, incentrata sulla recessione che segnò proprio quel biennio 1974-75. Ancora una volta si
procedette - in uno con l’impiego degli strumenti di politica economica tipici di ogni periodo di crisi - alla
distruzione anche del capitale variabile. La riproduzione dell’esercito industriale di riserva - che caratterizzò
di lì in poi tutta la fase, a partire dalla seconda metà degli anni ‘70 fino a oggi - si è venuta sempre più
manifestando nella sua forma stagnante: l’irregolarità di occupazione e salario, e non solo la
“disoccupazione”, spiazzò definitivamente le politiche keynesiane (peraltro già inesorabilmente svuotate per
la loro improbabile propensione a colpire trivialmente il sottoconsumo, e perciò incapaci di afferrare
l’immanenza, la non accidentalità, della sovraproduzione). Gli avvenimenti economici e politici italiani di
quel periodo sono tutti inscritti nella rispondenza alla strategia del nuovo ordine mondiale.
Già fin dalla metà degli anni ‘70, senza dunque dover attendere il decennio successivo per cercare una
spiegazione, si ebbe la risposta del grande capitale. Data la maggior vicinanza fisica degli accadimenti, qui
possono essere sufficientemente esemplificative le vicende italiane. Specialmente quella parte del capitale
operante in Italia che più era legato all’imperialismo transnazionale, sia americano che europeo, fu capace di
avviare la ristrutturazione tecnologica, organizzativa e finanziaria, che le veniva richiesta. Tale processo tese
ad assumere caratteristiche del tutto omologhe a quelle seguite nel resto del mondo imperialistico, e
conseguentemente funzionali al mercato mondiale, che stavano e tuttora stanno alla base delle direttive del
Fmi:
- forte riduzione permanente dei livelli di occupazione stabile, accompagnata da una maggiore selettività
del mercato del lavoro e dall’attacco generalizzato al salario, con l’immagine di nuova professionalità da
raggiungere per quei pochi che avessero cercato di conservare i più elevati livelli salariali individuali già acquisiti, al fine di porre le condizioni fondamentali per la ripresa di comando sul lavoro da parte del capitale;
- attacco alla rigidità della forza-lavoro di massa in fabbrica (rigidità conquistata con le lotte del 1969-70),
attraverso la restaurazione di una flessibilità sulla base della riorganizzazione del processo di lavoro negli
impianti ristrutturati (mobilità interna), con nuovi carichi di lavoro, ritmi e mansioni, nonché dell’introduzione funzionale e non indiscriminata di singoli macchinari di nuovo tipo, impianti complessi composti di più
macchine, specializzazione per fasi omogenee di lavorazione;
- centralizzazione finanziaria e organizzativa strategica, articolata nella concentrazione produttiva per le
fasi di lavorazione ristrutturate, insieme a decentramento di fasi non ancora ristrutturate tecnicamente (lavoro
a domicilio, per conto terzi, e mobilità esterna), oltre che, in prospettiva, di reti e filiere sussumibili all’automazione del controllo, nell’àmbito di una ridefinizione transnazionale e trasversale sul mercato mondiale,
della divisione internazionale del lavoro e degli assetti proprietari (in cui si colloca il dispotismo dell’imperialismo transnazionale, tramite il controllo del Fmi, sull’economia e la politica dei paesi dominati);
- trasformazione e diversificazione della produzione verso una maggiore specializzazione tecnologica e
settoriale, non necessariamente più avanzata nella sfera produttiva (perché ciò dipende dalla divisione
internazionale del lavoro), ma resa funzionale alla nuove esigenze della sfera della circolazione, sia materiale
sia di plusvalore, di merci e di denaro, in conformità alle nuove esigenze del mercato mondiale dei capitali e
delle strutture finanziarie;
- adeguamento all’intero processo di ristrutturazione in atto delle condizioni istituzionali e infrastrutturali
(legislative e amministrative), sostenuto da politiche monetarie, creditizie, fiscali e doganali rese conformi ai
dettami delle direttive sovranazionali imposte dalla strategia transnazionale del grande capitale e gestite, per
suo conto, da Fmi e Bm.
Miscelando maggior flessibilità nel mercato del lavoro con riforma bancaria e del sistema finanziario e
con accelerazione di privatizzazione e ristrutturazione delle imprese pubbliche, il tutto viene presentato dal
Fmi come “fondamento su cui le autorità possono continuare a edificare la prosperità per il popolo”. Del
resto, da un’ideologia in cui i movimenti migratori internazionali vengono definiti “liberalizzazione dello
scambio di capitale umano” non ci si può attendere altro! È una logica conseguenza che le “ricette” del Fmi
riguardino preferenzialmente la flessibilità della forza-lavoro e il taglio della spesa pubblica a fini sociali.
Se, da un lato, il Fmi dice che “la liberalizzazione del mercato del lavoro favorisce un più sostenuto sviluppo, il che significa un maggiore guadagno per l’intera economia”, dall’altro [seminario sulla “Riforma del
sistema pensionistico pubblico”, 8-12 agosto 1994] invita a soffermarsi su misure tendenti a <regolare e
rivedere la gestione dei fondi delle pensioni pubbliche di 39 paesi industriali e in sviluppo”. Parallelamente,
&%PAGINA&
anche la Bm si è occupata del tema, con un suo studio intitolato “Percepire la crisi dell’invecchiamento:
politiche per proteggere gli anziani e promuovere lo sviluppo”. Ma la verità di tale strategia sovranazionale
viene presto a galla laddove si precisa che i “fondi-pensione capitalizzati e gestiti competitivamente offrono,
ai paesi che affrontano la riforma pensionistica, la prospettiva di tassi di risparmio crescenti e di
allargamento del mercato dei capitali”.
Il senso ultimo dell’azione del Fmi appare chiara in un altro “rapporto”. “In molti paesi la generosità delle
assicurazioni sociali rappresenta un fattore altamente disincentivante al lavoro in quanto il reddito da lavoro,
detratte le imposte, in certi casi è solo di poco superiore ai sussidi disponibili”. Par di capire che non sia tanto
la disoccupazione in sé (con i suoi tragici epiloghi) a preoccupare il capitale finanziario internazionale,
quanto l’entità numerica dell’esercito industriale di riserva. Perché se da un lato esso deve essere funzionale
a una fluida accumulazione capitalistica, dall’altro non deve stimolare troppi conflitti sociali. L’imperativo
del capitale, assistito dal Fmi, in ogni paese è una riforma del mercato del lavoro che realizzi, attraverso la
precarizzazione del rapporto di lavoro unitamente al taglio dei salari, un maggiore sfruttamento della forzalavoro (che viene occultato sotto l’etichetta di flessibilità).
Tale tipo di riforma, coordinata dagli uffici del Fmi, punta in particolare il dito contro il funzionamento
del mercato del lavoro in Europa, accusato di “carenza di flessibilità”: il confronto è con la situazione in Usa.
Gli esperti del Fmi, al cospetto di una crisi che sembra irresolubile, contrappongono a un modello europeo “molti disoccupati relativamente benestanti” - il modello americano - “molti occupati poveri”. A dispetto
delle critiche sulle gravi conseguenze sociali comportate dal “modello americano” - col quale peraltro non si
è di certo risolta la crisi da sovraproduzione - è proprio sul suo affidamento al “gioco di mercato” che
puntano le forze imperialiste. Si invitano i governi europei a non aver paura degli effetti redistributivi,
soprattutto ai danni degli strati più bassi della popolazione lavoratrice. Dal confronto tra i due “modelli”
emergono le indicazioni del Fondo. E quello americano è preferito perché comporta:
- minori sostegni alla disoccupazione
- maggior sventagliamento salariale
- minore sindacalizzazione
- minori mediazioni statali
- minori vincoli per le assunzioni
- minori vincoli per i licenziamenti
- minori costi extra-salariali
- riduzione delle ferie pagate.
Di conseguenza, sono definite “distorsioni” - rispetto alle esigenze di flessibilità - le politiche europee che
prevedono indennità di disoccupazione, livelli salariali minimi, garanzie occupazionali, e, infine, la possibilità di “riduzione legale del tempo di lavoro”: tutto ciò è considerato come un insieme di “iniziative
controproducenti”.
La fase del capitale transnazionale
L’odierna peculiarità del capitale transnazionale non è più data solo, o prevalentemente, dal trasferimento
diretto di capitale proveniente dalla “base” originaria, per fare nuovi investimenti nei punti di destinazione.
La parte maggiore la svolge il reinvestimento effettuato in loco a opera delle sezioni distaccate e delle filiali
già operanti nei territori coperti dalla rete mondiale di quel medesimo capitale monopolistico finanziario. La
rinnovata funzione del Fmi e degli altri organismi sovranazionali nati a Bretton Woods, dopo i primi
venticinque anni a egemonia assoluta statunitense, è proprio tesa a organizzare tra le “nazioni” la
circolazione di codesto capitale “senza nazione” per la ricerca di produzione di nuovo plusvalore. Dopo
l’acme dei primi 25 anni (1944-1969), dunque, sono state proprio le difficoltà che hanno segnato la grande
crisi del monopolio di potere Usa sul mercato mondiale ad aver messo Fmi e Bm di fronte a còmpiti per i
quali non erano attrezzati: si osservino bene le date via via indicate e le forme di sviluppo delle fasi della
crisi. Il regime multilaterale era stato eroso da bilateralismo e “regionalismo”, né sembrano rimedi
adeguati a ciò il Wto post-Gatt e il G.7-8.
Il direttore generale del Fondo, Camdessus, ha perciò celebrato il cinquantesimo anniversario con alcune
considerazioni che meritano attenzione, partendo dalla constatazione che la responsabilità per il controllo
delle politiche influenti sui tassi di cambio, affidata al Fmi a Bretton Woods, rappresentava un còmpito
ormai datato. L’attuale collasso di quel sistema rimanda agli sviluppi dell’internazionalizzazione dei
movimenti di capitale in una misura che era inconcepibile nel 1944. Perciò, con l’attuale deregolamentazione
del movimento transnazionale dei capitali le funzioni del Fmi di controllo sugli stati membri sono ormai
considerate “anacronistiche”. Insomma, il capitale non ha più confini nazionali, e dunque lo stesso Fmi non
può più essere considerato “separatamente dai suoi membri”. La spartizione in tre grande aree, come si
dirà, è perciò integrata da nuove forme di cointeressenze trasversali a esse. Il momento della lotta
&%PAGINA&
interimperialistica non è scisso da quello della collusione, per consentire altre lotte motivate e sostenute da
diverse interferenze di interessi.
Sono ora gli stessi rappresentanti Usa che auspicano l’allargamento effettivo del “processo di cooperazione internazionale” - ossia lo svincolamento delle sorti del capitale Usa dai suoi confini. Per far ciò si
individuano alcune “zone” come obiettivi prioritari. I cosiddetti paesi “in sviluppo” (130 su 179 membri) ora
non sono più soltanto ricevitori di “aiuti”; in particolare l’intera area asiatica del Pacifico (non solo il
Giappone) ha ormai raggiunto le aree americana ed europea; è aumentata l’integrazione internazionale per la
mobilità di merci, capitale e lavoro. Inoltre, le economie già centralmente pianificate sono state reintegrate in
quelle che i funzionari del Fondo chiamano le “nostre” istituzioni.
Con “il suo contributo, il Fmi ha favorito l’aggiustamento verso politiche di crescita nei paesi in via di
sviluppo, che così hanno aiutato a sostenere la crescita in tutto il mondo in via di sviluppo e, più in generale,
nel mondo intero, a fronte della recente recessione nei paesi industrializzati. Non si dimentichi che sono stati
i suddetti paesi "in sviluppo" che hanno praticamente determinato l’intero sviluppo mondiale, e che la
crescita delle loro importazioni ha coperto quella di tutto il mondo”. In tale direzione, si va delineando “una
nuova generazione di prestiti attraverso cui la Banca mondiale sostiene riforme politiche, istituzionali e
giuridiche volte a migliorare l’ambiente quotidiano in cui operano le imprese”. Tali esigenze sono state
sintetizzate dal comitato dei governatori delle banche centrali in una sorta di decalogo [questa “tavola della
legge” è stata qui numerata redazionalmente, ma le parole sono testuali], acciocché vi sia:
I. Ambiente attraente per gli investitori esteri.
II. Clima politico stabile.
III. Politica macroeconomica solida.
IV. Settore privato interno sano, vigoroso e competitivo.
V. Quadro istituzionale non discriminatorio per gli investitori esteri.
VI. Regime di scambi liberi.
VII. Mercato del lavoro flessibile.
VIII. Amministratori pubblici capaci.
IX. Adeguamento delle infrastrutture fisiche e umane.
X. Riduzione degli impegni debitòri.
Il capitalismo, d’altronde, conquistando nuovi mercati e nuovi territori, non esporta solo capitale e merci,
ma il suo stesso modo di produzione. Paesi con strutture precapitalistiche, un tempo coloniali e dominati, si
trasformano così a loro volta in nuove potenze capitalistiche. Sono potenzialmente questi i nuovi concorrenti
sul mercato mondiale. Tale processo è già più che evidente per Germania e Giappone, peraltro affacciatisi al
proscenio imperialistico, con alterne fortune, fin dalla fine del secolo scorso. Ma oramai potenzialmente analoghe considerazioni possono farsi guardando alla triplicata crescita del reddito di alcuni paesi già dominati o
finora ai margini del mercato mondiale: ci si riferisce ai cosiddetti paesi di nuova industrializzazione (dai Nic
ormai “classici”, alle “quattro tigri” del Pacifico asiatico, ai nuovi “miracoli” economici consentiti da
condizioni di morte sociale e civile, quali Indonesia, Malesia, Filippine, ecc.), e in prospettiva ancor più alla
Cina “comunista” (con contorno di Vietnam, Cambogia, ecc.); ma non è solo l’Asia a offrire tali prospettive.
Nel panorama mondiale, dunque, l’unico sviluppo, definito “robusto”, che soddisfa il capitale, investe
molti paesi dominati dall’imperialismo. “Investe”, nel senso letterale del termine, quello degli investimenti
diretti esteri [gli Ide]: “il rilancio del flusso finanziario privato verso i paesi in sviluppo continua. La
maggior parte di esso rimane concentrato in quei pochi paesi asiatici ed europei che erano riusciti a evitare le
difficoltà del debito estero negli anni ‘80, e in quei paesi dell’America latina che erano stati in grado di
normalizzare le loro relazioni con i creditori”. Dunque, Camdessus ha potuto affermare soddisfatto che
“possiamo anche salutare con gioia l’impressionante progresso fatto da alcuni paesi asiatici in transizione,
non soltanto la Cina, ma anche Mongolia, Vietnam e Cambogia”. E poco importa, allora, se “grandi disparità
persistono tra diversi paesi, e le previsioni a breve termine per i paesi più poveri non mostrano miglioramenti
sostanziali; i percorsi dello sviluppo rimangono molto ineguali, soprattutto a causa delle profonde differenze
nella qualità delle politiche di aggiustamento e stabilizzazione”.
Il Fmi affronta, da par suo, il problema della dilagante povertà nel mondo, con “programmi di aggiustamento strutturale” rivolti soprattutto ai cosiddetti paesi “meno sviluppati”, messi in difficoltà dalla grande sovraproduzione mondiale prima, dalla crisi del debito estero e dal crollo dei prezzi dei prodotti base poi. I
cosiddetti “programmi di aggiustamento [predisposti da Bm e Fmi] - si dice - permetteranno a quei paesi di
sfuggire alla trappola del debito”. Ma non si dice però chi abbia messo codesta “trappola”. Attraverso tali
prestiti i paesi poveri “sostenuti” dal Fondo possono ricevere trattamenti “facilitati” - purché rispondano con
“massicci cambiamenti delle loro politiche interne”, conformemente al “decalogo” del Fondo stesso potendo restituire i soldi dopo dieci anni: nel frattempo il capitale finanziario transnazionale ha mano libera
sui loro territori. Il versante della “spirale del debito”, esaminato dal punto di vista dei paesi dominati
dall’imperialismo, merita un’esame particolarmente approfondito che esula dal presente esame, dedicato
invece al funzionamento della centrale operativa del capitale monopolistico finanziario transnazionale.
&%PAGINA&
Quell’esame può e deve essere condotto altrove. Qui bastino alcuni cenni alle conseguenze più gravi di
quella spirale di assoggettamento e povertà.
È in tal contesto che alcuni “responsabili” di organizzazioni non governative [meglio note come Ong],
preposte semi-formalmente all’assistenza ai paesi poveri, si sono “improvvisamente” accorti che “molti paesi
in via di sviluppo debbono restituire attualmente al Fmi e alla Bm somme più alte di quelle che ricevono per
l’assistenza finanziaria, col risultato che il deflusso netto di fondi da questi paesi mina dalle fondamenta il
loro sviluppo economico”. Si dà il caso che le mitiche Ong - assai spesso articolate sulle spalle e sul difficile
lavoro di coraggiosi, onesti (e sovente ingenui), “missionari dell’economia” - servano puntualmente ai fini e
ai metodi dell’espansione del dominio del grande capitale monopolistico finanziario transnazionale. Sotto le
belle parole, gli affari (per di più a basso costo)! Al fine di “dialogare” con le Ong, la Banca mondiale ha
pensato bene di istituire una propria divisione intitolata allo “sviluppo ambientalmente sostenibile”,
affidandola peraltro a un esperto proveniente da quelle aree dominate, per “raggiungere un miglioramento
permanente e sostenibile della condizione umana, specialmente quella dei poveri di tutto il mondo”. In
effetti, i portavoce del Fmi non nascondono affatto che “l’onere del programma di aggiustamento ricada
spesso sui gruppi più deboli e vulnerabili della società. Disagi sociali, alcuni dei quali con tragiche
conseguenze, che si sono verificati in diversi paesi, riflettono i severi vincoli posti dai programmi di
aggiustamento”.
Ma, dice consolatoriamente il Fondo, “il nemico no.1 dei poveri è l’inflazione”. È ingenuo, quindi, chi
credesse che si tratti del capitale, del denaro e della proprietà privata, fonti originarie del moderno
sfruttamento su scala mondiale: l’inflazione si erge allora come una sorta di mostro inanimato che prende
vita indipendentemente dalla volontà dei padroni, cosicché gli organismi sovranazionali, posti quei severi
vincoli dei programmi di aggiustamento, possano lavarsene le mani, giacché “è prerogativa degli stati
sovrani decidere essi stessi le misure da adottare per le politiche di aggiustamento, per le quali sono in ultima
istanza i soli responsabili”. È così che “l’aggiustamento strutturale diviene realmente una forza di
centralizzazione del potere economico mondiale, anziché di aiuto alle popolazioni dei paesi in via di
sviluppo. Negli anni ‘60, alcuni paesi che ebbero alti tassi di sviluppo economico, videro che la loro
distribuzione del reddito diventava sempre più ineguale, facendo aumentare l’incidenza della povertà. Il
conseguente aumento della ricchezza si concentrava in un numero sempre più ristretto di persone, e i poveri
videro peggiorare la loro situazione rispetto a come era prima dell’aggiustamento”.
L’attenzione alla povertà diviene così il simulacro per nascondere che il problema di fondo del capitale
mondiale consiste precisamente solo nel ritrovare condizioni e spazî - internazionali ma anche interni - per
l’accumulazione, per la produzione di plusvalore (in termini reali, attesoché quelli monetari intervengano
post festum), e dunque per la fuoriuscita dalla crisi. Ma tutto ciò implica lotta di classe, sia come lotta tra le
classi, sia come lotta entro la classe della grande borghesia finanziaria transnazionale. La sfida agli Usa,
lanciata da Giappone e Germania, riemergenti dalla sconfitta bellica, dunque, cominciò a sostanziarsi
significativamente proprio allorché fu raggiunto il punto di svolta dell’egemonia americana - ossia verso il
termine dei venticinque anni dalla fine della II guerra mondiale, quel termine rispetto al quale si esaurì anche
l’assetto originariamente dato al mercato mondiale dagli accordi di Bretton Woods.
Il nuovo ruolo delle istituzioni sovranazionali
Le intese e le istituzioni varate a Bretton Woods furono, sì, il primo tentativo moderno di coordinamento
del sistema capitalistico finanziario mondiale, ma esse, come si è detto, hanno avuto il loro apogeo tra il
1959 e il 1967, l’epoca d’oro del dominio Usa nel mondo. La necessità di una ridefinizione del loro ruolo
risale, perciò, al collasso che esse ebbero tra il 1968 e il 1971, “a séguito della massiccia espansione
monetaria Usa, che creò l’inflazione su scala mondiale”. Così scrivono ora apertamente gli stessi organismi
sovranazionali: nessuno più ormai nega che “furono gli Usa a rompere le regole implicite connesse al
cosiddetto dollar standard [il riferimento al dollaro come unica valuta internazionalmente riconosciuta e
convertibile], minando la stabilità dei prezzi a partire dal 1965”. È molto significativo osservare la data: chi
già trent’anni fa parlava di prodromi della crisi, che sarebbe poi scoppiata in tutta la sua virulenza, veniva al
minimo dileggiato. La non comprensione dell’esatta periodizzazione delle fasi della crisi ha poi, perciò,
condotto a successive mistificazioni ideologiche. Prima sulla pretestuosa “crisi petrolifera” del 1973 (ben
otto anni dopo quel 1965!) cui cospicui economisti, anche di “sinistra”, imputarono la prima ondata
inflazionistica (replicata in seconda visione nel 1979). Poi riservando la successiva colpevolizzazione a un
supponente insostenibile aumento del mitizzato “costo del lavoro”!
Le cose vengono ora presentate ben diversamente anche da quegli economisti dominanti, almeno assennati se non “illuminati”: causa prima del voluto processo inflazionistico fu la crescente circolazione di dollari
che venne sostenuta con l’emissione di titoli a lungo termine, sul mercato mondiale. I paesi con eccedenze
valutarie cominciarono così a finanziare i disavanzi commerciali esteri e di bilancio interno dei paesi
&%PAGINA&
declinanti, Gran Bretagna e, soprattutto, Usa. Fu di fronte a queste circostanze, imposte loro con la forza
dell’arbitrio yankee, che le altre potenze imperialiste (guidate da Germania e Giappone) si mostrarono
riluttanti a continuare a seguire quella politica americana, vanificando così definitivamente l’originaria forma
data alle istituzioni nate a Bretton Woods.
Perciò - faticosamente giunti al “fatidico” 1971, dopo i primi quattro o cinque anni di insicurezza e difficoltà statunitense - con un lento ma continuo progredire fino a oggi, l’Europa a guida tedesca e il Giappone
non hanno esitato a porsi strategicamente contro il dominio Usa. Gli stessi dati statistici economici più
semplici sono significativi: nel ventennio ‘70-‘80, di contro a un 2,5% del ritmo medio di sviluppo in Usa, si
è avuto un 3% per l’Europa e un 4,5% per il Giappone. E la crisi che nell’avvio degli anni ‘90 ha colpito più
a fondo, endemicamente anche se saltuariamente, pure questi ultimi non comporta certo un vantaggio per l’area americana, che anzi, al cospetto di un mercato mondiale stagnante, accentua il suo declino.
Con la crisi iniziatasi alla fine degli anni ‘60, si sono via via prodotte e accumulate conseguenze generali
gravi, dovute sia al lento trascinarsi della crisi stessa, sia alla sua prolungata e dura gestione imperialistica.
Così, pur in presenza di una crisi ancora irrisolta, si sono venute sovrapponendo situazioni di dopo-crisi non solo economiche, ma anche sociali, istituzionali e culturali - in tutto corrispondenti a quelle di un dopoguerra. La corretta lezione degli studi del barone gen. von Clausewitz, fine allievo di Hegel, al di là di facili
e abusati slogan, lo insegna bene. Non è una novità che tra politica e guerra vi sia una stretta continuità
dialettica, perseguendo entrambe le stesse finalità di dominio di classe, con strumenti e armi adeguate alle
diversità delle fasi. Dunque, anche la crisi dell’economia e della politica non può non avere effetti devastanti,
sia pure apparentemente meno violenti ed evidenti, più soft e prolungati.
Viceversa, questo stretto legame dialettico è volutamente ignorato, ed esorcizzato, dagli ideologi borghesi. Per costoro, meno si parla di crisi e meglio è: e anche quando siano costretti a farlo, lo fanno per
invocare sacrifici, partecipazione e consenso, da imporre ai sudditi. Pertanto, come e forse più che per i loro
predecessori, anche per i moderni “meteorologi economici” la crisi è meglio che non esista - ovvero, è
meglio che essa assuma solo la parvenza di crisi dei mercati monetari e valutari e, di conseguenza, investa
principalmente la competenza delle istituzioni nazionali e sovranazionali preposte a tali compiti. Quella
che per tali ideologi non esiste è la crisi reale da sovraproduzione, la condizione che attraverso la
saturazione del mercato mondiale impedisce al capitale di continuare ad autovalorizzarsi, cosicché le
misure da prendere vengano tutte rabbassate ad alchimie monetaristiche: quasi che tali misure siano, esse,
in grado di raddrizzare il cattivo andare delle cose economiche, invertendo causa ed effetto - appunto,
come già notava Marx nella sua critica.
Tutte le precauzioni seguite per esorcizzare le crisi, dalla fine del secolo scorso a oggi, passando per gli
accordi di Bretton Woods, si sono affidate alla regolamentazione del “modo di traffico” e non del modo di
produzione: né potrebbe essere altrimenti, per chi considera “sacro” il sistema capitalistico. È già stato fatto
notare come sia affatto curioso l’atteggiamento borghese rispetto all’oro: dal considerarlo il simbolo
massimo della ricchezza, al dimenticarlo quando la produzione e lo scambio di merci procede spedito, al
precipitarlo nel nulla di fronte alla circolazione cartacea e al credito, per poi rituffarcisi dentro non appena le
contraddizioni e le crisi non offrano prospettive rosee.
Una precisa periodizzazione della crisi, dunque, serve qui per interpretare criticamente lo svolgimento
degli eventi del capitalismo mondiale nel mezzo secolo successivo alla II guerra mondiale. Tale
periodizzazione, perciò, partendo da metà anni ‘60, segna con precisione tutte le tappe del ciclo di
accumulazione e crisi del capitale imperialistico nella sua fase oggi superiore, quella transnazionale, evitando
così anche di dire banalmente che tutto dipende da tutto, in un’interdipendenza circolare e anodina che
sempre più affascina il pensiero debole delle teorie sistemiche. Di contro a una “complessità” che, lungi
dall’essere una novità alla moda, non è stata mai assente dalla storia, si assumono semplicemente quei criteri
e metodi di analisi scientifica che si siano mostrati capaci di dare spiegazioni universalmente significative ai
problemi posti dalla realtà. Il “concetto del contenuto”, per dirla con Hegel, è ciò che “è svelato dal metodo
stesso come sua anima”, ed è dunque ciò che fa la differenza dell’analisi, in quanto intrinseco e appartenente
a quel metodo pieno di contenuto.
Tra le altre cose, allora, seguendo il criterio che conduce alla periodizzazione causale, qui proposta e
seguìta anche per gli avvenimenti più recenti (quelli a partire dalla fine degli anni ‘80), si può escludere
agevolmente il riferimento allo “spettro” della grande crisi del 1929. È molto più significativo - anche se non
molto più confortante, di certo - il confronto con la grande depressione del secolo scorso. Si può perfino
apprezzare la straordinaria, quasi cabalistica, coincidenza di date, con cent’anni precisi di differenza, da
ricordare per pura curiosità: l’incubazione iniziale a partire dal 1867 fino all’eruzione violenta nel 1873, una
ricaduta intorno al 1878-79, poi una breve ripresa culminata intorno al 1883, una nuova recrudescenza della
crisi dal 1890, fino al passaggio di fase intorno al 1896. Ciò che qui interessa è che tutte quelle fasi furono
accompagnate da fenomeni industriali, commerciali e monetari, la cui somiglianza con l’oggi può sembrare
straordinaria.
&%PAGINA&
Essa, tuttavia, non appare più così straordinaria, non appena si pensi che, anche allora, si trattò di un periodo di grande trasformazione entro il modo di produzione capitalistico. Quel periodo segnò la nascita dell’imperialismo, a partire dal capitale britannico fino all’affermazione della potenza Usa, con la comparsa nell’epoca moderna di Germania e Giappone. Ossia, si trattò di una crisi epocale segnata dalla lotta per la ridefinizione della spartizione del mercato mondiale allora conosciuto. Ora la crisi irrisolta, protratta fino alle
soglie del 2000, segna un altro grande passaggio d’epoca: da un lato con la fine del monopolio imperialistico
Usa, dall’altro con il già consolidato passaggio dalla forma prevalentemente nazionale a quella
transnazionale dell’imperialismo stesso - con tutto ciò che comporta per le questioni politiche istituzionali
circa il ruolo degli stati nazionali, sullo sfondo di una ridefinizione della divisione internazionale del lavoro
basata sulla seconda grande rivoluzione industriale, quella dell’automazione del controllo, per una nuova
organizzazione della produzione e del lavoro.
Una svolta epocale
Questa nuova svolta epocale è sostenuta, dunque, sul piano delle potenzialità dei processi produttivi, sia
dall’unificazione del mercato mondiale dei capitali, per la prima volta nella storia dell’umanità esteso a tutto
il pianeta, sia dalla seconda grande rivoluzione industriale telematica, dell’automazione del controllo.
Avendo a mente ciò che riguarda direttamente l’Italia di oggi (la cui situazione economica può essere ancora
presa come esemplificazione di più facile lettura), è agevole collocare opportunamente e meglio
comprendere la definizione del quadro mondiale.
Sulla cosiddetta internazionalizzazione dell’economia sono state condotte sufficienti e soddisfacenti ricerche, per dimostrare la crescente tendenza in tale direzione, con peculiarità omologhe in tutti i paesi
capitalisticamente più forti. Anche il capitalismo a base italiana ha una tale collocazione imperialistica,
riconosciuta con la sua appartenenza al G.7. La sua storia ne illustra esemplarmente portata e limiti; se da un
lato è rilevante la sua ascesa a un posto compreso tra il quarto e il sesto nella graduatoria mondiale
dell’epoca, al vertice di Tokyo del 1986, dall’altro non si può evitare di osservare che quel riconoscimento
internazionale avvenne dopo il ricordato famoso accordo trilaterale del Plaza Hotel a New York nel 1985.
Comunque, chi parli di un’Italia alle soglie del precipizio nel cosiddetto “terzo mondo” non sa quello che
dice, sia per l’incomprensione degli interessi del grande capitale a base nazionale scissi da quelli della
popolazione e della “nazione”, sia per la non conoscenza delle reali condizioni di vita nei paesi dominati
dall’imperialismo.
Le caratteristiche degli investimenti diretti all’estero (Ide) ripetono ovunque i consueti schemi che vanno
dall’integrazione verticale all’articolazione dei processi produttivi (da materie prime a semilavorati), con
subordinazione funzionale di unità produttive “locali” formalmente indipendenti, al trasferimento di
segmenti del processo di produzione e circolazione con dislocazione all’estero. Ciò rispecchia la medesima
tipologia della connessione delle filiere produttive anche sul territorio “nazionale”, proprio in quanto
segmento del mercato mondiale. Ed è precisamente intorno alla promozione e alla tutela degli Ide che si è
sviluppata l’azione del Fmi (con il sostegno della Bm e dell’Ida, agenzia per lo sviluppo internazionale),
soprattutto nel suo secondo venticinquennio di vita, dopo la fine dell’egemonia degli Usa che autogestivano i
propri investimenti.
La periodizzazione data agli avvenimenti del secondo dopoguerra, perciò, spiega anche come le riprese
cicliche parziali (in particolare quella degli anni ‘80) non fossero affatto sufficienti a ristabilire il processo di
accumulazione stesso. E non si tratta tanto del prevalere delle inespressive cosiddette “onde lunghe”, a meno
che con tale terminologia ci si voglia limitare alla banale rilevazione fattuale di un ciclo di crisi di maggior
durata, rinunciando a fornirne un’interpretazione causale [che quella tassonomia statistica certamente non
può dare, soprattutto nei termini della marxiana critica dell’economia politica, dal momento che pone alla
loro base cause idealisticamente definite sociopolitiche, ossia ritenute inopinatamente metaeconomiche, in
quanto presuntivamente considerate estranee alla logica interna del sistema capitalistico: e tra queste cause
vengono annoverate lotte di classe, rivoluzioni come quella del 1848, guerre come perfino le due guerre
imperialistiche mondiali, prezzi del petrolio e delle materie prime nello scambio ineguale, debito estero,
ecc.].
Del resto, per capire che questa lunga e irrisolta ultima crisi sia di carattere strutturale non si richiedono
letture particolarmente forzate. Non occorreva, da un lato, come fanno gli “economisti illuminati” sempre
atterriti dall’horror del ristagno, attenderne il protrarsi nel tempo, giacché il suo carattere “strutturale” non è
dato da dimensioni temporali, bensì dalla non funzionalità dell’eccesso di sovraproduzione nei riguardi dell’estrazione di plusvalore. D’altra parte, serve a poco pure l’enfatica dichiarazione, preferita da apocalittici e
speranzosi teorici di sinistra, circa l’”assolutezza” dell’eccesso di capitale, giacché o questa è altrettanto
descrittivamente ovvia della lunghezza dell’onda, poiché una tale assolutezza è da Marx già chiaramente
inscritta in ogni periodica e ricorrente crisi da sovraproduzione generale capitalistica di merci (nelle sue
&%PAGINA&
forme funzionali di capitale-merce, capitale produttivo e capitale-denaro), o nasconde un’inespressa illusione
di un’improbabile “crisi finale” del modo di produzione capitalistico, seguìta dal suo imminente “crollo” o
abbattimento.
In un certo senso, dunque, le apparenti “ripresine” degli anni ‘80 rappresentavano delle finzioni, in quanto
costruite sull’assorbimento, da parte delle poche decine di imprese transnazionali forti, della rimanente
struttura economica fatiscente e fallimentare. Gli aumenti di produzione, nei vari paesi, mentre da un lato
registravano andamenti dimezzati rispetto ai ritmi medi mondiali del primo ventennio postbellico (3% contro
6%, all’incirca), dall’altro erano attribuibili principalmente a ristrutturazioni condotte dalle grandi imprese, a
séguito di fusioni e acquisizioni. In una fase critica da carpe diem - in cui dunque l’attività produttiva si
preoccupava soprattutto della razionalizzazione qualitativa di processi, prodotti e lavoro - è stata la
speculazione finanziaria a far valere le proprie leggi di classe: come insegna Henryk Grossmann, essa è
legge inesorabile della fase discendente della crisi ciclica scatenata dall’eccesso di sovraproduzione. Altro
che “reaganomics”, neomonetarismo e “ricette” del Fmi!
La nuova divisione internazionale del lavoro ha imposto al capitale operante dimensioni crescenti su
scala mondiale. Nel rammentato perdurante processo di fallimenti assorbimenti e fusioni, l’imperialismo Usa
ha ceduto potere, nonostante il processo di centralizzazione che lo ha visto promotore e protagonista. La
sfida lanciata da parte di Germania e Giappone era ormai partita in forma irreversibile. In un decennio gli
Usa, dai primi tre posti che detenevano nella graduatoria mondiale delle banche, sono scivolati in dodicesima
posizione, lasciando il primato a dieci banche giapponesi, le quali peraltro hanno basato tale loro ascesa sulla
volatilità di un fragile rigonfiamento della speculazione monetaria. L’esposizione a grandi rischi di fallimenti
di banche e istituzioni monetarie finanziarie e di repentini e fragorosi crolli di borsa hanno perciò
concentrato l’attenzione del Fmi (dal crollo della borsa di New York nel 1987 alle prime avvisaglie dello
scoppio della “bolla di sapone” speculativa alla borsa di Tokyo nel 1993, fino al crack messicano del 199495).
A séguito dello svolgersi del processo di crisi nelle sue fasi successive, la tripolarità imperialistica, delineatasi agli inizi della crisi, si è in un certo senso assestata. Purtuttavia essa ha sviluppato contrastanti
forme di profonda e tuttora irrisolta contraddittorietà. Così, da un lato, alla fine dell’egemonia economica
assoluta degli Usa, fa riscontro la permanenza della loro dominanza politica militare, che è tale da
determinare un arroccamento delle principali tre potenze imperialistiche come poli di riferimento all’interno
delle loro aree e zone di influenza, caratterizzando su basi rinnovate il ruolo dei loro stati nazionali in quanto
dominanti. Dall’altro, si è venuta articolando negli ultimi tempi, proprio dopo e in funzione di
quell’assestamento conflittuale, una certa pervasiva trasversalità agli stati nazionali stessi, più rispondente
alla diversificazione per interessi della collocazione di classe del capitale finanziario nel mercato mondiale.
Il nuovo ruolo del Fmi si definisce proprio in funzione della duplice mediazione necessaria sia riguardo
all’azione degli stati nazionali, rappresentativi del capitale avente in ciascuno di essi la propria base
preponderante, sia riguardo al libero movimento del grande capitale monopolistico finanziario transnazionale
sull’intero mercato mondiale (ciò che va sotto il nome insignificante e mal tradotto di “globalizzazione”).
Su queste basi si definisce quel riassetto dei rapporti di proprietà, su scala mondiale, per il quale la
grande borghesia finanziaria transnazionale tiene sempre più in una considerazione funzionalmente
subalterna la base nazionale di provenienza. La logica imperialistica transnazionale considera qualsiasi
economia nazionale (anche grande e significativa come quella Usa) come un’articolazione e un comparto del
mercato capitalistico mondiale. Pur dando ancora un forte significato, soprattutto di potere politico e
militare, al riferimento alle istituzioni statuali nazionali, dunque, i differenti rappresentanti del grande
capitale non esitano a cambiare con una certa agilità tali loro riferimenti, secondo convenienza, alleandosi
all’occorrenza con altre frazioni capitalistiche della medesima area di interesse industriale, appartenenti a
diversi basi nazionali di provenienza: quindi, eventualmente, contro interessi capitalistici “connazionali” ma
di differenti settori. In una dimensione economica così strutturata, perciò, che è concepita in una prospettiva
di dominio transnazionale di classe, si capisce facilmente perché divenga fuorviante, quanto anacronistica,
l’impropria metonimia nord-sud, con tutta la categorizzazione che l’accompagna, tanto appetita da quanti
bramano di sostituire contraddizioni di classe con varianti sistemiche. Non per caso una simile sostituzione
di categorie geopolitiche a quelle di classe è agevolata e assecondata dal l’intellighentsia degli organismi
sovranazionali, dal Fmi alla Bm all’Onu.
Il potere capitalistico, che si va riassestando in quei nuovi rapporti di proprietà, è in larga parte rappresentato, nella misura in cui tali protagonisti sappiano spaziare nella “meteorologia” monetaria, dai cosiddetti
investitori istituzionali finanziari, non appartenenti al settore bancario in senso proprio: costoro coprono
ormai il 60% delle transazioni sui mercati finanziari internazionali. Tale circostanza spiega compiutamente
perché oggi le manovre speculative sui titoli e sulle valute, effettuate in tempo reale nelle diverse borse del
mondo, sfuggano al controllo anche delle banche centrali e, a maggior ragione, degli organi statuali e
governativi in loro assoluta balìa. In una siffatta gerarchia mondiale, in cui le banche centrali - con diverso
rango di importanza - ormai “divorziate” dai rispettivi governi nazionali, funzionano espressamente come
&%PAGINA&
“terminali” della Bm e del Fmi, si inquadra adeguatamente il ruolo di questi ultimi organismi sovranazionali
soltanto concependoli, per quello che sono: ossia, sedi di compensazione e attuazione “tecnica” della
strategia autocontraddittoria e conflittuale dell’imperialismo transnazionale - con buona pace di quei politici
ed economisti “illuminati” che dissertano ancora sui princìpî ideali astratti della democrazia e dell’autonomia
delle istituzioni borghesi, nazionali internazionali e sovranazionali.
Conclusione
Quanto esposto risponde a quei “disegni degli astuti politici affaristi che, controllando la stampa, la
scuola, e se necessario la chiesa, impongono l’imperialismo alle masse nella forma attraente di un
patriottismo sensazionale”, di cui del resto scriveva Hobson, già quasi un secolo fa. Nella mistura sociale che
coartava le masse al consenso, necessario per la vitale interpenetrazione del militarismo nell’economia, si
andò consolidando negli anni ‘30 la prospettiva storica del moderno corporativismo. Oggi il
neocorporativismo rappresenta la tendenza dominante nel nuovo ordine mondiale - come il ricordato “piano
Kissinger” ha disegnato. Di contro a un declino generale e inesorabile del processo di accumulazione,
l’unica risposta provvisoriamente data è stata proprio la tendenza accentratrice dei capitali esistenti,
congiuntamente con la ripresa di assoluto comando sul lavoro. Ed è nella logica dell’imperialismo che tale
processo si traduca inevitabilmente anche in un accentramento sempre più dispotico e violento del potere
politico - dal piano sociale a quello militare.
Gli elementi qui sommariamente riportati possono forse bastare per comprendere adeguatamente la storia
e l’opera cinquantennale del Fmi, inquadrandole nel contesto epocale della fase transnazionale del capitalismo, senza rischiare di isolarle in una descrizione meramente cronachistica, magari oscillante tra esposizione
tecnica ed eventuale denuncia moralistica. Ma già ancora prima dell’epoca dell’imperialismo, Marx,
trattando nel Capitale del sistema creditizio, vide chiaramente i caratteri di fondo delle tendenze a venire.
“Che cosa vuol dire l’accentramento! Il sistema creditizio che ha come centro le pretese banche nazionali e i
potenti prestatori di denaro, e gli usurai che pullulano attorno a essi, rappresenta un accentramento enorme e
assicura a questa classe di parassiti una forza favolosa, tale non solo da decimare periodicamente i capitalisti
industriali, ma anche da intervenire nel modo più pericoloso nella produzione effettiva - e questa banda non
sa nulla della produzione e non ha nulla a che fare con essa. Questi rispettabili banditi - ai quali si uniscono i
finanzieri e gli speculatori di borsa - sfruttano la produzione nazionale e internazionale”.
BREVE NOTA BIBLIOGRAFICA
La maggior parte delle notizie e delle indicazioni sul Fmi e sulla Bm sono tratte dal bollettino quindicinale
Imf survey e da numerosi altri documenti ufficiali del Fmi stesso. Una ricca documentazione e ricostruzione
storica è contenuta in Michael D. Bordo - Barry Eichengreen, A retrospective on the Bretton Woods system:
lessons for international monetary reform, University of Chicago, 1991. Notizie storiche dirette, e commenti,
si trovano in John M. Keynes, Collected writings: works and correspondence, McMillan, London 1971-79.
I riferimenti classici rimandano a Karl Marx, Il Capitale (in particolare vol.III, sez.V), e Henryk
Grossmann, La legge dell’accumulazione e del crollo del sistema capitalistico [1929] (tr.it., Jaca Book,
Bologna 1977). Per una più dettagliata documentazione sull’ascesa e il declino dell’imperialismo Usa si
rimanda a Berch Berberoglu, L’eredità dell’impero: declino economico e polarizzazione di classe negli Stati
Uniti, Vangelista, Milano 1995, e Victor Perlo, Super profits and crises: modern U.S. capitalism,
International, New York 1988.
&%PAGINA&
DOCUMENTAZIONE 1
Il funzionamento del Fmi
Storia
Dal 1° al 22 luglio 1944, a Bretton Woods nel New Hampshire (Usa), fu formulato l’accordo sul sistema
monetario e finanziario internazionale, con la stesura degli articoli costitutivi del Fondo monetario internazionale [Fmi, ovvero secondo le iniziali inglesi Imf] e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo
sviluppo [Birs, ovvero Ibrd] meglio nota come Banca mondiale [Bm, ovvero Wb]. Gli articoli dell’accordo
furono approvati il 27 dicembre 1945 da 29 governi, traducendo così l’amara lezione della depressione
seguìta dalla seconda guerra mondiale in un sistema monetario internazionale stabile e cooperativo. La
Germania e il Giappone entrarono a far parte del Fmi il 14 agosto 1952.
Il Fmi ha portato i princìpî di Bretton Woods, affrontando situazioni di crisi, a sostenere eventi tali che i
promotori non si sarebbero mai immaginato. Il 15 agosto 1971 il governo degli Usa informò il Fmi della
decisione di dichiarare l’inconvertibilità del dollaro in oro per i pagamenti internazionali: con la fine della
convertibilità del dollaro e del regime di parità fisse dei cambi valutari caddero due caratteristiche
fondamentali del sistema di Bretton Woods. Il 18 dicembre dello stesso anno [accordi detti “Smithsonian”,
dal nome dell’Istituto in cui avvenne l’incontro] fu stabilito il “riallineamento” delle valute dei paesi
industriali, con una “fluttuazione generalizzata” che si affermò a partire dal 19 marzo 1973 allorché la Cee
introdusse un proprio sistema monetario europeo di fluttuazioni congiunte rispetto al dollaro.
Nel frattempo, il 26 luglio 1972, la massima autorità del Fmi aveva nominato una commissione per la
riforma del sistema monetario internazionale, che concluse i suoi lavori il 13 giugno 1974, indicando alcune
linee generali per passare a un sistema di cambi fluttuanti. Il 1° aprile 1978 il secondo emendamento agli
accordi del 1944 consentì agli stati membri di adottare un sistema di cambi liberi. Il 30 aprile 1978 il Fmi
stabilì una strategia coordinata per promuovere lo sviluppo economico, e il 25 aprile 1980 decise di ampliare
il proprio ruolo in materia di aggiustamento e finanziamento degli squilibri delle bilance dei pagamenti degli
stati membri, fornendo assistenza per periodi più lunghi e per importi maggiori di quanto fino ad allora
stabilito. Il 22 febbraio 1987 (accordo del “Louvre”, tra i sei più importanti paesi industriali) fu stabilito un
maggiore coordinamento delle politiche economiche.
Dopo i cambiamenti che il mondo ha visto in cinquant’anni, gli obiettivi del Fmi sono rimasti al centro
della dinamica internazionale: promuovere la cooperazione monetaria internazionale; facilitare l’espansione
equilibrata del commercio internazionale; promuovere la stabilità del sistema dei cambi; assistere la
formazione di un sistema di pagamenti multilaterali; dare fiducia agli stati membri mettendo a loro
disposizione le risorse esistenti; ridurre la durata e l’intensità degli squilibri delle bilance dei pagamenti. Alla
luce dei recenti eventi sono stati indicati cinque prerequisiti per uno “sviluppo sostenibile di alta qualità”:
- quadro macroeconomico solido e stabile, con regime fiscale disciplinato, politica monetaria antinflazionistica e anticiclica, tassi di interesse e di cambio realistici;
- politiche strutturali capaci di contrastare bassi tassi di risparmio e investimento e di incoraggiare un
vigoroso settore privato;
- liberalizzazione del commercio e del corso dei cambi;
- politiche sociali come ammortizzatori degli aggiustamenti economici;
- buon governo.
Il ruolo fondamentale attribuito a forti politiche macroeconomiche, tese a garantire risultati a lungo termine delle riforme strutturali per raggiungere uno “sviluppo sostenibile”, è stato di recente esteso dai paesi in
via di sviluppo alle economie in “transizione” verso il libero mercato, il cui còmpito di portata storica merita
il sostegno pieno e concertato della comunità internazionale. D’altra parte, bassi tassi di inflazione nei paesi
industrializzati sono richiesti dalla strategia di sviluppo. Il Fmi mette rapidamente in moto la sua assistenza
finanziaria e tecnica per quei paesi che, nelle circostanze proprie a ognuno di essi, seguano un’adeguata
strategia in termini fiscali, salariali, monetari e strutturali. Ciononostante, povertà e basso sviluppo persistono
nei paesi meno sviluppati.
1
Si riportano qui stralci dei documenti ufficiali del Fmi pubblicati o ripubblicati in occasione del cinquantenario degli accordi di
Bretton Woods, e del successivo dibattito: essi illustrano le circostanze in cui si è giunti alla costituzione di questi organismi
sovranazionali e definiscono le norme del loro funzionamento nel corso degli anni. Mentre la successione delle parti del testo, qui
riprodotto e liberamente montato, è esclusivamente redazionale, le diverse parti stesse sono tutte pienamente corrispondenti alle fonti.
&%PAGINA&
Turbolenze nel corso dei cambi tra le principali valute provocano rapidi spostamenti nei mercati internazionali dei capitali, come nel caso dell’inversione del flusso dei capitali con il Messico. Il sostegno senza
precedenti fornito al Messico nel febbraio 1995 - 30 mmrd di lire, il maggiore finanziamento mai concesso
dal Fmi, seguìto dagli 11 mmrd stanziati per la Russia nell’aprile dello stesso anno - è stato teso a limitare
speculazioni ed effetti di “contagio”. In séguito a tale esperienza, gli organismi del Fmi hanno formulato
ulteriori raccomandazioni: un confronto più stretto e continuo tra il Fondo e i suoi membri, per una
descrizione più sincera dei rischi connessi ad alcune politiche; una più regolare acquisizione di dati
economici dei paesi membri e un miglior uso da parte del Fondo dei dati relativi al mercato finanziario;
pubblicazione periodica ed esauriente dei dati, rilevati con criteri omogenei; maggior attenzione all’attività di
sorveglianza del Fmi sulla solidità delle politiche finanziarie degli stati membri, con particolare cognizione
dei rischi relativi alla facile inversione dei flussi di capitale.
Organizzazione
La struttura organizzativa del Fmi è stabilita nell’articolato dell’accordo approvato nel dicembre 1945
(con tre emendamenti apportati successivamente). Essa prevede un Consiglio dei Governatori, un Comitato
esecutivo, un Direttore generale con un ufficio internazionale di funzionari e impiegati. Una prevista
struttura indicata come organo di “governo” permanente del Fmi non è stata mai formata, e al suo posto,
dall’ottobre 1974, funziona una Commissione interinale, oltre ad una Commissione per lo sviluppo.
Entrambe queste commissioni sono attualmente composte da 24 governatori o ministri delle finanze e si
riuniscono due volte l’anno.
Esistono poi, a fianco di questi organismi ufficiali fissi, strutture decisionali più o meno informali e occasionali, ciascuna delle quali normalmente chiamata Gruppo [G.] seguìto da un numero corrispondente al
numero dei paesi che ne fanno parte. [Il meno formale, e che non si riunisce mai ufficialmente, è il G.3
costituito dai tre più forti stati del mondo: Usa, Giappone, Germania]. Il primo livello riconosciuto è il G.5,
formato dagli stati membri le cui valute costituiscono ora la base di calcolo dell’unità di conto del Fmi, i
Diritti speciali di prelievo [Dsp, ovvero Sdr] (si veda appresso): ossia, G.3 più Francia e Regno Unito. Poi, il
più noto attualmente, a partire dal 1987, è il G.7 che consiste dei sette paesi attualmente più industrializzati:
ossia, G.5 più Italia e Canada, rappresentati a livello di capi di governo. Il G.10 fu formato nel 1962 da quei
paesi che avrebbero in séguito costituito il G.7, più Belgio, Olanda e Svezia, ai quali era aggregata anche la
Svizzera (come undicesimo stato allora ancora non membro del Fmi, e poi integrata dopo l’adesione nel
1992), per la gestione dell’accordo generale sui prestiti, Gab (si veda appresso), e delle risorse finanziarie
messe a disposizione dei partecipanti 2. Dal gruppo dei 77 paesi in via di sviluppo riuniti a Lima nel 1972 fu
creata una struttura intergovernativa elettiva, il G.24, composto appunto da 24 rappresentanti di tali paesi, 8
per ciascuna area: Africa, Asia, America latina.
La massima autorità del Fmi è rappresentata dal Consiglio dei governatori, è costituita da un governatore
e un vice-governatore (normalmente ministri delle finanze, governatori delle banche centrali o cariche
equivalenti) nominati da ogni stato membro, e di norma si riunisce una volta l’anno. La riunione inaugurale
del Consiglio dei Governatori si tenne dall’8 al 18 marzo 1946 a Savannah, Georgia (Usa), nel corso della
quale fu stabilito che gli uffici centrali del Fmi fossero aperti a Washington. Il 1° marzo 1947 il Fmi iniziò a
operare effettivamente.
Il Consiglio dei governatori ha delegato la maggior parte delle proprie funzioni al Comitato esecutivo,
che è perciò l’organo decisionale permanente del Fmi, con sede nell’ufficio centrale di Washington. Quest’ultimo, in rappresentanza dei 179 paesi [per un totale delle quote, espresse in Dsp (si veda appresso), pari
a 144,9 mrd], è composto da 24 direttori esecutivi nominati dagli stati membri o eletti da gruppi di stati
membri, e il cui voto pesa in proporzione alle quote versate. I suoi còmpiti riguardano la sorveglianza delle
politiche di cambio, l’assistenza finanziaria e la consultazione periodica degli stati membri. Esso elegge
anche il direttore generale del Fmi: dal 1946 a oggi i direttori generali sono stati un belga, due svedesi, un
olandese e tre francesi.3
2
Può
3
rappresentare una curiosità la notizia che segretario di questo gruppo è stato per lunghissimo tempo Lamberto Dini.
Qui di seguito sono elencate la provenienza dei 24 direttori e le quote al 1° settembre 1995 [in % sul totale delle quote dei
partecipanti, in Dsp, che assommano ora al 99,04%], che ciascuno di essi esprime per i paesi che rappresenta. Essi sono: uno
ciascuno in rappresentanza diretta dei 5 paesi principali, Usa [17,83], Germania [5,55], Giappone [5,55], Francia [5] e Gran Bretagna
[5]; più, da soli, i 3 rappresentanti di Arabia Saudita [3,46], Russia [2,91] e Cina [2,29]; e altri 16 in rappresentanza di aree
macroregionali, provenienti, attualmente, da Belgio (per Austria, Bielorussia, Rep.Ceca, Kazakistan, Lussemburgo, Slovacchia,
Slovenia, Turchia, Ungheria) [5,10], Olanda (per Armenia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Georgia, Israele, Macedonia, Moldavia,
Romania, Ukraina) [4,89], Venezuela (per Costarica, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Salvador, Spagna) [4,32], Italia (per
Albania, Grecia, Malta, Portogallo, San Marino) [4,03], Canada (Antigua, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica,
Grenada, Irlanda, San Kitts, Santa Lucia, San Vincent) [3,73], Norvegia (per Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia,
Lituania, Svezia) [3,48], Australia (per Corea, Filippine, Kiribati, Marshall, Micronesia, Mongolia, Nuova Guinea, Nuova Zelanda,
Samoa, Seychelles, Solomon, Vanuatu) [3,30], Egitto (per Bahrain, Emirati arabi, Giordania, Irak, Kuwait, Libano, Libia, Maldive,
Oman, Qatar, Siria, Yemen) [3,20], Indonesia (per Cambogia, Fiji, Laos, Malesia, Myanmar, Nepal, Singapore, Tailandia, Tonga,
&%PAGINA&
Il 29 settembre 1967 il consiglio dei governatori istituì i diritti speciali di prelievo [Dsp, o Sdr], che il 28
luglio 1969, in séguito al primo emendamento dell’articolato originario dell’accordo, furono presi come base
per le condizioni di finanziamento e, a partire dal 1° gennaio 1970, per la sottoscrizione delle quote. Il 13
giugno 1974 fu stabilita una nuova base di calcolo dei Dsp ancorata a 16 monete principali. Il 17 settembre
1980 fu decisa la semplificazione della base di calcolo dei Dsp (che entrò in vigore il 1° gennaio 1981),
ancorandola alle sole 5 principali monete: dollaro Usa, marco tedesco, yen giapponese, franco francese e
sterlina inglese. I Dsp rappresentano l’unità di conto del Fmi e di altre organizzazioni internazionali,
attualmente 15, perlopiù banche continentali o macroregionali. Il valore dei Dsp è determinato correntemente
sulla base delle quotazioni delle cinque monete che ne costituiscono la media ponderata 4.
La ponderazione di tale media è rivista periodicamente per rispecchiare le variazioni dell’importanza
relativa delle valute che la costituiscono, nella finanza e nel commercio internazionale. Il 1° gennaio 1986 fu
rivisto il peso delle diverse monete, aumentando quello dello yen e diminuendo quello di franco e sterlina;
un’ulteriore variazione fu apportata il 1° gennaio 1991, aumentando il peso di marco e yen a scapito delle
altre tre valute. Anche il tasso di interesse relativo ai Dsp è calcolato come media ponderata dei rendimenti
dei buoni del tesoro a tre mesi emessi dai cinque paesi. Il Fmi può indicare quali stati membri possano
fornire valuta in cambio di Dsp, sulla base della forza delle loro bilance dei pagamenti e delle loro riserve.
L’uso dei Dsp tra stati membri e Fmi consiste nel loro trasferimento reciproco per pagamenti e
finanziamenti. Gli stati membri possono impiegare i Dsp anche per diversi trasferimenti volontari.
Ultimamente è stato considerato un possibile ruolo futuro più rilevante da attribuire ai Dsp.
Attualmente ciascuno stato membro del Fmi ha una quota - espressa in Dsp, e pagata per il 25% in Dsp o
in valute di altri paesi, indicate dal Fmi - che riflette la sua relativa forza economica. Al 30 aprile 1995 gli
stati membri detenevano il 2,6% delle proprie riserve valutarie (non auree) in Dsp. La quota in Dsp
determina il potere di voto di ogni stato membro, sulla base di un voto per ogni 100 mila Dsp di tale quota
più una base fissa di 250 voti ciascuno. In funzione della quota è determinato anche il massimo livello di
accesso ai finanziamenti concessi. Il 5 ottobre 1991 l’Urss firmò con il Fmi un accordo per l’assistenza
tecnica; nel maggio 1992 il comitato esecutivo approvò l’adesione di molti stati nati dalla dissoluzione
dell’Urss. Il 29 maggio 1992 aderì anche la Svizzera.
Le quote dei membri originari del Fmi, fino agli inizi degli anni ‘60, erano determinate sulla base della
cosiddetta formula di Bretton Woods, che considerava i flussi di esportazione e importazione, le riserve in
oro e in dollari, e il reddito nazionale. Dal 1963 furono considerati, parallelamente, indicatori sulle
transazioni e sulle entrate di parte corrente, al posto dei dati su esportazioni e importazioni. Agli inizi degli
anni ‘80 i criteri di calcolo delle quote furono ulteriormente rivisti e semplificati: i dati sul Pnl (prodotto
nazionale lordo) sostituirono quelli sul reddito nazionale, furono seguiti criteri più ampi per la valutazione
delle riserve ufficiali e i dati sulle transazioni di parte corrente sostituirono definitivamente quelli su
esportazioni e importazioni.
Per tener conto della crescita dell’economia mondiale e delle variazioni nelle posizioni relative occupate
dagli stati membri, ogni cinque anni si provvede a una revisione delle quote. Il 28 giugno 1990, con la nona
revisione generale delle quote, fu elevata la disponibilità totale del Fmi da 90,1 a 135,2 md di Dsp, fino a
raggiungere il rammentato livello di 144,9 md di Dsp, il 1° agosto 1994. Si stabilì allora anche che nessuna
modifica potesse essere approvata con una maggioranza inferiore all’85% dei voti (fino al 30 dicembre 1991)
e al 70% in séguito. La decima revisione delle quote, dicembre 1995, si è conclusa senza alcun aumento delle
quote stesse.
La struttura finanziaria del Fmi è basata sul principio che la sottoscrizione delle quote rimane la fonte
principale di finanziamento; tuttavia l’ottenimento di prestiti, prima da parte dei paesi esportatori di petrolio
(1974), poi da organismi ufficiali quali la Banca dei regolamenti internazionali [Bri, ovvero Bis] e le banche
centrali di stati membri (1987), ha rappresentato un’importante integrazione temporanea alle disponibilità del
Fmi stesso, che a partire dal 1962 aveva formulato l’accordo generale sul prestito [Gab]. L’accordo è stato
rivisto e rinnovato più volte. Di fronte alla “crisi del debito”, il 30 dicembre 1983 il G.10 ne decise la
revisione, allargò le linee di credito combinato e introdusse la possibilità del ricorso all’accordo anche ai non
partecipanti, avendo già esteso l’accordo stesso all’agenzia monetaria dell’Arabia saudita [Sama], fino a tutto
Vietnam) [2,80], Svizzera (per Azerbaijan, Kirghizistan, Polonia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekhistan) [2,77], Iran (per
Afghanistan, Algeria, Ghana, Marocco, Pakistan, Tunisia) [2,66], Brasile (per Colombia, Ecuador, Guyana, Haiti, Panama, Santo
Domingo, Suriname, Trinidad) [2,64], India (per Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka) [2,59], Swaziland (per Angola, Botswana, Burundi,
Eritrea, Etiopia, Gambia, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Sierra Leone, Tanzania, Uganda, Zambia,
Zimbabwe) [2,45], Perù (per Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay, Uruguay) [2,15] e Costa d'Avorio, (per Benin, Burkina Faso,
Camerun, Capo Verde, Centro Africa, Ciad, Comore, Gabon, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Guinea equatoriale, Madagascar,
Mauritania, Mauritius, Nigeria, Ruanda, Sao Tomè, Senegal, Togo) [1,34]. Al 1° settembre 1995 Somalia e Sudafrica non avevano
ancora partecipato regolarmente, mentre i diritti di voto di Sudan e Zaire sono sospesi. L'attuale direttore generale, dal 1987, è il
francese Michel Camdessus.
4
Per avere un'idea sommaria, la base media si può pensare composta con un rapporto di 4 dollari, a 2 yen e marchi, a 1 franco
francese e sterlina, rispettivamente; con qualche approssimazione (per difetto di decimali) 38% di dollari, 22% di yen, 20% di
marchi, 10% di franchi e 8% sterline; ovviamente il peso effettivo varia con l'andamento del corso dei cambi di tali valute; il 28
agosto 1995 un Dsp valeva 1,495 dollari Usa, qualcosa come 2400 lire italiane.
&%PAGINA&
il 1998. Per i non partecipanti i prestiti sono condizionati ai programmi di aggiustamento sostenuti dal Fmi,
per fronteggiare le situazioni eccezionali delle bilance dei pagamenti che potrebbero minacciare la stabilità
del sistema monetario internazionale. Attualmente il credito potenziale elargibile dal Gab è di circa 45 mmd
di lire. Ma già il G.7, nel vertice di Halifax del giugno 1995, ha richiesto al più presto il raddoppio della
dotazione. Anche un’ulteriore revisione delle procedure è stata considerata, al fine di avere più rapide
risposte per il meccanismo di finanziamento.
Sorveglianza
In base all’articolo IV dell’accordo costitutivo i funzionari del Fmi si incontrano regolarmente, ogni anno,
con i rappresentanti dei governi di ciascuno degli stati membri per analizzarne le politiche economiche e i
loro sviluppi, esaminarne le politiche monetarie, valutarie e fiscali e l’andamento delle bilance dei
pagamenti, dando anche rilievo alle implicazioni internazionali di tali politiche. In particolare, per imporre
princìpî guida sulle politiche di cambio degli stati membri, esercitano una stretta sorveglianza su di esse,
analizzando tutti gli aspetti delle politiche macroeconomiche e strutturali, in quanto queste ultime nel loro
insieme hanno importanti ricadute sul corso dei cambi.
Col passare degli anni la portata di tali interventi si è estesa, avendo riguardo agli effetti a medio termine
e alle riforme strutturali. Hanno assunto maggior rilievo le tematiche interstatuali e macroregionali, relative
alle conseguenze macroeconomiche e strutturali sullo sviluppo e sul benessere di ciascun paese, in quanto tali conseguenze possono significativamente incidere sulla credibilità e sulla sostenibilità di tali politiche.
Negli anni più recenti la sorveglianza del Fmi ha tenuto conto sempre più di questioni sociali quali la
povertà, e di problemi industriali, occupazionali e ambientali.
Il Fmi incoraggia i diversi paesi ad adottare politiche economiche adeguate al rispetto degli impegni presi,
per sostenere uno sviluppo economico non inflazionistico. Rientra in questo quadro l’attenzione data ai
profondi mutamenti intervenuti nell’economia mondiale, col rapido sviluppo e l’internazionalizzazione dei
mercati dei capitali privati, la maggiore vulnerabilità del sistema monetario internazionale rispetto agli
squilibri macroeconomici tra diversi paesi, i rilevanti spostamenti verso l’integrazione monetaria e
macroregionale (inclusa l’Unione europea), le tendenze neoliberiste e di riforma verso l’economia di
mercato.
Discussioni multilaterali hanno luogo, due volte l’anno, nell’ambito delle prospettive sull’economia
mondiale. Tali prospettive [World economic outlook - Weo] forniscono al comitato esecutivo un quadro di
riferimento per analizzare le politiche degli stati membri da un punto di vista multilaterale, relativamente a
problemi del commercio internazionale, del mercato del lavoro e della disoccupazione, e della
stabilizzazione delle riforme nei paesi in “transizione” verso l’economia di mercato. È in quest’ottica che
anche il direttore generale del Fmi partecipa agli incontri intergovernativi del G.7. Il comitato esecutivo
considera sia il percorso di aggiustamento seguìto dagli stati membri, sia la coerenza del programma da
esso messo in atto per riequilibrare le sottostanti politiche macroeconomiche. In forza dell’articolo V degli
accordi di Bretton Woods, procedure di sorveglianza intensificata sono utilizzate per assicurare un sostegno
finanziario esterno.
Ogni due anni il Fmi rivede i princìpî e le procedure, stabilite nel 1977, che guidano la sua sorveglianza.
L’ultima revisione, dell’aprile 1995, ha posto particolare attenzione sull’accresciuta estensione mondiale del
mercato di capitali, sulla maggiore mobilità alle frontiere dei flussi di capitale e sulla capacità del Fondo di
individuare sul nascere le tensioni finanziarie (la cui necessità è stata sollecitata dal recente caso del
Messico). Per migliorare la sorveglianza relativa ad aree macroregionali, i direttori esecutivi hanno
concordato di tenere discussioni annuali sui rapporti delle unioni economiche e valutarie.
Nell’aprile 1995, dopo l’esperienza messicana, si è rilevato che i ritardi nel reperimento dei dati fondamentali da parte del Fondo hanno rappresentato elementi chiave per la crisi. Cosicché nel luglio 1995, il
comitato ha riesaminato i dati per la sorveglianza forniti dagli stati membri, decidendo per l’indicazione di
undici categorie di dati da considerare come centrali, e stabilendo norme comuni per la pubblicazione dei
dati nazionali. È stata data maggior rilevanza alla convertibilità in conto capitale negli stati membri e rispetto
alle emissioni del Fmi. Oltre alle consultazioni previste dall’articolo IV, gli stati membri hanno considerato
accordi precauzionali (per suscitare maggior fiducia nelle politiche di finanziamento da parte del Fondo),
indagini informali (per stabilire compiti e norme sulla base di programmi “ombra”), e una sorveglianza
intensificata (per facilitare rinegoziazione dei debiti con banche private).
La richiesta esplicita, rivolta agli stati membri, di attuare un particolare insieme di politiche economiche è
definita come “stato condizionale”: l’utilizzazione delle risorse del Fmi è subordinata al ripristino dell’equilibrio della bilancia dei pagamenti e al raggiungimento di uno sviluppo economico sostenibile, che siano
compatibili con le prospettive di sviluppo e con la possibilità di ottemperare al pagamento del servizio del
&%PAGINA&
debito, senza ricorrere a restrizioni sul commercio e sui pagamenti correnti, come impone il rispetto dell’articolo VIII degli accordi di Bretton Woods.
Nel 1979, il comitato esecutivo adottò le seguenti linee guida relative al suddetto “stato condizionale”:
incoraggiare gli stati membri ad adottare tempestivamente le misure correttive; seguirne attentamente gli
obiettivi sociali e politici e le priorità economiche; permettere una certa flessibilità nel numero e nel
contenuto degli obiettivi; sottolineare che l’assistenza finanziaria del Fmi non è frutto di accordi contrattuali
ma è una decisione unilaterale del Fmi stesso.
I programmi di intervento del Fmi hanno come riferimento alcuni aggregati economici quali il credito
interno, il disavanzo pubblico, le riserve internazionali e il debito estero. Considerano inoltre l’andamento
dei prezzi - delle merci, del tasso di interesse e dei cambi - poiché essi incidono significativamente sia sulle
finanze pubbliche e sul commercio internazionale del paese, sia sulla sua capacità di offerta. I tassi di
interesse e di cambio sono particolarmente importanti poiché essi incidono sulle decisioni di risparmio e di
investimento e, di conseguenza, sulle prospettive di sviluppo del paese. Nel corso dell’assistenza finanziaria
data, il Fmi controlla il programma di riforme del paese interessato, rimuovendo le distorsioni che ostacolano
lo sviluppo delle esportazioni e favorendo l’efficienza della spesa pubblica.
Per gli aspetti strutturali dei programmi di sviluppo sostenuti dal Fmi è particolarmente importante la
stretta collaborazione con la Bm. I cosiddetti programmi di “aggiustamento” sono tali da avere conseguenze
rilevanti sulla distribuzione del reddito, l’occupazione e i servizi sociali. Per promuovere sviluppo e
occupazione sostenuti nel tempo, si hanno nel breve periodo costi sociali a carico dei gruppi più deboli. Per
questi ultimi, al fine di ovviare alle conseguenze negative dovute alle misure di riforme strutturali, il Fmi in
collaborazione con la Bm studia come provvedere a forme di assistenza sociale e al loro finanziamento entro
i programmi stessi.
L’assistenza tecnica può aiutare efficacemente, assecondandolo, un paese impegnato in un processo di
aggiustamento e riforma a compiere il “salto iniziale”. Il Fmi tradizionalmente fornisce tale assistenza, attraverso i suoi dipartimenti, in aree fondamentali quali quelle riguardanti la politica monetaria, fiscale e del
debito pubblico, la strutturazione delle banche centrali e del mercato dei cambi, la riforma del commercio
internazionale, la documentazione statistica e l’informatizzazione, la formazione di funzionari e la revisione
della legislazione. Dal 1989 il Fmi coordina la sua assistenza tecnica cooperando con altri organismi
sovranazionali, oltre alla Bm, quali il programma di sviluppo dell’Onu [Undp], l’organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico [Ocse, ovvero Oecd], la commissione per l’assistenza allo sviluppo e
l’agenzia per lo sviluppo internazionale [Ida], e la Bri quale area di coordinamento delle banche centrali.
Seminari specificamente organizzati a tal fine sono stati promossi insieme al Giappone e all’Unione europea.
Finanziamenti agevolati
Le risorse finanziarie del Fmi sono messe a disposizione degli stati membri, conformemente alla loro
specifica situazione, attraverso una serie di agevolazioni. Gli stati membri ottengono i fondi acquistando
valute di altri paesi o Dsp; per la restituzione ripagano tali fondi riacquistando successivamente le loro
proprie monete, in un arco di tempo prestabilito.
Ogni paese membro può avere una posizione di riserva qualora la sua quota ecceda la quantità della
propria moneta detenuta dal Fmi; può ottenere una normale apertura di credito, fino al 25% della propria
quota, per affrontare momentanee difficoltà della bilancia dei pagamenti, purché dimostri la credibilità degli
sforzi compiuti per risolvere la questione. Livelli superiori di credito sono collegati a programmi concordati.
I cosiddetti accordi di attesa [stand-by] dànno diritto a prelevare, su base trimestrale, un determinato
ammontare nell’arco di un tempo stabilito; il programma concordato si riferisce al controllo della politica
creditizia, del debito pubblico, dei vincoli sui pagamenti e del commercio internazionale, e sul livello delle
riserve. Gli accordi di attesa coprono usualmente un periodo massimo di 18 mesi; la restituzione deve
avvenire entro 5 anni. I finanziamenti agevolati estesi [Eef] sono intesi a coprire difficoltà della bilancia dei
pagamenti dovute a problemi strutturali, e dunque richiedenti un periodo più lungo di “aggiustamento”. Tali
finanziamenti coprono generalmente periodi di 3 anni; la restituzione può avvenire in un massimo di 10 anni.
Tra le agevolazioni speciali è stato creato nell’aprile 1993 il finanziamento per le trasformazioni di sistema [Stf], per affrontare quelle necessità delle economie in “transizione” verso il commercio multilaterale,
basato su prezzi di mercato: difficoltà, cioè, che derivino dalla repentina rottura dei loro tradizionali
precedenti sistemi di commercio e pagamento, tali da provocare un crollo improvviso delle entrate da
esportazioni, un aumento permanente nei costi di importazione, con particolare riferimento ai prodotti
energetici. Questo tipo di finanziamento è fornito in due rate ciascuna pari, al massimo, al 25% della quota
del paese interessato; le modalità di restituzione sono le stesse previste per i finanziamenti agevolati estesi.
Il finanziamento agevolato per compensazione e contingenza [Ccff], che sostituì nell’agosto del 1988 i
“finanziamenti compensativi” introdotti nel febbraio 1963, intende compensare gli stati membri che abbiano
&%PAGINA&
perdite temporanee nelle entrate per esportazioni e nelle rimesse per servizî o aumenti temporanei di costi
per l’importazione di cereali. Con tale tipo di finanziamento si coprono gli scostamenti sfavorevoli dovuti a
variabili altamente volatili, quali i prezzi internazionali all’esportazione e all’importazione e i tassi di
interesse internazionali. Sono inoltre previste altre forme particolari di assistenza, tra cui una di emergenza
per quelle necessità della bilancia dei pagamenti dovute a improvvisi e imprevedibili disastri naturali.
Nel marzo 1986 fu introdotto un tipo di agevolazione particolare - ma in forma di concessione di prestiti denominata finanziamento per aggiustamento strutturale [Saf], per sostenere appunto politiche di “aggiustamento” macroeconomico a medio termine e di riforme strutturali. L’obiettivo consisteva nel promuovere uno
“sviluppo sostenibile”, rafforzare la bilancia dei pagamenti, mettere ordine ai rapporti con i creditori e ridurre
le restrizioni al commercio e ai pagamenti internazionali. Ma fin dal dicembre 1987, perfezionando poi la
decisione nel febbraio 1994, il comitato esecutivo sostituì il Saf con il finanziamento per aggiustamento
strutturale avanzato [Esaf]; quest’ultimo è diventato il principale strumento finanziario con il quale il Fmi
fornisce, sempre in forma di concessione di prestito, agli stati membri a basso reddito e in via di sviluppo, il
proprio sostegno per programmi di forte aggiustamento strutturale a medio termine. I paesi richiedenti
devono predisporre, con l’assistenza del Fmi e della Bm, un quadro politico di riferimento per un programma
di aggiustamento triennale, indicando le priorità macroeconomiche e le misure politiche che intendono
adottare. La collaborazione Bm-Fmi rafforza l’indicazione delle principali fonti di finanziamento esterno e di
assistenza tecnica al programma, che viene aggiornato ogni anno. I prestiti Esaf sono rimborsati in rate
semestrali, al massimo entro 10 anni, al tasso di interesse dello 0,5% annuo.
Debito estero
Il 13 agosto 1982 il Fmi iniziò a sostenere i principali programmi di aggiustamento dei paesi in difficoltà
per il debito estero; il 2 dicembre 1985 il Fmi e la Bm dichiararono il loro appoggio al “piano Baker” (proposto dal segretario di stato Usa per la gestione del debito estero); il 4 aprile 1989 furono adottate iniziative
sulla base del “piano Brady” (proposto dal ministro del tesoro Usa). Il 23 maggio 1989 il comitato esecutivo
affrontò la questione del debito estero dei paesi in via di sviluppo, subordinando le strategie per la riduzione
del debito stesso a forti “programmi di aggiustamento” a medio termine e di riforme strutturali.
La strategia del Fmi sui problemi del debito estero mira ad assicurare che i paesi debitori raggiungano uno
“sviluppo sostenibile” con una bilancia dei pagamenti affidabile, stabilendo relazioni normali con i creditori,
compreso il regolare accesso ai mercati finanziari internazionali. La strategia di fondo continua a riguardare
l’aggiustamento e le riforme strutturali rivolte allo sviluppo, la definizione di condizioni economiche
generali favorevoli, il sostegno finanziario da parte degli organismi internazionali e dei privati.
Mentre continuano a crescere i finanziamenti privati che spontaneamente fluiscono verso quei paesi che si
stanno sviluppando economicamente con successo, per la maggior parte dei paesi più poveri e indebitati le
prospettive di ottenere finanziamenti privati appare ancora remota, dovendosi questi ancora pesantemente
affidare alle fonti ufficiali. Per questi ultimi si pone il problema della riduzione del debito e del servizio del
debito (interessi passivi), anche rispetto alle banche private.
Il Fmi continua a sostenere codeste operazioni di riduzione del debito e del servizio del debito, mirando a
rafforzare le politiche economiche degli stati membri tese a riguadagnare l’accesso ai mercati del credito. A
tal fine il Fmi esamina la coerenza dei programmi di riduzione con le capacità economiche di medio termine
del paese in questione, valutandone la sostenibilità dei costi, la praticabilità in termini di possibili alternative
e la possibilità che esso fornisca basi valide per un ripristino del finanziamento spontaneo. Il Fmi collabora
significativamente con il cosiddetto Club di Parigi per la ridefinizione dei programmi economici rivolti ad
alleviare le posizioni debitorie bilaterali ufficiali.
Il Fmi, per far fronte al pagamento di posizioni arretrate nei suoi confronti, ha messo in atto una strategia
“cooperativa” di programmi di controllo delle politiche seguite da parte degli stati membri debitori. In particolare, un programma detto di accumulazione di diritti consente al paese interessato di “incassare” quanto
per esso accantonato, normalmente al termine di tre anni, qualora abbia completato con successo il
programma stesso di rientro e di pagamento degli arretrati. Col terzo emendamento all’articolato di Bretton
Woods, votato l’8 maggio 1990, fu decisa la sospensione del diritto di voto e di partecipazione di quegli stati
membri che non avessero rispettato gli impegni assunti.
&%PAGINA&
Indice
Introduzione
Gli accordi di Bretton Woods
La fiducia nel dollaro
Il declino Usa
La crisi dell’imperialismo
Il nuovo ordine neocorporativo
La fase del capitale transnazionale
Il nuovo ruolo delle istituzioni sovranazionali
Una svolta epocale
Conclusione
Documentazione - Il funzionamento del Fmi
Storia
Organizzazione
Sorveglianza
Finanziamenti agevolati
Debito estero
&%PAGINA&
(IV di copertina)
I fenomeni economici, che nell’era contemporanea - quella dell’imperialismo, in particolare nella sua fase
transnazionale - appaiono sempre più, al primo impatto, nella loro forma monetaria, hanno un ben diverso
fondamento. E che i fatti monetari si pongano alla ribalta delle questioni internazionali che si svolgono sul
mercato mondiale è fuor di dubbio: sia nei termini della superficiale informazione di massa, e sia pure in
quelli degli organismi sovranazionali, alla cui testa sono il Fondo monetario internazionale e la Banca
mondiale [Bm]).
Il 22 luglio 1944, con gli accordi di Bretton Woods si addivenne a una soluzione negoziata della “guerra
fraterna”, occulta e non dichiarata, ma condotta e vinta dagli Usa contro il Regno unito. Si trattava di portare
a compimento quel confronto a due - già avviato con la I guerra mondiale - che avrebbe dovuto definire il
passaggio di consegne alla guida dell’imperialismo mondiale. Gli scontri per il controllo del mercato
mondiale erano già passati per la conferenza di Teheran, fine novembre 1943 (occupazione americana
dell’Europa continentale, con esclusione della regione balcanica); l’avvio della conferenza di Bretton Woods
precedette di poco quella di Dumbarton Oaks, agosto-ottobre 1944 (varo dell’organizzazione delle “Nazioni
Unite” nella lotta contro l’asse Germania-Italia-Giappone, e cancellazione del piano Morgenthau di
smembramento agricolo della Germania, in vista della sua ricostruzione industriale), in preparazione di
Yalta, febbraio 1945 (definizione delle zone di influenza e dei “blocchi”) e dell’accordo di Potsdam, agosto
1945 (spartizione della Germania).
La pax americana, in termini di potere economico mondiale, fu posta con riferimento ai problemi di
aggiustamento finanziario, liquidità, fiducia. Sotto la parvenza di un compromesso tra le due potenze
contendenti, la soluzione emersa a Bretton Woods consolidò il processo di centralizzazione intorno al
capitale Usa. Con il controllo del mercato mondiale dei capitali preso dagli Usa, tutta la storia dell’economia
mondiale in quella fase fu determinata dall’egemonia americana.
L’epoca del pieno dominio Usa fu quella compresa tra la fine della II guerra mondiale e gli ultimi anni
sessanta: l’epoca della guerra fredda e del funzionamento originario del Fmi e degli altri organismi
sovranazionali postbellici (i loro primi venticinque anni su cinquanta), l’epoca che Victor Perlo ebbe a
definire l’”economia di guerra in tempo di pace”. Non è per caso, dunque, che le tappe e i mutamenti del
sistema di Bretton Woods coincidano con le fasi di questo periodo. La temperie della fine dello sviluppo
postbellico, col suo sistema di Bretton Woods, e dell’avvio della grande ultima crisi, si cominciò a fare
sempre più minacciosa tra il 1967 e il 1969. Da allora - sotto i colpi della crisi reale da sovraproduzione l’abbandono delle restrizioni monetarie, l’aumento del volume di moneta circolante, lo sviluppo dei mercati
valutari, rappresentarono l’avvio dell’attuazione della strategia “cartacea” del dollaro. In quelle avvisaglie di
crisi sono presenti i prodromi del crollo del vecchio ordine mondiale costruito a Bretton Woods: e costì
dunque sono pure i prodromi della crisi da cui, anche in Italia, esperti economisti si propongono di uscire. Il
quadro del declino Usa, nelle fasi dell’ultima crisi, inquadra agevolmente le mutevoli vicende del Fmi e dei
“vertici” a esso collegati.
La rinnovata funzione del Fmi e degli altri organismi sovranazionali nati a Bretton Woods, dopo i primi
venticinque anni a egemonia assoluta statunitense, è proprio tesa a organizzare tra le “nazioni” la
circolazione di un capitale ormai sempre più “senza nazione”, per la ricerca di produzione di nuovo
plusvalore. Dopo l’acme dei primi 25 anni (1944-1969), dunque, sono state proprio le difficoltà che hanno
segnato la grande crisi del monopolio di potere Usa sul mercato mondiale ad aver messo Fmi e Bm di
fronte a còmpiti per i quali non erano attrezzati. In tale quadro, in cui era posta la necessità della
trasformazione funzionale degli organismi sovranazionali nati a Bretton Woods, si sviluppò lo svolgimento
internazionale della crisi da sovraproduzione, incentrata sulla recessione che segnò proprio quel biennio
1974-75 nel quale, attraverso il cosiddetto “piano Kissinger” fu formulata la sostanza neocorporativa
planetaria della fase a venire.
Oggi il neocorporativismo rappresenta la tendenza dominante nel nuovo ordine mondiale. Di contro a un
declino generale e inesorabile del processo di accumulazione, l’unica risposta provvisoriamente data è stata
proprio la tendenza accentratrice dei capitali esistenti, congiuntamente con la ripresa di assoluto comando
sul lavoro. Ed è nella logica dell’imperialismo che tale processo si traduca inevitabilmente anche in un
accentramento sempre più dispotico e violento del potere politico - dal piano sociale a quello militare. Il Fmi
è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale in siffatta strategia.
&%PAGINA&