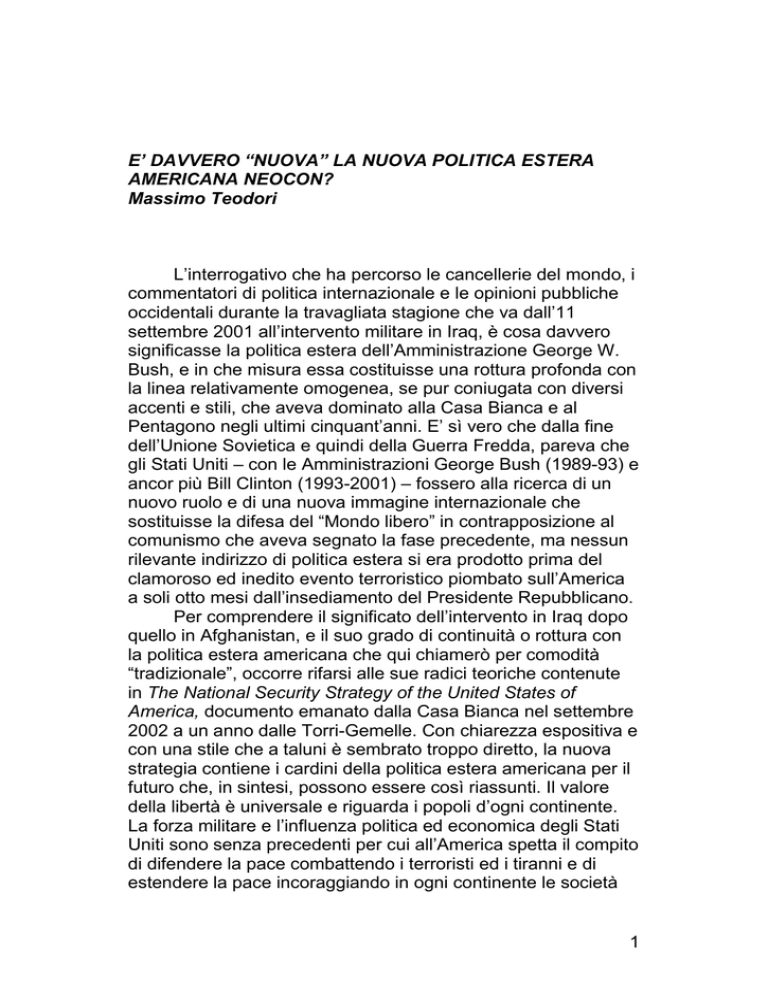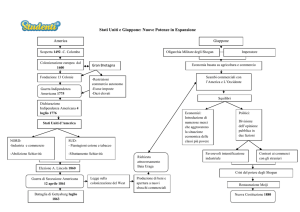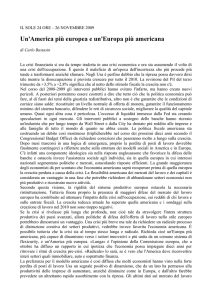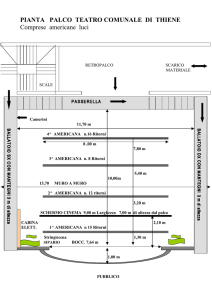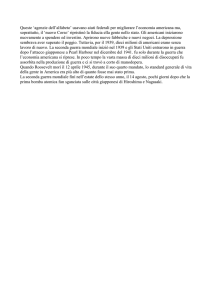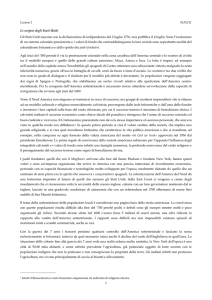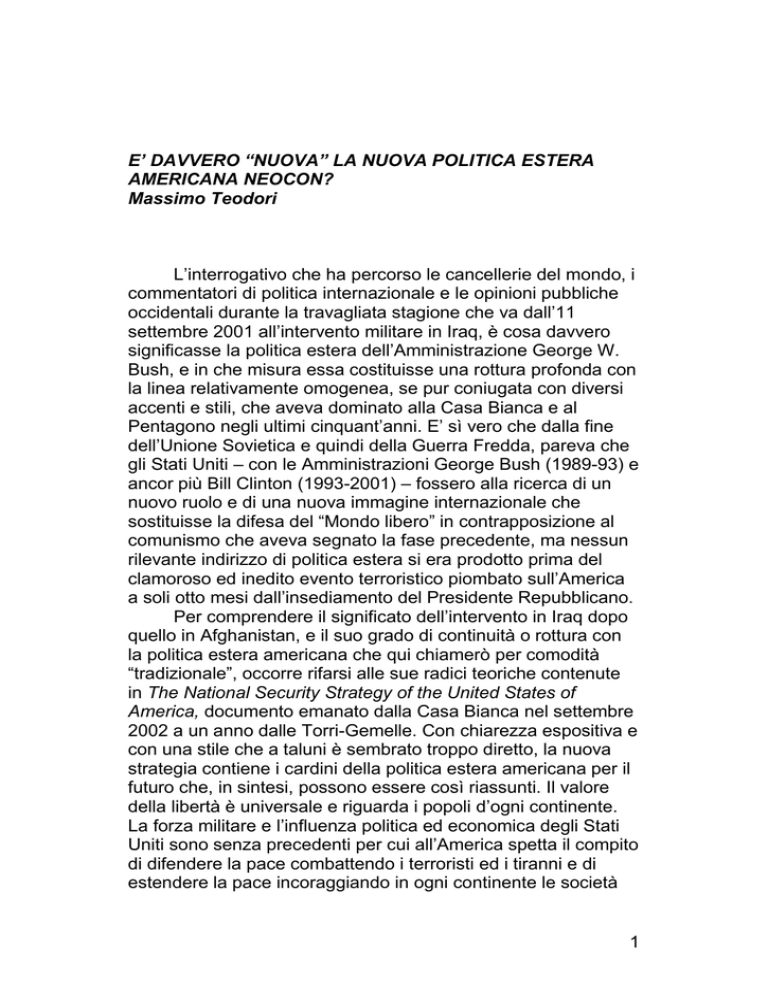
E’ DAVVERO “NUOVA” LA NUOVA POLITICA ESTERA
AMERICANA NEOCON?
Massimo Teodori
L’interrogativo che ha percorso le cancellerie del mondo, i
commentatori di politica internazionale e le opinioni pubbliche
occidentali durante la travagliata stagione che va dall’11
settembre 2001 all’intervento militare in Iraq, è cosa davvero
significasse la politica estera dell’Amministrazione George W.
Bush, e in che misura essa costituisse una rottura profonda con
la linea relativamente omogenea, se pur coniugata con diversi
accenti e stili, che aveva dominato alla Casa Bianca e al
Pentagono negli ultimi cinquant’anni. E’ sì vero che dalla fine
dell’Unione Sovietica e quindi della Guerra Fredda, pareva che
gli Stati Uniti – con le Amministrazioni George Bush (1989-93) e
ancor più Bill Clinton (1993-2001) – fossero alla ricerca di un
nuovo ruolo e di una nuova immagine internazionale che
sostituisse la difesa del “Mondo libero” in contrapposizione al
comunismo che aveva segnato la fase precedente, ma nessun
rilevante indirizzo di politica estera si era prodotto prima del
clamoroso ed inedito evento terroristico piombato sull’America
a soli otto mesi dall’insediamento del Presidente Repubblicano.
Per comprendere il significato dell’intervento in Iraq dopo
quello in Afghanistan, e il suo grado di continuità o rottura con
la politica estera americana che qui chiamerò per comodità
“tradizionale”, occorre rifarsi alle sue radici teoriche contenute
in The National Security Strategy of the United States of
America, documento emanato dalla Casa Bianca nel settembre
2002 a un anno dalle Torri-Gemelle. Con chiarezza espositiva e
con una stile che a taluni è sembrato troppo diretto, la nuova
strategia contiene i cardini della politica estera americana per il
futuro che, in sintesi, possono essere così riassunti. Il valore
della libertà è universale e riguarda i popoli d’ogni continente.
La forza militare e l’influenza politica ed economica degli Stati
Uniti sono senza precedenti per cui all’America spetta il compito
di difendere la pace combattendo i terroristi ed i tiranni e di
estendere la pace incoraggiando in ogni continente le società
1
libere ed aperte. Quel che ha rivoluzionato il quadro
internazionale è il terrorismo che ha caratteristiche del tutto
diverse dalle minacce del passato: gli Stati Uniti devono colpire
queste minacce emergenti prima che si formino. La strada per
la pace e la sicurezza è l’azione che estende la libertà nel
mondo, un’azione che porta con sé le speranze di democrazia,
sviluppo, e del mercato e commercio liberi. L’America è sì
impegnata a mantenere istituzioni multilaterali come le Nazioni
Unite, il WTO e la Nato, ma le “coalizioni dei volenterosi” che si
formano sulle specifiche missioni intorno a individuate priorità
internazionali, servono ad aumentare il potenziale delle
istituzioni permanenti.
Questa dottrina che si fa risalire ai neoconservatori è stata
abbracciata da George W.Bush solo con l’11 settembre. Nei
primi mesi della nuova Amministrazione Repubblicana circolava
insistentemente l’interrogativo sulla possibile ripresa di una
spinta isolazionistica che da sempre costituisce una tendenza
radicata nella tradizione dei Repubblicani. Come è noto, ma
spesso si tende a dimenticarlo, sono state le Amministrazioni
Democratiche che nel Novecento hanno dato vita a politiche
interventiste, anche sul piano militare. Così, dopo l’ondeggiante
periodo clintoniano, si poteva anche prevedere che l’America si
ritirasse in parte dagli impegni internazionali per concentrarsi
sugli affari interni. Ed invece il pendolo internazionale
americano, da sempre oscillante tra interventismo e
isolazionismo, si è decisamente indirizzato sul primo corno del
dilemma, secondo quella particolare strategia interventista che
il pensiero neoconservatore aveva elaborato dai tempi della
Presidenza Reagan a cui aveva suggerito la politica riarmista
per mettere alle corde l’Unione Sovietica, come in effetti
accadde alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso.
L’eccezionalità dell’11 settembre nella vicenda storica
americana è questione che è stata troppo dibattuta per doverci
tornare sopra, ma che deve essere attentamente considerata
allorché si vogliano valutare le ragioni profonde delle campagne
afghana ed irakena, e degli interventi che magari in futuro
seguiranno una logica irrispettosa degli equilibri esistenti. Quel
che più interessa è capire in che misura la nuova politica
internazionale che da allora è stata assunta sia davvero così
“nuova”, una volta spogliata dello stile con cui è stata
enunciata, e scontata la singolare novità del suo punto di
partenza - il terrorismo islamico che è la vera novità storica con
2
cui si trova a fare i conti. Non c’è dubbio che l’intervento irakeno
abbia rotto quello status quo internazionale di cui la
superpotenza americana era stata finora la maggiore garante
contro i tanti protagonisti “dinamici” che non accettavano
l’immobilismo internazionale, ed abbia dunque rappresentato il
primo importante banco di prova nella riscrittura delle regole del
gioco internazionale. Ma questa rottura è davvero tale?
* * *
Il mio punto di vista sulla nuova politica estera americana
ispirata dai neoconservatori è che in essa vi siano molti più
elementi di continuità con il Novecento americano di quanto
usualmente si ritenga. L’odierno interventismo statunitense per
cui il Paese consapevole della propria forza militare, economica
e politica ritiene suo diritto, e suo dovere, uscire dai propri
confini per assicurare non solo la sicurezza nazionale ma
anche propugnare un nuovo ordine internazionale nel quale si
diffonda la democrazia e gli elementi destabilizzanti siano
affrontati frontalmente, è tutt’altro che nuovo. Erano
certamente ispirati al principio della “esportazione della
democrazia” i Quattordici punti del Democratico Woodrow
Wilson. La stesso intervento dei soldati US nella prima guerra
Mondiale, fu ispirato dalla necessità di combattere accanto alle
democrazie europee quel che era al tempo considerato il
“male”, gli imperi centrali. La concezione dell’ordine mondiale
che ispirò la Società delle Nazioni concepita da Wilson come
un’utopica alleanza dei Paesi democratici, doveva fare argine ai
Paesi non democratici e fronteggiare la diversa filosofia
internazionalista sostenuta negli stessi anni dai bolscevichi di
Lenin.
Né sono state molto diverse dall’impostazione che oggi
regge la strategia americana internazionale, le idee forza che
hanno mosso e sostenuto le più rilevanti e significative azioni
internazionali degli Stati Uniti lungo l’intero Novecento. Franklin
D.Roosevelt fece programmi, contrariamente alla maggior parte
dell’opinione pubblica americana e dello stesso Congresso, che
la libertà e la democrazia in America non potessero essere
difese estraniandosi dal grande scontro allora in atto con il
nazismo. Quando nell’ultimo periodo della sua vita, mentre era
ancora in corso la durissima guerra in Europa e in Estremo
Oriente, Roosevelt progettò i piani per le nazioni vinte
3
(Germania, Giappone e Italia), e concepì con l’ONU la nuova
versione dell’internazionalismo istituzionalizzato, prendeva le
mosse da alcune convinzioni chiare e radicate che al tempo
stesso tenevano in considerazione gli interessi statunitensi
sull’assetto del mondo e le idealità democratico-progressiste
insite nella rivoluzione newdealista. La prima riguardava la
necessità di esportare la democrazia procedendo, dopo la resa
senza convinzioni, a progetti di denazificazione,
defascistizzazione e demilitarizzazione delle potenze dell’Asse
propugnando delle costituzioni democratiche e, possibilmente,
federali. La seconda era l’ancoraggio all’organizzazione
internazionale come contrappeso al pericolo di un ritorno a
quell’isolazionismo che aveva dovuto combattere tra gli anni
trenta e quaranta mentre le democrazie europee si
estenuavano contro Hitler e che, alla fine della Presidenza
Wilson (1920) aveva respinto la partecipazione americana alla
società delle Nazioni. E la terza convinzione di Roosevelt
faceva perno sulla necessità dell’uso della forza – Hiroshima –
come elemento risolutivo per battere i regimi autoritari (prima
della Bomba atomica c’erano stati i bombardamenti a tappeto
delle città tedesche) e come premessa indispensabile
all’organizzazione futura del mondo.
L’intera vicenda della Guerra Fredda per quel che
riguarda gli Stati Uniti, si compone di capitoli in cui convivono
principi e strumenti apparentemente contrastanti in un mix che
è il vero DNA americano: l’uso della forza in maniera diretta o
deterrente e le profonde convinzioni ideali (ed ideologiche),
l’arroganza del potere e le missioni di libertà e democrazia.
Certo il radicale cambiamento della minaccia esterna, dal
comunismo con il suo territorio, le sue regole interne e un
codice per il dialogo esterno, al terrorismo islamico senza
regole, senza sensibilità alla deterrenza e senza confini, non
consente di stabilire analogie simmetriche tra la stagione che
inizia nel 1947 e quella del post-11 settembre. Se dunque in
termini geostrategici dalla Guerra Fredda alla Guerra al
Terrorismo tutto è cambiato, a me invece pare che non siano
così radicalmente mutati quell’insieme di valori, principi, e
ispirazioni che nelle due diverse epoche hanno mosso la
politica internazionale americana e hanno identificato la stessa
surperpotenza, unica sopravvissuta nel Terzo millennio.
La “crociata” contro il pericolo esterno è stata alla base
della missione dell’America nel mondo, cioè della sua immagine
4
identitaria rispetto al proprio popolo ed agli altri Paesi durante
l’intero quarto di secolo che segue la guerra mondiale. L’uso
della forza in tutto questo periodo è stato costante: una forza
che costituiva la precondizione stessa del dialogo e del
negoziato. L’ordine mondiale in un sistema bipolare era un
ordine basato niente affatto sul diritto internazionale ma
principalmente sulla forza, talora anche preventiva ed usata
senza risparmi. Nella guerra di Corea il contenimento del
comunismo si trasformò ben presto nello scontro diretto tra
Stati Uniti e i suoi alleati orientali e la Cina con le sue
propaggini militari ed ideologiche. Ancor prima la minaccia della
forza e il suo stesso uso erano serviti a risolvere le crisi di
Grecia e Turchia di fronte all’espansionismo sovietico. Nelle
crisi di Berlino e di Cuba il più democratico ma anche il più
anticomunista dei Presidenti americani del dopoguerra arrivò
per ben due volte in mille giorni a mettere in atto un braccio di
ferro fino agli estremi margini delle guerra, spingendosi sull’orlo
dell’abisso, come aveva teorizzato John Foster Dulles, il
passionale segretario di Stato del Presidente Eisenhower. In
Vietnam poi lo stesso John F. Kennedy cominciò con l’inviare
18.000 “consiglieri”, un’azione bellica continuata dal suo
successore, Lyndon B. Johnson, autentico rappresentante del
progressismo liberal all’interno, che portò ad oltre trecentomila
soldati il contingente americano in una guerra come non mai
direttamente guerreggiata. La stessa mano tesa di Nixon alla
Cina arrivò contestualmente ad una serie di attacchi frontali
contro il suo diretto alleato e protetto, il Vietnam del Nord,
sempre in nome della difesa dei regimi liberi e della
esportazione della democrazia stile occidentale.
Da ultimo sarebbe arduo negare che la teoria della
“ingerenza umanitaria”, sperimentata nel Kosovo ed esaltata da
Tony Blair e da tutta la nuova sinistra al di qua e al di la
dell’Atlantico come un “nuovo internazionalismo” volto alla
difesa dei diritti dell’uomo ovunque minacciati, non avesse
qualcosa a che fare con l’esportazione della democrazia e della
libertà, così cara alla politica di Bush.
* * *
L’imperialismo liberale, che ha una dimensione
essenzialmente ideologica in quanto mira a diffondere la
democrazia ritenuta il migliore avamposto della sicurezza degli
Stati Uniti e il più efficace presupposto della pace
5
internazionale, non nasce con i neoconservatori e non è una
prerogativa di quello che viene ritenuto il più aggressivo ed
estremista dei Presidenti dell’ultimo secolo. I Democratici
Wilson, Roosevelt, Truman, Kennedy e Johnson non furono
meno sensibili all’uso della forza nella difesa degli interessi e
degli ideali americani. E la ragione di questa continuità, pur
nella differenza dei contesti storici, sta con ogni probabilità nella
eccezionalità della storia americana.
LIBERAL - giugno 2003
| Torna agli articoli | Scrivete a [email protected] |
6