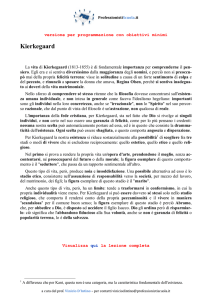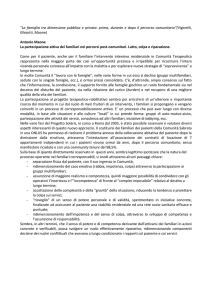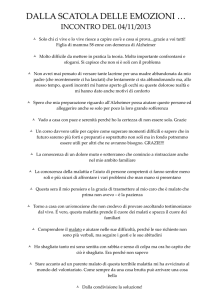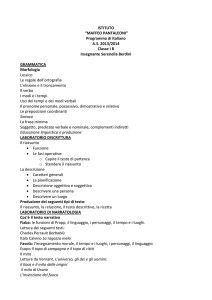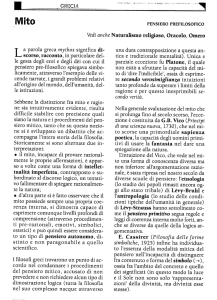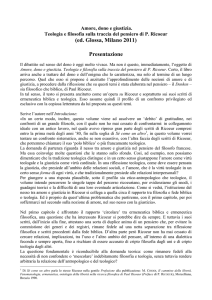Annali del Dipartimento di Filosofia (Nuova Serie), XVIII (2012), pp. 151-163
L’enigma della colpa: Kierkegaard e Ricoeur
Marta Mauriello
This paper faces the problem of the guilt’s ambivalence, torn
between responsibility and temptation, self-affirmation and
strangeness to himself.
Following Kierkegaard’s and Ricoeur’s thinking, we try to sound
out this indissoluble polarity by means of analysis of adamitic
myth, in which the sinner conscience rationally confesses to itself
this terrible experience, the perception of being sinner, wicked,
and of being at the same time deceived, victim of a pre-existent
and irresistible evil.
Keywords: guilt; evil; adamitic myth; Kierkegaard; Ricoeur.
Se vi è un’esperienza umana angosciante e scandalosa nella sua inspiegabilità, questa è senza dubbio l’esperienza della colpa. Essa, nelle
sue diverse declinazioni di fallimento, errore, inganno, sperdimento, è
presente e informa di sé ogni esistenza umana: poiché è proprio dell’essere
umano l’essere fallibile, imperfetto, soggetto allo sbaglio e al male. Ma,
d’altro canto, questa esperienza, così naturale e attinente al dato umano,
non è qualcosa di placidamente razionale, linearmente inscrivibile in un
rapporto di causa-effetto: è invece tortuosa, tormentata, enigmatica. Ciò
perché nel concetto di colpa - o di peccato, di male morale, di deviazione – si sovrappongono e confondono problemi diversi: il problema
della disposizione, della motivazione, della scelta del male, il problema
della tentazione e il suo rapporto con la libera scelta, il problema della
convergenza di male commesso e male subìto, e quindi la coincidenza
di fallibilità e di seduzione, di castigo e di ingiustizia, di sofferenza e di
malvagità. Si tratta di un universo di concetti che pur non essendo assimilabili o semplicemente riducibili l’uno all’altro vengono nondimeno
pensati insieme, in unità l’uno con l’altro. È questa, per così dire, unità
nella distinzione, ma anche distinzione nell’unità, a rendere il male un
enigma, con cui la coscienza si scontra e con cui la riflessione – filosofica,
ma anche teologica – necessariamente si trova a confrontarsi.
Non per caso, allora, questo enigma è al centro della speculazione
di Søren Kierkegaard, speculazione filosofica sempre al confine con la
http://www.fupress.com/adf
ISSN 0394-5073 (print) ISSN 1824-3770 (online)
© 2013 Firenze University Press
152
Marta Mauriello
teologia e che, incentrata sull’esistenza dell’uomo, trova sulla sua strada questo problema, che continuamente affronta direttamente o a cui
implicitamente allude. E non a caso su questo problema si incentra uno
dei filoni secondo i quali viene svolgendosi la riflessione di Paul Ricoeur,
ugualmente tesa, tra filosofia e teologia, ad indagare quanto è di più
intimamente connesso alla specificità dell’essere umano. Perché questa
costellazione di concetti è veramente l’orizzonte entro cui si situa la condizione umana, ed essa, pur nella sua «irrecusabile polarità»,1 esprime
«in modo molteplice la condizione umana nella sua unità profonda».2
Certamente è da giustificare questa unitarietà di concetti di per sé
così distanti tra loro: perché il male commesso è sentito come subìto, o
come indotto? E com’è possibile pensare sotto una luce unica sofferenza
e peccato, male sofferto e male compiuto? Se la sofferenza attiene al piano
fisico, sensibile, ed esprime quel doloroso stupore di fronte al male che
subiamo da parte degli altri uomini, o dal mondo, o dalla nostra stessa
condizione umana, sottoposta alla caducità, alla malattia, al degrado e
alla morte, e se di contro la colpa attiene invece al piano morale e designa
il consapevole allontanarsi da ciò che – giuridicamente, socialmente,
religiosamente, moralmente – è ritenuto il bene, ebbene, cos’è che mette
in comune questi due universi?
In una prospettiva semplicemente ‘storica’, una prima sovrapposizione tra questi due piani ha una motivazione del tutto ‘fattuale’: il male
compiuto rende il colpevole oggetto di biasimo e di imputazione; egli è
perciò accusato e condannato ad una punizione per il male commesso,
punizione che è sofferenza. Che sia una sofferenza fisica - perdita della
libertà, punizione corporale, condanna a morte - o morale – il pubblico
ludibrio, l’allontanamento dalla comunità, la vergogna e il disonore, il
sentimento di indegnità, il rimorso – la pena inflitta «scavalca la frattura
tra il male commesso e il male subìto»,3 anzi, salda in sé questa frattura,
nel suo essere sofferenza subìta per una colpa commessa. D’altro lato,
ancora secondo quella prospettiva storica indicata, il male che uno compie
cade sempre, più o meno direttamente, a danno di un altro: ciò fa sì che
ogni male commesso sia una sofferenza inflitta ad altri, e che dunque
peccato e sofferenza anche da questo punto di vista vengano a coincidere.
Su questa base storica il pensiero ha costruito una coincidenza – e
un’ambiguità – ancora più profonda tra i due termini: infatti, se ogni
punizione è una sofferenza inflitta per una colpa commessa, allora se
1 P. Ricoeur, Il male. Una sfida alla filosofia e alla teologia, trad. it. di I. Bertoletti,
Morcelliana, Brescia 1993, p. 13.
2 Ivi, p. 14.
3 Ivi, p. 13.
L’enigma della colpa: Kierkegaard e Ricoeur
153
ne può trarre che ogni sofferenza sia a sua volta una punizione per una
colpa personale o collettiva o avita, commessa consapevolmente o meno.
Questo è il paradigma della retribuzione, che ha avuto lunga fortuna
nell’Occidente di tradizione giudaico-cristiana, e che ancora influenza
fortemente il nostro modo di guardare al male, perché fornisce uno
schema razionalizzante entro cui situare l’esperienza del male e della
colpa, per renderla comprensibile, e quindi più rassicurante: chi soffre,
fallisce, muore, sconta una qualche colpa, dunque il male è giustificato
e il reo almeno in parte confortato.
Anche dalla prospettiva del colpevole vi è un’analoga commistione di
concetti: poiché è proprio dell’esperienza della colpa il suscitare allo stesso
tempo un sentimento di estrema responsabilità e di radicale estraneità: chi
ha commesso del male si sente sempre al contempo colpevole e vittima,
responsabile e soggetto, libero eppure avvinto, in una affermazione di
sé che allo stesso tempo è alterità a se stesso, sperdimento. Qui si arriva
al cuore del mistero della colpa, a ciò che rende questa esperienza veramente drammatica: questo è «il fondo tenebroso, mai completamente
demitizzato, che fa del male un unico enigma».4
Già Kierkegaard aveva messo in luce tale ambiguità della colpevolezza, che rende questa esperienza tipicamente umana un mistero per la
riflessione. Nel Concetto dell’angoscia e nella Malattia mortale, in cui si
affronta il concetto di peccato, egli muove da due sentimenti negativi il
cui oggetto resta indeterminato, rispettivamente l’angoscia e la disperazione: essi introducono all’esperienza di colpa da due vie differenti, in
modo tale che essa appare molto diversa nei due scritti.
Nel Concetto dell’angoscia, in cui si affronta un’analisi filosoficopsicologica del racconto mitico della caduta, il peccato è visto come
«pullulare sorgivo»,5 come evento che scaturisce nell’istante, improvviso
e inspiegabile come un salto, preparato dalla vertigine dell’angoscia di
fronte alla possibilità infinita. A questo evento la riflessione si può solo
avvicinare il più possibile, ma quando esso sgorga improvviso, essa deve
arretrare: non è un dato spiegabile con le determinazioni della ragione,
è salto, evento. Al peccato la riflessione si può volgere nuovamente solo
dopo che esso sia stato posto, vale a dire quando sia quantitativamente definibile. Ciò avviene nella Malattia mortale, che invece è uno «svolgimento
psicologico cristiano»6 in cui si esamina il sentimento della disperazione:
Ivi, p. 15.
P. Ricoeur, Kierkegaard. La filosofia e l’«eccezione», trad. it. di I. Bertoletti, Morcelliana, Brescia 1996, p. 12.
6 Come recita il sottotitolo dell’opera: S. Kierkegaard, La malattia mortale, trad. it.
di F. Gentili, Mondadori, Milano 2007.
4 5 154
Marta Mauriello
qui il peccato viene ad apparire come già posto e fissato, come qualcosa
di positivamente in essere, malattia che infetta l’anima e che è realmente
mortale perché ha come esito il perdere se stessi.
Siamo qui, dunque, di fronte ad un paradosso: l’analisi antropologica e psicologica di Kierkegaard arriva fino all’istante precedente il
peccato – la situazione di angoscia nell’innocenza - e subito dopo si trova
nell’istante immediatamente seguente il peccato – che poi si radicalizza
nella disperazione, oggetto di un discorso psicologico ed edificante. Ciò
che è impossibile da analizzare con gli occhi della ragione è proprio il
passaggio dall’innocenza alla colpa, questo salto inspiegabile che pone
una nuova qualità, che è appunto il male.
È proprio questa inspiegabilità del salto con cui il male è posto che
sembra essere l’eredità fondamentale del pensiero kierkegaardiano nella
teoresi di Ricoeur sulla colpa. Egli prende atto di questo fondo oscuro
dell’esperienza dell’umano: nel momento in cui l’uomo con più veemenza
afferma se stesso, nel momento dell’allontanamento dalla legge morale e
dell’affermazione della propria legge – nel momento, cioè, in cui è sommamente libero, sommamente in possesso di se stesso – proprio in quel
momento egli è anche sommamente altro da se stesso, inesorabilmente
prigioniero, preso dalle maglie di un male che in qualche modo gli preesiste e già lo avvince. C’è come un punctum caecum di incomprensibilità,
radicato nel cuore dell’esperienza più umana di tutte, che è l’esperienza
dell’essere soggetti alla colpevolezza, all’errore, alla sofferenza.
Per questo Ricoeur in Finitudine e colpa si propone una ermeneutica
del male partendo da un esame del concetto di fallibilità, concetto che
trasferisce sul piano della speculazione razionale la percezione immediata,
irriflessa, di questa naturale propensione all’imperfezione. Esito di questa
analisi fenomenologica e antropologica – che non staremo qui a ripercorrere – è il medesimo della conclusione del Concetto dell’angoscia kierkegaardiano: la fallibilità, fragilità originaria inerente all’essere dell’uomo
come unione non coincidente di infinità e finitezza, è luogo, possibilità,
potere del male, ma essa non è il male, né è premessa necessaria del male.
Il male si pone infatti in modo nuovo, non deducibile da questa predisposizione: «dire che l’uomo è fallibile è dire che la limitazione propria ad
un essere che non coincide con se stesso è la debolezza originaria da cui
il male procede. E, tuttavia, il male non procede da questa debolezza se
non per il fatto che si pone».7 Come dire, con le parole di Kierkegaard,
che il male è una «nuova qualità»,8 che non si pone grazie all’assommarsi
7 p. 242.
8 P. Ricoeur, Finitudine e colpa, trad. it. di M. Girardet, Il Mulino, Bologna 1970,
S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, trad. it. di C. Fabro, SE, Milano 2007, p. 33.
L’enigma della colpa: Kierkegaard e Ricoeur
155
di determinazioni quantitative, ma che emerge improvvisamente con quel
«salto qualitativo»9 che la ragione non è in grado di catturare. Eppure,
questo salto inspiegabile, compiuto in preda a una sorta di vertigine,10 è
rottura improvvisa non meno che slittamento graduale e misterioso: poiché a partire dal male posto si coglie retrospettivamente che esso è anche
compimento della debolezza. «È questa transizione dall’innocenza alla
colpa, scoperta nel porsi stesso del male, che dà al concetto di fallibilità
tutta la sua ambigua profondità».11
Ma se di fronte a questo paradosso Kierkegaard si rassegna all’incomprensibilità, tacitando la riflessione per lasciar parlare il mito, Ricoeur
invece vuole tentare di scandagliare l’enigma. Per far ciò, si volge anch’egli al mito biblico della caduta, non deponendo le armi della ragione di
fronte ad esso, ma piuttosto interpretandolo con l’ermeneutica: il compito diviene quello, allora, di interrogare il mito affinché la riflessione
possa farsi depositaria della ricchezza semantica ed esistenziale che esso
racchiude. L’intento, però, non è affatto quello di eviscerare il mito, vivisezionandolo per scoprirne tutti i segreti più reconditi – uccidendolo
-, ma di ascoltarlo con l’orecchio della filosofia, teso ad individuare quel
nucleo di verità esistenziale che la filosofia da sola non può raggiungere,
ma che le è necessario per non cadere in un’astratta e vana tautologia.
Si tratta pertanto di attuare un’ermeneutica di tipo nuovo, distinta dai
metodi filosofici tradizionali, inadeguati a quest’impresa: ermeneutica
volta al rispettoso ascolto e all’interpretazione dei simboli mediante i
quali l’uomo confessa a se stesso l’esperienza oscura e tremenda dell’essere colpevole, peccatore. Perché se la riflessione propria della ragione
è incapace di cogliere appieno questo scandalo, il singolo individuo che
vi è coinvolto lo sente con tutta la forza della propria corporeità, o, per
meglio dire, della propria ‘emozionalità’, tramite la quale coglie come
la libera responsabilità che la ragione difende sia solo la faccia luminosa
della colpa, complementare a quella faccia oscura che è il sentimento
intenso e bruciante della propria debolezza di fronte ad un male che
ammalia, tenta, asservisce. Vi è un divario tra la riflessione sulla fallibilità
e l’esperienza concreta della colpa, ed è il divario tra il pensiero, che nel
suo sforzo di comprensione razionale coglie solo ciò che è pura razionalità,
lasciando da parte «la realtà quotidiana, cioè, per l’uomo, la “schiavitù
delle passioni”»,12 e il sentimento, il dato esistenziale: ma questo divario
Ivi, p. 49.
È estremamente significativo che il concetto di vertigine compaia sia in Kierkegaard che in Ricoeur a caratterizzare il momento psicologico precedente la caduta,
come un sentimento soverchiante ma assecondato, che è la cifra dell’ambiguità del salto.
11 Ricoeur, Finitudine e colpa, cit., p. 242.
12 Ivi, p. 623.
9 10 156
Marta Mauriello
può essere superato e colmato, mediante un’ermeneutica filosofica del
linguaggio della confessione. Questo linguaggio simbolico, che poi si
struttura nel mito, è capace di operare tale mediazione tra l’esperienza viva
e la filosofia, perché risulta allo stesso tempo interno e altro rispetto alla
riflessione: altro, dal momento che non è speculazione bensì espressione
confusa e balbettante che porta alla luce il dramma del male; ma interno,
dal momento che la confessione è già riflessione proprio nel suo essere già
linguaggio, e come tale di pertinenza della filosofia. Ciò rende possibile
una ermeneutica di questo linguaggio, non per snaturarlo e ridurlo ad
astrattezza, ma per coglierne la ricchezza mantenendolo intatto nella sua
immediata aderenza al dato esistenziale. È questo, forse, il solo modo per
poter accedere al cuore dell’enigma e al sentimento immediato che esso
suscita e che la confessione raccoglie, portandolo alla parola.
Il linguaggio della confessione, infatti, rivela la drammaticità dell’esperienza di colpa, che è un’esperienza cieca e scandalosa, prigioniera, come
essa è, dell’emozione, della paura, dell’angoscia. L’uomo che è caduto non
sa spiegare né il come né il perché della sua caduta, si confessa responsabile
del male che ha compiuto, ma al tempo stesso afferma di aver agito come
preso da una forza estranea. Inoltre, la confessione mostra che questa esperienza è complessa, stratificata, poiché in essa si sovrappongono diverse
concezioni del male, con cui la coscienza ha tentato nel corso della storia
di elaborare questo trauma: la percezione del male come un quid negativo,
qualcosa di oggettivo e preesistente che infetta l’uomo, lo conquista, lo
rende prigioniero, e la percezione del male come scelta dell’uomo, come
cominciamento, decisione libera, atto nuovo e responsabilmente posto.
Come si vede, si torna sempre di nuovo al problema dell’ambivalenza del
male: qualunque sia la strada percorsa, ciò che si trova è la percezione
immediata di questo accavallarsi di piani, di questa inscindibile polarità,
che è la ragione del mistero di questa esperienza.
Ciò che si può fare è affrontare una ermeneutica del mito della caduta, mediante il quale la coscienza ha tentato di darsi una spiegazione
plausibile di uno scandalo tanto grande, qual è l’esistenza del male e la
possibilità umana di aderirvi. Ricoeur non tenta una analisi filosofica di
questo mito, consapevole dell’impossibilità per la riflessione di comprendere il peccato, come Kierkegaard aveva fatto presente. Se essa si accinge
a spiegarlo, è destinata comunque a fallire: infatti, o tenta di razionalizzarlo, e lo fagocita in un sistema, ottenendo così, certo, di racchiuderlo
nelle proprie categorie, ma non di comprenderlo realmente, dato che se
ne lascia sfuggire la sostanza effettiva, con tutta la carica di novità e di
negatività che lo caratterizzano; oppure, se sceglie di conservare al male
la sua natura, esso le resta inaccessibile, e la riflessione si trova costretta
a dichiarare la propria resa.
L’enigma della colpa: Kierkegaard e Ricoeur
157
Per non trovarsi in quest’impasse, Ricoeur tenta una strada nuova,
cogliendo la «sfida senza pari»13 che il male lancia alla speculazione, una
«provocazione a pensare di più, addirittura a pensare altrimenti»,14 che
per lui significa appunto interpretare filosoficamente il mito che racconta
l’origine del male.
Questo mito, adamitico, è, secondo Ricoeur, «il mito antropologico
per eccellenza»,15 poiché esso affronta il problema del male in rapporto
all’uomo, con un taglio diverso da tutti gli altri miti, ossia facendo dell’uomo l’origine del male. «Che vi sia un uomo, questo è il male; la genesi
del male coincide con l’antropogonia»:16 questo è innanzi tutto quanto ci
comunica il mito. Il quale però ci rivela un’altra intuizione fondamentale,
opposta a questa: ossia che l’uomo non coincide con il male, ma che c’è
un male che lo precede e a cui egli dà il suo assenso, quando lo comincia.
Per portare alla luce questa polarità – da cui il concetto di colpevolezza non può prescindere -, il mito procede secondo un doppio ritmo:
da un lato tende a concentrare tutto il male della storia in un’unica figura
– Adamo – che in un unico istante compie un atto unico e irripetibile;
dall’altro invece scandisce l’episodio in molteplici personaggi – Adamo
stesso, Eva, il serpente – e lo presenta in un contesto temporale, facendone in tal modo un dramma che possiede una durata e un significato
non univoco.
La complessità e la fecondità del racconto adamitico risultano proprio dalla compresenza di questi due aspetti opposti, dal fatto cioè di
essere allo stesso tempo «mito della cesura e mito della transizione, mito
dell’atto e mito della motivazione, mito della cattiva scelta e mito della
tentazione».17 Il nostro tentativo sarà allora quello di interpretare i simboli che costruiscono questo mito, per poter «comprendere la dialettica
tra l’«avvenimento» della caduta e il «tempo» della tentazione»18 - che è
un’altra faccia del problema che scandisce il nostro percorso: la dialettica
paradossale di colpevole e vittima, di libertà e soggezione, di responsabilità e seduzione. È così che l’ermeneutica del mito potrà dare alla filosofia
quella spinta a comprendere senza la quale questa dialettica resterebbe
un ostacolo insormontabile per la riflessione sul problema del male.
Per quel che riguarda lo schema dell’avvenimento o della caduta,
esso concentra l’evento in un solo uomo, Adamo, nel quale «siamo uno
Ricoeur, Il male. Una sfida alla filosofia e alla teologia, cit., p. 7.
Ibidem.
15 Ricoeur, Finitudine e colpa, cit., p. 497.
16 Ibidem
17 Ivi, p. 519.
18 Ivi, p. 509.
13 14 158
Marta Mauriello
e tutti»:19 in lui si concentra, all’origine della storia, l’unità molteplice
dell’uomo, in lui si manifesta l’avvento paradigmatico del male nel mondo
e in ognuno di noi. Quest’uomo è una creatura libera e buona, a immagine
del Creatore; ma egli, nel racconto dell’avvenimento, «si riassume in un
unico gesto: “prese del frutto e ne mangiò”. Di questo avvenimento non
v’è nulla da dire: non si può che raccontarlo; accade, in un istante, e ormai
il male è avvenuto. Dell’istante come cesura si può solo dire che finisce e
comincia. Da un lato termina un tempo d’innocenza, dall’altro comincia
il tempo di maledizione».20 L’istante in cui il peccato è compiuto scava un
abisso insormontabile tra il prima – lo stato di innocenza, la condizione
originaria dell’uomo che non conosceva il peccato – e il dopo – la colpa,
la pena che ne deriva, che è la maledizione a cui la vita dell’uomo sarà
per sempre soggiogata, maledizione che è l’inclinazione al male che toglie
ad ogni cosa il suo senso originario di bene, e la perverte in sofferenza,
fatica, castigo.21 Con il mito si compie così un’operazione fondamentale,
in quanto, ponendo il mondo «come ciò nel quale il peccato è entrato»22
e l’innocenza «come ciò a partire da cui il peccato ha deviato»,23 il
peccato giunge a mostrarsi non in quanto realtà originaria dell’uomo,
bensì come un qualcosa che diviene oltre il suo essere ontologico. «Si
apre così la possibilità di interpretare lo stato d’innocenza e quello di
peccato non più in successione, ma in sovrimpressione; il peccato non
succede all’innocenza ma, nell’Istante, la perde».24 Nell’istante, quindi,
innocenza e peccato sono contemporanei: l’uno pone fine all’altra nel
medesimo momento, per mezzo del gesto improvviso e misterioso di cui
Adamo si fa responsabile. Così il mito, raccontando la caduta «come un
avvenimento, sorto da non si sa dove»,25 offre alla riflessione un concetto
chiave, ossia «la contingenza di questo male radicale che il penitente è
sempre sul punto di chiamare la sua natura malvagia».26
Anche Kierkegaard aveva letto all’incirca negli stessi termini il primo
peccato di Adamo, ossia come una novità assoluta che sopravviene improvvisamente ed enigmaticamente, col «salto qualitativo»: con una repentina
Ivi, p. 510.
Ibidem.
21 Cfr. Gen 3, 17-19: «Maledetto il suolo per causa tua!/ Con dolore ne trarrai il
cibo/ per tutti i giorni della tua vita./ Spine e cardi produrrà per te/ e mangerai l’erba dei
campi./ Con il sudore del tuo volto mangerai il pane,/ finché non ritornerai alla terra,/
perché da essa sei stato tratto:/ polvere tu sei e in polvere tornerai!».
22 Ricoeur, Finitudine e colpa, cit., p. 517.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ivi, p. 518.
26 Ibidem.
19 20 L’enigma della colpa: Kierkegaard e Ricoeur
159
perdita di quell’innocenza che connotava la condizione di Adamo nel
Paradiso. Ed è proprio così che si introduce nel mondo il male: Kierkegaard sottolinea sempre con forza l’ambiguità di questo salto, la cui fonte
ultima è la libertà del singolo, con una scelta personale e insondabile che
avviene nell’istante. «Il peccato, dunque, entra come qualcosa di subitaneo,
cioè col salto; ma questo salto pone, nello stesso tempo, la qualità; e, al
momento stesso in cui la qualità è posta, il salto è compreso nella qualità e
presupposto nella qualità, così come la qualità del salto. Questo è uno scandalo per l’intelletto»,27 del tutto incapace di pensarlo. L’unica spiegazione
possibile è quella fornita dal mito biblico, che semplicemente ci dice che
«il peccato entrò nel mondo con un peccato […], spiegazione dalla quale
risulta la profonda conclusione che il peccato presuppone se stesso; che
esso viene nel mondo in modo che, mentre è, esso è già presupposto».28
Subitaneità ed ambiguità, appunto: proprio nel momento in cui il male fa la
propria comparsa si ha la sensazione che esso fosse già lì, in qualche modo
presupposto nel nostro atto, come un invito al male da parte di un male
che ancora non c’è, ma già ci attrae irresistibilmente, e ci porta a peccare.
E così, appunto, Ricoeur, il quale, kierkegaardianamente, mostra
come lo stesso mito, dal punto di vista temporale, si sviluppi in una molteplicità di figure e di episodi che ne fanno un vero e proprio dramma, tanto
che «il “passaggio” [il “salto”] dall’innocenza alla colpa prende il senso
di uno slittamento insensibile e non più di un’insorgenza improvvisa».29
Vorremmo sottolineare il fatto che si tratta di uno slittamento insensibile,
perché è proprio questo il punto: se secondo lo schema dell’avvenimento
– o della responsabilità, possiamo dire – il male è un atto improvviso e
ingiustificabile che l’uomo compie liberamente nell’istante, secondo lo
schema temporale – o della seduzione o della cattività – il male è invece
un atto, sì, che però scaturisce da un progressivo scivolamento di cui
l’uomo non è consapevole, sotto l’influsso di «una specie di vertigine, da
cui l’atto cattivo uscirebbe come per fascinazione».30 E il polo di riferimento di questa vertigine, di questa libertà che è già prigioniera e per così
dire ammaliata, è la figura del serpente, legata ad un altro personaggio
ancora, la donna: in tal modo «il mito moltiplica gli intermediari, come
controparte dell’irrazionalità dell’istante».31
Allora, il serpente si rivolge alla donna e le pone di fronte il limite
della sua finitezza creaturale come un qualcosa di costrittivo e di altro
Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, cit., p. 35.
Ivi, p. 35.
29 Ricoeur, Finitudine e colpa, cit., p. 519.
30 Ibidem
31 Ibidem
27 28 160
Marta Mauriello
da sé, così che «il limite creatore diviene negatività ostile e, come tale,
problematica»;32 si annebbia la percezione della propria finitezza, mentre
sorge prepotente il «desiderio d’infinità […] è l’infinità del desiderio
stesso, è il desiderio del desiderio che afferra il conoscere, il volere, il
fare e l’essere».33 Questa dialettica tra l’infinità del desiderio e la finitezza
ontologica che attiene all’essere dell’uomo era stata riconosciuta anche
da Kierkegaard, sotto l’aspetto dell’angoscia che precede il salto e che
è come una vertigine di fronte alle possibilità infinite che si aprono di
fronte all’uomo: «l’angoscia è la realtà della libertà come possibilità per
la possibilità».34 Quando è ancora nello stato di innocenza35 l’uomo,
nella sua libertà, è preso da questa vertigine di fronte all’infinità che gli
si apre come possibilità, e alla opposta finitezza del suo essere naturale.
È in preda a questa vertigine di angoscia che egli cade, scegliendo la finitezza; ma questa «caduta», questo passaggio dall’innocenza alla colpa, è
anch’esso ambiguo, perché avviene sotto l’influsso di una forza esteriore
all’uomo, ma anche sommamente intima a lui, perché dovuta al suo essere
finito, in quanto essere naturale, e allo stesso tempo infinito, in quanto
spirito dotato di libertà: «L’angoscia è la vertigine della libertà [...che],
guardando giù nella propria possibilità, afferra il finito per fermarsi in
esso. In questa vertigine la libertà cade. Più in là la psicologia non può
andare e non lo vuole neanche. Nello stesso momento tutto è cambiato
e, mentre la libertà si solleva di nuovo, essa vede che è colpevole. Tra
questi due momenti si trova il salto, che nessuna scienza ha spiegato né
può spiegare».36
È proprio questa vertigine a fare del salto che pone il peccato qualcosa di ambiguo e razionalmente inspiegabile, poiché è allo stesso tempo una
scelta libera e consapevole, e uno scivolamento inarrestabile e sottilissimo
provocato da un sentimento estraneo all’uomo, ma a lui più intimo di
ogni altro. Infatti: «colui che, mediante l’angoscia, diventa colpevole è di
certo innocente; infatti non era lui, ma l’angoscia, una potenza estranea,
che lo prese; una potenza che egli non amava, ma di cui si angosciava...;
eppure egli è colpevole, perché si lasciò cadere nell’angoscia che egli, pur
temendo, amava. Non c’è nel mondo niente di più ambiguo di questo».37
Ibidem
Ricoeur, Finitudine e colpa, cit., p. 520.
34 Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, cit., p. 44.
35 Lo ‘stato di innocenza’ è un’astrazione che individua quello stato immaginario in
cui si può pensare la condizione originaria dell’uomo come svincolata dal decadimento
successivo: uno stato in cui il male non è ancora posto, e in cui dunque si può esaminare
il primo apparire del peccato. Cfr. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, cit., pp. 38-40.
36 Ivi, p. 61.
37 Ivi, p. 45.
32 33 L’enigma della colpa: Kierkegaard e Ricoeur
161
Questa inspiegabilità e ambiguità del porsi del peccato, che Kierkegaard sottolinea molte volte, sia in relazione all’angoscia, sia all’esseresempre-già-lì del peccato, è ben presente anche in Ricoeur, che pertanto
pone l’accento sul duplice significato del mito, in quanto avvenimento
e dramma, che ne costituisce la profonda complessità e l’ambiguità. Se
però Kierkegaard non dà nessuna rilevanza alla figura del serpente e della
donna, concentrando tutta l’attenzione sul processo psicologico che porta
Adamo al peccato, Ricoeur invece approfondisce il significato simbolico
di questi due personaggi del mito, per comprenderli pienamente.
Intanto, perché la donna? Prescindendo in questa sede dalle varie
e note interpretazioni culturali sociali e sessuali, è interessante leggere
questo fatto come la proposizione, da parte del mito adamitico, di una
sorta di «eterno femminino»38 che non ha a che fare con determinazioni di
carattere sessuale, ma con l’elemento di fragilità che vi è nell’essere umano,
quello che lui chiama la «mediazione della debolezza».39 La donna, Eva,
rappresenta cioè quel punto di minima resistenza al male presente in ogni
uomo e in ogni donna, che scaturisce direttamente dalla struttura dell’essere umano: una libertà potenzialmente infinita, che tuttavia è circoscritta
alla finitezza del proprio essere creatura, con limiti fisici, temporali, etici,
ontologici – qui per Kierkegaard sta la sorgente dell’angoscia che conduce al peccato, qui per Ricoeur sta la fonte della fallibilità che definisce
ognuno di noi e che inesorabilmente ci espone alla possibilità del male:
questo «rapporto sproporzionato tra finitezza e infinità»40 è per entrambi
il luogo ontologico in cui si situa l’origine del male umano.
Per quel che riguarda, invece, la figura del serpente, si apre un problema molto controverso: il serpente è astuto ed è malvagio già prima
della colpa di Adamo – però è anch’esso una creatura. In questa figura il
mito vuole prima di tutto incarnare l’esperienza della «quasi-esteriorità
della tentazione»,41 come se la seduzione ci venisse da una parte di noi
stessi che non riconosciamo come nostra, e a cui la nostra libertà cede.
Però non si può ridurre il senso di questo personaggio solo a questo
aspetto: «il serpente non è soltanto la proiezione dell’uomo fatta da lui
stesso, non è solo la nostra animalità eccitata dalla proibizione, smarrita
nella vertigine dell’infinito […] il serpente è anche “fuori” in modo più
radicale».42 Poiché infatti nel serpente si concretizza una situazione che
ognuno di noi, quando decide per il male, sperimenta: quella che il male
Ricoeur, Finitudine e colpa, cit., p. 521.
Ibidem.
40 Ricoeur, Finitudine e colpa, cit.,, p. 228.
41 Ivi, p. 523.
42 Ivi, p. 524.
38 39 162
Marta Mauriello
sia sempre radicalmente già lì, già dato, anteriore a noi e più astuto di
noi, in grado di perdere la nostra debole libertà.
Vi è, infine, anche un altro significato del serpente, un significato
potremmo dire cosmico: esso rappresenta infatti l’esteriorità radicale del
male che consiste nell’indifferenza del mondo nei confronti dell’uomo
e dell’esigenza etica di cui egli è portatore: «dallo spettacolo delle cose,
dal corso della storia, dalla crudeltà della natura e degli uomini, deriva
un sentimento dell’assurdità universale che invita l’uomo a dubitare della
sua destinazione».43
Il serpente, insomma, personifica quegli aspetti del male che non
possono essere ricondotti alla libertà dell’uomo: in esso il mito ci avverte
di una verità fondamentale, e cioè del fatto che l’uomo non è cattivo in
assoluto, non è il malvagio primo, in senso temporale e ontologico, ma è
malvagio solo in quanto partecipa di un male che lo precede e lo sorpassa. Così Ricoeur: «l’uomo non è il malvagio assoluto; è solo un malvagio
in seconda, un malvagio a causa della seduzione. Non è il Cattivo, il
Maligno in senso sostantivo, se così si può dire, ma è cattivo, malvagio
come attributo; si fa malvagio per una specie di contro-partecipazione, di
contro-imitazione, per consenso ad una sorgente del male che l’ingenuo
autore del racconto biblico dipinge come un astuto animale. Peccare
è cedere».44 Sebbene il serpente rimanga una figura-limite, in cui né la
confessione né la speculazione possono più di tanto addentrarsi per non
cadere in contraddizioni senza soluzione, l’ermeneutica vi riconosce il
simbolo di «quel male che io continuo quando anch’io lo comincio e lo
introduco nel mondo».45
Così il mito, in questo personaggio anomalo, ci parla ancora una
volta dell’enigma del male, di quel paradosso che si sperimenta quando
il male che noi conosciamo in quanto da noi inaugurato e compiuto, ci
appare allo stesso tempo come già iniziato, già presente prima che noi
lo introducessimo nel mondo, come se noi non potessimo mai davvero
cominciare il male in modo originale, perché è come se esso già sempre
ci aspettasse al varco del nostro cedergli.
Quello che il mito consegna alla riflessione è, allora, l’esperienza viva
dell’enigma della colpa: non però in modo semplicemente irriflesso, bensì
in modo tale che questa esperienza, per quanto sia confusa e prigioniera
della paura, è portata al livello del linguaggio, ad un primo stadio della
riflessione. È per questo che «il simbolo dà a pensare»:46 perché il simbolo
Ivi, p. 525.
Ivi, p. 526.
45 Ivi, p. 527.
46 Ivi, p. 623.
43 44 L’enigma della colpa: Kierkegaard e Ricoeur
163
è veramente, per sua natura, quel ponte tra vita e filosofia che arricchisce
entrambe. Tale arricchimento è possibile se l’ermeneutica si fa «interpretazione creatrice di senso, che sia al tempo stesso fedele all’impulso,
al dono di senso del simbolo e fedele al giuramento del filosofo, che è
quello di comprendere».47 È, questa, una scommessa che il filosofo può
scegliere di fare: scegliere di credere che si possa comprendere meglio
l’uomo nella sua totalità seguendo l’indicazione del pensiero simbolico.
Il compito diviene allora quello di elaborare concetti a partire dai simboli, dunque strutture del pensiero che non siano astratte, ma che siano
strutture dell’esistenza, ancorate al dato vivo e vivente: veri concetti
esistenziali in grado di dare conto della complessità dell’essere umano,
fatto di ragione e di carnalità, di pensiero e di sentimento. Questa forma
di filosofia, incentrata sull’ermeneutica, è così in grado di riconoscere al
mistero del male e della colpa tutta la sua profondità, senza svilirla nello
sforzo di comprenderla, e senza lasciarsene vincere: ma questo diviene
solo il punto di partenza per un nuovo discorso sull’uomo, in grado di
abbracciarne l’inesauribile e insondata ricchezza esistenziale.
47 Ivi, p. 624.