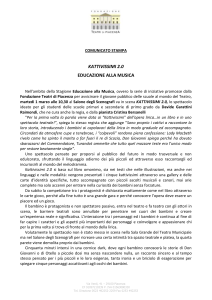DALLE CENERI
dall’opera di Tahar Ben Jelloun
con Ibrahima Diouf, Ndiawar Diagne, Marie Madaleine Mendy,
Mamadou Seye, Jean Guillaume Tekagne
regia e scena MASSIMO LUCONI
costumi Aurora Damanti
luci Roberto Innocenti
musiche Mirio Cosottini, Selif Keita
produzione Teatro Metastasio Stabile della Toscana
con la collaborazione di Centro culturale francese di St. Louis (Senegal),
Associazione APPI, Comunità senegalese di Prato
PRIMA NAZIONALE
Spettacolo visto al Fabbricone il 29 gennaio 2015
Recensione di Laura Buscemi
Molte volte ci ritroviamo ad ascoltare o a leggere storie di eventi drammatici, di esseri umani rapiti
dalla morte per i vizi dei potenti, di coloro che pensano di essere vivi perché possono sedere su una
poltrona d’oro, discutendo sul futuro dei popoli con un’arma nel cassetto, al di sopra di ogni
sospetto. Molti sono infatti gli avvenimenti conflittuali a cui oramai assistiamo da secoli, così tanti
da sembrare quasi la normalità, senza lasciar spazio allo stupore e senza accorgersi di quanti
innocenti, che siano bambini o adulti, profughi o clandestini, perdono la vita tutti i giorni, o
comunque la loro dignità, i loro diritti, divenendo cenere sperduta nel vento.
Ed è questo che spinge il regista Massimo Luconi a portare per la prima volta in scena al Teatro
Fabbricone di Prato lo spettacolo Dalle ceneri, dando voce ai tanti corpi insepolti delle guerre
attraverso i versi del poeta marocchino Tahar Ben Jelloun, noto principalmente per i suoi scritti
sull'immigrazione e sul razzismo. Quattro angeli illuminano la scena con il loro candore,
spolverando la memoria di un soldato devastato (protagonista interpretato dal giovane talento
senegalese Ibrahima Diouf), un uomo dalla grande spiritualità che in maniera onirica e profonda,
delicata e forte allo stesso tempo, riesce a scuotere i nostri animi, molto spesso indifferenti alle
tragedie del nostro tempo. In una narrazione linguisticamente articolata, tra francese, wolof e
italiano, fatta ora di canti e di litanie, ora di preghiere e di percussioni, gli spettatori sono immersi
nella scena, sul palcoscenico, a stretto contatto con gli attori.
Fra poesia e sogno, in un momento storico di cattiva informazione e di massificazione culturale e di
perdita di valori, assistiamo ad una produzione teatrale dal grande spessore artistico che denuncia
l’assurdità delle guerre e che ci porta inevitabilmente a riflettere, affinché tutti i morti abbandonati
possano nuovamente rivivere ed essere perlomeno considerati.
Recensione di Chiara Collina
È Ibrahima Diouf il protagonista dello spettacolo Dalle ceneri del regista Massimo Luconi, che ci
ha presentato un adattamento teatrale di un'opera dello scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun. Il
regista porta lo spettatore in un altro mondo, o meglio, nel non mondo dove lo spazio non è definito
perché non è né cielo né terra. Anche il tempo sembra continuamente ripetersi su se stesso ed è qui
che si trova il protagonista, in questo non luogo senza tempo, perché lui non è più tra i vivi ma
neppure tra i morti: il limbo. Questo destino è inevitabile per coloro che non vengono sepolti
secondo i riti religiosi a causa della guerra; i loro corpi restano senza vita coperti dalla sabbia o sul
fondo del mare e nessuno è interessato a recuperarli. Per questo non possono trovare la pace e
vengono perseguitati dal loro passato: la memoria che riaffiora fa soffrire e le persone della vita
precedente diventano solo delle ombre. La poesia accompagna il protagonista in questo viaggio
senza meta e sembra essere l'unico aiuto che può ricevere. La sensazione di trovarsi in un luogo
atemporale è favorita da due scelte registiche e scenografiche: la prima è stata quella di ricoprire
tutto il palcoscenico con un grosso telo e di conseguenza non permettere allo spettatore di definire
lo spazio in cui avviene la vicenda e la seconda di avere la presenza del pubblico direttamente sul
palco a pochi passi dagli attori. In questo modo viene eliminato definitivamente quel distacco tra il
pubblico e gli attori che nel teatro tradizionale nemmeno l'immaginazione dello spettatore più
fervido può riuscire a colmare. Il protagonista parla in francese ma in molti casi le traduzioni non
servono perché il dolore da lui espresso è universale e non ha bisogno di essere esplicitato. Il regista
Luconi ha deciso di mettere a fianco di Ibrahima Diouf, l'unico vero attore, altri quattro attori non
professionisti che però sono legati al primo non solo per la provenienza dal Senegal, ma anche da
un profondo amore per il teatro e la recitazione.
Recensione di Julia Margaret Pagliuca
Massimo Luconi lavora con i suoi attori non professionisti concentrandosi sulle loro tradizioni e sul
loro stile di vita, dando importanza all'Africa e in particolar modo al Senegal.
Questa rappresentazione parla dei morti di guerra, un messaggio universale che può far riferimento
a qualsiasi momento di conflitti, morti, disastri, orrori. È per coloro che sono abbandonati e
dimenticati, distrutti da una guerra che lascia senza dignità i corpi degli uomini non sepolti e non
ricordati.
Lo spettacolo mette in scena quattro angeli neri (N. Diagne, M. M. Mendy, J. G. Tekagne, M.
Seine) e un uomo morto a causa della guerra. Recitato in italiano e principalmente in francese, il
pubblico trova posto anche a lato della scena, creando un effetto di coinvolgimento totale favorito
dalla predisposizione del Fabbricone.
L'opera punta all'essenza della poesia; un teatro, dunque, poetico che pone i suoi riferimenti nella
cultura africana, con i suoi canti e i suoi riti. La messa in scena infatti si presenta come un rito di
dolore e di preghiera, un'esorcizzazione. All'inizio tre angeli al centro della scena sono su un telo
bianco e in sottofondo si ode il suono del mare. Trascinando il tessuto, al di sotto compare un uomo
disteso in un baule. Un morto senza tomba, senza dignità, né memorie o nome. Ecco cosa resta di
un'anima dopo la guerra, di un corpo sotto terra. Non restano che polveri e l'uomo (I. Diouf)
racconta ciò che ha vissuto, quello che prova e del limbo nel quale si trova. Le lacrime sono verso
gli uomini che si credono grandi e consapevoli, colti e superiori, c'è un grido di domanda per sapere
se quella è dignità.
Lo spettacolo è un inno al dolore, al rito per un corpo che non ha avuto sepoltura ma che senza
membra, braccia, gambe e occhi, ha solo la sua anima che vaga senza tregua e senza pace in cerca
di una giustizia e la cui stessa fine prende il nome di Destino.
La scenografia si presenta essenziale e il baule è come una sorta di vita terrena, di raccoglimento di
frammenti che hanno accompagnato la vita dell'uomo e adesso viene aperto, portato sempre dietro,
trascinato, perché è l'unica cosa sulla quale aggrapparsi. Sul fondo della scena vengono proiettate le
traduzioni dalla lingua francese e l'attore principale viene a contatto col pubblico avvicinandosi
quasi a sfiorarlo. Le luci si proiettano sui singoli attori per isolarli da tutto il resto che
sostanzialmente non esiste. Suoni, talvolta, accompagnano il rito, fino ad arrivare verso la fine della
stessa rappresentazione in cui canti africani vengono rievocati dall'uomo morto.
Le parole di questo teatro, dunque, diventano il modo per trovare un respiro dal dolore e per cercare
sollievo in un luogo senza memorie.


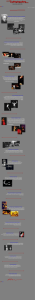


![Musica_e_immagine.pps [modalità compatibilità]](http://s1.studylibit.com/store/data/007566322_1-58d70b56b536a079f8882415348ab4fa-300x300.png)