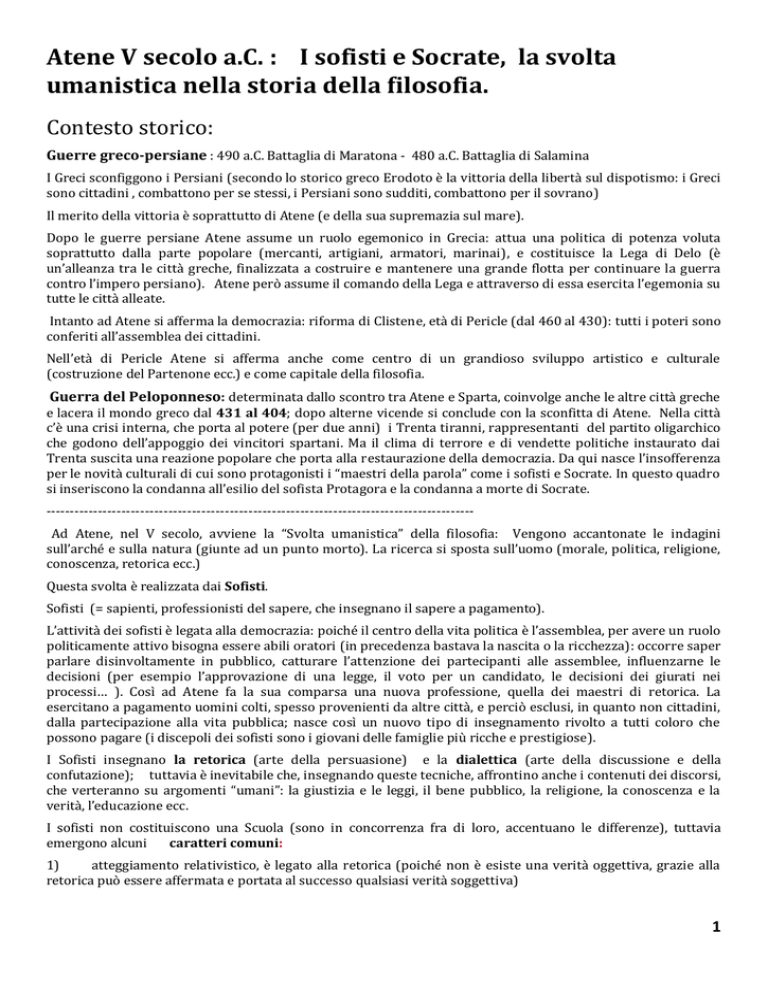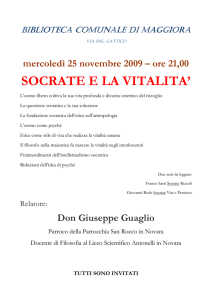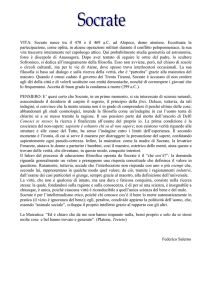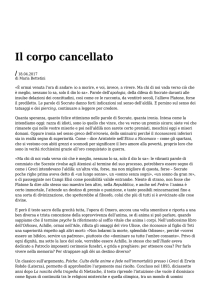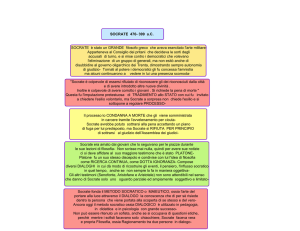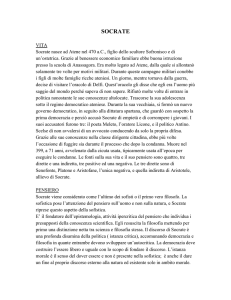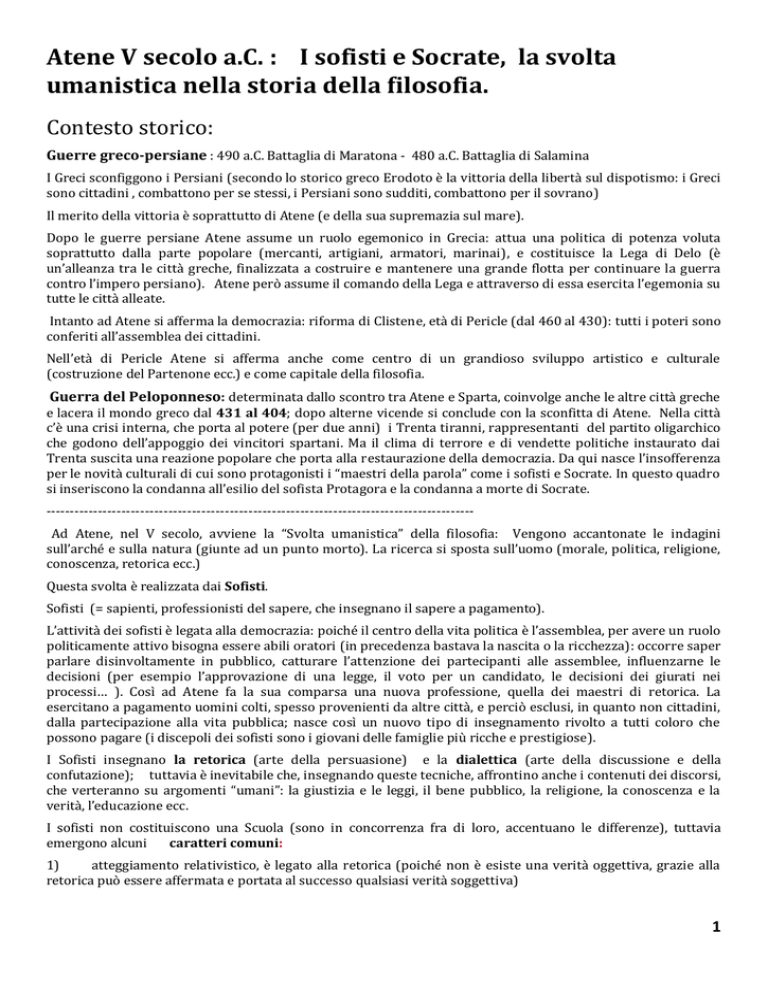
Atene V secolo a.C. : I sofisti e Socrate, la svolta
umanistica nella storia della filosofia.
Contesto storico:
Guerre greco-persiane : 490 a.C. Battaglia di Maratona - 480 a.C. Battaglia di Salamina
I Greci sconfiggono i Persiani (secondo lo storico greco Erodoto è la vittoria della libertà sul dispotismo: i Greci
sono cittadini , combattono per se stessi, i Persiani sono sudditi, combattono per il sovrano)
Il merito della vittoria è soprattutto di Atene (e della sua supremazia sul mare).
Dopo le guerre persiane Atene assume un ruolo egemonico in Grecia: attua una politica di potenza voluta
soprattutto dalla parte popolare (mercanti, artigiani, armatori, marinai), e costituisce la Lega di Delo (è
un’alleanza tra le città greche, finalizzata a costruire e mantenere una grande flotta per continuare la guerra
contro l’impero persiano). Atene però assume il comando della Lega e attraverso di essa esercita l’egemonia su
tutte le città alleate.
Intanto ad Atene si afferma la democrazia: riforma di Clistene, età di Pericle (dal 460 al 430): tutti i poteri sono
conferiti all’assemblea dei cittadini.
Nell’età di Pericle Atene si afferma anche come centro di un grandioso sviluppo artistico e culturale
(costruzione del Partenone ecc.) e come capitale della filosofia.
Guerra del Peloponneso: determinata dallo scontro tra Atene e Sparta, coinvolge anche le altre città greche
e lacera il mondo greco dal 431 al 404; dopo alterne vicende si conclude con la sconfitta di Atene. Nella città
c’è una crisi interna, che porta al potere (per due anni) i Trenta tiranni, rappresentanti del partito oligarchico
che godono dell’appoggio dei vincitori spartani. Ma il clima di terrore e di vendette politiche instaurato dai
Trenta suscita una reazione popolare che porta alla restaurazione della democrazia. Da qui nasce l’insofferenza
per le novità culturali di cui sono protagonisti i “maestri della parola” come i sofisti e Socrate. In questo quadro
si inseriscono la condanna all’esilio del sofista Protagora e la condanna a morte di Socrate.
------------------------------------------------------------------------------------------Ad Atene, nel V secolo, avviene la “Svolta umanistica” della filosofia: Vengono accantonate le indagini
sull’arché e sulla natura (giunte ad un punto morto). La ricerca si sposta sull’uomo (morale, politica, religione,
conoscenza, retorica ecc.)
Questa svolta è realizzata dai Sofisti.
Sofisti (= sapienti, professionisti del sapere, che insegnano il sapere a pagamento).
L’attività dei sofisti è legata alla democrazia: poiché il centro della vita politica è l’assemblea, per avere un ruolo
politicamente attivo bisogna essere abili oratori (in precedenza bastava la nascita o la ricchezza): occorre saper
parlare disinvoltamente in pubblico, catturare l’attenzione dei partecipanti alle assemblee, influenzarne le
decisioni (per esempio l’approvazione di una legge, il voto per un candidato, le decisioni dei giurati nei
processi… ). Così ad Atene fa la sua comparsa una nuova professione, quella dei maestri di retorica. La
esercitano a pagamento uomini colti, spesso provenienti da altre città, e perciò esclusi, in quanto non cittadini,
dalla partecipazione alla vita pubblica; nasce così un nuovo tipo di insegnamento rivolto a tutti coloro che
possono pagare (i discepoli dei sofisti sono i giovani delle famiglie più ricche e prestigiose).
I Sofisti insegnano la retorica (arte della persuasione) e la dialettica (arte della discussione e della
confutazione); tuttavia è inevitabile che, insegnando queste tecniche, affrontino anche i contenuti dei discorsi,
che verteranno su argomenti “umani”: la giustizia e le leggi, il bene pubblico, la religione, la conoscenza e la
verità, l’educazione ecc.
I sofisti non costituiscono una Scuola (sono in concorrenza fra di loro, accentuano le differenze), tuttavia
emergono alcuni
caratteri comuni:
1)
atteggiamento relativistico, è legato alla retorica (poiché non è esiste una verità oggettiva, grazie alla
retorica può essere affermata e portata al successo qualsiasi verità soggettiva)
1
2)
critica razionalista ai miti e alle credenze della tradizione.
3)
superamento del nazionalismo, riconoscimento della molteplicità delle culture, tendenziale
cosmopolitismo
Maggiori sofisti : Protagora di Abdera, Gorgia di Lentini, Prodico di Ceo, Ippia di Elide, Antifonte:
Sono stranieri ad Atene.
I Sofisti hanno avuto una cattiva reputazione nella storia della filosofia (sofistico è diventato sinonimo di
capzioso, ingannevole) : già alla fine del V secolo, dopo la Guerra del Peloponneso, furono accusati della crisi di
Atene, e furono espulsi dalla città, le loro opere furono distrutte (per cui anche riguardo alle opere dei sofisti
abbiamo una conoscenza frammentaria e indiretta).
Sono noti soprattutto attraverso i libri di Platone, avversario dei Sofisti (il quale pertanto li presentava sotto
una luce piuttosto negativa).
Oggi si tende a rivalutare il pensiero dei Sofisti, sia perché si riconosce loro il merito di aver attuato la “svolta
umanistica” nella storia della filosofia e di aver affrontato nuovi temi di grande rilevanza, ignorati dai
Presocratici; sia perché alcune tesi dei Sofisti sono riprese e condivise da alcune correnti della filosofia
contemporanea.
PROTAGORA DI ABDERA (480-400 a.C.)
Nato ad Abdera, viaggiò per molte città greche e visse a lungo ad Atene, dove trovò il successo e diventò perfino
consigliere di Pericle. Ma dopo la morte di Pericle, e in conseguenza del declino di Atene durante la guerra del
Peloponneso, nel 411 fu esiliato da Atene per empietà. Delle sue opere restano pochi frammenti, però abbiamo
ampie testimonianze sul suo pensiero, soprattutto da parte di Platone (uno dei dialoghi di Platone è intitolato
“Protagora”).
Scrisse le ANTILOGIE = “discorsi contrapposti”: in quest’opera presentava, riguardo a diversi argomenti, due
tesi contrapposte: lo scopo di quest’opera non era quindi la ricerca e l’esposizione della “verità”, ma
l’esposizione delle tecniche con cui qualsiasi tesi (vera o falsa che sia) può essere difesa e argomentata.
La “verità” viene quindi relativizzata.
E infatti uno dei frammenti rimastoci riporta la tesi centrale del pensiero di Protagora: “L’uomo è misura di
tutte le cose, di quelle che sono per ciò che sono e di quelle che non sono per ciò che non sono”.
Altri frammenti ci permettono di capire che Protagora identifica la conoscenza con l’esperienza: siccome nella
percezione sensibile è vero ciò che viene percepito soggettivamente (se un cibo è percepito come dolce, è dolce,
se lo stesso cibo è percepito da un altro come amaro, è amaro; non ha senso dire che uno dei due ha una
percezione vera e l’altro falsa), allora l’esperienza individuale è il metro con cui giudicare le cose.
Conseguenze:
1) RELATIVISMO = non esiste una verità oggettiva, tutte le opinioni sono soggettive ed equivalenti (ciò
che conta è l’efficacia del discorso > retorica), anche i costumi, le leggi, le credenze sono relativi.
2) Non si può dire nulla di ciò di cui non si può fare esperienza: “degli dei non è possibile accertare né se
esistono né di che natura sono” (AGNOSTICISMO)
Nella pratica, nelle decisioni politiche collettive, come scegliere in assenza di verità? Il criterio è l’UTILITA’,
l’UTILE della POLIS, definito dalla maggioranza dei cittadini.
La funzione del sofista è “rendere più forte l’argomento più debole”: attraverso il linguaggio, la retorica,
indirizzare i cittadini verso le scelte più utili , favorendo l’unità e la formazione delle maggioranze necessarie
per assumere decisioni collettive; la funzione del sofista viene paragonata a quella del medico, perché il sofista
usa il linguaggio per procurare vantaggi alla polis, come il medico usa le medicine per la salute dei suoi
pazienti.
PROBLEMA: anche sull’UTILITA’ possono esistere opinioni diverse; in base a quale criterio l’opinione del sofista
viene considerata migliore, più vantaggiosa? Il problema della verità oggettiva si ripropone.
2
GORGIA DI LEONTINI (480-380 ca a.C.)
Nato a Lentini Insegnante e retore in varie città della Grecia
Opera “Sul non essere” (o Sulla natura): nega le tesi eleatiche con la dimostrazione per assurdo
1.
2.
3.
L’essere non è (= il nulla esiste) i filosofi che hanno indagato l’essere sono giunti a tesi contraddittorie (p.e.
Parmenide dice che è finito, Melisso che è infinito, Parmenide che è immobile e immutabile, Eraclito che
tutto si muove e muta – ma siccome l’essere non può essere insieme finito e infinito, immobile e mobile ecc,
allora l’essere non esiste.
Se l’essere fosse, non sarebbe conoscibile né pensabile = non esiste corrispondenza tra pensiero ed
essere, infatti ci sono pensati non esistenti (come l’uomo che vola), allora il non-essere è pensabile, quindi
l’essere è non-pensabile, cioè inconoscibile.
Se l’essere fosse conoscibile, non sarebbe comunicabile = la parola è in noi, non può comunicare l’oggetto
che è esterno a noi. La parola è diversa dalla cosa, dunque il linguaggio non esprime l’essere.
Il fine di queste tesi non è proporre una nuova ontologia o una nuova filosofia della natura, ma dimostrare che
tutte le filosofie precedenti sono inconsistenti, prive di senso, e che non può esistere rapporto tra il pensiero, il
linguaggio e la realtà.
Allora il linguaggio è indipendente dalle cose, quindi non esprime la verità delle cose, ma proprio per questo
può essere usato per convincere di qualsiasi tesi.
Gorgia ha scritto anche il discorso Elogio di Elena :
I. Gorgia rovescia la tesi tradizionale secondo cui Elena era colpevole della guerra di Troia; egli sostiene che
Elena non può essere considerata responsabile perché è stata trascinata da forze superiori alla sua volontà:
gli dèi, la forza persuasiva e irresistibile delle parole di Paride, il sentimento d’amore.
II. Gorgia vuole soprattutto mettere in evidenza la forza persuasiva del discorso, sia di quello di Paride, sia del
proprio, capace di ribaltare il giudizio comune su Elena.
Nella retorica la parola convince non perché portatrice di verità, ma perché suscita emozioni e passioni.
Gorgia scopre anche l’autonomia dell’arte e il valore positivo della finzione poetica; infatti afferma: “chi si
lascia ingannare è migliore di chi non si lascia ingannare” ; con ciò egli intende dire che per godere
pienamente dell’arte occorre accettare, come fosse vera, la realtà fittizia e illusoria creata da essa.
Altri temi dei Sofisti: Nomos e Physis.
Dal confronto tra leggi credenze e istituzioni di diversi popoli emerge la distinzione tra Legge Convenzionale
(Nomos) e Legge di Natura (Physis): questa distinzione è stata posta ed è stata meditata da alcuni sofisti
minori: Ippia, Antifonte, Trasimaco, Callicle.
La legge di natura è valida in senso universale e assoluto, perché la natura è la stessa per tutti gli esseri umani,
quindi la legge di natura è superiore al Nomos, cioè alle leggi convenzionali, decise dagli uomini, e valide solo
per i luoghi i tempi e le persone che hanno stabilito la convenzione.
Da questa distinzione possono però derivare due conseguenze molto diverse:
A) tutti gli uomini sono accomunati dalla legge di natura (Ippia dice che tutti gli uomini sono parenti, familiari e
concittadini per natura) , mentre le differenze di lingua, di religione, di leggi ecc. sono convenzionali, e sono
frutto di pregiudizi e di decisioni arbitrarie. L’esito di questa concezione è il cosmopolitismo, l’eguaglianza tra
tutti gli esseri umani.
B) Poiché è legge di natura che ogni uomo soddisfi i propri desideri e bisogni a suo piacimento, è inevitabile ed
è naturale che sorgano conflitti tra gli uomini e che i più forti impongano la loro volontà ai più deboli: insomma,
la legge di natura è la legge del più forte, e le diseguaglianze hanno origine dalla natura. Secondo Trasimaco
ciò che viene definito “giusto” non è una pacifica “convenzione” ammessa da tutte le parti sociali, ma è l’utile del
più forte, è cioè un insieme di norme e di valori imposti a tutti dalle classi dominanti, perché utili alla
conservazione del potere e dei privilegi. Anche Callicle pensa che sia legge di natura la differenza tra uomini
forti e uomini deboli, e che sia giusto, secondo natura, il dominio dei primi sui secondi, ma ritiene che i valori e
le norme (Nomos) siano stati “inventati” dai deboli come arma di difesa, per tenere a freno le ambizioni dei
forti e per non esserne soggiogati.
3
LETTURE:
Protagora e il mito sulla virtù politica
Nel Protagora di Platone viene rappresentato l’incontro tra il sofista Protagora e Socrate, in una cornice vivace
e festosa di dibattito, con larga partecipazione di pubblico. Il personaggio Protagora si esibisce in un lungo
discorso per rispondere a una domanda di Socrate che va a toccare i fondamenti della democrazia: perché gli
ateniesi sulle questioni di carattere tecnico prendono in considerazione solo il parere degli esperti, mentre
sulle questioni di interesse comune lasciano che chiunque possa prendere la parola in Assemblea? Credono
che questa capacità sia insegnabile a tutti? Il mito con cui Protagora risponde è una rielaborazione molto
mirata di una storia tradizionale: il titano Prometeo (il cui nome significa «colui che riflette in anticipo») ruba
il fuoco agli dèi per correggere l’errore di suo fratello Epimeteo (il cui nome significa «colui che riflette dopo»),
che ha distribuito mezzi di difesa a tutti gli animali, lasciandone privo l’uomo; con il fuoco e le tecniche che ne
derivano, gli uomini riescono a difendersi dalle belve, ma entrano anche in conflitto con gli altri, rischiando la
reciproca distruzione. La versione di Protagora aggiunge un epilogo che contiene un argomento a favore della
democrazia: gli uomini ricevono allora da Zeus, la virtù politica; un dono così necessario alla sopravvivenza
sociale dell’uomo da venir distribuito senza distinzioni a ogni individuo. Protagora sostiene dunque, attraverso
il mito, che il diritto di parlare in assemblea è fondato su una capacità che appartiene all’uomo e che consente a
ciascuno di contribuire con il suo giudizio al bene comune. Aggiunge poi che la disposizione iniziale viene
coltivata dall’educazione perché diventi vera virtù politica, cosicché essa è il risultato congiunto di natura e
insegnamento. Non sappiamo quanto la rappresentazione platonica corrisponda a una dottrina o a un discorso
effettivamente sostenuti da Protagora, ma i suoi contenuti dovevano essere verosimilmente attribuibili al
sofista.
“Vi era un tempo in cui esistevano gli dèi, ma non ancora razze mortali. Quando anche per queste giunse il tempo
destinato alla generazione, gli dèi le plasmarono all’interno della terra, mescolando terra, fuoco e gli elementi che
si combinano col fuoco e con la terra. Immediatamente prima di portarle alla luce, incaricarono Prometeo ed
Epimeteo di ordinarle e di distribuire ad ognuna le possibilità confacenti. Epimeteo pregò Prometeo di lasciargli il
compito della distribuzione. «Dopo che avrò distribuito, disse, tu verrai a controllare.» Ottenuto il suo consenso, si
mise all’opera. Nella distribuzione assegnò ad alcuni la forza senza la velocità; ad altri più deboli assegnò la
velocità; dotò alcuni di mezzi di difesa e di offesa; per altri, che aveva provvisti di natura inerme, escogitò qualche
altra possibilità di conservazione. Agli animali che foggiava piccoli concedeva ali per la fuga o un’abitazione
sotterranea; a quelli che faceva grandi di corpo, dava modo di conservarsi con la loro grandezza. Così distribuì le
altre doti in modo che si compensassero. Escogitandole, aveva la precauzione che nessuna razza si estinguesse.
Distribuisce cibi e stabilisce l’equilibrio tra predatori e prede... Dopo che le ebbe dotate in modo che sfuggissero
alla distruzione reciproca, elaborò espedienti di difesa contro le intemperie del cielo: rivestì le razze di fitto
pelame e di dure pelli, sufficienti a proteggere dall’inverno, ma capaci anche di difendere dai calori estivi, e fece in
modo che questi rivestimenti costituissero, quando andavano a dormire, coperte proprie e naturali. E calzò alcune
di zoccoli, altre di pelli spesse e senza sangue. In seguito fornì ad ogni specie cibi diversi: ad alcune l’erba della
terra, ad altre i frutti degli alberi, ad altre ancora le radici. E ve ne sono altre alle quali diede come cibo la carne
di altri animali; a queste egli assegnò scarsa prolificità, alle loro prede, invece, grande prolificità, procurando così
la conservazione della specie. Ma Epimeteo, che non era un gran sapiente, non si accorse di aver consumato le
possibilità in favore degli animali senza ragione: il genere umano rimaneva ancora privo di ordine ed egli non
sapeva che fare. Mentre era in difficoltà sopraggiunse Prometeo per esaminare la distribuzione e vide che gli altri
animali erano forniti di ogni cosa in giusta proporzione, mentre l’uomo era nudo, scalzo, senza coperte e inerme.
Ormai era imminente il giorno destinato in cui anche l’uomo doveva uscire dalla terra alla luce. Preso dalla
difficoltà di trovare una via di salvezza per l’uomo, Prometeo rubò l’abilità tecnica di Efesto e di Atena insieme col
fuoco (perché acquisire o impiegare questa tecnica senza il fuoco era impossibile) e ne fece dono all’uomo. Con
essa l’uomo ottenne la sapienza per la vita, ma non la sapienza politica. Questa si trovava presso Zeus e a
Prometeo non era concesso di penetrare nell’Acropoli, abitazione di Zeus; inoltre le guardie di Zeus lo
intimorivano. Si introdusse invece di nascosto nell’officina comune di Atena ed Efesto, ove essi lavoravano e
insieme, rubò la tecnica di usare il fuoco, propria di Efesto, e l’altra, propria di Atena, e ne fece dono all’uomo. Da
Prometeo quindi provenne all’uomo la risorsa necessaria per vivere; ma in seguito, a quel che si dice, a causa di
Epimeteo, egli dovette scontare la pena del suo furto. Divenuto partecipe di una condizione divina, l’uomo fu, in
primo luogo, a causa della sua parentela con la divinità, il solo tra gli animali a credere negli dèi e ad innalzare
4
ad essi altari e statue; in secondo luogo, egli articolò ben presto con tecnica voce e parole, e inventò abitazioni,
vesti, calzature, coperte e gli alimenti che nascono dalla terra. Pur essendo così forniti, in principio gli uomini
vivevano dispersi e non esistevano città; perivano quindi uccisi dalle fiere, dato che erano in tutto più deboli di
esse: la tecnica artigianale bastava per aiutarli a procacciarsi il cibo, ma era insufficiente nella lotta contro le
fiere, perché essi non possedevano ancora la tecnica politica, di cui è pane la tecnica di guerra. Cercavano allora
di riunirsi e di salvarsi fondando città; ma quando si erano riuniti, commettevano ingiustizie reciproche in quanto
non possedevano la tecnica politica, sicché nuovamente si disperdevano e perivano. Zeus, temendo l’estinzione
totale della nostra specie, inviò Ermes a portare agli uomini il rispetto e la giustizia, affinché costituissero l’ordine
della città e fossero vincoli di solidarietà e di amicizia. Ermes chiese a Zeus in che modo dovesse dare la giustizia e
il rispetto agli uomini: «Devo distribuirli come le altre tecniche? Queste sono distribuite in modo che un solo
medico, per esempio, basta per molti profani; allo stesso modo gli altri artigiani. La giustizia e il rispetto devo
stabilirli in questo modo tra gli uomini o devo distribuirli a tutti?». «A tutti, rispose Zeus, e tutti ne partecipino:
non esisterebbero città, se, come avviene per le altre tecniche, soltanto pochi ne partecipassero. E stabilisci in mio
nome una legge per la quale chi non può partecipare di rispetto e giustizia sia ucciso come peste della città». Per
questo, Socrate, gli Ateniesi, come gli altri uomini, quando si discute sulla virtù costruttrice o su qualche altra
tecnica artigianale, credono che sia compito di pochi dare consigli, e se qualcuno, estraneo a questi, si mette a
darne, non lo tollerano, come tu dici, e a ragione, dico io. Quando invece si riuniscono a consiglio sulla virtù
politica, che deve procedere interamente secondo giustizia e saggezza, è naturale che ammettano a parlare
chiunque, poiché è proprio di ognuno partecipare di questa virtù; altrimenti non esisterebbero città. Questa,
Socrate, è la causa del fatto. […]”
Platone, Protagora, in Dialoghi filosofici, vol. I, a cura di G. Cambiano, Torino, Utet, 1987, 320c-323a
SOCRATE (Atene 470 -399 a.C.)
Figlio di uno scultore e di una levatrice
In giovinezza partecipa valorosamente a diverse battaglie, assume una carica pubblica nel 406, ma si astiene
dalla vita politica e non fa parte né del partito democratico né di quello oligarchico, tuttavia la sua cerchia di
amici e discepoli è composta soprattutto da aristocratici ed egli stesso esprime critiche alla democrazia
ateniese.
Vive insegnando ai giovani (senza farsi pagare, a differenza dei sofisti) e dialogando con i concittadini.
Nel 399 viene denunciato per empietà e corruzione dei giovani; perciò subisce un processo e la condanna a
morte . La Apologia di Socrate, scritta dal suo discepolo Platone, è la trascrizione (presumibilmente fedele)
dei discorsi fatti da Socrate durante il processo a suo carico.
Socrate non ha scritto nulla, il suo insegnamento è solo orale, ed è basato sul dialogo. Si pone quindi il problema
della conoscenza del pensiero e dell’insegnamento autentico di Socrate; alcuni studiosi arrivano a dire che non
è possibile conoscere il “vero” pensiero di Socrate. Noi seguiamo piuttosto altri storici della filosofia (p.e.
Giovanni Reale e Franco Trabattoni) che ritengono invece che sia possibile ricostruire il pensiero autentico e
originale di Socrate a a partire da una analisi critica e comparata delle fonti e delle testimonianze antiche.
Principali testimonianze su Socrate:
Aristofane commediografo: ritratto caricaturale in Le Nuvole = Socrate viene presentato come un naturalista
ateo e sofista che mina le tradizioni e l’autorità dei padri. Questa testimonianza non è per niente attendibile,
perché propone un Socrate troppo diverso da quello presentato dalle altre fonti; Aristofane ha “messo in scena”
un Socrate che rappresenta genericamente l’idea che gli Ateniesi incolti si facevano dei filosofi.
Senofonte storico discepolo di S. = ha scitto un’altra Apologia di Socrate e i Detti memorabili di Socrate; queste
due opere offrono una testimonianza attendibile sulla vita e l’integrità morale di S. , ma il ritratto filosofico è
sfocato, a parte le informazioni sulla teologia socratica.
Platone filosofo discepolo di S. = Socrate è il protagonista di quasi tutti i suoi Dialoghi: però molte delle idee
che vengono espresse dal personaggio Socrate nei dialoghi platonici della maturità e della vecchiaia sono da
5
attribuire a Platone e non a Socrate. E’ possibile stabilire che il “Socrate autentico” è molto vicino al
“personaggio Socrate” dei dialoghi giovanili di Platone.
Aristotele filosofo discepolo di Platone = non ha conosciuto Socrate, ne ha una conoscenza indiretta, però è
molto importante perché ci informa sulle differenze tra il pensiero di Socrate e quello di Platone (e quindi ci
permette di distinguere, nei dialoghi platonici, le idee che effettivamente risalgono all’insegnamento di Socrate
e quelle che invece, pur essendo attribuite al personaggio Socrate, sono frutto del pensiero di Platone.
SOCRATE E I SOFISTI
Hanno in comune: la svolta umanistica, l’atteggiamento spregiudicato e razionalista nei confronti dei miti e
della tradizione, l’abilità dialettica,
Differenze: Socrate non condivide il relativismo, rifiuta la retorica, crede nella verità come punto d’arrivo di una
ricerca continua ( e non si fa pagare).
METODO DI SOCRATE: nei dialoghi con i suoi concittadini Socrate segue sempre un metodo costituito da
queste tappe
IRONIA = Socrate si mette all’ascolto degli “esperti” , finge di credere al loro sapere superiore e di dichiara di
voler imparare da essi; solitamente egli chiede di definire e spiegare una virtù di cui essi dovrebbero essere
esperti (p.e. la giustizia a un giudice, la santità a un sacerdote, il coraggio a un soldato ecc.)
CONFUTAZIONE = Socrate smaschera gli esperti , li fa cadere in contraddizione, oppure mostra l’inconsistenza
delle loro risposte.
AMMISSIONE DELL’IGNORANZA (o fuga), ABBANDONO DELLE IDEE FALSE: il fatto di aver riconosciuto che le
definizioni e spiegazioni date sono sbagliate o insufficienti costituisce già un avvicinamento alla verità, ma
soprattutto chi riconosce la propria ignoranza si mette nella disposizione giusta per ricercare e scoprire la
verità.
MAIEUTICA (arte dell’Ostetrica) = Socrate si dichiara ignorante, quindi non dà risposte, non propone proprie
definizioni, ma trae fuori la verità che ogni uomo ha dentro di sé, sollecitandolo con domande e obiezioni. Egli
chiede “CHE COS’E’?” e non vuole un esempio, ma il valore in generale, p.e. “che cos’è la giustizia?”, ciò che
rende giuste tutte le azioni giuste? La ricerca è aperta (= Socrate non vuole dimostrare una tesi precostituita,
vuole scoprire una verità ancora sconosciuta), e spesso rimane incompiuta.
L’ORIGINE E LA FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO SOCRATICO
Nell’Apologia Socrate spiega in questi termini l’inizio della sua attività di filosofo “pubblico”:
«Un nostro concittadino aveva interrogato l’oracolo di Delfi su quale fosse il più sapiente degli Ateniesi, e l’oracolo
aveva risposto: il più sapiente è Socrate. Allora io, che mi ritenevo tutt’altro che sapiente, pensando di poter
smentire l’oracolo, cominciai a interrogare i miei concittadini per trovare qualcuno più sapiente di me... prima
interrogai i politici, poi i poeti e gli artisti, poi gli artigiani... ma con mio grande stupore mi resi conto che nessuno
di questi era veramente sapiente: tutti costoro presumevano di avere una grande sapienza, ma quando venivano
interrogati si contraddicevano, oppure non sapevano spiegare quello che dicevano o facevano. Insomma mi resi
conto che anche loro, come me, non erano affatto sapienti; io tuttavia me ne rendevo conto, mentre essi erano
pieni di presunzione e di superbia. Alla fine interpretai così il responso dell’oracolo di Delfi: l’oracolo aveva voluto
dire che solo la divinità è veramente sapiente, e che rispetto alla sapienza divina la sapienza umana è nulla, tanto
che il più sapiente degli uomini è colui che riconosce e ammette la propria ignoranza.»
Socrate aggiunge che questa sua indagine gli aveva procurato molti nemici, anche perché i giovani avevano
cominciato ad accompagnarlo, per vedere come smascherava i suoi interlocutori, come “smontava” le loro
certezze e la loro presunzione, e avevano anche cominciato a imitarlo. Questo racconto ci rivela con grande
verosimiglianza il comportamento importuno e irriverente di Socrate e la prevedibile reazione di fastidio o
addirittura di odio di molti dei suoi concittadini.
Cosa significa questo racconto? Socrate è convinto che la verità esista e che essa sia conosciuta perfettamente
solo dalla divinità; rispetto alla sapienza divina ogni uomo è ignorante.
6
Tuttavia l’uomo ha bisogno di conoscere la verità, di avvicinarsi ad essa, almeno riguardo al problema della vita
umana e delle scelte che essa impone (che cosa è bene e cosa è male per l’uomo? che cosa è giusto e ingiusto?
ecc. ecc.). Per conoscere la verità bisogna cercarla, ma per cercarla bisogna prima di tutto riconoscere la
propria ignoranza, e quindi riconoscere e abbandonare tutti i pregiudizi, tutte le convinzioni false accettate solo
per conformismo o per convenienza.
Socrate però non si accontenta di riconoscere la propria ignoranza e di ricercare privatamente la conoscenza
della verità; egli cerca di coinvolgere anche i suoi concittadini sollecitandoli prima di tutto a esaminare se
stessi, le proprie idee e credenze. Questo avviene perché Socrate, come tutti i Greci dell’antichità, ha un forte
senso di appartenenza alla Polis, non si sente un individuo isolato, ma un membro della cittadinanza. Inoltre i
problemi che interessano Socrate (l’essenza dell’uomo, i valori della vita umana) hanno una grandissima
incidenza sulla politica, cioè sulla vita della comunità: quindi gli Ateniesi sono sollecitati da Socrate a cercare la
verità su questi problemi perché la politica (=la vita della comunità) ateniese diventi più ordinata, più sana.
Socrate è convinto, provocando i suoi concittadini, spingendoli a riflettere, a ragionare, a correggersi, di far del
bene a loro e a tutta la città; inoltre è convinto di dover agire così perché la divinità stessa gli ha conferito
questo compito.
LA SCOPERTA DELL’ANIMA
Socrate dichiara di “sapere di non sapere”, dichiara di non avere nessuna verità da comunicare agli altri, però
nell’Apologia ammette di avere una certa sapienza: “la sapienza umana” , cioè la sapienza che l’uomo può avere
sull’uomo, e che è necessaria per raggiungere la virtù e la felicità
In che cosa consiste questa sapienza sull’uomo? I Naturalisti avevano cercato di rispondere al problema “Che
cos’è la natura e la realtà ultima delle cose?”. Socrate cerca invece di rispondere al problema “Che cos’è la natura
e la realtà ultima dell’uomo? Che cos’è l’essenza dell’uomo?”. E la risposta che trova è questa: “L’essenza
dell’uomo è la sua anima” intendendo, con la parola ANIMA, la nostra RAGIONE, o la SEDE DEL NOSTRO
PENSIERO E DELLA NOSTRA VOLONTA’ o, in altri termini, la nostra COSCIENZA E PERSONALITA’
INTELLETTUALE E MORALE.
Si tratta di una nuova concezione dell’anima nella mentalità greca perché, prima di Socrate, l’anima era
concepita come il principio vivificante, il “soffio vitale”, oppure era concepita, dagli Orfici, come la scintilla
divina che è caduta nel corpo e che trasmigra da un corpo all’altro (anche dal corpo umano al corpo di un
animale): quindi nella mentalità greca presocratica l’anima era concepita come un elemento che non
apparteneva solo all’uomo, ma a tutti gli esseri viventi.
Invece l’anima concepita da Socrate come ragione, coscienza, personalità intellettuale e morale, è
esclusivamente umana (notiamo che la concezione socratica dell’anima è quella che ancor oggi caratterizza la
cultura e la mentalità europea, quindi Socrate è il fondatore di uno dei fondamenti spirituali dell’Europa).
Quali sono le argomentazioni che Socrate usa per sostenere la tesi che “L’essenza dell’uomo è la sua anima” ?
Prima argomentazione: L’anima (intesa come ragione...) è ciò che distingue in maniera specifica l’uomo da
qualunque altra cosa, è ciò che caratterizza l’uomo.
Seconda argomentazione: L’uomo utilizza il proprio corpo come uno strumento (utilizza le gambe quando
decide di camminare, la bocca quando vuole mangiare ecc.). Ma più precisamente il soggetto che utilizza lo
strumento-corpo è la RAGIONE, cioè l’anima. Pertanto l’essenza dell’uomo non può identificarsi con lo
strumento-corpo ma con l’anima che utilizza il corpo.
La prima conseguenza della tesi sull’essenza dell’uomo è questa: l’uomo per realizzare se stesso ed essere felice
deve prima di tutto curare la propria anima, cercare di perfezionare la propria anima. Così Socrate parla
nell’Apologia: «...Né altro in verità io faccio con questo mio andare attorno se non persuadere voi, giovani e
vecchi, che non del corpo dovete avere cura né delle ricchezze né di alcuna altra cosa prima e più dell’anima, in
modo che essa diventi ottima e virtuosissima; e che non dalle ricchezze nasce virtù, ma dalla virtù nasce la
ricchezza e tutte le altre cose che sono beni per gli uomini, così ai cittadini singolarmente come allo Stato».
IL NUOVO SIGNIFICATO DI VIRTU’
Quello che noi oggi chiamiamo VIRTU’ i Greci chiamavano ARETE’, intendendo con questo termine quell’attività
o quel modo di essere che perfeziona ciascuna cosa facendola essere ciò che deve essere (il Greco parlava,
quindi, di una virtù dei vari strumenti, di una virtù degli animali ecc.; per esempio la virtù del cane è quella di
7
essere buon guardiano, la virtù del cavallo è di correre veloce, ecc. Quindi la parola virtù-areté non aveva
ancora, presso i greci, quel significato morale che riveste oggi).
Per Socrate, di conseguenza, la virtù dell’uomo sarà l’attività che realizza e perfeziona l’anima, cioè la “scienza”
o “conoscenza”, mentre il “vizio” (il contrario della virtù) sarà la mancanza di scienza e di conoscenza, vale a
dire l’ignoranza.
Socrate in tal modo opera una rivoluzione della tradizionale tavola dei valori. I valori veri non sono quelli legati
alle cose esteriori, come la ricchezza, la potenza, la fama, e neppure quelli legati al corpo, come la salute, la
vigoria, la bellezza, ma solamente i valori dell’anima che si assommano tutti quanti nella conoscenza.
Questo non significa che tutti i valori tradizionali divengano senz’altro dei dis-valori (in sé negativi); significa
che per se stessi non hanno valore e che diventano valori solo se usati come la conoscenza esige, cioè in
funzione dell’anima e della sua virtù.
I PARADOSSI DELL’ETICA SOCRATICA - LA FELICITA’
La tesi socratica sopra illustrata implicava due conseguenze che sono state considerate (da molti filosofi
successivi) come dei “paradossi”, ma che sono assai importanti e che vanno opportunamente chiarificate.
1) La virtù (ciascuna e tutte le virtù: sapienza, giustizia, fortezza, temperanza) è scienza (conoscenza) e il vizio
(ciascuno e tutti i vizi) è ignoranza.
2) Nessuno pecca volontariamente , e chi fa il male lo fa per ignoranza del bene.
Queste due proposizioni riassumono quello che è stato denominato “intellettualismo etico”, in quanto riducono
il bene morale a un fatto di conoscenza , dato che è ritenuto impossibile conoscere il bene e non farlo.
L’intellettualismo etico socratico ha influenzato tutto il pensiero dei Greci, al punto da diventare un minimo
comune denominatore di tutti i sistemi filosofici dell’antica Grecia.
Chiarifichiamo ora il significato delle due proposizioni:
1) In primo luogo, è da rilevare la potente carica sintetica della prima proposizione. Infatti l’opinione comune
dei Greci prima di Socrate considerava le diverse virtù come una pluralità (una cosa è la giustizia, un’altra la
santità, un’altra la prudenza, un’altra il coraggio ecc.) della quale non sapevano cogliere il nesso essenziale,
ossia quell’elemento comune per cui sono tutte “virtù”. Per di più tutti avevano accolto le diverse virtù come
qualcosa fondato sulle abitudini, sul costume e sulle convenzioni sociali. Socrate invece tenta di sottoporre al
dominio della ragione la vita umana e i suoi valori. E poiché per lui la natura stessa dell’uomo è la sua anima
(ossia la ragione), e le virtù sono ciò che perfeziona ed attua pienamente la natura dell’uomo , ossia la ragione, è
evidente che tutte le virtù risultano essere una forma di scienza e di conoscenza, perchè è appunto la scienza e
la conoscenza che perfeziona l’anima e la ragione.
2) Socrate ha visto molto bene che l’uomo, per sua natura, ricerca sempre il proprio bene e che, quando fa il
male, in realtà non lo fa perché lo ritiene “male”, ma perché si aspetta di ricavarne un bene. Dire che il male (o
la colpa) è involontario significa che l’uomo si inganna nell’aspettarsi un bene da esso, e che, in realtà, fa un
errore di calcolo e sbaglia, ossia è vittima di ignoranza.
Socrate insomma non considera che un uomo può agire in un modo cattivo o vizioso pur rendendosi conto che
quello che fa non è bene, né per lui né per gli altri. Socrate infatti concepisce la ragione e la volontà come un
tutt’uno; solo la cultura romana e il cristianesimo metteranno in evidenza il fatto che la volontà è una facoltà
dell’anima distinta dalla ragione, e che quindi il volere può essere difforme dalla conoscenza razionale.
Ma per capire pienamente il punto di vista di Socrate espresso nella seconda proposizione bisogna anche far
riferimento al pensiero di Socrate sulla felicità. Se l’essenza dell’uomo è la sua anima, la felicità non può venire
dalle cose esteriori o dal corpo, ma solo dall’anima. E l’anima è felice quando si realizza pienamente, cioè
quando è virtuosa, cioè quando conosce. L’uomo virtuoso, che vive cercando la perfezione della propria anima,
è felice intrinsecamente, immediatamente. E’ felice quali che siano le circostanze e le condizioni esteriori in cui
gli tocca vivere, è felice senza bisogno che la felicità gli sia donata dall’esterno (nemmeno come premio nell’aldi- là).
Se è così allora l’uomo colpevole, l’uomo che fa il male, è ignorante soprattutto perché si aspetta la felicità da
azioni che non possono renderlo veramente felice. Invece l’uomo che fa il bene è colui che sa che la felicità gli
verrà dal servire e seguire l’anima, anche se magari ciò potrà costargli molto da un punto di vista esteriore.
8
LA LIBERTA’ SOCRATICA
La concezione socratica dell’anima, e quelle correlate di virtù e di felicità, modificano anche la concezione della
libertà. L’uomo è libero quando è libera la sua anima, e l’anima può perdere la sua libertà solo a causa dei vizi,
dell’ignoranza, degli istinti e dei bisogni legati al corpo. Perciò l’uomo veramente libero è quello che sa
sottomettere i suoi istinti al dominio della ragione, quindi colui che possiede “autodominio”; invece l’uomo
veramente schiavo è l’uomo che è succube dei suoi istinti e impulsi corporei. Gli uomini o le condizioni esterne
(per esempio la prigione) non possono davvero limitare la libertà dell’uomo, perché la vera libertà è quella
interiore.
L’ATTEGGIAMENTO DI SOCRATE DURANTE IL PROCESSO
Il comportamento e le parole di Socrate durante il processo in cui viene condannato a morte costituiscono una
testimonianza esemplare del suo insegnamento. Socrate non implora clemenza dai suoi giudici, né cerca in
alcun modo di accondiscendere alle aspettative del tribunale o di giustificarsi mascherando o attenuando il
significato della sua attività filosofica; al contrario giustifica il suo comportamento con grande franchezza
dicendo anche cose che possono risultare sgradite e offensive per i giudici; inoltre rifiuta di promettere di
astenersi in futuro da tale attività; quando viene dichiarato colpevole dichiara di essere convinto di meritare come pena - di esser mantenuto a spese della Polis; e alla fine propone come pena il pagamento di una piccola
multa. Socrate è consapevole che questo comportamento probabilmente lo porterà alla condanna a morte, ma
non si comporta diversamente perché vuole agire seguendo la verità e la propria coscienza, e vuole agire così
perché pensa di poter essere felice solo in questo modo.
Infatti, egli dice, nessun male può venire all’uomo virtuoso dall’esterno (dai giudici, dai concittadini, dalle
circostanze), perché l’uomo virtuoso realizza la sua anima, mentre gli altri possono danneggiare solo il suo
corpo o i suoi averi. Neppure la morte può far del male all’uomo virtuoso, perché, se c’ è un aldilà dopo la
morte, il virtuoso avrà un premio, e se invece non c’è un aldilà, il virtuoso ha già vissuto bene nella vita terrena
e la morte è annullamento totale (come un sonno senza sogni).
Al contrario, secondo Socrate l’uomo può essere danneggiato “dall’interno”, cioè dal vizio e dalla malvagità che
può corrompere la sua anima. Infatti, dice Socrate, io farei veramente del male a me stesso, se andassi contro la
mia coscienza e contro la verità per salvarmi la vita, perché rovinerei la mia anima, e i miei accusatori hanno
creduto di farmi del male, condannandomi a morte, ma in realtà hanno fatto assai più male a se stessi, perché
essi hanno distrutto il mio corpo, ma hanno anche distrutto, agendo in modo malvagio, la propria anima.
LA DOTTRINA DELLA NON-VIOLENZA.
Quindi per Socrate è preferibile “subire un torto piuttosto che farlo”, appunto perché fare un torto, una violenza,
rovina e corrompe l’anima, un torto ricevuto invece non può danneggiare l’anima, cioè l’essenza dell’uomo, ma
solo il corpo o i beni materiali, che non sono essenziali per l’uomo.
Questo atteggiamento non-violento di Socrate si manifestò anche dopo il processo, quando Socrate accettò la
condanna e si rifiutò di fuggire dal carcere, malgrado i suoi amici avessero organizzato ogni cosa per la fuga.
Infatti la fuga dal carcere sarebbe stata una violazione della legge della Polis, mentre per Socrate l’unica arma
che l’uomo può usare è la sua ragione e la persuasione. Platone riferisce così le motivazioni di Socrate: « non si
deve disertare, né ritirarsi, né abbandonare il proprio posto, ma in guerra e in tribunale e in ogni altro luogo,
bisogna fare quello che la patria e la città comandano, oppure persuaderle in che consiste la giustizia: mentre far
uso di violenza è cosa empia ».
LA TEOLOGIA SOCRATICA
Abbiamo detto che Socrate fu condannato a morte anche per empietà, perché “non credeva negli dèi in cui
credeva la città e introduceva nuovi dèi ”. Effettivamente Socrate aveva una concezione della divinità come
intelligenza ordinatrice immateriale, quindi una concezione che rifiutava l’antropomorfismo e il materialismo
della religione greca ufficiale.
Socrate ha fornito una argomentazione razionale (che ci viene riferita da Senofonte e che rappresenta la prima
“prova” razionale dell’esistenza di Dio nella storia della filosofia) della sua concezione teologica: A) ciò che non
è semplice opera del caso, ma risulta costituito per raggiungere uno scopo e un fine, esige un’intelligenza che
l’abbia prodotto intenzionalmente; in particolare se osserviamo l’uomo, notiamo che tutti i suoi organi sono
connessi e finalizzati in maniera che non possono essere assolutamente spiegabili come opera del caso, ma
solamente come opera di un artefice intelligente; quindi per Socrate deve esistere un Dio artefice intelligente
9
dell’ ordine e dell’organizzazione che vediamo nella natura. B) Il fatto che questa divinità intelligente non sia
visibile non costituisce un’obiezione: infatti anche l’anima (= intelligenza) dell’uomo non è visibile, eppure
esiste e governa il comportamento finalizzandolo al conseguimento di scopi.
Socrate dice anche di avere un Dèmone personale (Daimon, essere intermedio tra divinità e uomo) che gli parla
interiormente avvertendolo e rimproverandolo quando fa o dice qualcosa di ingiusto e dannoso; questa voce
interiore ha anche “vietato” a Socrate di partecipare attivamente alla vita politica. Questo Daimon è stato
interpretato dagli studiosi in molti modi: potrebbe rappresentare la voce della coscienza (il rimorso, comune a
tutti gli uomini), potrebbe rappresentare un’esperienza eccezionale di Socrate, un’esperienza mistica o estatica,
potrebbe infine essere semplicemente un artificio retorico (come la Dea che rivela la verità a Parmenide).
CONCLUSIONI SU SOCRATE: IL CARATTERE PROBLEMATICO DELLA SAPIENZA SOCRATICA
Il discorso socratico apportava una quantità di tesi e idee innovative, ma lasciava una serie di problemi aperti.
In primo luogo il suo discorso sull’anima si limita a determinare la funzione e l’attività dell’anima, ed esige
approfondimenti: se l’anima si serve del corpo e lo domina, vuol dire che è altro dal corpo, che ontologicamente
se ne distingue. E allora che cos’è? Qual è il suo “essere”? Qual è la sua differenza rispetto al corpo?
Analogo discorso si deve fare a proposito di Dio: la Divina Intelligenza si colloca al di sopra degli elementi fisici,
ma in che cosa si distingue da essi?
Infine abbiamo osservato che Socrate si dichiara ignorante e che le sue “operazioni maieutiche” il più delle volte
risultano fallimentari: Socrate non riesce a far scaturire la verità dalla mente dei suoi interlocutori e quindi la
ricerca sui valori morali (il “bene”, il “giusto”, il “coraggio”, il “santo”) rimane incompiuta. Sembra allora che la
conoscenza-virtù di cui parla Socrate sia irrealizzabile, ma per Socrate il motto “la virtù è conoscenza” è vero in
due modi: esso indica non solo che basta conoscere in che cosa consiste la virtù per attuarla, ma anche che la
virtù coincide con la stessa attività di ricerca: il modo migliore per praticare la virtù (in attesa di sapere con
precisione in che cosa consista) è dedicare la vita a sforzarsi di capire che cosa sia: chi si comporta così non può
essere malvagio, e anzi è già virtuoso e felice, nella misura consentita dalla limitatezza della condizione umana.
Cionostante la filosofia di Socrate pare contrassegnata dallo scetticismo, ossia dall’idea che non sia possibile
conseguire risultati certi e definitivi nella conoscenza dei valori universali.
Il discepolo Platone si differenzierà dal maestro Socrate soprattutto perché cercherà di superare lo scetticismo
e di arrivare a una conoscenza certa e universale, dando risposta ai problemi insoluti della filosofia socratica.
LETTURE:
PLATONE: EUTIFRONE
INTRODUZIONE
Il deuteragonista che dà il nome al dialogo ( che porta anche il titolo " Sul santo " ) é una figura di "sacerdote"
di ben modesta statura morale. Nel nostro dialogo Eutifrone é un personaggio gretto e di statura morale assai
piccola . Egli fa il processo al padre non per malvagità , nè per ambizione , ma per cortezza di mente e
piccolezza d'animo . Nel suo fanatismo intollerante e nella sua sicurezza farisaica , non sa vedere la realtà nelle
sue giuste proporzioni . In sostanza , non é in malafede , in quanto é convinto di dover agire contro il padre per
non "contaminarsi" ; ma oltre che vittima di un concetto di contaminazione estremamente ambiguo , é in
errore in molti sensi . Ciò che Platone vuol suggerire con questo personaggio, é quanto segue. Eutifrone,
sacerdote della religione ufficiale, che professa con tanta sicurezza di possedere l'esatta conoscenza del santo e
dell'empio, non riesce, nella discussione con Socrate, se non a contraddirsi e a confondersi, mostrando di avere
conoscenze tutt'altro che chiare ( crede di fare cose sante accusando il padre , mentre cade nell'empietà)
Pertanto la religione ufficiale che Eutifrone rappresenta non ha affatto un adeguato concetto di santo . Socrate
invece ha superato quella fallace credenza sugli dei , con una ben più alta visione della divinità : proprio quella
concezione che voleva insegnare agli Ateniesi e per cui é stato condannato. Il dialogo si svolge nel 399 a.C.,
anno del processo di Socrate, e la scena é il portico del tribunale che si occupava dei processi riguardanti le
questioni connesse con questioni religiose, davanti al quale Socrate si trova per via della famosa accusa
mossagli dagli Ateniesi.
Socrate spiega ad Eutifrone di essere stato accusato di empietà , di corrompere i giovani e di molte altre cose .
Eutifrone, dal canto suo, tira in ballo la causa in corso con suo padre , che egli ha accusato dell' omicidio di un
suo dipendente con cui coltivava terreni a Nasso: infatti questo dipendente aveva ucciso un altro servo,
pertanto il padre di Eutifrone lo aveva picchiato e imprigionato, in attesa dell’intervento delle autorità ateniesi,
10
ma il dipendente, ferito e rinchiuso, era morto. Eutifrone poi aggiunge che tutti i suoi parenti sono contro di lui
perché sostengono che la vittima era già , dal canto suo , un assassino : ma che cosa c'entra questo , chiede
Eutifrone ? Essi , secondo lui , non sanno quale sia la legge divina circa il santo e l'empio . Ma che cosa é il santo
e che cosa l'empio, chiede Socrate , sfruttando la solita " ironia socratica " e dicendo di non saperlo
assolutamente , a differenza del sacerdote.
E da questa domanda si sviluppa il dialogo, che dunque ha come tema la definizione della santità.
dal Dialogo EUTIFRONE
Eutifrone, Socrate I.
Eu. Che c'è di nuovo, Socrate, che hai lasciato i trattenimenti del Liceo per venire oggi a trattenerti qui intorno al
Portico del re?. Non credo che anche tu abbia, come ho io, una causa davanti al re.
So. Veramente, Eutifrone, questa mia gli Ateniesi non la chiamano una causa, ma un'accusa.
Eu. Che dici? Qualcuno dunque ha sporto un'accusa contro di te? Perché non ti farò il torto di supporre che tu
accusi un altro.
So. No, di certo.
Eu. Ma un altro accusa te?
So. Precisamente.
Eu. E chi è costui?
So. In coscienza, Eutifrone, neppur io so bene chi egli sia. Deve però essere giovane ed ignoto. Lo chiamano, se non
erro, Meleto, ed è del demo di Pittos. Non hai tu per caso in mente un Meleto Pitteo, con zazzera, poca barba e
naso aquilino?
Eu. Non credo di conoscerlo, Socrate. Ma, insomma, di che ti accusa?
So. Di che? D’un’accusa che rivela un uomo non comune, mi sembra. Perché, così giovane, intendersi d'una
faccenda così grave, non è affare da nulla. Egli difatti, a quanto afferma, sa in che modo si corrompano i giovani e
chi siano quelli che li corrompono. E dev'essere un sapiente; s'è accorto della mia ignoranza, ha visto che
corrompo i suoi coetanei, e viene ad accusarmi alla città, come ad una madre comune. È, mi pare, il solo dei nostri
uomini di Stato che cominci bene, giacché è cominciar bene il prendersi cura prima di tutto dei giovani, in modo
che riescano ottimi, come il dovere d'un buon agricoltore è aver cura prima delle tenere piante e poi delle altre. E
perciò forse anche Meleto monda il terreno innanzi tutto di noi che corrompiamo, a suo dire, i germogli dei
giovani; e in seguito, quando si sarà messo a curare i più anziani, procaccerà evidentemente moltissimi e
grandissimi beni alla città, come c'è da aspettarselo da chi comincia a questo modo. (…)
Ora Eutifrone, sacerdote della religione olimpica e indovino, spiega che è lì per denunciare il padre che si è
reso colpevole della morte di un suo dipendente, che a sua volta aveva ucciso un altro servo. E spiega che vuole
denunciarlo e farlo punire perché altrimente rimarrebbe contaminato dal genitore omicida.
Eu. …Ed ora perciò mio padre e gli altri di casa ce l'hanno con me, perché per un omicida sporgo querela
d'omicidio contro mio padre, che, dicono, non l'uccise, e perché, quand'anche l'avesse ucciso, dal momento che il
morto era un omicida, non bisognava darsi pena per lui. E sentenziano che è un'empietà da parte d'un figlio
sporgere contro il padre una querela d'omicidio, perché, Socrate, non hanno un'idea precisa di quel che, secondo il
diritto divino è santo o empio.
So. Sicché tu, Eutifrone, in nome di Zeus, credi di vederci così chiaro nei giudizi divini, circa quello che è santo o
empio, da non temere che, stando i fatti come tu li hai narrati, con l'accusa contro tuo padre tu non commetta per
caso un'azione empia?
Eu. Non varrei nulla, Socrate, né Eutifrone sarebbe dappiù del volgo, s'io non sapessi a fondo tutte queste cose.
(…)
So. Ed è questa la ragione per cui, mio caro amico, desidero di farmi tuo discepolo, giacché vedo che mentre di te
né altri né questo Meleto mostrano d’accorgersi, quanto a me egli m'ha scorto così addentro e così facilmente da
accusarmi d'empietà. Or dunque, in nome di Zeus, dimmi ciò che asserivi di saper tanto bene: che cosa sia, secondo
te, pio, e che cosa empio, così in fatto d'omicidio, come in qualsiasi altro caso. O in ogni atto ciò che è santo non è
sempre identico a se stesso, e ciò che invece non santo contrario di tutto ciò che è santo ma sempre però identico a
sé?
Eu. Certamente, Socrate.
So. Su, dunque, rispondimi: come definisci ciò che è santo e ciò che non è santo?
Eu. Ebbene, io dico che la santità è fare quel che io fo ora: perseguire chi, sia padre sia madre sia un altro
11
qualunque, operi ingiustamente, commettendo o un omicidio o un furto sacrilego o qualche altra azione
colpevole; l'empietà invece nel non perseguirlo. Poiché, vedi, Socrate, ti addurrò la prova decisiva per dimostrare
che si fa bene a far così, a non avere alcuna indulgenza per l'empio, chiunque egli sia. Quegli stessi infatti, che
tengono Zeus per il migliore e il più giusto tra gli dei, ammettono che anch'egli incatenasse il proprio padre
perché divorava ingiustamente i figlioli, e che quello a sua volta avesse mutilato suo padre per colpe simili; e
s'adirano poi con me, perché chiamo in giudizio mio padre, che ha commesso un reato. E così sono in
contradizione con se stessi nel giudicare gli dei e me.
So. Ah! Eutifrone, che la ragione per cui mi son tirato addosso quest'accusa, sia appunto perché, quando degli dei
si raccontano delle storie siffatte, io non posso udirle senza sdegnarmene? E perciò, probabilmente, c'è chi dirà
ch'io pecco. Ma ora, poiché ci credi anche tu, che di queste cose t'intendi assai bene, dovremo per forza, mi pare,
convenirne anche noi. Che potremo infatti opporre noi che siamo i primi a confessare di non intendercene affatto?
Ma dimmi, in nome di Zeus protettore dell'amicizia: pensi tu davvero che quei fatti siano andati proprio a quel
modo?
Eu. Anzi ce n'è anche di più sorprendenti che la gente non sospetta nemmeno.
So. Sicché tu ritieni che ci siano realmente tra gli dei e guerre intestine e inimicizie terribili e battaglie e tante
altre cose dello stesso genere, che ci si raccontano dai poeti e di cui sono adorni per mano dei nostri migliori
artisti molti luoghi e oggetti sacri? Diremo che questi fatti son veri, Eutifrone?
Eu. E non solo codesti, Socrate, ma, come dicevo or ora, degli dei, se vuoi, ti racconterò tante altre storie, che a
udirle ne rimarrai, lo so bene, addirittura stupito.
So. Non ne dubito, ma queste me le racconterai un'altra volta. Per ora provati a spiegarmi più chiaramente quel
che ti chiedevo prima. Io t'avevo domandato che cosa mai fosse la santità; tu, amico, non m'hai insegnato a
dovere, ma mi hai detto che santo è suppergiù quel che fai ora, perseguendo d'omicidio tuo padre.
Eu. E ho detto la verità, Socrate.
So. Forse. Tuttavia, Eutifrone, ci sono molti altri atti che tu chiami santi.
Eu. Ci sono di certo.
So. Ebbene, ti ricorderai ch'io t'avevo pregato d'indicarmi, non uno o due di quei tanti atti che tu chiami santi, ma
precisamente quell'idea per cui tutto ciò che è santo è santo. Tu devi infatti avermi detto che in forza di un'unica
idea tutti gli atti empi sono empi e i santi santi. O non te ne rammenti?
Eu. Io, sicuro.
So. Dunque, insegnami precisamente qual è codesta idea, affinché, mirando ad essa e servendomene come d'un
esemplare, io dica santo quello che le somigli tra gli atti che tu o altri faccia, ed empio quello che non le somigli.
Eu. Ma se desideri così, Socrate, ti risponderò anche così.
So. Ma lo desidero certo.
Eu. Ebbene, quello che è caro agli dei è santo, quello che ad essi non è caro, empio.
So. Egregiamente, Eutifrone; ora mi hai risposto proprio così come ti pregavo di rispondermi. Se per altro m'hai
risposto in modo conforme al vero, non lo so ancora. Ma tu senza dubbio mi dimostrerai per giunta che quel che
dici è vero.
Eu. Indiscutibilmente.
So. Orsù, vediamo un po' che cosa diciamo. Ciò che è caro agli dei e l'uomo caro agli dei, è santo; ciò invece che è
odioso agli dei e l'uomo odioso ad essi, empio. E non sono la stessa cosa; ma il santo è il puro contrario dell'empio.
Non è così?
Eu. Appunto.
So. E ti pare che si sia detto bene?
Eu. Mi pare Socrate.
So. Però, Eutifrone, s'è anche detto che gli dei non sono d'accordo, che dissentono gli uni dagli altri, che c'è
dell'inimicizia tra loro?
Eu. Difatti s'è detto.
So. Orbene, mio eccellente amico, inimicizia ed ire sono l'effetto d'un dissenso su che cosa? Esaminiamo così: se io
e tu dissentiamo su un numero, quale dei due sia maggiore, questo dissenso potrebbe mai renderci nemici e
metterci in collera l'uno contro l'altro? O, fatto il conto, ci troveremmo su un punto simile immediatamente
d'accordo?
Eu. Sicuro. (…)
So. Ma quali sono allora gli argomenti, per i quali, in mancanza d'un criterio sicuro, diverremmo nemici tra noi e
monteremmo in collera? Forse non hai subito la risposta. Ma guarda se non siano questi che dico io: il giusto e
l'ingiusto, il bello e il brutto, il buono e il cattivo. Non son forse questi gli argomenti, su cui in caso di dissenso, ove
non si possa ricorrere a un mezzo di giudizio incontestabile, diventiamo tra noi nemici, quando lo diventiamo, e io
12
e tu e tutti gli altri uomini?
Eu. Ma sì, Socrate, è appunto qui il dissenso e su questi argomenti.
So. E gli dei, Eutifrone? Se dissentono, non dissentono forse per queste medesime ragioni?
Eu. Necessariamente.
So. E così, nobile Eutifrone, anche gli dei, stando alle tue parole, non tutti stimano le stesse cose o giuste o belle o
brutte o buone o cattive. Perché forse non litigherebbero tra loro, se non dissentissero intorno a questi argomenti.
O no?
Eu. Hai ragione.
So. E però quelle cose che ciascun di loro stima buone e giuste, sono appunto quelle che ama, laddove odia le cose
contrarie ad esse?
Eu. Certo.
So. Sono dunque le stesse cose, come tu dici, quelle che alcuni stimano giuste, altri ingiuste; e poiché intorno ad
esse non sono d'accordo, vengono a liti e a guerre gli uni con gli altri. Non è così?
Eu. Proprio così.
So. Sicché, le stesse cose, pare, sono odiate e amate dagli dei, e sarebbero perciò odiose e care agli dei.
Eu. Parrebbe.
So. E per conseguenza, Eutifrone, secondo questo ragionamento, sarebbero sante ed empie ad un tempo.
Eu. Probabilmente.
So. Ma tu non hai risposto, o amico meraviglioso, a quel che ti chiedevo; io non ti domandavo quello che a un
tempo si trova ad essere santo e non santo; quello che, pur essendo caro agli dèi è anche in odio ad essi, a quanto
sembra.
(…) A questo punto Socrate offre a Eutifrone una “via d’uscita” dalla contraddizione in cui si è inviluppato…
So. …Orbene, vogliamo correggere la nostra asserzione dicendo che quel che tutti gli dei odiano è empio; quel che
essi amano, santo, e quello che alcuni amano e altri odiano, né l'una né l'altra cosa, o l'una e l'altra cosa ad un
tempo? Preferisci dunque che si dia questa definizione della santità e dell'empietà?
Eu. E che difficoltà, Socrate?
So. Per me, Eutifrone, nessuna; ma tu rifletti al caso tuo, se, muovendo da questo presupposto, ti riuscirà poi tanto
facile d'insegnarmi quel che hai promesso.
Eu. Ma sì; io direi che il santo è ciò che tutti gli dei amano, e il contrario, ciò che tutti gli dei detestano, non santo.
So. E non vogliamo, Eutifrone, esaminare daccapo, se così è ben detto? O lasceremo correre, e saremo così
indulgenti con noi stessi e con gli altri, che non appena qualcuno asserisca che una cosa stia ad un certo modo,
ammetteremo che sia così? O è necessario esaminare che cosa dice chi parla?
Eu. È necessario, certo. Però io credo che così ora si sia detto bene.
So. Tra poco, mio buon amico, lo sapremo meglio. Rifletti un po' a questo: il santo si ama dagli dei perché santo, o
perché s'ama è santo?
Eu. Non intendo ciò che vuoi dire, Socrate.
(…)
So. Perché dunque è santo si ama, non già perché si ama è santo?
Eu. Pare.
So. Perché siamo d'accordo che il santo si ama perché è santo, ma non è santo perché si ama. O no?
Eu. È vero.
So. (…) Ed io temo, Eutifrone, che tu, richiesto che cosa sia il santo, non me ne abbia voluto chiarire l'essenza, e
me ne abbia indicato appena una qualità: che al santo accade questo, d'essere amato da tutti gli dei. Ma quel che
sia, non me l'hai ancora detto. E però, se ti piace, non tenermelo nascosto, ma dimmi daccapo: che è il santo, sia
esso amato dagli dei o soggetto a qualsiasi altro accidente, perché su questo non litigheremo. Orsù, fatti animo e
di' che è la santità e che l'empietà.
Eu. Ma, Socrate, io non so proprio come spiegarti il mio pensiero. (…)
So. Ora, io so bene che tu pensi di conoscere con sicurezza ciò che è santo e ciò che non lo è: dimmelo dunque, o
carissimo Eutifrone, e non nascondermi cosa pensi di questo.
Eu. Un'altra volta, o Socrate, ora mi affretto ad andare in un luogo ed è ora, per me, che vada.
So. Oh, che fai, amico! Te ne vai e mi fai precipitare da una grande speranza che avevo, che avendo appreso da te
le cose sante e quelle non sante, mi sarei scrollato di dosso l'accusa di Meleto, dimostrando a lui che, in fatto di
cose divine, io sono diventato sapiente a opera di Eutifrone, e non avrei più agito con ignoranza né mi sarei
13
pronunciato con leggerezza riguardo ad esse, e avrei appunto vissuto meglio il resto della mia vita.
Il dialogo dunque si conclude con Eutifrone che batte in ritirata e abbandona il campo per sfuggire alle
incalzanti domande di Socrate, ma non vuole ammettere la propria sconfitta.
E il dialogo si chiude nel segno dell'ironia, ma senza che i due protagonisti siano giunti a una definizione
accettabile della santità.
BRANI DA “APOLOGIA DI SOCRATE” Trad. di Maria Chiara Pievatolo (pubblicata sul Web)
L’AUTODIFESA DI SOCRATE:
(...) Ma forse qualcuno potrebbe dire: - Socrate, non ti vergogni di esserti dedicato ad una attività per la quale sei
ora esposto al rischio di morire?
Io avrei ragione di ribattere: - Ragazzo, non ragioni correttamente, se pensi che un uomo, anche di valore
modesto, debba tener conto di essere vivo o morto, e non debba invece considerare, quando agisce, solo questo: se
agisce giustamente o ingiustamente e se le sue opere sono da uomo buono o cattivo. Infatti, a tuo dire, sarebbero
dei mediocri tutti i semidei che hanno concluso la loro vita a Troia, fra cui il figlio di Tetide che preferì affrontare
il pericolo piuttosto che la vergogna. (…) Pensi che lui si sia preoccupato della morte e del pericolo? –
Perché in verità è così, cittadini ateniesi: dove uno si sia schierato da sé, perché lo riteneva il posto migliore, o
dove sia stato messo da un comandante, lì si deve - secondo me - avere il coraggio di restare, senza curarsi né
della morte né di altro di fronte alla vergogna. Cittadini ateniesi, quando i comandanti che voi sceglieste per me
mi schierarono in battaglia a Potidea, ad Anfipoli e a Delio, rimasi dove mi avevano disposto, come qualsiasi altro,
e rischiavo di morire. Farei dunque una azione terribile se, quando invece a schierarmi è il dio, come io ho
supposto e inteso, con l'ordine di vivere facendo filosofia ed esaminando me stesso e gli altri, avessi paura della
morte o di qualunque altra cosa e abbandonassi il mio posto. Sarebbe una cosa terribile, e mi si potrebbe certo
portare in tribunale giustamente, con l'accusa di non credere che gli dei esistano, perché disubbidisco all'oracolo,
ho paura della morte e penso di essere sapiente senza esserlo. Infatti, cittadini, aver paura della morte non è
nient'altro che sembrare sapiente senza esserlo, cioè credere di sapere quello che non si sa. Perché nessuno sa se
per l'uomo la morte non sia per caso il più grande dei beni, eppure la temono come se sapessero bene che è il più
grande dei mali. E credere di sapere quello che non si sa non è veramente la più vergognosa forma di ignoranza?
Io, cittadini, sono diverso dalla maggior parte degli uomini forse anche per questo, e se dovessi dichiarare che
sono più sapiente di qualcuno in qualcosa, direi che lo sono perché, non sapendo abbastanza di quanto avviene
nell'Ade, non penso neppure di conoscerlo. Però una cosa la so: agire ingiustamente e disubbidire a chi è migliore
di noi, uomo o dio che sia, è cattivo e vergognoso. Di fronte a mali che so essere tali io non mi spaventerò né
fuggirò mai quello che non so se sia, per caso, bene. (…)
- Cittadini ateniesi, io vi amo e vi rispetto, ma ubbidirò al dio piuttosto che a voi, e finché avrò respiro e sarò in
grado di farlo, non smetterò di fare filosofia, di consigliarvi e di insegnare a chiunque incontri di voi, dicendo,
come sono solito: "O ottimo uomo, tu che sei Ateniese, della città più grande e famosa per sapienza e forza, non ti
vergogni di preoccuparti dei soldi, per averne più che puoi, della reputazione e dell'onore, senza però curarti e
darti pensiero della saggezza, della verità e dell'anima, perché sia la migliore possibile?" E se qualcuno di voi mi
contesta, affermando di prendersene cura, non lo lascerò subito andare né me ne andrò io, ma lo interrogherò, lo
esaminerò e lo confuterò, e se mi sembrerà che non abbia virtù se non a parole, lo rimprovererò perché disprezza
quello che vale di più e apprezza quello che vale di meno. Farò questo a chiunque incontri, giovane e vecchio,
forestiero e cittadino, ma soprattutto ai cittadini, in quanto mi siete più vicini per nascita. Perché questo è quello
che mi ordina il dio - tenetelo presente - e io penso che alla città finora non sia accaduto nessun bene più grande
del mio servizio al dio. Infatti io me ne vado in giro senza fare altro se non persuadervi, giovani e vecchi, a non
preoccuparvi né del corpo né dei soldi più che dell'anima, perché sia quanto migliore possibile, dicendo: "La virtù
non deriva dalla ricchezza, ma dalla virtù provengono la ricchezza e tutti gli altri beni per gli uomini, sia come
privati sia in quanto comunità." E se dicendo questo corrompo i giovani, consideratelo pure dannoso: ma se
qualcuno afferma che dico cose diverse da queste, dice il falso. (…)
Non schiamazzate, cittadini ateniesi, ma continuate a comportarvi come vi ho chiesto, ascoltandomi senza far
chiasso su quello che dico, anche perché - credo - ne trarrete beneficio. Infatti sto per aggiungere qualcos'altro
che forse vi farà schiamazzare; ma statevene zitti. Tenete presente che se mi condannate a morte, perché sono
come dico di essere, non danneggerete me più di voi stessi: a me, infatti. niente mi può danneggiare, né Meleto né
Anito - non ne sarebbero neppure capaci - in quanto, credo, non è permesso che un uomo migliore sia danneggiato
14
da uno peggiore. Forse mi può uccidere o esiliare o disonorare; ma mentre egli e qualcun altro possono credere
che questi siano grandi mali, io non lo credo, e considero invece un male molto maggiore fare ciò che loro stanno
facendo ora, cioè tentare di condannare ingiustamente a morte un uomo. Perciò, cittadini ateniesi, io non parlo
per difendere me stesso, come qualcuno potrebbe supporre, ma per voi, perché non abbiate ad errare su quello
che il dio vi dato, votando contro di me. Infatti se mi condannate, non troverete facilmente un altro che - sia pur
detto in modo ridicolo - venga assegnato dal dio alla città come a un cavallo grande e nobile, ma pigro a causa
della sua grandezza e bisognoso di essere svegliato da un qualche tafano. Perché mi sembra che il dio mi abbia
posto sulla città con questa funzione: non smettere di stare appresso a voi - a ciascuno di voi - tutto il giorno e
dovunque per stimolarvi, convincervi e rimproverarvi. Un altro tipo così, cittadini, non vi rinascerà facilmente:
risparmiatemi, se mi date retta. (…)
IL DISCORSO DI SOCRATE DOPO LA CONDANNA A MORTE
Cittadini ateniesi, riceverete, da parte chi vuole insultare la città, la fama e la colpa di aver ucciso Socrate, uomo
sapiente - perché chi vi vuole offendere dirà che sono sapiente, anche se non lo sono - per guadagnare non molto
tempo davvero: se aveste aspettato un poco, la cosa sarebbe avvenuta da sé. Vedete la mia età, già avanti nella
vita, e anzi vicina alla morte. Questo non lo dico a tutti voi, ma a quelli che hanno votato per la mia condanna a
morte. E a loro dico anche questo: voi forse credete, cittadini ateniesi, di avermi colto in difetto di discorsi con cui
convincervi, se avessi ritenuto indispensabile fare e dire di tutto pur di sfuggire alla condanna. Ma non è così. Sono
stato colto in difetto, ma non certo di discorsi, bensì di sfrontatezza e spudoratezza, e di voglia di dirvi quello che
avreste ascoltato con più piacere: lamenti, pianti e molte altre azioni e parole indegne di me - dico - ma che voi
siete abituati a sentire dagli altri. Tuttavia, io non ritenni allora doveroso comportarmi in modo indegno di un
uomo libero per paura del pericolo, e non mi pento ora di essermi difeso così, ma preferisco di gran lunga morire
con questa autodifesa che vivere in quel modo. Perché né in tribunale, né in guerra, né altrove, nessuno deve
ricorrere a espedienti di quel genere per sfuggire in tutti i modi alla morte. Anche nelle battaglie spesso si rende
chiaro che qualcuno potrebbe evitare di morire gettando le armi e voltandosi a supplicare chi lo insegue; e in tutti
i pericoli ci sono molti altri espedienti per sfuggire alla morte, se non ci si fa scrupolo di fare e dire qualunque
cosa. Ma, cittadini, forse evitare la morte non è difficile, ed è molto più difficile evitare la malvagità, perché corre
più veloce della morte. E ora io, che sono così lento e vecchio, sono stato catturato dalla più lenta, mentre i miei
accusatori, che sono così bravi e svelti, li ha presi la più veloce, la cattiveria. E ora me ne vado, io condannato a
morte da voi, loro condannati alla malvagità e all'ingiustizia dalla verità. Io mantengo la mia pena, loro la loro.
Forse era in qualche modo necessario che fosse così; e io penso che sia secondo la giusta misura.
Ma desidero fare una predizione a voi, che avete votato contro di me: perché sono già là dove le persone sono più
propense a fare predizioni, quando stanno per morire. Io vi dico, uomini che mi avete ucciso, che ci sarà per voi
una retribuzione, subito dopo la mia morte, molto più dura di quella pena cui mi avete condannato. Perché voi
ora avete fatto questo credendo di liberarvi dal compito di esporre la vita a esame e confutazione, ma ne deriverà
tutto il contrario, ve lo dico io. A mettervi sotto esame per confutarvi saranno di più: quelli che finora trattenevo,
di cui voi non vi accorgevate; e saranno tanto più duri quanto più sono giovani, e tanto più ne sarete irritati.
Perché se pensate che basti uccidere le persone per impedire di criticarvi perché non vivete rettamente, non
pensate bene. Non è questa la liberazione - né possibile, né bella - ma quella, bellissima e facilissima, non di
reprimere gli altri, bensì preparare se stessi per essere quanto possibile eccellenti. Con questo vaticinio per voi che
avete votato contro di me prendo congedo.
Ora mi piacerebbe discutere su quello che è accaduto con chi ha votato per la mia assoluzione, mentre i
magistrati sono occupati e non vado ancora dove bisogna morire. State con me, cittadini, per questo tempo:
niente impedisce che conversiamo fra di noi, finché è permesso. A voi, perché mi siete amici, ho voglia di far vedere
qual è il senso di quello che mi è successo oggi. Perché a me, giudici - e chiamandovi giudici credo di chiamarvi
correttamente - è accaduto qualcosa di meraviglioso. La solita voce oracolare - la voce di qualcosa di demonico prima mi era continuamente vicina e si opponeva sempre, anche su cose di poco conto, se stavo per fare qualcosa
di non giusto. Ora mi è successo - lo vedete da voi - questo, che qualcuno potrebbe considerare un male estremo e
che è creduto tale. Ma il segno del dio non mi ha trattenuto né la mattina presto, mentre uscivo di casa, né
quando salivo qui in tribunale, né in nessun punto del discorso, mentre stavo per dire qualcosa. Eppure molte
volte, in altri discorsi, mi ha addirittura interrotto; oggi, invece, non mi si è mai opposto in nulla di quello che
facevo e dicevo. Quale suppongo ne sia la causa? Ve lo dirò: quello che è successo ha l'aria di essere stato un bene e
non è possibile che abbia ragione chi di noi pensa che morire sia un male. Ne ho avuto una grande prova: se quello
che stavo per fare non fosse stato un bene, il segno consueto non avrebbe mancato di trattenermi.
Ma consideriamo per quale altro motivo sia così grande la speranza che morire sia un bene. Morire è una di
15
queste due cose: o chi è morto non è e non ha percezione di nulla, oppure morire, come si dice, può essere per
l'anima una specie di trasformazione e di trasmigrazione da qui a un altro luogo. E se è assenza di percezione
come un sonno, quando dormendo non si vede niente, neanche un sogno, allora la morte sarebbe un meraviglioso
guadagno - perché io penso che se qualcuno, dopo aver scelto quella notte in cui dormì così profondamente da
non vedere neppure un sogno, e paragonato a questa le altre notti e giorni della sua vita, dovesse dire, tutto
considerato, quanti giorni e quante notti abbia vissuto meglio e più dolcemente di quella notte, penso che non solo
un qualsiasi privato, ma lo stesso Gran Re troverebbe, rispetto agli altri, questi giorni e queste notti facili da
contare - se dunque è questa la morte, io dico che è un guadagno; anche perché così il tempo tutto intero non
sembra più di una notte sola. Se d'altra parte la morte è un emigrare da qui a un altro luogo, ed è vero quel che si
dice, che dunque tutti i morti sono là, o giudici, che bene ci può essere più grande di questo? Perché se qualcuno,
arrivato all'Ade, liberatosi dai sedicenti giudici di qui, troverà quelli che sono giudici veramente, che appunto si
dice giudichino là, Minasse, Radamanto, Eaco, Trittolemo e tutti gli altri semidei che furono giusti nella loro vita,
potrà forse essere, questa, una migrazione da nulla? O ancora per stare con Orfeo e con Museo, con Esiodo e con
Omero, quanto ciascuno di voi accetterebbe di pagare? Se questo è vero, da parte mia sono disposto a morire più
volte. Oltretutto, per l'appunto, là io avrei davvero un passatempo straordinario, se m'imbattessi in Palamede, in
Aiace Telamonio o in qualcun altro degli antichi morto per un giudizio ingiusto, paragonando le mie esperienze
alle loro - non credo che sarebbe spiacevole - e soprattutto non sarebbe spiacevole continuare ad esaminare ed
interrogare quelli di là come quelli di qua, per capire chi di loro è sapiente e chi crede di esserlo, ma non lo è.
Quanto sarebbe disposto a pagare chiunque di voi, giudici, per mettere sotto esame chi condusse contro Troia il
grande esercito, o Odisseo, o Sisifo, o gli innumerevoli altri di cui si potrebbe dire, uomini e donne? Discutere con
loro e starci insieme e metterli sotto esame non sarebbe una inconcepibile felicità? In ogni caso la gente di là non
mi può certo far morire per questo: se quanto si dice è vero, quelli di là sono più felici di quelli di qua anche per
altri aspetti e sono già immortali per il tempo che rimane.
Ma bisogna, giudici, che anche voi speriate bene davanti alla morte e teniate in mente questa verità, che non può
esserci male per un uomo buono, né da vivo né da morto, e niente di quanto lo riguarda è trascurato dagli dei;
anche le mie vicende d'ora non sono avvenute da sé, ma mi è chiaro che ormai per me morire ed esser liberato dal
peso dell'azione era la cosa migliore. Per questo anche il segno non è mai intervenuto a distogliermi ed io
personalmente non provo nessun rancore verso chi mi ha votato contro e chi mi ha accusato. A dire il vero, non mi
hanno votato contro ed accusato con questa intenzione, ma pensando di danneggiarmi, e perciò meritano di
essere biasimati. Tuttavia, a loro faccio questa preghiera: i miei figli, una volta cresciuti, puniteli, cittadini,
tormentandoli come io tormentavo voi, se vi sembra che si preoccupino dei soldi e d'altro prima che delle virtù; e
se fanno finta di essere qualcosa ma non sono nulla, svergognateli come io facevo con voi, perché non si prendono
cura di ciò di cui occorre curarsi e pensano di essere qualcosa senza valer nulla. E se farete così, io sarò trattato
giustamente da voi, ed anche i miei figli.
Ma è già l'ora di andarsene, io a morire, voi a vivere; chi dei due però vada verso il meglio, è cosa oscura a tutti,
meno che al dio.
16