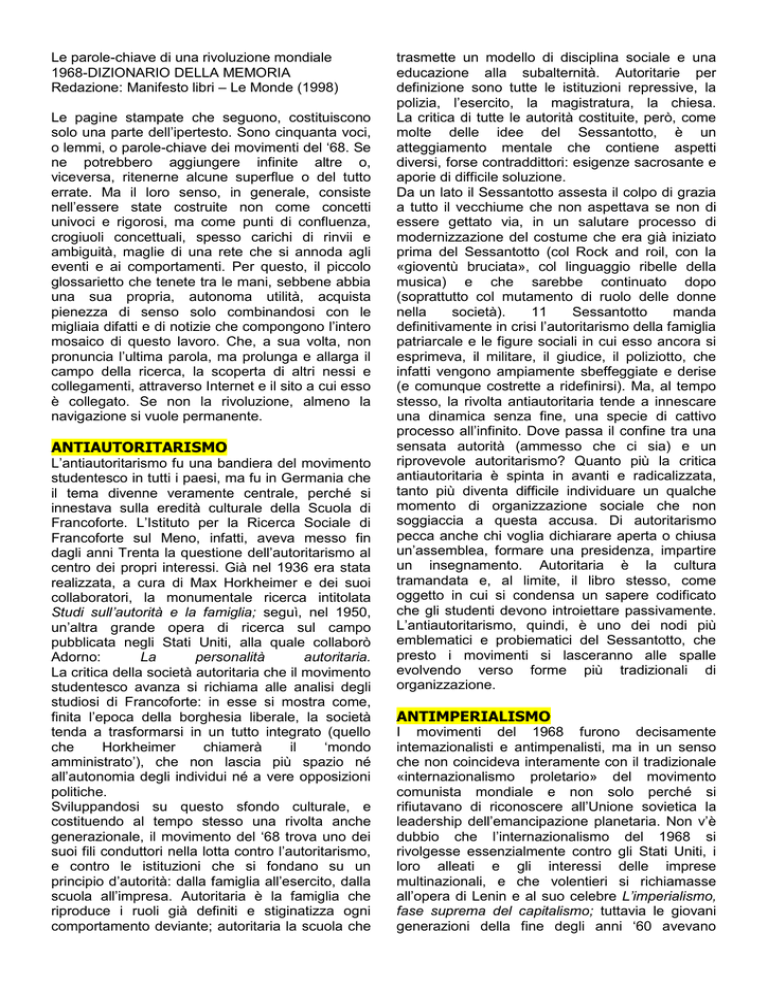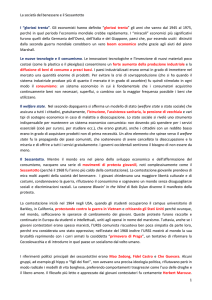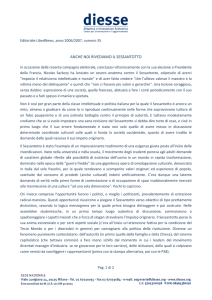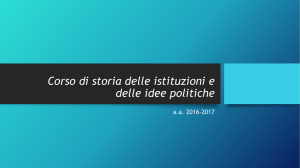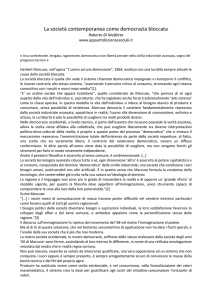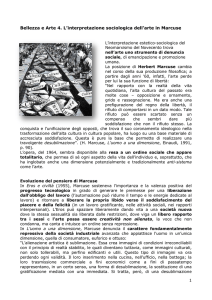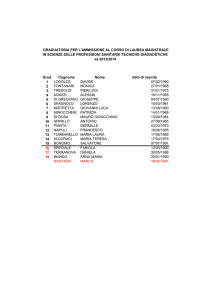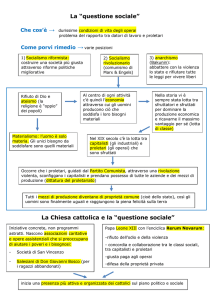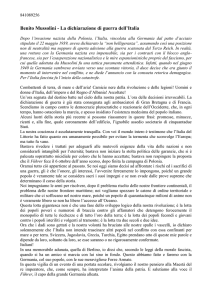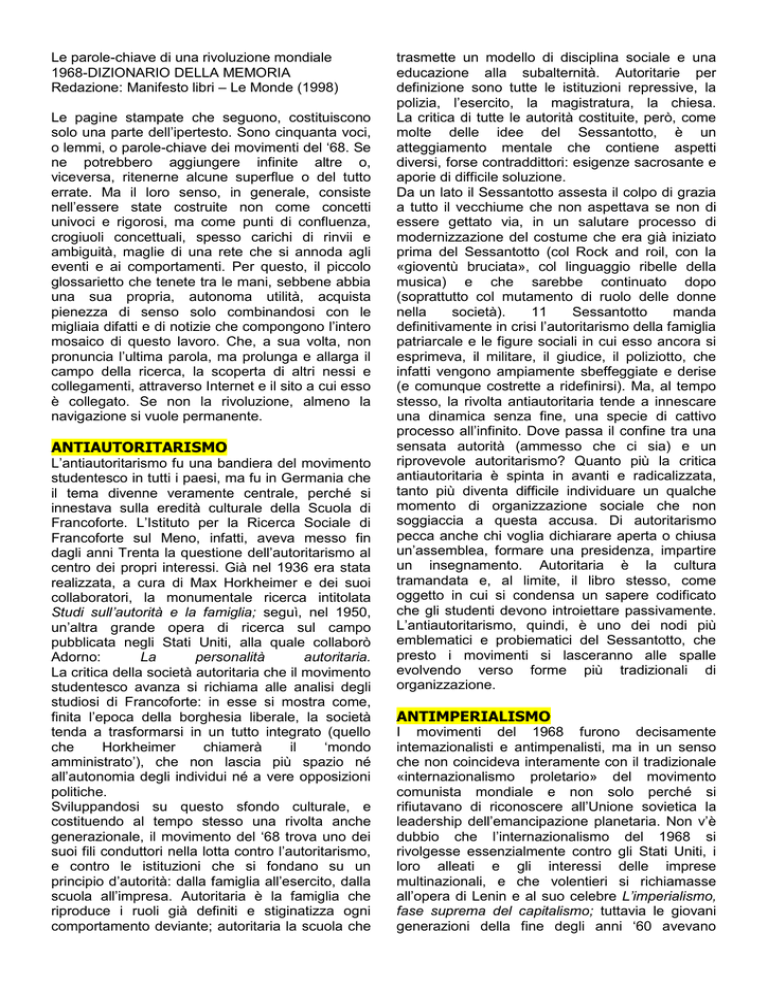
Le parole-chiave di una rivoluzione mondiale
1968-DIZIONARIO DELLA MEMORIA
Redazione: Manifesto libri – Le Monde (1998)
Le pagine stampate che seguono, costituiscono
solo una parte dell’ipertesto. Sono cinquanta voci,
o lemmi, o parole-chiave dei movimenti del ‘68. Se
ne potrebbero aggiungere infinite altre o,
viceversa, ritenerne alcune superflue o del tutto
errate. Ma il loro senso, in generale, consiste
nell’essere state costruite non come concetti
univoci e rigorosi, ma come punti di confluenza,
crogiuoli concettuali, spesso carichi di rinvii e
ambiguità, maglie di una rete che si annoda agli
eventi e ai comportamenti. Per questo, il piccolo
glossarietto che tenete tra le mani, sebbene abbia
una sua propria, autonoma utilità, acquista
pienezza di senso solo combinandosi con le
migliaia difatti e di notizie che compongono l’intero
mosaico di questo lavoro. Che, a sua volta, non
pronuncia l’ultima parola, ma prolunga e allarga il
campo della ricerca, la scoperta di altri nessi e
collegamenti, attraverso Internet e il sito a cui esso
è collegato. Se non la rivoluzione, almeno la
navigazione si vuole permanente.
ANTIAUTORITARISMO
L’antiautoritarismo fu una bandiera del movimento
studentesco in tutti i paesi, ma fu in Germania che
il tema divenne veramente centrale, perché si
innestava sulla eredità culturale della Scuola di
Francoforte. L’Istituto per la Ricerca Sociale di
Francoforte sul Meno, infatti, aveva messo fin
dagli anni Trenta la questione dell’autoritarismo al
centro dei propri interessi. Già nel 1936 era stata
realizzata, a cura di Max Horkheimer e dei suoi
collaboratori, la monumentale ricerca intitolata
Studi sull’autorità e la famiglia; seguì, nel 1950,
un’altra grande opera di ricerca sul campo
pubblicata negli Stati Uniti, alla quale collaborò
Adorno:
La
personalità
autoritaria.
La critica della società autoritaria che il movimento
studentesco avanza si richiama alle analisi degli
studiosi di Francoforte: in esse si mostra come,
finita l’epoca della borghesia liberale, la società
tenda a trasformarsi in un tutto integrato (quello
che
Horkheimer
chiamerà
il
‘mondo
amministrato’), che non lascia più spazio né
all’autonomia degli individui né a vere opposizioni
politiche.
Sviluppandosi su questo sfondo culturale, e
costituendo al tempo stesso una rivolta anche
generazionale, il movimento del ‘68 trova uno dei
suoi fili conduttori nella lotta contro l’autoritarismo,
e contro le istituzioni che si fondano su un
principio d’autorità: dalla famiglia all’esercito, dalla
scuola all’impresa. Autoritaria è la famiglia che
riproduce i ruoli già definiti e stiginatizza ogni
comportamento deviante; autoritaria la scuola che
trasmette un modello di disciplina sociale e una
educazione alla subalternità. Autoritarie per
definizione sono tutte le istituzioni repressive, la
polizia, l’esercito, la magistratura, la chiesa.
La critica di tutte le autorità costituite, però, come
molte delle idee del Sessantotto, è un
atteggiamento mentale che contiene aspetti
diversi, forse contraddittori: esigenze sacrosante e
aporie di difficile soluzione.
Da un lato il Sessantotto assesta il colpo di grazia
a tutto il vecchiume che non aspettava se non di
essere gettato via, in un salutare processo di
modernizzazione del costume che era già iniziato
prima del Sessantotto (col Rock and roil, con la
«gioventù bruciata», col linguaggio ribelle della
musica) e che sarebbe continuato dopo
(soprattutto col mutamento di ruolo delle donne
nella
società).
11
Sessantotto
manda
definitivamente in crisi l’autoritarismo della famiglia
patriarcale e le figure sociali in cui esso ancora si
esprimeva, il militare, il giudice, il poliziotto, che
infatti vengono ampiamente sbeffeggiate e derise
(e comunque costrette a ridefinirsi). Ma, al tempo
stesso, la rivolta antiautoritaria tende a innescare
una dinamica senza fine, una specie di cattivo
processo all’infinito. Dove passa il confine tra una
sensata autorità (ammesso che ci sia) e un
riprovevole autoritarismo? Quanto più la critica
antiautoritaria è spinta in avanti e radicalizzata,
tanto più diventa difficile individuare un qualche
momento di organizzazione sociale che non
soggiaccia a questa accusa. Di autoritarismo
pecca anche chi voglia dichiarare aperta o chiusa
un’assemblea, formare una presidenza, impartire
un insegnamento. Autoritaria è la cultura
tramandata e, al limite, il libro stesso, come
oggetto in cui si condensa un sapere codificato
che gli studenti devono introiettare passivamente.
L’antiautoritarismo, quindi, è uno dei nodi più
emblematici e probiematici del Sessantotto, che
presto i movimenti si lasceranno alle spalle
evolvendo verso forme più tradizionali di
organizzazione.
ANTIMPERIALISMO
I movimenti del 1968 furono decisamente
intemazionalisti e antimpenalisti, ma in un senso
che non coincideva interamente con il tradizionale
«internazionalismo proletario» del movimento
comunista mondiale e non solo perché si
rifiutavano di riconoscere all’Unione sovietica la
leadership dell’emancipazione planetaria. Non v’è
dubbio che l’internazionalismo del 1968 si
rivolgesse essenzialmente contro gli Stati Uniti, i
loro alleati e gli interessi delle imprese
multinazionali, e che volentieri si richiamasse
all’opera di Lenin e al suo celebre L’imperialismo,
fase suprema del capitalismo; tuttavia le giovani
generazioni della fine degli anni ‘60 avevano
sviluppato un interesse politico-antropologico per
le culture «altre», considerate non solo come
masse oppresse da liberare, ma anche come
portatrici di valori ed esperienze necessari a
scardinare le abitudini e le regole borghesi
dell’Occidente
sviluppato.
Questa
diversità
assumeva talvolta le sembianze, come nel caso
della Cina o di Cuba, di un comunismo
«autentico»
da
contrapporre
a
quello
burocratizzato, cinico e autoritario dell’Urss e dei
paesi del patto di Varsavia, tal’altra quelle delle
filosofie orientali o di tradizioni comunitarie rimaste
ai margini della modernizzazione capitalistica.
Comunque culture «altre», cui si chiedeva di
indicare qualcosa di diverso, e di migliore, dai miti,
dai riti e dalle merci della società opulenta. Da
questa impostazione si sarebbe sviluppata in
seguito una linea critica verso l’ideologia
progressista e i miti dello sviluppo, in parte
ereditata dai movimenti verdi dell’ultimo ventennio.
Del Vietnam, per esempio, non appassionava solo
la difesa senza compromessi del principio di
autodeterminazione e la propensione per il
socialismo, ma anche quel talento artigianale e
contadino della guerra, quelle trappole di liane e
aculei, quella creatività povera e ingegnosa e
soprattutto quel fitto, solidissimo, tessuto di
rapporti e di solidarietà comunitarie che
circondavano da ogni parte ed insidiavano non
solo gli uomini, ma la cultura stessa
dell’occupazione. La resistenza cli questo «altro»,
culturale e politico, offriva un formidabile principio
di legittimazione e una speranza di successo per
la resistenza di ogni «altro» perseguitato nelle
cittadelle del mondo sviluppato.
Anche per questo il Vietnam fu al centro
dell’internazionalismo del 1968. Mai come in quel
frangente, una guerra guerreggiata e un
movimento di solidarietà, che attraversava tutto il
mondo, avevano agito all’unisono e con un esito
tanto fattuale. I movimenti di contestazione si
consideravano, a buon diritto, come un
«proseguimento della guerra vietnamita con altri
mezzi».
E l’intervento americano in Indocina divenne il
prototipo di ogni politica di potenza e
sopraffazione. Gli orrori della guerra vietnamita, i
feroci regimi tenuti in vita in America latina,
mettevano in discussione la qualità politica delle
democrazie occidentali postbelliche e la loro
stessa tradizione civile. Per le giovani generazioni
del mondo sviluppato, la violenza dispiegata
contro i popoli del terzo mondo era la prova
tangibile di quanto limitata e condizionata fosse la
libertà che veniva loro promessa, apparente la
pluralità delle scelte consentite, ipocrita la buona
coscienza del dopoguerra.
Nelle
sue
versioni
più
estreme,
il
«terzomondismo» degli anni ‘60 e 70 confidava
esdusivamente nelle lotte di liberazione dei popoli
del terzo mondo per sconfiggere le ingiustizie
insite nel modello di sviluppo capitalistico,
ritenendo la classe operaia del mondo sviluppato
«integrata» nel «sistema» e, in conseguenza,
beneficiaria, seppure di infimo rango, dello
sfruttamento dei paesi poveri da parte dei paesi
ricchi. Insensibile, dunque, allo scandalo morale
implicito nei mezzi impiegati per salvaguardare gli
interessi dell’Occidente nel resto del mondo.
Secondo questa linea interpretativa, nei paesi
sfruttati del Terzo mondo che non avevano nulla
da perdere, dal Vietnam all’America latina, dove si
impugnavano le armi, li si situavano i «punti alti»
della lotta di dasse. Ai giovani rivoluzionari delle
metropoli, spettava il compito di lavorare ai fianchi
gli aggressori, di agire dietro alle linee insieme con
il «terzo mondo interno», come i neri americani e
gli
altri
esdusi
dalla
società
affluente.
Nel 1968 era ancora viva la memoria della
stagione delle indi- pendenze e il trauma della
guerra d’Algeria. La guerra coloniale era in corso
nei possedimenti portoghesi in Africa. I «due, tre,
cento
Vietnam»,
predicati
da
Guevara,
sembravano una realtà incontrovertibile. Gli
interessi economici e geopolitici dell’Occidente
opponevano una resistenza senza esclusione di
colpi ai movimenti di emancipazione nel mondo
postcoloniale. La triste involuzione che i
nazionalismi del terzo mondo avrebbero subito,
anche a causa di questa resistenza, restava
ancora in ombra. E non minava la speranza che
dalla rivolta dei paesi poveri sarebbe potuta
scaturire una prospettiva di liberazione generale.
La disillusione fu enorme, tale da offuscare perfino
le indubitabili ragioni di quella stagione di lotte.
ANTIPSICHIATRIA
Prima di diventare uno dei poli culturali a cui
guarda
il
movimento
del
Sessantotto,
l’antipsichiatria è una corrente di pensiero che si
sviluppa durante gli anni Sessanta attraverso la
critica della psicanalisi e della psichiatria ufficiale.
Lo sfondo culturale, più o meno remoto, è nella
riscoperta di correnti e autori che la psichiatria
accademica aveva lasciato cadere nell’oblio:
innanzitutto l’analisi esistenziale e fenomenologica
di Minkowski e Binswanger, che si era sviluppata a
partire da alcune tra le più rilevanti esperienze
filosofiche del Novecento: la fenomenologia di
Husserl, l’esistenzialismo di Jaspers, l’analitica
dell’Esserci delineata da Martin Heideggeer nel
suo primo capolavoro ifiosofico, Essere e tempo.
Come movimento di idee, l’antipsichiatria si
sviluppa fin dall’inizio come un arcipelago diffuso a
livello internazionale, e molto differenziato al suo
interno. In Gran Bretagna gli esponenti più noti
sono Ronald Laing (l’autore de L’Io diviso) e David
Cooper (cui si deve un altro libro che ebbe grande
successo, La morte della famiglia); negli Stati Uniti
Thomas Szasz; mentre in Italia la critica delle
istituzioni psichiatriche trova il suo più significativo
portavoce in Franco Basaglia, per le cui cure uscì
un libro che nel Sessantotto ebbe enorme
successo, L’istituzione negata — Rapporto da un
ospedale psichiatrico.
Le varie tendenze antipsichiatriche contestano
innanzitutto le forme correnti di trattamento dei
malati di mente, per giungere fino una critica
radicale del concetto di malattia mentale.
Nonostante quello che tante volte si è scritto, da
parte dei numerosi denigratori, l’antipsichiatria non
nega l’esistenza della malattia mentale, o meglio
non nega che si diano stati di disagio e di
sofferenza psicologica individuale, né che si diano
comportamenti che, misurati secondo i metri
consueti, appaiono completamente irrazionali,
incomprensibili e quindi «foffi». Quello che cambia
completamente, però, è la posizione in cui
l’operatore psichiatrico si colloca nei confronti di
questo disagio. Per cominciare l’antipsichiatrica
rifiuta le terapie coatte e soprattutto la
segregazione manicomiale, che non ha alcun
valore terapeutico ma ha soio la funzione di
escludere, dalla vista della società, quegli elementi
nei quali si catalizza, o viene a deflagrazione, un
disagio che ha radici molto più ampie. Ma
soprattutto, nella prospettiva dell’antipschiatria, il
disagio mentale, anziché venir segregato,
dev’essere interpretato: esso è un modo in cui
l’individuo risponde a condizionamenti o a pretese
contraddittorie che il suo ambito di relazioni sociali,
a cominciare ovviamente dalla famiglia, solleva nei
suoi confronti. 11 deviante è l’anello debole sul
quale si scaricano le tensioni derivanti da
situazioni patogene. Malato non è l’individuo
sofferente, ma il contesto che genera la sua
«malattia».
In Italia, a partire da questo filone, ebbe uno
straordinario impatto, culturale e politico,
l’esperimento avviato da Franco Basaglia
nell’ospedale psichiatrico di Gorizia: porte aperte,
abbattimento di grate e reti, abbandono della
contenzione fisica dei malati, gestione comunitaria
dell’istituzione. A partire da questa esperienza si
rafforzerà la denuncia dell’inutile sadismo
dell’istituzione manicomiale, attraverso una lunga
battaglia che porterà infine, in Italia come altrove,
alla chiusura dei manicomi e alla difficile
costruzione di nuove strutture di aiuto e di cura del
disagio mentale.
Quella di Basaglia fu anche un’esperienza che
intrecciò rubito un rapporto, non privo anche di
malintesi e di contraddizioni, con il movimento
degli studenti. Contraddizioni che, del resto, lo
stesso approccio antipsichiatrico teneva dentro di
sé, essendone anche ben consapevole: «La
nostra situazione — scrivevano gli autori nella
seconda edizione dell’Istituzione negata — non
può che essere contraddittoria: l’istituzione è
completamente negata e gestita, la malattia è
messa tra parentesi e curata, l’atto terapeutico
rifiutato ed agito».
ANTISTATALISMO
Il 1968 fu un movimento sostanzialmente
antistatalista. Non vi si troverà alcuna richiesta di
più Stato e meno privato. La statalizzazione dei
mezzi di produzione e l’economia pianificata
avevano perduto da un pezzo qualsiasi appeal.
Semmai la ricerca era rivolta verso altre forme di
socializzazione
e
gestione
collettiva.
Le proporzioni e gli equilibri tra pubblico e privato,
che occupavano il dibattito fra le forze politiche
istituzionali, e con cui si cimentava il riformismo
degli anni ‘60, ricadevano del tutto al di fuori
dall’orizzonte dei movimenti. Poteri pubblici e
privati apparivano come elementi complementari e
solidali di un unico «sistema», per nulla minato da
contraddizioni interne, e dunque superflua ogni
astuzia politica volta ad agire su queste
contraddizioni. Lo Stato si presentò agli occhi dei
movimenti, ad Est come ad Ovest; in Europa come
negli Usa, essenzialmente come apparato
repressivo, come garante dello stato di cose
esistente: polizia e magistratura, poteri accademici
e poteri burocratici, censura e controllo. Come
portatore di una ideologia vecchia, oppressiva e
intrisa di violenza. La scuola che fu investita dalla
contestazione era la scuola pubblica, nella sua
funzione pubblica di fabbrica del consenso e di
omologazione culturale di Stato. Ben pochi
vagheggiarono la sostituzione dello stato borghese
(il famoso «comitato d’affari della borghesia») con
uno stato socialista. In questo, i movimenti di
protesta al di qua e aldilà della cortina di ferro,
nonostante diffidenze e incompresioni, ebbero un
forte elemento comune e si richiamarono al
medesimo ius resistentiae contro una gerarchia
sclerotizzata e inamovibile. Nell’Est, lo stato si
ergeva poi, con tutta la sua screditata retorica,
come unico ostacolo all’esercizio di libertà
individuali essenziali e diritti collettivi, mascherato
dietro un cumulo di menzogne. L’antistatalismo dei
movimenti del 1968, fortemente attivo anche sul
piano simbolico, insieme al triste spettacolo offerto
dal socialismo reale, contribuirà, poi, a scuotere
nell’opinione pubblica della sinistra occidentale la
fede nella superiore razionalità dello Stato.
Allo Stato i movimenti del ‘68 avevano chiesto
sostanzialmente di farsi da parte, di ritirarsi dai
terreni destinati all’autogestione, di dimettersi nella
persona di questo o quel rettore, di questo o quel
questore, di questo o quel ministro, di liberare gli
arrestati, di abrogare leggi. Praticamente nessuna
richiesta in positivo, salvo qualche sporadica
pretesa di redistribuzione di risorse. Le libertà
premevano più delle garanzie, la «sicurezza» e la
«tutela» non rientravano nel novero dei bisogni più
sentiti e, semmai, se ne percepivano i rischi di
oppressione. Il maggio francese mise poi in scena,
per alcuni giorni, una delle più grandiose
rappresentazioni dell’<’estinzione» dello Stato che
si ricordino. I movimenti del ‘68 ebbero certamente
una propria concezione del contropotere, ma
questa non scimmiottò mai in formato minore le
strutture del potere statale, come avevano invece
fatto partiti e sindacati, ma anche movimenti
utopistici del passato.
ASSEMBLEA
Coerentemente con il rifiuto, più o meno radicale
secondo i momenti e le circostanze, di forme e
strumenti della democrazia delegata, i movimenti
studenteschi fecero dell’Assemblea la sede
principale di ogni decisione e, nello stesso tempo,
il luogo privilegiato per la formazione del
consenso. L’Assemblea non fu mai concepita
come uno strumento di governo, poiché intendeva
appunto cancellare il divario tra governanti e
governati, ma come sede cli un pronunciamnento
collettivo calato nel flusso tumultuoso delle
scadenze di lotta. Maggioranze e minoranze
precarie vi si formavano e disfacevano in risposta
al succedersi degli eventi e alla reazione, anche
emotiva,
dei
partecipanti.
Nondimeno,
il
movimento
rivendica
«tutto
il
potere»
all’assemblea, che diviene permanente e può
darsi, al massimo, organi di pura direzione del
dibattito. In realtà, a governare l’andamento e gli
esiti di riunioni assembleari altrimenti ingovernabili,
sono spesso accordi definiti in altre sedi tra le
diverse correnti del movimento o tra i suoi
esponenti di maggior prestigio, privi, peraltro, di
ogni rappresentanza istituzionale, sempre esposti
al rischio del rifiuto
e dell’insuccesso.
Pur soggetta a ogni genere di sopraffazioni e
proibitiva per le posizioni più timide e incerte,
l’Assemblea rappresentò comunque una sfera
pubblica autonoma da ogni assetto istituzionale,
un momento di larga e intensa partecipazione, uno
strumento altamente comunicativo. Rispetto
all’esterno, alle controparti del movimento, agli
organi istituzionali e alle gerarchie consolidate,
l’Assemblea fu un vero e proprio contropotere in
atto, una presenza minacciosa che interrompeva
lo spazio e il tempo dell’ordine costituito nelle
università, nelle scuole, nelle fabbriche e nei
quartieri. Non a caso il movimento si oppose
furiosamente a ogni sua regolamentazione, non ne
accettò mai forme concesse e definite per via
normativa. Gli spazi e i tempi conquistati
all’Assemblea furono considerati un bottino di
guerra non negoziabile.
Questo spazio e questo tempo sarà poi anche
popolato da teatranti improvvisati, da esibizioni
d’ogni genere e gusto, dalla sceneggiata surreale
a un’interminabile e compiaciuta Oratoria politica,
fino alla parodia della dassica astuzia
parlamentare. L’Assemblea sarà, infine, una
grande fucina di stereotipi ossessivi, ma anche,
spesso, di folgoranti invenzioni linguistiche.
AUTOGESTIONE
L’Autogestione fu tra i movimenti della fine degli
anni ‘60 e per tutto il decennio successivo una
delle parole d’ordine più popolari e, al tempo
stesso, una pratica diffusa nell’organizzazione
delle situazioni di lotta, una richiesta pressante e
generalizzata di partecipazione «dal basso». Ogni
momento collettivo: corsi e seminari di studio,
realtà di lavoro militante, luoghi di produzione
artistica e culturale, asffi d’infanzia, in breve
qualsiasi genere di spazio o di attività sociale, si
volevano «autogestiti», ossia al riparo da ogni
eteronomia e dipendenza. Dovevano essere i
membri stessi del collettivo a stabilire, per via
assembleare, le sue regole e i suoi modi di
funzionamento. Questo implicava una decisa
contrapposizione
alle
norme
imposte
dall’organizzazione
politica
e
produttiva
dominante, con le sue gerarchie consolidate, ma
anche un rifiuto, altrettanto netto, di ogni forma di
dirigismo e di delega ad altri poteri centralizzati,
che si trattasse di un partito, di un gruppo dirigente
stabile espresso dal movimento o di un
coordinamento
eccessivamente
vincolante.
Le Università e le scuole furono il primo luogo in
cui fu sperimentata la pratica dell’autogestione,
che si sarebbe poi estesa a realtà operaie in lotta
(fabbriche occupate) quartieri popolari e
occupazioni di case (i comitati di quartiere), a
numerose realtà nel settore dei servizi (sanità,
assistenza sociale, ecc), in svariate forme e con
intensità variabile, nei diversi paesi europei.
Ma l’Autogestione rappresentava anche un
modello macrosociale nettamente delimitato tanto
verso il potere impersonale dell’economia di
mercato, la costrizione «pseudoggettiva» delle
leggi capitalistiche, quanto verso l’autoritarismo
statalista della pianfficazione. In questo si
ricollegava, oltre che alla tradizione della
democrazia consiliare, a una corrente di
«socialismo autogestionario» che puntava al
controllo diretto dei lavoratori sulle proprie
specifiche attività produttive, alla socializzazione
non statalizzata dei mezzi produttivi, a una
produzione orientata dall’utilità sociale e non dal
profitto Questa corrente ha generato diverse
varianti, dalle più radicali, alle più moderate, dal
rifiuto più totale dell’ordine capitalistico al
compromesso con le sue compatibilità, dalle
comuni egualitarie alla politica socialdemocratica
della cogestione.
A metà strada tra questi estremi si collocava
l’esperimento iugoslavo, come variante eretica nel
campo socialista, sebbene l’autonomia decisionale
e organizzativa delle realtà sociali e produttive,
propugnata nella teoria, si scontrasse nella realtà
con potenti limiti, diseguaglianze sociali, problemi
occupazionali e strutture autoritarie. Tant’è che il
modello
iugoslavo,
ritenuto
moderato
e
compromissorio, non fu affatto amato dai
movimenti radicali in Occidente, molto più
suggestionati dai caratteri estremi delle comuni
cinesi. All’est, l’idea dell’Autogestione, interpretata
soprattutto come autonomia delle realtà produttive
dall’inefficiente
arbitrio
della
pianificazione
centralizzata, ebbe invece un certo corso nella
lotta contro lo strapotere dello stato burocratico
entro la cornice di un sistema che si voleva ancora
socialista.
L’idea e la pratica dell’Autogestione, soprattutto
come forma di organizzazione delle realtà di lotta,
come tentativo di far sopravvivere, rilevandole e
autogestendole, attività produttive destinate dal
padronato alla liquidazione (basti ricordare il caso
della fabbrica francese di orologi Lip nei primi anni
‘70), o come forma associativa di cittadini
impegnati nella difesa di un territorio o di uno
spazio sociale, sopravviverà poi con alterne
fortune fino al giorno d’oggi. Si pensi
all’esperienza delle Buergerinitiativen in Germania,
o a quella dei Centri sociali in Italia.
LA COMUNE E LE COMUNI
Il modello della Comune è tra i più diffusi motivi di
ispirazione dei movimenti alla fine degli anni ‘60.
Con diversità di accenti e impostazioni attraversa
quasi tutti i paesi investiti dall’ondata del 1968.
Esso si affaccia sulla scena in una duplice veste.
Da una parte come modello di autogoverno
combattente e di democrazia diretta che si
contrappone tanto alla tradizione liberale del
parlamentarismo, quanto
al potere della
burocrazia di stato e di partito propria del
«socialismo reale», rifacendosi all’esempio storico,
più o meno idealizzato, della Comune di Parigi del
1871. E in questa veste che la parola d’ordine
della Comune risuona dalla Shanghai della
Rivoluzione culturale alla Parigi del joli mai, e
ispira, in generale, il movimento delle comuni
cinesi come risposta, decentrata e governata dal
basso, almeno in teoria, al modello centralistico e
autoritario dello sviluppo sovietico. Mao stesso
parlerà di «Comune di Parigi degli anni ‘60».
Anche la corrente di tradizione anarchica, che
percorre diffusamente i movimenti del 1968,
contribuisce alla fortuna dell’idea di Comune come
forma ideale complessiva dell’organizzazione
sociale.
Dall’altra parte, soprattutto per i giovani occidentali
su entrambe le sponde dell’Atlantico, le comuni
assumono il senso di una forma di socializzazione
e organizzazione della vita quotidiana collettiva,
contrapposta alla famiglia borghese e alla
disciplina produttiva del capitalismo, con tutta la
competitività che la contraddistingue. Nelle
migliaia di comuni che si diffondono in diversi
paesi dalla seconda metà degli anni ‘60 ai primi
anni ‘70 confluiscono tanto l’esperienza delle
comunità hippie americane e di altre aggregazioni,
anche a carattere religioso, di circoli alternativi
legati da interessi artistici e culturali quanto quella
dei collettivi politici, scaturiti dalle più diverse
situazioni di lotta.
Negli Stati Uniti, soprattutto in California e nel New
England, e nell’Europa del nord, soprattutto in
Germania e Olanda, si occupano case sfitte, a
volte interi quartieri, terre abbandonate vengono
colonizzate da variopinte comunità. Migliaia di
giovani scelgono di vivere in collettività, più o
meno strutturate, più o meno ideologizzate, la loro
vita personale.
La comune diventa così lo spazio, per eccellenza,
entro cui possono svilupparsi rapporti sociali più
egualitari e un progetto di vita personale più ricco
di senso e di relazioni, sottratto alle norme, alle
convenzioni, alle gerarchie e agli antagonisrni
della socìetà borghese. Contrariamente alla
famiglia, che di queste norme è considerata
potente «cinghia di trasmissione», la comune
offrirebbe la possibilità di relazioni e affetti
«autentici» e trasparenti, perché liberamente scelti
e revocabili in ogni momento, saldandosi, inoltre,
con lo slancio utopistico che vuole dimostrare, ora
e qui, la possibffità concreta di instaurare rapporti
liberi e solidali. in questo senso la comune si
presenta come esempio ed embrione della nuova
società. Ma non è solo una stagione di ingenui
entusiasmi. Spesso i «comunardi» saranno ben
coscienti dei caratteri azzardati e sperimentali del
loro tentativo, che sarà anche sottoposto a un
aspro vaglio critico e oggetto di infinite discussioni,
che condurranno, intorno alla metà degli anni ‘70,
all’esaurirsi del fenomeno, almeno come
insorgenza ampiamente diffusa e collegata a un
progetto politico.
CONTRO LA NEUTRALITÀ DELLA
SCIENZA
L’oggettività è la categoria messa radicalmente in
causa dai movimenti, attraverso una fortissima e
originale estensione della critica marxiana
dell’ideologia. Nulla è neutro dice il ‘68, nel senso
che tutto è segnato dal marchio di classe che
porta con sé. Non c’è l’umanità neutra dunque, ma
gli sfruttati e gli sfruttatori, i governanti e i
governati, chi ha potere e chi non ce l’ha. Non è
neutro il linguaggio né il sapere scientifico.
Anzi, chi parla di neutralità, svolge, secondo i
movimenti del ‘68, la più pericolosa opera di
mistificazione perché suggerisce che esistano
zone libere dai conflitti, dove servo e padrone non
si scontrano perché hanno valori comuni, idee che
vanno bene per tutti, saperi condivisi. Questa
pretesa comunanza, dice il ‘68, è la forma
attraverso la quale la sfera dominante proclama
universali i propri interessi, dichiarandoli validi per
tutti e appunto esenti dal conflitto di classe.
Così il ‘68 diventa inaccettabile per l’ordine
costituito non quando critica l’inefficienza o alcuni
aspetti autoritari dell’istituzione scolastica, ma
quando appunto mette in discussione la natura
«universale» del sapere e, così facendo, lo
delegittima tutto, la cultura di destra come quella
storica della sinistra.
Il movimento delle università cercherà di abbattere
la neutralità apparente della cultura, soprattutto nei
controcorsi, gestiti direttamente dagli studenti nelle
facoltà occupate. Il tema della controcultura
diventa scottante perché il rifiuto della tradizione
codificata, anche di quella marxista, obbliga a
rifondazioni totali, non soltanto nel metodo
dell’insegnamento, ma anche nelle basi della
cultura.
In questo senso un terreno particolarmente
impegnativo è quello delle discipline scientifiche
che anche dal pensiero di sinistra sono state
sempre considerate oggettive perché fondate,
scientfficamente appunto, su di un principio di
realtà e su leggi oggettive. Qui sì delineano
schematicamente due filoni di pensiero. Per una
parte il sapere è neutro, ma non lo è il suo uso.
Anzi, si sostiene, è proprio il capitalismo che
mortifica e piega a usi disumani (militari e di
sfruttamento) la buona scienza. In particolare nel
caso della Guerra del Vietnam, che utilizzava un
ampio spiegamento di scienza e di tecnologia,
risultava evidente a tutti che la cosiddetta
«internazionale degli scienziati» non aveva alcuna
funzione progressiva, come era stato sostenuto
invece dalla sinistra per tanti anni, ma al contrario
svolgeva un ruolo di sostegno all’aggressione
americana.
Un altro filone di pensiero, più fecondo, cominciò
invece a interrogarsi sui fondamenti stessi della
conoscenza e della macchina sociale che produce
scienza. Si ricollegava in questo anche a una
revisione dell’ortodossia marxista che aveva
cominciato a farsi strada fin dai primi anni ‘60 con
la rilettura del Marx dei Manoscritti del ‘44 e dei
Grundrisse.
La non neutralità della scienza viene riconosciuta
non solo nelle soluzioni che offre a problemi
determinati, ma nel processo che sta a monte,
quello della formulazione dei problemi da risolvere.
Proprio qui entrano in gioco fattori estranei alla
scienza stessa, che derivano invece dai poteri e
dalle gerarchie della società nel suo complesso e
che sono dunque segnati dal conflitto di classe.
L’elemento di passaggio dai bisogni del capitale ai
contenuti della scienza viene individuato nella
struttura del sistema della ricerca (finanziamenti,
possibilità di carriera, circolazione delle idee e
delle pubblicazioni).
Si prende atto in quegli anni che la scienza è
sempre più forza produttiva, non solo perché viene
sovente piegata a fini produttivi diretti, ma anche
perché su di essa si esercita una pressione
sociale:
nella scelta dei settori da sviluppare e degli
investimenti da effettuare, nella formazione delle
scale di valori delle ricerche, nel diverso prestigio
attribuito all’una o all’altra branca della scienza
Nei casi migliori le facoltà scientifiche occupate,
dove spesso gli stessi docenti e ricercatori
partecipavano al movimento, si produssero
signfficative elaborazioni sia relativamente alla
sociologia delle scienza, sia di tipo epistemologico,
che hanno lasciato un segno permanente nel
pensiero contemporaneo. In particolare proprio da
quelle riflessioni a caldo riprese dignità e sviluppo
un settore tradizionalmente considerato minore,
come quello della storia della scienza, che è
insieme storia interna alle discipline, e storia
esterna, che riguarda alla società e ai suoi
processi di trasformazione.
CRITICA DEL LAVORO
La critica del lavoro raggiunse con le lotte
studentesche e operaie della fine degli anni ‘60
una vastissima articolazione. Come critica della
divisione sociale del lavoro e delle gerarchie che
ne conseguivano, come critica dell’alienazione e
come critica radicale del lavoro salariato tout court,
della sua forma di merce. Nei movimenti
studenteschi fu accolta con entusiasmo e, subito
estesa allo studio e ai ruoli professionali qualificati,
l’idea marxiana di alienazione, nel senso generico
di un agire che si separa dai bisogni e dalla
volontà dei soggetti, per svilupparsi secondo leggi
proprie ed estranee, quelle della merce e
dell’accumulazione del profitto. Entrare nella
macchina produttiva significava agire contro se
stessi, i propri bisogni e quelli dei propri simili.
Altrettanta fortuna ebbe la critica della divisione
sociale del lavoro (che proprio in quegli anni
raggiungeva
il
massimo
di
rigidità
e
parcellizzazione) che riduceva e schiacciava
l’insieme delle facoltà e della potenzialità del
soggetto all’esecuzione ripetitiva e devastante di
una singola funzione produttiva. fl rifiuto di questa
«uniclimensionalità», di questa cancellazione della
persona
e
della
segmentazione
sociale
gerarchizzata che ne conseguiva fu una delle
principali correnti che attraversarono i movimenti,
in cerca di una ricomposizione dei soggetti che
rimescolasse egualitariamente i compiti necessari
alla riproduzione sociale, magari ispirandosi alla
Cina delle guardie rosse. 11 superamento della
divisione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale
fu, di conseguenza, una delle parole d’ordine più
diffuse nei movimenti studenteschi. Non
mancarono poi frange operaie e tecniche
politicizzate che presero di mira l’organizzazione
del lavoro, pretendendo di imporre il proprio
controllo sul ciclo produttivo e di riappropriarsi,
sulla base del proprio sapere collettivo, dei modi e
delle finalità della produzione, sottraendoli
all’arbitrio padronale. Un’attitudine che, più tardi,
sarà
messa
a
profitto,
sfigurandola
e
sottomettendola alle regole della competitività, dal
toyotismo.
Ma la posizione più radicale fu quella del «rifiuto
del lavoro» che puntava a una negazione
immediata e immanente del lavoro salariato.
Respingendo l’idea di una capacità di
emancipazione msita nel lavoro stesso e di un suo
qualsiasi valore etico (la vecchia etica del lavoro
interiorizzata dal movimento operaio), mirava a sot
trargli con ogni mezzo, tempo ed energie, a
mettere in questione il sistema stesso del lavoro
salariato e le sue unità di misura con l’idea di un
reddito non più correlato alla produttività. Di qui il
carattere non circoscritto e «rivoluzionario» che fu
attribuito alla rivendicazione salariale. La richiesta
di «più soldi» sganciati da «più produttività»
avrebbe messo in questione il carattere di merce
della capacità lavorativa umana. Nell’unico modo
possibile: inflazionandone il costo, creando una
continua «dismisura».
Ma il «rifiuto del lavoro» non fu solo una posizione
teorica, articolata attraverso il privilegiamento di
determinati obiettivi di lotta, bensì anche un
movimento spontaneo che si era espresso nei
comportamenti e nelle subculture giovanili, con il
loro disperato tentativo di sottrarsi a una grigia
predestinazione operaia, e in altre forme di esodo
individuale e collettivo, più o meno ideologizzate,
dalla società produttiva. La stessa pervasività della
politica nel 1968, il suo invadere prepotentemente
ogni ambito e ogni campo, la sua pretesa di
primato, si contrapponeva in qualche modo al
lavoro. 11 «fare politica», che «occupava» decine
di migliaia di giovani era appunto quel «fare» che
non era riconducibile alla natura di merce del
lavoro e alle sue unità di misura. E, per questo,
discostandosi da ogni idea «professionale» della
politica, si proponeva immediatamente come
modello di liberazione.
CRITICA DEL SOCIALISMO REALE
Il 1968 è l’anno del «Nuovo corso» e l’anno
dell’invasione di Praga. I carri armati del Patto di
Varsavia mettono fine a un tentativo di riforma
economica e di liberalizzazione politica, pacifico,
voluto e condotto da un partito comunista che
sceglie non solo di mantenersi interamente nella
cornice del sistema socialista, ma nemmeno
intende mettere in questione la coesione del
blocco orientale. Questa circostanza pone, all’Est
come all’Ovest, una domanda cruciale: il
«socialismo
reale»
è
riformabile?
La
destalinizzazione del ‘56 ha effettivamente aperto
delle possibilità di trasformazione o i caratteri
stagnanti e autoritari del sistema sono connaturati
a qualcosa di più basilare della deformazione
staliniana e delle sue sopravvivenze? Nei dodici
anni che intecorrono tra il ventesimo congresso, i
tumulti e le lacerazioni che ne seguirono (prima tra
tutte quella della sanguinosa insurrezione
ungherese), nei paesi dell’Est si sviluppano
correnti critiche e spinte innovative, a cominciare
dall’inquieta Polonia, in forma di opposizione
intellettuale, spesso ancora di matrice marxista, o
di ricerca riformista di un nuovo modello di
sviluppo economico, comunque altemativo a
quello del capitalismo (si pensi al gruppo di Lange,
Bobrowski, Kalecki). La rottura con il modello
stalinista e la riflessione sulla sua parabola storica,
confluiscono in posizioni critiche che investono
non solo il passato, ma il presente stesso del
socialismo reale, entrando in rotta di collisione con
i suoi gruppi dirigenti. Un’ampia dissidenza
intellettuale di sinistra si sviluppa nella Repubblica
democratica tedesca, dai filosofi Ernst Bloch e
Wolfgang Harich (che organizzano nel ‘56 un
celebre convegno intitolato «il problema della
libertà alla luce del socialismo scientifico»), al
fisico Robert Havemann, al cantautore (che sarà
anche il cantore della rivolta studentesca in
Germania occidentale) Wolf Biermann e molti altri.
Tutti prendono di mira, in forma più o meno
radicale, l’arbitrio degli apparati burocratici e il
soffocamento della dialettica sociale, ricorrendo
allo strumentario critico del marxismo. In
Cecoslovacchia, paese tagliato fuori dai tumulti del
1956 e a lentissima destalinizzazione, tutto
precipita nei febbrili mesi della «Primavera», le cui
ambizioni
di
pacifica
democratizzazione,
autonomia
delle
imprese
e
progressiva
introduzione di elementi di mercato, sembrano, per
un momento, indicare a tutto il blocco orientale
una via moderata e dunque percorribile.
Nel campo del marxismo ocddentale, la critica del
socialismo reale si addensà sostanzialmente lungo
due direttrici. La prima, riconducibile alla ipotesi
formulata da Deutscher nel 1956, assunta da
intellettuali cornejean Paul Sartre e da partiti
comunisti, come quello italiano, giustificava la
natura autoritaria del regime sovietico con le
condizioni di arretratezza e di accerchiamento
internazionale della rivoluzione sovietica. Tuttavia
l’avvenuta abolizione della proprietà privata dei
mezzi di produzione avrebbe prodotto una sana
«struttura socialista» che, prima o poi, avrebbe
condotto a un mutamento in senso democratico
della sovrastruttura politica. La seconda, che
faceva capo a Charles Bettelheim e Bernard
Chavance, riteneva che l’abolizione della proprietà
privata dei capitali avesse generato un monopolio
capitalistico di stato del tutto coerente con il
regime autoritario a partito unico. Questa
interpretazione comportava che nel processo
rivoluzionario descritto da Marx l’abolizione della
proprietà privata dei mezzi di produzione fosse un
elemento necessario ma non sufficiente, il fine
essendo la riappropriazione del lavoro e
l’estinzione dello stato. Si auspicava dunque una
ripresa della lotta di dasse nei paesi socialisti,
capace di riunire le nuove figure di espropriati. E la
Rivoluzione culturale cinese sembrava muovere in
questa direzione.
Fu questa seconda linea interpretativa (del tutto
marginale tra gli oppositori dell’Est) ad incontrare
maggiore fortuna nella nuova sinistra scaturita dal
movimento del 1968. Quest’ultimo non aveva
nutrito alcuna simpatia per il modello sovietico,
accusato
di
«tradimento»,
«revisionismo»,
«autoritarismo», e lo aveva anche avversato
radicalmente,
soprattutto
nelle
sue
forti
componenti anarchiche e non comuniste (in
Francia, l’Internazionale situazionista condusse
una critica spietata contro il socialismo sovietico e
la sua restaurazione culturale), ma, in generale,
nonostante i sussulti di Praga e Varsavia i
movimenti del 1968 non considerarono il «campo
socialista» come un terreno fertile per Io sviluppo
delle lotte. Non era da quella parte che ci si
attendevano spinte signfficative di trasformazione
sociale. E, sebbene l’onda della protesta avesse
investito entrambi i campi, la cesura rimase.
CRITICA DELLA FAMIGLIA
Reprime, forma personalità adattabili a ordini
autoritari, educa all’ipocrisia, trasmette la paura: la
famiglia borghese è messa sotto accusa dalla
critica corrosiva degli studenti. La loro analisi, nata
dalle discussioni dei comitati che si formano nelle
università, è alimentata per un verso dalle analisi
sociologiche della Scuola di Francoforte
(Horkheimer, Adorno, la grande opera collettiva
del 1936 che si intitolava Stridi szill’autorita’ e la
famiglia); e per altro verso dalla elaborazioni degli
antipsichiatri Cooper, Laing, Esterson, che
dall’inizio degli anni Sessanta lavorano sulla
schizofrenia e scavano nei rapporti patologici che
legano tra loro i membri della famiglia (a rendere
popolare e fruibile da tutti questa straordinaria
esperienza culturale e liberatoria sarà il bellissimo
film
Family
Life,
di
Ken
Loach).
Nelle analisi di David Cooper (che nel 1971
pubblicherà su questo tema un libro di grande
successo, La morte della famiglia), la famiglia è
innanzitutto, in tutte le società basate sullo
sfruttamento, uno strumento di condizionamento
ideologico; più in profondità, la famiglia è una sorta
di paradigma le cui figure-chiave, il «padre» e «la
madre», amate o detestate, tornano a strutturare
le relazioni nei più diversi tipi di istituzioni sociali:
la Chiesa, l’impresa, la scuola, il partito, e così via.
Quella della famiglia è dunque una situazione che
pre-struttura tutta la nostra esperienza sociale,
incapsulandola al tempo stesso in una serie di
tabù e di false sicurezze che amputano,
dell’individuo, proprio le parti più profondamente e
intensamente vitali: « la morte del dubbio e la
morte del corpo — scrive Cooper — hanno la loro
origine nei bisogui gregari sviluppati all’interno
della famiglia». La famiglia è dunque, in questa
prospettiva, il luogo originario dell’alienazione:
«sottomissione passiva all’invasione degli altri»,
che a sua volta genera nei soggetti reazioni
«paranoiche», nelle quali si esprime una forma di
risposta
a questa
devastante
invasione.
L’educazione familiare, in sostanza, avvia
l’individuo, attraverso i suoi rituali e le sue
sicurezze apparenti, verso un esito di
sottomissione sociale al quale egli sacrifica le sue
esperienze creative spontanee, il suo potenziale di
sviluppo libero, di invenzione, di immaginazione e
di sogno.
Anche sulla base di riflessioni come queste
nascono, attorno ai movimenti del Sessantotto, le
esperienze di educazione antiautoritaria: dai
Kinderlaeden di Berlino ovest agli asffi
antiautoritari di Milano si ricercano forme di
socializzazione che non sacrifichino il potenziale
creativo del bambino, che non siano finalizzate
alla creazione di sudditi bravi e disciplinati. Una
ricerca che non è a sua volta priva di
contraddizioni: ideologia, psicanalisi, spunti
libertari si mescolano nelle teste degli educatori
sessantottini, alle prese con un compito troppo
gravoso per una generazione che è ancora
impegnata nella sfida difficile di definire la propria
identità.
CRITICA DELLE PROFESSIONI
«Sono stato impiegato come bastonatore e
dunque bastono». Questa battuta, pronunciata da
uno dei fantasmagorici funzionari del Processo di
Franz Kafka, fu ripresa in un memorabile saggio
degli anni ‘30 di Guenther Anders per indicare
l’assurdità delle professioni, anzi l’assurdità stessa
eletta a professione, messa in scena da tanti
straordinari personaggi kafkiani. I movimenti del
‘68 aggredirono con altrettanta radicalità i ruoli
professionali. Contestarono la presunta neutralità
degli specialismi, ne denunciarono l’asservimento
agli interessi dominanti, la cieca esecuzione di
prescrizioni imposte dall’alto. A partire dal luogo, le
scuole e le università, in cui le regole disciplinari
del lavoro qualificato venivano definite e
trasmesse. Nelle professioni non fu visto un
sapere volto a soddisfare i bisogni della società,
ma un sistema di funzioni deputate a riprodurne
acriticarnente
la
struttura
dassista
e
discriminatoria. A partire da queste premesse gli
studenti intrapresero una critica sistematica
dall’interno dei singoli ambiti disciplinari. I futuri
ingegneri cominciarono a interrogarsi su quale
ruolo sarebbe stato loro destinato nella struttura
sociale e produttiva esistente. Altrettanto
cominciarono a chiedersi i futuri chimici, architetti,
fisici, avvocati, insegnanti, medici. Queste
domande si tradussero in una vasta elaborazione,
teorica e sociologica, che avrebbe passato al
vaglio la natura e le regole dei più diversi ruoli
professionali, prendendo di mira interessi
corporativi, meccanismi competitivi, piramidi
gerarchiche e rapporti semifeudali radicati nel
mondo delle professioni.
Rapidamente il movimento critico si spostò dalle
università a circoli di professionisti già attivi, decisi
a rompere l’unità della categoria, tra quanti
intendevano riprodurne le regole consolidare e
quanti intendevano, invece, porre i propri strumenti
conoscitivi al servizio di una trasformazione
sociale e rifiutare il ruolo che veniva loro
assegnato. Oltre alla propria classe di
provenienza, a molti parve opportuno «tradire»
anche la propria professione. Si formarono così
gruppi di, medici, psichiatri, tecnici, giuristi,
urbanisti, perfino magistrati, «democratici»,
impegnati nel contestare il proprio ruolo
funzionale, nello smascherarne la falsa neutralità e
nel cercare una nuova collocazione all’interno
della lotta generale per la trasformazione dei
rapporti sociali.
Ma nelle figure professionali la critica individuò
anche quella «unidimensionalità», quella radicale
mutilazione della personalità che ne restringeva
l’orizzonte a una funzione parcellizzata, seppure
ad alto contenuto di sapere, ottusa e
irresponsabile nei confronti della problematica
sociale. La lingua tedesca possiede un termine
estremamente preciso per designare questa
colpevole unilateralità: Fachidiot. Qualcosa come
«idiota specializzato», intendendo con questo il
detentore di un sapere approfondito e circoscritto,
del tutto disinteressato al contesto in cui si colloca
il suo segmento di sapere, per non parlare del più
generale ambito della società. Di personaggi di
questo genere aveva potuto servirsi il nazismo e
poteva servirsi qualsiasi altro potere di
sopraffazione violenta, presente e futuro.
il sistema dell’istruzione fu appunto accusato di
essere una catena di montaggio per la
fabbricazione di siffatti individui, funzionali
all’organizzazione fordista del lavoro che, proprio
in quegli anni, aveva spinto al limite estremo la
divisione sociale del lavoro e la parcellizzazione
delle mansioni e dei saperi.
sociali e realtà collettive, contrassegnato da una
politicizzazione integrale di tutti gli ambiti
dell’esistenza. Un processo di questa natura non
poteva che svilupparsi sulla base di una generale
partecipazione diretta alle scadenze e alle
iniziative del movimento, ai suoi momenti di
discussione ed elaborazione. Ogni idea di delega
e di rappresentanza ne fu, conseguentemente,
travolta. I delegati e i rappresentanti, che si
trattasse dei deputati dei parlamenti nazionali, dei
parlamentini studenteschi, o degli organismi
sindacali, furono considerati, più o meno
aspramente, controparti ostili, corpo separato,
agenti
di
un
generale
meccanismo
di
espropriazione dei soggetti. La dassica critica
marxista
della
democrazia
formale
fu
generalmente accolta come strumento teorico di
base per «smascherare» gli inganni della
rappresentanza. Alla democrazia delegata, dalle
scuole, alle università, all’idea generale di una
nuova organizzazione politica della società, si
contrapponeva l’idea di una «democrazia diretta»,
che, inoltre, aveva il compito di distanziarsi
radicalmente dal modello statalista e burocratico
dei regimi dell’Est.
Ogni delega è consegna della propria volontà
politica in mani altrui e infide. Ogni mandato non
revocabile è sacrificio all’autoritarismo e
negazione del potere sovrano popolare. Se si
aggiunge, poi, che questa delega è manipolata, al
momento del suffragio, dalla forza dei media e dai
poteri forti che li controllano, ne consegue che sia
lo stato, sia i partiti o i sindacati che si modellano
su uno stato moderno, negano di fatto la sovranità
di base da cui pretendono di trarre legittimità.
Contro tutto questo il movimento cerca di rifarsi
alle forme di organizzazione che i movimenti
rivoluzionari si danno nella fase nascente, o nei
momenti più tumultuosi e partecipati del conflitto: i
soviet del 1917, i consigli operai della rivoluzione
tedesca del 1919, le organizzazioni combattenti
delle guardie rosse, le formazioni anarchiche nella
guerra di Spagna. Si cercano lumi teorici nelle
opere di Rosa Luxemburg, Karl Korsch o
Pannekoek. Ma l’idea di democrazia diretta resta
comunque
molto
più
saldamente
legata
all’esperienza pratica delle lotte, nelle università
prima e nelle fabbriche poi, e dei sistemi di
relazione e comunicazione che le attraversano,
che non a un modello teorico-politico,
compiutamente formelato. La stabilizzazione di
forme politiche definite non rientra nell’orizzonte
del movimento, almeno per buona parte del 1968.
DEMOCRAZIA DIRETTA
DIALETTICHE DELLA LBERAZIONE
La caratteristica più saliente e generalizzata del
1968 fu il passaggio della dimensione politica dalle
sue sedi istituzionali e storicamente consolidate a
una pluralità, in continua crescita, di soggetti
Dialectics of Liberation (Dialettiche della
liberazione) è il titolo di uno straordinario e
affollatissirno meeting che si tenne a Londra dal
15 al 30 luglio del 1967. La sua singolarità sta nel
fatto che esso riusci a costituire una sorta di punto
d’incontro tra le molte culture critiche, differenziate
e decisamente plurali, che però si ponevano tutte,
in questo particolarissimo tornante degli anni
Sessanta, le questioni, appunto, della liberazione.
Al convegno parteciparono Herbert Marcuse, con
la sua critica della società unidimensionale e della
tolleranza repressiva, Paul Sweezy il teorico del
capitale monopolistico, il leader del Black Power
Stokely
Carmichael,
i
maestri
londinesi
dell’antipsichiatria, Ronald Laing e David Cooper,
che avevano mostrato il carattere patogeno dei
rapporti sociali e familiari vigenti. E ancora il poeta
Allen Ginsberg, lo scienziato e antropologo
Gregory Bateson, il filosofo dialettico Lucien
Goldmann. Si sviluppava così un singolarissimo e
ambizioso tentativo di mettere insieme tante
culture contestative che, pur parlando lingue
diverse, convergevano almeno nel denunciare il
capitalismo ‘liberale’ come un sistema (nella sua
vera e nascosta realtà) oppressivo e totalitario; e
si incontravano altresì nella critica del non meno
autoritario sistema sovietico. «Tutti gli uomini sono
in catene» — scriveva il manifesto programmatico
del convegno. Anche se diverse sono le forme di
schiavitù da cui essi sono irretiti: tali non sono
solamente l’oppressione esplicita, la povertà e la
fame; schiavitù è anche quella in cui vivono gli
abitanti del ricco Occidente, alienati nella corsa al
possesso, alle inutili merci, al prestigio sociale e al
potere.
La pluralità delle forme di oppressione, che però si
sostengono l’una con l’altra e formano un
«sistema», può essere contrastata soltanto dalla
convergenza potente di una altrettanto articolata
pluralità di ‘dialettiche della liberazione’. Quel che
caratterizza infatti le culture che alimentano il
Sessantotto è proprio una nuova consapevolezza
di questo punto: non ci sarà nessuna liberazione
politica, nessuna liberazione collettiva, se anche
gli individui non saranno capaci di liberarsi da tutte
le forme di soggezione, di non-libertà, tanto più
insidiose quanto più introiettate dagli individui
stessi.
EGUALITARISMO
Il tema dell’uguaglianza esplose nel movimento
degli studenti, da un capo all’altro del pianeta, in
una forma originale che va molto al di là di un
semplice traguardo egualitario quantitativo. Esso
aveva investito un dato essenziale del mondo
contemporaneo, la gerarchia dei ruoli. Questa
gerarchia, con la conseguente rigida divisione del
lavoro, era stata contestata nella scuola, nella
famiglia e in ogni rapporto sociale. La gerarchia fu
messa in discussione esplicitamente sulla base
dei diritti uguali della persona umana, al di sopra di
tutti i condizionamenti dei rapporti di forza tra le
persone e tra le dassi. Fu considerata di per sé la
sostanza stessa della diseguaglianza, ma anche il
punto di arrivo di un processo che la determina:
processo che riproduce nel lavoro, nella scuola,
nella vita civile, differenze e subordinazioni. I
movimenti aggredirono dunque la diseguaglianza
non solo negli effetti finali, ma anche nelle sue
radici determinate. L’egualitarismo che si
presentava come riconoscimento di bisogni sociali
comuni, conteneva già in sé quelle caratteristiche
che travalicario qualunque fine direttamente
negoziabile. Era una spinta ideale in grado di
promuovere la formazione di un soggetto collettivo
e dunque attinente alla costituzione della sua
identità.
In questa sua dimensione antigerarchica, che non
risparmiò i ruoli sociali e politici definiti dal sistema
della delega e della rappresentanza nella
tradizione
democratico-parlamentare
dell’
Occidente, la spinta egualitaria ebbe carattere
dirompente anche in quelle società che si
pretendevano organizzate secondo principi
egualitari. In Cina, e più marginalmente in qualche
paese dell’Europa dell’est, il movimento egualitario
si rivolse, anche violentemente, contro quei poteri
(di Stato, di partito) che negavano, nell’affermare
le proprie prerogative e nel garantirne la
riproduzione, quell’eguaglianza alla quale si
richiamavano e dalla quale facevano discendere la
propria legittimità. In questa scia si situava il
«bombardare
il
quartier
generale»
della
Rivoluzione culturale cinese e il radicalismo della
Comune di Shanghai. Quanto questi movimenti
fossero poi condizionati dalla lotta politica tra
gruppi dirigenti non cambia molto alla sostanza
della spinta che li animava: l’interesse comune di
soggetti impegnati in un conflitto contro l’autorità di
poteri sovrastanti che si erano resi autonomi dalla
concreta realtà del contesto sociale, costituendosi
in corpi separati. Non si spiegherebbe altrimenti la
fascinazione esercitata dalle guardie rosse,
prodotto di una storia e di un costume tanto
diversi, sui giovani contestatori occidentali. Per
questi ultimi, salvo alcune componenti più o meno
estese e più o meno durevoli, l’istanza egualitaria
radicale, rappresentò, infatti, più uno strumento di
lotta contro le gerarchie che non un principio di
buongoverno e disciplinamento delle diversità.
Strettamente legato a una condizione di lotta e a
un’idea di conflittualità permanente fu anche il
movimento egualitario nelle fabbriche (popolato di
nuovi soggetti estranei alle tradizioni storiche del
movimento operaio), soprattutto in Italia, dove
esso investì tanto il rapporto tra capitale e lavoro,
quanto i rapporti tra i lavoratori e il terreno della
democrazia sindacale. Furono rifiutate le divisioni
funzionali all’organizzazione produttiva, affermata
una soggettività autonoma contro le compatibilità
aziendali (il salario e la salute come «variabili
indipendenti»), aggredite le sperequazioni salariali
e le gerarchie di fabbrica, preteso il massimo
grado di democrazia diretta nella rappresentanza
degli interessi operai. L’egualitarismo passò in
quegli anni dall’essere assetto ideale di una
società futura a pratica di lotta incarnata nei
conflitti del presente.
FIGURA SOCIALE DELLO STUDENTE
«Perché studio? come mai io posso studiare e la
maggior parte degli uomini no? a cosa serve
questo tipo di studio? e a chi serve?». Formulate
in varie maniere e linguaggi sono queste le
domande che, negli Stati Uniti come in Francia, in
Italia come in Germania, correvano profonde nelle
assemblee e nelle teste dei singoli studenti e nel
movimento. E sono anche le radici di quelle stesse
lotte.
Le risposte che vennero date furono assai diverse,
e tutte cercavano di ridefinire il ruolo e la figura
sociale dello studente. In alcune formulazioni esso
venne inteso come figura rivoluzionaria in senso
stretto, magari destinata a sostituire, in questa
fase storica, gli operai e in genere i proletari. A
maggior ragione, in quanto il movimento operaio
tradizionale avrebbe introiettato i valori e le
compatibilità del sistema. Dunque gli studenti non
solo erano «classe rivoluzionaria», ma la sola
possibile.
Questa discussione si intrecciava con quella sui
nuovi processi di proletarizzazione, in particolare
dei nuovi strati tecnici e intellettuali. Ma anche si
biforcava: nelle posizioni che si rifacevano alle
analisi marxiste più ortodosse, si trattava di un
vero e proprio passaggio nelle file e a fianco del
proletariato già esistente, quello di fabbrica.
Semplicemente,
il
capitalismo
andava
trasformando in suoi strumenti anche altri strati
sociali, come quelli intellettuali, che in precedenza
avevano goduto di una parziale, anche se forse
apparente, immunità. Gli stessi nuovi processi
produttivi
attivati
nell’industria
culturale,
riprendevano
tutte
la
caratteristiche
di
subordinazione e espropriazione che prima erano
state tipiche del lavoro operaio: catene di
comando, gerarchie, alienazione, divisione e
compartimentazione del lavoro, estrazione di
plusvalore.
Non tutti però la pensavano così, o quantomeno
non tutti proponevano una identificazione stretta
tra studenti e nuovi proletari. Per altri, gli studenti
costituivano semmai una sorta di «categoria
sociale» trasversale alle classi e non una classe in
sé. La loro si configurava sì come una «lotta
anticapitalistica», ma non venne mai candidata a
sostituire la lotta operaia. Né a essere l’innesco
della rivoluzione.
Questa analisi si intrecciava, un p0’ ovunque, con
quella del ruolo della scuola e dell’istruzione
superiore: «luogo di produzione della forza lavoro
qualificata», si disse. Dunque, se non proletario in
senso stretto, certo lo studente ne usciva come
una figura sociale subordinata, e questo da un
duplice punto di vista: sia per la collocazione che
lo attendeva nel mondo del lavoro (tecnico
subalterno oppure agente e propagandista del
consenso sociale), sia per il suo essere già ora «in
miseria», dati i meccanismi in base ai quali
l’università è costituita. Questi sono basati sulla
divisione capitalistica del lavoro intellettuale, sulla
parcellizzazione delle conoscenze e sulla loro
sterilizzazione in compartimenti separati; sono poi
trasmessi solo dall’alto, attraverso formale
essenzialmente autoritarie.
Presenti, ma del tutto minoritarie, furono invece le
posizioni che, volendosj marxiste ortodosse,
continuavano a classificare gli studenti come
borghesia, anzi «piccola borghesia», il cui
eventuale ruolo antagonista poteva darsi soltanto
attraverso un salto di coscienza e un parallelo
«tradimento» della propria classe di appartenenza
per «schierarsi a fianco» dell’unico soggetto
rivoluzionario possibile, il proletariato industriale.
In questo caso gli studenti erano visti soltanto
come aspiranti borghesi frustrati, vittime di un
sistema che non era in grado di mantenere le sue
promesse di promozione sociale e di status.
FORME DELLA COMUNICAZIONE
Ciclostile, dazebao, graffiti, manifesti. Questi i
principali strumenti cui i movimenti del ‘68
affidavano la propria possibilità di crescere e,
soprattutto, di influire sul terreno sociale e politico
circostante, specialmente rivolgendosi agli altri
soggetti antagonisti, «proletari» e «proletarizzati».
Il cidostile, oggi scomparso quasi ovunque, era un
attrezzo povero ma assai efficace: serviva una
matrice su cui battere il testo con la macchina da
scrivere (e sulla quale, eventualmente incidere con
uno stilo elementari disegni a tratto). Fissata al
rullo inchiostratore, la matrice poteva produrre
migliaia di copie su carta, in formato standard,
pronte alla diffusione a braccio. Quanto alla
impaginazione e alla grafica erano quasi sempre
spartane o ingenue: era scontato, in questi casi,
che il contenuto fosse più importante della forma e
il linguaggio usato sovente carico di retorica, punti
esclamativi e enfasi.
Erano lunghe notti passati a alimentare la
macchina che, con il suo rumore ritmato prende il
foglio, lo fa passare, lo scarica dall’altra parte,
diventa una musica. I volantini, freschi di stampa,
partivano immediatamente per i loro luoghi di
destinazione:
materiali
per
un
consumo
istantaneo, per una mobilitazione d’urgenza, per
una contro-informazione diffusa, che contrastasse
quella dei mezzi di comunicazione «di regime».
Diversa era la funzione del dazebao che
riprendeva ,anche nel nome, l’esperienza cinese di
un’opera collettiva: manifesto murale o molteplicità
di testi appesi allo stesso muro (di una strada, di
una scuola). Il dazebao è diverso dal classico
manifesto nel senso che assai spesso nasce dal
basso e contiene elementi di critica verso il vertice
o di denuncia di situazioni specifiche. Poteva
essere la contestazione di una base silenziosa nei
confronti delle autorità, ma anche delle dirigenze
del movimento. Era il modo di prendere la parola
in pubblico di coloro ai quali di solito non era
consentito.
Per definizione e prassi, il dazebao è opera in
divenire e interattiva. Sovente suscita repliche,
sullo stesso muro o sugli stessi spazi di carta, è il
prolungamento dell’assemblea con altri mezzi, il
coagularsi in scritte della discussione spontanea. Il
suo carattere occasionale, fa sì, purtroppo, che dei
dazebao del 68 restino testimonianze minime,
meno ancora dei volantini.
I graffiti avevano invece un ruolo di comunicazione
e di espressione rivolto soprattutto all’esterno, al
grande pubblico. Sono scritte e disegni spontanei
che i movimenti e i gruppi più o meno organizzati
depositano sulle superfici esposte di edifici
pubblici. Il fenomeno si manifestò in tutta la sua
imponenza, anche visiva, soprattutto durante le
giornate del maggio a Parigi dove, a opera degli
studenti, e specialmente di queffi della Ecole des
Beaux Arts, venne prodotto un numero enorme di
scritte murali che invase praticamente tutto il
Quartiere Latino e alcune migliaia di mani festi con
testi e immagini, eseguiti con la tecnica della
serigrafia.
Per i movimenti politici alternativi era essenziale la
possibilità di occupare uno spazio pubblico
esposto: un monumento, le mura interne e esterne
di una università o di una fabbrica, i palazzi stessi
del potere.
Lo scopo è duplice: da un lato si tratta di far
pervenire all’opinione pubblica il proprio punto di
vista e le proprie notizie (controinformazione),
dall’altro si vuole anche segnalare visivamente la
propria presenza fisica nel territorio.
Negli anni a seguire, tra tutte le tecniche possibili,
se ne imporrà una per facilità e rapidità, quella
della bomboletta spray. È una forma di
comunicazione dal basso che è stata fatta propria
dai giovani e dai gruppi alternativi di tutto il mondo
e che ha dato luogo a novità grafiche che sono
divenute patrimonio comune di tutti, persino della
pubblicità. Nello stesso tempo ha generato una
lunga e infinita guerriglia tecnologica tra i
possessori delle superfici, che le desiderano libere
e «pulite» e gli autori anonimi e spontanei dei
graffiti urbani.
GIOVANI
Per tutto il corso degli anni ‘50, a cominciare dagli
Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, ma il resto dei
paesi sviluppati seguiranno a breve distanza, si
viene costruendo un nuovo campo problematico,
l’adolescenza, con al centro un nuovo Oggettosoggetto inquietante e conffittuale, i teen ager. Le
tracce di questa emersione sono chiaramente
registrate nei temi e nei linguaggi della cultura di
massa. Per in prima vàlta i giovani diventarono di
per sé veicolo per l’autori- flessione di una intera
società su se stessa, poio privilegiato in grado di
condensare tutte le inquietudini rimosse, la
sensazione d’instabilità mascherata dall’ottimismo
conformista del decennio. Fino ad allora, infatti, la
problematica giovanile, ben presente fin dalla
metà del secolo scorso, era stata per lo più
inquadrata nella cornice complessiva della
«questione sociale». L’interpretazione più corrente
del nuovo fenomeno fu, alla fine degli anni ‘50,
l’aumento del benessere economico e del tempo
libero, la dilazione dell’ingresso nel mondo del
lavoro, la scoperta di un nuovo formidabile bacino
di consumo da parte dell’industria culturale. In
Europa, soprattutto nella Repubblica federale
tedesca, si deve aggiungere una frattura profonda
tra la generazione della guerra e quella
successiva, accompagnata, nelle sue frange più
coscienti, da un rifiuto radicale. Dopo la metà degli
anni ‘60, a cominciare dagli Usa, la rivolta
giovanile si sarebbe spostata dalle guerre di
posizione in famiglia, dai ritrovi di quartiere, dai
segni identiflcanti dello stile e del corpo, alle aule
universitarie, alle marce, ai sit-in, alle battaglie per
i diritti civili, ma con tonalità diverse dal vecchio
impegno radical, allargandosi fino ad includere
l’intera area della cultura: la creatività, i
comportamenti, le modalità di aggregazione.
In Europa, l’emergenza di un universo giovanile
inquieto e in rivolta, si mostrò prima tra i ragazzi
della working class inglese con la sottocultura dei
mods, giovani in fuga dall’angusto grigiore della
predestinazione operaia, attraverso la musica
soul, le anfetamine, gli abiti, le acconciature. Ma
mentre il movimento hippie, politico e
controculturale, si dimostrò capace di proporre un
antagonismo radicale e utopico complessivo,
dispiegato sull’intera area dei rapporti sociali e
culturali, le sottoculture urbane, più segnate dalla
loro provenienza di classe, rimasero un tentativo di
resistenza
diretta
e
immediata
contro
un’oppressione vissuta nella quotidianità, pur
estendendo la loro influenza a gusti, stili e modi di
vita del decennio.
Una forte eco di tutto questo raggiunse l’Europa
continentale ben prima del 1968, dove però il
costituirsi di un soggetto giovanile antagonista,
visibile e di massa, coincise più da vicino con l’ora
della politica e del movimento di protesta.
Quest’ultimo, conservò, nei suoi esordi, una forte
soggettività giovanile, in Germania dove i padri
erano universalmente sospetti, ma anche in
Francia
e
in
Italia,
che
andrà
però
progressivamente attenuandosi man mano che si
afferma l’interpretazione del conffitto in termini di
«lotta di classe», escludendo con questo ogni
autorappresentazione del movimento in termini di
conflitto strettamente generazionale. Anche se,
nelle forme di aggregazione e di comunicazione, il
segno della rivolta giovanile non sarà mai
interamente cancellato.
GUERRIGLIA
Le insorgenze guerrigliere nel terzo mondo, a
ridosso della stagione delle indipendenze, furono
per l’opinione pubblica più radicale una sorta di
moderna incarnazione del bellum iustum. E la
ribellione violenta del più debole contro il più forte,
ma non più come semplice disperazione e
protesta, bensì come identità e progetto, capaci di
incrinare poteri incommensurabilmente maggiori.
Non sbaraglia il nemico militarmente, in campo
aperto, nello scontro tra eserciti, ma insidia
l’avversario per ogni dove, ne mina le certezze, ne
logora il prestigio e l’immagine, fa esplodere
tensioni parziali e imprevedibili colpendolo sui
terreno dell’identità e delle compatibilità politiche.
La prima teorizzazione di questa violenza è il foco
guerrigliero dei cubani, che intende appunto agire
sullo squilibrio tra potenza militare e debolezza
politica. Nell’esperienza guerrigliera, la violenza
armata e la politica, il proselitismo e l’azione
combattente,
appaiono
indissolubilmente
intrecciate
nella
soggettività
stessa
del
guerrigliero. Questi appare, con una buona dose di
idealizzazione, una persona più completa e
cosciente del militare che esegue ordini e svolge,
per così dire, una funzione specializzata.
Nell’immagine del guerrigliero la dedizione alla
causa si accompagna a un senso tutto personale
di giustizia e alla partecipazione soggettiva a un
generale processo di trasformazione della società.
Tutto questo contribuisce a costruire quell’aura
romantica che circonda la figura del guerrigliero e
che suggestionò potentemente le giovani
generazioni alla fine degli anni ‘60. Molto forte era
ancora il richiamo ai partigiani della resistenza
antifascista nella seconda guerra mondiale, anche
se, diversamente da questi, le guerriglie del
dopoguerra sembravano dover fare tutto da sole,
contare sulle proprie forze, camminare sulle
proprie gambe (sebbene nel mondo bipolare
ereditato da Yalta non fosse proprio così). Nei
movimenti di guerriglia del terzo mondo i
condizionamenti e il gioco geopolitico delle
superpotenze pesarono non poco e si resero ben
visibili negli assetti politici e statuali e nelle
tragedie sociali che scaturirono da molte di quelle
esperienze di lotta.
La guerriglia appariva dunque una forma violenta
di lotta alla portata di tutti, gestibile dal basso,
egualitaria, non separata dal tessuto sociale di
riferimento, capace di colpire ripetutamente poteri
repressivi immensamente più forti e, per questo, i
movimenti di protesta nei paesi occidentali ne
adottarono o credettero di adottarne il modello.
Guerriglia di strada, guerriglia urbana, così
venivano correntemente definiti gli scontri di
piazza tra manifestanti e forze di polizia. Ma non si
trattava solo di una questione di forme di lotta.
Segmenti di movimento (alcuni dei quali daranno
vita ai gruppi armati degli anni ‘70, essenzialmente
la Raf in Germania federale) vollero considerarsi,
in una società che ritenevano interamente e
inesorabilmente integrata nel sistema capitalistico,
come pattuglie guerrigliere della lotta di liberazione
del terzo mondo, destinate ad agire nelle
metropoli, dietro le linee nemiche.
IMMAGINAZIONE AL POTERE
L’immaginazione al potere fu lo slogan forse più
celebre del maggio francese. E, negli anni che
seguirono, forse anche il più deriso. Una
sciocchezza degna della altrettanto celebre
definizione data da De Gaulle del joli mai, la
chienlit, una carnevalata.
Ma quell’«immaginazione al potere» non fu solo
uno slogan provocatorio, fu la formula che più
precisamente restituiva il vissuto di quei giorni, lo
stato d’animo dei molti che parteciparono
all’«insurrezione». Nel momento culminante del
maggio il potere era praticamente sparito,
sembrava essersi dissolto, anche se, in realtà, era
stato solo provvisoriamente sloggiato dalle sue
sedi abituali. Qualche cosa aveva riempito questo
vuoto, qualcosa aveva sostituito il potere e
occupato interamente lo spazio fisico e simbolico
di Parigi. Questo qualcosa, che difficilmente
poteva essere assimilato a un nuovo potere, per i
suoi caratteri fluidi, spontanei, imprevedibili,
poteva anche definirsi «immaginazione». Si
trattava dell’occupazione di uno spazio pubblico in
cui tutto poteva e doveva essere sperimentato.
Una dissacrazione totale aveva investito istituzioni,
cultura, abitudini. E dunque tutto poteva essere
«immaginato» di nuovo. L’immaginazione al
potere indicava quel tempo che si colloca tra un
«non più» e un «non ancora», senza sospettare
che presto sarebbe stato chiuso in una parentesi.
Una dimensione del «possibile» che aveva però
materialmente invaso e occupato la scena del
reale e che alimentò una straordinaria creatività di
massa,
nei
linguaggi,
nelle
forme
di
comunicazione, in una quotidianità anomala,
inventata e vissuta giorno per giorno. Dall’Atelier
populaire installato nell’Ecole des Beaux arts,
straordinario laboratorio in cui lavorarono per più
di un mese un migliaio di persone, alla libera
tribuna dell’Odeon occupato. L’«immaginazione al
potere», non designò dunque un delirante
programma di governo, ma una parola d’ordine
che prendeva radicalmente di mira le forme stesse
della politica, anche quella di opposizione, che
furono poi uno dei principali bersagli del movimenti
del 1968. Tn questo senso non fu solo una
bandiera del joli mai, ma una corrente critica e un
bisogno di innovazione creativa che attraversò,
con risultati più o meno apprezzabili, i movimenti
di protesta in diversi paesi.
INDUSTRIA CULTURALE
“Nell’analisi critica della società che viene
sviluppata dai movimenti studenteschi, un
concetto che occupa un ruolo-chiave è quello di
«industria culturale». Nelle società del tardocapitalismo, infatti, il conflitto e l’antagonismo
sociale sono assopiti, e resi inoffensivi, dalla
presenza di un pervasivo
apparato
di
manipolazione delle coscienze, che si giova di tutti
i moderni mezzi di comunicazione di massa. La
battaglia politica contro la manipolazione
dell’informazione da parte dei media asserviti al
potere è un aspetto che accomuna i movimenti
studenteschi dei vari paesi. Il conflitto tra il
movimento e i media tocca il suo apice nella
mobiitazione degli studenti tedeschi contro i
giornali dell’editore Springer, ma anche in Italia si
registrano episodi significativi su questo fronte,
come ad esempio la protesta degli studenti
milanesi che si spinge fino al tentativo di impedire
l’uscita
del
Corriere
della
sera.
Il concetto di industria culturale, di cui si fece largo
uso nel Sessantotto, era stato elaborato già
parecchi anni prima. La critica sociale dell’industria
culturale, infatti, si trova sviluppata per la prima
volta in modo sistematico in un libro pubblicato nel
1947, la Dialettica dell’illuminismo, che forse si
può considerare il capolavoro dei due maestri
della Scuola di Francoforte, Max Horkheimer e
Theodor W. Adorno. Dedicando un capitolo della
loro opera filosofica all’industria culturale, gli autori
insistono sulla necessità di utilizzare proprio
questo concetto, respingendo quello più comune e
diffuso di «cultura di massa». A differenza che nel
concetto di cultura di massa, infatti, in quello di
industria culturale appare chiaro che ciò di cui si
parla non è in alcun modo un fenomeno
spontaneo. È vero piuttosto il contrario: quella che
nelle società tardo-capitalistiche appare come
cultura di massa è in realtà il prodotto pianificato di
un apparato industriale imponente che, con tutti gli
strumenti di cui dispone (radio, televisione, giornali
popolari e d’informazione, cinema di consumo,
musica, forme varie di spettacolo e di
intrattenimento) sostiene e diffonde in modo tanto
più efficace quanto più implicito i modelli cli vita e
di consumo che meglio si armonizzano con
l’assetto vigente dei poteri. In tutte le sue forme,
dunque, l’industria culturale è ideologia o, più
precisamente, apologia dello stato di cose
esistente; ma, a differenza delle ideologie
tradizionali, è ideologia in forma di merce. In una
società
caratterizzata
dall’accrescimento
quantitativo del tempo libero, i soggetti riempiono
questo tempo vuoto acquistando le merci
scintillanti che l’industria culturale propone loro.
Più che veicolare contenuti ideologici specifici, i
prodotti dell’industria culturale tra. smettono
comunque un messaggio che, anche quando sia
implicito, è molto preciso: viviamo nel migliore dei
mondi possibffi, e la cosa più razionale che
possiamo fare è non porci troppe domande, e
cercare di adattarci ad esso.
INTEGRAZIONE DELLA CLASSE OPERAIA
Mentre nella visione del marxismo classico la
classe operaia era il soggetto sociale collocato in
posizione «naturalmente» antagonista rispetto al
capitale, e l’unico che poteva abbattere il regime
capitalistico per far nascere una società diversa,
questa certezza non può più essere condivisa, a
livello generale, dai movimenti studenteschi e
giovanili del Sessantotto. In un modo che è assai
condizionato dalle diverse situazioni nazionali,
quindi, i movimenti si pongono il problema di quale
sia la funzione che la classe operaia può svolgere
in rapporto alla loro critica radicale della società
esistente: essa è ancora il principale soggetto
rivoluzionario, rispetto al quale gli studenti
possono svolgere una funzione di stimolo o di
avanguardia intellettuale, oppure è ormai
irrimediabilmente
integrata
nel
sistema?
La tesi della integrazione della classe operaia, che
avrebbe definitivamente perso il suo potenziale
critico
e
rivoluzionario,
viene
sostenuta
autorevolmente da Herbert Marcuse, il filosofo
della Scuola di Francoforte rimasto ad insegnare
negli Stati Uniti. Nella situazione presente del
capitalismo, sostiene Marcuse, per esempio, nelle
conferenze che pronuncia nel luglio 1967 presso
la Libera università di Berlino Ovest, non è più
possibile individuare una classe che, per al sua
posizione, sia in qualche modo predestinata a
svolgere il ruolo di forza trainante del processo
rivoluzionario. Se Marx individuà nel proletariato la
classe rivoluzionaria, sostiene Marcuse, ciò era
motivato anche dal fatto che egli vedeva in esso la
classe totalmente spossessata e, proprio per
questo, libera anche dalle false rappresentazioni
ideologiche che adornano il mondo borghese. Nel
frattempo, però, questa alterità è completamente
venuta meno, la classe proletaria è stata inclusa e
integrata; oggi l’individuo operaio non esprime
bisogni diversi da quelli che si riscontrano negli
altri strati della società. Non si rovescia l’ordine
esistente, sostiene però Marcuse, se non si parte
innanzitutto dalla affermazione di nuovi bisogni,
radicalmente diversi da quelli che la società
capitalistica produce e incoraggia, e grazie ai quali
si riconferma di continuo il consenso che i
governati assicurano ai rapporti sociali dominanti.
I portatori di nuovi bisogni radicali, incompatibili
con il «principio di prestazione» che domina nella
società borghese, non sono dunque gli operai, ma
piuttosto coloro come i giovani ribeffi, gli hippies, i
beatniks, nei quali si esprime il rifiuto di
partecipare ai benefici della società opulenta, la
critica dei modelli di consumo e di vita che essa
propone.
Ma la tesi della integrazione della classe operaia
non appartiene solo al filone marcusiano, e anzi si
ritrova, sebbene in termini del tutto diversi, nelle
tendenze «terzomondiste», che guardano ai
«dannati della terra» dei paesi poveri e colonizzati
come all’unica forza in grado si sfidare sul serio
l’ordine capitalista mondiale. Riprendendo un tema
che già Lenin aveva posto nel suo libro
sull’imperialismo, si sostiene che la classe operaia
delle metropoli capitaliste gode anch’essa in una
certa misura dei benefici che derivano dal dominio
imperiale, e quindi non ha alcun reale interesse a
schierarsi contro di esso. La vera lotta di classe è
quindi, in questa prospettiva, quella che oppone le
metropoli ricche alle periferie sfruttate del mondo,
è la lotta della «campagna» contro la «città».
Le teorie dell’integrazione della classe operaia si
affermarono nei contesti nei quali questa
sembrava una verità evidente, come per esempio
negli Usa o in Germania federale, mentre non
furono mai davvero accolte in paesi europei come
la Francia o l’Italia, dove anzi il boom economico
degli anni Sessanta si era accompagnato a una
ripresa forte e radicale di antagonismo operaio.
LOTTE DI LIBERAZIONE NAZIONALE
Alla fine degli anni ‘60 erano ormai venuti
pienamente in luce i limiti delle decolonizzazioni
che avevano inaugurato il decennio: fallimenti
economici, dipendenza fortissima dalle ex
metropoli, dai paesi sviluppati o dalla sfera di
influenza delle superpotenze. Il movimento dei
non-allineati era entrato in una fase di latenza
dalla metà del decennio, Cuba e la Cina non
nutrivano più grandi illusioni sulle potenzialità
rivoluzionarie del continente nero. Il classico
schema
determinista
che
prevedeva
l’indipendenza, la formazione di una borghesia
nazionale, lo sviluppo delle forze produttive che
avrebbe poi generato quelle contraddizioni
destinate a sfociare nella rivoluzione proletaria,
non poteva convincere più nessuno. Per le guerre
coloniali ancora in corso, essenzialmente quelle
nelle colonie portoghesi in Africa, si riteneva ormai
che l’indipendenza, per essere effettiva, avrebbe
dovuto coincidere immediatamente con una
rivoluzione: la socializzazione dei mezzi di
produzione
e
un
rapporto
radicalmente
riequilibrato tra città e campagna, secondo
l’insegnamento cinese. Insomma l’indipendenza si
sarebbe attuata insieme all’edificazione di una
nuova società e una nuova cultura. L’esponente
più significativo di questa corrente di pensiero fu
Amilcar Cabral, leader del movimento di
liberazione della Guinea Bissau, tra i più vicini allo
spirito dei movimenti del 1968.
Ma l’idea di liberazione nazionale andava ben oltre
la sfera delle guerre coloniali. Il dominio e il potere
di ricatto economico, culturale, politico-militare
delle potenze occidentali e, in particolare,
dell’imperialismo nordamericano si intendeva
esteso ai paesi indipendenti e perfino ai più deboli
alleati sviluppati degli Stati Uniti i quali, ovunque
nel mondo, avrebbero posto un freno alle forze
popolati e democratiche e garantito, con ogni
mezzo, le gerarchie sociali del capitalismo.
Dunque ogni lotta di liberazione nazionale, per
essere effettiva, sarebbe stata antiniperialista, in
particolare
antiamericana,
e
ogni
lotta
antimperialista sarebbe stata implicitamente una
lotta di liberazione nazionale, secondo l’esempio
vietnamita. Questa impostazione, che pur metteva
in luce rapporti di forza reali e maccettabffi
sudditanze, sottrasse ai movimenti ogni capacità
critica nei confronti del cinico gioco di potenza
condotto dall’Unione sovietica, del disastroso
fallimento dei modelli imposti nella sua area di
influenza, dei regimi autoritari e repressivi
appoggiati dal Cremlino. Inoltre, affiancata dalla
scoperta del relativismo culturale e del valore delle
«culture altre», finì col legittimare a sinistra
borghesie nazionali corrotte e feroci, regimi
fanatici e dittatoriali, in nome del loro
antiamericanismo. L’entusiasmo di una parte della
sinistra radicale per la rivoluzione iraniana del
1979 fa ancora parte di questa storia.
MAOISMO
Nei cortei, nelle assemblee e nelle manifestazioni
studentesche del Sessantotto, il nome di Mao fu di
queffi che più frequentemente risuonavano, anche
nella trinità un p0’ surreale «Marx-MaoMarcuse»,
che per una breve fase effettivamente campeggiò
sui cartelli e nelle scritte murali. Ma cosa ci
trovavano gli studenti, e anche gli intellettuali
europei (da La Cina è vicina di Bellocchio a La
Chinoise di Godard) nella Cina del presidente
Mao? Molte cose, e certamente anche molto
contraddittorie. Per i partitini marxistileninisti, che
si formarono soprattutto in Italia, in Germania e in
Francia, il maoismo funzionò come una sorta di
mito molto populista e molto integralista, come il
paradigma e il «santino» di un mondo alternativo a
quello borghese, portatore di una sorta di purezza
originaria, che i rivoluzionari dell’Occidente
dovevano riconquistare, anche attraverso un
lavoro di quasi religiosa autocritica (parola chiave
dei gruppi maoisti) e renovatio di se stessi.
Questo maoismo dagli aspetti molto caricaturali fu
quello nel cui «sogno» vissero gruppi come
l’italiana «Unione dei marxisti leninisti», che sulle
sue bandiere esponeva il motto «servire il
popolo».
Altri erano però gli aspetti dell’esperienza maoista
che attraevano le punte intellettualmente più
avanzate del movimento. In Mao si vedeva,
innanzitutto, il capo rivoluziobario che aveva
tentato, in un paese contadino, una via di sviluppo
notevolmente diversa da quella seguita, con
enormi costi, dai sovietici: no al primato
dell’industria pesante, no alla collettivizzazione
forzata in agricoltura. Ma, soprattutto, il Mao
amato dal movimento fu quello della Rivoluzione
culturale: il Mao dello slogan «bombardate il
quartier generale!», della contestazione dal basso
di tutti i poteri gerarchici nel partito e nella società,
dell’attacco senza quartiere alle incrostazioni
burocratiche, e quindi anche ai privilegi o ai poteri
basati su (presunti o reali) specialismi. Uno degli
aspetti del maoismo che piacque di più al
movimento fu proprio la critica alla neutralità del
sapere e dello specialismo, che si incontrava con
riflessioni analoghe maturate sul terreno più
avanzato dell’Occidente.
La critica antiistituzionale e antipartito, che è uno
dei punti- chiave della Rivoluzione culturale, aveva
ovviamente anche un aspetto meno piacevole, che
però il movimento tendeva in sostanza a non
vedere: il rapporto diretto, senza mediazioni, tra le
masse e il capo, con tutta la santificazione che
inevitabilmente ne derivava. Proliferavano i ritratti
oleografici di Mao, si sventolava il «libretto rosso»,
raccolta di citazioni dalle opere del Presidente che
fungeva al tempo stesso da bandiera e da summa
di saggezza, ricalcata sul modello dei più antichi
maestri di sapienza orientali.Nel Sessantotto,
nentre i giovani d’Europa guardavano con
passione e partecipazione a Mao e alla sua inedita
rivoluzione, in Cina la rivoluzione delle guardie
rosse si stava esaurendo. In seguito essa fu
criticata e poi infine addirittura demonizzata, fino
alla immagine terribile che ne ha dato agli
spettatori di tutto il mondo il più recente cinema
cinese (una delle cose migliori, peraltro, che dalla
cultura cinese siano venute in questi ultimi anni).
Epoca di una grande spinta libertaria o invece
tempo buio, caratterizzato da un vero e proprio
oscuramento delle ragione? Col problema se la
vedranno gli storici; il movimento del Sessantotto,
a caldo, non poté averne neppure il sentore.
HERBERT MARCUSE
L’importanza di Herbert Marcuse per la cultura del
movimento del ‘68, almeno in Europa occidentale
e negli Stati Uniti d’America, fu grandissima. Molto
letto e discusso suo paese d’origine e in quello
d’elezione (la Germania e gli Stati Uniti), Marcuse
fu anche in Italia e in Francia voracemente e
tempestivamente tradotto. I suoi libri più
importanti, da Eros e civiltà a L’uomo a una
dimensione a Critica della tolleranza, funzionarono
per un certe periodo come una bandiera, che ogni
studente del movimento aveva l’orgoglio di esibire
e di portare con sé.
Ma quale fu l’uso che gli studenti fecero di questo
filosofo dalla biografia singolare, che prima aveva
studiato con Heidegger, poi aveva collaborato con
Horkheimer e Adorno, e infine, quando i
capiscuola francofortesi erano tornati in Germania,
aveva continuato a lavorare in America,
insegnando all’università di California? Per capirlo
si può cominciare col ricordare un episodio di
assoluto rilievo, l’incontro-dibattito tra Marcuse e
gli studenti che si tenne nel luglio ‘67 a Berlino
Ovest, organizzato dal comitato di lotta della
Libera Università.
L’idea da cui Marcuse in quella occasione prende
le mosse è quella di «fine dell’utopia». Ma
attenzione a non fraintenderla: fine dell’utopia non
vuoi dire che si debbano abbandonare le utopie
per convertirsi al realismo, ma proprio l’opposto:
ciò che fino a ieri poteva apparire utopico, sogno e
speranza eccessiva anche per il socialismo di
ispirazione marxista, è ormai, dice Marcuse, una
possibilità del tutto tangibile e realizzabile,
realistica almeno nel senso che non è ostacolata
da nessun insormontabile elemento oggettivo.
Nella società dell’opulenza e dell’automazione,
sostiene Marcuse, è ormai a portata di mano non
solo la cancellazione della povertà e della miseria,
ma anche l’abolizione del lavoro estraniato, e con
esso di tutte le forme evitabili di repressione
sociale e istintuale.
Se le difficoltà ci sono, e anche grandi, come
Marcuse non si stanca di ricordare agli studenti
impazienti, non è su questo terreno che vanno
cercate, ma su quello, che infatti diventa centrale,
della soggettività: la seconda tesi di Marcuse,
quella che più sarà discussa, è infatti che alla
presenza delle più ampie possibilità oggettive di
liberazione fa riscontro l’assenza di forze
soggettive capaci di cogliere queste possibilità e di
tradurle in pratica. La classe operaia, che
nell’ottica marxista avrebbe dovuto essere la forza
portante della trasformazione sociale, è ormai,
almeno nei paesi di capitalismo avanzato,
saldamente integrata nel sistema: grazie
soprattutto alla diffusione dei beni di consumo e
alla potenza manipolativa dei mezzi di
comunicazione di massa. Questi costituiscono
ormai un apparato ideologico inattaccabile, che
assicura il sostegno più efficace alla democrazia
autoritaria del tardo capitalismo. Certo, Marcuse
non si stanca di insistere sul fatto che sarebbe un
grave errore confondere questa col fascismo: la
«tolleranza repressiva» del tardo capitalismo ha
modi assai più «soft», e consente una vita molto
più comoda, anche se riesce altrettanto bene a
impedire la formazione di un’opinione pubblica
autonoma e cli organizzazioni politiche di autentica
opposizione. Anche dietro le forme democraticoliberali, perciò, si cela, secondo Marcuse, una
struttura di potere come sempre inattaccabile,
sostenuta non solo dai tradizionali apparati di
dominio repressivo-polizieschi, ma anche e
soprattutto dai nuovi strumenti di manipolazione.
Alle nuove forme di dominio, perciò, può
contrapporsi — sostiene Marcuse — solo
un’opposizione di tipo completamente nuovo: essa
ha il suo punto di forza da un lato nelle masse
sfruttate del Terzo Mondo (che costituiscono oggi
il vero proletariato) e dall’altro nei nascenti (ma
minoritari) potenziali di rifiuto e di antagonismo che
cominciano a svilupparsi anche nelle metropoli.
L’opposizione, qui, non nascerà di certo dalla
classe operaia o dai ceti medi che occupano la
parte centrale della piramide sociale; essa si
svilupperà piuttosto alle sue estremità, e cioè tra le
élites studentesche e intellettuali oppure,
all’estremo opposto, tra i gruppi più poveri ed
emarginati del sottoproletariato urbano. Ma il ruolo
dei giovani e degli studenti è essenziale, perché
essi sono portatori di nuovi bisogni radicali,
fortemente connotati in senso istintuale, erotico ed
estetico, che risultano incompatibili con una
società dominata dal «principio di prestazione». E
proprio grazie all’emergere di questi bisogni
radicali che si può cominciare a prospettare una
politica della liberazione di tipo nuovo, proiettata
verso un’utopia realista, che s’ispira più a Fourier
e al suo «mondo amoroso» che non al vecchio
Marx.
Il grande interesse dei movimenti studenteschi
per Marcuse, però, andò scemando piuttosto
rapidamente. Quando il filosofo tornò a Berlino
nell’aprile del ‘68 fu ancora accolto, nell’aula
magna gremita, da studenti che cantavano
l’internazionale, ma la speranza rivoluzionaria si
nutriva ora di apporti diversi (leninismo, maoismo,
tutte le varietà del marxismo eterodosso) e quindi
finì per non aver più bisogno del vecchio
francofortese. In Francia e in Italia, poi, il
movimento coinvolse in pieno anche la classe
operaia
cosicché
il
Marcuse
teorico
dell’integrazione
apparve
clamorosamente
smentito dai fatti e la ricerca di punti di riferimento
teorici si volse altrove.
MITI DEL ‘68
Il movimento del 1968 fu forse l’ultimo fenomeno
collettivo del nostro secolo a imporre nelle piazze
di tutto il mondo i propri exempla virtutis, in
quell’antico senso etico e civico, che non
avrebbero più posseduto altri miti generazionali
degli anni successivi. Tanto è vero che fino ai
giorni nostri sopravvive, un po’ misteriosamente, il
più potente di quegli exempla, quello di Che
Guevara. Ma non fu il solo. Nelle strade di mezzo
mondo furono scanditi i nomi e issate le immagini
di Ho Chi Minh, di Mao Tse Tung, di Fidel Castro,
Camilo Torres, Amilcar Cabral, Malcolm X.
Come tutti i momenti di rottura, il 1968 ebbe fretta
di costruirsi una tradizione e un punto di
riferimento nei grandi sommovimenti della storia
contemporanea, un campo che, al di là delle
differenze che lo attraversavano, delimitasse
l’orizzonte della Rivoluzione. Da una parte
troneggiava il modello di chi aveva guidato, o
stava guidando, grandi masse oppresse nella lotta
contro maggiori potenze mondiali, come nel caso
di Mao e di Ho Chi Minh, dall’altro, l’esempio di
coraggio, sacrificio personale e rifiuto del
compromesso, come nel caso di Guevara,
Malcolm X, Cabral, Torres. Ma in entrambi i casi si
trattava di figure combattenti (il Mao che
appassionò fu quello della Rivoluzione culturale),
mai di governi stabili, pur generati da rivoluzioni
vittoriose (la Cuba di Castro era considerata una
trincea di prima linea in guerra contro
l’imperialismo americano), il 1968 coltivò molto più
un’ idea di rivoluzione permanente, che quella di
un socialismo realizzato, anche diverso e migliore
di quello miserevole offerto dall’Europa dell’Est.
Nulla gli fu più estraneo dell’idea di una «fine della
storia». E le figure simboliche che si scelse si
attagliavano tutte a questa dimensione conflittuale
permanente.
Con lo stesso fervore, il movimento elesse a suoi
contemporanei e ispiratori pensatori e politici del
passato, in gran parte riappropriandosi della
tradizione del movimento operaio, ma in parte
discostandosene e riscoprendo figure eretiche o
dimenticate o minoritarie. Tornarono oggetti di
culto, ma anche di studio approfondito e di analisi
critica, i capi bolscevichi da Lenin a Trotsky a
Zinoviev, i dirigenti sconfitti della rivoluzione
tedesca Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, gli
uomini della Comune di Parigi, gli anarchici
catalani, i movimenti consiliari, i teorici classi c del
marxismo, ma anche i marxisti più eterodossi. Si
disputava a colpi di citazioni, non sempre
pertinenti, cariche dell’autorità di quella tradizione,
si istituivano cortocircuiti e improbabili paragoni tra
situazioni storiche passate e presenti, ma si
alimentò anche un fermento di riflessione critica
che avrebbe dato presto i suoi frutti originali, e non
solo nell’ambito specffico del pensiero politico.
NEOMARXISMI
Avido com’era di teoria che gli consentisse di
pensare una rivoluzione possibile, il movimento
del Sessantotto si gettò voracemente su tutta la
gamma di pensiero marxista o neomarxista allora
disponibile, e fu altresì all’origine della riscoperta
di aspetti eterodossi o dimenticati del marxismo
«storico». Intorno al Sessantotto, subito prima o
poco dopo, tornarono in circolazione in Germania
(talvolta con edizioni pirata) e furono tradotti in
Francia e in Italia i grandi dassici del marxismo
teorico del Novecento: Storia e coscienza di
classe di Lukcs e Marxismo e filosofia di Karl
Korsch. Furono letti con avidità i testi classici della
Scuola
di
Francoforte
(la
Dialettica
dell’illuminismo, gli scritti di Horkheimer negli anni
Trenta), che gli autori, come raccontò una volta
Habermas, avevano lasciato coprirsi di polvere in
qualche scantinato dell’Istituto per la ricerca
sociale, e non avevano nessuna voglia di veder
ristampati. Si ripresero, anche se con meno
intensità, le tradizioni antiortodosse e consffiari,
dalla Luxemburg a personaggi assai meno noti
come Anton Pannekoek.
Ma accanto a questa vasta opera di ripescaggio a
tutto campo, il movimento si confrontò con quegli
intellettuali che, nel dopoguerra, avevano
sviluppato il confronto col marxismo e ne avevano
dato nuove interpretazioni. Primo fra tutti Louis
Althusser: Pour Marx, il testo che lo fece
conoscere in tutto il mondo, era uscito in Francia
nel ‘6 nel ‘68 usciva l’opera collettiva Lire Le
Capital (Leggere il Capitale), alla quale
partecipavano Etienne Balibar, Jacques Rancière
e altri studiosi della scuola althusseriana. Nei libri
di Althusser gli studenti incontravano un approccio
al marxismo assolutamente originale: un Marx
letto come protagonista di una grande rivoluzione
epistemologica, alla luce della suggestiva filosofia
della scienza di Gaston Bachelard. Un Marx che
rompeva con due grandi ideologie degli anni
Cinquanta e Sessanta, lo storicismo e
l’umanesimo. E che veniva ricostruito come il
teorico di un «processo senza soggetto», come il
pensatore non dello storicismo ma, al contrario,
della «struttura». Con Althusser il marxismo
tornava al centro della scena e apriva un dialogo
con tutta una generazione di teorici eterodossi che
allora affollavano la scena francese: dal LéviStrauss studioso delle «strutture» della parentela
fino a Foucault e Lacan.
In Germania, accanto all’eredità della Scuola di
Francoforte, tuttora ben viva e vitale (e ripresa,
dall’interno del movimento, da un intellettuale
precoce e geniale come Hans-Jùrgen Krahl) a
occupare la scena vi è anche il pensiero
dell’anziano Ernst Bloch, l’autore dello Spirito
dell’utopia che nel 1961 aveva lasciato la Ddr per
trasferirsi all’Università di Tùbingen, e che nel ‘68
intreccia un dialogo con Rudi Dutschke.
Sul fronte dell’analisi sociale ed economica una
delle più rilevanti novità viene dagli Stati Uniti:
proprio nel Sessantotto Paul Baran e Paul Sweezy
(gli animatori della Monthly Review, una delle
riviste più lette di quegli anni) pubblicano Il capitale
monopolistico, forse il libro di economia più
importante di quel periodo. Guardando alla
struttura economica e sociale degli Stati Uniti,
Baran e Sweezy aggiornano radicalmente gli
strumenti dell’economia marxista (esponendosi
anche agli strali degli ortodossi), introducono
il concetto di «surplus», e fanno i conti con le
grandi imprese, lo Stato, il consumismo, il
militarismo.
OPERAI E STUDENTI
L’uscita dalle università e dalle scuole verso il
sociale e verso la fabbrica avvenne in maniera
pressoché spontanea e quasi obbligata, anche se
a produrla furono molti fattori, non tutti coerenti tra
di loro. Da un lato i leader degli studenti si resero
ben presto conto che il movimento rischiava di
rtare soffocato nella dialettica occupazionesgombero-nuova occupazione. Sapevano bene di
dover mantenere il proprio specifico e la propria
«base di massa», ma anche che quella esperienza
poteva finire per semplice esaurimento. Dunque la
scelta di proiettarsi all’esterno corrispondeva
anche a un bisogno di sostegno e di alleanze
sociali. La fabbrica e i quartieri erano il terreno
naturale dove cercarle.
Dall’altro, alcune elaborazioni erano andate oltre la
questione scolastica e della riforma dell’università.
Le analisi teoriche tendevano a vedere lo studente
come parte della produzione, sia nella versione
della «proletarizzazione», che in quella della forza
lavoro in via di qualificazione. Perciò gli stessi
problemi dell’università non potevano avere
soluzione solo dentro le sue mura Non si trattava
semplicemente di attivare una politica delle
alleanze tra gruppi sociali diversi, ma piuttosto di
operare per una più avanzata «ricomposizione di
classe». Infatti, se studenti, operai e tecnici erano
tutti forze produttive soggette alle dinamiche di
controllo e di esproprio del capitale, se
tendenzialmente erano la stessa cosa, allora era
ragionevole concretizzare questa condizione di
uguaglianza in una teoria e in una pratica che
riunificasse quello che fino ad allora era rimasto
artificialmente diviso.
Infine da parte di chi considerava, teoricamente o
di fatto, gli studenti come una forza rivoluzionaria,
era inevitabile la tendenza a esercitare questo
ruolo nella società nel suo complesso. In questa
versione gli studenti apparivano come le
avanguardie più consapevoli e radicali e il loro
compito storico doveva essere quello di propagare
l’incendio sociale anche in altri settori. A maggior
ragione se si riteneva che le organizzazioni
storiche del movimento operaio, partiti e sindacati,
avessero in qualche modo «tradito» o comunque
ingabbiato l’antagonismo operaio in una pratica e
in una teoria riformiste, che non mettevano più in
discussione gli equilibri di potere della società. In
questa versione si trattava soprattutto di
«smascherare» il ruolo di collaborazione di classe
delle organizzazioni storiche del movimento
operaio e di indicare la linea giusta, anche
entrando direttamente nel merito delle piattaforme
rivendicative.
Quali che fossero le motivazioni, insomma, per le
avanguardie studentesche l’andata verso i cancelli
delle fabbriche fu dunque un passo naturale, che
si concretizzò in diversi modi: dalla costituzione di
collettivi misti studenti operai con scopi prevalenti
di analisi e di confronto della propria condizione
subalterna, diversa ma simile, al volantinaggio un
po’ ingenuo davanti agli ingressi per chiedere
solidarietà, per convocare manifestazioni comuni o
su
temi
di
portata
politica
generale.
I frutti di questo lavoro comune si sarebbero visti,
soprattutto in Italia, a partire dall’autunno e poi per
tutto il 1969. Ma va detto che, al di là delle
manifestazioni comuni, il rapporto organico con la
classe operaia riguardò essenzialmente fasce
ristrette degli uni e degli altri. Pesò ugualmente e
in maniera significativa nelle vicende del
sindacalismo italiano; produsse analisi importanti
anche sul piano teorico, ma fu inevitabilmente
confinato ai protagonisti più politici di quei
movimenti. E proprio il mancato «incontro di
massa» produsse come unica possibile scelta, la
nascita dei «gruppi politici», in forma se non di
partito, certo di avanguardie a tutto campo, con
una propria elaborazione separata e proprie
strutture organizzative diverse da quelle del
movimento e delle assemblee.
OPERAIO MASSA
Con il termine di «operaio-massa» fu designato
l’operaio «senza qualità» della fabbrica fordista e,
al tempo stesso, il soggetto principale di un nuovo
ciclo di lotte, con caratteristiche sue proprie,
proprie
forme
di
organizzazione
e
di
insubordinazione. E l’emergere, all’interno della
classe, dell’operaio di linea, non qualificato, calato
nella più totale parcellizzazione del processo
produttivo, posto, nel modo più crudo possibile, di
fronte alla sua natura di merce, privo di
significative tradizioni ideologiche e organizzative.
Questo
nuovo
soggetto,
alimentato
dall’immigrazione, dall’espansione economica
degli anni ‘60 e dall’organizzazione taylorisrica del
lavoro, si contrapporrà alla classica fIgura
dell’operaio professionale europeo. cuore della
tradizione socialista e sindacale, anticapitalista,
ma orgoglioso della sua capacità di produttore e
attento alle ragioni dell’«interesse generale».
L’«operaio massa», risultato di una gigantesca
mutazione della composizione di classe, indotta
dalla razionalizzazione taylorista della produzione
nella grande industria, che riduce sempre più il
lavoro ai suoi caratteri astratti e impersonali, è, al
tempo stesso, il protagonista del tumultuoso ciclo
di lotte di fabbrica che si colloca a cavallo degli
anni ‘60 e ‘70. Queste lotte, alimentate da una
diffusa spontaneità, punteranno a inceppare il ciclo
produttivo, sfruttandone la natura e le debolezze,
con il minimo di rischio e di esposizione per i
singoli operai: scioperi selvaggi, interruzioni
improvvise, atti di sabotaggio, scontro diretto, e
spesso violento, con le gerarchie di fabbrica.
Dall’operaio dequaliflcato proverrà poi anche una
prepotente spinta egualitaria, insofferente delle
divisioni legate alla vecchia scala professionale, e
una volontà di partecipazione diretta in costante
tensione conflittuale con le organizzazioni
sindacali, oltre a una forte accentuazione delle
rivendicazioni salariali, le quali rifiutano ormai di
subordinarsi alle «compatibffità» dell’azienda. In
Italia, dove il nuovo ciclo di lotte operaie
raggiunge, a partire dal 1969, l’intensità e la
persistenza maggiori, nasce la parola d’ordine del
«salario come variabiie indipendente».
Sarà proprio questa componente della classe
operaia a entrare più facilmente in contatto con i
gruppi politici più radicali di origine studentesca e
a percorrere spesso nuove vie di politicizzazione
proiettate fuori dalla fabbrica e fondate sul rifiuto
stesso della condizione operaia. Ma se l’Italia
resterà per diversi anni il principale laboratorio
dell’operaio massa» e delle sue forme di
espressione conflittuale, gli operai di linea non
qualificati e la rottura con la tradizione della
disciplina sindacale, occuparono un posto
importante anche durante il maggio francese, con
il rifiuto degli accordi sindacali, pur discretamente
favorevoli, di Grenelle e in Germania, durante il
ciclo di scioperi selvaggi dell’autunno 1969.
OPERAISMO
Tra le molte correnti intellettuali, marxiste o
neomarxiste, che prepararono il terreno per il
movimento del Sessantotto, una delle più ricche
intellettualmente e soprattutto una delle più
originali fu quella che si raccolse, proprio all’inizio
degli anni Sessanta, attorno alla rivista Quaderni
rossi. I Quaderni furono la prima e anche la più
importante tra le riviste del cosiddetto operaismo
italiano, e l’intellettuale che più diede ad essa la
sua impronta fu Raniero Panzieri, che veniva dalla
militanza socialista e che sarebbe stato poi, fino al
licenziamento per motivi politici, redattore della
casa editrice Einaudi.
Contro i teorici del neocapitalismo come portatore
di benessere e di pace sociale, la scommessa dei
Quaderni rossi, come scrisse un altro degli
intellettuali del gruppo, Mario Tronti, era che
l’impetuoso sviluppo del capitalismo (siamo nella
fase del cosiddetto boom economico) avrebbe
prodotto non solo liveffi più alti di lotta operaia ma,
al tempo stesso, una nuova qualità dello scontro di
classe: rifiuto della delega in bianco alle
organizzazioni sindacali, centralità dell’assemblea
operaia, rivendicazione non solo di più salario ma,
diceva già allora Panzieri, di potere operaio. I
Quaderni rossi furono «operaisti», quindi,
innanzitutto
nel
rivendicare
il
carattere
sommamente politico delle lotte di fabbrica. Non
ha senso, diceva Panzieri, pensare di salire al
decimo piano, quello politico-statuale, quello delle
istituzioni, se prima non si sono pazientemente
scalati gli altri nove, se non si sono intaccati i
rapporti di potere sociale dalle loro fondamenta,
nella fabbrica. In questo conflitto un’arma
fondamentale è quello che Panzieri chiama «l’uso
capitalistico delle macchine»: l’innovazione
tecnologica dei processi produttivi non è neutrale,
ma è uno strumento di cui il potere capitalistico si
serve per rafforzarsi e ristrutturarsi di continuo, e
quindi per scomporre e indebolire la resistenza
operaia.
L’altro tema non ortodosso sul quale Panzieri
insiste è quello del capitale come pianificazione
(rovesciando il discorso tradizionale sulla anarchia
del mercato): col passaggio al capitalismo di
monopolio e allo stato del benessere, il capitale
governa e pianifica per la prima volta la società nel
suo insieme — un processo che, in qualche modo,
cancella la differenza tra la fabbrica e la società
intera. Alcune delle ipotesi teoriche dei Quaderni
rossi trovano conferma nei mutamenti che si
producono nei primi anni Sessanta: la ripresa delle
lotte operaie, gli scontri di Piazza Statuto a Torino
nel luglio del 1962.
Nel 1964 dai Quaderni rossi si stacca un gruppo
(ne fanno parte Mario Tronti, Alberto Asor Rosa,
Toni Negri) che dà vita al giornale Classe operaia.
Qui la teoria operaista si radicalizza, si pone in
modo più diretto il problema di costruire una
organizzazione, riscopre il leninisrno (Lenin in
Inghilterra, si intitola un celebre articolo di Tronti
nel ‘64, mentre il suo libro più famoso è Operai e
capitale). Tipica di questa fase è l’enfasi sulla
autonomia della classe operaia: sono i movimenti
della classe che generano lo sviluppo e le
trasformazioni del capitale, e non viceversa.
Dal filone operaista nascono poi, tra il Sessantasei
e il Sessantotto, una serie di gruppi di intervento
operaio organizzati localmente, come il Potere
operaio veneto-emiliano e il Potere operaio di
Pisa, e a Roma il gruppo che si raccoglie intorno
alla rivista Classe e stato. Nel frattempo però
all’interno della vasta galassia operaista si sono
ormai sedimentate delle divisioni profonde: mentre
il gruppo di Asor Rosa, Tronti e Cacciari si orienta
per operare all’interno del Partito Comunista, Negri
e altri lavorano per dar vita a organizzazioni
politiche autonome. L’ultimo tentativo di una
elaborazione teorica comune, e cli altro proffio, è
la rivista Coniropiano, che viene progettata nel ‘67
ed esce nel ‘68. Ma il lavoro comune dura poco,
perché già dal secondo numero Negri lascia la
direzione del periodico. Dalla matrice operaista
derivano quindi esperienze politiche molto diverse
e anche tra loro conflittuali.
PERSONALE È POLITICO
«Il personale è politico» è uno slogan del ‘68 che è
sopravvissuto a lungo anche nella cultura
postsessantottina. Signffica che non ci sono spazi,
personali o privati, che siano neutrali o
indipendenti dai conflitti e dai poteri che si
confrontano
nella
società.
Nella
visione
sessantottina, tutto è determinato dal sistema, che
non è tanto il sistema di produzione, quanto il
sistema delle gerarchie, dallo Stato alle istituzioni
parziali come la famiglia e la scuola, fino alle
istituzioni totali come l’ospedale e il carcere. Ma
proprio perché la logica del sistema è
onnipervasiva, altrettanto è il suo rovesciamento:
ogni affermazione della persona che contesta la
propria manipolazione o il proprio utilizzo ai fini
della trasmissione e della difesa dei ruoli stabffiti è
anch’essa politica, ha già un valore di opposizione
e di antagonismo. L’io è politicità irriducibile,
compressa e repressa. Politico quindi è, per prima
cosa, il conflitto genitori-figli all’interno della
famiglia: la posta in gioco nello scontro con le
figure parentali è l’introiezione dei ruoli sociali che i
genitori pretendono di inculcare ai figli, nell’abito,
nelle maniere, nella sessualità, nel linguaggio e
più che mai nelle scelte che riguardano l’avvenire.
Politica, quindi, non è solo la sfera che
tradizionalmente questo concetto aveva delimitato:
politico è anche lo spazio dei rapporti
interpersonali che gli individui tentano di impostare
in modo diverso da quello che il sistema vorrebbe
imporre loro. Anzi, la vera novità del Sessantotto
forse sta proprio qui: nella consapevolezza del
fatto che non c’è liberazione collettiva, cioè
politica, se non insieme con un processo di
autoemancipazione dell’individuo, che comincia
dai luoghi e dai rapporti che tradizionalmente sono
stati considerati come privati e personali
«Il personale è politico», quindi, è una parola
d’ordine che viene scagliata contro quei modi di
relazione interpersonale nei quali la generazione
ribelle del Sessantotto non si riconosce più. Ma al
tempo stesso segna anche il rischio di una sorta di
politicizzazione totale, integrale, infine un po’
ossessiva, di ogni ambito dell’esperienza: caduta
la separatezza della politica, la si ritrova in ogni
dettaglio, in ogni aspetto anche nascosto della vita
dell’individuo. Quando arriverà il riflusso, questa
politicizzazione totale sarà la prima cosa a essere
volta in caricatura: anche per fare l’amore, c’è un
modo di destra e uno di sinistra. Negli anni a
seguire, sarà invece il femminismo a rilanciare la
carica di ribellione contenuta in questa parola
d’ordine sessantottina, ma in un contesto sociale e
teorico completamente diverso. Quello della
differenza sessuale che metteva in questione
l’universalità sessualmente indifferenziata del
politico.
POTERE-SISTEMA
I movimenti studenteschi del 1968 e le correnti di
pensiero critico che li influenzarono e ne furono
influenzate si attribuirono un compito essenziale di
«smascheramento»: si trattava di indagare,
svelare e trasmettere all’opinione pubblica,
l’asprezza dei rapporti reali che si celavano dietro
le apparenze sociali, la sostanza di oppressione
che sottendeva le civili forme della democrazia. E
non si stancarono mai, fino a raggiungere vere e
proprie forme di ossessione, di denunciare la
complicità tra i comportamenti sociali «normali», le
abitudini apparentemente più innocenti, e gli orrori
che, in difesa dei rapporti di potere dominanti,
venivano perpetrati in paesi lontani o ai danni dei
ceri sociali più deboli in casa propria. Le complicità
dei saperi scientifici e tecnologici con l’industria
bellica e i meccanismi dello sfruttamento (un tema
centrale
del
movement
statunitense),
l’interiorizzazione
di
valori
egoistici,
la
discriminazione dei diversi, l’obbedienza e la
disciplina (spesso confrontate, soprattutto in
Germania, con il significato che avevano assunto
durante il nazismo), il rifiuto della partecipazione e
l’esaltazione dell’impoliticità, le doppie morali e la
separazione drastica tra pubblico e privato, i miti
della sicurezza e dell’ordine, tutto questo fu
analizzato nei suoi risvolti più crudi e imputato di
tenere insieme un «sistema» unitario nei suoi
orrori e nei dividendi di benessere che distribuiva.
Il 1968 non si rivoltò contro questi o quei governi,
ma contro il «sistema», una realtà totalizzante e
pervasiva che dominava tanto sullo sfruttamento
delle risorse planetarie, naturali e sociali, quanto
sui modi di vita dei singoli e sulle loro forme di
pensiero (i movimenti del ‘68 saranno
successivamente definiti da alcuni studiosi, per
esempio Immanuel Wallerstein, «antisistemici»). In
questa designazione, poi caduta in disuso,
indebitamente derisa e disprezzata, confluivano in
realtà, fondendosi spesso in modo semplicistico,
alcuni tra i più rilevanti risultati teorici della critica
sociale: il concetto marxiano di «modo di
produzione» e l’analisi del «feticismo delle merci»
con il suo rovesciamento dei rapporti tra persone
in rapporti tra cose, la critica della razionalità
occidentale e il concetto di dominio, elaborato
dalla scuola di Francoforte, i risultati critici della
psicoanalisi e dell’antropologia. Si trattava
insomma di un approccio critico alla totalità
sociale, tutt’altro che privo di fondamenti.
«Sistema» funzionava anche senza aggettivi,
come «capitalistico» o «totalitario», nell’indicare un
insieme di nessi obbligati e di condizionamenti
reciproci, che costituivano la «normalità» e
facevano di ogni mancato schieramento e di ogni
delega irriflessa, una oggettiva complicità con la
violenza del potere dominante.
E il processo esattamente inverso rispetto alla
«teoria sistemica», stabilizzatrice e «esonerante»,
di Nklas Luhmann, che probabilmente deve una
parte della sua fortuna a una reazione all’eccesso
di partecipazione e impegno, preteso negli anni
dei movimenti. In effetti, la presenza del
«Sistema» e dei suoi «tentacoli» nell’immaginario
quotidiano del ‘68 assunse talvolta i tratti
paranoici, offuscò distinzioni importanti e finì con
l’alimentre diffusi stereotipi.
POTERE STUDENTESCO
Potere studentesco è la prima (e una delle più
condivise sullo scenario internazionale) tra le
parole d’ordine del movimento degli universitari.
Ma è anche un motto che segna una fase e che
indica un problema: potere studentesco è la parola
d’ordine della prima fase del movimento, quella
che
si
concentra sulla
lotta
all’interno
dell’istituzione universitaria, ed è quindi lo slogan
che verrà superato e messo in discussione
quando, troppo piccole per la carica rivoluzionaria
generale del movimento, le università e le scuole
diventeranno nei fatti la base dalla quale il
movimento partirà per portare il suo attacco
generale al sistema.
La rivendicazione del potere studentesco che, per
fare solo due esempi, risuona tanto nelle aule di
Palazzo Campana a Torino, quanto nell’edificio
londinese della London School of Economics, è
quasi il rovescio di quella critica dell’autoritarismo
accademico che è, un po’ dappertutto, il fattore
d’innesco della rivolta degli atenei. Gli studenti
rifiutano di essere i soggetti passivi di una
formazione sulla quale non hanno alcuna voce in
capitolo, e il cui scopo fondamentale è quello di
riprodurre subordinazione, obbedienza, e rinuncia
alle capacità critiche. Criticano l’università come
meccanismo d’integrazione sociale che ha la
funzione di riprodurre lealtà di massa nei confronti
dei poteri e dei sistemi di idee dominanti.
Potere studentesco è quindi, in primo luogo, la
rivendicazione di controllare o autogestire il
proprio percorso universitario, i contenuti dello
studio, i metodi di apprendimento, le modalità cli
funzionamento della istituzione universitaria nel
suo complesso, gli organi che la governano.
Anche in questo primo senso, però, potere
studentesco
non
è
una
rivendicazione
cogestionale o riformistica, ma mira piuttosto alla
costruzione di una università altra: occupazioni,
controcorsi,
università
critica,
università
autogestita. Pratiche in cui la conoscenza diventa
il risultato di un processo di autoeducazione
collettiva finalizzato alla costruzione di un sapere
critico che interrompe la funzione integrativa
dell’università e ne fa anzi la base propulsiva di un
generale attacco al sistema.
Quindi potere studentesco è anche, svolgendo le
implicazioni del primo e più ristretto signfficato,
affermazione di un potere degli studenti non solo
dentro le università, ma più in generale nella
società. Gli studenti, come scriveva David
Aldestein, uno dei leaders della protesta alla
Londori School of Economics, devono porsi come
un potere nella società capace di condizionare le
scelte di governo e di influenzare l’opinione
pubblica.
Potere studentesco, quindi, è una parola d’ordine
a partire dalla quale si genera una dinamica
instabile: poiché l’università è l’anello integrato di
un più complessivo sistema sociale, trasformarla
nel senso del contropotere studentesco non è, in
fin dei conti, né possibile né utile: gli studenti
finiscono
per
autocomprendersi
come
l’avanguardia di un processo rivoluzionario più
generale, la parola d’ordine non è più potere
studentesco ma potere alla classe operaia.
PROLETARIZZAZIONE
Con proletarizzazione s’intese designare la
progressiva assimilazione di tecnici, impiegati,
ricercatori alla condizione operaia. La teoria della
proletarizzazione gettava così un ponte oggettivo
fra le lotte studentesche, soprattutto quelle delle
facoltà scientifiche, e le lotte di fabbrica. In
questione non era più un «tradimento» da
consumare nei confronti della propria dasse
d’origine, ma il riconoscimento d’un dato di fatto
materiale e irreversibile, provocato dallo stesso
sviluppo capitalistico. Se anche si fosse trattato
soio d’una tendenza sarebbero state proprio le
lotte nelle università ad accelerame i tempi,
anticipando
nei
comportamenti
conflittuali
un’identità oggettiva ancora implicita o parziale.
La discussione sulla proletarizzazione fu, ad un
tempo, carica di effetti pratici, dipendendo da essa
i modi di stabilire rapporti con le fabbriche, e
gremita di questioni dottrinarie. Molte furono le
categorie marxiane chiamate in causa, più o meno
creativamente. Anzitutto, quella di lavoro
produttivo. Premesso che per Marx è produttiva
solo l’attività da cui il capitalista ricava un
plusvalore, può considerarsi tale quella d’un
chimico o d’un geometra? Gli «antiautoritari»
ritenevano che i ruoli intermedi cui si accede
provenendo dall’università fossero solo anela
subalterni della gerarchia, moli da controllori
controllati, certamente alienati, ma pur sempre
improduttivi. I fautori della «proletarizzazione»,
invece, sostenevano che il lavoro tecnicointellettuale, lungi dal comandare o sorvegliare o
progettare, era del tutto inserito nella fabbrica.
zione diretta del prodotto, contribuendo pertanto
alla formazione del profitto. Né si trattava solo di
determinazioni economiche, ma anche della
stretta analogia fra mansioni operaie e mansioni
tecniche. Oltre al rapporto salariale e al pluslavoro,
le stesse concrete modalità esecutive segnalano
l’unificazione
oggettiva
dell’intero
lavoro
dipendente: nell’ufficio e nel laboratorio, proprio
come in officina, v’è parcellizzazione, anonimia,
intercambiabilità, ripetitività. Ancora in termini
marxiani, il lavoro «potenziato» o «complesso»
dell’intellettuale può senz’altro venir considerato
un mero multiplo del lavoro «semplice» alla linea
di montaggio: multiplo sempre computabile in base
alla universale unità di misura, il tempo di lavoro
astratto.
La teoria della proletarizzazione comportava il
privilegiamento, nelle facoltà e nelle scuole, di tutti
quegli obiettivi in grado di meglio sottolineare la
sintonia esplicita con le lotte operaie. I costi dello
studio (tasse, libri, alloggi per i fuorisede, presalari
ecc.) dove. vano costituire il pendant delle
rivendicazioni
salariali
in
fabbrica.
Allo stesso modo, veniva istituita una similitudine
fra organi.zzazione del lavoro e organizzazione
dello studio, allargando a quest’ultima l’istanza
d’un «controllo» e d’un capillare contropotere.
Inoltre, la riflessione sulla scienza, o meglio sulla
sua
non
neutralità,
anziché
concludere
genericamente con l’interfunzionalità fra saperi e
poteri, riceveva una drastica specificazione: la
scienza è un’immediata forza produttiva, si
rapprende nel capitale fisso, nel sistema di
macchine, nelle tecnologie miranti a intensificare
lo sfruttamento, è li la sua verità ed è da ll che
deve muovere la critica.
ll concetto di proletarizzazione è imparentato con
un altro termine, che allora si diffuse largamente:
ricomposizione di classe. A «ricomporsi» può
essere solo ciò che è già, almeno virtualmente,
omogeneo. La polemica con la politica «delle
alleanze» è aspra e insistita: agli operai non sta,
come vorrebbe il progressismo democraticoriformista, trovare un terreno di confluenza con
«ceti medi» e strati «popolari» vari, ma per
l’appunto ricomporsi come classe politica,
invertendo quella frammentazione connaturata
all’essere la forza lavoro una merce, seppur
speciale.
REPRESSIONE
Contrariamente a quanto capita spesso di sentir
affermare, il movimento del ‘68 non fu accolto con
nessuna delicatezza. Al contrario, gli episodi di
contestazione determinarono sovente risposte
spropositate. Fu solo il carattere di massa dei
movimenti e il fatto che vi partecipassero per la
prima volta ceti sociali diversi ed eterogenei
rispetto a quelli, operai e contadini, che avevano
animato i durissimi scontri di piazza del
dopoguerra, a porre, in un primo momento,
qualche argine all’impiego di mezzi repressivi. Gli
anni della contestazione videro dovunque un
inasprimento della legislazione relativa all’ordine
pubblico e, se qualche ammorbidimento vi fu,
questo fu rivolto solo alle normative riguardanti il
costume, oltre che determinare un modesto
ampliamento dei diritti politici. Cinasprimento della
legislazione sull’ordine pubblico è una tendenza
che, cresciuta a dismisura negli anni ‘70,
soprattutto in Italia e Germania, non ha mai subito
una decisa inversione, neppure dopo il declino
delle insorgenze sociali violente.
Ma i movimenti del 1968 investirono anche paesi
governati da regimi dittatoriali, come la Spagna e
la Grecia, da regimi autoritari come il Messico, il
Brasile, la Polonia. Qui la repressione fu durissima
e sanguinosa: stragi, arresti di massa, pesanti
pene detenrive, torture, persecuzioni che si
protrassero per anni, restrizione dei diritti politici e
civili, militarizzazione della vita pubblica.
Ma anche nei paesi a governo democratico le
politiche di repressione non arretrarono di fronte a
nulla. Negli Stati Uniti fu condotta una vera e
propria guerra guerreggiata di annientamento
contro i ghetti neri in rivolta e il Black Panther Pan,
ma anche la repressione contro gli studenti e il
movimento giovanile fu feroce: dai selvaggi
pestaggi di Chicago fino all’uso delle armi da fuoco
(i morti di Kent all’inizio degli anni ‘70). In tutta
Europa la reazione contro le manifestazioni
studentesche e le occupazioni delle università fu
durissima: arresti, processi, pesanti condanne,
pestaggi, intimidazioni, migliaia di feriti, un numero
non trascurabile di morti. Vi fu un massiccio
ricorso all’infiltrazione e alla provocazione, per
convogliare verso i movimenti il riflesso d’ordine e
l’odio del corpo sociale (la «strategia della
tensione» in Italia), si fece uso o si favorirono
indirettamente formazioni fasciste e neofasciste (in
Francia, Italia, Germania, Gran Bretagna) per
intimidire i movimenti studenteschi o trascinarli in
una spirale di guerra per bande. I media, salvo
eccezioni più o meno convinte, attaccarono e
denigrarono in ogni modo i movimenti e in alcuni
casi, come in Germania federale, si adoperarono
per creare un vero e proprio clima di linciaggio
intorno alla contestazione studentesca. Dovunque
l’ascolto delle istituzioni fu minimo e il
riconoscimento
dell’interlocutore
negato.
Dovunque i contestatoti si trovarono di fronte nuovi
corpi antisommossa, legislazioni d’emergenza (nel
‘68 in Germania vengono varati i famigerati
Notstandsgesetze)
magistrature
inflessibili.
La repressione, tuttavia, lungi dallo scoraggiare il
movimento contribuì grandemente ad alimentarlo,
istituendo una spirale in crescendo di repressione
e protesta. Quasi quotidiane divennero le
manifestazioni «contro la repressione» a loro volta
represse. Inoltre, la reazione dello stato e il
comportamento della polizia e della magistratura,
sembravano
confermare
la
diagnosi
dei
contestatori sulla natura sostanzialmente violenta
del «sistema», e aiutavano a diffonderla
nell’opinione pubblica. Solo dove la repressione
raggiunse la massima intensità, come nella strage
di piazza delle tre culture in Messico, con i carri
armati per le strade, a Praga o a Rio de Janeiro, o
con il pogrom antistudentesco e antisemita di
Varsavia, essa riuscì a spazzare via il movimento
o a spezzarne, per lungo tempo, la continuità.
REVISIONISMO
L’accusa di «revisionismo» rivolta ad avversari
politici e «concorrentix., provenienti dalla stessa
tradizione ideologica ebbe largo corso nel
movimento del 1968 e riprendeva uno dei termini
classici dello scontro politico e ideologico
all’interno del movimento operaio, socialista e
comunista.
Revisionjsmo
designava,
nella
tradizione, un allontanamento dall’impianto
politico-teorico del marxismo, nel senso della
rinuncia al suo programma rivoluzionario a favore
di un accomodamento riformjsta con i rapporti di
produzione capitalistici, oppure nel senso di una
interpretazione evoluzionistica e priva di rotture del
processo di trasformazione del modello sociale
secondo uno schema «progressista». La
letteratura socialista a cavallo del secolo, la
divisione del movimento operaio con la prima
guerra mondiale e la Rivoluzione d’Ottobre, la lotta
politica tra bolscevichi e menscevichi prima, e tra i
bolscevichi stessi poi, offrivano uno sterminato
repertorio per l’impiego «combattente» del termine
revisionismo, dal quale i diversi gruppi politici nati
intorno al 1968, soprattutto queffi marxisti-leninisti,
attinsero a piene mani.
Per questi, in Occidente, revisioniste erano le
organizzazioni storiche del movimento operaio,
non solo o non tanto perché avevano accettato,
più o meno strategicamente, il sistema
democratico- parlamentare borghese come quadro
e orizzonte del proprio agire politico, quanto
perché ostacolavano la radicalità delle lotte,
invitavano al compromesso e soffocavano le
«potenzialità rivoluzionarie delle masse». Dalla
tradizione del trotzkismo fu massicciamente
ripresa l’idea del «tradimento» dei gruppi dirigenti
comunisti,
che
avevano
sacrificato
la
«permanenza» della rivoluzione alla creazione di
un potere burocratico, ferocemente attaccato alla
sua autoconservazione e autoriproduzione. In
generale, la politica delle organizzazioni storiche
del movimento operaio fu considerata un elemento
di resistenza contro l’urgenza e la radicalità della
domanda di trasformazione sociale che si riteneva
espressa da ampi settori sociali o comunque
radicata nella superiore razionalità dell’analisi
marxista. In America latina fu duro scontro tra i
fautori del foca guerrigliero e i partiti comunisti
inseriti integralmente nel prudente gioco
geopolitico condotto da Mosca. Ma anche
all’interno del mondo comunista l’accusa di
«revisionismo» continuava ad essere operante,
nello scontro su1 modello di sviluppo tra Cina e
Unione sovietica, nella propaganda stalinista
albanese (revisionismo assumeva qui anche il
senso
di
condanna
dell’allontanamento
dall’ortodossia staliniana dopo il ventesimo
congresso del Pcus nel 1956), nella repressione
sovietica del Nuovo corso, accusato però di una
colpa ancora più grave, quella di volere imboccare
bui court la via del capitalismo. L’Urss stessa fu a
sua volta considerata revisionista non solo da
cinesi e albanesi, ma anche da larga parte dei
movimenti radicali in Occidente che ritenevano
non vi fosse stata edificata alcuna società
socialista ma un capitalismo di stato i cui interessi
di superpotenza ostacolavano o strumentalizzavano lo
sviluppo delle lotte nel mondo. Nel suo insieme il
movimento del 1968 fu decisamente antisovietico,
sebbene in buona parte ostile all’idea di pluralismo
e spesso poco sensibile alla richiesta di libertà
democratiche nei paesi del socialismo reale.
RIVOLUZIONE SESSUALE
La
novità
del
movimento
studentesco
nell’Occidente sviluppato non fu quella di proporre
e praticare una liberazione sessuale.
La liberazione sessuale è stata in Occidente un
processo di lunga durata che ha percorso almeno
tutto il nostro secolo, collegato ad altre tendenze
primarie: l’industrializzazione, il lavoro femminile,
l’urbanizzazione, il venir meno della famiglia
allargata. Tutti fenomeni che subirono una forte
accelerazione nel dopoguerra. A queste grandi
tendenze strutturali di fondo, si sovrappose un
nuovo costume che precede di gran lunga il 1968:
un atteggiamento più libero verso la sessualità è
teorizzato e praticato dall’esistenzialismo francese,
cui si ricongiungerà l’antipsichiatria britannica (il
libro di Latng e Cooper Ragione e violenza è
dedicato a Sartre), per non parlare della diffusione
di massa di nuovi modelli, dalla Londra
trasgressiva dei primi anni sessanta agli Stati
Uniti: non a caso Elvis Presley fu chiamato «Elvis
the Pelvis» per il suo modo di cantare.
La liberazione sessuale fu quindi un processo più
vasto e più lungo del movimento del ‘68. Quello
che caratterizzà i movimenti del 1968 fu il fatto di
considerare la liberazione sessuale un «gesto
politico». La base teorica era duplice. Da un lato le
analisi e gli studi dello psicana]ista austriaco
Wilhelrn Reich negli anni ‘20 e ‘30 e il suo
tentativo di immettere una politica sessuale per i
giovani (Sexpol) nel movimento comunista
tedesco. Dall’altro il filone antiautoritario della
Scuola di Francoforte, culminato nell’Eros e civiltà
di Herbert Marcuse, che ricollegava la repressione
sessuale alla formazione di quella personalità
autoritaria, gregaria e acritica, ad un tempo, che
costituisce la base di massa dei fascismi e di ogni
forma violenta di dominio.
Per i movimenti del 1968 in Occidente, la
sessualità fu un versante decisivo della nuova
libertà politica da conquistare e costruire.
Altrimenti sarebbe incomprensibile un termine
come «lotta per la liberazione sessuale». Anche
per questo il pieno e libero possesso di questa
dimensione doveva essere esteso a tutti i soggetti
tenuti sotto tutela dalle istituzioni, come i bambini
(l’esperienza degli asili antiautoritari, soprattutto in
Germania) o i malati di mente (la lotta contro
l’istituzione manicomiale e le sue regole). La
sessualità libera diventava così una componente
decisiva del soggetto «non alienato», dell’«uomo
nuovo», non prevista dalla tradizione maggioritaria
del movimento operaio o abbandonata lungo la
strada. Fu un elemento cruciale della nuova
ideologia del movimento, un terreno «pubblico» su
cui rompere e contrapporsi ai tabù e alle norme
dominanti. Bisognava svelare il significato
«politico» dei rapporti umani più intensi e privati,
fame il centro, esibito e mostrato anche con intenti
provocatori e trasgressivi, della propria irriducibile
alterità alla società e al «sistema» - «Naturalità,>,
contrapposta alle ipocrisie sociali e agli artifici
disumanizzanti della società produttiva, mezzo
«pieno» di comunicazione tra le persone,
strumento di identità collettive: questa fu la
coscienza sessuale, del tutto pubblica, dei
movimenti del 1968. Di tutto questo, i mass media
dell’epoca colsero solo l’aspetto di colore e
rovesciarono completamente il senso del
fenomeno, desumendo dalla centralità della
liberazione sessuale il carattere pretestuoso della
volontà politica che si andava affermando tra i
giovani. Era il contrario esatto di quanto stava
accadendo.
SCUOLA DI FRANCOFORTE
Tra i vari filoni di pensiero critico che alimentarono
il movimento degli studenti del Sessantotto, quello
dal quale il movimento attinse alcune delle idee
più caratterizzanti fu senza dubbio la cosiddetta
Scuola di Francoforte. Nel Sessantotto, i maestri
del pensiero francofortese (Max Horkheimer,
Theodor Adorno e Herbert Marcuse) erano ancora
viventi e attivi; Adorno sarebbe morto l’anno dopo,
nell’agosto del 1969. Sebbene nel Sessantotto i
grandi vecchi assumessero posizioni molto diverse
(a un estremo il conservatorismo cauto di
Horkheimer, all’altro il rivoluzionarismo quasi
giovanilistico di Marcuse) la strada che avevano
percorso insieme era stata lunga e significativa.
L’Istituto per la Ricerca sociale, infatti, aveva ormai
nel Sessantotto una lunga storia alle spalle.
Inaugurato a Francoforte nel 1924, l’Istituto era
nato (grazie al mecenate finanziatore Felix Weil)
come centro di ricerche sul marxismo e sul
movimento operaio, e aveva sviluppato in
particolare le sue analisi di teoria sociale a partire
dal 1930, quando Horkheimer ne aveva assunto la
direzione. Tre anni dopo 1-litler prendeva il potere
in Germania. E per l’Istituto iniziava il lungo
periodo
dell’esilio,
che
avrebbe
portato
Horkheimer e, suoi collaboratori prima a Parigi e
successivamente negli Stati Uniti, dove alla fine
degli anni Trenta l’Istituto trovò ospitalità presso la
Columbia
University
di
New
YorkProprio l’esperienza del totalitarismo fu la
problematica decisiva attorno alla quale si
concentrarono, tra gli anni Trenta e i Cinquanta, le
ricerche filosofico.sociologiChe elaborate dalla
Scuola di Francoforte. Le radici profonde
dell’autoritarismo e della acquiescenza al dominio
totalitario vennero indagate in una grande opera
collettiva pubblicata nel 1936, gli Studi sull’autorità
e la famiglia, cui collaborarono tra gli altri Marcuse,
lo psicanalista Erich Fromm (che in seguito
avrebbe rotto con gli altri per il suo «revisionismo»
freudiano), lo studioso del dispotismo orientale
Karl August Wittfogel. Nel 1942 un altro studioso
legato all’Istituto, Franz Neumann, pubblicò una
delle più profonde analisi della Germania nazista,
che intitolà Behernoth, dal nome di un mostro
mitico citato nella Bibbia e ripreso da Hobbes
come simbolo del disordine e del caos. Nel 1950,
a New York, usci la monumentale ricerca sulla
Personalità autoritaria, frutto della collaborazione
tra un filosofo come Adorno e studiosi statunitensi
di formazione molto più empirica, nella quale si
indagavano, con strumenti soprattutto freudiani, le
radici psicologiche del tipo di personalità incline al
pregiudizio, all’autoritarismo e all’antisemitismo. il
nocciolo filosofico di tutto questo lavoro di ricerca
lo si trova espresso, in tutta la sua radicalità, nel
volume scritto da Adorno e Horkheimer nell’esffio
americano che s’intitola Dialettica dell’illuminismo,
e che studia appunto il processo per cui la
razionalità illuminata dell’occidente ha potuto
generare dal suo seno la mostruosa barbarie del
nazismo. Nel dopoguerra, mentre Marcuse restò
negli Stati Uniti, divenendo poi un interlocutore pri- vilegiato del movimento giovanile, Horkheimer e
Adorno tornarono nel vecchio continente. Negli
anni Sessanta il primo si ritirerà nella quiete di
Montagnola, in Svizzera, mentre Adorno,
nell’Istituto di Francoforte, si scontrerà con la
contestazione studentesca, in un conflitto che avrà
anche episodi spiacevoli. Marcuse, invece,
polemizzerà con i suoi antichi sodali, in nome dei
vecchi ideali comuni. Tra i paradossi del
Sessantotto c’è anche quello per cui gli studenti
del movimento, che soprattutto in Germania si
erano formati sui testi di Adorno e Horkheimer, si
troveranno a scontrarsi proprio con i maestri dai
quali più avevano imparato.
SELEZIONE E MERITOCRAZIA
Tutti i movimenti studenteschi, senza eccezione, si
scontrarono in primo luogo con i meccanismi di
selezione e giudizio propri dell’istituzione
scolastica. Le università e gli istituti superiori,
cresciuti enormemente con la scolarizzazione di
massa degli anni ‘60, mostravano ormai in pieno la
contraddizione patente tra la vecchia funzione eli.
tana di selezionare e formare una classe dirigente
e il bisogno di una acculturazione più diffusa,
collegato alle esigenze dello sviluppo economico.
Ma la contestazione studentesca non si adagiò
affatto sull’onda di questa modernizzazione,
peraltro minata da contraddizioni e ritardi,
scegliendo, al contrario, di schierarsi contro la
corrente. Non fu preso di mira solo il vecchio
classismo, che precludeva ai ceri popolari
l’accesso all’istruzione o glielo rendeva impresa
ardua, riservata a individui d’eccezione, ma anche
la pretesa di selezionare quadri sulla base delle
necessità funzionali allo sviluppo economico. In
questo gli studenti vedevano un elemento
inaccettabile di eterodirezione e di cancellazione
della propria soggettività. Il movimento rifiutò
radicalmente una scala dei meriti e delle
prestazioni fondata sulla divisione sociale del
lavoro
e
sui
ruoli
funzionali
stabiliti
dall’organizzazione del lavoro e dalle leggi
dell’accumulazione
capitalistica,
del
tutto
indipendentemente dai bisogni e dalle aspirazioni
dei soggetti concreti. Il merito preteso
dall’istituzione scolastica apparve misurato sul
grado di adesione a un sistema di valori che
veniva radicalmente rifiutato. Per questo la scuola
fu tacciata di duplice classismo: da un lato perché
penalizzava, dietro la falsa apparenza delle pari
opportunità, i soggetti più deboli per provenienza
famffiare di classe, dall’altro perché trasmetteva
un sistema di valori proprio della società divisa in
classi.
Il rifiuto della scala dei meriti comportò una lotta
senza quartiere contro tutti i meccanismi di
selezione che ne conseguivano. La selezione e la
«meritocrazia»,
con
i
loro
fondamenti
pseudoggettivi, furono considerate responsabili di
un enorme spreco di risorse sociali e individuali, di
«scartare» arbitrariamente un grande numero di
individui e di mutilare gravemente le potenzialità
degli altri, piegandoli alle sole funzionalità
produttive. Alla competizione per la conquista di
un posto nella scala gerarchica socialmente
riconosciuta fu contrapposto un processo di
crescita collettiva su contenuti e strumenti propri
del movimento, strettamente connessi con una
idea di «smascheramento» delle apparenze e
delle ipocrisie sociali. Le università furono in
realtà, in quegli anni, nonostante semplificazioni
ideologiche e approssimazioni d’ogni genere,
teatro di una febbrile attività intellettuale, di
elaborazione,
di
apprendimento
e
di
comunicazione, anticipatrice di talenti e facoltà che
solo molto più tardi avrebbero rivelato appieno le
proprie potenzialità, anche produttive.
SOCIALISMO DAL VOLTO UMANO
Il «socialismo dal volto umano» fu il fortunato
slogan nel quale si espressero, di fronte
all’opinione pubblica di tutto il mondo, le speranze
e i sogni della primavera di Praga e del suo
popolare leader Alexander Dubcek. Lo slogan
certamente non poteva piacere ai sovietici perché
sottintendeva, senza alcun dubbio, un giudizio di
condanna senza appello degli errori ed orrori del
socialismo fino ad allora esistente, che veniva in
sostanza tacciato di disumanità. Alle spalle del
socialismo dal volto umano vi era quindi la
sentenza sullo stalinismo e sui suoi crimini che già
era stata pronunciata da Krusciov nel suo rapporto
al ventesimo congresso del Partito sovietico, nel
1956, ma che non si era tradotta in un vero
processo di riforma e di democratizzazione dei
paesi a economia socialista. Il socialismo dal volto
umano, quindi, aveva l’ambizione di riprendere il
discorso
interrotto
sul
rinnovamento
del
socialismo, l’unica chiave che poteva consentire,
secondo Dubcek, di riaprire anche in Europa
occidentale un fronte di lotta più avanzato: un
socialismo rinnovato avrebbe contribuito a
indebolire, a Ovest, il pregiudizio anticomunista, e
quindi ad aprire nuove possibilità per i partiti
comunisti occidentali che fossero stati capaci di
coglierle.
Il punto decisivo per una riforma del socialismo
veniva individuato, dai teorici del nuovo corso,
nella questione della democrazia; ma con essa
non si esauriva di certo lo spettro delle necessarie
riforme. Si voleva innanzitutto l’abolizione della
censura, la possibilità di dibattere liberamente le
idee, il diritto per tutti i cittadini di dire la loro sul
processo di rinnovamento in corso. Si voleva farla
finita con i metodi autoritari e stalinisti che
avevano segnato così profondamente la storia del
«socialismo reale». Non era in discussione la base
economica, ma anche su questo terreno appariva
necessaria una trasformazione, che ridefinisse i
rapporti tra piano e mercato, tenendo conto anche
di un modello dte allora appariva a molti
interessante, quello della autogestione jugoslava.
Vi era inoltre una nuova attenzione verso la
necessità di incrementare la ricerca scientifica, e
di potenziare il ruolo della intellighenzia tecnicoscientifica, che si sentiva mortificata e frustrata nel
contributo che riteneva di poter dare allo sviluppo
socialista.
La ricerca di un socialismo dal volto umano fu
interrotta dai cingoli dei carri armati del Patto di
Varsavia; si trattò comunque del più significativo
tra i tentativi di autoriforma del socialismo
esteuropeo. Non sappiamo quali frutti avrebbe
potuto dare, se non fosse stato estirpato prima
ancora di mettere radici.
SOCIETÀ DEI CONSUMI
La critica della società dei consumi è uno degli
elementi che segnano la novità e la specfficità del
movimento del Sessantotto rispetto ad altri
movimenti di massa che lo precedettero o lo
seguirono: gli studenti non chiedono di accedere al
mondo del consumo di massa, del quale come
giovani e come appartenenti alla media e piccola
borghesia sono in qualche misura già partecipi.
Muovono piuttosto un attacco frontale alle forme
dominanti del consumismo, che sfocia in episodi
paradigrnatici come per esempio le contestazioni e
le azioni di disturbo contro il rito profano dello
shopping natalizio.
La critica della società dei consumi ha certamente
anche un lato populistico o pauperistico: attacca,
in nome di chi non partecipa alla festa, le forme di
consumo vistoso riservate agli strati superiori della
borghesia, la cui funzione primaria è quella di
esibire e confermare uno status (si pensi, per
esempio, ai pomodori lanciati contro i buoni
borghesi che affollano le prime della Scala, a
Milano).
Ma al tempo stesso nella critica della società dei
consumi si riflette anche lo sfondo culturale di cui il
movimento del Sessantotto si nutre, e in
particolare l’influenza della Scuola di Francoforte,
cui si deve la prima e la più influente critica «da
sinistra» della società opulenta caratterizzata dal
consumo di massa. Il guaio non è — avevano
scritto Horkheimer e Adorno nella Dialettica
dell’illuminismo — che i beni di consumo liquidino
ottusamente la vecchia metafisica; il guaio è che
diventano essi stessi una moderna e impenetrabile
metafisica. O, in altri termini, una fitta cortina
ideologica che, rendendo tutti gli individui eguali in
quanto consumatori, nasconde e fa sparire i reali
rapporti di classe e di poter& nella società.
Ma il rifiuto della società dei consumi diventa, nel
movimento degli studenti, anche la molla a partire
dalla quale si cercano stili di vita alternativi, modi
di consumo diversi da queffi egemoni. La difficoltà
di sottrarsi alla logica onnipervasiva della società
dei consumi e dello spettacolo si rivela
paradossalmente proprio nel fatto che la rivolta
anticonsumista genera senza volerlo anch’essa le
proprie mode e i propri oggetti di culto (il giaccone
tipo Eskimo, le scarpe Clark, la Renault 4,
l’abbigliamento in stile militare). Oggetti di
consumo ahemativo che diventano espressioni
simboliche della propria identità, e che, con le loro
ammaccature e i loro strappi, vengono feticizzati
quasi come i buoni borghesi feticizzano i capi
d’abbigliamento firmati da prestigiosi stilisti. Quasi
a confermare ironicamente le analisi catastrofiche
sul sistema che tutto omologa, anche le bandiere
anticonsumiste diventano così per contrappasso
oggetti un p0’ feticistici di consumo e di culto.
SOCIETÀ DELLO SPETTACOLO
La fortunata e, nel tempo, anche abusata dizione
«società dello spettacolo» è, originariamente, il
titolo di un libro che il più importante tra gli
intellettuali situazionisti, Guy Debord, pubblica nel
novembre del 1967, proprio alla vigilia
dell’esplosione del movimento del Sessantotto.
Debord aveva fondato nel 1957 l’Internazionale
Situazionista e, dal 1958 al 1969, pubblicò la
rivista «Internationale Situationiste».
L’organizzazione si sciolse nel 1972, dopo aver
subito diverse scissioni.
La società dello spettacolo è un libro
straordinariamente anticipatore: infatti, nel tempo
in cui esso veniva pubblicato, la trasformazione
della politica e della intera vita sociale e culturale
in un fantasmagoria spettacolare non aveva
ancora raggiunto le dimensioni che avrebbe
conosciuto negli anni Ottanta e Novanta.
Parafrasando Marx, che descriveva la società
moderna come una immane raccolta di merci,
Debord scriveva nel suo saggio: «fl capitalismo
nella sua forma ultima si presenta come una
immensa accumulazione di spettacoli, in cui tutto
ciò che era direttamente vissutosi è allontanato in
una rappresentazione».
Ma in che senso lo spettacolo diventa, nell’analisi
di Debord, il fenomeno centrale che caratterizza le
società del tardo-capitalismo? «Lo spettacolo —
scrive Debord — non può essere inteso come un
abuso del mondo visivo, prodotto dalle tecniche di
diffusione massiva delle immagini E...]. Lo
spettacolo compreso nella sua totalità è, nello
stesso tempo, il risultato e il progetto del modo di
produzione esistente. Non è un supplemento del
mondo reale, la sua decorazione sovrapposta. E il
cuore dell’irrealismo della società reale». Lo
spettacolo, insomma, lungi dall’essere un
fenomeno specifico, si colloca invece al centro del
modo di produzione capitalistico. Non si tratta
infatti solo di un prodotto particolare, di quel tipo
singolare di merce che viene prodotto dall’industria
culturale. Lo spettacolo, nel tardo-capitalismo,
coinvolge l’intera produzione sociale in quanto
essa è sempre più intessuta di processi
comunicativi:
competenze
linguistiche,
immaginazione, sapere, cultura.
Lo spettacolo ha dunque una doppia natura: è per
un verso un prodotto specifico che si affianca a
tutti gli altri, ma al tempo stesso rappresenta (nel
senso più letterale del tem-iine) la quintessenza
del modo di produzione nel suo complesso. Lo
spettacolo, come dice Debord, è «l’esposizione
generale della razionalità del sistema». Nella
merce spettacolo, il cui valore d’uso è linguistico-culturale, sembra rispecchiarsi la qualità
comunicativa della produzione tardo-capitalistica
nel suo complesso.
Vent’anni dopo La società dello spettacolo, nei
Commentari pubblicati nel maggio del 1988,
Debord proseguiva la sua riflessione mettendo a
fuoco quella che secondo lui era la natura della
fase ulteriore, che egli definiva come la fase dello
«spettacolo integrato». «Il senso ultimo dello
spettacolo integrato — scriveva — è che esso si è
integrato nella realtà a misura che ne parlava: e
che la ricostruisce così come ne parla, in modo
che essa non gli sta più di fronte come qualcosa di
estraneo. Quando lo spettacolare era concentrato,
la maggior parte della società periferica gli
sfuggiva: quando era diffuso, gliene sfuggiva una
piccola parte; oggi più nulla. Lo spettacolo si è
mescolato a ogni realtà, permeandola. Com’era
prevedibile in teoria, l’esperienza pratica del
compimento sfrenato della ragione mercantile
mostra, rapidamente e senza eccezioni, che il
diventar-mondo della falsificazione era anche
undiventar-falsificazione del mondo».
Nel frattempo, morto Debord, la critica della
società dello spettacolo, così come della culturaspettacolo e della politica-spettacolo, la si può
ritrovare sulle bocche di tutti, resa inoffensiva e
spogliata della sua forza sovversiva. Per altro
verso, il pensiero postmoderno ha in qualche
modo rovesciato la diagnosi pessimistica
dell’intellettuale situazionista, tessendo l’elogio
disincantato di un mondo derealizzato, ridotto
senza residui a simulacro e fantasmagoria.
SVILUPPO E SOTTOSVILUPPO
Fino alla metà degli anni ‘60, per l’economia
tradizionale, il «Terzo mondo» non esisteva. C’era
al massimo il problema dell’«arretratezza» nei
processi di sviluppo economico. La concezione
prevalente restava quella consolante di un modello
di crescita lineare, lungo il quale vi sono paesi più
arretrati e paesi più avanzati, teorizzata
dall’economista americano Walt Whitman Rostow,
che fu anche consigliere sul Vietnam per la Casa
bianca. Tuttavia, nel corso del decennio, di fronte
agli evidenti squilibri del sistema economico
internazionale e al mancato decollo di molti paesi
dell’Asia, Africa e America latina si era sviluppata
una corrente di pensiero critico, sul versante
marxista e non, che costringeva a fare seriamente
i conti con le illusioni evoluzioniste. Vi furono gli
importanti studi di Gunnar Myrdal, del geografo
Yves Lacoste, di René Dumont e Bernard Rosier,
dei marxisti americani Baran, Sweezy e Magdoff
del gruppo newyorkese della Monthiy review, del
marxista ortodosso Hosea Jaffe.
Quale è la natura del Terzo mondo? E
capitalistico,
precapitalistico
o
una
sovrapposizione di entrambi? E quali sono i suoi
rapporti con l’economia mondiale? Perché le sue
condizioni economiche non danno segno di
migliorare e la modernizzazione appare spesso
foriera di nuove miserie? Questi gli interrogativi
teorici posti dai critici dell’economia mondiale e
generalmente assunti dai movimenti della seconda
metà degli anni ‘60 come questioni cruciali, tali da
disvelare la sostanza innominabile dell’economia
di mercato e la violenza insita nei rapporti di forze
internazionali.
Uno dei primi tentativi teorici di spiegare nelle sue
radici strutturali il sottosviluppo nel sistema
capitalistico è dovuto all’economista André Gunder
Frank che, a partire dalle sue ricerche suil’America
latina degli anni ‘60, sviluppò l’idea di una
dipendenza dei paesi della «periferia» dal
«centro» capitalistico, in cui il sottosviluppo dei
primi e lo sviluppo dei secondi non sono che due
aspetti dello stesso processo capitalistico. Tra la
fine degli anni ‘60 e i primi anni ‘70, si
moltiplicarono grandemente, lungo questa linea
interpretativa, gli studi critici sugli squilibri e le
contraddizioni dell’economia mondiale, sul sistema
dei prezzi e degli scambi internazionali, sui flussi
di merci e di capitali (Samir Amin), sul sistema
delle imprese multinazionali (Stephen Hvmer),
sugli inganni degli aiuti economici (Teresa Hayter),
sui rapporti tra centro e periferia (Giovanni Arrighi).
La consapevolezza di un legame strutturale tra
l’opulenza dei paesi a capitalismo avanzato e la
miseria della «periferia» fornì una base più solida
e motivata alla solidarietà internazionale con i
movimenti di liberazione e i popoli del Terzo
mondo. Dall’analisi secondo cui il meccanismo
dello sviluppo capitalistico, e non la sua assenza,
starebbe all’origine del sottosviluppo, scaturirà poi
l’idea di una crescita «autocentrata» e meno
integrata nel mercato mondiale dei paesi più
poveri (Samir Arnin). Ipotesi cui i rapporti di forza
internazionali non hanno praticamente concesso
alcuno spazio di applicazione
TOLLERANZA REPRESSIVA
Nel 1965 il filosofo Robert Paul Wolff, il sociologo
Barrington Moore jr. e il più noto Herbert Marcuse,
membri tutti e tre della comunità accademica di
Cambridge, Massachusetts, pubblicarono un
volumetto che, riecheggiando in modo un po’
irriverente la Critica della ragion pura di Kant,
intitolarono Critica della tolleranza pura (A Critique
of Pure Tolerance). Il libretto divenne una bandiera
per gli studenti del Sessantotto, che in esso
trovarono una delle più acute critiche della
democrazia liberale occidentale, da un punto di
vista che, però, non nutriva alcuna tenerezza
verso il «socialismo realizzato» orientale.
il volumetto prendeva di mira l’apologia della
libertà occidentale mettendo sotto tiro proprio il
concetto
apparentemente
più
ineccepibile,
indiscutibile e positivo: quello della tolleranza, il
tema delle grandi battaglie di Voltaire, l’idea più
nobile nell’arsenale dei concetti illuministici.
Mettendo a fuoco la questione della tolleranza
oggi, Marcuse proponeva un rovesciamento secco
dei luoghi comuni dominanti, coi quali aspramente
polemizzava: la tolleranza «pura», astratta e
indiscriminata delle società tardo-capitalistiche —
diceva — è in realtà intollerante, perché chiude
ogni spazio alla seria discussione di ogni pensiero
che sia eterodosso o sovversivo. E, per converso,
la vera tolleranza, intesa come strumento che
promuove la razionalità e la libertà umana, può
vivere oggi solo trasformandosi in decisa
intolleranza: intolleranza verso i movimenti e
anche verso le idee che si schierano a favore della
repressione, del razzismo, di tutte le forme, piùo
meno brutali, di asservimento degli uomini e di
diseguaglianza. «Se la tolleranza democratica
fosse stata ritirata quando i futuri capi
cominciarono la loro campagna — scrive Marcuse
—, l’umanità avrebbe avuto la possibilità di evitare
Auschwitz e una guerra mondiale». E d’altra parte,
«quando la tolleranza serve principalmente a
proteggere e a conservare una società repressiva,
quando serve a neutralizzare l’opposizione e a
rendere gli uomini immuni contro forme di vita
diverse e migliori, allora la tolleranza è stata
corrotta».
Nella società presente la tolleranza è corrotta,
innanzitutto, perché vengono a mancare i
presupposti in base ai quali essa costituisce un
valore: la discussione libera ed eguale di tutte le
opinioni serve a scoprire quelle migliori se è una
discussione razionale, condotta con autonomia di
pensiero, libera dalla manipolazione, dall’
indottrinamento e dal pregiudizio. Ma proprio
queste sono le condizioni che non si danno nella
società del tardo-capitalismo. Qui domina piuttosto
la neutralizzazione di tutte le opinioni su un
mercato delle idee apparentemente aperto, ma in
realtà chiuso ermeticamente a qualsiasi pensiero
che non è assimilabile all’ordine di cose vigente.
L’unica risposta sensata a questa situazione, dice
Marcuse, è un «ritiro sistematico della tolleranza»:
primo passo per dare uno scossone alla «falsa
coscienza» onnipervasiva, che in realtà è il più
solido sostegno di un sistema pseudoliberale e
pseudotollerante.
UTOPIA
«Siate realisti, chiedete l’impossibile». Pochi
slogan possono esprimere meglio di questo,
coniato durante il maggio francese, quella che fu
la carica utopica del movimento del Sessantotto.
Utopico è il Sessantotto nel senso che,
diversamente dai movimenti che l’hanno
preceduto e che lo seguiranno, si muove nella
prospettiva di una trasformazione assolutamente
radicale, della quale forse percepisce anche
l’impossibilità (come nello slogan prima ricordato)
sentendola però come sfida, come scommessa,
come dato che l’entusiasmo e la passione
possono e debbono mutare. il Sessantotto non
conosce né il riformismo che si accontenta di
piccoli, ma realistici passi, né la disperazione in cui
la protesta si trasforma quando si accorge di avere
di fronte un muro. Come momento generativo,
come inizio che vede un orizzonte aperto davanti a
sé, il movimento non respinge la critica di
utopismo, facendone anzi motivo di orgoglio. In
qualche modo esprime questa visione anche
Herbert Marcuse che, nel suo La fine dell’utopia,
proprio da questa problematica prende le mosse.
In genere sono diffamati come utopici, scrive
Marcuse, i progetti di una nuova società che sono
ritenuti irrealizzabili, in quanto i fattori soggettivi e
oggettivi porrebbero un limite invalicabile alla loro
attuazione. Utopici erano per esempio, i progetti
comunisti durante la rivoluzione francese. E lo
stesso sviluppo del capitalismo, del progresso
tecnico-scientffico, della società opulenta e
dell’automazione, però, che rende oggi obsoleta
l’accusa di utopismo: «Oggi esistono tutte le forze
materiali e intellettuali per realizzare una società
libera», sostiene Marcuse, e il fatto che non
vengano utilizzate non significa altro se non che è
la società stessa, in qualche modo accecata, che
oppone una sorda resistenza alla stessa
possibffità della propria liberazione.
Il movimento del Sessantotto, però, non si
accontenta di sognare l’utopia, o di battersi per
essa, ma prova anche a metterla in pratica. Dalla
consapevolezza che non si cambia la società se
non cambiando anche se stessi nascono tentativi
di costruire forme di vita che siano già, qui ed ora,
modi di praticare rapporti sociali alternativi: è
l’esperienza degli asili antiautoritari, oppure quella
delle comuni, praticata dagli studenti berlinesi così
come dagli hippies americani. fl movimento del
Sessantotto è utopico perché non vuole solo fare
la rivoluzione, ma addirittura cambiare la vita. E
invero la cambierà, anche nel profondo, perché
innescherà tanti mutamenti, tanti frammenti di
liberazione, diversissimi però da quelli aspettati e
voluti.
VIOLENZA E NON VIOLENZA
Violenza e repressione segnarono ricorrentemente
i conflitti sociali e politici del dopoguerra in Europa
e non soio nei paesi sottoposti alla dittatura. Ma fu
alla fine degli anni ‘60, e in particolare nel 1968,
che la violenza politica e sociale fu scoperta,
discussa e vissuta a livello di massa, anche in
segmenti di società che ne erano rimasti fino ad
allora al riparo e tra i giovani che non avevano
vissuto l’esperienza della guerra. Fu scoperta e
denunciata dai movimenti la violenza e la
costrizione che sottendevario non uno stato di
guerra,
ma
una
condizione
di
pace:
discriminazioni,
persecuzioni,
ingiustizie,
sfruttamento, repressione di ogni protesta appena
vagamente minacciosa. Questa violenza fu
generalmente riconosciuta come «violenza di
classe», esercitata non solo e non tanto dagli
organi repressivi degli stati, quanto dagli stessi
rapporti sociali dominanti, dalle diseguaglianze e
dalla difesa senza scrupoli del privilegio. A questa
si aggiungeva la violenza aperta, dispiegata in
paesi lontani, per difendere gli interessi
dell’Occidente.
Di fronte a questa violenza, interna e
internazionale, del «sistema», i movimenti
rivendicarono una sorta di diritto naturale, di
moderno ius resistentiae. Non si poteva stare alle
regole del gioco senza sottomettersi, senza
accettare implicitamente ingiustizie e sopraffazioni.
Per i movimenti di protesta la «legalità» non
garantiva civilmente lo spazio del conflitto, ma era
spudoratamente di parte, al servizio di un ordine
sociale inaccettabile che non contemplava
alternative o varianti. Di conseguenza i movimenti
rivendicarono per sé la pratica dell’«illegalità»,
cioè l’infrazione sistematica di norme previste
dall’ordinamento e lo scontro con i suoi difensori.
L’dllegalitì» di massa non fu considerata
semplicemente una scelta tattica volta al
perseguimento di questo o quell’obiettivo, ma una
condizjorie di esistenza del movimento stesso,
della sua visibilità e della sua voce. La legge è la
sistemazione giuridica del potere, l’illegalità è
l’emergere di bisogni negati che si riconoscono e
parlano. Le occupazioni nelle università e nelle
fabbriche violavano l’ordine costituito in forma di
sostituzione, facevano sparire il potere dai luoghi
in cui era fisicamente insediato, ma non lo
estingue- vano e nemmeno arrivarono a logorano.
La repressione non si fece attendere e la violenza
cessò di essere implicita e latente. I movimenti
reagirono, conseguendo anche effimere vittorie sul
campo, a Parigi, Lerlino, Roma, Chicago. Per gli
studenti, in Europa come negli Stati Uniti, la
resistenza
passiva
non
bastava
più.
Quali fossero i confini ragionevoli dell’<illegalità» e
lo spazio legittimo per l’esercizio della violenza fu
una questione lungamente dibattuta, tanto sul
piano etico, quanto sul piano tattico dd «livello di
scontro» sostenibile, ma in generale il movimento
del 1968 non escluse in linea di principio il ricorso
alla violenza, e finì con l’assumerlo nel suo senso
comune. Piuttosto si cercò un difficile equilibrio tra
pratica dell’illegalità e confronto con le istituzioni.
Sopravviveva
certo,
soprattutto
nell’area
anglosassone, il retaggio dei movimenti pacifisti
del dopoguerra, e la lotta non violenta di massa fu
sostenuta e praticata, per esempio tra i neri
americani, da importanti organizzazioni, come
quella di Martin Luther King. Ma con l’inasprimento
dello scontro nel 1968 queste componenti furono
in parte sopraffatte dai movimenti più radicali che
teorizzavano e praticavano l’autodifesa armata e
lo scontro violento con i poteri dello stato, come il
Black Panther Party.
Infine, diversi settori di movimento, sì
considerarono direttamente implicati in una guerra
guerreggiata di carattere planetario che aveva in
Vietnam il suo epicentro. E si attribuirono il
compito di colpire dietro le linee del nemico,
l’imperialismo americano, con attentati e atti di
sabotaggio. Qui la scelta della violenza, riportata
in una ottica di guerra totale, non sottostava più ad
alcuna limitazione e poteva astrarsi da ogni
contesto. E il percorso che condurrà alla
formazione e alla breve parabola della Rote
Armee Fraktion in Germania.