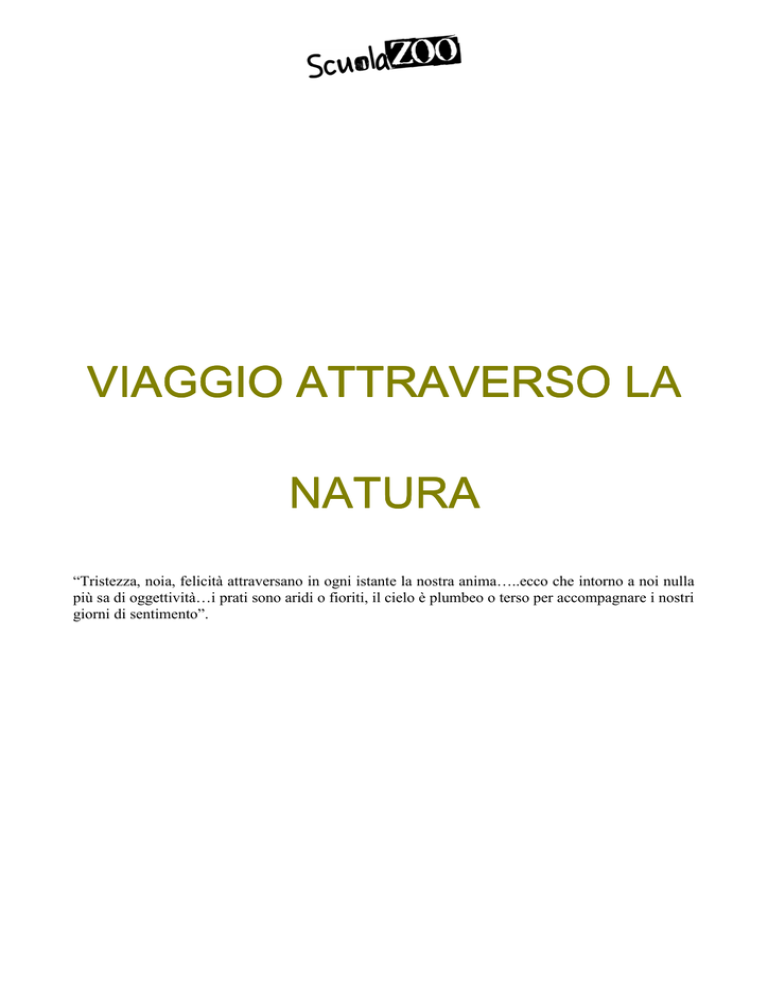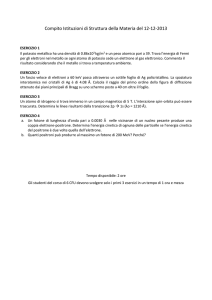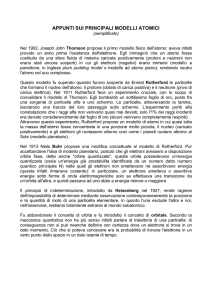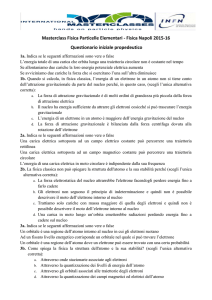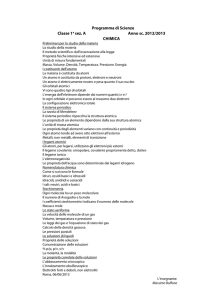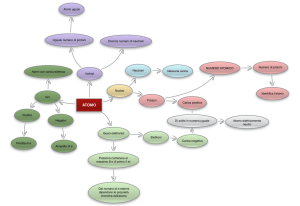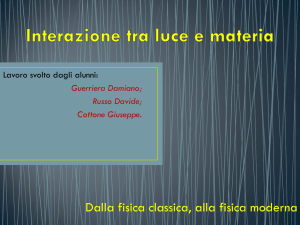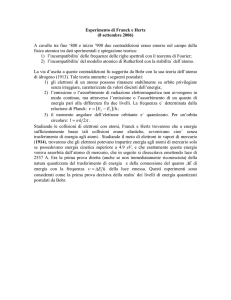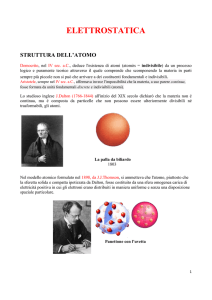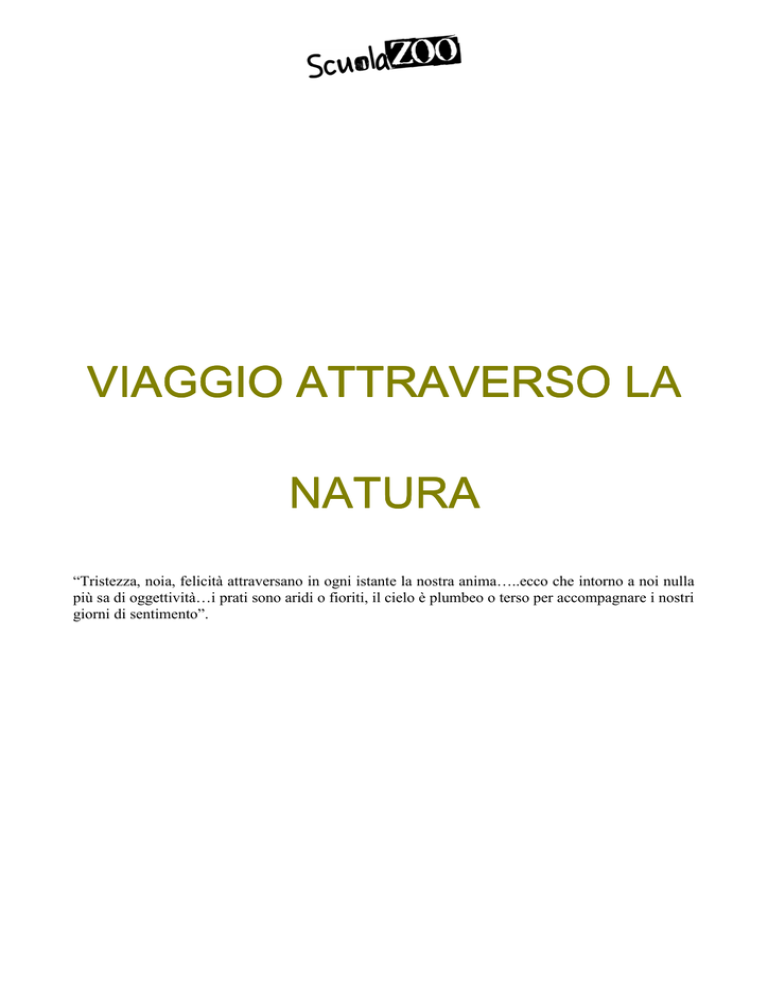
VIAGGIO ATTRAVERSO LA
NATURA
“Tristezza, noia, felicità attraversano in ogni istante la nostra anima…..ecco che intorno a noi nulla
più sa di oggettività…i prati sono aridi o fioriti, il cielo è plumbeo o terso per accompagnare i nostri
giorni di sentimento”.
ITALIANO
Nell’arte e nella letteratura, la natura si presenta in tanti modi suggestivi; ogni volta con un volto
diverso, diversi colori, diverse sfumature. Foscolo, a metà tra neo-classicismo e romanticismo
anima romanticamente la sua natura e la rende complice dei suoi stati d’animo. Nelle “Ultime
lettere di Jacopo Ortis” la natura animata romanticamente può essere idillica o tempestosa, ma
suscita sempre sensazioni profonde e drammaticamente inquietanti. In “Alla Sera”, quando giunge
la quiete e la pacatezza che rimanda alla morte non importa se natura è nubi estive e zeffiri sereni o
nevoso aere e inquiete tenebre. La Natura è protagonista romantica della classico-romantica poesia
foscoliana. L‘atmosfera in “In morte del fratello Giovani” è di pace ritrovata nella morte. I termini
pietra, cenere, ossa e l’immagine della vecchia che si reca sulla tomba del figlio morto, fanno
pensare ad una atmosfera cimiteriale, quella dei Sepolcri o dell’Elegia di Gray. In “A Zacinto”
ricorre frequente il motivo dell’acqua ”onde del greco mar”. L’acqua miticamente datrice di vita si
identifica con l’immagine materna. La presenza costante del motivo dell’acqua è testimoniata
inoltre dal sistema rime (sponde, onde, feconde, fronde, giacque, nacque, tacque, acque). Vi sono
poi le sacre sponde che esprimono il bisogno di regressione, la ricerca di sicurezza tra le braccia di
una madre (A Zacinto), che fanciulletto lo avevano raccolto. La Natura vive da protagonista nei
Sepolcri foscoliani: nella prima parte(vv1-22), una negazione della bellezza della natura(ove più il
sole per me alla terra non fecondi questa bella d’erbe famiglia e d’animali) con affermazione delle
leggi materialistiche; nella seconda sezione(vv.23-50) si propone l’alternativa dell’illusione della
sepoltura lacrimata: fiore odoroso e l’ombra di un albero amico diventano motivo di conforto. Da
Gray è tratto l’espressione:”né passeggier solingo oda il sospir che dal tumulo noi manda natura”,
nessuno può udire il sospiro del defunto che esprime il desiderio di sopravvivenza. Segue
nell’episodio del Parini, un’atmosfera di tipo cimiteriale che unitamente all’effetto fonico dato
dall’uso di u-r-s, crea un’atmosfera inquietante, per sottolineare l’assurdità della legge sulle
sepolture: ”Senti raspar tra le macerie e i bronchi la derelitta cagna ululando, e uscir dal
teschio…..(vv.78-90)”. Nei versi della giustificazione storica la natura personificata è colei che
sottopone i resti umani ad un perenne ciclo di trasformazione(vv.93-96). Il carme si conclude con
una stupenda profezia (finché il sole risplenderà sulle sciagure umane), che esprime il senso di
eterno che la natura porta con se’.
Nell’opera del Leopardi la natura ha un’importanza di tipo filosofico: nella prima fase, che va sotto
il nome di PESSIMISMO STORICO, la natura è positiva perché dà all’uomo la facoltà
dell’immaginazione che crea le illusioni. Nell’”INFINITO” vi sono alcune immagini naturali che
consentono al poeta di intuire infiniti spazi, sovraumani silenzi e profondissima quiete. Quindi il
Leopardi utilizza oltre alla poetica della ricordanza, dell’indefinito e del fonosimbolismo, anche
immagini della natura che lo proiettano nella dimensione dell’INFINITO. Il colle, inoltre, trova
anche un’interpretazione psicoanalitica nel critico Amoretti. Quest’ultimo afferma che il Leopardi
trova sicurezza nell’immagine del colle così come si può trovare sicurezza nel seno di una madre.
Sono immagini di grande suggestione lirica: il dolce naufragio nel mare dell’infinito è emblematico
di ciò. Le OPERETTE MORALI E I GRANDI IDILLI rientrano invece nell’ambito del pessimismo
cosmico: la natura(meccanicistica) è matrigna; la ragione è positiva perché disvelatrice della misera
condizione umana. Esplicativa di quanto detto è l’operetta morale”il dialogo della natura e di un
islandese”: la natura è nemica, crudele, e indifferente, il dolore la distruzione, la morte, lungi
dall’essere errori accidentali nel piano della natura, sono elementi essenziali del suo stesso ordine. Il
mondo è un ciclo eterno di produzione e distruzione la quale è indispensabile alla conservazione del
mondo. Il dialogo con la natura si conclude con la domanda: a che serve questa vita infelicissima
dell’universo? E’ la domanda che il pastore del canto notturno rivolgerà alla luna ed è una domanda
che non ha risposta. Ma la natura in senso filosofico è crudele perché non restituisce nella maturità
ciò che promette in gioventù e quando il tempo della speranza finisce e SILVIA perisce combattuta
e vinta “da chiuso morbo, il verno inaridisce l’erba”, la natura risponde alla morte con la morte di se
stessa.
“già tutta l’aria imbruna, torna azzurro il sereno e tornan l’ombre giù da colli e dai tetti, al
biancheggiar della recente luna e calano le tenebre e con essa giunge l’ansiosa attesa della festa”.
Nel” Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” protagonista in assoluto è la luna
silenziosa,intatta, solinga, eterna, peregrina, candida; la luna nella sua personificazione, appare
maestosa, indifferente ai travagli interiori del pastore, ma allo stesso tempo immagine consolatoria,
squisitamente femminile e materno. La luna, ed in genere la natura, si presentano diversi dai restanti
grandi idilli, il canto non è più vaneggiamento del “ caro immaginario”, ma lucida riflessione
filosofica fondata sul vero. Ne “La ginestra”, l’ideologia leopardiana giunge a completa
maturazione approdando al pessimismo eroico: appello alla solidarietà fra gli uomini per ergersi
contro la Natura su di una base di impegno etico civile e di aperto confronto con le ideologie
dominanti. La Ginestra indica proprio la resistenza all’avversità della natura, nonostante i campi
siano cosparsi di cenere infeconde e ricoperti dell’impietrita lava, che sotto i passi al peregrin
risono, la ginestra profumata continua a sporgere intorno i suoi cespi solitari. La Natura che
riempie i versi dell’ultimo Leopardi è dunque espressione concreta della sua ideologia. La colpa del
male di vivere è quindi unicamente della natura, ma l’uomo non può e non deve rifugiarsi nelle
illusioni: deve affrontare il “vero” a testa alta, con coraggio ed eroismo ed è per questo che il poeta
si pone di fronte all’umanità come maestro di questa verità e come negatore delle illusioni del
“secol superbo e sciocco”. E’ questa la poetica della Ginestra dove il poeta si apre agli altri in nome
di una solidarietà umana che allevia almeno in parte il male della vita. In questa lirica il Leopardi si
propone di smontare le illusioni sulla umana “possanza” e perfettibilità, ponendo gli uomini di
fronte alla cruda verità su una Natura crudele, matrigna a causa di tutto il male del mondo. In nome
di questa oggettività del male il poeta propone un consorzio umano, fondato sulla coscienza del
vero e per questo sulla solidarietà che aiuti ad attraversare il dolore della vita. L’uomo si deve
quindi porre con coraggio di fronte alla natura senza piegare vilmente il capo, ma affrontando con
coraggio la verità, pur sapendo di essere soggetto ai capricci della Natura, che può distruggerlo da
un momento all’altro. Come la ginestra, insomma, l’uomo deve sfidare la natura con il proprio
eroico coraggio, in modo da superare il male della vita.In genere in Leopardi la natura trova sempre
una giustificazione che va al di là dei dati oggettivi.
In VERGA la Natura diventa spesso accumulo di roba: ciò è evidente nella novella “la roba”, dove
le immagini tratte dal mondo rurale, indicano i possedimenti di MAZZARO’. Le stoppie riarse della
Piana di Catania, gli aranci sempreverdi di Francoforte e i sugheri di Rosecene, i pascoli di Passaoto
Passanitello, vigne, uliveti, aranceti, buoi, tutto è di Mazzarò e nel completo rifiuto di altri valori
teme la morte poiché teme di non poter portare con sé la sua “roba”. In ROSSO MALPELO, invece,
la natura, solo a tratti presente, esprime quella durezza di sentimenti, lo scarno verismo e
pessimismo di Verga: la sciara si stendeva malinconica e discreta fin dove giungeva la vista, e
saliva e scendeva in picchi e burroni, nera e rugosa, senza un grillo che vi grillasse, o un uccello che
venisse a cantarci. Più che realismo, vi è però adattamento della natura alla realtà di ROSSO
MALPELO: la natura diventa birbona come lui. Lo stesso soggettivismo dei personaggi dinanzi alla
natura in contraddizione con la poetica verghiana, è presente ne ”I Malavoglia”. Nel passo ”Mena
Compare Alfio e le stelle che ammiccavano più forte”, il dialogo fra Mena e compare Alfio è tutto
giocato sulla reticenza, e trova il suo completamento nel sentimento dell’ignoto, che scaturisce dal
rumore dei carri e dal mare. Il russare del mare e l’ammiccare delle stelle di certo non sono dati
colti oggettivamente, ma dettagli illuminati dalla volontà di creare una certa atmosfera. Stesso
discorso per “L’addio di N’Toni”: il paese si colora dello stato d’animo di N’Toni, è buio, e dice a
N’Toni che potrà illuminarsi per lui solo per l’ultima e nostalgica volta, il mare brontola, non può
più accogliere colui che porta con sé disgregazione e progresso. Il quadro naturale non è di certo
colto nella sua oggettività, le immagini nascondono significati metaforici che svelano l’essenza
dell’animo verghiano. In “Mastro Don Gesualdo” la natura è ancora accumulo di roba nel brano del
colloquio con Diodata, Gesualdo guarda il raccolto sotto agli occhi, la mula che abboccava nella
bica, i buoi accovacciati attorno all’aia, legati ai cestoni colmi di fieno: per tutto questo è pronto a
rinunciare anche al vero amore, quello sincero di Diodata. Quando sposerà Isabella Trao per
ascendere la scala sociale, si accorgerà, che “il pesco non si innesta all’ulivo”: tale metafora, tratta
dal mondo naturale, esprime l’impossibilità di conciliare gli affetti e gli interessi, anche se Mastro
Don Gesualdo non sa cancellare del tutto gli affetti, e il sentirli impossibili gli lascia “una spina nel
cuore”. Ancora una volta, anche nell’ambito del verismo la natura esprime concetti che vanno al di
là di essa.
In Carducci invece si quando funge da sfondo delle gesta umane, sia quando funge da stimolo al
sentimento e alla fantasia la natura dei paesaggi è sempre splendida, bella e vigorosa, ispiratrice di
forza, di serenità e di pace: egli infatti è l’ultimo poeta che abbia contemplato la natura con una
sensibilità ancora semplice, sana d immediata, non guastata ed alterata dalla morbosità più o meno
inconscia, dello spirito moderno. In “Traversando la Maremma Toscana” oltre l’amore per la
Maremma, la terra della sua fanciullezza, si evidenzia quel paesaggio aspro e selvaggio che ha
profondamente inciso sulla sua natura di uomo e di poeta. La visione di quei luoghi ben noti suscita
nel poeta il ricordo struggente dei sogni giovanili che, sempre inseguiti con tanto entusiasmo per
tutta la vita sono miseramente caduti ad uno ad uno, e contemporaneamente il senso della morte e
dell’inutilità del proprio operare. Egli però non ama soffermarsi su considerazioni tristi ma
preferisce volgere lo sguardo al paesaggio sfumato nella nebbia, che, dalla verde pianura dilavata di
fresco, vaporano verso le colline infondendogli nel cuore un senso sereno di pace.
In Pascoli, la natura si carica di valenze allusive e simboliche, rimanda sempre a qualcosa che è al
di là di essa, all’ignoto di cui è messaggio misterioso e affascinante. Anche la precisione botanica e
ornitologica con cui Pascoli designa fiori, piante, varietà di uccelli, pur avendo la sua radice nel
rigore classificatorio della scienza positivistica, assume poi ben diversa valenza: il termine preciso
diviene come la formula magica che permette di andare al cuore della natura,di attingere all’essenza
segreta di essa. La sfera dell’io si confonde con quella della realtà naturale, le cose acquistano una
visione antropomorfizzata, si caricano di significati umani.. Ne ”Il gelsomino notturno” tutte le
immagini naturali (farfalle crepuscolari, erba, ape, l’alba, viburni) formano la metafora di un rito di
fecondazione, rivelando una turbata visione del sesso, dopo la frantumazione del suo nido. La
natura quindi non è idillica e viene utilizzata per esprimere altri significati. Fuori del “nido”la realtà
gli appare oscura e minacciosa, il suo atteggiamento è di smarrimento angoscioso, non c’è niente
che dia un senso all’uomo e alla sua mortalità: la gelida infinità degli spazi cosmici, in cui la terra
non è che uno sperduto “atomo opaco” lo opprime fisicamente; l’intera realtà gli appare “un
mistero”. Si potrebbe tentare di stabilire un parallelo con l’inesausta domanda leopardiana sul
perché dell’universo meccanico, disegnato dalla scienza settecentesca; ma Pascoli non ha lucidità
razionale di Leopardi, il suo rifiuto della consolazione, ne’ quel suo tono di sfida verso la cultura
del proprio tempo; il suo atteggiamento verso il mistero della natura è emotivo e sgomento e rientra
in uno crisi generale dell’ottimismo positivista.
In Pirandello la natura rappresenta, per certi versi, l’evasione dall’assurdità del vivere,
dall’oppressione delle istituzioni. Ne ”Il treno ha fischiato” Belluca dice di essere arrivato in Siberia
e nelle foreste del Congo; la sua pazzia è testimonianza del bisogno di liberazione della maschera
che indossa. Belluca realmente vorrebbe rifugiarsi negli spazi della natura per sfuggire la pena di
vivere così. In “Ciaula scopre la luna” il protagonista si apre alla natura e al suo contatto si sente
rigenerare, prova un senso di refrigerio ed intravede in essa la dolcezza di un conforto, di un riscatto
dalla condizione di vita bestiale, a cui è costretto dalla sorte. Qui inoltre si intravede l’angoscia
alienante dell’uomo, che, a volte, spezzato l’involucro della “forma” intravede una realtà più
profonda, fuori e dentro di lui: l’assoluto, il tutto, a cui segretamente e incessantemente anela. Infine
in questa novella si evidenzia la concezione lirica della natura e del paesaggio che ebbe Pirandello.
Per lui la natura è l’unico punto fermo nell’universo, mutabilità della vita e degli esseri. Passano gli
uomini, si trasformano le cose, ma la natura è alterna con i suoi meravigliosi spettacoli di bellezza,
di potenza o di armonia. Nel suo grembo l’uomo prova dolcezza e conforto come se essa fosse
partecipe della sua pena.
La compenetrazione uomo-natura, che implica lo scambio fra mondo animato e mondo inanimato è
un tema costante della poesia ungarettiana. In”San Martino del Carso” assistiamo all’umanizzazione
di un paese. Il poeta osserva lo scempio che la guerra ha operato a San Martino del Carso, un
villaggio del quale non è rimasto in piedi che qualche brandello di muro, e immediatamente pensa a
tanti compagni dei quali non sono rimasti che brandelli. Il paesaggio è immobile, fuori dal tempo, in
uno spazio rarefatto e statico, dove si stempera anche il dramma. Lo stupore del poeta di fronte alla
natura è come quello dei primi uomini dinanzi alla creazione, è un rivivere l’innocenza antica, e
l’immergersi in una memoria cosmica amorale.
“Meriggiare pallido ed assorto” di Montale è un momento di sospensione quasi assoluta, in cui la
vita sembra essersi arrestata nella proprie forme e parvenze. Il paesaggio è antiidillico, arido,
scabro, emblema di una condizione esistenziale desolata, prosciugata e svuotata di ogni slancio
vitale (rovente, muro, pruni, sterpi, crepe del suolo, calvi picchi, sole che abbaglia). Il paesaggio
non si apre all’uomo, vive in se stesso, nella sua incomunicabilità. Non è uno scopo, ma un tramite
verso un qualcosa che resta, alla fine, misterioso e in conoscibile.
In Saba domina una natura cittadina. In “Città Vecchia”, si parla di oscure vie, del giallo dei fanali
che si specchia nelle pozzanghere e di gente che viene e che va: la città è amata in se stessa ma
anche nei luoghi in cui il poeta può isolarsi. Il desiderio di tuffarsi nella vita di tutti è la riscoperta di
un senso di partecipazione che presuppone la solitudine e l’esclusione dell’individuo.
GRECO
Teocrito fu contemporaneo di Callimaco. Trascorre la sua vita tra la Sicilia e Cos dove forse muore.
Tra i grandi temi della poesia teocritea un posto rilevante lo occupa l’amore: esso è tormento,
disillusione, profonda frustrazione; il poeta rifugge da ogni sentimentalismo e comunicazione.
L’amore diviene beffarda ironia nel Ciclope, tormento dei sensi e dell’anima nelle Incantatrici,
malattia struggente e misteriosa nella morte di Dafni che è nel Tirsi. Accanto all’amore, altro
motivo fondamentale ispiratore della poesia di Teocrito è il sentimento per la natura. Egli indulge
nella descrizione del paesaggio; infatti un capraio affida a Teocrito il compito di essere poeta dei
pastori, tra cui egli sceglie i suoi personaggi. Leggendo i suoi Idilli e i suoi Mimi ci rendiamo conto
che
un
argomento
popolare
assume
un
carattere
grande. ”Nessun autore antico, dice Serrao, amò la natura e il paesaggio più di Teocrito, ma il
paesaggio che egli si compiace di raffigurare è quasi sempre quello agreste”. Infatti la campagna
non deve fare soltanto da sfondo, ma assume una valenza quasi umana. La natura ha una sua vita e
all’uomo resta soltanto doverla accettare. In Omero si fa riferimento alla campagna soltanto quando
si devono fare dei paragoni perché c’è la grandezza del mito, eccetto che nella descrizione di
Calipso. Tutti i poeti rappresentano la realtà vista da loro, a differenza di Teocrito è come se egli
fosse piccolo, proteso ad ascoltare e l’unico valore è la forza della natura, la sua vitalità che è in
grado di portare l’uomo alla verità. Parte da una visione realistica e nel tradurre la natura attraverso
il canto arriva alla catarsi, che crea quella serenità di spirito, che fu la massima aspirazione di
Teocrito.Due concetti rappresentano i due termini entro i quali si muove la poetica teocritea: quello
dell’e quello dell’; la prima viene indicata attraverso la realtà delle
Siracusane, dei campi, l’odore della Sicilia; la seconda rappresenta la serenità che l’uomo
raggiunge. L’ , la verità, indica una poesia “personale” in contrapposizione alla poesia
“impersonale” che è pura imitazione; l’ è facilmente raggiungibile attraverso il canto.
Nel mondo greco Teocrito fonda un nuovo valore, un NODO ETICO mai trovato fino ad ora e
questo è la Natura. Dopo Teocrito, la visione della natura perde la sua forza originaria: il paesaggio
diventa povero e convenzionale; nasce cosi una specie di “mascherata bucolica”, concetto opposto a
quello di Teocrito, diventando, la poesia bucolica, poesia di evasione. Gli Idilli di Teocrito sono
brevi componimenti che trattano scene riprese dall’esistenza quotidiana di uomini della città e della
campagna, rievocando vite e miti di pastori, sentimenti, curiosità, invidie, amicizie, che riempiono il
cuore di questa umanità semplice e schietta.
“L’animo ingenuo ed ardente del cittadino siracusano, del lettore appassionato di Saffo, prevale sul
cortigiano di Alessandria e nascono cosi gli Idilli, frutto di originale talento poetico e squisita
sensibilità artistica”.(Colonna)
Scompaiono le immagini ricercate e l’erudizione mitologica per far posto alla sincera esplosione dei
sentimenti, come l’amore, con una spontaneità che ricorda Saffo. La vera poesia di Teocrito è nei
carmi bucolici e negli schizzi di vita cittadina, dove l’acuto spirito di osservazione fa rivivere le
curiosità, i pettegolezzi, le meraviglie della gente del popolo.
“A rendere più vera la descrizione c’è da un lato il dialetto con una frequenza di idiotismi, propri
delle condizioni sociali e delle nazionalità dei personaggi, dall’altra la duttilità dello stile, che ora
riproduce l’ingenua rozzezza del bifolco, ora la loquacità del paesano, ora la timida ritrosia del
giovane innamorato”.(Colonna)
“Teocrito ha scritto versi teneri e dolci, ma non è il poeta dei sentimenti dolci; è delicato e raffinato,
ma non è il poeta della tenerezza e del sentimento languido. Non è neanche un realista; i suoi
pastori pur non essendo pastori da salotto, non sono neanche pastori poveri”.(Perrotta)
In tal senso è ravvisabile una certa somiglianza, pur nella diversità, con Virgilio. Il poeta latino
possiede altrettanta sensibilità umana, una profonda spiritualità tipicamente romana e soprattutto un
legame fraterno con le creature umili e dolenti e un forte sentimento di ideale sanità agreste come
ricerca di pace e di armonia interiore (otium contemplativo) tale da alleviare le sofferenze della
nostra esistenza umana. (Paratore)
STORIA DELL’ARTE
Emozioni,sensazioni e dolori possono diventare poesia così come possono essere proiettati su di
una tela o in qualsiasi altra forma d’arte. L’effetto sarà ogni volta il nostro animo si stupirà nel
vedersi a tal punto coinvolto in immagini di natura. I colori, le forme, gli equilibri dell’arte riescono
talvolta a sottolineare elementi della natura che sfuggono alla disattenzione umana oppure possono
elevare la realtà della natura in una dimensione ideale. Fidia fu il maggior rappresentante dell’arte
greca classica, famoso soprattutto per la costruzione e decorazione del Partenone. La decorazione
scultorea e pittorica ravvivava ed esaltava il tempio. Sobria quella relativa alle modanature in
marmo dotate di piccoli fregi con perle. In quella del tetto predominava il motivo della palmetta.
Contenuta anche la cromia:poco azzurro, rosso,oro in alcune modanature e sui cassettoni marmorei,
con motivi geometrici o floreali stilizzati. Sulle metope troviamo la rappresentazione di una
Amazzonomachia, di una Gigantomachia e una Lotta tra Centauri e Lapiti. Lo sfondo delle tre è
neutro, senza ambiente al di dietro; il centauro esprime con il corpo quello che esprime con il volto.
Tutti i temi delle metope stanno a simboleggiare la vittoria della civiltà sulla barbaria e della
ragione sull’irrazionale. Nel fregio non vi è una collocazione spaziale perché lo sfondo è neutro e
non c’è una successione di spazio. Inoltre vi è un perfetto equilibrio tra dei, natura e personaggi. Nel
Frontone sembra che le due figure nascono una dall’altra (figure continue). Il panneggio viene
indicato come un’invenzione di Fidia.
Nel Realismo, l’arte è riproduzione oggettiva della realtà. Quadri di natura sono quelli di Millet che,
di origine contadina, era cresciuto in mezzo ai campi. La pittura di Millet, priva di ribellioni, è
soffusa di una dolce tristezza: uomini e paesaggi sono accomunati nel sentimento dell’eterno. Vi è
in Millet una concezione panica della natura: uomo e natura sono legati indissolubilmente e sono
partecipi l’uno della vita dell’altro. Nell’Impressionismo, poi, la natura è percepita attraverso “
IMPRESSIONI “ di forme, di luci, di colori, impressioni diverse dall’uno all’altro osservatore. Ne “
LA GRENOUILLERE “ di Monet, non vi è il sentimento romantico della natura; la natura vive in
tutta la sua mobilità e continuità e noi viviamo in mezzo ad essa. Protagonista del quadro è l’acqua
che domina buona pare della superficie; tutto ciò che la sovrasta e la circonda vi si specchia con i
suoi diversi colori, che influenzano reciprocamente. Ma per Monet l’acqua non è soltanto uno
specchio moltiplicatore di colori in movimento. Esprime piuttosto il senso della relatività dei
rapporti, del nostro essere e della nostra natura che ci circonda. Ancora una volta esaminando il
concetto di natura in periodi ed in diversi autori, il risultato è di un profondo soggettivismo dinanzi
alle manifestazioni di essa. Anche lo stesso Gaugain, dopo il viaggio a Tahiti, addentratosi e
cominciando a condividere gli usi, le abitudini di quella popolazione, è affascinato dal rapporto
diretto, immediato con la natura, che vive realizzata nell’età dell’oro. Ciò che gli interessa è saper
cogliere nella natura i percorsi misteriosi. Nei dipinti di Tahiti la natura è risolta con arabeschi
lineari, è mitizzata anche perché la ricorda cosi, attraverso la memoria.
FILOSOFIA
Nei pensieri dell’uomo la natura può essere non solo mera presenza esteriore, ma anche fonte di
motivi filosofici. Anche in filosofia svariate sono le nozioni, per di più astratte, della natura. Come
scriverà Friederich Schiller, esponendo con chiarezza e precisione le idee kantiane, “si chiama
sublime un oggetto alla cui rappresentazione la nostra natura fisica sente i propri limiti, nello stesso
tempo in cui la nostra natura ragionevole sente la propria superiorità, la sua indipendenza da ogni
limite: un oggetto rispetto al quale siamo fisicamente deboli, mentre moralmente ci eleviamo sopra
di esso con le idee. In altri termini, sublime è quello stato d’animo che proviamo di fronte a entità
naturali smisuratamente grandi(sublime matematico,o dinamico), che inizialmente richiamano la
nostra piccolezza fisica, ma che in seguito rimandano alla nostra grandezza spirituale, testimoniata
dal nostro essere portatori delle idee della ragione, in particolare dell’idea dell’infinito. Parlando di
sublime matematico, Kant definisce sublime, ciò al cui confronto ogni altra cosa è piccola,
precisando che “la natura è sublime in quei suoi fenomeni, la cui natura include l’idea della sua
infinità”. Parlando del sublime dinamico, Kant dice “La natura qui non è dunque chiamata sublime
se non perché eleva l’immaginazione a rappresentare quei casi in cui l’animo può sentire la
sublimità della propria destinazione, anche al di sopra della natura”. “La sublimità non risiede
dunque in nessuna cosa della natura, ma soltanto nell’animo nostro, quando possiamo accorgerci di
essere superiori alla natura che è in noi, e perciò anche alla natura che è fuori di noi”. Anche
relativamente al concetto di natura, quindi, Kant opera una sorta di rivoluzione copernicana, per cui
non è la mente ad adattarsi alla realtà, bensì la realtà che si modella sulle forme a priori attraverso
cui la percepiamo. In Schelling l’Assoluto è un insieme di oggetto e di soggetto, ragione e natura.
La filosofia della natura mostra come “essa” si risolva nello spirito. La Natura è un organismo che
organizza se stesso e non un’opera d’arte il cui concetto stia fuori di essa, nella mente dell’artista.
Inoltre, Shelling parla di natura come preistoria dello spirito: è uno spirito inconscio in moto verso
la coscienza; la natura comincia in maniera inconscia e finisce consciamente. Ciò a dimostrazione
che natura e spirito sfociano l’uno nell’altro perché elementi di un unico assoluto. In Hegel, la
Natura è l’Idea fuori di se o l’Idea nella forma dell’essere altro, ossia l’estrinsecazione alienata
dell’Idea nella realtà spazio temporale del mondo. Il concetto di natura ha nella dottrina di Hegel
una funzione chiave e non potrebbe essere eliminato o tolto senza eliminare o togliere l’intera
dottrina. Il principio stesso dell’identità di realtà e ragione pone infatti a questa dottrina l’obbligo di
giustificare e risolvere nella ragione tutti gli aspetti della realtà. Hegel respinge fuori dalla realtà,
quindi nell’apparenza, ciò che è finito, accidentale e contingente, legato al tempo e allo spazio e la
stessa individualità in ciò che ha di proprio e di irriducibile alla ragione. Ma tutto ciò deve pur
trovare un qualche posto, una qualche giustificazione, sia pure di mero titolo d’apparenza se,
almeno come apparenza, è reale e trova posto e giustificazione nella Natura che da questo punto di
vista si configura come una sorta di pattumiera del sistema. Le divisioni fondamentali della natura
sono: la meccanica, la fisica e la fisica organica. Schopenhauer, invece, afferma che la volontà di
vivere è la radice noumenica dell’uomo e dell’universo. Anche la natura, in tutte le sue
manifestazioni e con diversi gradi di consapevolezza, nasce da una volontà di vivere, che è
l’essenza intima di tutto l’universo. Per ognun di noi, menti eccelse oppure no, la natura rappresenta
qualcosa: forza creatrice, forza distruttrice, motivo d’ispirazione e di consolazione.
FISICA
La natura al di là di interpretazioni umanistiche va sottoposta ad un’analisi anche scientifica; e che
cosa analizzare se non l’atomo, componente fondamentale della materia?
Dal ton nel 1803 formulò la prima teoria atomica della materia:
•
•
•
•
La materia non è continua, ma è composta da particelle che non possono essere
ulteriormente divisibili ne trasformabili, gli atomi;
Gli atomi di un particolare elemento sono tutti uguali tra loro e hanno la stessa massa;
Le reazioni chimiche avvengono tra atomi interi e non tra frazioni di essi;
In una reazione chimica tra due o più elementi gli atomi, pur conservando la propria identità,
si combinano secondo rapporti definiti, dando luogo a composti.
Fisici e chimici, a partire dalla metà del sec. Scorso sono stati in grado di dimostrare che l’atomo è
costituito da particelle semplici che hanno una natura elettrica: le particelle subatomiche. Tra tutte
le particelle scoperte( oltre 100) si considerano solo l’elettrone, il protone, e il neutrone. Le altre,
infatti, sono infinitamente più piccole e hanno una vita molta breve. L’elettrone è l’unità elementare
d’elettricità mobile della materia ed è indubbiamente la particella più importante di chimica; ha una
massa di 9.109 * 10-28 grammi e possiede una carica elettrica negativa pari a 1,602* 10-19 Coulomb
alla quale per convenzione si attribuisce il valore –1 e viene indicato con il simbolo e-. Tutti gli
elettroni sono identici tra loro indipendentemente dall’atomo di cui fanno parte. Gli elettroni furono
scoperti da Thompson nel 1897. Il protone, invece, scoperto nel 1914 da Goldstein, è una particella
di massa 1’672* 10-24 grammi e di carica uguale a quella dell’elettrone ma di segno opposto, alla
quale, viene attribuito valore +1. Al protone, quindi, è associata un’unità di carica elettrica positiva.
Tutti i protoni sono identici tra loro indipendentemente dall’atomo di cui fanno parte. Poiché
l’atomo è elettricamente neutro,in ogni atomo il numero di elettroni deve essere uguale a quello dei
protoni. Il neutrone scoperto da CHADWICK nel 1932, è una particella elettricamente neutra, cioè
priva di carica, che possiede una massa pari a 1,675*10-24 grammi ( praticamente uguale a quello de
neurone). Tutti i neutroni sono uguali tra loro. Fisicamente, dunque, l’atomo è tutt’altro che
divisibile, ma la sua suddivisione in particelle subatomiche comporta la perdita della caratteristiche
dell’elemento di cui fa parte. Pertanto l’atomo può essere considerato come la più piccola entità di
un elemento che ne conserva le caratteristiche e che non può essere ulteriormente suddiviso con
mezzi chimici. Il termine atomo (nel senso di indivisibile) perciò è ancora chimicamente
valido,anche se fisicamente è un termine improprio. Gli scienziati a partire dalla fine del 19 sec.
sentirono l’esigenza di ideare dei modelli atomici. I modelli atomici nacquero, dunque,
dall’intuizione di alcuni scienziati di fronte all’impossibilità di interpretare in modo semplice
fenomeni complessi. Il primo modello atomico formulato nel 1928 da Thompson, ammetteva che
l’atomo, ipotizzato da Dal ton, fosse un aggregato di particelle semplici. Alla luce dei pochi dati
sperimentali in suo possesso, Thompson ipotizzò che l’atomo fosse costituito da una sfera
omogenea carica di elettricità positiva, in cui gli elettroni erano distribuiti in maniera uniforme e
senza una disposizione spaziale particolare. Tra il 1909 e il 1911 Routherford progettò con altri
ricercatori un ingegnoso esperimento per indagare sulla costituzione interna dell’atomo. Tale
esperimento consisteva nell’irradiare con un fascio di particelle alfa (2 unità di carica positiva e una
massa 4 volte superiore a quella dell’atomo di idrogeno), provenienti da una sorgente radioattiva,
una sottile lamina d’oro, osservando su uno schermo fluorescente gli effetti che tali “ proiettili”
producevano nell’attraversare la lamina ad alta velocità. In particolare Routherford osservò che la
maggior parte delle particelle alfa attraversavano la lamina indisturbatamente, mentre altre ne
venivano deviate e alcune addirittura riflesse. Pertanto Routherford e i suoi collaboratori
ipotizzarono un nuovo modello di atomo che fosse in accordo con i risultati ottenuti. In tale modello
tutta la carica positiva e la massa dell’atomo erano concentrate in una piccola regione dell’atomo
stesso che venne chiamata nucleo, mentre gli elettroni si trovavano nel grande spazio attorno ad
esso, spazio avente un diametro da 10000 a 100000 volte maggiore di quello del nucleo. In altre
parole, il nucleo occupa una piccolissima porzione del volume atomico, per cui, si può dire che
quasi tutto il volume dell’atomo è occupato dagli elettroni. Rutherford,inoltre, intuì che i protoni da
soli non bastavano a giustificare l’intera massa del nucleo di un altro tipo di particelle che, anche se
prive di carica, contribuivano comunque, con la loro massa all’intera massa del nucleo, tali
particelle erano i neutroni. Il modello di Rutherford lasciava però insoluti alcuni problemi. Esso,
infatti, non riusciva a spiegare come particelle di uguale carica potessero convivere indisturbate nel
nucleo senza respingersi reciprocamente. Non spiegava inoltre, come mai gli elettroni in rapida
rotazione attorno al nucleo non perdessero quota fino a cadere su di esso, dato che, secondo le leggi
dell’elettromagnetismo, cariche elettriche in movimento, dovrebbero perdere energia irradiandola
sotto forma di onde elettromagnetiche. A tali problemi hanno dato risposta successivamente altri
scienziati, che attraverso più sofisticati modelli atomici, trovarono giustificazione per tutti quei
fenomeni che le leggi della fisica classica non potevano spiegare. Un valido contributo alla
soluzione dei problemi del modello di Rutherford venne dato dallo studio degli spettri di emissione
a righe degli atomi (complesso delle luci in cui si scompone un raggio luminoso passando attraverso
un prisma). L’osservazione degli spettri di emissione a righe degli atomi mise definitivamente in
crisi il modello di Rutherford. Si è detto, infatti, che secondo le leggi della fisica l’elettrone,
ruotando attorno al nucleo avrebbe una graduale e continua perdita di energia, che, se essa sotto
forma di radiazioni luminose, dovrebbe dar luogo ad uno spettro continuo dove i colori sfumano
gradualmente (radiazioni ad alta energia) al rosso ( radiazioni a bassa energia) mentre dai dati
sperimentali si è osservato che gli atomi emettono spettri a righe. Il fatto che lo spettro si rivelasse
composto da righe ben distinte, sempre le stesse per ogni elemento, significa che le transazioni di
energia di un atomo dovevano avvenire in modo discontinuo secondo quantità discrete, che
chiameremo QUANTI DI ENERGIA,e non mediante una variazione graduale e continua. Nel 1900
PLANCK capì che l’energia non può essere suddivisa all’infinito, ma fino al quanto; quindi il
quanto è la più piccola porzione che può essere ottenuta dal processo di suddivisione dell’energia.
In tutti i processi fisici l’energia può essere emessa o assorbita solo in quanti o multipli di essi, mai
in frazioni. Planck, inoltre, definì un valore h (costante di plank) che mette in relazione l’energia (E)
emessa da una radiazione luminosa con la sua frequenza (v): E=hv (h=0,66*10-33). Sollecitato dai
dati sperimentali emersi, nel 1913, il danese Niels Bohr ideò un modello atomico più corretto di
quello di Rutherford che dava una spiegazione degli spettri a righe emesse dagli atomi eccitati e
contemporaneamente spigava gli spettri a righe emessi dagli atomi eccitati e la loro stabilità. Per
costruire il suo modello Bohr si basò fondamentalmente su due postulati:
· Finché un elettrone ruota nella sua orbita non perde energia per irradiazione;
· Quando per effetto di una scarica elettrica o per riscaldamento viene somministrata
energia all’atomo,gli elettroni possono assumere quanti di energia che li portavano ad
uno stato eccitato.
Questo comporta un salto degli elettroni dalle normali orbite a loro permesse a orbite superiori a più
alto contenuto energetico, mentre non è permesso agli elettroni di assumere valori d’energia
intermedi che li porterebbero ad occupare orbite non permesse. Ogni orbita appartiene ad un dato
livello energetico o guscio individuato da un numero progressivo 1,2,3,…..chiamato numero
quantico principale. Il modello atomico di Bohr aveva il difetto di voler determinare rigorosamente
le orbite, le velocità e l’energia degli elettroni in un atomo, applicando le stesse leggi fisiche che
descrivono il moto di quantità microscopiche di materia a particelle estremamente piccole, come
sono gli elettroni. Ma ciò è impossibile, come afferma il principio d’indeterminazione di
Heisemberg, enunciato nel 1927 secondo il quale non è possibile misurare, e quindi conoscere
contemporaneamente, con la massima precisione, la posizione e la velocità istantanea dell’elettrone.
Con il principio d’indeterminazione si sostituisce al concetto di orbita quello di orbitale, che è
definito come una regione dello spazio all’interno della quale si può trovare l’elettrone. In questo
modo non si parla più della posizione dell’elettrone, ma solo della probabilità di trovarlo in una
certa zona. Nel 1924 L. de Broglie avanza l’ipotesi che ad ogni particella in movimento sia
associata un’onda; gli esperimenti confermarono che l’elettrone ha una doppia natura può
comportarsi sia come particella che come onda. Nel 1926 E. Schrodinger formulò un’equazione
matematica per descrivere il moto ondulatorio dell’elettrone in funzione della sua energia,
considerandolo come un’onda stazionaria. I risultati dell’equazione sono funzioni che descrivono i
diversi stati dell’elettrone intorno al nucleo. Svolgendo l’equazione si può stabilire l’orbitale. Il
termine orbitale indica quindi, le funzioni che si ottengono come soluzione dell’equazione di
Schrodinger. Tra il modello quanto –meccanico di Bohr e quello derivante dalla meccanica
ondulatoria, esistono dei parametri numerici comuni, ma con diverso significato: i numeri quantici.
Essi sono tre e servono nel modello di Bohr a descrivere in termini fisici a dimensione, la forma e
l’orientmento dell’orbitale:
n= numero quantico principale (indica la distanza dell’elettrone dal nucleo; quanti orbitali vi sono
in quel livello energetico=n2 n§1 a 7)
l= forma dell’orbitale 0/l/-1
m= magnetico§ una carica elettrica in movimenta genera un campo magnetico; campi elettrici
vicini interferiscono tre di loro e si orientano in modo diverso nello spazio -1/m/+1
Vi è poi un quarto numero quantico, lo spin (rotazione) che corrisponde al momento angolare
dell’elettrone. Può assumere valori ½ e –1/2. La presenza di un terzo elettrone nell’orbitale non è
ammissibile poiché il suo spin dovrebbe essere necessariamente uguale a uno dei due elettroni
preesistenti dal quale sarebbe doppiamente respinto (repulsione elettrostatica e magnetica). Da ciò
scaturisce il principio di Pauli: in un orbitale possono coesistere al massimo 2 elettroni aventi max
tre numeri quantici uguali( spin opposto). Fino a questo momento è stata considerata la struttura
interna dell’atomo, considerato nella sua neutralità, cioè quando il numero di elettroni è uguale a
quello dei protoni; quando un atomo perde o acquista elettroni, diventa elettricamente carico( la
carica sarà positiva quando l’atomo perde elettroni e negativa quando ne acquista). Elettrizzare,
quindi non significa creare una carica, ma far emergere carica mediante acquisto o perdita di
elettroni.
Esistono vari tipi di elettrizazione:
·
Elettrizzazione per strofinio
·
Elettrizzazione per induzione
·
Elettrizzazione per contatto
Elettrizzazione per strofinio
Una bacchetta di ambra strofinata su un panno di lana viene elettrizzata positivamente (perde
elettroni) e riesce ad attrarre piccoli frammenti di carta o paglia. Se invece la bacchetta è strofinata
con un panno di seta, si elettrizza negativamente (acquista elettroni). Se avviciniamo due bacchette
una carica positivamente e l’altra negativamente, esse tenderanno ad attrarsi, mentre se sono cariche
dello stesso segno tenderanno a respingersi, in virtù del principio che asserisce che due corpi
elettricamente carichi si respingono se le cariche da esse possedute sono dello stesso tipo, si
attraggono se le cariche sono di diverso tipo.
Elettrizzazione per contatto
Un corpo conduttore può essere elettrizzato solo posto a contato con un altro corpo carico. Si può
riconoscere se ed eventualmente quanto un corpo è elettrizzato mettendolo a contatto con un
elettroscopio a foglie d’oro.
Elettrizzazione per induzione
Fenomeno nel quale si ha una ridistribuzione della carica in un conduttore neutro causata dalla
vicinanza di un corpo carico. Il nome deriva dal fatto che sul corpo neutro sono state indotte (cioè
accumulate localmente) delle cariche. Tra due corpi elettricamente carichi posti ad una certa
distanza l’uno dall’altro, si esercitano delle forze. Esse sono repulsive se le cariche dei corpi sono
dello stesso segno e attrattive in caso contrario. La forza che esprime l’interazione tra due corpi
carichi è quella di Coulomb che è direttamente proporzionale al prodotto delle quantità di elettricità
possedute dai 2 corpi e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. La regione dello
spazio in cui si avverte l’azione delle forze elettriche, viene definita “campo elettrostatico”. Questo
è un campo conservativo: si può definire il potenziale, poiché il lavoro è indipendente dalla
traiettoria, ma dipende esclusivamente dalla posizione iniziale e quella finale. Il potenziale elettrico
è il lavoro necessario per spostare una carica da un punto all’infinito. Il campo elettrostatico è
definito da 2 grandezze: il flusso e la circuitazione. Per una superficie s piana e un campo elettrico
E costante, si definisce il flusso del vettore campo elettrico attraverso s mediante la relazione: F(E)=
ES. Dato un campo vettoriale Z e una linea chiusa orientata L si chiama circuitazione di Z lungo L
la quantità GÖ(Z)= DZåli dove delta l i rappresenta uno spostamento elementare lungo L e z è il
valore del campo vettoriale z nei punti delta elle i. La circuitazione nel campo elettrico è nulla
poiché tale grandezza consente di calcolare il lavoro lungo una linea chiusa, ma il campo elettrico è
un campo conservativo dove il lavoro dipende esclusivamente dalla posizione iniziale e finale, per
cui il lavoro di una linea chiusa sarà sicuramente nullo. Il flusso è nullo e la circuitazione è diversa
da zero.
MAPPA CONCETTUALE
Italiano
Foscolo: Ultime lettere di Jacopo Ortis; sonetti(Alla sera – A Zacinto)
Leopardi: L’infinito – A Silvia – Canto notturno di un pastore errante dell’Asia – Il Sabato del
villaggio – Dialogo della natura e di un’islandese – La ginestra;
Verga: Vita dei campi( Rosso Malpelo); Malavoglia( L’addio di N’toni- Le stelle ammiccano più
forte) Mastro Don Gesualdo ( Il pesco non all’ulivo – Il colloquio tra Gesualda e Diodata)
Carducci: Traversando la Maremma Toscana
Pascoli: Il gelsomino notturno
Pirandello: Il treno ha fischiato.
Ungaretti: San Martino del Carso
Saba: Città vecchia.
Greco
Teocrito: la poesia bucolica
Storia dell’arte
Fidia
Natura impressionistica con riferimenti.
Natura simbolista con riferimenti
Filosofia
Concetto di nature in Scelling, Hegel, Kant, Schopenhauer.
Fisica
L’atomo: Modello di Bohr – Modello di Rutherford
Campo elettrico ( Flusso – Circuitazione )®riferimenti campo magnetico