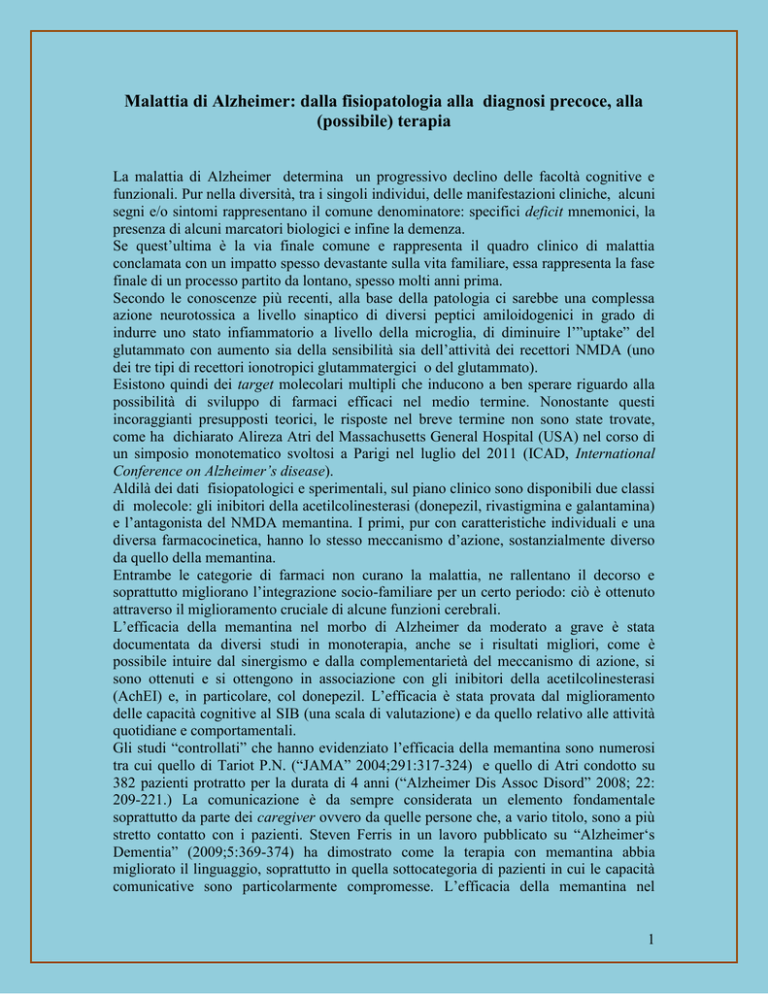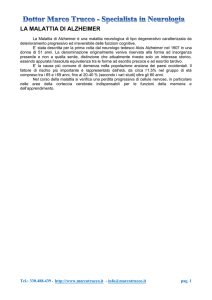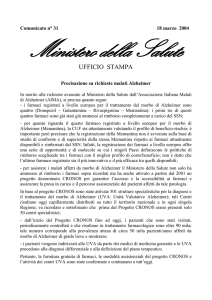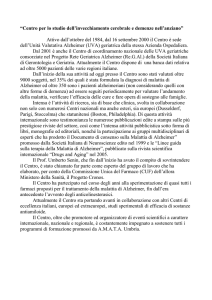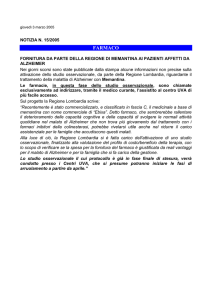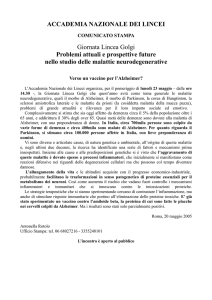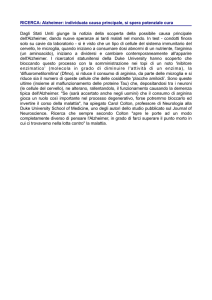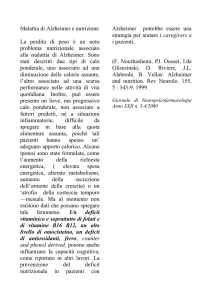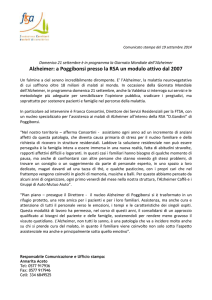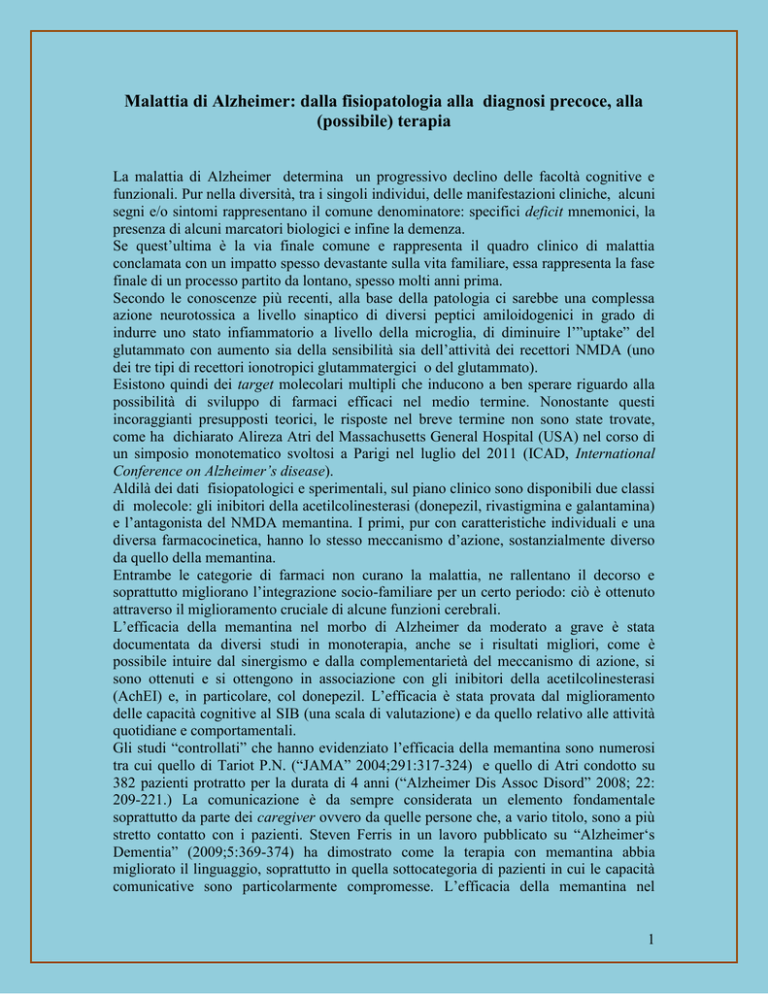
Malattia di Alzheimer: dalla fisiopatologia alla diagnosi precoce, alla
(possibile) terapia
La malattia di Alzheimer determina un progressivo declino delle facoltà cognitive e
funzionali. Pur nella diversità, tra i singoli individui, delle manifestazioni cliniche, alcuni
segni e/o sintomi rappresentano il comune denominatore: specifici deficit mnemonici, la
presenza di alcuni marcatori biologici e infine la demenza.
Se quest’ultima è la via finale comune e rappresenta il quadro clinico di malattia
conclamata con un impatto spesso devastante sulla vita familiare, essa rappresenta la fase
finale di un processo partito da lontano, spesso molti anni prima.
Secondo le conoscenze più recenti, alla base della patologia ci sarebbe una complessa
azione neurotossica a livello sinaptico di diversi peptici amiloidogenici in grado di
indurre uno stato infiammatorio a livello della microglia, di diminuire l’”uptake” del
glutammato con aumento sia della sensibilità sia dell’attività dei recettori NMDA (uno
dei tre tipi di recettori ionotropici glutammatergici o del glutammato).
Esistono quindi dei target molecolari multipli che inducono a ben sperare riguardo alla
possibilità di sviluppo di farmaci efficaci nel medio termine. Nonostante questi
incoraggianti presupposti teorici, le risposte nel breve termine non sono state trovate,
come ha dichiarato Alireza Atri del Massachusetts General Hospital (USA) nel corso di
un simposio monotematico svoltosi a Parigi nel luglio del 2011 (ICAD, International
Conference on Alzheimer’s disease).
Aldilà dei dati fisiopatologici e sperimentali, sul piano clinico sono disponibili due classi
di molecole: gli inibitori della acetilcolinesterasi (donepezil, rivastigmina e galantamina)
e l’antagonista del NMDA memantina. I primi, pur con caratteristiche individuali e una
diversa farmacocinetica, hanno lo stesso meccanismo d’azione, sostanzialmente diverso
da quello della memantina.
Entrambe le categorie di farmaci non curano la malattia, ne rallentano il decorso e
soprattutto migliorano l’integrazione socio-familiare per un certo periodo: ciò è ottenuto
attraverso il miglioramento cruciale di alcune funzioni cerebrali.
L’efficacia della memantina nel morbo di Alzheimer da moderato a grave è stata
documentata da diversi studi in monoterapia, anche se i risultati migliori, come è
possibile intuire dal sinergismo e dalla complementarietà del meccanismo di azione, si
sono ottenuti e si ottengono in associazione con gli inibitori della acetilcolinesterasi
(AchEI) e, in particolare, col donepezil. L’efficacia è stata provata dal miglioramento
delle capacità cognitive al SIB (una scala di valutazione) e da quello relativo alle attività
quotidiane e comportamentali.
Gli studi “controllati” che hanno evidenziato l’efficacia della memantina sono numerosi
tra cui quello di Tariot P.N. (“JAMA” 2004;291:317-324) e quello di Atri condotto su
382 pazienti protratto per la durata di 4 anni (“Alzheimer Dis Assoc Disord” 2008; 22:
209-221.) La comunicazione è da sempre considerata un elemento fondamentale
soprattutto da parte dei caregiver ovvero da quelle persone che, a vario titolo, sono a più
stretto contatto con i pazienti. Steven Ferris in un lavoro pubblicato su “Alzheimer‘s
Dementia” (2009;5:369-374) ha dimostrato come la terapia con memantina abbia
migliorato il linguaggio, soprattutto in quella sottocategoria di pazienti in cui le capacità
comunicative sono particolarmente compromesse. L’efficacia della memantina nel
1
salvaguardare e nel rallentare la compromissione della comunicazione è stata
documentata utilizzando diverse scale di valutazione (SIB, ADAS-Cog, CERAD-NP)
come ha sottolineato Patrizia Mecucci nel corso del simposio parigino sopra citato. I
risultati migliori, come già messo in rilievo, sono stati ottenuti utilizzando il farmaco in
associazione con gli AchEI, in particolare con il donepezil. Alla dose di 20 mg al dì di
memantina, effetti positivi cominciano a presentarsi tra la quarta e l’ottava settimana,
migliorando ulteriormente nel tempo. Singolari anche le conclusioni pubblicate da Jorge
Schulz sul “Journal Alzheimer’s Dis.” 2011;25 (3):463-475) e presentate al simposio
francese: il miglioramento delle funzioni cognitive e del linguaggio si è mantenuto anche
dopo quattro settimane di wash out, come ha documentato il punteggio totale ottenuto
con un test di valutazione (FLCI).
Un segmento nodale è rappresentato da quei pazienti che manifestano “mild cognitive
Impairment” (MCI). Solo una parte di essi vanno incontro a un morbo di Alzheimer
conclamato.
Esistono, quindi, fattori di rischio predittivi di un morbo di Alzheimer in pazienti
con M.C.I.?
All’ICAD di Parigi sono stati presentati importanti dati epidemiologici sulle condizioni
che favoriscono la progressione da “mild cognitive Impairment” in malattia di
Alzheimer; l’importanza deriva sia dalla vasta casistica (12.000 pazienti) sia dal lungo
periodo di osservazione. Innanzitutto da una metanalisi emerge come il MCI sia una
condizione propria dei paesi industrializzati con un’incidenza che varia dal 15,4% al 42%
della popolazione totale. E’ chiaro che non tutti i pazienti, avanzando negli anni,
manifestano una progressione verso il morbo di Alzheimer.
L’aspetto ritenuto centrale è quello riguardante il precoce riconoscimento dei soggetti che
presentano un maggiore rischio di un ulteriore decadimento cognitivo; intervenire con
forte anticipo significa rallentare il loro declino.
L’identificazione dei fattori di rischio insieme alle nuove tecniche di imaging e ai marker
biologici della malattia rappresentano una piattaforma per identificare (e trattare con un
intervento integrato) questo sottogruppo di pazienti con un alto rischio di evoluzione
peggiorativa del quadro cognitivo.
Quali sono i fattori di rischio?
Quelli più frequentemente riscontrati sono depressione, apatia, ansietà e basso livello di
scolarizzazione; subito dopo, in ordine di frequenza, la perdita dell’abilità nelle normali
azioni quotidiane, ma anche il diabete e l’ictus.
Non vanno trascurati gli individui che presentano una perdita soggettiva della memoria
o, peggio, coloro che sono falsamente rassicurati: con fermezza deve essere loro
consigliato un approfondimento medico-specialistico.
Inoltre numerosi e ricorrenti dati scientifici depongono a favore dell’importante ruolo
concausale, nel deterioramento mentale, dell’ipertensione, del diabete e
dell’ipercolesterolemia.
2
Barnes D. et Al., dell’Università della California, hanno presentato all’ICAD di Parigi un
nuovo modello matematico in grado di suggerire che, intervenendo sui fattori di rischio
modificabili, è possibile ridurre l’incidenza della AD ( Alzheimer’s disease) fino al 25%.
Ciò significa prevenire tre milioni di nuovi casi a livello globale.
E’ impressionante notare come fattori di rischio considerati significativi (bassa scolarità,
fumo e obesità) siano straordinariamente comuni. Questo spiegherebbe la diffusione
apparentemente epidemica della malattia. Negli Stati Uniti in cima alla lista dei fattori di
rischio è posta la sedentarietà; non c’è da stupirsi, visto che un terzo della popolazione
non pratica alcun esercizio fisico. Dal momento che il modello americano è adottato in
altre parti del mondo in modo sempre più rapido e acritico, è facile prevedere che quanto
prima la mancanza di movimento conquisterà un ruolo primario anche nei paesi
sviluppati.
Il fumo mantiene il secondo posto nella lista dei fattori di rischio, con una percentuale del
14%. Ciò significa che abolendo il fumo è possibile ridurre l’incidenza del morbo di
Alzheimer nella misura del 14%. Importante è anche il basso livello di scolarità, tanto più
importante se si tiene presente il flusso migratorio in costante aumento verso l’Europa
dalle aree più povere del mondo.
Quali sono le nuove tecniche di imaging per la diagnosi del morbo di Alzheimer?
In tempi recenti, alla tomografia ad emissione di positroni con Fluoro-desossi-glucosio
(Fdg-Pet) si è affiancato un nuovo tipo di risonanza magnetica chiamato “arterial spin
labeling” (ASL); è stata utilizzata da alcuni ricercatori della “Perelman School of
Medicine” presso l’Università della Pennsylvania (USA), per misurare i cambiamenti
della funzionalità cerebrale e quindi diagnosticare precocemente il morbo di Alzheimer.
L’ASL-Mri è in grado di rilevare il flusso sanguigno cerebrale mentre la Fdg-Pet misura
il metabolismo del glucosio nel cervello. Nonostante la diversità dei presupposti, John A.
Detre, professore di Neurologia e Radiologia, ha messo in evidenza lo stretto
collegamento dei due fenomeni (metabolismo del glucosio nel cervello e flusso
sanguigno cerebrale). A suo parere gli aumenti e i cali della funzionalità cerebrale si
accompagnano a variazioni sia del flusso sanguigno che del metabolismo del glucosio.
Due studi pubblicati contemporaneamente hanno messo a confronto le due tecniche di
imaging in pazienti affetti da morbo di Alzheimer e in un gruppo di controllo composto
da soggetti di età simile. Il metabolismo del glucosio e il flusso sanguigno cerebrale sono
stati misurati simultaneamente, iniettando il tracciante PET durante lo studio di
risonanza. Nel primo elaborato, comparso su “Alzheimer’s and Dementia” le immagini
sono state analizzate tramite esame visivo con revisione effettuata in modo indipendente
e in doppio cieco da esperti di Medicina Nucleare. Nel secondo studio l’analisi è stata
eseguita in modo automatico con un apposito software. I numeri della casistica sono
limitati; ciononostante i pattern di ridotto metabolismo del glucosio e di ridotto flusso
sanguigno cerebrale evidenziati da Fdg e da ASL-MRI sono risultati identici. I due tipi di
test avrebbero in conclusione la stessa capacità, quella di escludere (sensibilità) o di
diagnosticare (specificità) il morbo di Alzheimer. Tre elementi però sono a favore della
risonanza magnetica “arterial spin labeling” per un uso più estensivo nello screening: di
essere completamente non invasiva, di non esporre il paziente a radiazioni e di
comportare una spesa quattro volte inferiore rispetto al Fdg-Pet.
3
In conclusione occorre sottolineare che grandi aspettative sono riposte nelle cellule
staminali.
L’iniezione intracerebrale di cellule staminali murine ha determinato, in modelli animali,
una riduzione della beta amiloide nelle aree interessate.
Non si tratta di cellule staminali qualsiasi ma di cellule con il gene che codifica la
neprilisina, che è un enzima in grado di degradare la beta amiloide; in questo modo è
possibile determinare una riduzione della sostanza ritenuta responsabile della malattia
nelle zone “critiche” del cervello e, quindi, almeno potenzialmente, modificare il decorso
della malattia.
In breve sintesi, se la causa del morbo è molecolare, la terapia non potrà che essere
molecolare.
Tale dato, se trasferito all’uomo con gli stessi risultati, potrà aprire scenari impensabili.
Al momento si tratta, però, solo di una via promettente di ricerca. La prudenza è
innegabilmente d’obbligo.
“Alzheimer’s and Dementia”, 2011 oct 20;
“Neurology”, 2011 nov 29,77 (22):1977-85.
Umberto Piccone
Tutti i diritti sono riservati
4