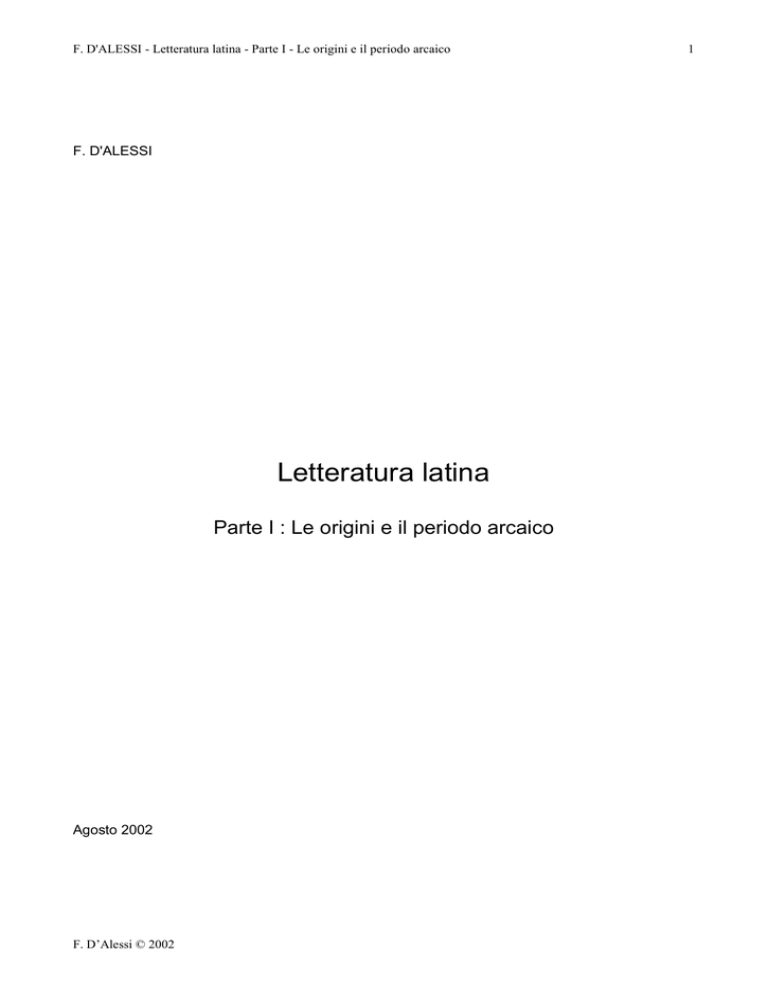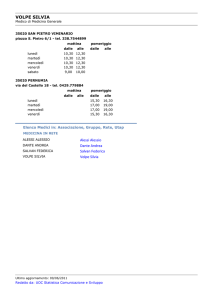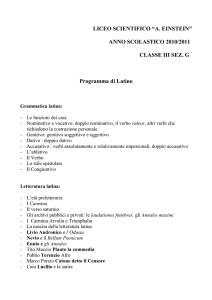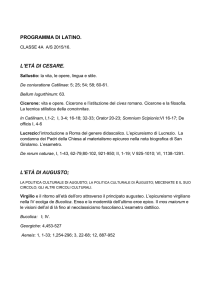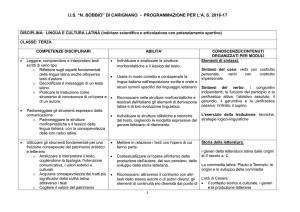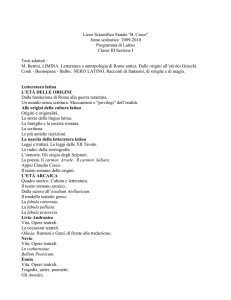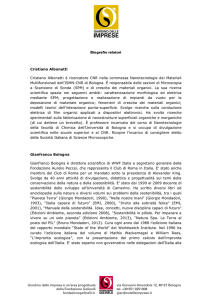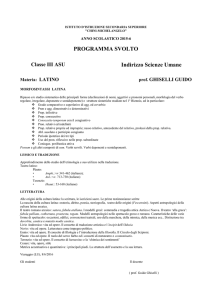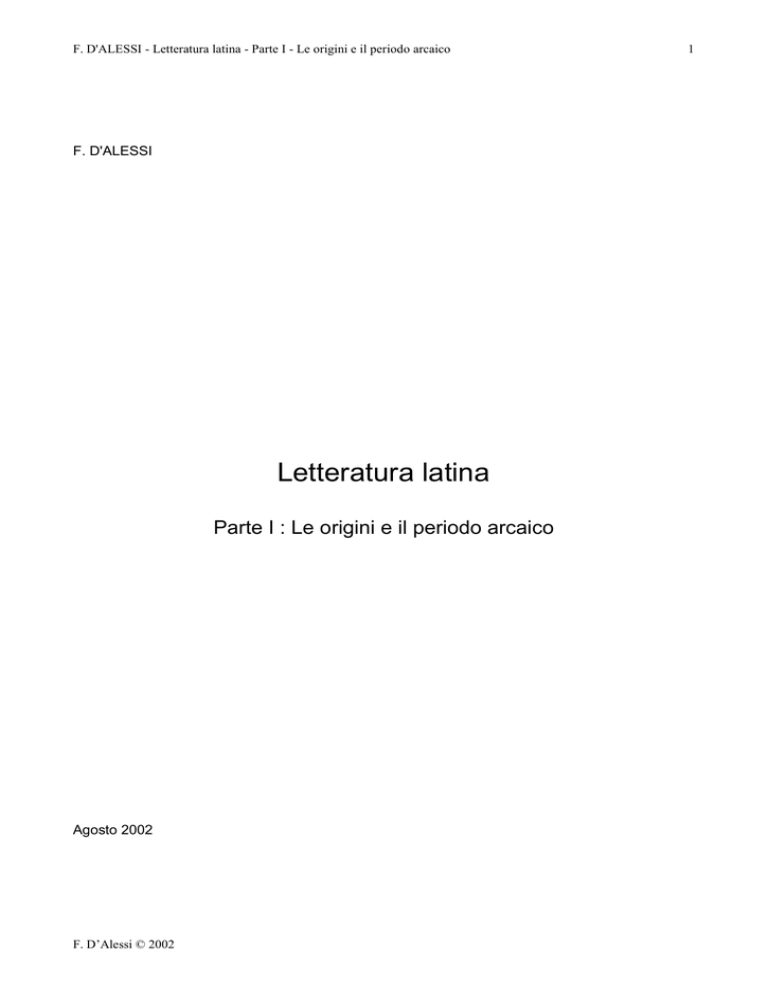
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
F. D'ALESSI
Letteratura latina
Parte I : Le origini e il periodo arcaico
Agosto 2002
F. D’Alessi © 2002
1
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
2
I - Le origini e il periodo arcaico
Il periodo delle origini
Quadro storico: dalla fondazione della città alla prima guerra punica
Origini - "leggende" e "storie" della Storia romana
(Da Erodoto, Storie, I, 94) - L'immigrazione dei Tirreni Lydi in Italia. I Lydi raccontano che essi mandarono
una colonia nella Tirrenia. Ecco, secondo come dicono, come andò il fatto:
Sotto il regno di Atys, figlio di Manes, tutta la Lydia fu afflitta da una grande carestia, che i Lydi sopportarono
per qualche tempo con pazienza. Ma, poiché durante diciotto anni il male, anziché diminuire, aumentava, il
re divise tutti i Lydi in due parti, delle quali fece tirare a sorte quale dovesse restare in patria e quale partire.
Quella che la sorte destinava a restare ebbe per capo il re stesso, l'altra che doveva emigrare, il figlio del re,
Tyrreno.
I Lydi che la sorte costringeva ad abbandonare la propria patria andarono dapprima a Smirne, dove
costruirono navi, sulle quali, dopo avervi caricata ogni sorta di mobili e cose utili, salparono in cerca di una
terra ospitale. Dopo avere toccati vari paesi, approdarono in Umbria, dove si costruirono delle città che
abitano oggi ancora. Senonché, là giunti, essi abbandonarono il nome di Lydi, per assumere quello di
Tyrreni, dal nome del loro capo, il principe Tyrreno".
(Da Strabone, libro V) - " I Romani chiamano i Tyrreni Etruschi o Tusci. I Greci hanno
dato loro questo nome di Tyrreni da Tyrreno, figlio di Atys, che condusse, a quanto si racconta, una colonia
di Lydi in quel paese.
Giacché il re Atys, essendo il paese afflitto da carestia, fece tirare a sorte quale dei suoi due figli dovesse
emigrare con una gran parte del popolo. Questa sorte toccò a Tyrreno, mentre il fratello Lydo, favorito dalla
sorte, rimase in patria col padre."
Le LEGGENDE relative alla fondazione di Roma
(Da Tito Livio, Istorie, I)
Presa Troia, si fece scempio di tutti gli altri Troiani, ma verso Enea non usarono i Greci alcun diritto della
vittoria, sia per ragion di antica ospitalità, sia perché aveva sempre consigliata la pace e la restituzione di
Elena. Pertanto Enea, scortato dal destino a dar principio a cose maggiori, dicono che prima calasse in
Macedonia; indi cercando dove stabilirsi, fosse balzato in Sicilia, e dalla Sicilia approdasse alle terre di
Laurentano. Sbarcati i Troiani e datisi a predare i campi come quelli cui null'altro restava dalla loro quasi
interminabile navigazione che le armi e le navi, il re Latino e gli Aborigeni, che tenevano allora quei luoghi,
accorsero armati dalla città e dal contado a respingere la violenza degli stranieri: alcuni dicono che, vinto in
battaglia, il re Latino stringesse pace, indi affinità con Enea; altri che, come si muovessero gli eserciti, e
prima che suonassero le trombe, si avanzasse il re Latino in mezzo ai suoi capitani e chiamasse a
parlamento il duce degli stranieri; indi, avendo chiesto chi mortali fossero mai, da dove e per quale ventura
erano partiti dalla loro patria; poi inteso che era gente troiana, che il capitano Enea, figlio di Anchise e di
Venere, e che, arsa la patria, andavano peregrinando, cercando dove restare e un sito dove fondarvi una
città, ammirando l'alta chiarezza della nazione e dell'eroe, pronto alla guerra del pari che alla pace,
porgendogli la destra, giurasse fede di futura amicizia. Quindi i due capi si strinsero in lega, gli eserciti si
salutarono. Enea fu accolto in casa dal re Latino, dove questi, davanti agli Dei Penati, aggiunse alla pubblica
la domestica alleanza, concedendogli in sposa la propria figlia. In seguito i Troiani costruirono una città che
Enea, dal nome della moglie, chiamò Lavinio.
Indi Turno, rè dei Rutuli, a cui era stata promessa Lavinia innanzi la venuta di Enea, mal soffrendo che gli
fosse preferito uno straniero, fece guerra a un tempo ad Enea ed a Latino. Nessuna parte uscì lieta da tale
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
3
conflitto. I Rutuli furono vinti, i Latini ed i Troiani, vincitori, vi perdettero il capo, Latino. Allora Turno e i Rutuli,
temendo per le cose loro, ricorsero alla potenza degli Etruschi, ch'erano in fiore ed al loro re Mesenzio; e
questi, che aveva la signoria di Cere, città a quei dì potentissima, sin da principio nulla contento della
fondazione della nuova città, vedendo che lo Stato troiano cresceva ormai troppo più che non si convenisse
alla sicurezza dei vicini, senza farsi pregare, alleò alle sue all'armi i Rutuli. Enea, per conciliarsi l'animo degli
aborigeni in mezzo al terrore di tanta guerra, e perché avessero tutti non solo uno stesso governo, ma un
nome stesso, chiamò Latini l'una e l'altra nazione, né di poi gli aborigeni cedettero ai Troiani in devozione e
fedeltà verso di Enea.
Egli, affidatosi a tali disposizioni dei due popoli, che ogni giorno si univano insieme, benché sì grande fosse
la potenza dell'Etruria, che aveva già empito di sua fama non solamente la terra, ma il mare ancora per tutta
la lunghezza d'Italia, dall'Alpi al mar di Sicilia, benché potesse dentro le mura ribattere il nemico, trasse fuori
l'esercito a battaglia.
Fu questa la seconda guerra dei Latini, e fu anche l'ultima opera mortale di Enea. Egli giace, comunque sia
giusto o lecito chiamarlo, in riva al fiume Numide, col nome di Giove Indigete.
Ascanio, figlio di Enea (e non si sa se della prima moglie di costui, Creusa, ovvero di Lavinia),
sovrabbondando già Lavinio di popolazione, lasciò alla madre, o matrigna che fosse, il possesso della città,
per quei tempi assai florida e doviziosa; egli ne fabbricò un'altra sulla costa del monte Albano, che, dal sito,
fu chiamata Albalunga, come quella che si stendeva lungo il declivio.
Dalla fondazione di Lavinio al trasporto della colonia in Alba passarono circa trent'anni; e nello stesso tempo
era cresciuta la potenza dei Latini, specialmente dopo la rotta degli Etruschi, che né alla morte di Enea, né
poi durante la tutela di una donna e la prima esperienza di un re giovanotto, osarono mai muovere in armi
contro di essi né Mesenzio con i suoi Etruschi, né alcun altro confinante.
Si era con la pace convenuto che il fiume Albula, oggi Tevere, fosse il confine fra gli Etruschi ed i Latini.
Dopo altri 10 re, tutti discendenti da Ascanio o Giulo regnò Proca, che generò NUMITORE ed AMULIO, e
lasciò a Numitore, maggiore di età, il regno. Riuscì peraltro più la violenza che le disposizioni del padre o il
riguardo all'età. Amulio, cacciò Numitore, usurpò il regno, e, aggiungendo delitto a delitto, uccise i figli
maschi del fratello; poi elesse a Vestale, sotto pretesto di onorarla, la figlia di lui Rea Silvia, e, la costrinse a
perpetua verginità, togliendo ad essa ogni possibilità di prole.
Ma era, io credo, ordinata dai fati l'origine di sì grande città, e il principio di un impero, dopo quello degli Dei,
il più possente.
La Vestale diede alla luce due gemelli, di cui ella disse padre il dio Marte. Ma né gli Dei, né gli uomini
sottrassero la madre e la prole alla crudeltà del tiranno Amulio; che fece prendere la sacerdotessa per
imprigionarla, e comandò che i due bambini fossero gettati nella corrente dei fiume Tevere.
Per fortunata sorte, e non senza consiglio divino, il Tevere in quei giorni, straripando, si era sparso in una
quieta laguna; non ci si poteva da alcuna parte avvicinare al vero letto e alla corrente del fiume, e quelli che
vi portavano i fanciulli credevano che si sarebbero potuti annegare anche là, dove l'acqua invece
languidamente stagnava. Così pensando di aver adempiuti gli ordini del re esposero i bambini nella gora più
vicina, dov' è ora il fico Ruminale, e se ne andarono
Erano quei luoghi a quel tempo vaste solitudini. Vuole la tradizione che, avendo l'acqua, nel ribassarsi,
lasciato in secco il canestro galleggiante, entro cui erano stati esposti i fanciulli, una lupa vagante, scesa dai
monti vicini, si accorgesse dei vagiti dei bimbi e porgesse loro in un modo mansueto le penzolanti
mammelle; così raccontò un pastore che li trovò in atto di lambirle con la bocca.
Dicono che il pastore avesse nome Faustolo e che li affidasse alla moglie Larenzia in modo da allevarli per
poi condurre le greggia, Così nati, così allevati, appena crebbero in età, pur non trascurando le stalle e i
pascoli, presero a cacciare per boschi montani, e quindi, acquistando vigore d'animo e di corpo, non solo
abbattevano le fiere, ma coraggiosi si gettavano sui ladroni carichi di preda e spartivano il bottino coi pastori;
e con essi, crescendo ogni giorno di più lo stuolo dei giovani, celebravano feste e giuochi.
Faustolo sin da principio aveva in testa che quella che stava allevando in casa fosse una prole reale; perché
sapeva che erano stati esposti due bambini per ordine del re, e il tempo, in cui li aveva raccolti, concordava
perfettamente con quell'ordine; ma era deciso a non rivelar la cosa prima del tempo, se non per favorevole
congiuntura o per necessità,
Questa occasione venne col fatto che Remo sotto l'imputazione di avere invaso le terre di Numitore fu
arrestato e consegnato a Numitore stesso, che tenne Remo in prigione. Ma udendo che erano gemelli,
confrontando l'età e la loro indole tutt'altro che volgare, fu toccato nell'animo dalla memoria dei nipoti fatti
uccidere dal fratello; cosicché venne al punto da riconoscere Remo.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
4
Ma ormai Romolo per liberare Remo, con i suoi giovani a una una data ora, piombò nella reggia. Dalla casa
di Numitore, con altra gente appostatavi, uscì Remo a sostenerlo e ammazzarono il re.
Numitore, nella prima confusione, gridando tutto intorno che i nemici erano dentro la città e che avevano
assalita la reggia, rivolse l'invito alla gioventù albana di difendere la rocca; e, poiché vide i due giovani che,
fatto il colpo, si congratulavano l'un l'altro, chiamato subito il popolo a parlamento, espose le crudeltà
usategli dal fratello, l'origine dei nipoti, come erano nati, come allevati, come riconosciuti, indi la uccisione
del tiranno, della quale si confessò di essere autore egli stesso.
Avanzatisi il gruppo di giovani in mezzo all'assemblea del popolo e salutato l'avolo re, si levò da ogni parte
un grido concorde che gli raffermò il titolo e la regia podestà.
Data così a Numitore la signoria di Alba, venne il desiderio a Romolo e a Remo di fondare e costruire una
città in quegli stessi luoghi, dov'erano stati esposti ed allevati. E già sovrabbondavano gli abitanti in Alba e
nelle altre città del Lazio, accresciuti da molti pastori; e tutti costoro facevano manifestamente prevedere che
Alba sarebbe stata piccola, e piccolo Lavinio a confronto della città che si sarebbe fondata. Ma si frappose a
tali disegni la passione avita della smania di avere un regno, e dopo un principio abbastanza tranquillo,
sorse tra i due fratelli una sciagurata contesa.
Poiché Romolo e Remo erano gemelli, né poteva il rispetto all'età far differenza, affinché gli Dei tutelari di
quei luoghi eleggessero con gli auguri quale di loro due dovesse dar nome alla nuova città, e, dopo averla
costruita, chi regnare su essa, Romolo scelse il Palatino, Remo l'Aventino, come luoghi da prendere gli
auspizi. Si narra che prima a Remo apparissero quale augurio sei avvoltoi, e che, dopo annunziato
l'auspizio, un doppio numero se ne mostrasse a Romolo; onde i rispettivi partigiani li avevano entrambi
salutati re, gli uni aggiudicando il regno a Remo favorito dal tempo, gli altri a Remolo favorito dal numero
degli uccelli.
Affrontatisi prima a parole per questa contesa, nel bollore della lite vennero alle mani e Remo nella mischia
cadde trafitto. È tradizione più comune che Remo deridendo il fratello a mo' di sfida varcasse d'un salto le
nuove mura, e che Romolo sdegnato del gesto arrogante l'uccidesse, aggiungendo anche queste
minacciose parole. "tal fine sia di ognuno chi d'ora in poi varcherà le mie mura".
Così Romolo solo fu padrone del regno, e la città costruita ebbe nome dal fondatore"
(Da Tito Livio, Istorie, I - trad. L. Mabil-T.Gironi, ed. Paravia)
Fonti:
ERODOTO, STORIE
STRABONE, STORIA ROMANA
TITO LIVIO, ISTORIE
CASSIO DIONE - STORIA ROMANA
+ BIBLIOTECA DELL'AUTORE
I PRIMI ANNI DELLA REPUBBLICA (510-495 a. C.)
LE NUOVE MAGISTRATURE - TENTATIVI DEI TARQUINI DI RECUPERARE IL REGNO - GUERRA
CONTRO PORSENNA - ORAZIO COCLITE - PACE CON GLI ETRUSCHI - GUERRE COI SABINI E LATINI
- LA BATTAGLIA DEL LAGO REGILLO - LA TRADIZIONE E LA CRITICA STORICA - LE ISTITUZIONI
-----------------------------------------------------------LE NUOVE MAGISTRATURE
La ricostruzione del periodo regio, da Romolo a Tarquinio il Superbo, anche se buona parte ce lo riferisce la
tradizione, non tutto deve essere posto tra le leggende, nè a queste, d'altra parte, si può non attribuire alcun
valore, adombrando parecchie di esse la verità storica.
Se di questo periodo noi vogliamo tentare una ricostruzione storica, molti avvenimenti citati dagli storici e
molte leggende dobbiamo sacrificare, ma gli uni e le altre ci saranno di grande aiuto perchè con i nomi, con i
simboli, con le personificazioni agevoleranno grandemente questa indagine.
Ci siamo affidati per la ricostruzione del periodo regio (le note sui SETTE RE DI ROMA) alla Istoria di Tito
Livio, che indubbiamente anche lui si è affidato alla tradizione.
La critica storica, spesso è stata spietata contro la tradizione romana, e ha perfino cercato di dimostrare che
i re di Roma non sono mai esistiti e che nessuno di essi ha un nome proprio, ma un appellativo, in relazione
con l'azione principale loro attribuita. E così Romolo significa romano, Numa il legislatore, Ostilio lo straniero,
Anco un ex servo, Tazio il rappresentante dei Tizii, Tarquinio perchè era di Tarquinia.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
5
I critici congetturano che gli antichi trovandosi di fronte a dei fatti compiuti di cui non sapevano spiegarsi
l'origine, quali la fondazione della città, gli ordinamenti religiosi, la tribù straniera dei Luceri (Etruschi?), e la
formazione della classe servile dei plebei, attribuiscono la paternità di ciascuno di questi fatti ad un individuo
immaginario, denominandolo dal fatto stesso (e se non inventati, amplificati in tempi tardi). Seguendo lo
stesso metodo di critica, i Tarquini rappresenterebbero due periodi in cui Roma ebbero il supremo potere
stirpi etrusche, e Servio quell'altro periodo durante il quale cominciarono ad essere riconosciuti ed affermati
certi diritti della plebe.
Messa in dubbio poi da quasi tutti i critici, è giudicata la cronologia dei sette regni dell'antica Roma, e molti
sono del parere che la fondazione dell'urbe sia da porsi in una data di molto anteriore a quella che la
tradizione ci ha lasciata.
Secondo la cronologia tradizionale difatti il periodo monarchico sarebbe durato 244 anni, spazio di tempo in
verità troppo breve per tante conquiste, tanti lavori, tante leggi e tanto progresso sociale.
Se si osservi che Roma ha un numero ragguardevole di abitanti e un territorio abbastanza vasto, che ha
templi e monumenti considerevoli, che ha distrutto Alba Longa, fiaccati parecchi nemici potenti e potuto
conseguire l'incontrastata supremazia su tutto il Lazio, che ha totalmente sviluppato il suo commercio
marittimo ed acquistata tanta rinomanza da stipulare un vantaggioso trattato con la potente Cartagine nei
primi anni della Repubblica, che le sue leggi e i suoi riti hanno un'organizzazione tutt'altro che rudimentale,
se si osservi infine il grado di maturità a cui è giunta la plebe, si deve convenire che tanto progresso non
poteva essere compiuto in soli due secoli e mezzo.
Di certo oggi sappiamo che il territorio in cui sorge Roma fu abitato in tempi molto antichi.
Ma è in questo oscuro periodo regio, che tutto induce a credere che gli Etruschi, nella loro tendenza di
espansione, riuscissero ad estendere il loro dominio o protettorato anche nel Lazio, o per lo meno a Roma,
importandovi le loro abitudini di gente raffinata, facilmente assimilate dai rozzi abitanti della città fluviale e dei
dintorni. Una popolazione primitiva divisa in tre tribù, corrispondenti a tre schiatte diverse: Ramni (Latini), Tizi
(Sabini) e Luceri (stranieri, Etruschi?).
Senonchè l'incremento della vita civile di Roma non valse a compensare i Romani della perdita
dell'autonomia; cosicchè, dopo vari tentativi fatti per scuotere il dominio straniero, vi riuscirono finalmente in
questo fatidico anno 510 a.C. in seguito ad un largo movimento di popolo, affiancato dai cittadini
appartenenti alle più ragguardevoli famiglie romane (un centinaio, legate fra loro da vincoli di parentela
(genti) che componevano ciascuna delle "tre" "tribù" (dal greco tris= tre e da "bhu"=essere (phy).
Queste ultime non vollero abdicare all'importanza acquistata nella lotta, rimettendo ad un "re" nazionale tutti i
poteri dello stato. Ma al re nominato non lasciarono che la suprema autorità religiosa, per cui quegli si
trasformò solo in un "Re delle cose sacre" (Rex sacrorum); laddove i poteri politici, che prima aspettavano
pure al re, furono affidati - come vedremo più avanti- a due magistrati elettivi, da rinnovarsi ogni anno (prima
detti pretori, più tardi consoli.
Con questi mutamenti politici, da questo anno 510 a. C., iniziamo ad avere più precisi riscontri storici.
Infatti siamo oggi in grado di elencare tutti i consoli succedutisi nei 578 anni.
E in parallelo, molti fatti non sono più leggende, ma veri eventi storici.
Il primo di questi eventi è, che cacciato TARQUINIO il "Superbo", ed abolita la monarchia, si stabilì di
affidare il potere dello Stato a due magistrati (pretori) che dovevano essere eletti ogni anno nei comizi
centuriati, e l'autorità religiosa affidata ad un magistrato chiamato "rex dacrificulus", che non poteva arringare
il popolo e non poteva coprire nessuna carica politica. Quest'ultimo magistrato doveva inoltre dipendere dal
pontefice massimo. Fu stabilito pure di affidare l'amministrazione dell'erario pubblico a due "qaestores
aerarii".
I primi a coprire la carica di "pretori", nome che poi fu mutato in quello di "consoli", furono i due protagonisti
della rivolta (che abbiamo letto nelle pagine di Tito Livio, nella storia dell'ultimo re di Roma, il suddetto
Tarquinio il "Superbo") cioè LUCIO GIUNIO BRUTO e LUCIO TARQUINIO COLLATINO (che sono appunto i
primi due consoli, che appaiono nel lungo, intero e preciso elenco nel link riportato sopra), i quali fecero
confermare dai comizi innanzitutto il bando contro la famiglia reale, e giurarono che non si sarebbe mai più
permesso il ritorno del regime monarchico.
Venne tuttavia ripristinata la Costituzione detta di Servio Tullio (il re fatto uccidere da Tarquinio).
Secondo le antiche leggende, fu questo re per primo che provvide ad inquadrare anche i plebei fra i cittadini
romani; sia allo scopo di accrescere le file dell'esercito, sia per interessarli alla cosa pubblica. Dovuto o no a
quel re, tale provvedimento fu il primo riconoscimento dell'importanza non solo numerica, ma anche
finanziaria, che ormai la plebe aveva acquistato in Roma.
Secondo tale riforma (una delle prime espressioni popolari della futura democrazia romana) che presenta
qualche affinità con quella greca di Solone, senza dubbio più antica, tutti i cittadini indistintamente furono
divisi, in base alle terre da essi possedute, in 5 classi. Ogni classe fu poi suddivisa in "centurie", cioè in
gruppi, ciascuno dei quali doveva, è da credere, fornire all'esercito un corpo di 100 soldati o "centuria";
senonchè, costituendo i soli cittadini della prima classe 98 centurie, mentre tutte le altre classi insieme non
ne formavano che 95, ne veniva di conseguenza che i ricchi, appartenenti alla prima classe, dovessero
molto spesso essere sotto le armi, laddove il servizio militare incombeva molto più rado man mano che dalla
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
6
prima si discendeva alla quinta classe; mentre i "proletari", cioè coloro che non possedevano nulla,
costituivano una sola centuria fuori classe.
Non solo il nome di centuria, ma anche quello di classe aveva un significato militare: perché classi erano
dette le diverse parti dell'esercito romano, a cui spettava una particolare armatura e modo di combattere:
così la 1a classe costituiva la cavalleria e la fanteria pesante, cioé la parte essenziale dell'esercito: la 2a, la
3a e la 4a tre diversi tipi di fanteria meno armata; la 5a era rappresentata dai lanciatori di proiettili, con fionde
od archi.
Donde si vede come la riforma di Servio Tullio fosse di carattere essenzialmente militare; allo stesso modo
che in origine dovette avere importanza pure esclusivamente militare la nuova assemblea detta dei "Comizi
centuriati", alla quale i Romani partecipavano ordinati per centurie, probabilmente solo in quanto erano sotto
le armi. Soltanto più tardi i Comizi centuriati acquisttarono un'importanza preponderante, mentre pochissima
ne veniva lasciata ai Comizi Curiati.
Poichè questa riforma serviana, mentre eguagliava per importanza i plebei ricchi ai patrizi, sia nell'esercito,
sia nei Comizi centuriati, manteneva però sempre l'esclusione di tutti i plebei, poveri o ricchi, dalle cariche
pubbliche, è naturale che essa non potesse soddisfare alle aspirazioni di una classe della cittadinanza
romana che, ormai numerosissima, godeva nella città di grandissima importanza finanziaria. (non
dimentichiamo che qualcosa del genere accadde poi anche nel 1300 (nelle lotte Comunali), e poi ancora alla
fine del 1700 (nella Rivoluzione Francese).
E fu per questo motivo, che fin dal primo anno della Repubblica, ci furono le lotte civile, protratte per oltre un
secolo, alimentate dalla volontà indomita dei plebei di conseguire assoluta eguaglianza di diritti rispetto a
coloro che si ritenevano i soli veri cittadini di Roma, e dall'ostinazione dei patrizi di non rinunciare
all'esclusivo godimento di quei diritti che li facevano padroni della città.
Abbiamo detto fin dal primo anno della Repubblica, perchè la caduta della monarchia fu un danno per i
plebei, dal momento che si era formata una Repubblica aristocratica e dei più ricchi (ma ex plebei - nel 1300
questi ultimi li chiameremo Ghibellini, e nel 1800 "borghesi").
Inoltre l'obbligo di partecipare alle guerre senza retribuzione e il fatto di stare lontani dai propri interessi per
lunghi periodi, aveva costretto i più poveri a contrarre dei debiti per mantenere se stessi e le famiglie. E i
debiti venivano puniti con pene gravissime, che arrivavano alla schiavitù e perfino alla morte. Ecco perchè i
plebei si organizzarono per resistere a queste prepotenze; e la loro agitazione aveva il fine di una
equiparazione politica e civile tra patriziato e plebe, e il fine economico di migliorare la condizioni dei più
diseredati. Vedremo più avanti (nel 494, con Agrippa, poi nel 449 con la legge delle XII tavole) quando i
plebei si organizzeranno per avere tribuni propri, la cui presenza (veto) impediva ai magistrati di votare leggi
contro di loro.
In questa prima repubblica, con il ripristino della costituzione serviana, fu portato a trecento il numero dei
senatori, che era stato ridotto dalle stragi di Tarquinio, e a questa carica furono innalzati oltre che i patrizi i
più influenti e i più ricchi tra i plebei che vennero chiamati "conscripti".
(anche nella Venezia del XV secolo, la chiusa casta del patriziato, accolse nel suo seno (alcuni con
disgusto) un certo numero di plebei diventati ricchissimi; e lo fecero solo perchè questi portavano nelle casse
della Serenissma tanti denari o erano disposti a fare alla stessa dei grossi prestiti)
Poco tempo dopo, BRUTO, sapendo che il popolo non vedeva di buon occhio COLLATINO, perchè parente
dello spodestato monarca, consigliò il collega a dimettersi dalla carica e poichè questi -che era un ottimo
cittadino ed un magistrato esemplare- temporeggiava, lo fece destituire dai comizi centuriati. Collatino lasciò
Roma e si recò a Laviruo e in sua vece venne eletto P. Valerio.
Frattanto TARQUINIO, non rassegnato alla sua sorte, tramava di ritornare sul trono e fingendo di chiedere la
restituzione dei suoi beni privati, mandò a Roma alcune persone di sua fiducia perchè organizzassero
presso i suoi aderenti dei gruppi armati o per preparare una congiura. Tutto questo non riuscì molto difficile:
parecchi maggiorenti di Roma si schierarono segretamente in favore del re, fra i quali gli stessi figli di Bruto e
due nipoti di Collatino, ma uno schiavo chiamato Vindicio rivelò la trama che si ordiva e i consoli
condannarono a morte i congiurati. Si narra che Giunio Bruto con grande fermezza d'animo, preponendo
l'amor di patria all'amore paterno, non abbia esitato a firmare la sentenza contro i propri figli ed abbia
assistito con freddezza alla esecuzione della pena capitale.
I beni privati di Tarquinio, che lui reclamava, furono dal Senato distribuiti alla plebe, e l'agro tra il Tevere e il
Campidoglio fu consacrato a Marte, e sotto il nome di Campo Marzio, fu adibito a luogo di riunione dei
comizi centuriati. Tutto ciò non fece che acuire in Tarquinio il desiderio di ricuperare il trono. Non essendogli
riuscita la congiura, ricorse per aiuti alle città Veio e Tarquinia, e, ricevute un contingente di soldati, marciò
contro Roma.
Alla notizia che lo spodestato re si avvicinava alla testa di un esercito, le milizie romane uscirono ad
incontrarlo. I fanti li comandava il console GIUNIO BRUTO, e i cavalieri P. VALERIO. Venuti a contatto i due
eserciti, Bruto si scagliò contro ARUNTE, figlio di Tarquinio, che guidava i cavalieri Tarquiniesi e Vejenti. In
questo primo assalto, entrambi persero la vita.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
7
Accesasi poi con violenza inaudita la battaglia, questa durò per tutta la giornata con sorte incerta. Durante la
notte - come narra la tradizione - dalla selva Arsia si fece udire la voce del dio Silvano, che affermava che la
vittoria era dei Romani, e i nemici, impauriti, lasciarono il campo e fecero ritorno in Etruria.
Il corpo di Bruto fu trasportato a Roma dove fu sepolto dopo solenni cerimonie funebri. Valerio tessé l'elogio
del collega e le matrone romane si vestirono di gramaglie per un anno.
Morto Bruto, si tardò qualche tempo a nominare il successore, e poiché Valerio aveva cominciato a costruirsi
una casa sul Velia, accanto alla reggia di Tullo Ostilio, sorse nel popolo il sospetto che il console aveva in
mente di divenire ora lui il padrone della città; ma Valerio, venuto a conoscenza delle dicerie, fece demolire
la nuova casa, ordinò la costruzione di un'altra dimora alle falde del Velia e, fatte approvare dai comizi
centuriati due leggi che poi presero il nome di "valerie"; in una vi si stabiliva di mettere al bando tutti coloro
che volevanoo ripristinare il regime monarchico, confiscandone i beni; nell'altra di permettere ai condannati a
morte ed alla flagellazione di appellarsi al tribunale del popolo; leggi che valsero a Valerio l'appellativo di
"Poplicola"; poi si procedette all'elezione del nuovo console. Risultò eletto SPURIO LUCREZIO, ma essendo
molto vecchio, morì poco tempo dopo. Gli successe M. ORAZIO PULVILLO.
GUERRA CONTRO PORSENNA
TARQUINIO il SUPERBO intanto, avuta ospitalità da PORSENNA, re di Chiusi, aveva ottenuto che il
sovrano etrusco prendesse le armi contro i Romani aiutandolo a ricuperare il trono.
Correva l'anno 508 a. C., quando Porsenna con un fortissimo esercito giunse presso Roma. I Romani
atterriti dalle imponenti forze degli Etruschi, non osarono uscire per attaccarle in aperta campagna.
Il nemico ordinò che Roma fosse vigorosamente investita e una forte schiera etrusca, dato l'assalto al
Gianicolo, conquistò la cima sbaragliando la debole guarnigione; poi, esaltata dal successo, fece un attacco
verso il Ponte Sublicio.
L'eroismo di un uomo però salvò Roma dall'invasione. ORAZIO COCLITE, insieme a SPURIO LARZIO e
TITO ERMINIO; coraggiosamente affrontarono il nemico, il quale inutilmente si accaniva per aprirsi il passo
difeso dai tre impavidi soldati con le aste e gli scudi. Intanto, all'altra estremità, i Romani lavoravano con lena
a distruggere il ponte.
Rimandati indietro i due compagni, Coclite rimase solo contro l'orda sempre più crescente degli Etruschi,
infine, quando si accorse che il ponte stava per rovinare, innalzata al dio Tiberino una breve invocazione, si
lanciò armato nelle acque del Tevere, nello stesso istante che crollava fragorosamente il ponte di legno; ma
lui a nuoto fra un nugolo di frecce nemiche, giunse miracolosamente all'altra sponda accolto trionfalmente
dai Romani.
La città fu grata all'eroismo di Orazio Coclite, il quale come premio ricevette in dono tanta terra quanta in un
giorno poteva esser circondata dall'aratro. All'eroe poi fu eretta sul Comizio una statua.
A quel punto Porsenna, decise di prender per fame la città e pose l'assedio, che non fu breve.
I viveri scarseggiavano a Roma e la prepotenza degli Etruschi era tale che il bestiame si era dovuto ripararlo
dentro le mura. Ma il console Publio Valerio volle dare una dura lezione al nemico ed ordinò ai suoi di
mandar fuori tutto il bestiame dalla porta Esquilina; poi fece uscire TITO ERMINIO con un manipolo di soldati
con l'ordine che si ponesse in agguato sulla via Gabinia, a due miglia di distanza, ed appostò SPURIO
LARZIO alla porta Collina con un gruppo di giovani armati alla leggera.
Il console Lucrezio con una schiera uscì dalla porta Nevia e Valerio scese dal Celio con alcune squadre di
soldati scelti.
Saputo il nemico, da alcune spie, che il bestiame doveva uscire dalla porta Esquilina, mandò da quella parte,
oltre il Tevere, una numeroso gruppo di predatori, che però caddero nella trappola preparata da Valerio.
Difatti, mentre gli Etruschi erano alle prese con le forze di Lucrezio, Tito Erminio li assalì con i suoi alle
spalle, e i nemici, stretti anche dai Romani usciti da porta Nevia e porta Collina, furono fatti a pezzi.
Questo successo rianimò i Romani, ma la carestia si faceva di giorno in giorno più grave. Allora un giovane
e valoroso patrizio, chiamato CAJO MUZIO, concepì l'arduo disegno di uccidere PORSENNA allo scopo di
liberare la città dall'assedio e, fingendosi disertore, ottenuta licenza dal Senato, nascosto un pugnale sotto la
veste, penetrò nel campo nemico e si spinse fino alla tenda del re. Era giorno di paga e Porsenna sedeva
accanto ad un suo funzionario che, come il re, indossava magnifiche vesti. Non sapendo chi dei due fosse il
sovrano e non parendogli opportuno chiederlo ai soldati che si affollavano intorno al seggio reale, Cajo
Muzio vibrò il colpo uccidendo il funzionario e, fattosi largo tra la calca con il pugnale insanguinato nella
destra, tentò di mettersi in salvo; ma, arrestato dalle guardie del re, fu condotto alla presenza di Porsenna e,
interrogato, sprezzantemente rispose che era cittadino romano, che non temeva di affrontare la morte e che
se a lui era fallito, per sbaglio, il colpo, vi erano molti altri Romani che l'avrebbero ritentato.
Infiammato di sdegno, Porsenna ordinò che il prigioniero fosse torturato perché rivelasse le trame ordite a
Roma contro la persona del re. Muzio allora, avvicinandosi ad un braciere, acceso per i sacrifici, esclamò:
"guarda, e sappi come i Romani disprezzano la vita", detto questo, stese la destra sulle fiamme come per
punirla dell'errore.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
8
Sbalordito Porsenna da tanto eroismo, ordinò che il giovane fosse rimandato incolume a Roma; e Muzio che poi fu chiamato "SCEVOLA" cioè "mancino", per ricambiare la generosità del re, gli disse: "Poiché sai
rendere onore alla virtù spontaneamente e per riconoscenza, ti svelerò quello che da me con le minacce non
avresti saputo. Trecento giovani di Roma hanno giurato di ucciderti. La sorte ha voluto che io fossi il primo a
tentare il colpo, fallito, ma gli altri ritenteranno".
Muzio fece ritorno a Roma, e la patria in premio gli regalò un pezzo di terra che poi da lui prese il nome di
"Mucia prata".
Spaventato PORSENNA dalle rivelazioni di Cajo Muzio, iniziò con Roma trattative di pace e prima cercò di
ottenere che fosse rimesso TARQUINIO sul trono poi, non essendoci riuscito, pose come condizione che ai
Vejenti fossero restituiti i "sette pagi" e che a lui, per lo sgombero del Gianicolo, fossero consegnati venti
ostaggi, dieci giovanetti e dieci donzelle, scelti fra le famiglie più cospicue. Fra le fanciulle ce n'era una
chiamata Clelia, la quale, essendo il campo etrusco non lontano dal Tevere, alla testa delle sue compagne,
riuscendo ad evitare con l'astuzia la vigilanza delle sentinelle, riuscirono a fuggire, ad attraversare il fiume a
nuoto, giungere Roma.
Porsenna reclamò presso i Romani e, perché la pace non fosse rotta, questi furono costretti a rimandare le
dieci donzelle.
Ma il re di Chiusi non era rimasto insensibile all'audacia di Clelia. Fattala venire davanti a sé, le ridiede la
libertà e, in più, le concesse di portarsi via alcuni degli ostaggi.
Si dice che la giovinetta scelse tutte le fanciulle minori di quattordici anni.
L'eroismo di Clelia non rimase senza premio: infatti, Roma decretò che in onore di lei fosse innalzata
all'inizio della Via Sacra una statua equestre.
Conclusa così la pace e rientrato in Etruria, Porsenna, perché non sembrasse di aver levato invano in arme
l'esercito, mandò il figlio Arunte con alcune schiere contro Aricia, fiorente città del Lazio, la quale, non
potendo con le sole sue forze opporsi agli Etruschi domandò aiuti a città vicine ed amiche. Mandarono dei
soccorsi Anzio, Tuscolo e Cuma, e gli Aricini, resi baldanzosi dai rinforzi, uscirono dalle mura ed attaccarono
gli Etruschi.
Questi però riuscirono a scompaginare gli assalitori, ed avrebbero ottenuta una vittoria decisiva se
ARISTODEMO, re di Cuma, non fosse giunto a tempo alle spalle del nemico, che, affrontato e messo in
fuga, nell'inseguimento fu quasi completamente distrutto.
Pochi Etruschi scamparono all'eccidio rifugiandosi inermi a Roma, che li accolse ospitalmente e, dopo aver
curato i feriti, rimandò in Etruria quelli che vollero tornare in patria e a quelli che vollero rimanere diede come
sede un quartiere che poi fu chiamato "Vico Tosco". Porsenna, per ricambiare l'atto amichevole dei Romani,
rimandò liberi i rimanenti ostaggi e restituì a Roma i "sette pagi".
LA BATTAGLIA DEL LAGO REGILLO
Conclusa la pace tra Porsenna e Roma, Tarquinio si rivolse al suo genero OTTAVIO MAMILIO, signore di
Tuscolo, affinché convincesse altre città del Lazio a muover guerra ai Romani per ripristinare la monarchia.
Mamilio accolse volentieri le richieste del suocero ed iniziò alcuni approcci con le città della lega la quale per
ben tre volte inviarono i loro rappresentanti nella Selva Ferentina per prendere gli opportuni accordi.
Finalmente fu dichiarata la guerra a Roma, ma non iniziarono subito le azioni belliche, anzi si lasciarono
trascorrere due anni forse in preparativi, forse anche perché tra l'una e le altre città latine la concordia non
era completa.
Era morto, nell'anno 502 a. C., VALERIO POPLICOLA, console quattro volte, al quale, erano stati fatti
solenni funerali a spese dello Stato e Roma in quel tempo aveva accolto nelle sue mura un importante
personaggio Sabino di Regillo, APPIO CLAUDIO, il quale essendo un sostenitore della pace con i Romani,
sopraffatto da quelli che volevano invece la guerra, era andato a stabilirsi con cinquemila uomini a Roma.
Appio Claudio era stato fatto patrizio e senatore e ai suoi uomini era stata accordata la cittadinanza romana
e della terra oltre l'Aniene.
I Romani approfittarono dell' indugiare dei Latini, ai quali Tarquinio si era rivolto, e mossero contro i Sabini.
Essendosi le colonie romane di Pomezia e Cora date agli Aurunci, i Romani - consoli MENENIO AGRIPPA e
PUBLIO POSTUMIO - sconfissero sanguinosamente un esercito di Aurunci; poi, guidati dai nuovi consoli
OPITERO VIRGINIO e SPURIO CASSIO, avanzarono contro Pomezia una prima volta con risultato infelice
ma nella seconda ottennero ciò che volevano. Arresasi Pomezia, la città fu distrutta.
L'anno seguente, sotto il consolato di POSTUMIO COMINIO e TITO LARZIO, verificatosi una rivolta a
Roma, fu istituita la "dittatura" e Tito Larzio fu il primo ad essere investito di questa carica straordinaria.
Assediata più tardi Fidena e presa Crustumerio, i Romani non aspettarono che i Latini iniziassero le
operazioni di guerra e con un forte esercito si mossero contro di loro.
Era dittatore AULO POSTUMIO e maestro della cavalleria TITO EBUZIO. I due eserciti si scontrarono correva l'anno 258 (498 a.C.) - presso il Lago Regillo, nel contado tuscolano, e la battaglia che ne seguì fu
violentissima. Tarquinio il Superbo si trovò di fronte a Postumio e, ferito, fu dai suoi condotto indietro;
EBUZIO sostenne un combattimento contro MAMILIO ed entrambi rimasero feriti, l'uno al braccio, l'altro al
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
9
petto, e dovettero ritirarsi nelle seconde linee. Ma ben presto Mamilio ritornò nella mischia guidando, insieme
con il figlio di Tarquinio, la schiera dei fuorusciti romani.
Contro di questi mosse MARCO VALERIO, fratello di Poplicola, ma inoltratosi nelle file dei nemici e
circondato da tutte le parti, rimase vittima sul campo.
Si verificò allora fra i Romani un momento di esitazione che sarebbe riuscito fatale se il dittatore con la sua
coorte non avesse dato addosso al fuorusciti sgominandoli. Corse al riparo con truppe fresche MAMILIO,
che, riconosciuto da TITO ERMINIO, fu da questo risolutamente assalito ed ucciso.
Anche Erminio però ci lasciò la vita, perché, ferito da un dardo mentre spogliava il vinto, spirò mentre gli
veniva medicata la ferita.
La fanteria romana era stanca dal lungo combattere. Il dittatore allora pregò i cavalieri che smontassero e
rinforzassero a piedi la battaglia. Ed ecco i cavalieri saltar di sella e correre in prima linea, e i fanti, stanchi,
riprender lena, nuovamente a osare e ributtare il nemico, mentre i cavalieri, rimontati a cavallo, inseguivano i
fuggiaschi.
Cruda, ma completa fu la vittoria. Si narra che, quando la mischia pendeva incerta, Postumio fece voto ai
Dioscuri di edificar in loro onore un tempio; e in quel momento furono visti due giovani sconosciuti guerrieri,
montati su bianchi cavalli, combattere valorosamente nelle prime file dei Romani, poi, volgendo la battaglia
al termine, abbandonare il campo. Erano - narra la leggenda- i Dioscuri, i quali erano corsi a Roma a portar
la notizia della sconfitta nemica e, lavati i cavalli alla fonte Giuturna, si erano poi allontanati, né furono più
visti.
Postumio sciolse il voto, innalzando a CASTORE e POLLUCE un tempio presso la fonte Giuturna.
Mentre lo sconfitto Tarquinio ottenne ospitalità a Cuma dal tiranno Aristodemo e qui finì i suoi giorni si narra,
molto vecchio.
LA TRADIZIONE E LA CRITICA STORICA
Come accennato all'inizio, riguardo alle leggende, non occorre molto acume per accorgersi del carattere
leggendario dei fatti sopra narrati, i quali, oltre essere dagli antichi storici raccontati in modo diverso e
contraddittorio, non reggono ad un esame rigorosamente critico e mostrano le incongruenze, gli errori, le
illogicità, le contraddizioni di cui sono pieni questi fatti.
Gli avvenimenti di questo periodo della storia romana dovettero svolgersi molto diversamente da come ci
sono riferiti dalla tradizione.
Perplessità innanzitutto il movente della rivolta che abbatté la monarchia, non possiamo ammettere cioè che
sia la plebe che, perseguitata da Tarquinio, si ribelli perché il Superbo risulta invece amico dei plebei.
Dobbiamo piuttosto pensare ad una congiura di patrizi, che non vedono di buon occhio il potere accentrato
nelle mani di Tarquinio. Né possiamo ammettere che la cacciata di Tarquinio sia avvenuta per unanime
volontà dei Romani; infatti abbiamo visto molti dei fuorusciti che militano a favore del sovrano spodestato e
una congiura per rimetterlo sul trono è tramata dagli stessi poco tempo dopo l'abolizione della monarchia.
E poiché alla testa della rivolta contro Tarquinio, la tradizione mette BRUTO e COLLATINO, due parenti del
re, non è illogico ed arbitrario supporre che causa dei fatti non fu la volontà di porre termine al regime
monarchico, ma semmai per una profonda discordia prodottasi nella casa dei Tarquini (e sopra abbiamo
visto che gli stessi figli e nipoti dei due che hanno spodestato Tarquinio, sono a fianco del re.
Espulso il Superbo, noi troviamo al potere Bruto e Collatino e in questo fatto si legge chiaramente il trionfo di
uno dei rami della famiglia regnante.
Successivi dissensi sorti tra Giunio Bruto e Collatino giustificano la deposizione di quest'ultimo, che può
anche ascriversi al desiderio dei patrizi di liberarsi completamente dei membri della famiglia regia.
Il passaggio dal vecchio al nuovo regime è, secondo la critica storica, graduale. S'inizia con un colpo di
mano, ben riuscito, del ramo cadetto della casa regnante, continua con la deposizione di questo ramo
operata dal patriziato, prosegue con il sopravvento sugli altri patrizi della famiglia dei Valerii e col tentativo di
Publio Valerio di consolidare il suo primato e finalmente si risolve nella regolare rotazione dei consoli e degli
altri magistrati.
Anche le vittorie dei Romani sugli Etruschi e sui Latini la critica le ha messe nel numero delle leggende.
Secondo i critici, gli episodi di Orazio Coclite, di Muzio Scevola e di Clelia non sarebbero che romanzo
inventato dagli storici per nascondere la realtà. E la realtà dovette essere ben diversa. Ecco come gli storici
ricostruiscono gli avvenimenti.
Alcuni anni dopo l'abolizione della monarchia a Roma, avvenne un'invasione di Celti nell' Etruria e gli
Etruschi premuti dal nord, cercarono compensi territoriali nell' Italia centrale e meridionale. Con numerose
milizie, sotto la guida di un re o di un dittatore, s'avviarono verso il Lazio, assediarono e sottomisero Roma,
poi scesero verso la Campania; ma ad Aricia soccombettero in una battaglia campale.
Conseguenza della prime vittorie degli Etruschi sui Romani sono - secondo i critici - la guerra o meglio la
ribellione dei Latini contro Roma. Le città della lega, infatti, colgono l'occasione della sconfitta della loro
rivale Roma per liberarsi dal suo dominio, ma non vi riescono per i rovesci subiti dagli Etruschi e per il
conseguente risollevarsi delle sorti ad Aricia.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
10
LE ISTITUZIONI
Se la storia romana di questo periodo è molto oscura ed incerta per quanto si riferisce alle imprese di guerra
e all'avvenuto mutamento di regime, molto esaurienti e chiare invece sono le notizie che abbiamo sulle
riforme politiche e sulle istituzioni. Che di quanto già detto all'inizio- riepiloghiamo
La suprema autorità politica dello Stato passa dal re a due magistrati che durano in carica un anno ed hanno
eguali poteri. All'inizio essi prendono il nome di pretori, più tardi vengono designati col nome di consoli e il
primitivo nome viene dato, in seguito, al magistrato rivestito della podestà giudiziaria. Nei primi tempi della
repubblica i consoli detengono tutti i poteri che aveva il re, salvo il religioso di cui invece è investito un
sacerdote denominato rex sacrificulus o rex sacrorum.
I consoli vengono eletti nei comizi centuriati e confermati dalle curie e siccome la maggioranza dei voti è
assicurata ai patrizi, così loro soltanto sono gli arbitri delle elezioni consolari.
Altra magistratura importante è la dittatura. Discordi sono gli storici sulla sua origine e sulle cause di una tale
istituzione. LIVIO pensa che sia stata provocata dal pericolo delle guerre e dalla scarsa fiducia che i Romani
avevano dei consoli; DIONISIO invece ritiene che la dittatura sia stata istituita per vincere la riluttanza della
plebe al servizio militare.
Probabilmente la "dittatura" è comunque la prima carica creata dopo l'abolizione della monarchia, in
sostituzione della potestà regia. Abolita in seguito alla creazione dei consoli, viene più tardi ripristinata nei
momenti più delicati della vita dello Stato sia per tenere a freno la plebe sia per dare unità di comando alle
complesse azioni militari.
Ma come nell'elezione dei consoli anche di quella del dittatore sono arbitri i patrizi. Infatti, è il Senato che
designa il personaggio da eleggersi e dà mandato ad uno dei consoli di conferire la carica al designato, il
quale assume pieni poteri per sei mesi ed è coadiuvato e nel medesimo tempo tenuto d'occhio dal "magister
equitum" (capo della cavalleria) scelto fra i patrizi più influenti.
All'amministrazione del tesoro pubblico sono preposti i "questori dell'erario" e alla giustizia i "questori
criminali".
Del Senato sappiamo che, abolita la monarchia che lo aveva ridotto di numero, è ricondotto al numero di
300, ed accoglie nel suo seno alcuni elementi scelti fra la plebe. Anche ora, come al tempo dei re, il Senato
rappresenta un'assemblea consultiva; esso è convocato dai consoli e da esso presieduto però si limita a
discutere le proposte dei consoli. Ma la sua inferiorità rispetto ai consoli è più formale che sostanziale. I
consoli, infatti, durano in carica un anno, e la loro autorità può essere pure ridotta dal "veto" di uno di loro e
dalla nomina di un dittatore, mentre i senatori rappresentano un corpo vitalizio che ha un numero imponente
di membri e dietro di sé un numero non meno imponente di famiglie, di genti, di clienti, e nello stesso tempo
può infirmare l'autorità consolare, avendo diritto di esaminarne le proposte prima che siano portate davanti ai
comizi.
Questi, infine, non sono un'istituzione nuova, ma la loro funzione acquista sviluppi ed importanza nei primi
tempi della repubblica.
I comizi centuriati eleggono i magistrati, confermano i trattati di pace, funzionano da suprema corte d'appello
nei processi capitali ed hanno il potere legislativo. E se non possono proporre delle leggi - il che limita
grandemente la loro funzione - possono però respingere le proposte fatte dai consoli. Ma anche questa
prerogativa ha la sua limitazione, perché le deliberazioni dei comizi centuriati non sono valide se non dopo la
sanzione delle curie, le quali è un organo esclusivamente composto di patrizi, investito della funzione
delicatissima della sanzione che lo mette al di sopra di ogni altro organo politico dello Stato.
Da tutto quel che si è detto sopra, risulta chiaramente il carattere oligarchico della repubblica romana. Difatti
il potere è nelle mani del Senato e delle Curie, cioè nelle mani dei patrizi, essendo il primo formato in
maggioranza di patrizi e il secondo esclusivamente solo di questi.
Partecipa, è vero, anche la plebe al governo dello Stato, ma la sua partecipazione non ha alcun'importanza
e non può arrecare benefici a se stessa. Da questa condizione d'inferiorità del ceto plebeo (che ricordiamo
non è solo formato da poveri, ma anche da ricchi artigiani, commercianti ecc.) e dalla sempre crescente
potenza del patriziato nasceranno presto quei dissidi d'indole economica e politica che causeranno aspre
lotte per mezzo delle quali si giungerà a quell'equilibrio che doveva essere il coefficiente fondamentale della
potenza romana.
Questi primi dissidi, poi sfociati in aperte ribellioni, iniziano quasi subito; e di queste lotte parleremo appunto
nel prossimo capitolo periodo dall'anno 495 al 454 > > >
Fonti, Bibliografia, Testi, Citazioni:
TITO LIVIO - STORIE (ab Urbe condita)
APPIANO - BELL. CIV. STORIA ROMANA
DIONE CASSIO - STORIA ROMANA
PAOLO GIUDICI - STORIA D'ITALIA
UTET - CRONOLOGIA UNIVERSALE
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
11
I. CAZZANIGA , ST. LETT. LATINA,
+ altri, in Biblioteca dell'Autore
LE LOTTE FRA IL PATRIZIATO E LA PLEBE - LE LEGGI (495-454 a. C.).
PRIMI TUMULTI DELLA PLEBE - GUERRE CONTRO I VOLSCI E I SABINI - APPIO CLAUDIO - VALERIO
DITTATORE - LA PLEBE SUL MONTE SACRO - MENENIO AGRIPPA - ISTITUZIONE DEL TRIBUNATO
DELLA PLEBE - TRATTATO CON I LATINI - GUERRA CONTRO I VOLSCI E CARESTIA. - LA LEGGENDA
DI CORIOLANO - SPURIO CASSIO E LA LEGGE AGRARIA - I FABII - LA LEGGE PUBLILIA - LA LEGGE
TERENTILIA - CINCINNATO - LA LEGGE ICILIA - LA LEGGE TARPEJA-ATERNIA
------------------------------------------------------------Poiché con la Repubblica, si era ripristinata la riforma serviana, che manteneva sempre l'esclusione di tutti i
plebei, poveri o ricchi, dalle cariche pubbliche, è naturale che essa non riuscisse a soddisfare le aspirazioni
di una classe della cittadinanza romana che, ormai rilevante non solo numericamente, aveva una
grandissima importanza finanziaria. Mentre i patrizi né lavoravano, né operavano nel commercio; entrambe
le due attività erano considerate disonorevoli e volgari.
Infatti, i primi dissidi tra patrizi e plebei furono causati da interessi economici.
Tristissime erano le condizioni in cui versavano i plebei nei primi tempi della repubblica. Gravati di tributi,
distratti dal lavoro per le continue guerre che lo Stato sosteneva contro i nemici esterni, ben presto essi
furono costretti a contrarre prestiti con i patrizi, i quali volentieri, allo scopo di ridurre in servitù la plebe, si
servivano delle leggi inumane che al creditore davano diritto di considerare come schiavo il debitore che non
pagava.
E non soltanto il capo della famiglia, ma tutta la famiglia del debitore cadeva in temporanea schiavitù,
durante la quale il trattamento subito era ciò che di più duro si possa immaginare. Erano caricati di catene,
chiusi nei sotterranei e addetti a fatiche insopportabili cui si aggiungeva la fustigazione.
Questo stato di cose non poteva certamente durare a lungo e doveva fatalmente causare un malcontento
che alla fine produsse aperte ribellioni.
Un giorno dell'anno 259 (459 a. C.), - come c'informa la tradizione - mentre il popolo si trovava radunato nel
foro, comparve un vecchio centurione. Il petto lo aveva pieno di cicatrici che attestavano il suo valore come
guerriero, ma nel dorso portava i segni d'orribili frustate. Raccontò con le lacrime agli occhi che in molte
battaglie aveva versato il suo sangue per la salvezza di Roma, ma che da un patrizio di cui era debitore era
stato fatto schiavo e orribilmente maltrattato. Al racconto del vecchio guerriero arse di sdegno la plebe e,
tumultuando, chiese ai consoli che convocassero il Senato per alleviare con nuove leggi le condizioni dei
plebei.
Era il Senato radunato quando giunse improvvisamente l'annunzio che un forte esercito di Volsci marciava
contro Roma.
La notizia sgomentò i senatori; al contrario la plebe era lieta vedendo nel nemico la vendetta degli dei, e
diceva di non voler brandire le armi in difesa della città e che si lasciassero ai superbi patrizi la cura e i
pericoli della guerra.
Ma la Curia e il Senato, temendo sia i nemici sia la plebe, si raccomandarono al console SERVILIO, un
magistrato che godeva il favore del popolo; il console, abbandonato il Senato, uscì a parlamentare con i
plebei e disse loro che i senatori erano ben disposti a favorire il popolo, ma che prima d'ogni altra cosa si
doveva pensare a difendere la patria dal nemico, indi pubblicò un editto con il quale si ordinava che tutti i
plebei che volevano iscriversi nell'esercito e che per debiti si trovavano in carcere fossero subito posti in
libertà e che, durante il servizio militare, non fossero occupati o venduti i beni dei debitori né trattenuti in
garanzia i loro figli e nipoti.
Pubblicato l'editto, un gran numero i plebei, specialmente i debitori, corsero ad arruolarsi e in breve fu
radunato un fortissimo esercito, che, sotto il comando dello stesso console, uscì dalla città e andò ad
accamparsi vicino ai nemici. Questi, cui era giunta la notizia della discordia sorta nella cittadinanza romana,
durante la notte cercarono di far passare nelle proprie file una buona parte dei soldati avversari, ma, dato
l'allarme, il tentativo dei Volsci fallì. Spuntato il giorno, i Volsci diedero l'assalto al campo romano, ma ebbero
la peggio, perché i Romani ingaggiarono la lotta con grande determinazione e ributtarono i nemici, che si
rifugiarono nel proprio accampamento; ma anche di là furono scacciati dalle truppe di Servilio, che, messo a
sacco e bruciato il campo avversario, inseguì i Volsci fino a Suessa Pomezia che in pochi giorni fu
espugnata e saccheggiata.
Era appena Servilio ritornato a Roma carico di bottino quando fu portato l'annunzio che i Sabini erano giunti
fino all'Aniene e depredavano il territorio romano. Furono allora riprese le armi e contro il nemico fu inviato
AULO POSTUMIO con la cavalleria e SERVILIO con un buon contingente di fanti. Sorpresi i Sabini durante
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
12
la notte sparsi per le ville e ubriachi, furono facilmente sbaragliati. Pochi giorni dopo, avendo gli Aurunci
dichiarato guerra ai Romani, questi, senza perder tempo, andarono contro il nuovo nemico e, dopo averlo
incontrato nei pressi d'Aricia, lo sconfissero.
Speravano i plebei, che tanto si erano segnalati in queste guerre, nella gratitudine del Senato ed
aspettavano che il console mantenesse fede alle sue promesse.
Ma uno dei consoli, APPIO CLAUDIO, uomo superbo e crudele, invidioso del favore che presso il popolo
godeva il collega, rimandò in prigione i debitori. Invano questi si appellavano a SERVILIO, ricordandogli le
promesse ricevute e i servigi resi in guerra. Il buon console, pur commuovendosi, temporeggiava,
tergivisava, non osava schierarsi apertamente contro Appio Claudio e il patriziato. Così facendo, Servilio non
s'ingraziò i patrizi, dai quali era considerato ambizioso e di poca energia, ma si acquistò solo l'odio della
plebe come l'uomo che non aveva mantenuto le promesse.
Il contegno dei consoli e del Senato inasprì talmente i plebei che questi ricominciarono a tumultuare e non
prestarono più obbedienza ai decreti. Al grave malcontento della plebe si aggiunse la minaccia di una guerra
da parte dei Sabini e solo allora si capì dalle autorità la gravità della situazione perché nessuno dei plebei
rispose alla chiamata alle armi.
Cominciava intanto l'anno 494 a. C. Furono eletti consoli VIRGINIO e VETURIO, i quali cercarono di salvare
la situazione chiamando il popolo alle armi. Nuovo rifiuto da parte dei plebei, che ora, preso animo, si
radunavano sull'Aventino e sull'Esquilino e con fare minaccioso gremivano il foro.
I nuovi consoli convocarono il Senato, dove molte furono le proposte sui provvedimenti da prendere; ma su
tutte prevalse quella di Appio Claudio di nominare un dittatore.
A questa suprema carica fu assunto VALERIO, fratello del Poplicola, il quale, allo scopo di tenere a freno la
plebe e di prepararsi contro i Volsci, gli Equi ed i Sabini che si preparavano alla guerra, pubblicò un editto
simile a quello di Servilio e chiamò quindi i cittadini alle armi. I plebei vollero per la seconda volta credere
alle promesse contenute nel bando e risposero così generosamente all'appello che furono composte dieci
legioni e, poiché gli Equi avevano invaso il territorio dei Latini e questi avevano chiesto soccorsi a Roma, si
giudicò opportuno d'inviare truppe contro i nemici.
Dei due consoli, sotto il cui comando erano state poste sei legioni, Veturio fu mandato contro gli Equi, che,
lasciata la pianura, per meglio difendersi si rifugiarono sulle montagne, Virginio fu inviato contro i Volsci, che
costretti a battaglia nell'aperta pianura, furono sgominati e inseguiti fino a Velitre, che quale poi cadde in
mano dei Romani.
Il dittatore nel frattempo, alla testa delle altre quattro legioni, affrontava i Sabini e li sconfiggeva.
Terminata vittoriosamente la guerra, il dittatore Valerio tornò a Roma e suo primo pensiero fu di adempiere
le promesse fatte alla plebe, per la qual cosa chiese al Senato che fossero; condonati i debiti e liberati i
debitori.
Il Senato oppose un rifiuto e Valerio, sdegnato, si dimise dalla carica. Temendo i senatori che i plebei, se
fosse stato sciolto l'esercito, tornassero a tumultuare, lo mantennero sotto le armi. Ma questa scelta fu il
peggiore dei mali. Esasperate, le legioni plebee si ribellarono ai consoli ed eletto capo L. LICINIO, andarono
ad accamparsi tre miglia lontano della città, oltre l'Aniene, sopra un colle che più tardi fu chiamato Monte
Sacro.
La plebe rimasta a Roma, temendo per la propria sicurezza, se ne andò ? come credono certi critici ?
sull'Aventino. Questi fatti preoccuparono immensamente i patrizi, non solo perché si preannunciavano gravi
lotte civili, ma perché potevano indurre i nemici esterni ad assalire Roma, che in simili condizioni non poteva
essere validamente difesa.
Fu perciò deciso di avviare trattative con i plebei. Molti furono gli ambasciatori, ma nessuno di loro riuscì a
persuadere la plebe a ritornare in città. Allora fu inviato sul Monte Sacro MENENIO AGRIPPA, uomo con
molti anni, pieno di senno e molto caro al popolo, il quale per mezzo del famoso apologo del ventre e delle
membra, persuase i plebei che la discordia era di danno al patriziato e alla plebe e che solo nella concordia
tra le due parti potevano queste trovare il benessere. Disarmati gli animi, i plebei ricevettero il dittatore
Valerio col quale furono trattate le condizioni di pace. Queste furono: condono dei debiti ai debitori insolvibili,
restituzione della libertà a quei debitori caduti in servitù dei creditori per inadempienza dei pagamenti,
assicurazione di regolare con legge centuriata i contratti tra creditore e debitore, ed infine l'istituzione di un
magistrato della plebe.
Questo magistrato, che prese il nome di "tribuno della plebe" doveva aiutare i plebei che ne facevano
richiesta contro gli arbitrii consolari; la sua persona doveva essere inviolabile; chi avesse osato ostacolarlo
nell'esercizio delle sue funzioni avrebbe subito la confisca dei beni e poteva anche essere ucciso. Nessun
patrizio spettava rivestire tale carica. Il tribuno doveva essere assistito da altri magistrati: i cosiddetti "edili
plebei e giudici decemviri". Gli uni dovevano presiedere alla polizia, regolare l'annona e i ludi plebei,
registrare i plebisciti, giudicare le liti in nome del tribuno e fare eseguire le sentenze; gli altri dovevano
istruire i processi civili e coadiuvare il tribuno nelle sue funzioni.
La pace, solennemente giurata alla presenza dei Feciali, fu detta "sacrata" e a ricordo di quest'avvenimento
furono istituiti i "giuochi plebei".
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
13
TRATTATO CON I LATINI
Nel 261 ( 493 a.C.) dalla sua fondazione, Roma stipulò un trattato federativo con le seguenti città latine:
Ardea, Aricia, Boville, Bubento, Corne, Carvento, Circeio, Corioli, Corbione, Cora, Fortinea, Gabio, Laurento,
Lanuvio, Lavinio, Labico, Nomento, Norba, Preneste, Pedo, Querquetulo, Satrico, Scapzia, Sezia, Tellene,
Tiburi, Tuscolo, Tolerio, Triario e Velitre.
Nel trattato erano consacrati i seguenti punti: fra Roma e le suddette città doveva regnare pace eterna; il
bottino acquistato nelle guerre combattute insieme doveva essere ripartito in parti eguali; se una delle due
parti fosse stata aggredita dai nemici, l'altra, doveva difenderla con tutte le sue forze; i processi tra un
Romano e un Latino dovevano essere risolti entro dieci giorni, infine non poteva essere tolto o aggiunto al
trattato alcun punto senza il consenso di Roma e di tutte le città latine confederate.
GUERRA CONTRO I VOLSCI E CARESTIA
Nello stesso anno scoppiò una guerra tra Roma e i Volsci di Anzio. Il console Postumio Cominio, incontratosi
con l'esercito nemico, lo sbaragliò, lo mise in fuga e lo inseguì fino a Longula che fu dunque conquistata.
Espugnata quindi Pollusca, marciò su Corioli e la cinse d'assedio. Si trovava fra le truppe un patrizio
giovanissimo di nome GNEO MARCIO, valoroso e prudente guerriero. Essendosi un giorno gli abitanti di
Corioli, per il sopraggiungere di soccorsi inviati dai Volsci, decisi a fare un'uscita improvvisa, il giovine Marcio
frenò con i suoi l'impeto dei nemici e, messi questi in fuga, li inseguì, e insieme con loro riuscì a penetrare
nella città provocando una grande strage, tanto che i Volsci, senza colpo ferire, sbigottiti se ne tornarono ad
Anzio.
Gneo Marcio, che era stato l'eroe della giornata, salì a grande popolarità e prestigio e si ebbe il soprannome
di CORIOLANO. _
Moriva in quello stesso anno MENENIO AGRIPPA in estrema povertà. Non lasciò nemmeno i denari per
essere sepolto e i cittadini, che tanto lo amavano per aver lui ricondotta la concordia a Roma, si tassarono
ciascuno di un sesterzio per fargli le esequie.
L'anno seguente Roma fu afflitta da una grande carestia e, venendo a mancare le vettovaglie e cominciando
la plebe a soffrire la fame, i consoli, che erano TITO GEGANIO e PUBLIO MINUCIO, mandarono a
comperar grano in Etruria, presso i Volsci, in Campania e in Sicilia; ma soltanto in Sicilia e in Etruria si riuscì
ad acquistarne. I Volsci, che nutrivano fiero odio contro i Romani, si rifiutarono di venderlo e maltrattarono e
cacciarono via i compratori; a Cuma si riuscì a comprare qualcosa, ma il tiranno Aristodemo, cui Tarquinio il
Superbo aveva per testamento lasciato i propri beni confiscati da Roma, per rivalsa sequestrò le navi
romane cariche di frumento.
I Volsci avrebbero forse certamente approfittato delle ristrettezze in cui Roma si trovava per muoverle guerra
se nel loro territorio non fosse scoppiata una grave pestilenza.
Giunto a Roma il grano dalla Sicilia, fu convocato il Senato per stabilire a quale prezzo doveva esser
venduto alla plebe. Alcuni senatori furono di parere di regalare il frumento che il tiranno di Siracusa aveva
gratuitamente offerto, e di vendere a basso prezzo quello acquistato; altri però proposero di costringere la
plebe a rinunziare ai tribuni in cambio delle vettovaglie.
Fra questi ultimi fu GNEO MARCIO CORIOLANO, il quale odiava i plebei perché non gli avevano dato il voto
nelle elezioni consolari. In una rovente e sdegnosa orazione, pronunciata davanti all'assemblea dei senatori,
si scagliò contro la plebe e i tribuni e sostenne che si dovesse, ora che l'occasione si era presentata,
obbligarla a rinunziare a quei diritti acquisiti con la sedizione o altrimenti lasciarla perire di fame.
Le parole del giovane patrizio, conosciute ben presto dai plebei, scatenarono la furia del popolo contro di lui,
che, uscito dalla curia, sarebbe stato fatto a pezzi dalla folla tumultuante se non fosse stato salvato dai
tribuni. Questi lo accusarono di violazione della "legge sacrata" e lo citarono a comparire dinnanzi al concilio
plebeo.
Il patriziato cercò di calmare la plebe concedendo il grano a bassissimo prezzo, ma questo non valse a far
ritirare l'accusa contro Coriolano, il quale fu giudicato in contumacia e dichiarato meritevole della pena
capitale.
Ma CORIOLANO, già prevedendo la sentenza, aveva lasciato Roma e si era rifugiato presso i nemici di
Roma, i Volsci. Aveva trovato ospitalità presso ATTIO TULLIO, signore di Anzio, fiero nemico dei Romani,
con il quale prese accordi per muovere guerra alla propria patria. Ma i Volsci, pure loro provati dalla
pestilenza e sfiduciati dall'esito sfavorevole delle precedenti guerre sostenute contro i Romani, si rifiutarono
di brandire le armi. Questo fatto però non fece desistere Tullio e Coriolano dal loro proposito, e non potendo
metterlo in attuazione con la persuasione pensarono di ricorrere ad uno stratagemma.
Si dovevano celebrare a Roma con grande solennità i giuochi nel Circo e dai territori vicini molta gente si
recò ad assistervi; e fra gli altri un gran numero di pacifici Volsci. Insieme con questi era Attio Tullio, il quale,
giunto in Roma, si recò segretamente dai consoli e disse loro che i Volsci erano venuti non per assistere
pacificamente alle feste ma per approfittarne per tentare un colpo di mano sulla città.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
14
Ricevuta la confidenza, i consoli convocarono il Senato al quale riferirono le brutte intenzioni dei Volsci, e,
poiché questi erano sempre stati nemici di Roma, nessuno pensò di mettere in dubbio l'informazione di Attio
Tullio.
Subito furono mandati in giro i pubblici banditori e fu per mezzo di questi ordinato che tutti i Volsci, presenti a
Roma, lasciassero la città prima del calar della notte.
L'ordine inaspettato produsse sgomento nei Volsci che si affrettarono ad uscire; al timore però successe lo
sdegno per il trattamento ricevuto, e per vendicare l'onta patita fu su due piedi decisa la guerra contro Roma.
CORIOLANO
ATTIO TULLIO e CORIOLANO furono eletti comandanti dell'esercito dei Volsci.
La guerra iniziò con la presa di Circeio, dove fu scacciata la colonia romana; poi l'esercito dei Volsci si
impadronì di Satrico, Longula, Pollusca, Corioli, Mugilla, Lavinio, Corbione, Vitellia, Trebio, Labico e Pedo e
si accampò alla Fossa Cluilia a cinque miglia da Roma.
Allo scopo di far nascere discordie tra il patriziato e la plebe, Coriolano fece devastare le proprietà che i
plebei avevano nei dintorni romani ma risparmiò quelle dei patrizi, che furono per questo motivo accusati di
connivenza con il fuoruscito.
Erano consoli in quel tempo SPURIO NAUZIO e SESTO FURIO. Questi, un giorno, mentre sovrintendevano
ai preparativi della difesa, furono circondati da una moltitudine di plebei che, chiedendo la pace, li
costrinsero a convocare il Senato e a proporre di mandare ambasciatori a Coriolano.
Il Senato, considerando che sarebbe stato difficile avere ragione del nemico a causa della plebe contraria
alla guerra, accettò la proposta, ed inviò cinque senatori a Coriolano perché lo informassero che sarebbe
stato reintegrato nei suoi diritti se avesse fatto allontanare i Volsci da Roma.
Coriolano superbamente rispose che non poteva intavolare trattative di pace se prima dai Romani non erano
ridati ai Volsci i territori sottratti. E fissò un termine di trenta giorni, passati i quali, il Senato mandò una
seconda ambasceria di dieci consolari per tentare di ottenere condizioni meno gravi.
Il fuoruscito però non si piegò e concedette tre giorni di tempo ai senatori per accettare le condizioni. Allora
si tentò di render più mite Coriolano, inviando a lui i sacerdoti e, riuscito vano anche questo tentativo, molte
matrone romane andarono dalla madre di Coriolano, VETURIA, e la persuasero ad intercedere presso il
figlio per la salvezza della Patria.
VETURIA partì con la nuora VOLUNNIA, portandosi dietro due figlioletti di Coriolano ed un numeroso gruppo
di matrone, ma, giunto il corteo femminile al campo nemico, non avrebbe ottenuto udienza se un famigliare
di Gneo Marcio, riconosciute Veturia e Volunnia, non avesse detto a Coriolano: - Se non m'inganno, ecco
tua madre, tua moglie e i tuoi figliuoli. - Fuori di sé, Coriolano si lanciò incontro alla madre per abbracciarla,
ma questa, allontanandolo da sé, severamente gli disse: "Prima che tu mi abbracci dimmi se io sono venuta
a visitare il figliuolo o il nemico, se io nel tuo campo sono prigioniera e serva oppure madre, poiché la mia
lunga vita e l'infelice vecchiaia ha voluto che ti vedessi prima fuoruscito e poi nemico. Come hai tu potuto
saccheggiare questa terra che ti ha dato i natali e ti ha nutrito? Come non cessò l'ira nell'animo tuo nel
metter piede dentro questi confini? Come, alla vista di Roma, non hai potuto pensare che dentro alle sue
mura tu avevi la tua casa, i tuoi Penati, la madre e i figliuoli? Se io non ti avessi partorito, Roma ora non
sarebbe stata combattuta, se io non avessi avuto un figlio sarei morta libera nella mia libera patria. Ma
oramai io non posso sopportare cosa alcuna a me più misera o a te più turpe e vituperevole; sebbene io sia
infelice non potrò a lungo durare: pensa tu a costoro, che per causa tua periranno d'immatura morte o
saranno oppressi da lunga servitù".
La moglie e i figli abbracciarono Coriolano, che, commosso dalla loro presenza, dalle giuste ammonizioni
della madre e dal pianto delle matrone, ordinò che si levasse il campo e l'esercito lasciasse subito il territorio
di Roma.
Discordanti sono le notizie circa la fine di Coriolano. Alcuni affermano essersi ucciso, altri essere stato
trucidato dall'esercito o per ordine di Attio Tullio perché aveva tradito i patti. Ma forse egli continuò a vivere in
esilio tra i Volsci fino a tarda età.
CRITICA DELLA LEGGENDA DI CORIOLANO
Anche qui molte sono le critiche, e alcuni affermano che non ci vuole molto per capire che sono leggendari i
fatti che si attribuiscono a Coriolano.
Come mai, difatti, si può parlare della conquista di Corioli, avvenuta nel 261, se in quello stesso anno questa
città è compresa nel numero delle altre che stringono il patto con Roma. Come mai Coriolano, che
nell'occupazione di Corioli è un giovinetto, un anno dopo, durante la carestia, è senatore e di tale prestigio
da fare accettare le sue proposte (di far morire di fame i plebei, se non rinunciavano ai diritti acquisiti).
Come mai può Coriolano addossare la responsabilità della carestia ai plebei, dicendo che a causa della loro
rivolta i campi rimasero incolti, visto che pochi giorni soltanto durò la rivolta stessa e questa, per giunta, ebbe
luogo in settembre a raccolto -pur scarso- già avvenuto.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
15
Né questo basta; vi è dell'altro. La tradizione fa regalare ai Romani dal tiranno Dionisio una certa quantità di
grano; ma noi sappiamo che in quel tempo non ci fu un tiranno di tal nome a Siracusa.
I Volsci muovono guerra ai Romani e invadono il Lazio e Roma sta inoperosa e i Latini non prendono le
armi. Ammesso che l'inerzia di Roma sia causata dalle discordie tra patrizi e plebei, come giustificare la
passività delle città latine, le quali non solo non portano aiuto, secondo i patti, alla loro alleata, ma non
tentano neppure di difendersi? Ed è infine credibile che, davanti a Roma, una parola di Coriolano, cioè di
uno straniero, possa esser sufficiente per far levare il campo ai Volsci e abbandonare i territori conquistati
(14 città)?
E non è un ripiego di storici posteriori l'attribuire la morte di Coriolano al malcontento dei Volsci? I quali,
poiché si accorgono d'essere stati ingannati, dovrebbero, ucciso Coriolano, portare la guerra fino alle
estreme conseguenze e non ritirarsi a mani vuote quando la vittoria era ormai certa e vicinissima.
"Sotto qualunque aspetto dunque si consideri la tradizione di Coriolano - scrive il Bertolini - essa si presenta
come un tessuto d'inattendibilità e di assurdi. Coriolano ha nome e gloria dalla liberazione di una città che
era già libera; passa improvvisamente dall'età adolescente all'adulta; prende occasione per levarsi contro la
plebe da una carestia immaginaria; conquista dodici o quattordici città munite senza combattere, e in una
sola estate; e tutto poi abbandona improvvisamente dietro preghiera della madre e della moglie, senza
incontrare opposizioni nei Volsci e nel suo stesso collega Attio Tullio, né sollevare contro di sé l'odio e l'ira
dei traditi; e passa in mezzo a loro l'intera sua vita, senza essere molestato, lamentando un esilio che egli
stesso si era imposto; chi ha potuto compiere tali cose non è un essere di questo mondo; e la tradizione che
così lo ritrae non ha diritto d'essere qualificata una tradizione storica".
Ma si domanderà, com'è nata e quale motivo la ispirò? È nata forse da una confusione, parte accidentale e
parte artificiale di fatti diversi per tempo e per natura; fu ispirata dall'orgoglio degli annalisti romani. I quali,
non potendo negare che un tempo la maggior parte delle città latine caddero in potere dei
Volsci e che Roma stessa ebbe a causa loro patire gravissimi danni, cercarono di salvare l'onore offeso con
il mettere a capo dei terribili invasori un cittadino romano ed attribuire a merito suo le conquiste e le vittorie
riportate dagli stranieri.
"Già da secoli correva per le bocche del popolo il nome del bandito Coriolano, cui si associavano i ricordi di
guerresche imprese condotte insieme con i Volsci contro la sua patria. E da questa tradizione trassero
partito gli annalisti per costruire la natura e il processo dei fatti in modo che l'orgoglio romano ne uscisse
illeso. Così Coriolano che aveva combattuto con i Volsci contro i Latini e i Romani, fu convertito in un duce
supremo dei Volsci stessi, ed egli diventò l'anima dell'impresa".
Come ogni leggenda, anche questa di Coriolano deve avere un fondamento storico. E questo punto sta nelle
guerre che verso la fine del terzo secolo di Roma - secondo Livio - furono combattute contro i Romani
(alleati dei Latini e degli Ernici) dai Volsci e dagli Equi.
Che queste guerre ci siano state è dimostrato, oltre che dall'affermazione liviana, dal fatto che nell'ultimo
ventennio di quel secolo tacquero le contese tra patrizi e plebei, entrambi concordi di fronte al nemico della
patria e dimentichi dei rispettivi interessi di classe.
Non nel 262 dunque sarebbe avvenuta la guerra ma molti anni dopo e non contro Volsci ed Equi soltanto,
ma anche contro un forte gruppo di fuorusciti romani, che detestavano, ed erano quindi odiati dalla plebe, o
forse esiliati perché rei di violazione della "legge sacrata" e quindi insofferenti del prestigio sempre maggiore
che essa era andata acquistandosi.
Quanto a Coriolano egli deve essere stato uno di questi fuorusciti, senza dubbio il loro capo, nato da famiglia
forse originaria di Corioli. L'improvvisa fine della guerra alle porte di Roma si spiegherebbe con la defezione
dei fuorusciti in seguito a trattative segretamente avviate tra loro e la loro patria, defezione che, rialzato il
morale e il numero dei difensori di Roma e sorpresi i Volsci, avrebbe consigliato questi ultimi a battere
precipitosamente in ritirata.
SPURIO CASSIO E LA LEGGE AGRARIA (268 di R. - 486 a.C.).
Dopo i fatti sopra, nei successivi cinque anni, cresceva di giorno in giorno il dissidio tra il patriziato e la
plebe. Correva l'anno 268 di Roma quando SPURIO CASSIO, eletto per la terza volta console, propose al
Senato la "legge agraria". Magistrato integro e di larghe vedute, avendo di mira l'interesse dello Stato ed
essendogli a cuore le sorti della plebe, benché fosse patrizio, Spurio Cassio si proponeva con la sua legge di
alleviare le tristi condizioni dei plebei concedendo a loro parte dell'agro pubblico, che era costituito dalle terre
sottratte ai popoli vinti. Di queste terre, diventate suo patrimonio, lo Stato distribuiva fra i coloni o vendeva o
dava in enfiteusi la parte coltivata, lasciava invece la parte devastata dalla guerra a chi, volendola coltivare,
s'impegnava a corrispondergli il decimo dei raccolti. Si capisce che solo i patrizi, appunto perché ricchi e
perciò in grado di metterle a coltura, prendevano queste terre in affitto, ma l'affitto a poco a poco si mutò in
proprietà e con l'andar del tempo la decima non fu più pagata.
La legge di Spurio Cassio con la quale si chiedeva che parte dell'agro pubblico fosse distribuita ai poveri e
che i possessori del rimanente pagassero i tributi, mise in grande agitazione la plebe in un verso e i ricchi in
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
16
un altro, e il Senato finse d'accogliere la proposta e nominò, per prendere tempo, una commissione di dieci
consolari perché misurasse l'agro pubblico e stabilisse la parte che doveva essere distribuita ai plebei.
Intanto, allo scopo di sopprimere il console, i patrizi cominciarono a spargere fra il popolo la voce che Spurio
Cassio cercava di ingraziarsi la plebe per poi diventar tiranno di Roma, e tanto fecero che il popolo
irrazionalmente diede ascolto a queste voci. Così con l'appoggio del popolo, i questori criminali, fra cui era
CESONE FABIO, accusarono Spurio Cassio, lo processarono come traditore della patria, lo condannarono,
e fu precipitato dalla rupe Tarpeia.
I FABII
Strumento del patriziato nella soppressione di Cassio fu soprattutto la gente dei Fabii, i quali in compenso
del servizio reso, ottenevano che un loro rappresentante fosse ogni anno eletto console. E così fu, infatti, per
molti anni con grande danno per la plebe, la quale, per opera dei Fabii, vide non applicata di anno in anno
l'esecuzione della legge agraria.
Questo stato di cose però non poteva durare a lungo. Nel 273 (481 a.C.), essendo scoppiata la guerra
contro Vejo, al console di Roma, che quell'anno era (ancora) CESONE FABIO, fu impedito dal
comportamento della plebe di riportare una decisiva vittoria sul nemico. Questo, infatti, era stato sbaragliato
dalla cavalleria romana comandata dal console stesso e messo in fuga, ma le legioni plebee anziché
inseguirlo, per diminuire la portata della vittoria e il merito dell'odiato Fabio, ritornarono agli accampamenti.
Questo fatto e parecchi altri ancora consigliarono la gente dei Fabii a schierarsi dalla parte della plebe e
l'anno dopo, essendo stato nominato console il fratello di Cesone, MARCO FABIO, promise ai plebei la
pronta esecuzione della legge agraria, ingraziandosi così la plebe.
La guerra contro Vejo si era riaccesa, ma questa volta i plebei combatterono con tanto valore che i Vejenti
furono clamorosamente disfatti. La guerra però costò la vita a QUINTO FABIO, altro fratello del console e
questi ne fu tanto addolorato che si dimise dalla carica. A suo successore fu nuovamente eletto CESONE
che tuttavia mantenne le promesse del fratello e chiese al Senato che la "legge cassia" fosse eseguita.
Se i Fabii avevano saputo accattivarsi le simpatie del popolo non avevano potuto sfuggire all'odio dei patrizi
che, facendo tutto questo per il proprio interesse e considerandoli traditori del proprio ceto, cominciarono a
perseguitarli aspramente. I Fabii avrebbero potuto, capeggiando la plebe, abbattere la potenza dei patrizi e
mantenersi al potere; ma avrebbero inasprite le interne discordie. Punti forse anche dal rimorso di avere
tradito il patriziato e di essere stato loro strumento contro Spurio Cassio, vollero scontare le loro colpe
mostrando il loro patriottismo.
Tutta la gente, eccettuato QUINTO FABIO perché ancora adolescente, sotto il comando di Cesone nell'anno
275 (479 a.C.) abbandonò Roma e si recò ad occupare una fortezza sul Cremera allo scopo di molestare
continuamente Vejo e facilitarne la sottomissione ai Romani.
I Fabii rimasero circa due anni sul Cremera e di là non poche devastazioni fecero nel territorio nemico, ma
un giorno, colti di sorpresa da un numero schiacciante di nemici, dopo un'eroica resistenza, trovarono la
morte sul campo di battaglia.
Indegna però di un romano fu in quella circostanza la condotta del console T. MENENIO che, trovandosi con
l'esercito nelle vicinanze, non volle portare aiuto ai Fabii a causa dell'odio che, come patrizio, nutriva contro
di loro.
Ma non restò impunito. Scaduto dalla carica, venne da L. CONSIDIO e T. GENUCIO, tribuni della plebe,
accusato di "perduellione" (contegno ostile) contro i plebei, fu condannato a pagare una multa di circa
duemila assi e per la vergogna si uccise (278).
In memoria dei Fabii fu messo tra i nefasti il giorno della loro morte e fu chiamata "scellerata" la porta
Carmentale per la quale essi erano usciti dalla città.
Alla legge agraria intanto non si dava esecuzione e nel 281 il TRIBUNO GNEO GENUCIO accusò i consoli
dell'anno precedente C. MANLIO e L. FINNIO pure loro di "perduellione" per avere essi impedito che la
legge di Spurio Cassio fosse eseguita. I patrizi, che male sopportavano la sempre crescente autorità e
ingerenza dei tribuni plebei decisero di sbarazzarsi di loro e la mattina stessa nella quale i due consoli
dovevano essere giudicati G. GENUCIO fu trovato morto nel suo letto.
LA LEGGE PUBLILIA (283 di R. - 471 a.C.)
Sbigottita, la plebe non osò protestare e il Senato chiamò i cittadini sotto le armi e i nuovi consoli nel
conferimento dei gradi militari commisero non poche ingiustizie. Un tale PUBLILIO VOLERONE, ad esempio,
che aveva il grado di centurione, fu messo nel numero dei semplici gregari e siccome lui osò fare pubbliche
rimostranze furono mandati i littori per arrestarlo. Volerone però, spalleggiato da altri plebei, respinse i littori
e il popolo che gremiva il foro, a quella scena, cominciò a tumultuare e inveì minacciosamente contro i
consoli, che si salvarono dall'ira popolare rifugiandosi nella curia.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
17
L'anno dopo (282) PUBLILIO VOLERONE fu eletto tribuno della plebe e, invece d'insistere perché fosse
data esecuzione alla legge agraria, presentò alla plebe una rogazione con la quale proponeva che dai comizi
tributi, per l'elezione dei tribuni, fossero esclusi i patrizi e che dai comizi stessi si stabilissero le attribuzioni.
La rogazione di Publio Volerone fu accolta ovviamente con ostilità dai patrizi, ma il Volerone, rieletto tribuno
l'anno seguente (283), ripresentò la rogazione validamente appoggiato dal collega LETORIO e dal contegno
risoluto della plebe, la quale, di fronte all'ostinazione del console Appio Claudio, minacciò una nuova
secessione.
La legge fu votata, e, tardando a venire la sanzione del Senato, i plebei si sollevarono e occuparono il colle
Capitolino. Solo allora i senatori cedettero e sanzionarono la cosiddetta "legge publilia".
APPIO CLAUDIO volle rifarsi dell'insuccesso opprimendo con una disciplina inumana i soldati ma ben presto
dovette subirne i tristi effetti, perché l'esercito, esasperato, combattendo contro i Volsci sotto il comando
dell'odiato console, volse le spalle al nemico. Ferocissimi furono i provvedimenti disciplinari adottati da Appio
Claudio; l'esercito fu condannato alla decimazione; cioè un soldato su ogni dieci fu dietro suo ordine preso a
caso e ucciso.
Scaduto Appio Claudio dalla carica di console, i tribuni lo citarono in giudizio, ma lui per evitare la vergogna
di esser giudicato dalla "indegna" plebe si tolse la vita.
LA LEGGE TERENTILIA (292 a. di R - 462 a.C.)
Parecchi anni dopo e precisamente nel 292, il tribuno GAJO TERENTILIO ARSA presentò ai comizi tributi,
che la votarono, una legge con la quale proponeva che fosse fatto un codice di leggi e nominata una
commissione di cinque cittadini per compilarlo.
La rogazione di Terentilio trovò ostile il patriziato, ma la plebe tenne duro e, per dimostrare la sua
approvazione ai tribuni, successi ad Arsa, che della sua proposta si erano fatti sostenitori, li confermò in
carica per cinque anni consecutivi. Dal canto loro i patrizi, per impedire l'esecuzione della legge, chiamarono
i cittadini più di una volta alle armi e lasciarono che insolenti giovani di nobili famiglie turbassero i lavori dei
comizi tributi.
Un figlio di L. QUINZIO CINCINNATO, chiamato CESONE QUINZIO, che si era distinto nell'ultima guerra
contro i Volsci e gli Equi, un giorno, capeggiando un manipolo di questi tracotanti giovani, penetrò nei comizi
e ne cacciò i tribuni. Per questo gravissimo fatto fu dal tribuno A. VIRGINIO citato in giudizio, ma i parenti del
reo ed i più influenti patrizi, temendo per l'accusato, cercarono con preghiere di salvarlo e ci sarebbero
riusciti se M. VOLSCIO FITTORE, già tribuno, non avesse rivelato che Cesone, due anni prima, gli aveva
ucciso il fratello. Tuttavia con la potenza del denaro, e quindi con il versamento di una cauzione di 30.000
assi i patrizi ottennero che Cesone rimanesse in libertà fino al giorno del processo. Di questa libertà
provvisoria ne approfittò Cesone, il quale, essendo sicuro di essere condannato, fuggì in Etruria.
L'odio dei patrizi prese allora di mira VOLSCIO. Nel 295 i questori, tra cui era T. Quinzio Capitolino, zio di
Cesone, lo citarono in giudizio accusandolo di falsa testimonianza e l'anno dopo, essendo dittatore
Cincinnato, Volscio fu dai comizi curiati mandato in esilio.
Mentre i patrizi sfogavano il loro rancore contro Volscio, Cesone dall'Etruria, d'accordo con i patrizi
organizzava su Roma, allo scopo di togliere alla plebe i diritti acquistati, un colpo di mano. Raccolti intorno a
sé un migliaio di fuorusciti romani, in compagnia del Sabino APPIO ERDONIO - il quale probabilmente è un
personaggio inventato - marciò su Roma ed occupò il Campidoglio. Alcuni storici affermano che i patrizi,
preoccupati delle conseguenze che sarebbero derivate, anziché sostenere i fuorusciti, si unirono alla plebe
per ricacciarli; altri invece scrivono che la plebe, invitata a prender le armi non ubbidì che dopo avere
ricevuta dal console Valerio la promessa che, liberato il Campidoglio, sarebbe stata sanzionata la legge
tarentilia.
La verità è che i patrizi -forse per paura- non si schierarono con Cesone per il contegno risoluto della plebe e
per l'avvicinarsi dell'alleato Mamilio con un esercito di Tuscolani. Assaliti dalle legioni romane ed alleate i
fuorusciti si batterono accanitamente, ma dovettero alla fine sgombrare il colle, lasciando numerosi morti e
prigionieri. Perirono nella lotta lo stesso Cesone e il console Valerio.
A sostituire il console morto fu chiamato L. QUINZIO CINCINNATO, il quale ordinò, non appena assunto in
carica, che tutti i cittadini sotto le armi si radunassero presso il Lago Regillo. Suo proposito era di riunire là
(cioé in un luogo dove contro l'autorità dei consoli non poteva ergersi l'autorità dei tribuni - che era limitata
solo dentro le mura) i comizi centuriati e far da questi votare la soppressione dei tribuni e l'annullamento
della legge sacrata.
Ma il colpo di mano non riuscì e Cincinnato e si ritirò a vita privata in un campo di quattro jugeri, unica
proprietà rimastogli dopo il pagamento della cauzione con la quale aveva ottenuto la libertà provvisoria per il
figlio. Ma ben presto come vedremo tornerà alla ribalta.
CINCINNATO
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
18
Durante gli anni in cui questi fatti si svolsero, Roma dovette sostenere delle accanite guerre contro i popoli
vicini.
Secondo la tradizione, nell'anno 295 i Volsci tentarono di assalire Anzio, ma furono sconfitti da un esercito
romano capitanato dal console FABIO. Non pare però che le cose siano andate proprio così e quella che gli
storici romani decantano come vittoria dovette essere una sconfitta. Risulta difatti che in quell'anno Anzio fu
conquistata dai Volsci, che vi distrussero la colonia dei Romani, dei Latini e degli Ernici. In un trattato di pace
firmato nel 295 i Romani rinunciarono ad Anzio in favore dei Volsci che la mantennero sotto il loro dominio
per molti anni.
In quell'anno medesimo Roma sostenne una guerra contro gli Equi, di cui gli antichi storici hanno alterato,
come al solito, l'esito sfavorevole ai Romani.
Secondo questi storici, essendosi gli Equi impadroniti di Tuscolo, il console Fabio piombò di notte sulla città
é la sottrasse nuovamente al nemico, costringendolo alla pace. L'anno dopo (296) gli Equi, riprese le armi,
invasero il territorio latino, giungendo fino all'Algido. Roma mandò al campo nemico degli ambasciatori,
perché chiedessero conto della rottura del trattato; ma GRACCO CLELIO, capo degli Equi, rifiutò di riceverli.
Deciso a vendicare l'affronto, il Senato romano spedì all'Algido il console MINUCIO con un esercito; ma la
spedizione ebbe un esito infelice: i Romani subirono una disfatta, furono circondati e a gran fatica il console
riuscì ad informare il Senato della critica situazione in cui lui si trovava.
Nell'assemblea dei senatori fu allora deciso di nominare un dittatore e la scelta cadde sopra un guerriero che
altre volte aveva fornito prove di valore: L. QUINZIO CINCINNATO.
Si trovava ad arare il suo campo quando la moglie Racilia gli annunziò la visita del messo inviatogli dal
Senato. Indossata la toga, Cincinnato ricevette il messo e, dimenticato le passate amarezze, accettò la
carica. Il giorno dopo il dittatore fece ritorno a Roma, ordinò che tutti i cittadini idonei alle armi, prima di sera,
si radunassero al Campo Marzio con una scorta di viveri per cinque giorni e dodici pali ciascuno e mise a
capo della cavalleria L. TARQUIZIO.
Al tramonto l'esercito era pronto a partire e si avviò verso l'Algido, presso cui giunse a metà della notte.
Senza far rumore i Romani costruirono durante la notte una palizzata intorno al campo nemico. Gli Equi,
all'alba, vistisi stretti tra l'esercito di Minucio e quello del dittatore, si arresero, accettando i patti imposti da
Cincinnato. Si obbligarono cioè a restituire la città di Cerbione, a consegnare le armi e a sottomettersi ai
romani. GRACCO CLELIO, incatenato, seguì a Roma il vincitore Cincinnato, ma Minucio fu rimosso dalla
carica.
Questo il racconto del fatto tramandatoci dagli storici, che senza dubbio è un romanzo inventato per
mascherare il risultato sfavorevole della guerra contro gli Equi.
Come più sopra abbiamo detto, durante la dittatura di Cincinnato, Volscio era stato condannato all'esilio e
questo provvedimento preso a scopo di vendetta provocò lo sdegno dei tribuni e della plebe, la quale,
avendo nel 297 i Sabini invaso il territorio romano, si rifiutò di prender le armi e di combattere contro il
nemico e cedette soltanto allorquando il Senato concesse che il numero dei tribuni da cinque fosse portato a
dieci.
LE LEGGI ICILIA E TARPEIA (298-300 A, di R. - 456-454 a.C.)
L'anno dopo (298), il tribuno L. ICILIO propose una legge che prese il suo nome, per mezzo della quale alla
plebe fu ceduto il possesso dell'Aventino il cui agro pubblico doveva essere distribuito a tutti quei plebei che
volessero su quel colle fissare la loro dimora. Era questa una legge vantaggiosa per le plebe, perché tramite
questa i plebei riuscivano ad avere un loro quartiere, dove potevano difendersi in caso di lotta con i patrizi.
Nel 299 i tribuni, non contenti dei privilegi strappati al Senato in favore della plebe, chiesero ancora che
fosse data esecuzione alla legge agraria di Spurio Cassio. Avvennero allora altre violenze da parte dei
giovani patrizi più intemperanti e scoppiarono tumulti nelle file della alla plebe che ottenne di citare in
giudizio alcuni membri delle famiglie patrizie dei Clelii, dei Sempronii e dei Postumii. Anche i consoli F.
Romilio e C. Veturio furono accusati e processati e i primi furono condannati alla confisca dei beni e all'esilio,
i secondi ad un'ammenda di diecimila assi ciascuno.
Ma questi forti contrasti tra patriziato e plebe non poteva durare senza danno dell'uno e dell'altro ceto; fu per
queste intollerabilità che nell'anno 300 i consoli SPURIO TARPEJO e AULO ATERNIO presentarono una
legge con la quale il potere dei consoli per ciò che riguardava le multe era limitato, fissando multe che
andavano da un minimo di un solo capo di piccolo bestiame ad un massimo di trenta capi di grosso
bestiame e due di piccolo. Secondo la "legge tarpeja-aternia" le multe dovevano essere applicate
gradualmente e il condannato ad una multa superiore alla massima poteva appellarsi al popolo.
Era un gran passo verso la pacificazione e il disarmo degli spiriti. I tribuni, visto il buon volere dei consoli,
non insistettero più sulla "legge terentilia" e fra loro e i consoli si stabilì di compilare un codice di leggi
comune ai due ceti.
E' il primo DECEMVIRATO di cui parleremo nel prossimo capitolo: vale a dire il periodo dal 453 al 449 a.C. >
>>
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
19
Fonti, Bibliografia, Testi, Citazioni:
TITO LIVIO - STORIE (ab Urbe condita)
APPIANO - BELL. CIV. STORIA ROMANA
DIONE CASSIO - STORIA ROMANA
PAOLO GIUDICI - STORIA D'ITALIA
UTET - CRONOLOGIA UNIVERSALE
I. CAZZANIGA , ST. LETT. LATINA,
+ altri, in Biblioteca dell'Autore
IL DECEMVIRATO - LEGGI 10 TAVOLE - LE LEGGI INIQUE 453-449 a. C.
IL PRIMO DECEMVIRATO - LE LEGGI DELLE "DIECI TAVOLE" - IL SECONDO DECEMVIRATO - LE
TAVOLE DELLE "LEGGI INIQUE" - GUERRA CONTRO I SABINI E GLI EQUI - SICCIO DENTATO - APPIO
CLAUDIO - MORTE DI VIRGINIA - RIVOLTA DELLA PLEBE - LE LEGIONI SULL'AVENTINO E SUL
MONTE SACRO - I TRIBUNI MILITARI - RISTABILIMENTO DEL GOVERNO CONSOLARE - LE LEGGI
VALERIE-ORAZIE - CONDANNA DEI DECEMVIRI - SUICIDIO DI APPIO CLAUDIO E SPURIO OPPIO VITTORIE SUI SABINI E SUGLI EQUI - TRIONFO DEI CONSOLI VALERIO E ORAZIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
IL PRIMO DECEMVIRATO
Stabilita la compilazione di un codice di leggi, una commissione di patrizi, composta di SPURIO POSTUMIO,
C. MANLIO e PUBLIO SULPICIO CAMERINO, fu inviata in Grecia per studiare le leggi di quel paese. Due
anni rimasero assenti e al loro ritorno A Roma, si formò una commissione di dieci la quale fu incaricata di
compilare il codice.
Allo scopo di dare alla commissione libertà di lavoro e di sottrarla alle influenze di magistrati, gli si conferì il
potere dittatoriale; la durata della carica fu stabilita di un anno.
La commissione fu composta di dieci uomini, tutti patrizi, e fu perciò chiamata dei Decemviri. Ne facevano
parte, oltre i tre che erano stati inviati in Grecia, i consoli APPIO CLAUDIO e T. GENUCIO ed i senatori
PUBLIO SESTIO, SPURIO VETURIO, CAJO GIULIO, PUBLIO CURIAZIO e TITO ROMILIO.
I decemviri entrarono in carica alle idi di maggio del 303 (451 a.C.) e stabilirono di tenere il supremo
comando a turno, un giorno uno, un giorno l'altro; il decemviro di turno amministrava la giustizia e teneva
presso di sé dodici littori con i fasci e la scure.
Il governo dei decemviri fu esemplare: la massima concordia regnò tra loro, e nessuna ingiustizia fu
commessa; anzi si distinsero per la loro grande equità e trattarono alla stessa stregua ricchi e poveri, patrizi
e plebei.
Appio Claudio, il più giovane di loro, uomo astuto ed ambizioso, si faceva in particolar modo notare per
l'ascendente che aveva saputo acquistarsi in seno ai dieci per la rettitudine e per l'amore che mostrava di
nutrire verso la plebe.
Anche le leggi da loro presentate al pubblico, tutti rimasero contenti. Erano queste divise in dieci tavole e
furono sottoposte al giudizio della cittadinanza nel foro affinché ognuno potesse prenderne visione, dare il
proprio parere e proporre correzioni ed aggiunte; poi, rivedute, ebbero l'approvazione dei comizi centuriati e
la sanzione dei curiati e, incise su dieci tavole di bronzo, furono esposte sul Comizio.
Poco noi sappiamo del contenuto delle leggi, ma dai frammenti che ci sono stati tramandati esse ci appaiono
ispirate a sensi d'umanità e di progresso civile. E se quasi nessuna delle consuetudini che avevano regolata
fino allora la società romana fu abolita, molte furono modificate e attenuate. La plebe le accolse con grande
favore anche perché i rapporti tra creditori e debitori erano regolati più umanamente di prima, dandosi un
respiro di novanta giorni dalla pubblicazione della condanna all'esecuzione e vietandosi la fustigazione e
l'uccisione dei debitori caduti in schiavitù.
IL SECONDO DECEMVIRATO
L'anno stava per finire e fra poco si doveva tornare alle istituzioni di prima. Si decise invece di prolungare di
un anno il decemvirato. Sul motivo che consigliò una tale scelta sono discordi gli storici: "Livio" scrive che,
mancando due tavole alle leggi, perché il codice fosse completo, si pensò di rieleggere per un altro anno
ancora dieci magistrati che curassero la compilazione delle due ultime tavole; Dionisio invece afferma - e
forse con ragione - che la proposta fu fatta dai patrizi allo scopo di sopprimere il tribunato che tanto filo da
torcere aveva dato a loro.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
20
Comunque la plebe non si mostrò ostile, ma pretese che tra i nuovi decemviri ci fosse una rappresentanza
del proprio ceto e concesso il diritto d'appello dall'uno all'altro dei dieci magistrati.
Furono convocati i comizi centuriati per le elezioni dei nuovi decemviri e non pochi patrizi si diedero da fare
per assicurarsi con lusinghe i suffragi della plebe. Fra questi il più attivo era APPIO CLAUDIO. Il suo
contegno destò la gelosia e il sospetto di molti patrizi e dei suoi stessi colleghi, i quali, non osando
combatterlo apertamente, adoperarono l'astuzia e gli conferirono l'incarico di presiedere ai comizi sicuri -che
in tale ufficio egli non avrebbe presentata la sua candidatura. Invece Appio Claudio non solo la mantenne
ma fece riuscire vittoriosa una lista di nomi da lui stesso proposta nella quale figurava anche il suo.
In tal modo vennero eletti sette patrizi: Appio Claudio, Marco Cornelio Maluginense, Marco Sergio, Lucio
Minucio, Quinto Fabio Vibulano, Quinto Petilio e Tito Antonio Merenda, e tre plebei: Cesone Duilio, Spurio
Oppio Cornicino e Manio Rabulejo.
LE LEGGI INIQUE
I nove colleghi di Appio Claudio erano uomini senza polso. Il nuovo collegio decemvirale entrò in carica alle
idi di maggio del 304 e inaugurò l'avvento al potere con una novità che sbigottì l'intera cittadinanza: uscendo
preceduti da dodici littori ciascuno, simili a dieci re. Non solo la plebe ne fu sbigottita, ma anche i patrizi e la
prima subito comprese che sarebbe stato lettera morta il diritto di appello data la solidarietà di cui facevano
mostra i decemviri. E in effetti il rigore del nuovo collegio fu sentito soltanto dalla plebe, cui a paragone parve
moderato il contegno dei precedenti consoli.
Invano i plebei cercarono scampo ai soprusi appellandosi ora a uno, ora all'altro, perché gli appelli davano
risultati peggiori; invano invocarono l'aiuto dei tre rappresentanti del loro ceto; questi fecero capire che nulla
potevano fare essendo dominati da Appio Claudio. Si vociferò anche che i Decemviri volessero mutare la
carica in tirannide, per questo non si sapeva se desiderare o no le nuove idi di maggio che dovevano
mettere fine al tristo potere dei Dieci o alle speranze in un ritorno al tribunato.
Durante il secondo decemvirato due tavole - che in seguito da CICERONE furono poi dette "inique" - furono
aggiunte alle altre dieci e così il codice prese il nome di Dodici tavole.
GUERRA CONTRO I- SABINI E GLI EQUI - SICCIO DENTATO
Venute le idi del maggio dell'anno 305 i decemviri non convocarono i comizi né lasciarono il potere. La
cittadinanza era così avvilita che i nemici di Roma ritenevano che era giunto il momento di approfittarne.
I Sabini penetrarono nel territorio romano saccheggiandolo, poi con il numeroso bestiame razziato si
accamparono ad Ereto. Gli Equi dal canto loro si spinsero fino all'Algido presso il quale posero gli
accampamenti e di là andavano depredando con continue scorrerie il territorio di Tuscolo. L'annuncio della
duplice invasione, l'affluire a Roma della popolazione del contado e un'ambasciata tuscolana che chiedeva
aiuto, spaventò la plebe e preoccupò il patriziato.
I Decemviri non sapendo cosa decidere in una così grave situazione, decisero di convocare il Senato per
farsi consigliare
Udendo la voce del banditore che chiamava i senatori alla Curia la plebe, curiosa e nello stesso tempo
sperando che sotto il pericolo del nemico si ripristinasse il passato regime, si radunò nel foro; ma il numero
dei senatori che risposero all'appello fu molto esiguo; la maggior parte di loro si erano ritirati nelle loro terre
ad occuparsi delle proprie faccende private, poiché della cosa pubblica non potevano più occuparsi.
Credevano sulle prime i Decemviri che i senatori non volevano radunarsi e mandarono alle loro case i
sergenti, ma, saputo che vivevano fuori di Roma, ordinarono che fossero avvisati di recarsi alla Curia il
giorno seguente. L'indomani l'assemblea senatoriale riuscì abbastanza numerosa.
Spiegato Appio Claudio il motivo della convocazione, iniziò a parlare LUCIO VALERIO POTITO, di famiglia
amica della plebe, ma, avendogli i Dieci, proibito di esporre il suo pensiero, protestò risolutamente
minacciando di uscire fuori del Senato a parlare alla plebe.
Non meno audace del collega fu un altro senatore amico dei plebei, di nome MARCO ORAZIO BARBATO, il
quale chiamò i Decemviri i dieci tarquinii, li minacciò di chiamare il popolo dentro il parlamento, li rimproverò
di tirannide e concluse: "Non confidate troppo nella timidezza altrui perché oramai agli uomini sembrano più
gravi le cose che soffrono di quelle che temono di patire".
A quel punto iniziò a parlare CAJO CLAUDIO, zio di Appio, che, biasimata la condotta del nipote, consigliò il
Senato di non prendere alcuna deliberazione essendo i Dieci privati cittadini.
Molti approvarono le parole di Claudio, molti altri proposero di creare un inter-re, ma LUCIO CORNELIO
MALUGINENSE, fratello del decemviro, con il segreto proposito di favorire la causa dei Dieci, affermò che
non era quello il momento di deliberare su questioni così importanti, ma di pensare a difendere la patria dal
nemico e a portare aiuto a Tuscolo.
Prevalsa questa proposta, furono chiamati i cittadini alle armi e, formate le legioni, Appio Claudio rimase a
Roma insieme con Spurio Appio; contro i Sabini fu mandato un esercito al comando di QUINZIO FABIO,
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
21
assistito da Manio Rubulejo e Quinzio Petilio; contro gli Equi fu inviato un secondo esercito comandato da
MARCO CORNELIO affiancato da Lucio Minucio, T. Antonio Merenda, Cesone Duilio e Marco Sergio.
Ma sia il primo che il secondo esercito combatterono male. Il primo, disfatto a Ereto, si ritirò
precipitosamente su un'altura tra Fidena e Crustumerio, dove si mantenne sulla difensiva; il secondo,
sconfitto all'Algido e perso perfino il campo con gli alloggiamenti e i rifornimenti, si rifugiò a Tuscolo senza le
armi.
Giunta a Roma la notizia della duplice disfatta, fu grande la costernazione della cittadinanza e i patrizi
consigliavano che si rifornisse d'armi l'esercito chiuso a Tuscolo, che tutti gli uomini validi si chiamassero
sotto le armi e a loro si affidasse la custodia delle mura e delle porte, e infine che l'esercito comandato da
Fabio fosse mandato in territorio Sabino.
Non commossi dalle sconfitte, i Decemviri davano sfogo alle loro vendette.
Nell'esercito inviato contro i Sabini si trovava L. SICCIO DENTATO, ex-tribuno della plebe, valoroso soldato
con il petto solcato da quaranta cicatrici, che aveva combattuto in centoventi battaglie, e nel 300 aveva citato
in giudizio Romilio. Dentato eccitava i soldati alla rivolta e i Decemviri, non osando di prendere contro di lui
provvedimenti disciplinari, deliberarono di disfarsene con il tradimento. Facendogli credere che l'esercito
doveva trasferirsi in un'altra località, lo mandarono in cerca di un punto adatto all'accampamento ma nello
stesso tempo ordinarono ai soldati che dovevano accompagnarlo di ucciderlo.
Così fu, ma non senza fatica, perché Dentato essendosi strenuamente difeso, caddero morti assieme a lui
alcuni dei sicari. Gli altri, ritornati, riferirono di essere stati assaliti dai nemici e che Siccio ed alcuni
compagni, dopo un'accanita resistenza, erano stati uccisi. Il racconto fu prima creduto, ma poi alcuni soldati
portatisi sul luogo per dar sepoltura ai caduti, non videro nessuna traccia di nemici e, cosa strana, trovarono
il cadavere di Siccio ancora rivestito delle armi e i corpi dei compagni rivolti verso di lui; era chiaro che più
che i nemici a fare la strage erano stati gli "amici".
Ritornati a Roma con la salma affermarono che Siccio Dentato era stato assassinato dai suoi stessi
compagni.
Grande furono il dolore e lo sdegno dell'esercito che stimava molto il prode scomparso e i Decemviri per non
essere sospettati complici degli assassini fecero tributare solenni esequie e seppellire Siccio a pubbliche
spese.
APPIO CLAUDIO E VIRGINIA
Mentre questo fatto accadeva al campo, di un altro delitto a Roma si macchiava il capo dei Decemviri.
Viveva a Roma una vergine plebea di rara bellezza, VIRGINIA, figlia di Lucio Virginio, prode soldato che,
con il grado di centurione, serviva nell'esercito di Marco Cornelio; la giovane era fidanzata di Lucio Icilio,
tribuno della plebe, caro al popolo per la famosa legge che aveva fruttato ai plebei il possesso dell'Aventino.
Di lei si era ardentemente invaghito Appio Claudio e con doni, carezze e promesse aveva cercato di
conquistarla e possederla, ma, rimaste vane le sue arti seduttrici di fronte agli sdegnosi rifiuti dell'onesta
giovane donna, si era proposto di appagare le sue malsane voglie con la violenza.
Approfittando dell'assenza del padre di lei, Appio Claudio ordinò ad un suo cliente di sostenere che Virginia
gli apparteneva come schiava. Tornando un giorno la giovinetta dalla scuola posta in via delle Taberne e
trovandosi a passare per il foro, il cliente di Appio, chiamandola serva e figlia di una sua serva, le mise le
mani addosso e le comandò di seguirlo, minacciandola di condurla con la forza se indugiava. La vergine
cominciò a gridare e subito una gran folla si radunò intorno a lei e riconosciutala si schierò a difenderla,
vietando minacciosamente al cliente di usarle violenza, ma questi affermò che aveva diritto di reclamare la
fanciulla e che questo diritto voleva fare valere dinnanzi al giudice.
Esortata dalla folla, Virginia si lasciò condurre davanti il decemviro Appio Claudio, al quale il cliente narrò
che Virginia era nata nella sua casa da una sua schiava e che poi era stata rubata e portata in casa del
centurione Virginio, e che d'accordo con la moglie l'aveva fatta credere una loro figlia. Il cliente disse inoltre
che era pronto a produrre testimoni e chiese che la fanciulla, mentre si celebrava il processo, gli fosse
affidata.
Si opposero però i difensori di Virginia sostenendo che il padre era assente per servizio dello Stato, che era
cosa iniqua deliberare della sorte di una figlia nell'assenza del padre, che doveva differirsi il giudizio fino al
ritorno del genitore, il quale, dopo essere stato informato, poteva trovarsi a Roma in un paio di giorni; nel
frattempo la giovinetta doveva essere considerata libera anche per non permettere che corresse rischio il
suo onore.
Rispose Appio Claudio che la stessa legge invocata dai difensori della fanciulla mostrava quanto fosse
favorevole alla libertà, ma che tale legge non poteva essere applicata in quel caso, contemplando soltanto le
persone libere. Virginia invece era sotto la patria potestà. Disse ancora che era contento che si mandasse a
chiamare il padre, ma che nel frattempo non poteva impedire all'uomo che reclamava la fanciulla di
portarsela a casa.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
22
Era al dibattito presente tra la folla PUBLIO NUMITORE, zio materno di Virginia e il fidanzato ICILIO, che a
quelle parole del decemviro, si fecero largo tra la calca, ma il littore, affrontandoli entrambi, ordinò loro
d'allontanarsi.
Icilio con voce risoluta e incoraggiato dall'appoggio della folla rispose: "O Appio, prima che tu abbia ciò che
desideri, soltanto con il ferro e con la forza io potrò esser cacciato di qui; Io sono il fidanzato di questa donna
immacolata e intendo sposarla. Fa pur venire i littori dei tuoi colleghi usando le verghe e le scuri, ma la futura
mia sposa non rimarrà fuori della casa paterna; ci avete tolto i tribuni e la facoltà di appello ma la vostra
libidine non ci toglierà le donne e i figli. Incrudelite pure contro di noi, ma sia salvo il pudore delle nostre
donne. Se oggi si vorrà usare la violenza io, il popolo e Virginio i soldati chiameremo in soccorso e gli dei
tutti; né la tua sentenza sarà eseguita finché vivi saremo. Pensa, Appio, a quel che fai. Si aspetti che Virginio
ritorni e tu sappi che io reclamo la libertà per la mia donna e che preferisco morire anziché venir meno alla
fede". .
Mentre così parlava Icilio già aveva cominciato a tumultuare la folla e già i littori avevano circondato il
giovane, quando Appio, fatta tornare la calma, annunciò che scopo di Icilio era di far nascere una rivolta e
che, per evitarla, lasciava libera Virginia per un giorno, affinché suo padre potesse tornare, ma che passato
quello avrebbe dato corso alla giustizia.
Senza perder tempo, il fratello d'Ici1io e un figlio di Numitore a cavallo corsero a dal padre della giovinetta
per informarlo dell'accaduto, mentre Appio Claudio scriveva ai suoi colleghi di non dare licenza a Virginio di
partire e di trattenerlo con la forza se occorreva.
Ma Virginio era già partito per Roma. Il mattino del giorno dopo il foro era gremito di folla nell'attesa del
processo quando comparvero l'infelice padre e la fanciulla, poveramente vestiti, che suscitarono l'interesse,
la pietà e la simpatia di tutti i presenti.,
Dinnanzi al tribunale, il cliente e complice di Appio Claudio cominciò a parlare, lagnandosi che il giorno prima
non gli fosse stata resa giustizia e seguitò a reclamare per sé la giovinetta.
Appio Claudio, senza dargli tempo di finire, accolse l'istanza e riconobbe Virginia come sua proprietà perché
figlia di una sua schiava.
Il cliente avanzò per impadronirsi della fanciulla e, siccome la folla, indignata dell'ingiusta sentenza, gli
sbarrava il passo, mentre le donne presenti alla scena levavano alti lamenti, Appio Claudio ordinò al
banditore che imponesse il silenzio, poi disse alla folla di stare tranquilla e di non partecipare alla sedizione
preparata da Icilio e da Virginio se non voleva che i littori iniziassero ad usare le armi.
La folla alle parole minacciose del decemviro si mise in disparte sbigottita e Virginio, vedendosi mancar
l'aiuto del popolo, in cui tanto aveva sperato, pensò di sottrarre la propria figlia al disonore sacrificandola e,
rivoltosi al tiranno, gli disse: "O Appio, io ti prego anzitutto che tu mi perdoni se io, angosciato, ho a te rivolto
parole risentite, poiché tu mi consenta, qui, alla presenza della fanciulla stessa, che io interroghi la nutrice e
sappia da lei in quale modo e perché abbiano fatto credermi padre di Virginia".
Ottenuto il permesso, Virginio trasse la figliuola e la nutrice presso il tempio della dea Cloacina e,
impadronitosi di un coltello nella bottega di un macellaio, immerse la lama nel seno di Virginia esclamando:
"Soltanto così, o figlia mia, io posso difendere e mantenere la tua libertà", poi, rivolgendosi al decemviro, gli
gridò: "O Appio, agli dei infernali io consacro te e il tuo capo".
Successe un istante di stupore nella folla. Appio Claudio, cieco dall'ira, ordinò ai littori che Virginio fosse
arrestato, ma questi con il coltello ancora sanguinante in mano si fece largo tra la folla e trovò scampo fuori
le porte.
Nel foro intanto il popolo rumoreggiava. Numitorio ed Icilio, rialzando da terra il corpo esanime della
fanciulla, lo mostravano alla moltitudine e giustificavano la violenza paterna provocata dai propositi scellerati
di Claudio; numerose donne, facendosi intorno al cadavere, piangevano la fine immatura di quella
giovinezza e dicevano: "È questa dunque la sorte di chi genera figliuoli? Sono questi i premi riservati
all'onestà?".
Il tumulto della folla aumentò e da ogni parte s'imprecava alle scelleratezze dei decemviri.
Appio Claudio, fuori di sé, comandò l'arresto di Icilio e, poiché i littori, ostacolati dalla gente, non potevano
giungere fino a lui, lui stesso con un manipolo di giovani patrizi si scagliò tra la folla che compatta difendeva
l'antico tribuno, spalleggiata da LUCIO VALERIO e MARCO ORAZIO.
Nacque nel foro una violenta mischia ed ai littori furono spezzate le verghe. Tentò Appio Claudio di parlare,
ma nessuno voleva ascoltarlo, prestavano orecchio solo alle indignate parole di Orazio e di Valerio. Vistosi a
mal partito e temendo per la sua vita, Appio Claudio segretamente si rifugiò in una casa vicina; Spurio Oppio
tentò di portare aiuto al collega, ma, accortosi che il popolo aveva il sopravvento e consigliato da molti, fece
radunare il Senato.
I senatori furono di parere che non si dovesse irritare la plebe e, pensando che Virginio potesse essersi
recato al campo a sommuovere l'esercito, spedirono al monte Vecilio, dove le truppe si trovavano, alcuni
giovani patrizi affinché si adoperassero a mantenere calmi i soldati.
Virginio però, seguito da circa quattrocento Romani, era giunto prima all'accampamento e qui, lordo ancora
di sangue e brandendo il coltello, aveva narrato ogni cosa ai soldati, li aveva informati dei turpi propositi di
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
23
Appio Claudio, aveva detto di avere uccisa la figliuola tanto amata per sottrarla alle insane voglie del
decemviro e li aveva infine incitati a scuotere il giogo degli iniqui magistrati ed a vendicare sua figlia.
Le parole di Virginio infiammarono di sdegno i soldati e, poiché era corsa la voce che a Roma la plebe si era
sollevata e qualcuno perfino asseriva che Appio Claudio era stato già ammazzato, le legioni, non prestando
più obbedienza ai capi che invano si sforzavano di calmarle e trattenerle, precedute dalle insegne,
marciarono verso Roma invitando alla rivolta tutti i plebei che incontravano per la via e, giunte sull'Aventino,
minacciosamente vi s'accamparono.
La notizia del loro arrivo si diffuse subito nella città e se rincuorò la plebe diffuse la costernazione nel
Senato, il quale radunatosi in fretta stabilì di mandare presso i rivoltosi i tre consolari SPURIO TARPEJO,
CAJO GIULIO e PUBLIO SULPICIO.
Questi in nome del Senato andarono e chiesero ai legionari perché mai avessero abbandonati gli
accampamenti e aver fatto ritorno in città; ma a gran voce fu risposto che non si voleva parlamentare con
nessuno salvo che con Lucio Valerio e Marco Orazio.
Partiti gli ambasciatori, dietro proposta di Virginio, furono creati dieci capi che furono chiamati "tribuni
militari".
Anche nell'esercito che si trovava in territorio sabino era, per opera di NUMITORIO ed ICILIO, scoppiata la
rivolta. Informati che sull'Aventino erano stati nominati i tribuni militari, le legioni di QUINZIO FABIO elessero
anche loro dieci tribuni e marciarono su Roma.
Entrarono per la porta Collina e, attraversata la città, andarono a congiungersi alle altre legioni dell'Aventino.
Qui i venti tribuni elessero Marco Appio e Sesto Manilio capi supremi.
I senatori intanto, sbigottiti dagli avvenimenti minacciosi, stavano sempre riuniti; ma tempestose ed
inconcludenti erano le loro sedute perché molti perdevano il tempo scambiandosi ingiurie e altri accusavano
i Dieci di essere stati loro la causa della ribellione dell'esercito. Infine fu dato l'incarico di parlamentare con la
plebe a Valerio ed Orazio, ma questi si rifiutarono dicendo che nessun passo a favore della pacificazione
loro avrebbero fatto se prima i Dieci non avessero lasciato il potere.
Informate di queste cose da Marco Duilio, già tribuno della plebe, le legioni abbandonarono l'Aventino e, per
la Via Ficulense, andarono ad accamparsi sul monte Sacro. Tutta la plebe raggiunse subito l'esercito e a
Roma non rimasero che gli uomini vecchi o invalidi.
Allora i senatori si accorsero della gravità della molto critica situazione ed ottennero che i Dieci si
dimettessero promettendo loro salva la vita; subito dopo MARCO ORAZIO e LUCIO VALERIO si recarono al
monte Sacro e furono accolti con grandi manifestazioni di giubilo dalla plebe, la quale, per bocca d'Icilio,
domandò, come condizione di pace, il ristabilimento del regime consolare e del tribunato e il diritto d'appello;
inoltre che nessuno fosse punito per la rivolta e che fossero consegnati a loro i Decemviri.
Quest'ultima condizione però non fu accettata da Valerio ed Orazio che consigliarono ed ottennero che la
plebe non insistesse. Il Senato accettò e sanzionò i patti e i Decemviri lasciarono finalmente il potere, poi gli
ambasciatori, tornati sul monte Sacro, parlarono così alla plebe:
"Con buon augurio vostro e della repubblica tornate in patria, alle case, alle donne ed ai vostri figli; ma
tornateci con la stessa disciplina con la quale fin'ora vi siete comportati, non danneggiando cosa alcuna.
Andate sull'Aventino, il luogo dove ebbe inizio la vostra libertà, e lì creerete i vostri tribuni alla presenza del
Pontefice Massimo".
Grida di giubilo accolsero le parole degli ambasciatori, poi le legioni con le insegne in testa scesero dal
Monte Sacro, attraversarono ordinatamente la città e si recarono sull'Aventino, dove furono convocati subito
i comizi e creati dieci tribuni.
Risultarono eletti LUCIO VIRGINIO, LUCIO ICILIO, PUBLIO NUMITORIO, MARCO DUILIO, CAJO SICINIO,
,MARCO TITINIO, MARCO POMPONIO, CAJO APRONIO, APPIO VILLIO e CAJO OPPIO.
I tribuni allora convocarono la plebe nei prati Flamini; e lì M. DUILIO propose che fosse approvata e
convertita in legge la deliberazione senatoriale di ripristinare il regime consolare e L. Icilio sottomise
all'approvazione la proposta d'immunità in favore di tutti coloro che avevano partecipato alla rivolta contro i
Decemviri. Si procedette infine alla nomina dei consoli che furono scelti nelle persone di L. VALERIO e M.
ORAZIO.
LE LEGGI VALERIE-ORAZIE
Questi due consoli rimasero famosi per tre leggi da loro presentate al Senato.
Con la prima era rimesso in vigore il diritto di provocazione e si dichiarava passibile di morte chiunque
creasse un magistrato senza facoltà d'appello; con la seconda si ripristinava l'inviolabilità dei tribuni della
plebe, che erano considerati sacrosanti, degli edili e dei giudici decemviri e si consacrava a Giove il capo di
chi a loro recava offesa e i beni erano confiscati e donati al tempio di Cerere. Inoltre era dichiarato reo di
morte colui che privava la plebe dei tribuni.
Con la terza legge erano ristabiliti i comizi tributi e si stabiliva che certe deliberazioni da loro prese avessero
valore per tutti i Romani, plebei e patrizi.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
24
CONDANNA DEI DECEMVIRI
Assicuratisi con queste leggi i diritti della plebe, si pensò di giudicare gli uomini che tante offese alla stessa
avevano fatte. Il tribuno VIRGINIO citò in giudizio Appio Claudio accusandolo di aver violate le leggi nel
processo della figlia. Appio si appellò agli altri tribuni, ma nessuno si levò in suo soccorso; allora si appellò a
quello stesso popolo che proprio lui aveva oppresso, ricordando i meriti dei suoi avi e le Dodici Tavole alla
cui compilazione lui aveva partecipato; ma Virginio si oppose che il decemviro rimanesse in libertà
provvisoria e, in attesa del giudizio, lo fece chiudere carcere.
Tutta la gente Claudia cercò di piegare l'animo dei tribuni alla pietà intercedendo in favore del decemviro e
perfino lo zio C. Claudio, che si era ritirato a vivere a Regillo e che anche lui aveva sempre rimproverato gli
atti del nipote, tornò a Roma per invocare la grazia ai tribuni. Ma questi furono inflessibili e, perduta ogni
speranza, Appio Claudio per non subire l'onta del giudizio della plebe si tolse la vita.
Dopo Appio fu accusato e citato da Publio Numitorio, Spurio Oppio, il quale, imprigionato, si tolse la vitaidò
pure lui prima di essere giudicato. Gli altri decemviri per sfuggire alla sorte che li aspettava andarono
volontariamente in esilio e tutti i loro beni furono confiscati. Forse altri uomini sarebbero stati citati in giudizio
dalla plebe assetata di giustizia e di vendetta; ma il tribuno Marco Duilio, per evitare che con altre condanne
gli animi s'inasprissero, dichiarò che non avrebbe permesso che altri fossero accusati e incarcerati dopo
l'esemplare condanna dei Decemviri e il ristabilimento del regime consolare e dei magistrati plebei.
VITTORIE SUI SABINI E SUGLI EQUI
Dato un riassetto alle cose della repubblica, fu ripresa la guerra contro i Sabini e gli Equi per ricacciarli dal
territorio romano. A combattere contro gli Equi e i Volsci uniti insieme andò il console Valerio, il quale alla
testa d'un esercito si accampò sull'Algido ad un miglio dal nemico. Ma non essendo, per le recenti discordie,
sicuro delle sue truppe ed essendo queste anche inferiori per numero a quelle avversarie, prudentemente si
tenne trincerato negli alloggiamenti; quando seppe però che i nemici, stanchi di provocare invano a battaglia
i Romani che credevano inattivi per paura, lasciando nel campo un esiguo presidio, s'erano recati a predare
nei paesi degli Ernici e dei Latini, finalmente si mosse a battaglia, e prima che Equi e Volsci potessero
schierarsi in ordine di combattimento li assalì impetuosamente con la fanteria, poi in parte circondati e in
parte sgominati con la cavalleria, prese d'assalto l'accampamento compiendo una strage, oltre che una
ricchissima preda.
Contro i Sabini fu mandato il console ORAZIO, che iniziò la campagna con scorrerie e scaramucce
vittoriose. Ma essendo giunta nel suo esercito la notizia della strepitosa vittoria delle truppe del collega né
potendo frenare il desiderio dei soldati, ordinò alle sue schiere la battaglia. Il cozzo fu tremendo e la lotta
altrettanto accanita. Poco però mancò che i Romani non perdessero la giornata perché, quando tutte le loro
forze erano impegnate, duemila fanti sabini di riserva entrarono in azione contro l'ala sinistra romana
respingendola e l'avrebbero circondata e massacrata se seicento cavalieri, smontati di sella e corsi nelle
prime linee, non avessero arginata l'impetuosa avanzata del nemico e non avessero trascinato con il loro
esempio le fanterie già in ritirata dopo il combattimento.
Ripreso l'ardire e nuovo vigore, i Romani ebbero il sopravvento e i Sabini, battuti duramente, fuggirono
lasciando il campo di battaglia.
Tornati a Roma, i due consoli vittoriosi chiesero al Senato di decretare a loro il trionfo, ma i senatori, pressati
dai patrizi preoccupati del crescente favore dei consoli plebei, si rifiutò. Contro il volere del Senato insorse il
tribuno Icilio, il quale propose che il trionfo fosse concesso tramite il plebiscito del popolo e così, per la prima
volta, senza l'autorizzazione del Senato, anzi contro l'espressa sua volontà, i consoli plebei ebbero
finalmente il loro trionfo.
Ma sia le leggi "Valerie-Orazie", che questo trionfo seminarono ulteriore malcontento, invidie e gelosie
nell'intollerante patriziato.
E' quello che leggeremo nel prossimo capitolo: il periodo dall'anno 445 al 391 > > >
Fonti, Bibliografia, Testi, Citazioni:
TITO LIVIO - STORIE (ab Urbe condita)
APPIANO - BELL. CIV. STORIA ROMANA
DIONE CASSIO - STORIA ROMANA
PAOLO GIUDICI - STORIA D'ITALIA
UTET - CRONOLOGIA UNIVERSALE
I. CAZZANIGA , ST. LETT. LATINA,
+ altri, in Biblioteca dell'Autore
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
25
LA LEGGE TREBONIA - LA CANULEIA - I TRIBUNI CONSOLARI 445-405 a. C.
LE LEGGI DUILIA E TREBONIA - BATTAGLIA DI CERBIONE - LA LEGGE CANULEIA - ISTITUZIONE DEL
TRIBUNATO CONSOLARE - I CENSORI - SPURIO MELIO - GUERRA CONTRO FIDENA E VEJO MORTO DEL RE TOLUNNIO - GUERRA CONTRO GLI EQUI E I VOLSCI. - GUERRA CONTRO I
FIDENATI E I VEJENTI - EMILIO MAMERCO DITTATORE - PRESA DI FIDENA - ALTRE GUERRE
CONTRO GLI EQUI E I VOLSCI; SESTO TEMPANIO - ROGAZIONE SUI QUESTORI - DITTATURA DI
SERVILIO PRISCO - CONQUISTA DI LABICO - ROGAZIONE DI MECILIO E METILIO - PRESA DI BOLA UCCISIONE DI POSTUMIO - DITTATURA DI PUBLIO CORNELIO - RESA DI ANXUR - PIU' PAGA AI
SOLDATI
--------------------------------------------------------------------------------------------------LE LEGGI TREBONIA E CANULEIA
Le leggi "valerie-orazie" avevano prodotto un grave malcontento nel patriziato che era diventato ancora più
infervorato quando, per volontà del popolo, era stato decretato il trionfo ai due consoli vittoriosi dei Sabini e
degli Equi. Temendo che le relazioni tra i due ceti divenissero più tese, e sospettando che i tribuni avessero
in animo di farsi rieleggere - il che avrebbe fatto peggiorare i rapporti fra patrizi e plebei, - M. DUILIO, uomo
prudente ed incline alla conciliazione degli animi, trovandosi presidente dei comizi delle tribù, propose che
non fossero rieletti i tribuni uscenti e assicurò che avrebbe dichiarato illegali e perciò nulli i voti dati a quelli.
Con questo singolare veto, l'effetto fu che solo cinque tribuni furono legalmente eletti, e M. DUILIO, anziché
fare altre elezioni per completare il numero dei magistrati, propose una legge con la quale si stabiliva che i
tribuni eletti potevano a loro volta nominare uomini da loro scelti per i posti rimasti vacanti. La legge,
approvata, andò subito in esecuzione e i tribuni, spinti da Duilio, con lo scopo di migliorare i rapporti con il
patriziato, si scelsero come colleghi tre plebei e due patrizi amici della plebe, SPURIO TARNEJO ed AULO
ATERNIO.
L'elezione a tribuni plebei di patrizi costituiva però un pericolo non lieve per la plebe, di modo che il tribuno L.
TREBONIO, nel 306 (448 a.C.) propose e fece approvare una legge che annullando quella di M. Duilio,
stabiliva che per completare il numero legale dei tribuni dovevano farsi altre elezioni in seno alle tribù. Le
cosiddette "leggi duilia e trebonia" non valsero a rendere migliori le relazioni tra i due ceti; anzi il desiderio di
conciliazione dei tribuni plebei interpretato come debolezza rese più audaci i giovani patrizi, i quali, più di
una volta, provocarono atti di violenza disturbando le assemblee popolari.
Le discordie intestine fecero rialzar la testa ai nemici esterni, ed Equi e Volsci più di una volta sconfitti dai
Romani, invasero prima il territorio dei Latini e, non trovando chi contrastasse loro il passo, si spinsero poi fin
presso la porta Esquilina devastando il contado di Roma e procurandosi e portando poi gran quantità di
bottino a Cerbione, dove posero il campo.
Di fronte al pericolo, rimproverati dai nobili e dalle severe parole del console QUINZIO CAPITOLINO e
sdegnati per le devastazioni, i plebei corsero alle armi ed è fama che un solo giorno bastò per allestire un
forte esercito; che, uscito da Roma, andò incontro al nemico. Schieratesi le truppe romane a battaglia,
Quinzio Capitolino assunse il comando all'ala destra, il collega AGRIPPA FURIO della sinistra, SPURIO
POSTUMIO ALBO del centro; e alla cavalleria fu preposto PUBLIO SULPICIO.
Il combattimento, iniziato dall'ala destra, presto divenne generale. Resistendo vigorosamente l'ala sinistra dei
nemici agli assalti delle fanterie di Quinzio, Publio Sulpicio entrò da quella parte in azione con i cavalieri e
ruppe le file avversarie, ma, sopravvenuta la cavalleria degli Equi e dei Volsci, per non essere preso in
mezzo a quel punto assalì con energia anche i cavalieri facendo strage di uomini e di cavalli.
Il centro e l'ala sinistra dell'esercito nemico furono i primi ad essere frantumati; maggiore resistenza oppose
la destra, ma anche di questa ebbe ragione Agrippa e, dopo una battaglia cruenta, i Romani conquistarono il
campo dei Volsci e degli Equi impadronendosi di ingente bottino.
Ricacciato il nemico, ripresero le contese tra il patriziato e la plebe, e questa, vista fallire la sua politica
conciliatrice, volle con azione energica strappare ai patrizi nuove concessioni.
Nel 309 C. CANULEIO, eletto tribuno, presentò una rogazione con la quale chiedeva che fosse abolita
quella legge delle XII Tavole che proibiva i matrimoni tra patrizi e plebei ed assegnava al ceto plebeo la prole
nata da unioni miste. Contemporaneamente altri tribuni proposero che uno dei due consoli fosse plebeo. I
patrizi accolsero le proposte con grandi ostilità; il Senato non volle sanzionarle e cercò in tutti i modi che le
proposte sarebbero state ritirate, minacciando di chiamare la plebe sotto le armi; tentando così di seminare
la discordia fra i tribuni e prospettando il pericolo di un'invasione nemica.
Ma Canuleio fu irremovibile e il Senato, sperando che gli altri nove tribuni avrebbero ritirata l'altra rogazione,
accordò la sanzione alla legge sui matrimoni tra patrizi e plebei.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
26
Gli altri tribuni invece mantennero risolutamente integra la loro proposta e, resi più audaci dal successo di
Canuleio, ricorsero pure alle violenze. Finalmente il Senato cercò di accontentare la plebe con l'istituzione di
tribuni militari investiti della potestà consolare da scegliersi tra patrizi e plebei; ma il vantaggio che ne ricavò
la plebe fu più formale che sostanziale. Infatti, con la nuova magistratura non veniva ad abolirsi il consolato,
ed era facoltà del popolo di eleggere ogni anno o due consoli o dei tribuni consolari; ma, siccome l'elezione
avveniva tra i comizi centuriati, così i patrizi avevano sempre la sicurezza che gli eletti fossero in
maggioranza del proprio ceto.
Inoltre per evitare che la potestà censoria - la quale era stata fino allora esercitata dai consoli - cadesse in
mano ai plebei crearono dei magistrati speciali: i "censori". Questi ebbero l'incarico di assegnare i cittadini
nelle varie classi secondo il censo, di compilare la lista dei senatori, di trasferire i cittadini da una classe
all'altra, di fare l'elenco dei cavalieri e degli stranieri che risiedevano a Roma, di vigilare sui costumi
applicando pene contro coloro che li offendevano e infine di dirigere i lavori pubblici (strade, acquedotti,
edifici, ecc.) e di amministrare le rendite della repubblica.
I censori pure questi erano scelti soltanto fra i patrizi e duravano in carica cinque anni; più tardi, con la "legge
Mamerca-Emilia" la loro durata fu ridotta a diciotto mesi.
I TRIBUNI CONSOLARI E SPURIO MELIO
I primi tribuni consolari - che entrarono in carica nel luglio del 310 - furono A. SEMPRONIO ATRATINO, T.
CECILIO e L. ATILIO, dei quali l'ultimo (o gli ultimi due, secondo alcuni storici) era plebeo.
Dovevano poi passare quarantun anni, prima che la plebe tornasse ad avere nel tribunato consolare un suo
rappresentante.
Infatti, i tre tribuni però non durarono a lungo nel loro ufficio e circa tre mesi dopo la loro elezione furono
costretti dal Senato a dimettersi con il pretesto che erano stati eletti senza l'intervento degli auguri ai comizi
elettorali.
Alle loro dimissioni, accolte secondo alcuni senza proteste, secondo altri con tumulti da parte della plebe,
successe un interregno, o, come vogliono alcuni storici, un dittatore; indi fu ripristinato il consolato, che, per
molti anni, poi si alternò con il tribunato consolare.
Nel 314 (440 a.C.) Roma fu afflitta da una carestia ed un ricco plebeo di nome SPURIO MELIO, per alleviare
le misere condizioni della plebe, fatta arrivare a sue spese una gran quantità di grano dall'Etruria e dalla
Campania parte la distribuì gratuitamente ai poveri, parte la vendette a basso prezzo. La generosità di Melio
fu, dal patriziato, interpretata come brama di conquistarsi il favore popolare per poi conseguire la signoria.
Accusatolo di aspirare alla tirannide e facendo credere che la repubblica era in pericolo, il Senato creò
dittatore QUINZIO CINCINNATO, il quale a sua volta creò maestro della cavalleria C. SERVILIO AHALA.
Questi incontrato nel foro SPURIO MELIO, lo uccise, e il Senato confiscò i beni dell'assassinato e, per dare
un esempio, fece demolire la nuova casa.
Secondo altri storici fu L. MINUCIO, prefetto dell'annona, che accusò Spurio Melio, rappresentandolo al
Senato come uomo ambizioso e pericoloso alla repubblica, e fu il Senato che diede mandato a C. Servilio di
trucidare il ricco plebeo. A L. Minucio fu decretata dai senatori una statua, ma Servilio dovette fuggire da
Roma per salvarsi dal furore della plebe.
GUERRA CONTRO VEJO E FIDENA
In mezzo a tante discordie ed essendo così accanite le lotte tra i due ceti, non deve fare meraviglia se i
nemici osarono recare offese a Roma e provocare guerre. Fra le città nemiche, Fidena era la più pericolosa,
perché vicina a Roma. Nel 318 Fidena scacciò - come pare - la colonia romana e si alleò con Vejo; poi, non
paga di questo, uccise gli ambasciatori romani CAJO FALCINIO, CLELIO TULLO, SPURIO ANZIO e LUCIO
ROSCIO.
Smorzate le discordie di fronte al contegno dei nemici, furono eletti consoli MARCO GEGANIO MACERINO
e LUCIO SERGIO; quest'ultimo fu incaricato della campagna contro Fidena e in una giornata campale contro
i nemici, riportò una sofferta cruente vittoria, che, per le numerose perdite subite, fu per i Romani peggiore di
una sconfitta.
Fu allora dal Senato creato dittatore MAMERCO EMILIO, che nominò maestro della cavalleria LUCIO
QUINZIO CINCINNATO, figlio del famoso dittatore, e come suoi luogotenenti QUINZIO CAPITOLINO e
MARCO FABIO VIBULANO. All'avanzarsi dell'esercito romano, rinforzato da veterani, i nemici si ritirarono di
là dall'Aniene, occupando le colline tra questo fiume e Fidena, e non scesero al piano fino a che non
ricevettero soccorsi dai Falisci. Solo allora si accamparono davanti le mura di Fidena e l'esercito romano
pose il campo alla confluenza dell'Aniene con il Tevere; e fu qui che avvenne lo scontro.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
27
Nello schieramento nemico i Vejenti avevano l'ala destra, i Falisci la sinistra e i Fidenati il centro. Contro le
ali mossero all'attacco Mamerco e Quinzio Capitolino, Cincinnato fece il suo assalto contro i Fidenati e
benché i Romani combattessero con straordinario valore al primo urto non riuscirono a sfondare le schiere
nemiche, specialmente quelle all'ala destra, perché la cavalleria di Vejo oppose un'ostinata resistenza,
incoraggiata da LARTE TOLUNNIO, loro re, che personalmente partecipava e sosteneva la battaglia; che
chissà quanto tempo sarebbe durato se il tribuno AULO CORNELIO COSSO, uomo atletico e di grande
coraggio, riconosciuto il re dalle vesti e dalle insegne, dato di sprone al cavallo, non l'avesse investito con la
lancia e buttato giù di sella. Scaraventato il re a terra, più volte Cosso lo colpì con lo scudo e con la lancia
finché non l'ebbe ucciso, indi, spogliatolo, gli recise il capo, e questo, conficcato sulla punta della lancia, lo
portò in giro nella mischia, sgomentando la cavalleria nemica, che girate le spalle abbandonò il campo con
una precipitosa fuga.
Il valore di COSSO decise le sorti delle battaglia, le legioni romane inseguirono il nemico fino al campo
conquistandolo; fu fatta una strage enorme di Vejenti e Falisci e solo alcuni Fidenati riuscirono a salvarsi
fuggendo sui vicini monti. Durante questa battaglia il campo romano fu assalito da una schiera di Vejenti, ma
Fabio Vibulano, che lo difendeva, fatta un'improvvisa sortita con i triarii, sorprese il nemico sulla destra,
prima lo mise in disordine poi lo costrinse alla fuga.
Trionfale fu il ritorno dell'esercito vittorioso a Roma; Cosso sospese le spoglie di Tolunnio nel tempio di
Giove Feretrio e, per volontà del popolo, fu posta in Campidoglio dal dittatore in onore di Giove una corona
d'oro del peso di una libbra.
L'anno seguente (319 A. di R. - 535 a.C.), sotto il consolato di MARCO CORNELIO MALUGINENSE e
LUCIO PAPIRIO CRASSO, furono fatte delle incursioni nel territorio dei Vejenti e dei Falisci, ma nessun
notevole fatto d'arme avvenne.
Quello stesso anno la peste infuriò a Roma e si rinnovò con tal violenza nel 320 (534 a.C.) che più nessuno
pensò alla guerra; ma i Fidenati, approfittando della strage che il morbo causava nella città, penetrarono
saccheggiando il territorio romano, poi, chiamati i Vejenti, passarono con questi l'Aniene e si spinsero
minacciosi sino alla porta Collina; ma quando seppero che era stato creato un dittatore nella persona di
AULO SERVILLO e che l'esercito romano si preparava ad uscire, si ritirarono sulle alture.
Qui però Servilio raggiunse i nemici e li sconfisse, poi li insegui fin sotto le mura di Fidena intorno alla quale
pose l'assedio. Ma la città era forte per posizione ed abbondantemente fornita di vettovaglie né per forza o
per fame poteva esser conquistata. Tuttavia Servilio non desistette dal proposito d'impadronirsene ed ordinò
che si scavasse una galleria nei fianchi del monte, tenendo notte e giorno impegnati i fidenati dalla parte
opposta perché non si accorgessero dei lavori; terminati i quali, i Romani la imboccarono e sbucarono
improvvisamente dentro la rocca e, mentre i difensori sulle mura erano intenti a ributtare le schiere di Servilio
che accortamente simulavano di volerle scalare, le sempre più numerose "talpe" che sbucavano dalla
galleria in breve si resero padroni della città.
GUERRE CONTRO GLI EQUI E I VOLSCI
La presa di Fidena preoccupò moltissimo Vejo ed i Fallisci; ma anche Roma era inquieta quando corse voce
che gli Etruschi si apprestavano a fare una coalizione ai danni della repubblica. Fu creato per la seconda
volta dittatore MAMERCO EMILIO, il quale -risultati infondati i timori di una guerra contro i popoli dell'Etruria
- rivolse il pensiero ad opere di pace e propose una legge con la quale la durata in carica dei censori fosse
ridotta da cinque anni ad un anno e mezzo. La legge del dittatore se ebbe l'approvazione unanime del
popolo, suscitò lo sdegno dei patrizi e dei censori, e Mamerco, che alla fine si era dimesso, fu privato perfino
dei diritti di cittadino.
La guerra, che Roma si aspettava dagli Etruschi, fu invece messa in moto alcuni anni dopo (324) dai Volsci
e dagli Equi, che, radunati due forti eserciti, si accamparono all'Algido.
Vinta la resistenza dei consoli TITO QUINZIO CINCINNATO, figlio di Lucio, e GNEO GIULIO MENTONE,
che non volevano cedere la carica, fu creato dittatore AULO POSTUMIO TIBERONE. Questi, oltre i Romani,
convocò alle armi gli Ernici e i Latini e con un poderoso esercito marciò verso l'Algido, dove giunto, passò
alcuni giorni a scaramucciare con i nemici, poi, afferrato il momento buono, li costrinse a una battaglia
campale. Questa fu piuttosto accanita; il dittatore fu ferito al capo, il luogotenente Marco Fabio ad una
coscia, e il console Cincinnato un braccio tagliato, tuttavia i nemici furono sbaragliati, espugnati i campi degli
Equi e dei Volsci, fatti moltissimi prigionieri, portato via un enorme bottino.
L'anno seguente gli Equi chiesero ed ottennero una tregua di otto anni.
PRESA DI FIDENA
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
28
Roma visse in pace per alcuni anni; ma nel 327 (427 a.C.) i Vejenti misero in atto alcune scorrerie nel
territorio romano e invano il Senato inviò a Vejo i Feciali per chiedere la restituzione della preda. Allora
l'anno dopo fu dichiarata la guerra (328) ed il comando delle milizie romane fu affidato ai tribuni consolari
QUINZIO CINCINNATO, CAJO FURIO e MARCO POSTUMIO. Però al primo scontro con i Vejenti,
mancando nelle truppe romane l'unità di comando, queste furono messe in fuga e costrette a riparare
nell'accampamento; fu più la vergogna che non il danno.
Si sentì allora a Roma il bisogno di ricorrere alla dittatura e fu innalzato in tale carica ancora una volta
MAMERCO EMILIO, che, dimenticando i danni ingiustamente ricevuti dai censori, accettò. Rincuorata la
cittadinanza, che si era scoraggiata per lo scacco subito e perché ai Vejenti si erano aggiunti i Fidenati, e
fatti voti e sacrifici, partì con l'esercito e si accampò tra il Tevere e i monti, a un miglio e mezzo da Fidena.
Fatte occupare segretamente le alture da alcune schiere al comando di QUINZIO CINCINNATO, il dittatore
con il grosso della truppa impegnò il combattimento e già al primo scontro gli era riuscito a far ripiegare il
nemico, quando da Fidena irruppe una colonna nemica armata di fiaccole che assalì furiosamente l'ala
sinistra romana e l'avrebbe scompigliata se non fosse intervenuta in tempo la cavalleria al comando di AULO
CORNELIO COSSO e dai monti non fossero scese le schiere di Cincinnato. Presi di fronte e alle spalle,
Vejenti e Fidenati subirono una sanguinosa sconfitta. Molti furono tagliati a pezzi, molti altri perirono
miseramente nel fiume cercando scampo, pochissimi riuscirono a fuggire a Fidena, dove furono peraltro
inseguiti e massacrati. La città fu poi presa e saccheggiata e l'esercito rientrò trionfante a Roma.
Ai Vejenti fu concessa una tregua di venti anni.
Nel 332 (422 a.C.) Roma tornò a combattere ancora contro i Volsci, ma le sorti di questa offensiva, per
l'imprudenza e la leggerezza del console CAJO SEMPRONIO ATRATINO, non furono all'inizio favorevoli ai
Romani e in una sanguinosa battaglia il loro esercito sarebbe stato vergognosamente sconfitto se un
decurione della cavalleria di nome SESTO TEMPANIO, consigliati i cavalieri a scender da cavallo, non li
avesse con estrema vigoria guidati contro i Volsci. Questi, non potendo resistere all'urto, ricorsero ad uno
stratagemma e, aperte le file, diedero spazio ai cavalieri romani di addentrarsi fra le truppe nemiche, poi si
chiusero e quelli rimasero accerchiati.
La battaglia così si frazionò, ma già le legioni romane, riordinatesi e ripreso animo, guadagnavano terreno e
Sesto Tempanio, rifugiatosi con i suoi uomini sopra un'altura, si difendeva abbastanza bene dai continui
assalti dei Volsci.
Solo la notte pose termine al combattimento e Romani e Volsci, anziché ritirarsi negli alloggiamenti,
andarono sui vicini monti. Soltanto una parte di Volsci rimase fino alla mezzanotte ad assediare i cavalieri
romani, ma informati che il loro campo era stato abbandonato, si ritirarono pure loro e di mattino, Tempanio
con i cavalieri superstiti, non sapendo dove il console era andato, fece ritorno a Roma, dove lo stesso giorno
da un'altra strada giunse Sempronio con il resto dell'esercito.
Due anni dopo (334 A di R. - 420 a.C.), tentarono gli Equi di scatenare un'offensiva contro i Romani, ma
questi con il comando del console GNEO FABIO VIBULANO, prima che i nemici potessero darsi un assetto
per la battaglia, li assalirono e li misero in fuga.
Per circa due anni Roma non fu più molestata dai nemici, ma non per questo rimase tranquilla perché il
desiderio dei plebei di acquistare altri diritti e il proposito dei patrizi di non concederne continuo a tenere
accesa la discordia nei due ceti.
ROGAZIONE SUI QUESTORI - PRESA DI LABICO
Dovendosi portare da due a quattro il numero dei questori, i tribuni della plebe chiesero che almeno due
fossero per legge plebei. Prima si rifiutò il Senato poi, avendo insistito i tribuni e fattasi sentire la plebe
rumoreggiando minacciosamente, accolse la domanda dei tribuni con la stessa modificazione apportata alla
richiesta dei plebei in occasione dell'istituzione del tribunato consolare. Si concedeva cioè che quella carica
potesse essere ricoperta anche da plebei.
La proposta di accrescere il numero dei questori a quattro, di cui due ("quaestores urbani parricidii")
dovevano rimanere a Roma e gli altri due ("quaestores aerarii o militares") dovevano accompagnare i consoli
nelle spedizioni militari per soprintendere all'amministrazione delle truppe ed alla distribuzione del bottino; la
proposta era stata fatta nel 333 dai consoli ed i tribuni l'avevano accettata a patto però che due fossero scelti
tra la plebe. I tribuni rifiutarono la modificazione proposta dal Senato e i consoli ritirarono la loro rogazione;
ma i tribuni presentarono a proprio nome la rogazione alle proprie tribù.
Il Senato si oppose alla convocazione dei comizi popolari e proclamò l'interregno. L'interRe L. PAPIRIO, nel
334, per calmare l'agitazione dei plebei, propose al Senato di creare, invece dei consoli, dei "tribuni
consolari", i quali dovevano accettare le rogazione dei consoli dell'anno precedente con la modifica del
Senato.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
29
I tribuni dovettero piegarsi e, giunti alle elezioni, cercarono di far emergere i candidati plebei; furono invece
eletti dei patrizi. Enorme fu il malcontento della plebe, fu accusato AULO SEMPRONIO ATRATINO,
presidente dei comizi, di avere alterato lo scrutinio, ma, non essendo sostenuta da prove, l'accusa si lasciò
cadere e l'ira popolare si rivolse su un parente di Aulo, sull'ex-console Cajo Sempronio che, processato per
la condotta della passata guerra, fu condannato ad una multa.
La carica di questore fu per parecchi anni di seguito occupata dai patrizi e fu soltanto nel 345 che alla plebe
riuscì a far eleggere alcuni questori plebei.
Placate le discordie, seguì un periodo di pace di alcuni anni turbato solo da un fallito tentativo di alcuni
schiavi di appiccare il fuoco alla città in vari punti per poter poi occupare il Campidoglio. Ma la congiura fu
denunciata da due schiavi che, in premio, ottennero la libertà e diecimila assi.
L'anno seguente, 337 di Roma (417 a.C.) essendo tribuni consolari LUCIO SERGIO FIDENATE, MARCO
PAPIRIO MUGELLANO e CAJO SERVILIO, i Labicani e gli Equi, uniti in un'alleanza, invasero e
saccheggiarono il territorio di Tuscolo, che chiese aiuti ai Romani.
Formate le legioni con elementi di sole dieci tribù, furono inviati contro il nemico i tribuni SERGIO e
PAPIRIO. Purtroppo la concordia non regnava tra i due capi e, volendo ciascuno che il proprio volere
prevalesse, fu stabilito che il comando supremo dell'esercito fosse tenuto un giorno da uno e un giorno
dall'altro.
Un giorno in cui il comando era affidato a Sergio, questi assalì con le truppe il campo nemico, dove gli Equi
si erano ritirati fingendo di aver paura, ma, fatta il nemico un'improvvisa e vigorosa sortita, i Romani furono
con gravi perdite ributtati e a stento riuscirono a difendere i propri alloggiamenti.
Ma il giorno dopo assaliti dagli Equi, i Romani vergognosamente abbandonarono anche quelli; i tribuni con
una parte della truppa si ritirarono a Tuscolo, il resto si sparse per la campagna e alla spicciolata se ne
ritornarono a Roma.
Fu allora creato dittatore QUINTO SERVILIO PRISCO, che, nominato Cajo suo figlio maestro della
cavalleria, raccolto un secondo esercito e richiamate da Tuscolo le superstiti milizie, marciò verso l'Algido
contro il nemico con il quale ben presto entrò in battaglia.
Il primo urto fu dato dalla cavalleria romana, che sgominò la prima linea avversaria. Servilio ordinò che le
fanterie sfruttassero il successo iniziale dei cavalieri entrando prontamente in azione; si narra che avendo
visto un vessillifero indugiare, gli corresse addosso e lo uccidesse.
I nemici non resistettero all'assalto delle legioni romane; girate le spalle, si affrettarono a rifugiarsi nel campo
ma anche da quello dovettero sloggiare e non trovarono scampo che dentro le mura di Labico. Ma per poco
tempo, perché il Dittatore, saccheggiato l'accampamento e distribuita la preda ai soldati, andò a porre
l'assedio alla città e, il giorno dopo, assalita con impeto la costrinse alla resa.
Per deliberazione del Senato il territorio di Labico fu confiscato e su quello fu inviata una colonia di mille e
duecento Romani, a ciascuno dei quali toccarono due iugeri di terra.
ROGAZIONE DI MECILIO E METILIO
GUERRE CONTRO GLI EQUI E I VOLSCI
Nel 339 (415 a.C.) i due tribuni della plebe SPURIO MECILIO e METILIO tornarono ad agitare la questione
della legge agraria e presentarono una rogazione che proponeva la divisione di tutto il territorio sottratto ai
nemici.
La proposta, se accettata, avrebbe danneggiato enormemente i patrizi; non deve quindi recare meraviglia se
questi cercarono tutti i modi per far cadere la rogazione.
Non sapendo i senatori cosa fare, uno di loro, Appio Claudio, della famiglia del famigerato decemviro, uomo
astuto, ambizioso e di animo vile, consigliò i suoi colleghi di trarre dalla loro parte i tribuni plebei e
persuaderli ad opporre il veto. Il consiglio piacque ai senatori, i quali tanto seppero fare e dire che
guadagnarono alla causa del patriziato sei tribuni plebei su dieci. Questi, chiamati alla Curia, dichiararono
che si sarebbero opposti a qualsiasi proposta dei propri colleghi che fosse "dal Senato giudicata dannosa
alla Repubblica"; la frase era velatamente ambigua, ma non sfuggì all'indignazione della plebe; Mecilio e
Metilio chiamarono i sei tribuni traditori del loro ceto e schiavi dei patrizi.
Alle discordie tra i due ceti si aggiunse la guerra contro gli Equi scoppiata nel 341. Capo dell'esercito romano
fu fatto il tribuno consolare MARCO POSTUMIO REGILLENSE, il quale, per spingere i soldati a combattere
con maggior animo, promise loro di ripartire il bottino che avrebbero fatto espugnando la città di Bola che
andavano ad assalire. Vinti e sbaragliati gli Equi in pochi e facili scontri, Bola fu presa, ma non mantenne il
tribuno la promessa, anzi, proposto dal tribuno Sestio, richiamato a Roma dal Senato per dare il proprio
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
30
parere intorno all'invio di una colonia a Bola, disse pubblicamente quando si accennò al malcontento delle
sue truppe: "Guai ai miei soldati se non staranno calmi".
Queste parole, riportate al campo, fecero crescere nei soldati il malcontento, il quale ben presto si mutò in
una pericolosa potenziale ribellione, anche perché littori e centurioni cercavano di trattenerla con la violenza;
ma non valse a nulla la loro autorità né quella dei questori militari, uno dei quali a stento inseguito riuscì
salvarsi con la fuga da una fitta sassaiola.
Di peggio avvenne quando proprio l'arrogante POSTUMIO, tornato fra le "sue" truppe, cercò di reprimere
con la forza la ribellione, la quale, al contrario, con la sua presenza divampò ancora più furiosa e non si
calmò se non quando il tribuno consolare, anche lui lapidato, restò vittima del furore dei soldati.
I guai che aveva promesso, se li era andati proprio a cercare
La notizia dell'uccisione di Postumio portò a Roma la costernazione e il Senato stabili di punire severamente
i colpevoli. I tribuni della plebe, data la gravità della situazione, tentarono di calmare lo sdegno dei senatori,
ma questi, fermi nel loro proposito, cercarono di approfittare del subbuglio per abbattere il tribunato
consolare e di eleggere i consoli. E vi riuscirono. Nominando interRè FABIO VIBULANO, e questi nel 342
indisse i comizi consolari che elessero consoli AULO CORNELIO COSSO e LUCIO FURIO MEDULLINO.
Ai due fu dalla plebe affidato l'incarico di giudicare i colpevoli della morte di Postumio; vi furono alcune
condanne alla pena capitale alla quale i rei si sottrassero dandosi di propria mano la morte. Questo fatto
aumentò l'odio della plebe, lagnandosi che la legge prontamente era applicata soltanto per punire i misfatti
dei plebei, mentre si metteva da parte quando si trattava di difendere i diritti del popolo.
Il quale non aveva dimenticato di insistere sulla divisione del territorio Bolano. Ed erano tanto esasperati gli
animi per l'opposizione del Senato, che sarebbero certamente nati, come a Bola, altrettanto simili gravi
tumulti se i Volsci, invadendo il territorio degli Ernici, non avessero paradossalmente cooperato a smorzare
le lotte intestine.
Tuttavia contro il nemico secolare fu inviato il console LUCIO FURIO, che, assalito Ferentino, dove una
grande moltitudine di Volsci si era rifugiata, la costrinse alla resa. Scarso fu il bottino; il territorio fu poi
affidato agli Ernici. Ma appena finita la guerra, si riaccesero le discordie interne e il tribuno LUCIO ICILIO,
all'inizio del 343; ripresentò la legge agraria; ma, sopraggiunta una mortale pestilenza, i pensieri dei cittadini
furono rivolti alla salute pubblica.
Essendo state lasciate incolte le terre dopo la peste seguì la carestia e, nel 344, il Senato fu costretto a
mandare ambasciatori presso i popoli vicini affinché acquistassero il frumento per attenuare la fame. Si
opposero alla compera i Sanniti che si erano resi padroni di Capua e di Cuma, ma una grande quantità
giunse dalla Sicilia e dall'Etruria. Ma era destino che a Roma finito un guaio ne sopraggiungesse un altro.
Erano tornati in arme gli Equi e i Volsci ed erano ancora una volta penetrati nel territorio dei Latini e degli
Ernici.
Correva l'anno 345 (409 a.C.) e tenevano il consolato MARCO EMILIO e CAJO VALERIO POTITO.
Quest'ultimo ordinò la leva militare, ma si oppose il tribuno MARCO MENIO, uno dei più tenaci sostenitori
della legge agraria. Essendo in quel frattempo i nemici riusciti ad occupare la Rocca Carventana, non fu
difficile a Valerio chiamare alle armi le legioni, alla testa delle quali il console diede l'assalto alla rocca e la
costrinse alla resa. Ordinò però che il bottino fosse dai questori venduto a beneficio dell'erario pubblico e
non distribuito fra i soldati, per punire costoro di non essersi arruolati al primo appello. Aumentò per questo
l'ira dei soldati e della plebe contro il console e quando questi, alla testa delle truppe, fece il suo ingresso a
Roma, dall'esercito si cantarono sconce canzoni all'indirizzo di Valerio e si inneggiò a MENIO.
Più che i dileggi cui era stato fatto segno Valerio il patriziato era preoccupato per il favore cresciuto presso il
popolo per Menio, e temendo che costui, il quale evidentemente aspirava al tribunato consolare, potesse
conseguirlo, il Senato convocò i comizi consolari, dai quali furono creati consoli per la seconda volta GNEO
CORNELIO COSSO e LUCIO FURIO MEDULLINO. Questo irritò ancora di più la plebe che nell'elezione dei
questori dell'anno 345 fece uscire tre plebei, QUINTO SILIO, PUBLIO ELIO e PUBLIO PIPIO, contro un solo
patrizio, FABIO AMBUSTO.
Il merito si dovette specialmente alla famiglia plebea degli ICILII che in quell'anno ottenne tre rappresentanti
nel tribunato della plebe. Per la vittoria conseguita i plebei diventarono più esigenti; ma giunse a proposito
per i patrizi (346) la notizia che Volsci ed Equi avevano invaso il territorio dei Latini e degli Ernici, ed i consoli
- volendo tenerli impegnati- chiamarono i cittadini alle armi.
Si opposero però i tribuni, ma essendo il momento d'estrema gravità poiché la Rocca Carventana era caduta
in potere degli Equi che n'avevano trucidato il presidio, il Senato si vide costretto a decretare che nelle future
elezioni sarebbero stati creati i tribuni consolari mettendo però come condizione che non potevano essere
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
31
eletti coloro che già coprivano la carica di tribuni della plebe. Questa clausola del Senato mirava
evidentemente ad escludere dalla suprema magistratura della repubblica gli ICILII. E solo allora poterono
cominciarono gli arruolamenti e gli altri preparativi di guerra. Quando fu pronto, l'esercito romano partì per
andare ad assalire la Rocca Carventana, ma i nemici si difesero così strenuamente che, riusciti inutili tutti gli
sforzi per prenderla, i Romani invasero il territorio dei Volsci e degli Equi che predandolo e devastandolo alla
fine conquistarono Verruca.
Terminato l'anno (346), furono convocati i comizi, ma anche questa volta furono patrizi gli eletti e cioè CAJO
GIULIO JULO, GNEO CORNELIO COSSO e CAJO SERVILIO ALA.
La guerra con i Volsci e con gli Equi intanto ricominciava e il nemico ad Anzio riuniva grandi forze.
Nonostante l'opposizione di due tribuni consolari, il Senato nominò dittatore PUBLIO CORNELIO che scelse
come maestro della cavalleria SERVILIO ALA. Le operazioni non furono lunghe e difficili; i nemici furono
sbaragliati ad Anzio in una battaglia di non grande importanza, fu poi percorso e saccheggiato il territorio dei
Volsci e conquistato a viva forza un castello sul lago Fucino, dove furono fatti tremila prigionieri (347 A.di R. 407 a.C.)).
I Volsci però non disarmarono e l'anno seguente ripresero ai romani Verruca, massacrandone il presidio.
Una clamorosa rivincita fu presa dai Romani nel 348. Dei quattro tribuni consolari che erano in carica, tre
furono inviati con un esercito ciascuno contro i Volsci, PUBLIO CORNELIO COSSO, LUCIO VALERIO
POTITO e CAJO FABIO AMBUSTO. Quest'ultimo pose l'assedio alla città di Anxur, l'odierna Terracina, e
dopo un accanito combattimento costrinse i difensori alla resa. I cittadini ebbero salva la vita, ma i loro beni
furono distribuiti ai soldati dei tre eserciti, che ricchi di bottino se ne tornarono a Roma.
Quell'anno stesso il Senato decretò di concedere ai soldati la paga con i fondi dell'erario pubblico. Questa
concessione non fu fatta certamente per amore alla plebe, ma perché era in vista una guerra di conquista
lunga e impegnativa e il Senato voleva ingraziarsi l'animo dei plebei, evitare tumulti ed opposizioni durante i
preparativi, ed infine a far sì che i soldati quando sarebbe arrivato il giorno dell'offensiva si battessero con
maggiore ardore.
Ma questa offensiva contro chi era? Contro l'odiata Vejo ed è narrata nel prossimo capitolo il periodo
dall'anno 406 al 391 a.C. > > >
Fonti, Bibliografia, Testi, Citazioni:
TITO LIVIO - STORIE (ab Urbe condita)
APPIANO - BELL. CIV. STORIA ROMANA
DIONE CASSIO - STORIA ROMANA
PAOLO GIUDICI - STORIA D'ITALIA
UTET - CRONOLOGIA UNIVERSALE
I. CAZZANIGA , ST. LETT. LATINA,
+ altri, in Biblioteca dell'Autore
ULTIMA GUERRA CONTRO VEJO - L'INGRATITUDINE A CAMILLO (406-391 a. C.)
GLI ETRUSCHI - L'ULTIMA GUERRA CONTRO VEJO - RESPONSO DELL'ORACOLO DI DELFO DITTATURA DI MARCO FURIO CAMILLO - PRESA DI VEJO - CAMILLO A FALERIA - ESILIO DI CAMILLO
-----------------------------------------------------Abbiamo visto come il Senato Romano, già progettava una guerra di conquista. Per ingraziarsi la plebe, che
da qualche tempo era restia a presentarsi alla chiamata alle armi, concesse a spese dell'erario le paghe ai
soldati.
La guerra messa in programma era quella contro Vejo, e questa volta Roma era determinata a chiudere una
volta per sempre il conflitto con la potente città etrusca quasi alle porte della città, assoggettarla, annettersi il
territorio e sottomettere la popolazione raggruppata in quattro tribù.
Dunque contro Vejo era rivolta quella guerra che Roma già da oltre un anno si preparava a combattere.
Vejo rappresentava per Roma sempre un pericolo perenne; era la sentinella avanzata dell'Etruria e nel
medesimo tempo era la fortezza che sbarrava ai Romani la via verso il nord, dove Roma iniziava già a
guardare. Inoltre quella barriera quasi davanti alle porte di casa, limitava l'azione commerciale sul Tevere
verso l'interno.
Di questo fiume Roma occupava la sponda sinistra, difesa dal baluardo del Gianicolo; invece testa di ponte
sulla sponda opposta, l'odiata Vejo sorgeva alla destra ed a sua volta aveva come punto avanzato, sull'altra
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
32
riva, la città amica Fidena. Su Roma, Vejo aveva un indiscutibile vantaggio: quello della posizione, resa
ancora più forte dalle potenti opere di difesa che erano state costruite sul confine.
Roma non temeva soltanto Vejo come solo una città rivale. Questa era la più ricca e una delle più forti città
etrusche; inoltre costituiva l'avanguardia di un popolo di razza diversa che mirava ad espandersi verso il sud;
un popolo che era giunto a un alto grado di civiltà e di floridezza. Anzi fra i popoli d'Italia era il più potente e
civile, e avrebbe potuto dominarli tutti se non gli avessero fatto difetto i grandi ideali politici, piuttosto ottusi e
limitati. La politica etrusca difatti non fu mai quella di una grande nazione; nelle loro stesse città stato vi era
sempre una lotta sterile e continua tra la monarchia e l'aristocrazia; lotte alternate a spedizioni di conquista,
ma poi ognuno tornava nel proprio piccolo "cortile".
Nonostante tra città e città non ci fossero rivalità ed interessi contrastanti e nonostante i vari Stati fossero
stretti in una lega religiosa, gli Etruschi non concepirono mai un'Etruria unita che potesse resistere ai popoli
rivali o con l'idea di assoggettarli; né fra i dodici Stati ce ne fu uno che s'imponesse agli altri o li guidasse per
sventare un pericolo che poteva benissimo essere comune a tutti gli Stati. Questo perché oltre che
equivalersi come forze, ogni stato era estremamente individualista.
Gli Etruschi non seppero sfruttare le condizioni d'Italia, per loro a quei tempi molto favorevoli. Anziché
stringere rapporti d'amicizia con gli altri popoli italici, gli Etruschi preferirono stringere alleanze con i lontani
Cartaginesi per spartirsi in "condominio" tutto il Mar Tirreno. Ne conseguì che, se da un lato consolidarono la
loro potenza -più economica che politica-, dall'altro, trascinati dalla politica punica, dovettero poi seguire le
sorti di Cartagine. Cioè scomparire senza lasciare tracce. I Fenici li riscopriremo duemila anni dopo; e degli
Etruschi di loro poco e quasi nulla sappiamo. I Fenici ci hanno lasciato l'alfabeto, gli etruschi neppure quello,
solo qualche iscrizione funeraria, con le solite cortissime e generiche frasi. Non un solo testo letterario,
quando invece duemila anni prima egiziani e sumeri compilavano già trattati, dizionari, o scrivevano
voluminosi romanzi.
Provocata un'alleanza tra Greci dell'Italia meridionale e Italici, costretti a difendersi, subirono i primi rovesci,
come si è visto, in Campania; battuti ad Imera i Cartaginesi dai Greci, gli Etruschi rimasero privi
dell'appoggio della potente Cartagine.
Da allora, con lo scioglimento della lega etrusco-fenicia nel 274 (480 a.C.), cominciò il crollo della potenza
marittima degli Etruschi. Nel 280 (474 a.C.) furono sconfitti a Cuma da GERONE di SIRACUSA, e perdettero
interamente il dominio della campania e insieme dell'Adriatico; e la loro attività commerciale scomparve del
tutto più tardi per opera del tiranno siracusano DIONISIO, che, cacciati o sottomessi gli Etruschi dall'Illiria e
dalle coste orientali d'Italia, stabilì con delle colonie la sua sovranità su Ancona, Numana, Hatria e sulle isole
di Lisso ed Issa.
Erano però ancora molto forti gli Etruschi quando Roma si stava preparando alla sua ultima lotta contro
Vejo, benché fossero stati scacciati dall'Adriatico e dal Tirreno meridionale e spinti da Greci e Italici verso il
centro della penisola. Ma non erano nella possibilità i vari Stati di aiutarsi a vicenda, né quelli del nord in
Toscana) potevano recare soccorsi a Vejo (nel Lazio) impegnati com'erano a difendere ancora una volta le
loro frontiere dai GALLI, che a più riprese, con una tribù dietro l'altra stanno già invadendo la pianura
Padana (e che nel prossimo capitolo, li troviamo già a varcare il Po e spingersi verso la Toscana e infine
verso il Lazio).
La guerra contro Vejo scoppiò nel 349 (405 a.C.) al principio del quale scadeva la tregua di venti anni firmata
nel 328. Narrano gli storici che la causa della nuova guerra contro l'odiata rivale fu la risposta data dai
Vejenti agli ambasciatori inviati da Roma che cioè abbandonassero subito il territorio di Vejo se non
volevano correre la sorte dell'altra ambasceria al tempo di Larte Tolunnio. Ma questa è forse una leggenda
creata apposta per giustificare l'aggressione dei Romani, da tempo meditata per disfarsi una buona volta di
Vejo; e che Roma si preparasse alla guerra lo mostra chiaramente la paga spontaneamente accordata ai
soldati dal Senato, già l'anno prima di fare i preparativi.
La guerra fu iniziata dai tribuni consolari TITO QUINZIO CAPITOLINO, T. QUINZIO CINCINNATO, CAJO
GIULIO JULO, AULO MANLIO, LUCIO FURIO MEDULLINO e MARCO EMILIO MAMERCINO, che, assalita
con grandi forze Vejo la città nemica e non potendola prendere con la forza, l'assediarono, risoluti a
conquistarla per fame.
Pare che i Vejenti fin dall'inizio delle ostilità avevano chiesto aiuto agli altri Stati etruschi, che, inviati i propri
rappresentanti al Fano di Volturno, stabilirono però di non inviare nessun soccorso.
Le operazioni di guerra del primo anno furono molto lente. Consisteva del resto solo in un cerchio
d'isolamento, e gli abitanti della città assediata erano ben forniti di viveri e confidavano che, l'assedio
andando per le lunghe, potessero a loro venire aiuti dagli altri stati di Toscana, o che altri popoli avrebbero
approfittato della guerra contro Vejo per assalire Roma sguarnita di truppe.
Aiuti dall'Etruria non ne giunsero, ma, come i Vejenti speravano, i Volsci brandirono le armi contro i Romani,
i quali dovettero, per far fronte al nuovo nemico, e ritirare dall'assedio alcune legioni e una parte dei tribuni.
L'esercito romano si scontrò con i Volsci presso Ferentino, li sconfisse poi marciò sulla città di Artena e la
cinse d'assedio. Avendo i Volsci tentata una sortita, non solo furono ricacciati dentro, ma i Romani
incalzandoli, non riuscirono a impedire che penetrassero nella città, che in breve tempo fu conquistata.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
33
Soltanto la Rocca rimase in potere dei Volsci, luogo inespugnabile per le superbe opere di difesa e capace
di resistere ad un lunghissimo assedio per la grandissima quantità di vettovaglie di cui era fornita. Perduta la
speranza di prender per forza o per fame la rocca, i Romani avrebbero certamente rimosso l'assedio se il
tradimento di uno schiavo non li avesse introdotti nella rocca, che poi fu distrutta totalmente assieme alla
città.
Vinti i Volsci, i Romani riportarono le legioni sotto Vejo e tutto lo sforzo della guerra fu rivolto contro questa
città. Giunto il tempo delle elezioni, furono nominati otto tribuni consolari: MARCO EMILIO MAMERCINO,
LUCIO VALERIO POTITO, APPIO CLAUDIO CRASSO, MARCO QUINTILIO VARO, L. GIULIO JULO,
MARCO POSTUMIO, MARCO FURIO CAMILLO e MARCO POSTUMIO ALBINO.
Questi, temendo che gli altri stati etruschi giungessero in aiuto di Vejo, per non esser presi alle spalle
ordinarono che si costruissero grandi opere di difesa contro un probabile attacco di alleati. Cinsero la città di
fossati, innalzarono steccati e torri, fabbricarono macchine da guerra, approntarono i quartieri invernali per
l'esercito.
I lavori intorno a Vejo erano sempre animati e continuavano, ma sia gli aiuti alleati sia difensori della città
non si facevano vivi; ma una notte questi, sapendo che i Romani, sicuri di non essere disturbati, non
facevano buona guardia durante le ore notturne, usciti numerosi da una porta armati di fiaccole appiccarono
il fuoco ai lavori e in poco tempo l'incendio consumò gli argini e le macchine e molti soldati romani, accorsi
prontamente, perirono o nel fuoco o furono assaliti dagli ardimentosi Vejenti. Fu insomma una punitiva beffa
con un risultato molto positivo e piuttosto umiliante per i Romani.
Giunta a Roma la notizia dell'improvviso scacco, la popolazione arse dal desiderio della rivincita e ci fu tra i
cittadini una nobilissima gara; cavalieri e plebei d'ogni età si offrirono volontariamente di andare in guerra
giurando di non far ritorno a Roma se non dopo aver costretta alla resa Vejo.
Commossi i senatori dall'entusiasmo di tutta la cittadinanza, ordinarono che da quel giorno si dessero inizio
alle paghe per tutti coloro che si erano offerti di arruolarsi; poi, allestito un numeroso esercito di volontari, fu
inviato a Vejo e questi uomini in poco tempo riallestirono non solo le opere abbattute e incendiate dai nemici,
ma ne furono costruite moltissime di nuove.
L'anno seguente, 352 di R.(402 a.C.), essendo tribuni consolari Cajo Servilio Ala, Quinto Servilio, Lucio
Virginio, Quinto Sulpicio, Aulo Manlio e Manio Sergio, la fortezza di Anxur, presidiata dai Romani, per una
negligenza della guarnigione locale fu assalita e conquistata dai Volsci.
A Vejo intanto le cose non volgevano in bene per l'esercito assediante sia per le rivalità dei tribuni (6 erano
un po' troppi), sia perché due popoli etruschi, i Capenati e i Falisci, ripetutamente chiamati, avevano
mandato consistenti soccorsi di uomini ai Vejenti.
I nuovi arrivati assalirono impetuosamente uno degli accampamenti romani di cui era comandante il tribuno
MANIO SERGIO.
Gli assedianti credevano che si erano mossi tutti i 12 stati Etruschi, in altre parole d'avere addosso tutte le
forze della lega etrusca; mentre i Vejenti, animati dall'improvviso soccorso uscirono dalle mura e così le
legioni di Sergio dovettero lottare contro due nemici, davanti e dietro, o dietro e davanti.
Si difesero con estremo valore e causarono pure molte perdite ai nemici; ma la loro posizione si aggravava
di momento in momento e stava diventando molto critica. SERGIO sperava che dal vicino campo il collega
VIRGINIO gli inviasse soccorsi che, se fossero giunti a tempo, avrebbero capovolto senza dubbio le sorti
della battaglia; ma Virginio che era nemico di Sergio, pur sapendo le critiche condizioni in cui si trovavano le
schiere del collega, si guardò bene dall'intervenire, di modo che sopraffatti dai nemici, dopo uno strenuo e
inutile combattimento, le legioni di Sergio abbandonarono le trincee; una piccola parte trovò rifugio nel
campo di Virginio ma il grosso se ne fuggì a Roma.
Qui giunto, MANIO SERGIO diede la colpa della disfatta al collega rimasto inoperoso, e il Senato, richiamato
a Roma VIRGINIO e lasciati a comandare gli eserciti di Vejo i Luogotenenti, decretò di convocare prima del
tempo i comizi per l'elezione dei nuovi tribuni consolari. Furono eletti Lucio Valerio Potito, Marco Furio
Camillo, Marco Emilio Mamercino, Gneo Cornelio Cosso,. Caio Fabio, Ambusto e Lucio Giullo Julo e subito
si provvide ad arruolare un altro esercito e si obbligarono pure i vecchi ed i giovanissimi ad entrare nella
milizia.
Ma dal momento che le casse dell'erario erano esauste s'imposero nuovi tributi e questi provocarono lo
sdegno dei tribuni della plebe. Risvegliatesi improvvisamente le discordie, in città ci fu perfino chi osò in quel
frangente, riandare alla questione della legge agraria; mentre altri proposero che Sergio e Virginio dovevano
essere puniti. I due tribuni finiti sotto processo, furono, con gran soddisfazione della plebe, condannati ad
una multa di diecimila assi.
Occorreva nello stesso tempo rialzare le sorti della guerra. LASCIATI MARCO EMILIO e QUINTO FABIO al
governo della città, MARCO FURIO CAMILLO e GNEO CORNELIO uscirono con le truppe contro i Capenati
e i Falisci, saccheggiarono il loro territorio, incendiarono ville e castelli, mentre VALERIO POTITO, incaricato
di combattere contro i Volsci che approfittando della caotica situazione erano tornati all'offensiva, cinse
d'assedio la fortezza di Anxur, che poco tempo dopo fu costretta alla resa.
Non passò molto tempo che la disfatta subita sotto le mura di Vejo fu vendicata grazie la cooperazione di
tutte le forze romane. Infatti i due alleati di Vejo, i Capenati e Falisci furono impetuosamente attaccati e
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
34
sconfitti e i Vejenti che avevano fatto una sortita per correre in difesa dei loro alleati furono ricacciati verso le
mura cercando rifugio con il rientro in città, ma per impedire che i Romani penetrassero con loro, i
concittadini chiusero le porte, e i malcapitati furono quasi tutti uccisi.
Quello stesso anno (354 A. di R. - 400 a.C.) si registrò una grande vittoria per la plebe, la quale finalmente
riuscì non solo a fare eleggere come tribuni consolari i suoi rappresentanti, ma guadagnò anche la
maggioranza.
Uno solo, MARCO VETURIO, del ceto patrizio fu eletto; tutti gli altri, e cioè M. POMPONIO, CAJO DUILIO,
VOLERONE PUBLILIO, GNEO GENUCIO e LUCIO ATTILIO, erano plebei.
L'anno dopo però il tribunato consolare tornò in mano ai patrizi e fra gli altri furono eletti LUCIO VALERIO
POTITO e MARCO FURIO CAMILLO, i quali, occupato il territorio etrusco dei Falisci e dei Capenati, vi
portarono la devastazione e rapine portando poi a Roma un ricchissimo bottino.
Narrano gli storici -con tanta fantasia- di numerosi prodigi avvenuti in quel tempo e si soffermano
specialmente sopra uno di questi. Il lago Albano, pur non essendo piovuto, era cresciuto oltre il normale, e
non sapendo i Romani spiegare il fenomeno e non potendo ricorrere agli aruspici etruschi a causa della
guerra, si inviò una delegazione ad interrogare l'oracolo di Delfo. Prima però che gli ambasciatori tornassero
con la risposta, riuscirono i soldati romani con uno stratagemma a catturare un aruspice di Vejo, il quale,
condotto al cospetto dei senatori, affermò che era già scritto nei libri fatali che, quando l'acqua del lago
Albano cresceva, se i Romani la toglievano in modo religioso sarebbe stata a loro concessa la vittoria su
Vejo, in caso contrario gli dèi avrebbero sempre protetto quella città.
Il Senato non credeva al responso dell'aruspice nemico ed aspettò che da Delo tornassero gli ambasciatori.
L'assedio intanto continuava e continuavano le operazioni contro i Falisci, i Capenati, contro gli Equi che
avevano assalita la colonia romana di Labico, contro i Volsci che avevano assediata la fortezza di Auxur, e
infine contro i Tarquiniesi.
Di ritorno da Delo l'ambasceria portò il seguente responso dell'oracolo: "Non fare, o Romano, che l'acqua
rimanga ancora nel lago e non lasciar che vada al mare per il suo corso, ma consumala dividendola in molti
ruscelli. Poi audacemente darai l'assalto alle mura nemiche e ricorda che dai fati, ora a te si manifestano,
che ti è concessa la vittoria sulla città cui da tanti anni mantieni l'assedio. Terminata vittoriosamente la
guerra, porterai un magnifico dono al mio tempio e farai i sacrifici fino ad oggi trascurati nella tua patria, e li
restaurerai corretti come si usava".
Il responso di Delfo era identico a quello dell'aruspice etrusco. Fu detto allora - e certo per opera dei patrizi
che sfruttavano sempre per i loro fini l'ignoranza della plebe credulona- che gli dèi erano sdegnati contro
Roma perché si erano trascurate le ferie e i sacrifici sul monte Albano e anche perché si era commesso il
grave errore nella creazione dei magistrati. Fu detto ancora, che per placare lo sdegno delle divinità l'acqua
del lago doveva essere dispersa nei campi per mezzo di canali e che i tribuni plebei dovevano rinunciare per
il bene di tutti a fare i magistrati.
Con queste frottole, ciarle maligne, i patrizi cercavano di ottenere due obiettivi: che il tribunato consolare
tornasse in loro potere e che la plebe irrigasse le loro terre. E cosi fu fatto! Si pose subito mano alle opere
d'irrigazione e il Senato decretò l'interregno.
Furono nominati interRe LUCIO VALERIO, QUINZIO SERVILIO FIDENATE e MARCO FURIO CAMILLO e
si prepararono i comizi, ma dovettero bene accorgersi i tribuni plebei delle intenzioni del patriziato e
provocarono sedizioni e si opposero alla convocazione dei comizi, chiedendo che la maggior parte dei tribuni
fosse plebea.
In quel tempo al Fano di Volturnia ci fu una dieta dei popoli etruschi nella quale i Capenati e i Falisci
domandarono che tutti gli stati dell'Etruria scendessero in campo per liberare Vejo dall'assedio. Ma fu loro
risposto negativamente. Però si diede libertà a quei giovani che volessero di andare volontari in aiuto dei
Vejenti.
Ma non è che i figli, potessero ad un tratto cambiare il carattere educato e plasmato dai padri.
A Roma si sparse la voce che da tutta l'Etruria numerosissimi volontari erano accorsi a Vejo per soccorrerla
e cominciarono a tacere le discordie, ma le operazioni militari non diedero tutte ottimo risultato e qualcuna si
risolse in uno scacco per fortuna non grave.
LUCIO TITINIO e GNEO GENUCIO, essendo tribuni consolari, avevano fatto una spedizione contro i Falisci
e i Capenati. Però, guerreggiando più con l'audacia che non la prudenza, caddero in un agguato. Genucio si
battè coraggiosamente ma pagò la sua imprudenza con eroica morte, Titinio, dal canto suo, riuniti i soldati,
per non fare la stessa fine, si ritirò sopra un'altura dove opponendo al nemico una accanita resistenza.
Non fu una vera e propria sconfitta e pochi danni subirono in verità le truppe dei due tribuni; ma al campo
romano intorno a Vejo la notizia di quel fatto d'arme giunse molto diversa dalla realtà; circolò la voce che ai
Romani gli era toccata una clamorosa disfatta e che gli eserciti di tutta l'Etruria, vincitori, si avvicinavano a
Vejo insieme con i Falisci e i Capenati. Poco mancò che i Romani non abbandonassero il campo per darsi
alla fuga.
Più gravi ancora furono le notizie giunte a Roma, secondo le quali il campo romano intorno a Vejo era stato
assalito e annientato e che una parte dei nemici marciavano sulla stessa Roma.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
35
Tali notizie portarono nella città la costernazione e lo sgomento; tutti quelli che potevano usare le armi
corsero subito alle mura, le matrone uscirono di casa e si recarono nei templi a supplicare gli dèi che
allontanassero da Roma ogni pericolo, supplicando la vittoria per gli eserciti romani.
DITTATURA DI CAMILLO E PRESA DI VEJO
A quel punto come nelle altre difficili circostanze si ricorse allora alla dittatura. Fu creato dittatore MARCO
FURIO CAMILLO, uno dei più famosi capitani romani, un uomo valoroso, audace quando era necessario,
ma prudente, che più di una volta, come abbiamo visto, aveva ricoperto la carica di tribuno consolare.
Assunto a quella suprema magistratura straordinaria, Camillo nominò maestro della cavalleria PUBLIO
CORNELIO SCIPIONE, poi, per restaurare la disciplina nell'esercito con degli esempi di severità, punì tutti
quei soldati che erano fuggiti da Vejo. Fatto questo, volò nel campo della città assediata per animare con la
sua presenza le truppe e fece subito ritorno a Roma per dirigere le operazioni di arruolamento. Nessuno
degli uomini validi rifiutò di iscriversi nell'esercito e tanta fu la fiducia che un tale uomo seppe ispirare che
perfino la gioventù dei Latini e degli Ernici corsero ad arruolarsi.
Quando ogni cosa fu pronta, Camillo fece voto e promise, per decreto del Senato, che, espugnata Vejo,
avrebbe fatto i "lugi magni" e rifatto e riconsacrato il tempio della dea Matuta, già consacrato dall'antico re di
Roma Servio Tullio; poi alla testa di un forte esercito partì da Roma alla volta di Nepete nel cui territorio
ingaggiò una battaglia con i Capenati e i Falisci e seppe con molta prudenza predisporre le cose e con tanta
perizia guidare il combattimento che la fortuna gli arrise.
Sconfitti i nemici, s'impadronì dei loro alloggiamenti e fece un ricchissimo bottino, di cui solo una piccolissima
parte distribuì fra le truppe e il resto consegnò ai questori militari.
Dopo questa riuscita offensiva, il Dittatore condusse l'esercito vittorioso a Vejo; fece rafforzare le bastie, ne
fece erigere delle nuove ed ordinò che nessuno doveva combattere senza il suo permesso.
Da qualche tempo si era cominciato a scavare un passaggio sotterraneo che doveva condurre alla cittadella,
Camillo comandò che i lavori fossero continuati con più alacrità e, perché questi procedessero più
velocemente e senza interruzione di giorno e di notte, divise i lavoratori in sei squadre a ciascuna delle quali
fu assegnato un turno di sei ore.
Quando la galleria fu scavata, il dittatore, vedendo prossima la conquista della città e sapendo che le
ricchezze che conteneva erano ingenti, per non incorrere nell'ira dell'esercito, ira che avrebbe certamente
suscitata se avesse proibito o limitato il saccheggio, ma nello stesso tempo per non essere poi rimproverato
dal Senato se una sì ricca preda avesse concesso alle truppe, scrisse al Senato chiedendogli istruzioni in
proposito. Vari furono i pareri espressi nell'assemblea dei senatori, ma prevalse su tutti quello di PUBLIO
LICINIO il quale consigliò di informare la plebe che chi voleva partecipare al bottino doveva andare al campo
di Vejo a combattere.
Resa pubblica la decisione del Senato, una grande moltitudine di gente armata corse a Vejo, e Camillo,
soddisfatto degl'improvvisi rinforzi giunti, si preparò alla sua impresa finale.
Prima sua cura fu di conquistare gli augurii, facendo voto di assegnare ad Apollo la decima parte della preda
e di portare a Roma, in un tempio magnifico, la grande statua di Giunone Regina che si trovava a Vejo;
infine mandò attraverso il passaggio sotterraneo un contingente di soldati scelti e, affinché i Vejenti non si
accorgessero dello stratagemma, con il resto delle truppe assalì e in un modo alquanto rumoroso da ogni
parte la città. I Vejenti, meravigliati di così un fulmineo assalto dopo tanti giorni di tregua, corsero armati, tutti
alle mura per respingere il vigoroso attacco dei nemici.
In quel frattempo, non visti, dal sotterraneo i soldati romani erano penetrati nella rocca, e precisamente nel
tempio di Giunone che era posto proprio sopra il tunnel. Di là, una parte, con ardimento mosse contro quelli
che difendevano le mura cogliendoli alle spalle, e una parte ancora più ardita raggiunse le porte per
abbatterle, mentre un altro manipolo si mise a percorrere le vie appiccando il fuoco alle case.
A quel punto la battaglia infuriò dentro la città oltre che fuori. Dalle case le donne e gli schiavi gettavano
sassi e tegole, mentre fiamme altissime si levavano al cielo. Sulle mura i difensori, assaliti di fronte e a tergo,
invano cercavano di resistere, e quelli che soccombevano erano precipitati dall'alto. Intanto, dalle porte
sfondate una folla urlante di combattenti si precipitava dentro la città seminando strage per le vie e nelle
abitazioni.
Camillo pose fine al combattimento facendo dai banditori sapere che sarebbero stati risparmiati gli abitanti
se avessero subito deposto le armi; poi abbandonò la città al saccheggio.
Il bottino fu ricchissimo, maggiore di quanto non si era sperato. Il giorno dopo Camillo mise in vendita i
prigionieri come schiavi e destinò alla cassa dello Stato il ricavato della vendita. Quest'ultima operazione non
piacque ai soldati, i quali, non contenti della ricca preda a ciascuno toccata, avrebbero voluto dividersi anche
quel denaro e del bottino fatto non a Camillo furono grati ma a PUBLIO LICINIO che -come detto sopra- in
Senato aveva dato il consiglio del saccheggio.
Spogliata di ogni ricchezza la città, si cominciò a prendere e a trasportare devotamente tutto ciò che si
trovava nei templi. Scelti in tutto l'esercito alcuni giovani, li mandarono vestiti di bianco al tempio di Giunone
per prendere il simulacro della Dea e portarlo a Roma, ed è nella leggenda poi tramandata, che la Dea,
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
36
richiesta se voleva esser trasportata nella città dei vincitori, rispondesse di sì con un cenno e anche con la
voce.
Tolta dalla sua base, la statua fu portata a Roma sull'Aventino, dove, quattro anni dopo, Camillo, sciogliendo
il voto, le dedicava un tempio.
Dieci anni, secondo la leggenda ricalcata su quella della guerra da Troja, era durato l'assedio di Vejo,
conquistata, come gli storici stessi dicono, più con lo stratagemma e per volere degli Dei che non per il
valore di armi.
CAMILLO A FALERIA
Giunta a Roma la notizia della vittoria, fu la gioia fu indescrivibile. Le donne gremirono i templi e innalzarono
inni di ringraziamento e il Senato decretò di fare in continuazione quattro giorni atti di riverenza agli dei.
Trionfale fu il ritorno di Camillo a Roma alla testa dell'esercito vittorioso, sopra un carro tirato da cavalli
bianchi, fra fitte ali di gente di ogni condizione ed età. Appena giunto in città, il Dittatore salì sull'Aventino,
scelse il posto per il tempio a Giunone Regina e consacrò, secondo il voto, il tempio alla dea Matuta. Dopo,
rinunciò alla dittatura e, poiché aveva promesso un dono ad Apollo, dietro consiglio dei pontefici si stabilì che
ciascuno rendesse la decima parte del bottino toccatogli.
In quel tempo giunsero a Roma gli ambasciatori degli Equi e dei Volsci a chieder la pace, che molto
volentieri fu concessa.
L'anno seguente (359), ai due tribuni consolari VALERIO e QUINTO SERVILIO fu affidata la guerra contro i
Capenati, con i quali, dopo alcune scorrerie, fu conclusa la pace; mentre i due tribuni militari PUBLIO
CORNELIO COSSO e PUBLIO CORNELIO SCIPIONE, anche loro in guerra contro i Falisci riuscirono a
saccheggiare il loro territorio.
Mentre ancora non era del tutto finita la guerra e fuori città le truppe romane erano ancora impegnate a
devastare le contrade del nemico, a Roma risorgevano le discordie. Il Senato aveva proposto che si
mandasse nel territorio dei Volsci, una colonia di tremila cittadini a ciascuno dei quali doveva essere
assegnato tre arpenti e mezzo di terreno. Questa proposta suscitò molti malumori che aumentarono quando
TITO LICINIO, a sua volta, propose che una parte della plebe e del Senato andasse ad abitare in Vejo.
Ma i senatori rifiutarono sdegnosamente questa proposta e, poiché MARCO FURIO CAMILLO affermava
che la decima parte del territorio vejentano era stata da lui promessa ad Apollo, furono, dietro parere dei
pontefici, stimati la città e il territorio di Vejo, poi venduti e dai tribuni militari con il ricavato fu comperato
dell'oro per fabbricare un dono ad Apollo.
Non bastando quello trovato, volontariamente le matrone romane portarono tutto l'oro e i gioielli in loro
possesso per poi realizzare una magnifica coppa.
L'anno dopo, continuando la guerra contro i Falisci, fra gli altri tribuni militari fu eletto Furio Camillo, e a lui
affidato il comando di tutte le operazioni di guerra.
Camillo mosse con l'esercito contro il nemico, ma questo, temendo di doversi scontrare in campo aperto,
rimaneva prudentemente chiuso nella città di Faleria; ma ben presto il tribuno romano lo costrinse ad uscire
iniziando a predare e a bruciare tutte le ville del territorio.
I Falisci si accamparono ad un miglio dalla città in una località forte per natura e di difficile accesso, ma
Camillo, guidato da un prigioniero, a notte alta lasciò i propri alloggiamenti e sul far dell'alba, giunto con le
sue truppe in un luogo sovrastante a quello dove stava il nemico, ordinò di fortificare la posizione occupata.
I Falisci cercarono di disturbare i lavori dei Romani, ma poi da questi furono assaliti li scompaginarono poi li
misero in fuga; e tanto fu lo spavento nelle file del nemico sbaragliato che questi non ebbero tempo e non
pensarono di ricoverarsi nel loro campo, ma cercarono scampo dentro le mura della città.
Preso il campo nemico e consegnata ai questori la preda, Marco Furio Camillo pose l'assedio a Faleria.
Tutti credevano che l'assedio non sarebbe stato meno lungo di quello di Vejo, essendo la città
abbondantemente fornita di vettovaglie; invece fu breve ed alla virtù e generosità di Camillo più che alle armi
si deve se si arrese.
Viveva a Faleria un maestro che insegnava ai figli delle principali famiglie della città; quasi quotidianamente
conduceva i suoi allievi a passeggio fuori della città, non tanto lontano però da esporli alle minacce degli
assedianti.
Sperando forse in un ricco premio, un giorno il maestro guidò i suoi scolari al campo romano e, presentatosi
a Camillo, gli offerse come ostaggi gli allievi, affermando che le famiglie di Faleria chissà cosa avrebbero
pagato per liberare i loro figli e che oltre questo, preoccupandosi per la loro sorte sarebbero state costrette a
cedere la città.
È fama che Camillo, sdegnato, rispondesse così:
"O infame uomo, tu con questo dono scellerato non sei venuto ad un popolo o ad un capitano a te
somigliante. Noi non usiamo le armi contro i fanciulli, ai quali si risparmia la vita anche quando si conquista
una città, noi le usiamo contro gli armati e contro quelli che, pur da noi non offesi o molestati, giunsero a
Vejo a combattere contro il nostro esercito. Tu hai superato i tuoi concittadini con questa tua infamia, e sappi
che io vincerò soltanto con i mezzi che di solito usano i Romani: con la virtù, con le munizioni e con le armi".
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
37
Detto questo, fece spogliare il disonesto maestro poi ordinò ai suoi stessi allievi - lasciandoli quindi liberi di
far ritorno alla propria città- che lo menassero nudo e con le mani legate dietro la schiena e fustigandolo con
le verghe
fino Faleria.
Vinti da questo atto nobile di Camillo, i Falisci si arresero accettando le condizioni imposte da Roma che cioè
pagassero il soldo di quell'anno ai soldati.
Conclusa la pace, Camillo ritornò a Roma, dove fu accolto con grandissimi onori e il Senato ordinò che una
commissione composta di Lucio Valerio, Lucio Sergio ed Aulo Manlio, portasse ad Apollo in Delfo la coppa
d'oro.
La nave che portava gli ambasciatori - secondo quel che narra la leggenda - giunta allo stretto di Messina fu
presa dai corsari e condotta a Lipari, ma il loro capo TIMASITEO, dopo avere ospitato cortesemente gli
ambasciatori, con buona scorta di navi li fece condurre a Delfo perché offrissero la coppa al dio e di là sani e
salvi li fece riaccompagnare a Roma.
Quello stesso anno, per le operazioni di guerra contro gli Equi furono incaricati i tribuni consolari CAJO
EMILIO e SPURIO POSTUMIO, che li sconfissero in una prima battaglia, ma essendo Emilio rimasto a
difendere Verruca, il collega, spintosi verso i confini degli Equi con l'esercito disordinato, fu improvvisamente
assalito e costretto a rifugiarsi sui monti vicini.
Qui però l'esercito, vergognandosi dello scacco subito, chiese di potersi riscattare e di voler combattere; già
nella stessa notte diedero inizio alla battaglia contro gli Equi sconfiggendoli e disperdendoli mentre le truppe
rimaste a Verruca, credendo che la disfatta era toccata ai loro compagni presi da un'improvvisa paura, si
ritiravano rifugiandosi a Tuscolo.
La guerra con gli Equi continuò con alterna vicenda: Vitellia, colonia romana, fu di notte e per tradimento
presa dai nemici; ma questi, più tardi, furono sconfitti dalle truppe del console Lucio Lucrezio Flavo e disfatti
un'altra volta, nel 362, presso l'Algido dai consoli Lucio Valerio Potito e Marco Manlio.
Altra guerra, poco tempo dopo, scoppiò con i Volsiniesi e i Salpinati. Contro i primi furono mandati i tribuni
consolari LUCIO LUCREZIO e CAJO EMILIO, che, incontrato un consistente esercito nemico, lo assalirono
e lo misero in fuga facendo ottomila prigionieri.
Contro i Salpinati andarono i tribuni AGRIPPA FURIO e SERVIO SULPICIO; quelli per paura si chiusero
dentro nella loro città e questi si misero a saccheggiare il loro territorio.
Ai Volsiniesi, quell'anno (363), fu concessa una tregua di venti anni a patto però di restituire quanto sottratto
ai Romani e pagassero il soldo di un anno ai soldati.
ESILIO DI CAMILLO
Nonostante le guerre con tanti nemici fuori, come il solito continuarono dentro Roma le discordie. Furono
condannati alla multa di diecimila assi gli ex-tribuni della plebe AULO VIRGINIO e QUINTO POMPONIO e fu
riproposta l'idea di inviare parte della popolazione a Vejo; ma contro questa intenzione insorse Marco Furio
Camillo.
"Più che lo sdegno del famoso capitano valsero le preghiere dei patrizi a non far approvare la proposta di
legge e più ancora la deliberazione presa dal Senato di dare sette iugeri di terra del contado di Vejo a
ciascun uomo, computando non solo i padri di famiglia e i capi di casa ma tutte le teste d'ogni nucleo
famigliare, affinché con questa speranza gli uomini allevassero più volentieri i figli" (Livio)
Contro MARCO FURIO CAMILLO intanto cresceva il malumore della plebe, dimenticando i grandi benefizi
che un uomo così grande aveva portato alla patria; era accusato di aver estorto ai soldati la decima parte
della preda di Vejo, di aver ricavando denaro dalla vendita dei prigionieri, e di aver obbligato il popolo a
comprare l'oro per il dono ad Apollo Delfico con i denari detratti dalle somme ricavate dalla vendita del
territorio di Vejo, infine di non aver nulla dato ai soldati del bottino realizzato nel campo dei Falisci.
Tutte queste accuse furono ufficialmente presentate nell'anno 363 dal tribuno APULEJO dal quale Camillo fu
citato in giudizio.
Ma lo sdegnoso guerriero preferì non comparire in pubblico in veste d'accusato e, abbandonata Roma, se
n'andò in esilio ad Ardea.
Si dice che, partendo, egli esclamasse: "Facciano gli dei immortali che, se tale ingiuria ingiustamente mi è
stata fatta, possa l'ingrata città desiderarmi ancora".
In contumacia fu condannato alla multa di quindicimila assi.
Fu un buon profeta; presto i Romani CAMILLO dovranno implorarlo per tornare al comando; fu il salvatore
della patria e quasi il secondo fondatore di Roma; e questa volta non erano i soliti nemici, ma erano popoli
ancora sconosciuti, dall'aspetto feroce, dall'anima non meno feroce, genti di statura gigantesca; tribù che già
in questi anni hanno varcato le Alpi.
Sono i cosiddetti GALLI e di loro ci occuperemo nel prossimo capitolo: nel periodo che segue dall'anno 390
al 389 > > >
Fonti, Bibliografia, Testi, Citazioni:
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
38
TITO LIVIO - STORIE (ab Urbe condita)
APPIANO - BELL. CIV. STORIA ROMANA
DIONE CASSIO - STORIA ROMANA
PAOLO GIUDICI - STORIA D'ITALIA
UTET - CRONOLOGIA UNIVERSALE
I. CAZZANIGA , ST. LETT. LATINA,
+ altri, in Biblioteca dell'Autore
I GALLI IN ITALIA - A CHIUSI, NEL LAZIO, A ROMA - SACCHEGGIO 390-389 a. C.
I GALLI E LA LORO DISCESA IN ITALIA - ASSEDIO DI CHIUSI - I CHIUSINI CHIEDONO AIUTO AI
ROMANI - AMBASCERIA DEI FABII - I GALLI MARCIANO SU ROMA- BATTAGLIA DELL'ALLIA SCONFITTA DEI ROMANI - ROMA ABBANDONATA - I GALLI A ROMA - IL SENATORE PAPIRIO INCENDIO E SACCHEGGIO DI ROMA - ASSEDIO DEL CAMPIDOGLIO - INCURSIONI GALLICHE NEL
LAZIO - I GALLI SCONFITTI AD ARDEA - GLI ETRUSCHI SCONFITTI A VEJO - ASSALTO DEL
CAMPIDOGLIO: M. MANLIO - MARCO FURIO CAMILLO SCONFIGGE I GALLI - LA TRADIZIONE E LA
CRITICA - RIEDIFICAZIONE DI ROMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I GALLI E LA LORO DISCESA IN ITALIA
Molto prima che i Romani iniziassero i preparativi per l'ultima guerra contro Vejo, era giunta a Roma la
notizia della comparsa di popolazioni nuove oltre le regioni abitate dagli Etruschi; e questi erano già
impegnati a difendere alcuni estremi confini a nord della Toscana, e in piccoli insediamenti nella pianura
Padana, o sulle coste adriatiche.
Luoghi che un Romano fino allora non si era mai spinto. Per tre motivi: l'esercito che Roma possedeva non
era ancora in grado né era organizzato per fare delle grandi campagne lontano dalla madre patria; c'era il
solito baluardo di Vejo che impediva di andare non oltre le porte a nord di Roma; ed infine non possedeva
ancora una flotta navale, anche perché in questi anni il mar Tirreno era dominato da navi etrusche o
cartaginesi; dalla Liguria alla Sicilia il mare era un "condominio" incontrastato, solcato solo dalle navi delle
due potenze, per lo più per scopi commerciali e non militari.
Tuttavia Roma apprese, forse dagli stessi Etruschi, le prime notizie di queste popolazioni erranti, che
facevano scorribande e razzie nei territori settentrionali della penisola.
Si riferiva che erano genti di statura gigantesca (l'italica come l'etrusca era di media alta 150-160 cm, i
barbari oltre i 180 cm.) dall'aspetto feroce e dall'anima non meno feroce; coraggiosissime, armate di scudi e
di rozze spade, amanti della guerra, che in battaglia operavano con orde numerose, e assalivano
popolazioni e territori con un impeto straordinario travolgente, emettendo urla terribili che portavano lo
spavento nelle schiere avversarie, recidevano le teste nemiche e le appendevano come ornamenti alle loro
selle, predavano e devastavano i territori per i quali passavano e, come traccia del loro passaggio, non
lasciavano che rovine e desolazione.
Queste genti erano i Galli.
(ne daremo un'altra descrizione, fatta più tardi, da Giulio Cesare, nel suo famoso "De bello gallico")
Quando i popoli di razza Aria (o indo-europea) come sono chiamati anche gli Italici, occuparono la penisola,
una gente della medesima stirpe si era stabilita nell'Europa centrale ed occidentale dove poi si era spinta a
nord nelle isole e penisole nordiche, ad oriente nella penisola Balcanica, ad ovest nella penisola Iberica ed a
sud nell'Italia settentrionale. Erano i Celti, dai Greci chiamati Galati e dai Romani Galli (Galli è infatti una
denominazione latina dei Celti).
Non si sa con precisione quando i Galli scendessero in Italia e in quali punti valicassero le Alpi. Certo non
prima di Tarquinio Prisco, forse dopo la cacciata dell'ultimo re da Roma (Tarquinio il Superbo - anni 534-510
a.C.).
Calarono probabilmente a più riprese, una tribù dopo l'altra.
LIVIO (una delle poche fonti che esistono al riguardo - ma scrive cinque secoli dopo, attingendo a tradizioni
e leggende ormai consolidate) narra che al tempo di Tarquinio Prisco, Ambigato, re dei celti Bitturigi, forse a
causa della sovrappopolazione nel suo regno, ordinò ai nipoti SIGOVESO e BELLOVESO di emigrare alla
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
39
testa d'alcune tribù, vere e proprie turbe; il primo verso le selva Ercinia (la regione boscosa e montuosa tra il
Reno e l'Alto Danubio), il secondo in Italia.
Belloveso con una moltitudine di Bitturigi, Arveni, Senoni, Edui Ambari, Carnuti ed Aulerci, dal paese dei
Taurini attraverso (allora) gli immensi boschi delle Alpi Giulie, scese nella grande pianura attraversata dal
Po, sconfisse gli Etruschi presso il Ticino ed occupò la regione degli Insubri dove fondò la città di Mediolano.
Sempre secondo Livio, un'altra moltitudine di Cenomani capitanati da Elitovio si spinsero nella regione ove
poi sorsero Brescia e Verona; dopo di questi seguirono i Sali che occuparono i passi confinanti con i Liguri;
più tardi i Boi e i Lingori, passati su zattere il Po, si spinsero fino all'Appennino, cacciando gli Etruschi e gli
Umbri, e da ultimo i Senoni occuparono il paese posto tra il fiume Uffente e il Ticino (In seguito li troveremo
tra Rimini e Ancona fino a Senigallia).
Ad ogni modo prima ad essere occupata dai Galli fu la regione a nord del Po che fu poi denominata Gallia
transpadana, dove abitavano i Liguri che perdettero i territori di Brescia e di Verona e parte di quelli
circostanti al Ticino. I Galli nel passare il Po, gli Etruschi perdettero quasi subito tutti i campi sulla sponda
destra del fiume e la regione felsinea, mentre i Liguri anche loro dalla pianura, furono cacciati da tutti i
territori dove si erano stanziati: da Piacenza a Modena.
Al tempo della guerra di Vejo la Gallia Transpadana era occupata dalle tribù galliche degli Insubri, che ad
ovest confinavano con i Liguri Salassi e Taurini, e dei Cenomani che confinavano ad est con i Veneti; nella
Cispadana i Longoni abitavano il territorio ravennate, i Senoni quello di Sinigallia e i Boi, più potenti fra tutti
gli altri Galli, i territori da Felsina (qui fondarono Bologna) al Po oltre il quale possedevano pure l'attuale
territorio di Lodi.
ASSEDIO DI CHIUSI
I popoli che maggiormente avevano sofferto per l'invasione gallica, essendo i primi a venire a contatto, erano
stati ovviamente gli Etruschi. Cacciati dai loro possedimenti settentrionali e cioè dalla regione tra l'Appennino
e il Po, in un primo tempo avevano cercato di rifarsi delle perdite subite trovando compensi a Sud, cioè nel
Lazio e nella Campania, ma, come abbiamo visto, dopo un primo successo a Roma erano stati sconfitti sotto
le mura di Aricia; poi, ridottisi tra l'Appennino e il Tirreno nell'Etruria propriamente detta, rimasero
continuamente in armi contro i Boi a difendere accanitamente le frontiere settentrionali del loro territorio.
Era naturale che i Romani rimanessero se non atterriti almeno preoccupati dalle notizie giunte fino a loro di
questi popoli barbari che tentavano con le armi di inoltrarsi nelle vie dell'Italia centrale; nessuna meraviglia
perciò se cercarono di avere maggiori notizie sul conto dei Galli e di raccogliere direttamente informazioni
sui loro propositi, inviando nel nord dell'Etruria persone che spiassero le mosse dei Galli, studiassero il loro
modo
di combattere, si rendessero conto dell'entità delle loro forze e tentassero di conoscere le loro mire.
Invece, secondo LIVIO, il cui racconto non può essere che leggendario, Chiusi, città etrusca, essendo
assediata dai Galli, chiese (cosa abbastanza strana) aiuto ai Romani.
Da Roma, anziché andare in soccorso dei Chiusini con un esercito, furono inviati ai Galli come ambasciatori
tre figli del pontefice massimo M. FABIO AMBUSTO, i quali tentarono d'indurre i barbari di levare l'assedio e
di non molestare i Chiusini.
Risposero i Galli che volentieri avrebbero fatta la pace con Chiusi se una parte del territorio di questa città
fosse stata loro amichevolmente ceduta. Avendo i Fabii obbiettato che non era giusto pretendere la cessione
di terre dai legittimi possessori, i Galli dissero con arroganza che essi portavano la ragione sulle armi e che
la terra apparteneva a chi sapeva conquistarla con la forza. Era del resto un concetto proprio di tutti i popoli
barbari, il "legittimo possesso" non aveva nessun senso, perché nella loro cultura e nelle loro leggi
consuetudinarie, non esisteva la proprietà terriera, ma solo quella tipicamente personale, e spesso neppure
quella; anche fra parenti stretti (vedremo in seguito le intestine lotte fra Longobardi, Franchi e Germani)
Sdegnati i Chiusini da quella risposta, corsero alle armi e da una parte e dall'altra si accese un'ostinata
battaglia alla quale sfortunatamente parteciparono i tre FABII, pur facendosi notare per il loro ardimento e
valore. Anzi uno di loro, QUINTO, staccandosi con il suo cavallo dalla prima schiera, assalì con la sua spada
e passò da parte a parte uno dei capi dell'esercito barbaro e, abbattutolo al suolo, lo spogliò delle armi.
Riconosciuto dai Galli per uno degli ambasciatori, fu grande l'ira del nemico, e BRENNO il loro condottiero, a
gran voce impartì gli ordini ai suoi uomini di toglier l'assedio e di marciare contro Roma, ma prevalse la
proposta di mandare alcuni ambasciatori al Senato romano a chiedere conto dell'ingiuria patita e a
domandare che fossero consegnati i tre Fabii.
Portarono gli ambasciatori la protesta e la richiesta dei Galli e il Senato, pur trovandole giuste, non osò
consegnare uomini di una così illustre famiglia oltre che valorosi e rimise la decisione al popolo, che non
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
40
soltanto rimandò indietro l'ambasceria con un rifiuto ma creò anche i tre Fabii per l'anno successivo tribuni
consolari, provocando lo sdegno negli ambasciatori, i quali ritornarono al campo presso Chiusi minacciando
la guerra.
Dalle minacce ai fatti non passò tanto tempo perché subito dopo al galoppo le orde barbariche scesero alla
volta di Roma attraverso l'Etruria.
Avrebbero dovuto i Romani, com'era loro costume, data la gravità della situazione creare un dittatore; invece
non se ne diedero pensiero, anzi nei preparativi di guerra non posero né cura né furono fatte sollecitazioni
per organizzare un efficiente esercito oltre che difensivo, offensivo.
BATTAGLIA DELL'ALLIA
Dall'Etruria, si avvicinava intanto il terribile nemico: un'onda infinita di combattenti al cui passaggio dal terrore
che li precedeva, fuggivano le popolazioni.
Ben presto giunse a Roma la notizia che uno sterminato esercito di Galli si avvicinava e grande fu lo
sgomento che invase gli animi dei cittadini. Si radunò come meglio si poté, in fretta e in furia un esercito, poi
informati che il nemico, passato il Tevere a monte della città, scendeva costeggiando la sinistra del fiume, le
legioni romane gli mossero incontro e, ad undici miglia da Roma, giunte che furono al torrente Allia,
avvistarono le avanguardie barbariche.
Non c'era il tempo di scegliere un luogo adatto per il campo né di costruire delle difese; avanzavano i nemici
come una incalzante marea ed era necessario schierare frettolosamente a battaglia l'esercito.
Era il 14 luglio dell'anno 364 (390 a.C.) e comandava quel giorno le truppe romane il tribuno consolare
QUINTO SULPICIO LONGO. Questi, forse per far fronte al numero grandissimo di nemici, forse per attirarli
al centro e premerli poi con le ali, schierò l'esercito tra il Tevere e i colli Crustumini lasciando il centro
protetto da una striminzita schiera di soldati, e lui si portò sui colli dove si stendeva l'ala destra e un nutrito
contingente di reclute che rappresentavano le schiere di rinforzo, e lì attese il nemico.
I Galli, compreso probabilmente il piano, dei Romani, anziché attaccare il centro e spezzare in due l'esercito
di Sulpicio, concentrarono la maggior parte delle loro forze contro le alture ed assalirono vigorosamente l'ala
destra. Lo scontro in quest'attacco gallico fu terrificante. I Romani non ressero all'urto; vacillò la destra, poi
questa si diede alla fuga precipitando dai colli al piano e trascinando con sé nella rotta il resto dell'esercito
che non ebbe il tempo nemmeno di iniziare il combattimento. Fu una rotta disastrosa! Il centro e la sinistra
credendosi circondati sulla destra e supponendo che fosse loro preclusa la ritirata verso la città, si
assieparono sulla sponda del Tevere, poi in gran confusione si gettarono nel fiume, dove molti per l'imperizia
del nuotare o per l'impaccio e il peso delle armi annegarono; ciononostante la maggior parte riuscì a porsi in
salvo nella sponda opposta e a rifugiarsi a Vejo.
Soltanto quelli dell'ala destra riuscirono entrare, gli altri fuggirono verso Roma. I Galli, stupiti di aver vinto
così facilmente un nemico del cui valore era giunta fino a loro la fama e non potendo credere alla realtà dei
fatti, temettero che i Romani avessero simulata la fuga per trarli in inganno e perciò non osarono inseguire i
fuggiaschi e, com'era loro costume, rimasti sul campo di battaglia, si diedero a raccogliere le spoglie dei vinti
mentre una parte della loro cavalleria si spingeva verso le mura della città in perlustrazione. Più tardi,
ritornati i cavalieri ed avendo riferito che le mura erano prive di guardia ed aperte le porte, il grosso
dell'esercito barbaro si mosse nel corso della notte verso Roma nelle cui vicinanze giunse allo spuntar del
sole. Sempre più meravigliati e temendo agguati da parte del nemico, i Galli sostarono titubanti tra la città e
l'Aniene.
Dal primo scontro, per tre giorni interi, i nemici rimasero incerti sul da farsi fuori della città limitandosi a
mandare sotto le mura alcuni drappelli di esploratori.
Questa indecisione fu la salvezza della cittadinanza. Al primo arrivo dei fuggiaschi, i Romani, non sapendo
che fine avessero fatto gli altri - la maggior parte dell'esercito e che fuggendo a Vejo si erano rifugiaticredendoli tutti periti nella battaglia, riempì di lamenti le case e le vie; ma al dolore si sostituì ben presto il
terrore e ciascuno pensò a come salvare la pelle prima che i barbari giungessero in città, che ormai era dato
per scontato.
Tutti i giovani idonei alle armi decisero di ritirarsi nella rocca del Campidoglio e difendersi a oltranza, fino
all'estremo. E nella rocca furono portate tutte le vettovaglie per resistere a un lungo assedio e iniziarono a
predisporre le difese.
Il resto della popolazione, portandosi dietro viveri e masserizie, abbandonò la città fra i saluti strazianti di
quelli che partivano e quelli che rimanevano. La maggior parte erano donne e fanciulli, alcuni trovarono
rifugio nello stesso Campidoglio, anche perché i difensori non ebbero il coraggio di respingerli, mentre altri si
rifugiarono sulla cima del Gianicolo, e altri ancora si dispersero per la campagna o per raggiungere i paesi
sulle vicine colline.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
41
I sacerdoti e le vestali spogliarono i templi di tutte le cose sacre perché non cadessero in mano del nemico,
e siccome non potevano trasportare tutto decisero di mettere una buona parte le varie cose in vasi e
sotterrarli in un tempietto vicino all'abitazione del sacerdote di Quirino.
Divise tra loro le rimanenti trasportabili cose, sacerdoti e vestali attraverso il ponte di legno presero la via del
Gianicolo. Era tanto allora il rispetto per i ministri della religione e per le cose divine, che Lucio Albino, il
quale insieme con la famiglia sopra un carro si allontanava dalla città, fece scendere i suoi familiari e
caricate le vestali e gli oggetti sacri, le une e gli altri li portò a Cere.
A Roma -narra Livio- rimasero soltanto ottanta vecchi patrizi, che volontariamente si offersero in sacrificio
alle divinità infernali e, dopo che furono consacrati dal pontefice massimo Marco Fabio, vestiti dei loro abiti
migliori, si sedettero nel foro sui seggi curiali e lì aspettarono il nemico.
I Barbari che finalmente si erano decisi a muoversi, entrarono in città dalla porta Collina. Roma era deserta e
silenziosa come una città morta. Vuote le vie, aperte le porte delle case, da dove nessuna voce veniva fuori.
Solo il Campidoglio dava qualche segno di vita e mostrava di volere opporre resistenza agli invasori. I quali
dapprima si rivolsero alla rocca, poi, lasciati nelle vicinanze alcuni uomini a far la guardia, si sparsero per la
città, meravigliati di non incontrar nessuno e piuttosto preoccupati di quel silenzio che forse nascondeva
qualche insidia.
Perplessi e timorosi i Galli non osavano penetrare nelle case, ma poi, giunti nel Foro, al loro sguardo si
offerse lo spettacolo di tutti quei vecchi riccamente vestiti, immobili e indifferenti seduti sui seggi, con le
lunghe barbe fluenti sui petti.
Uomini o divinità romane protettrici della città? Un soldato dei Galli si avvicinò ad un patrizio, era vecchio
MARCO PAPIRIO, e, incuriosito, gli toccò la barba. Il vegliardo alzò un bastone d'avorio che teneva in mano
e percosse con quello il barbaro. Non l'avesse mai fatto: fu il segnale della strage. Ad uno ad uno i patrizi
caddero colpiti da quell'orda che, urlando selvaggiamente, si diede poi nuovamente a percorrer le vie, invase
le case, uccidendo i vecchi e gl'infermi, che non avevano voluto o potuto abbandonar la città, e qua e là
cominciò ad appiccare il fuoco. Lingue di fiamme e nuovole di fumo si levarono in più punti della città verso il
cielo.
Dall'alto della rocca del Campidoglio i Romani guardavano la patria invasa dal nemico e gli incendi distruttori
e piangevano dal dolore e dalla collera. Così trascorse il giorno e così passò la notte illuminata dai bagliori
delle fiamme, dinnanzi alla cui violenza crollavano case e templi. Della Roma, quasi quattro volte centenaria,
non rimaneva oramai che una distesa fumante di rovine. Solo alcuni templi rimanevano, in piedi ed alcuni
palazzi sul Palatino che erano stati scelti come dimora dai capi barbari.
I GALLI SCONFITTI AD ARDEA
Così trascorsero alcuni giorni, ed avendo i Galli devastata ogni cosa e vedendo che il Campidoglio e la rocca
non mostravano intenzione alcuna di arrendersi, pensarono di prenderli d'assalto. Un giorno, sul far dell'alba,
assalirono con selvagge grida la fortezza. Non si persero d'animo i difensori, risoluti a non lasciar cadere
nelle mani nemiche l'ultimo brandello della patria romana, e, fortificate tutte le entrate controllate da buone
guardie, correvano dove maggiore era il pericolo; con gran coraggio fecero pure una audace sortita, e
ributtarono giù per la costa gli assalitori che su quella si erano avventurati.
Questi allora decisero di continuar l'assedio; ma avevano dimenticato come procurarsi il mangiare.
Mancavano infatti le vettovaglie, poiché nell'incendio avevano sconsideratamente distrutto ogni cosa, e né
potevano trovarne girando la città essendo stati tutti i viveri portati via da Roma. Furono costretti perciò a
lasciare una parte dell'esercito intorno al Campidoglio e se l'altra parte più numerosa voleva procurarsi
qualcosa da mangiare dovevano andare a razziare i territori vicini che però non erano migliori della città;
cioè non vi era nulla da mettere sotto i denti. Al massimo potevano fermarsi e mangiarsi i propri cavalli.
Alcune schiere di barbari dovettero spingersi molto lontano, e nemmeno fecero più ritorno nella città deserto.
E sembra che Dionisio tiranno di Siracusa, allora era in guerra contro le città della Magna Grecia, fece loro
proposte di entrare al suo soldo, e quelli si misero volentieri, per mangiare o per avidità di guadagno al suo
servizio.
Altre schiere invece corsero in lungo e in largo il Lazio dappertutto portando la devastazione. Ma ad Ardea
ebbero una dura lezione da MARCO FURIO CAMILLO, il quale, vivendo in esilio in quella città (per
l'ingratitudine del popolo e dei senatori che l'avevano condannato per un'accusa infamante) appreso che i
Galli erano entrati nel territorio con l'intenzione di depredarlo, persuase gli Ardeati a brandire le armi e di
notte con una numerosa schiera piombò improvvisamente sul campo dei Galli sepolti nel sonno. La strage di
nemici che fu compiuta fu grande e quei pochi che riuscirono fuggire da Ardea, penetrati nel territorio di
Anzio, che si era pure questa preparata a dare a loro il benvenuto, furono assaliti e tutti uccisi dagli abitanti
fortemente decisi a salvare le proprie cose.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
42
GLI ETRUSCHI SCONFITTI A VEJO
Mentre queste cose succedevano, gli Etruschi dimenticando che Roma si trovava in quelle condizioni per
aver voluto difendere Chiusi, approfittando della sconfitta della città latina, non si lasciarono sfuggire
l'occasione; pensarono che era giunto il momento di riprendere ai Romani, Vejo. Radunate le forze,
iniziarono a fare scorrerie fin quasi sotto le mura della città.
I Romani, quei pochi che si aggiravano ancora nei dintorni, già in collera per i barbari, gli incendi, le
distruzioni, arsero di sdegno nel vedere questi "avvoltoi" che approfittavano della tragedia che stava vivendo
l'intera Roma. Nonostante male armati e provati dalla sventura, decisero di difendere il nome e le ultime terre
di Roma. Elessero pertanto loro capo il centurione M. CEDICIO e di notte, usciti da Vejo, sorpresero un
campo etrusco che si era appostato nelle vicinanze e ne fecero una strage; poi guidati da alcuni prigionieri,
la notte successiva ripeterono l'impresa, assalendo un altro campo, ne distrussero il presidio e se ne
ritornarono carichi di armi e di bottino a Vejo.
La vittoria sugli Etruschi e le armi di cui erano venuti in possesso rialzarono fortemente il morale dei Romani
di Vejo, i diventati baldanzosi decisero di correre in soccorso dei poveri malcapitati chiusi e assediati nel
Campidoglio.
Ma mancava a loro un capo degno e strategicamente capace di una tale audace impresa.
Vejo fece loro pensare a Camillo, il gran capitano che l'aveva conquistata, e a Camillo pensavano anche
molti soldati che l'avevano avuto come duce in molte fortunate battaglie. Si decise di farlo ritornare dall'esilio
di Ardea, ma nessuno voleva assumersi la responsabilità di tale iniziativa e fu stabilito perciò di chiedere
licenza al Senato, di cui alcuni membri si trovavano pure loro asserragliati in Campidoglio. Impresa certo non
facile questa, essendo la rocca cinta d'assedio. Ma si trovò chi si offrì di tentarla. Un giovane valoroso,
PONZIO COMINIO, protetto dalle tenebre, passò a nuoto il Tevere, poi portatosi sul retro, che era il versante
più inaccessibile, scalata l'erta rupe, giunse al Campidoglio, fece l'ambasciata e, ricevuto il decreto del
Senato, che richiamava dall'esilio Camillo e gli affidava la dittatura proposta dalle centurie, ritornò per la
stessa via a Vejo.
ASSALTO DEL CAMPIDOGLIO LE OCHE SACRE E M. MANLIO
L'impresa felicemente portata a termine da Ponzio per poco non fece cadere il Campidoglio in potere dei
Galli, i quali, accortisi delle orme lasciate dal giovane, di notte si arrampicarono pure loro silenziosamente
per la stessa rupe e già stavano raggiungendo la sommità del Campidoglio favoriti dalla non vigilanza di una
guardia che non stava certamente compiendo il proprio dovere nel porre molta attenzione, o forse perché
riteneva impossibile che da quella via potessero sopraggiungere dei nemici.
A salvare la situazione che per pochi minuti poteva diventare critica per tutti gli altri, ci pensarono le oche; le
quali per essere sacre a Giunone erano state risparmiate dagli assediati affamati come piatto culinario.
Queste forse per sdebitarsi, quando il gallo stava per mettere piede sulla sommità della rupe cominciarono a
strepitare, avvertendo così del pericolo MARCO MANLIO che tre anni prima era stato console. Brandite le
armi, mentre gli altri da lui avvertiti si radunavano, corse subito alla rupe e, visto un Gallo in atto di superarla,
gli si avventò con lo scudo e lo fece precipitare. Il nemico, abbattendosi sui compagni che stavano salendo
dietro di lui, li trascinò in un groviglio di corpi nella caduta; ma altri ne rimanevano; molti li colpì lo stesso
Manlio, mentre altri, dai Romani accorsi, furono con un lancio di sassi fatti precipitare giù dalla rupe. La notte
poi passò tranquilla; il giorno dopo il soldato che aveva fatto cattiva guardia fu per volere dei soldati
precipitato dall'alto del Campidoglio e a Marco Manlio in premio fu regalata - dono nella carestia dell'assedio
di non poco valore - mezza libbra di farro e un quarto di vino.
Nonostante l'indomabile volontà di resistenza, la situazione dei difensori della rocca diventava di giorno in
giorno più critica. Le vettovaglie erano state consumate e i soldati si erano ridotti a cibarsi di erbe e perfino a
masticare il cuoio delle scarpe.
Ma in non migliori condizioni si trovavano gli assedianti Galli che oltre a non aver nulla da mettere sotto i
denti, o perché denutriti e debilitati o per le pessime condizioni igieniche in cui erano, ben presto iniziò a
infierire una terribile pestilenza, che comincio a mietere numerose vittime, che erano poi ammonticchiate e
bruciate in certo punto denominato più tardi "la tomba dei Galli".
CAMILLO SCONFIGGE I GALLI
I Romani asserragliati in Campidoglio, aspettavano fiduciosi l'arrivo di Camillo che li liberasse dall'assedio,
ma tardando il dittatore a giungere e non potendo più oltre resistere, furono alla fine costretti a venire a patti
con il nemico.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
43
Le trattative furono condotte a termine da PUBLIO SULPICIO, tribuno consolare e BRENNO, che era il capo
dei Galli. Fu stabilito che questi avrebbero tolto l'assedio a patto di ricevere mille libbre d'oro.
Portarono i Romani l'oro che cominciò ad esser pesato; ma le bilance che i Galli usavano erano false e
Quinto Sulpicio protestò. Non valse a nulla la protesta del tribuno. "Guai ai vinti" rispose con arroganza
Brenno e, così dicendo, buttò nel piatto dei pesi la sua pesante e minacciosa spada perché altrettanto oro
quant'essa pesava fosse aggiunto nell'altro piatto.
Ma non volevano gli dèi che Roma sopportasse un'onta così grande.
MARCO FURIO CAMILLO, conosciuto il decreto del Senato che revocava l'esilio e lo creava dittatore, era
partito da Ardea con alcune schiere di volontari e si era portato a Vejo dove lo aspettava già pronto in armi
un esercito di circa ventimila uomini composto di Romani e di Latini dei territori vicini. Alla testa di queste
truppe Camillo era giunto a Roma proprio nel momento in cui gli assediati del Campidoglio pesavano l'oro
del riscatto.
Udendo le arroganti parole di Brenno, CAMILLO con un coraggio che solo lui poteva avere, ordinò a Sulpicio
che l'oro fosse riportato nella Rocca non ritenendo validi i patti conclusi dal tribuno senza l'approvazione del
dittatore, poi, rivoltosi al capo dei Galli, gli disse fieramente: "Non con l'oro ma con il ferro Roma si
conquista".
Furono queste parole il segnale per scatenare la tremenda offensiva ai barbari di Brenno. Colti veramente di
sorpresa i Galli cercarono di opporre resistenza, ma furono sbaragliati con delle gravissime perdite e
dovettero abbandonare Roma e ritirarsi precipitosamente sulla via Gabinia, ad otto miglia di distanza, dove
si fermarono per passarvi la notte e per riorganizzare la marmaglia.
Ma il mattino dopo CAMILLO con audace determinazione attaccò con il suo esercito di ventimila uomini
freschi il campo dei Galli. Questi che si reggevano per la fame e le malattie appena in piedi, lottarono
disperatamente, ma la loro sconfitta fu totale e nessun barbaro riuscì a tornare al proprio paese, per portare
la notizia della drammatica disfatta.
LA TRADIZIONE E LA CRITICA
Molti dei fatti che gli antichi storici ci hanno tramandati e che noi abbiamo esposti, alcuni certamente non
corrispondono alla realtà.
Sembra strana, prima d'ogni altra cosa, la richiesta di aiuti da parte di Chiusi, città che non aveva mai avuto
alcun rapporto di amicizia con Roma, ma che anzi, per essere etrusca, doveva piuttosto esserle nemica, e
semmai si sarebbe dovuta rivolgere a quelli della sua schiatta. Dobbiamo quindi credere - se pur vogliamo
passar per vero l'invio dei tre Fabii - che questi non furono mandati in qualità di ambasciatori, ma per spiare
le mosse dei Galli. E questa non è una opinione nostra la quella dello storico DIODORO, scrittore non certo
interessato a mistificare i fatti.
Leggenda senza dubbio è il racconto tradizionale della parte presa dai Fabii nel combattimento contro i Galli,
dell'ambasceria da questi inviata al Senato romano perché consegnasse loro i colpevoli, della risposta
negativa e dell'elevazione al tribunato dei tre Fabii per volere del popolo. Che sia leggenda ne è prova la
discordia che esiste tra gli storici; e se vogliamo spiegarci perché sorse e fu divulgata questa leggenda
dobbiamo supporre che i Romani, per giustificare la loro sconfitta sul torrente Allia, la
presentarono come la conseguenza della collera degli dèi, sdegnati dalla condotta sleale degli ambasciatori.
Continuando nell'esame dei fatti non ci convince l'asserzione di Livio, il quale scrive che Roma non ebbe il
tempo di contrapporre al nemico un esercito numeroso e ben disciplinato. Pare invece che le cose
andassero diversamente. Infatti, sempre Diodoro ci informa che i Romani chiamarono in aiuto gli Ernici e i
Latini e poterono radunare circa quarantamila uomini.
Sorvoliamo sul racconto delle oche, che la tradizione fa passare come le salvatrici del Campidoglio, e che
forse trova origine in una antichissima cerimonia religiosa e soffermiamoci invece sulla liberazione di Roma
attribuita all'intervento di Camillo.
I critici, specie stranieri, vogliono che l'intervento del Dittatore sia una circostanza inventata dai Romani allo
scopo di lavare con una vittoria l'onta della disfatta sull'Allia e della distruzione di Roma.
Lo storico POLIBIO - gli storici dicono per dimostrare il carattere leggendario del racconto tradizionale - non
fa nessun accenno di Camillo, ma scrive che i Galli se ne ritornarono nel loro paese senza alcuna molestia
da parte dei Romani, portandosi dietro il prezzo del riscatto. Secondo quanto invece scrive DIODORO,
Camillo entra in scena soltanto l'anno dopo la partenza dei Galli da Roma. Questi assediavano una città
etrusca alleata dei Romani quando Camillo, giunto con un esercito, li sconfisse e tolse l'oro ricevuto dagli
assediati del Campidoglio.
SERVIO invece scrive che Camillo, giunto a Roma dopo che i Galli erano partiti, li inseguì e dopo averli
raggiunti presso Pesaro, li attaccò, li sconfisse e recuperò l'oro del riscatto.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
44
Che parecchie contraddizioni esistano tra le diverse versioni tramandateci dagli storici è innegabile, ma che
proprio sia da relegarsi tra le favole l'intervento di Camillo non ci pare, né, esaminati bene e senza
preconcetti gli avvenimenti, ci sembra di trovarci di fronte ad un fatto miracoloso e perciò inverosimile.
Al tempo in cui gli assediati del Campidoglio comprano il loro riscatto, l'esercito dei Galli non è più, come sei
od otto mesi prima, così forte e numeroso. Non pochi di loro - lo abbiamo visto - abbandonando Roma sono
stati presi al soldo da Dionisio per la guerra contro le città greche; una parte è continuamente occupata in
scorrerie per procacciarsi vettovaglie per sé e per le schiere rimaste affamate a Roma, queste si sono
assottigliate di molto per le epidemie, per la fame, per i disagi, per il clima; molti Galli inoltre hanno lasciata la
vita presso Ardea. Non più di un terzo quindi delle loro forze debbono trovarsi attorno al Campidoglio e
queste dopo otto mesi certo in non buone condizioni fisiche e morali.
A Vejo sono invece raccolti un gran numero i Romani; sono anzi tutti a Vejo gli uomini validi che non sono
rimasti uccisi sulle rive dell'Allia e che riuscirono a passare il Tevere; sono certamente là molti latini costretti
ad abbandonare il proprio territorio dalle continue scorrerie dei Galli; sono là infine i guerrieri di Ardea. E il
morale di tutta questa gente è alto; hanno ottenuto due vittorie successive sugli etruschi, sono desiderosi di
vendicare la sconfitta subita, la distruzione della città, il saccheggio delle campagne, bramano di liberare
quelli che eroicamente hanno resistito nella rocca, sanno che il nemico è di molto diminuito di numero, che è
stanco che è debole, e sanno ancora di essere guidati da un famoso capitano.
Da una battaglia tra Galli e Romani, stando cosi le cose, non possono uscir vincitori che questi ultimi.
Che Camillo sia giunto proprio nel momento in cui veniva pesato l'oro, e che abbia pronunziato le famose
parole su riportate può anche non esser vero; ma noi affermiamo che non esistono ragioni sufficienti per
mettere in dubbio la sconfitta dei Galli, dovuta all'intervento di Camillo, e che invece ne esistono parecchie e
convincenti in favore del racconto tradizionale.
RIEDIFICAZIONE DI ROMA
Camillo ritornò trionfalmente a Roma. Pregato dal Senato di non dimettersi dalla carica nelle condizioni
tristissime in cui la patria versava, Camillo non rinunziò - com'era costume - alla dittatura; ordinò che i templi
profanati dai Galli "si rinnovassero, terminassero e purgassero", che si stringesse amicizia con Cere, la
quale aveva ospitato dentro le sue mura i sacerdoti e le cose sacre di Roma, che fossero celebrati i giuochi
capitolini in onore di Giove Ottimo Massimo, il quale aveva difeso il Campidoglio, sede del suo tempio, e che
infine in questo fosse depositato l'oro recuperato ai Galli.
In quel tempo tornò in campo la proposta sicinia di abbandonare Roma e popolare Vejo. La proposta era
specialmente caldeggiata dalla plebe, la quale temeva, per la miseria in cui si trovava, di essere costretta
per la riedificazione della città a fare nuovi debiti con i patrizi. Inoltre conveniva ai plebei di trasferirsi a Vejo,
nel cui territorio c'erano le terre distribuite dal Senato. Fu Camillo che risolutamente si oppose alla proposta
con un fiero discorso pronunziato al cospetto di tutta la cittadinanza, del quale ci piace trascrivere la parte
finale riferita da Livio:
"Non senza motivo gli dèi e gli uomini scelsero, come sede Roma, questo luogo dai salubri colli, lambiti da
un fiume, che è via comodissima al trasporto delle biade e dei frutti e le merci nelle terre vicine ed al mare.
Il mare è vicino, ma non tanto da esporci ai pericoli delle flotte nemiche; la posizione di Roma è unica per
una città destinata a un grande avvenire. Il segno manifesto è la sua stessa grandezza. O Quiriti, sono oggi
trecentosessantacinque anni da che essa fu fondata; è tanto che voi combattete contro antichissimi popoli; e
in tutto questo tempo Volsci ed Equi e tante potenti città non sono state in guerra pari a voi; né ha potuto
resistere a voi tutta l'Etruria, potentissima per terra e per mare, che estende il suo dominio tra mare e mare
per quanto è larga l'Italia. Stando così le cose, perché volete fare una nuova esperienza poiché siete sicuri di
quella già fatta? Ma concesso che la virtù vostra si possa altrove trasferire, è certo che altrove non si può
portare la fortuna di questo luogo. Qui è il Campidoglio, dove - essendosi trovato il teschio di un uomo - fu
vaticinato che sarebbe il capo di tutte le cose e la somma dell'imperio. Di qui con grandissima letizia dei
nostri padri, quando per mezzo di augurii si liberava il Campidoglio, non patirono di esser mossi la dea
Gioventù e il dio Termine. Qui sono i sacri fuochi di Vesta, qui i sacri scudi mandati dal cielo, qui tutti gli dèi,
propizi e felici saranno se fermamente in questo luogo rimarrete".
Si narra che trovandosi il Senato raccolto nella Curia Ostilia per prendere una decisione, un centurione che
passava davanti la curia con una schiera di soldati, comandasse al portainsegne di fermarsi, dicendo: "qui
rimarremo ottimamente".
I senatori, udendo quelle parole, uscirono dalla Curia e dichiararono di accettare l'augurio. Così non si parlò
più del trasferimento del popolo a Vejo e ci si diede subito da fare per la riedificazione della città. Materiali
furono distribuiti gratuitamente dal Senato, fu permesso che si cavassero le pietre e si tagliasse il legname
ovunque e che i cittadini rifabbricassero le case nei luoghi che ognuno di loro piaceva scegliersi.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
45
Vejo fece le spese della nuova città e questa risorse in poco tempo. La fretta però, e la libertà concessa agli
abitanti, fecero sì che non si curassero le proporzioni e le disposizioni dei nuovi edifici, che alcune vie
risultassero strette e tortuose e che le fogne non seguissero il corso delle strade.
Comunque, Roma ritornò in vita e questo fu merito di Camillo, il quale oltre al titolo di salvatore della patria si
ebbe anche quello di secondo fondatore di Roma.
Con tutte queste liberalità concesse da Camillo, non mancarono chi lo accusava nuovamente di dittatura; le
discordie per tenerle vive i suoi avversari si appigliavano a tutto, anche alle cose ben fatte; ovviamente
quelle fatte agli altri, lasciavano sempre a qualcuno la bocca amara, o per invidia, o perché ogni cosa
doveva essere fatta (solo) a loro e non agli altri.
Proprio di queste guerre e di questi particolari anni di discordie che parleremo nel prossimo capitolo:
il periodo dall'anno 389 al 362 a.C. > > >
Fonti, Bibliografia, Testi, Citazioni:
TITO LIVIO - STORIE (ab Urbe condita)
APPIANO - BELL. CIV. STORIA ROMANA
DIONE CASSIO - STORIA ROMANA
PAOLO GIUDICI - STORIA D'ITALIA
UTET - CRONOLOGIA UNIVERSALE
I. CAZZANIGA , ST. LETT. LATINA,
+ altri, in Biblioteca dell'Autore
GUERRE E DISCORDIE - CAMILLO E MARCO MANLIO 389-362 a. C.
VOLSCI E GLI EQUI SCONFITTI - LIBERAZIONE DI SUTRI - OPERE DI PACE E DI GUERRA BATTAGLIA DI SATRICO - CAMILLO IN ETRURIA - AULO CORNELIO COSSO DITTATORE CONTRO I
VOLSCI E GLI ERNICI - MARCO MANLIO CAPITOLINO - GUERRE CONTRO I VOLSCI, VELLETRI E
PRENESTE - VITTORIE DELLA PLEBE - LEGGI LICINIE-SESTIE - DITTATURA DI L. MANLIO E GUERRA
CON GLI ERNICI - I VOLSCI E GLI EQUI NUOVAMENTE SCONFITTI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alla dittatura di MARCO FURIO CAMILLO (il salvatore della Patria), nel 388 a.C.,seguì l'interregno, poi
furono creati i tribuni consolari che rivolsero tutte le cure ad opere di pace di cui tanto aveva bisogno la
risorgente martoriata città; ma mentre a Roma proseguivano alacremente i lavori di ricostruzione, voci
minacciose di guerra venivano da fuori. I Volsci, desiderosi di abbattere Roma prima che tornasse di nuovo
fiorente e forte, avevano già ripreso le armi; altri preparativi di guerra facevano gli Equi; e alcuni mercanti
provenienti dal nord riferivano che al tempio di Volturnia i rappresentanti degli Stati etruschi avevano
compatti deciso di muovere guerra ai Romani.
Si diceva anche che i Latini e gli Ernici, fino allora opportunistici fedeli alleati, ma sempre insofferenti della
supremazia romana, pure loro avevano propositi di guerre contro Roma.
Di fronte a tante minacce e nell'imminenza di così gravi pericoli, gli occhi e gli animi dei Romani si fissarono
nuovamente su CAMILLO. Lui solo, con il suo prestigio e con il suo valore, poteva salvare ancora una volta
la patria.
Fu creato perciò di nuovo dittatore ed, eletto SERVILIO ALA maestro della cavalleria, Camillo chiamò alle
armi la gioventù romana e riunì in centurie pure gli anziani ancora validi, se non alle armi, utili per altri
compiti pur sempre legati a un conflitto oltre che difensivo, offensivo.
Quando l'esercito fu pronto, Camillo lo divise in tre corpi; uno sotto il comando del tribuno LUCIO EMILIO, fu
inviato contro gli Etruschi, al di là dal territorio di Vejo; il secondo, affidato ad AULO MANLIO, fu lasciato
nelle vicinanze di Roma come presidio della città e allo stesso tempo come una eventuale riserva per gli altri
corpi; mentre il terzo, il più efficiente, fu messo alle dirette dipendenze di Camillo, che con questo corpo
marciò immediatamente contro i Volsci.
Il dittatore incontrò il nemico a Admezio presso Lanuvio. I Volsci, appreso che duce dei Romani era MARCO
FURIO CAMILLO, n'ebbero tale spavento che si chiusero nel loro campo e in fretta e furia lo fortificarono e lo
circondarono con una robusta palizzata.
Queste difese però non impressionarono il dittatore, il quale, schierate le sue truppe a battaglia, prima di
muoverle ordinò che fosse appiccato il fuoco alla palizzata e, siccome il vento per fortuna spirava favorevole,
in brevissimo tempo l'incendio divampò verso l'interno, ed aprì il varco nelle difese nemiche; a quel punto
Camillo lanciò le schiere all'assalto e questo fu così travolgente che i Volsci furono immediatamente rotti,
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
46
sgominati, messi in fuga lasciandosi alle spalle il proprio accampamento che fu dai Romani subito occupato.
Il bottino fatto era molto ricco e il dittatore lo concesse ai suoi soldati; comportamento che fu molto gradito
all'esercito tanto più apprezzato quanto meno se l'aspettavano da un capitano che non era abituato a
regalare i bottini.
Dopo la vittoria di Admezio, Camillo percorse tutto il territorio dei Volsci saccheggiandolo e finalmente
costrinse i nemici a sottomettersi; indi fulmineamente entrò nelle terre degli Equi, sorprese il loro esercito a
Bola, lo attaccò, lo sconfisse e, preso il campo, si rivolse contro la città che fu costretta alla resa al primo
assalto.
LIBERAZIONE DI SUTRI
Nel frattempo tutta l'Etruria si era levata in arme e numerose forze avevano posto l'assedio alla città di Sutri,
alleata di Roma.
Al Senato romano, dalla città assediata, furono mandati ambasciatori e da Roma furono promessi aiuti, ma,
come abbiamo visto sopra, essendo Camillo impegnato altrove e non potendo più sopportare l'assedio, gli
abitanti di Sutri, sopraffatti dal numero, stanchi dalle continue fatiche, si arresero con il patto di consegnare
le armi e gli averi e di abbandonare al nemico la città e di allontanarsi dalla stessa per avere salva la vita.
Nell'abbandonarla i disperati erano giunti poco distante dalla città, quando avvistarono l'esercito di Camillo, il
quale, avvertito dal Senato, accorreva in difesa di Sutri. Il dittatore ordinò che tutti gli oggetti e gli arnesi di
guerra fossero lasciati sotto la guardia dei profughi e marciò alla testa del suo esercito contro la città.
Nessuna sentinella era sulle mura e alle porte; gli Etruschi, non di certo aspettando l'arrivo dei Romani,
appena i Sutresi avevano abbandonato la città si erano sparpagliati per le vie intenti a saccheggiare le case.
All'improvviso sopraggiungere dell'esercito di Camillo lo scompiglio fu grande e ancora più grande e
indescrivibile fu la strage. Cercavano scampo nella fuga, ma le porte erano state chiuse e dovunque c'erano
i Romani che uccidevano senza misericordia.
Gli Etruschi tentarono di riordinare le schiere per opporre una disperata resistenza, e già alcuni
cominciavano a radunarsi quando Cammillo fece gridare dai suoi banditori che avrebbero avuta salva la vita
soltanto coloro che buttavano le armi e uscivano dalle file consegnandosi. A quel punto, tutti gli Etruschi si
arresero e Sutri, nello stesso giorno della sua capitolazione, fu liberata.
OPERE DI PACE E DI GUERRA
Al suo ritorno a Roma il trionfo di Camillo, vincitore di tre guerre, fu splendido. Dalla vendita dei numerosi
prigionieri etruschi si ricavò tanto denaro, che non solo si restituì quello che le matrone romane avevano
offerto per pagare il riscatto ai Galli, ma ne rimase così tanto da poter fare tre coppe d'oro che furono poste
ai piedi della statua di Giunone.
Ai Vejenti, ai Capenati ed ai Falisci che durante le guerre volontariamente si erano rifugiati a Roma fu
concessa la cittadinanza romana e a questi nuovi cittadini furono affidate alcune concessioni. Siccome non
pochi romani si erano arbitrariamente trasferiti a Vejo, furono richiamati. A Roma c'era in quel periodo un
gran fervore di opere e queste furono condotte con tanta alacrità che non era passato nemmeno un anno e
la città era completamente ricostruita, più grande se non più bella e urbanisticamente, più regolare di prima.
Non riposarono però le armi: alcune scorrerie furono fatte nel territorio degli Equi e fu inviato pure un
esercito nel territorio di Tarquinia, dove prima fu assalita Cortuosa, indi espugnata, saccheggiata e data alle
fiamme; poi fu investita Cortenebra, che per più giorni non ebbe un solo istante di tregua, poi cadde in potere
dei Romani, che la saccheggiarono.
In quel tempo il Campidoglio fu fortificato con una superba cinta di pietre quadrate, fu consacrato da TITO
QUINZIO, uno dei due magistrati addetti ai sacrifici, il tempio di Marte e furono aggiunte quattro tribù di nuovi
cittadini: la Stellatina, la Tromentina, la Sabbatina e l'Arniense.
Nel 368 A. di R. (386 a.C.) essendo tribuni consolari SERVIO CORNELIO MALUGACENSE, QUINTO
SERVILIO FIDENATE, LUCIO QUINZIO CINCINNATO, LUCIO ORAZIO PULVILLO, PUBLIO VALERIO e
MARCO FURIO CAMILLO, fu decisa una spedizione contro Anzio, che si stava preparando alla guerra con
l'aiuto dei Volsci e dei Latini e degli Ernici. Prese il comando supremo dell'esercito, per volontà dei suoi
colleghi, ancora CAMILLO, il quale, sceltosi come compagno PUBLIO VALERIO, marciò con le legioni
portandosi davanti a Satrico, dove si erano concentrate le truppe nemiche. Erano queste così numerose che
gli ufficiali Romani erano dubbiosi se attaccare battaglia; e perfino le schiere di soldati, più che indecise
erano sgomente dalla paura.
Accortosi di ciò, Camillo percorse a cavallo tutto il fronte del suo esercito, per incitare i soldati con la voce;
poi deciso l'attacco al nemico dando l'esempio partì per primo trascinandosi dietro le sue truppe. La battaglia
fu lunga e sanguinosa; più che il valore dei Romani, bastava che passasse il nome di Camillo di bocca in
bocca, per mettere in fuga i nemici; dovunque questi tenevano testa a una legione, subito vi accorreva il
famoso condottiero rianimando con la sua presenza e con l'esempio i suoi e portando lo sgomento nelle file
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
47
avversarie; avrebbero subito una sconfitta memorabile se un temporale con una pioggia torrenziale non
avesse interrotta la battaglia, che per il nemico era ormai disperata.
Infatti, durante la notte, i Latini, e gli Ernici abbandonarono sfiduciati il campo e i Volsci, atterriti dalla
diserzione dei loro alleati, si chiusero dentro le mura di Satrico. Camillo circondò la città, poi, vedendo che i
Volsci non reagivano ai lavori d'assedio dei Romani, giudicando che fossero scoraggiati, comandò di
prenderla subito d'assalto da tutte le parti; infatti, la città senza nemmeno tentare una difesa si arrese quasi
subito.
Ma con la ritirata dei Latini e degli Ernici e la presa di Satrico, la guerra non era ancora finita; resisteva
Anzio, e questa bisognava ridurla all'impotenza se si voleva assicurare a Roma la vittoria definitiva. Perciò
Camillo, lasciato l'esercito sotto il comando di Valerio, corse a Roma per proporre al Senato l'assalto
definitivo, la conquista e l'altrettanta definitiva distruzione di Anzio.
C'era però un'altra impresa urgente: gli Etruschi marciavano contro Nepete e Sutri e a Camillo fu ordinato di
andare a soccorrerle. Richiamato Valerio da Satrico, alla testa di altre legioni già allestite a Roma,
l'infaticabile MARCO FURIO CAMILLO a marce forzate si precipitò a Sutri.
Quando vi giunse, la città da un lato era in parte già occupata dagli Etruschi; il resto, cioè l'altro lato resisteva
ancora e la battaglia infuriava già per le vie della stessa città. Camillo divise in due il suo esercito ed ordinò a
Publio Valerio di dar l'assalto alla città dalla parte in possesso dei nemici mentre lui si sarebbe introdotto
dalla parte opposta di Sutri. Così fu: Camillo, unite le sue forze agli abitanti con le armi in mano, rianimò la
loro difesa, poi sferrò la battaglia, ricacciando gli invasori dalle posizioni conquistate. Gli Etruschi, attaccati
quindi dai due lati, disperando per la sorte del combattimento, si diedero alla fuga affrettandosi verso una
porta non ancora bloccata dalle truppe di Valerio; i primi fuggiaschi riuscirono ad allontanarsi, ma gli ultimi
subirono delle gravissime perdite. In poche ore Sutri fu liberata.
Da Sutri, Camillo si diresse alla volta di Nepete che era già caduta nelle mani del nemico per tradimento di
una parte degli stessi abitanti. Anche qui il valore dei Romani ebbe ben presto ragione del nemico, anche
Nepete fu ripresa al primo assalto e gli Etruschi e i traditori furono passati tutti per le armi.
L'anno seguente (369 A. di R. (385 a.C.) fu ripresa la guerra contro i Volsci, ai quali si erano uniti gli Ernici, i
Latini e non pochi della città di Circeio e della colonia romana di Velletri.
Fu creato dittatore AULO CORNELIO COSSO e maestro della cavalleria TITO QUINZIO CAPITOLINO.
L'esercito romano penetrò nel territorio pontino, accampandosi di fronte al nemico. I primi ad assalire furono i
Volsci, i quali fidavano nella loro superiorità numerica; ma i Romani, secondo gli ordini di Cosso, li
aspettavano a pie' fermo e, quando i nemici si precipitarono disordinatamente sopra di loro, le fanterie di
Roma, ben predisposte e armate soltanto di spada, solo allora reagivano ma nello stesso istante faceva
irruzione la cavalleria. Già questo primo scontro era favorevole ai Romani, ma poi
i Volsci, sospinti all'indietro indietro, quando ebbero un momento d'incertezza, furono presi di fianco dai
cavalieri di Quinzio. A quel punto per non essere palesemente circondati volsero le spalle e si diedero ad
una precipitosa fuga, incalzati dai Romani.
L'inseguimento durò fino al calar della notte, e oltre che compiere una strage e il numero dei prigionieri fu
così rilevante che tutto il bottino degli accampamenti dei Volsci fu lasciato alle truppe.
Dopo questa vittoria AULO CORNELIO COSSO sospese le operazioni aspettando che da Roma gli
ordinasse il Senato di condurre fino in fondo la guerra contro i Volsci; invece fu richiamato in città, dove era
necessaria la sua presenza per l'atteggiamento minaccioso della plebe sul piede della ribellione.
MARCO MANLIO CAPITOLINO
La plebe, mentre si svolgevano tutti queste guerre vittoriose, da alcuni anni versava in condizioni davvero
misere risentendo di tutti i malanni che avevano afflitto Roma. La città, dopo la cacciata dei Galli, aveva fatto
sforzi giganteschi per risorgere, ma molti sacrifici erano stati imposti ai plebei. Si era dovuta riedificare quasi
per intera la città di Roma, si erano nello stesso tempo dovute sostenere guerre aspre e lunghe; e nei campi
per la coscrizione o con i volontari sensibili alle tante promesse dei bottini, mancando braccia, una parte
erano lasciati incolti, e l'altra mal coltivati; risultò così che non avevano prodotto quanto potesse bastare al
sostentamento della popolazione. Nonostante queste gravi carenze alimentari si era dovuto ricorrere ad
imposte straordinarie per far fronte ai pericoli esterni e fortificare la città.
La plebe, che prima dell'invasione gallica, godeva di un certo relativo benessere, nonostante le concessioni
che le erano state fatte, era stata costretta per vivere, per rifarsi un tetto e per pagare i nuovi tributi
straordinari, a ricorrere ai prestiti presso i patrizi, i quali, approfittando della scarsezza di danaro, avevano
imposto condizioni da usurai.
La decadenza economica della plebe aveva portato come conseguenza la decadenza politica a tutto
vantaggio del patriziato. Fra i grandi aveva acquistato immenso prestigio MARCO FURIO CAMILLO, che era
stato sempre avverso alla plebe e non aveva mai dimenticato che proprio i tribuni plebei lo avevano fatto
processare con accuse infamanti ed erano stati proprio loro la causa del suo esilio.
Il popolo rispettava Camillo per i grandi servizi resi alla patria e per le grandi virtù militari, ma non lo amava
per il carattere duro che gli era proprio e perché in lui vedeva il maggiore sostegno del patriziato.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
48
Ma non era soltanto la plebe a non amare Camillo. Fra gli stessi patrizi vi era qualcuno che non lo vedeva di
buon occhio: ed era MARCO MANLIO CAPITOLINO (Il valoroso uomo che abbiamo visto all'assedio del
Campidoglio, il primo a scaraventare giù dalla rupe i Galli).
Discendeva questi da una delle più nobili famiglie romane, che tanti uomini illustri nelle armi aveva dato alla
patria; era d'aspetto aggraziato e dignitoso, abbastanza eloquente, molto generoso e saggio; valoroso
capitano, aveva il petto solcato da ventitre cicatrici; aveva raccolto le spoglie di trenta uomini uccisi in
battaglia ed aveva di recente compiuto quell'impresa di cui andava meritamente orgoglioso salvando con il
suo valore il Campidoglio dai Galli.
Però MARCO MANLIO non era nelle grazie dei patrizi e da qualche tempo lo tenevano lontano dalle
pubbliche cariche. Il suo animo soffriva per quest'atteggiamento del patriziato, che non apprezzava i suoi
meriti né mostrava di riconoscergli l'alto valore. Tutti gli onori erano invece per Marco Furio Camillo, di cui
Manlio Capitolino non si riteneva, inferiore; a Camillo le dittature, a Camillo il tribunato consolare, a Camillo il
comando degli eserciti e il titolo di salvatore della patria.
Marco Manlio non nascondeva il suo risentimento verso i patrizi e l'invidia che portava a Camillo, anzi,
quando aveva l'occasione, non tralasciava di fare confronti per far risaltare i propri meriti ed abbassare quelli
del fortunato rivale; e andava affermando che Camillo non avrebbe potuto liberare la patria dall'assedio dei
nemici se prima il Campidoglio non fosse stato da lui salvato, che Camillo aveva assalito i Galli quando
questi, intenti a ricevere l'oro, non si aspettavano una battaglia, mentre lui li aveva vinti e ricacciati quando
quelli erano saliti armati per impadronirsi della rocca.
Odiato e contrastato dai nobili, Marco Manlio, anche per i suoi sensi d'umanità, si accostò alla plebe e cercò
di trovare in seno a questa quelle soddisfazioni e quel favore che invano aveva sperato dai patrizi.
Manlio vide un giorno un prode centurione malmenato in carcere dal suo creditore. Si commosse a quella
vista, e corse a liberare il vecchio soldato pagandone il debito; né questo fu tutto. Animato dall'ardore della
carità, sensibile alle altrui disgrazie, un giorno vendette i suoi poderi e con la somma ricavata liberò dalla
prigione quattrocento debitori.
Da allora Marco Manlio divenne l'idolo della plebe, tutti ne tessevano le lodi, e con il passa parola, che i
beneficiati moltiplicavano all'infinito, ne magnificavano la bontà dell'animo, la generosità, la filantropia, i
sentimenti democratici. Questo comportamento del nobile Marco Manlio, dava molto fastidio al patriziato,
perché nel suo piccolo risollevava le sorti di alcuni plebei, e questo atteggiamento protettivo era considerato
un tradimento di casta.
La sua casa era sempre piena di gente del popolo, e lui non si stancava mai di parlar male dei nobili, di
rimproverar l'usura dei ricchi, di stigmatizzare la tirannide dei patrizi; rammentava di far valere i diritti che si
era guadagnati il popolo; addebitava al cinismo e alla condotta dei nobili la presente miseria dei plebei;
parlava dell'agro Pontino che avrebbe dovuto esser distribuito al popolo e che invece presto sarebbe caduto
in mano dei soliti grandi parassiti proprietari per poi lasciarli incolti; ed insinuava perfino che i patrizi si erano
impossessati dell'oro recuperato ai Galli.
A lungo andare questo suo atteggiamento aveva trovato consensi nella plebe; ed alcuni convinti e altri solo
per averlo sentito dire, già lo ritenevano un capopopolo, capace di agire e di far agire. Dunque per la casta
aristocratica, un soggetto pericoloso, un effettivo o un potenziale fomentatore.
Fu per metter fine al fermento suscitato nel popolo da Manlio che il Senato richiamò dal campo Aulo
Cornelio Cosso, il quale, giunto a Roma ed essendo stato informato delle cose, citò dinanzi al suo tribunale
Marco Manlio Capitolino. Questi si presentò seguito da una numerosa turba di suoi seguaci e, richiesto dal
dittatore di rivelare il luogo dove lui andava sostenendo che il senato avesse nascosto l'oro dei Galli, si rifiutò
sdegnosamente di parlare; per questo motivo fu accusato di calunnia, e che diffondendo la stessa era in
sostanza un sobillatore, quindi fu arrestato e mandato in carcere.
I plebei non osarono protestare, ma mostrarono il loro dolore per l'arresto del loro difensore vestendosi tutti a
lutto e lasciando incolti i capelli e la barba.
Ma quando CORNELIO COSSO lasciò la dittatura, cominciarono a levarsi molte voci a favore di Marco
Manlio, e l'androne delle carceri dov'era rinchiuso, quotidianamente era gremito di popolo, che pareva
volesse con la sua presenza in quel luogo reclamare con qualche atto sconsiderato la liberazione dell'amico
della plebe.
Il Senato, temendo appunto una sedizione popolare, deliberò di inviare a Satrico una colonia di duemila
cittadini, assegnando a ciascuno due iugeri e mezzo di terra. Ma questo dono non sollecitato sembrò alla
plebe una concessione quasi per indurla ad abbandonare al suo destino e la causa di Manlio; di modo che il
malcontento invece di cessare, aumentò.
Se prima parlavano in separata sede dei mali che affliggeva la plebe e delle ingiustizie dei patrizi; ora
accusavano pubblicamente i patrizi quali usurai e tiranni, si ricordava quel che era accaduto a Spurio Cassio
e a Spurio Melio, si magnificavano le virtù civili e militari di Manlio, rievocando la liberazione del Campidoglio
dall'assalto notturno dei Galli; davanti al carcere una folla numerosa si accalcava non solo di giorno ma
sostava anche di notte, minacciando di forzare la porta e liberare Marco Manlio.
Il Senato un po' allarmato, allora decretò la liberazione del prigioniero; che però non contribuì a far
dimenticare la grave ingiuria ricevuta, e questa fece crescer l'odio contro i patrizi. Uscito dal carcere, Marco
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
49
Manlio tornò a parlar male dei suoi nemici e a sobillar il popolo, tenendo continue adunanze nella sua casa
che era (una delle rarissime case private) proprio sul Campidoglio.
Gli animi del popolo erano talmente eccitati che non soltanto i nobili erano preoccupati, ma anche i tribuni
della plebe, i quali, con tanta piccineria, vedendo nell'opera di Manlio una menomazione della loro carica di
difensori della classe popolare, pure loro non lo guardavano di buon occhio. Per questo motivo - operando
sulla meschinità di costoro- il Senato riuscì a persuadere i tribuni plebei MARIO MENENIO e QUINTO
PUBLILIO che avrebbero accusato di "perduellione" Manlio Capitolino. (che voleva attentare allo stato,
aspirando a farne un suo regno, dunque delitto d'alto tradimento).
Correva l'anno 370 A. di R.(384. a. C) quando MARCO MANLIO, citato in giudizio, comparve davanti ai
Comizi Centuriati nel Campo Marzio, dove con buona eloquenza si difese con molta abilità. Ricordò di avere
data la sua privata fortuna per aiutare i plebei debitori; di avere soccorsa la plebe non per desiderio di
tirannide, ma per un sentimento di umanità; di aver salvato in guerra la vita a molti cittadini romani, fra i quali
il maestro della cavalleria Caio Servilio, mostrando otto corone ricevute in premio di tali fatti e molti altri doni
ricevuti dai capitani per eroiche azioni in guerra; ricordò ancora di avere per ben due volte scalate per primo
le mura di città nemiche; fece vedere le armi e le spoglie di trenta nemici da lui uccisi e, scoprendosi il petto,
mostrò le ventitré cicatrici delle sue ferite. Da ultimo, volgendo lo sguardo al Campidoglio, pregò Giove e gli
altri dei che lo aiutassero ed illuminasse la mente dei giudici, indicando poi alle centurie riunite i templi che
lui aveva difesi e salvati, e ammonì di ricordarsi delle sue benemerenze prima di giudicarlo.
Mise tanta eloquenza e passione nella sua difesa, che il popolo, commosso, lo assolse. Ma i patrizi avevano
decretato che Marco Manlio doveva sparire e perire e, poiché soltanto i comizi centuriati potevano decretare
la pena di morte, si ricorse ad un'antica usanza. Si ricrearono cioè i "duunviri", i quali citarono Manlio,
accusandolo di "perduellione", e perché le curie che dovevano giudicarlo non si lasciassero prendere dalla
commozione, come era accaduto delle centurie, alla vista dei templi del Campidoglio, la sede del processo
fu trasferito nel bosco Petelino da dove il Capitolino non era visibile, e qui Manlio fu condannato alla pena
capitale, per "perduellione" (alto tradimento contro lo stato).
Incerta è la fine dell'agitatore. Alcuni storici scrivono che fu precipitato dalla rupe Tarpea, altri dicono invece
che morì di flagellazione. Ma se la morte è oscura, tutti sono d'accordo nel riferire che i suoi beni furono
confiscati, che fu vietato a un cittadino privato di possedere una casa nella rocca capitolina e che i parenti
abolirono il nome di Manlio nella famiglia.
Uno storico invece scrive - e i critici danno molto credito a questo racconto - che Marco Manlio, dopo la
sentenza pronunciata dalle curie, spinse la plebe alla ribellione ed occupò il Campidoglio. Fu creato allora
Camillo dittatore, ma, resistendo la plebe nella rocca, si ricorse al tradimento e Manlio fu ucciso da un
sicario.
GUERRE COI VOLSCI, CON VELLETRI E PRENESTE
L'anno seguente 371 A. di R.(384. a.C.) Roma fu funestata dalla pestilenza e dalla carestia; i numerosi
nemici ne approfittarono per muoverle guerra.
Brandirono le armi quasi contemporaneamente i Volsci, Lanuvio, e le colonie di Circeio e di Velletri. Contro
quest'ultima, alla quale si erano uniti i Prenestini, furono mandati con l'esercito i tribuni consolari SPURIO
PAPIRIO e LUCIO PAPIRIO che conseguirono la vittoria contro i nemici.
Preneste allora si alleò con i Volsci ed assalì Satrico, colonia romana, la quale, per essersi difesa
accanitamente, costretta alla resa che fu crudelmente trattata.
Per punire i Prenestini e liberare la fedele Satrico fu scelto ancora MARCO FURIO CAMILLO, tribuno
consolare per la settima volta, carico di anni, ma ancor sano di mente e vigoroso di corpo. Il vecchio e
famoso capitano prese con sé il collega LUCIO FURIO e con quattro legioni di quattromila soldati ciascuna,
uscito dalla porta esquilina, marciò su Satrico, dove i nemici, di molto superiori come numero, lo aspettavano
impavidi. Giunto nei pressi della città, Camillo si accorse dell'inferiorità delle proprie forze e con grande
prudenza cominciò a temporeggiare aspettando un'occasione propizia per attaccare gli avversari con
qualche probabilità di successo.
La condotta saggia e strategicamente prudente di Camillo non piacque al collega Lucio Furio, il quale, con la
sua giovane età, impaziente e desideroso di conquistarsi la gloria, di emulare quello che ormai per lui era un
vecchio rimbambito, si propose di iniziare la battaglia; anche se era stato sconsigliato da Camillo, che volle
perfino astenersi da seguirlo per non mettere a repentaglio la sua legione.
Tuttavia Camillo rimase al comando delle legioni di riserva, pronto ad accorrere in caso di necessità; LUCIO
FURIO schierò le sue truppe e diede l'assalto. La prima linea dei Volsci, prima ancora di ricevere l'urto, si
diede di proposito alla fuga per un'erta scoscesa e difficile, ma su un percorso già prestabilito, e dietro l'erta,
in agguato, c'era il grosso del nemico. I Romani, imbaldanziti dall'iniziale successo che poi era solo quello di
aver messo in fuga un manipolo di soldati, inseguirono i fuggiaschi e caddero nella trappola; infatti, superata
l'erta, ecco farsi avanti in gran numero i Volsci con soldati freschi, e a scompaginare le legioni di Lucio Furio,
che sgomente della sorpresa, non pensarono nemmeno a resistere ma si diedero subito ad una fuga
disordinata giù nella scoscesa erta, cercando riparo negli alloggiamenti.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
50
Qui stava Camillo, il quale, avute notizie della battaglia, era montato a cavallo ed aveva fatto uscire le
riserve. Al sopraggiungere dei fuggiaschi li accolse prima con gravi ammonimenti, poi li esortò con la voce a
far fronte al nemico ed onore al nome romano.
Più che le parole valsero l'esempio del prode vecchio, che fece per primo irruzione contro il nemico, e il
combattimento fu ripreso accanito e si risolse con la piena sconfitta dei Volsci, che perdettero gli
alloggiamenti e lasciarono nelle mani dei Romani numerosi prigionieri. Fra questi vi erano non pochi
Tusculani, e per questo motivo, fu dichiarata subito guerra a Tusculo, e Camillo senza pensarci nemmeno
su, invase il loro territorio. Ma non ci fu una battaglia, perché i Tusculani, forse pentiti, o forse impauriti,
accolsero amichevolmente le truppe di Roma, dichiarando che i Tuscolani che erano con i Volsci erano dei
fuoriusciti, e che loro non c'entravano; o in buona o in mala fede, furono creduti e ottennero perdono e pace.
Approfittando di altre discordie civili che Roma si apprestava a combattere e delle quali parleremo più avanti,
un esercito di Prenestini invase, saccheggiandolo, il territorio romano e si spinse fino a porta Collina.
La sorpresa della città fu grande; fu dato l'allarme e i cittadini, messe da parte le controversie, corsero alle
mura ed alle porte e, poiché la minaccia del nemico era piuttosto grave, fu creato dittatore TITO QUINZIO
CINCINNATO, che nominò AULO SEMPRONIO ATRATINO maestro della cavalleria.
I Prenestini si erano accampati sul torrente Allia e qui andò a scovarli il dittatore con le sue legioni. La
battaglia tra i due eserciti non fu lunga e nemmeno molto impegnativa per i Romani; al primo urto della
cavalleria le falangi di Preneste si sfasciarono e si diedero a una precipitosa fuga e si fermarono quando
furono in vista della loro città.
Occupata un'altura nelle vicinanze, vi si fortificarono, ma non vi rimasero a lungo perché, inseguiti e
nuovamente assaliti, furono anche qui sbaragliati e messi in fuga trovando riparo dentro le mura della loro
città, subito dai Romani assediata.
Prima conquistarono gli otto castelli nel territorio dei Prenestini, per impedire eventuali aiuti fu investita e
costretta alla resa Velletri, poi si rivolsero a
Preneste che a quel punto trovò più saggio arrendersi piuttosto perire.
Per il dittatore TITO QUINZIO CINCINNATO ci fu il meritato in trionfo a Roma. In memoria di questa
campagna vittoriosa al Campidoglio fu murata una targa con la seguente epigrafe: "Giove e tutti gli altri dei
concessero che nove terre fossero conquistate dal dittatore Tito Quinzio, il quale, dopo venti giorni, rinunziò
alla dittatura". 371 A. di R.(384. a.C.)
Dimessosi Tito Quinzio, la guerra contro i Volsci fu continuata dai tribuni consolari PUBLIO e CAJO MANLIO
che, nel 375 A. di R. (380. a.C.) subirono per la loro avventatezza un grave scacco; e l'anno seguente da
SPURIO FURIO e MARCO ORAZIO che saccheggiarono, distrussero e bruciarono in lungo e in largo il
territorio nemico.
Essendosi poi i Volsci uniti ai Latini ed avendo riunite numerose forze attorno a Satrico, furono inviati contro
di loro le legioni con i tribuni PUBLIO VALERIO e LUCIO EMILIO i quali attaccarono i due nemici alleati a
due miglia dalla città. Una pioggia improvvisa e torrenziale fece cessare la battaglia appena iniziata che,
ricominciata il giorno dopo, si mantenne a lungo incerta ma poi ebbe termine con la rotta dei Volsci e dei
Latini e l'occupazione dei loro alloggiamenti.
La notte seguente i nemici da Satrico fuggirono ad Anzio, inseguiti dai Romani, che non essendo forniti di
macchine per un assedio si limitarono a saccheggiare per alcuni giorni il territorio fino a quando gli Anziati,
stanchi e per limitare i danni si arresero, ma i Latini, decisi a continuare le ostilità, si ritirarono prima a
Satrico, prima di lasciarla la distrussero, poi marciarono su Tuscolo, la presero di sorpresa, all'infuori della
rocca dove gli abitanti avevano avuto il tempo di rifugiarsi, e si barricarono dentro questa città.
Da Roma partirono in soccorso della città amica i tribuni LUCIO QUINZIO e SERVIO SULPICIO, i quali,
trovate sbarrate le porte di Tuscolo, prima andarono a ridare coraggio ai Tusculani della rocca, poi insieme
scesero in città, la presero d'assalto, vi entrarono, e i Latini che l'avevano occupata non ne lasciarono uscire
uno, ma ad uno ad uno li fecero a pezzi.
VITTORIE DELLA PLEBE - "LEGGI LICINIE-SESTIE"
Nonostante tutte queste guerre esterne, a Roma - come abbiamo avuto occasione di accennare - le
discordie interne si alternarono ai conflitti.
Scompartso dalla scena Marco Manlio Capitolino, la plebe, come i patrizi avevano sperato, non si era
calmata, semmai era ancora più cresciuto il malcontento; per questo motivo per calmare gli animi il Senato si
vide costretto a distribuire alla plebe l'agro pontino e trasferirne dell'altra nelle colonie di Sutri, Nepete e Seza
(anni 371-375 di R. - (376-380. a.C.).
Ma era solo demagogia, perché ovviamente solo pochissimi plebei riuscirono a godere questi benefici,
mentre la maggior parte rimasta nelle gravi ristrettezze, seguitava a lamentarsi della miseria e, fra le altre
cose, reclamava che si facesse il censo non più tenuto da oltre un ventennio e che si mettesse termine alle
esose imposte e ai soprusi del patriziato.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
51
Erano così esasperati gli animi che quasi certamente sarebbero esplosi in sanguinosi tumulti, se due uomini
d'ingegno e di senno non avessero preso le difese della plebe, fiaccata la prepotenza patrizia, rialzate le
sorti del popolo.
Furono questi CAJO LICINIO STOLONE e LUCIO SESTIO LATERANO. Licinio era nipote di quel P. Licinio
Calvo che, primo fra i plebei, aveva nel 354 rivestito la carica di Tribuno consolare. Licinio (dunque plebeo)
aveva come sposa una delle due figliole del Patrizio Marco Fabio Ambusto, la quale un giorno - come narra
la leggenda - trovandosi in casa della sorella, che era la moglie del patrizio Servio Sulpicio, allora tribuno
consolare, rimase impressionata quando il littore come al solito annunciava con ampollosità il ritorno a casa
dell'illustre tribuno.
Forse invidiosa, e forse derisa dalla sorella, si lamentò con il suo genitore Fabio di essere stata sposata ad
un plebeo; il padre, per confortarla, le promise che avrebbe procurato di fare ottenere al marito i medesimi
onori del cognato.
Da quel giorno FABIO AMBUSTO non cessò di stimolare l'ambizione di suo genero CAJO LICINIO
STOLONE
Nell'anno 378 A.d.R - 376 a.C.) fu creato finalmente tribuno della plebe insieme con LUCIO SESTIO e
unitamente al collega propose le leggi che dovevano renderlo famoso.
Il PRIMO disegno di legge contemplava i debiti della plebe e proponeva che dalle somme ricevute in prestito
si sottraessero gli interessi pagati e che il resto fosse versato ratealmente in tre anni.
Il SECONDO stabiliva che nessun cittadino doveva possedere più di cinquecento jugeri di agro pubblico e
che si assegnassero a ciascun povero sette jugeri delle terre di quei ricchi che ne possedevano oltre il limite
fissato.
Il TERZO proponeva l'abolizione del tribunato consolare e il ristabilimento del consolato, stabilendo che dei
consoli, uno doveva essere sempre plebeo.
E cosa superflua ricordare che le rogazioni "licinie-sestie" trovarono un'ostile opposizione nel ceto patrizio.
Tuttavia Licinio e Sestio, per dieci anni, successivi furono confermati tribuni e si batterono strenuamente per
far applicare e trionfare i loro disegni di legge. I patrizi, seguendo la tattica che molte altre volte era loro
riuscita, tentarono di far respingere le rogazioni tribunizie seminando la discordia fra i tribuni e
corrompendolo provocarono il veto di alcuni di loro. Ci riuscirono per un periodo di cinque anni, ma furono
combattuti con le stesse armi da Licinio Stolone e Lucio Sestio, i quali, a loro volta, servendosi del "diritto
d'intercessione", impedirono le assemblee del Senato e le elezioni dei magistrati, provocando interregni.
Questo stato di cose -visto dai patrizi- non poteva durare e il Senato ricorse al rimedio estremo della
dittatura. Fu chiamato in questa carica, nell'anno 386, MARCO FURIE CAMILLO, ormai ottantenne; ma,
minacciato dai tribuni di una multa di cinquantamila assi, il vecchio capitano rinunziò all'ufficio.
Fu creato, in sua vece il dittatore PUBLIO MANLIO, che scelse come maestro della cavalleria CAJO LICINIO
CALVO, parente di Stolone. Il nuovo dittatore mostrò ben presto di essere animato da sentimenti favorevoli
alla plebe; quest'atteggiamento consigliò il Senato a recedere dalla sua intransigenza.
Proposero così i senatori di accettare le prime due rogazioni se i tribuni avessero ritirato la terza; ma questi
si mantennero fermi. I patrizi ricorsero allora ad un ultimo tentativo e, per bocca di APPIO CLAUDIO
COSSO, affermarono che i plebei non potevano esercitare la suprema magistratura perché non avevano la
facoltà di esercitare i sacri uffizi perché quest'incarico era un privilegio del patriziato.
LICINIO e SESTIO però vinsero anche quest'ultima opposizione, presentando una rogazione con la quale si
proponeva che la custodia dei libri sibillini fosse affidata a due plebei.
Nel 386 A.d R. -368 a.C.) fu nominato ancora dittatore Camillo, ma questo non valse a far desistere i tribuni
come nel 384, e l'82 enne capitano rinunciò una seconda volta alla carica, pregando gli dei che facessero
cessare le interne discordie che tanti danni procuravano alla patria e consigliando autorevolmente il Senato
di accettare le rogazioni licinie-sestie.
Finalmente l'antiplebeo Camillo si convertiva, e appoggiava le richieste del popolo.
L'anno dopo (387 A. d. R. - 367 a.C.) fu per il fermo contegno dei tribuni, per il timore di una sollevazione
plebea e per questa autorevole intercessione di Camillo che finalmente il Senato, dopo dieci anni da quando
erano state presentate le licinie-sestie, cedette. Però anche i tribuni furono costretti a fare una concessione.
Fu stabilito di togliere ai consoli l'autorità giudiziaria e di affidarla ad un nuovo magistrato detto "pretore", da
scegliersi fra i patrizi. Approvata la legge licinia-sestia, si procedette senza indugio alle elezioni e dei
candidati plebei riuscì eletto console LUCIO SESTIO LATERANO.
In memoria dell'avvenuta concordia tra i due ceti Camillo votò un tempio alla dea Concordia alle falde del
colle Capitolino, e il Senato decretò che ai "ludi Romani maximi" che duravano tre giorni ed erano celebrati in
onore di Giove, Giunone e Minerva, se ne aggiungesse un quarto e diventassero perciò "quattriduari" (16-19
settembre).
Siccome per tali feste gli edili plebei, che ad esse erano preposti, ricevevano cento assi, quando si aggiunse
il quarto giorno che comportava perciò spese maggiori declinarono l'incarico e fu allora creata l' "edilità
curule" di spettanza patrizia alla quale i ludi furono affidati.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
52
I primi due edili curuli furono GNEO QUINZIO CAPITOLINO e PUBLIO CORNELIO SCIPIONE; accanto a
Lucio Sestio fu eletto console il patrizio LUCIO EMILIO MAMERCO; pretore fu nominato SPURIO FURIO
CAMILLO, figlio di Marco.
L'anno che seguì (388 A.d.R. - 366 a.C.) il grande avvenimento, segnò un gravissimo lutto per Roma. Una
terribile pestilenza infierì nella città e si portò via pure MARCO FURIO CAMILLO, l'uomo più grande per
valore e generosità dell'antica Roma.
DITTATURA DI L. MANLIO E GUERRA CON GLI ERNICI
Il terzo anno (391 A.d.R. - 363 a.C.) dalla approvazione della famosa legge CAJO LICINIO STOLONE riuscì
a salire al consolato. Perdurando ancora la pestilenza si fece in onore degli dèi un "lettisternio", poi, per
placar l'ira celeste, furono ordinati per la prima volta i "ludi scenici" che si svolsero con istrioni chiamati
dall'Etruria.
La pestilenza, naturalmente, non cessò, anzi durante lo svolgimento dei giochi per una piena improvvisa del
Tevere l'acqua, straripando, invase il circo.
Si ricorse -allora ad un'antica consuetudine, quella di conficcare un chiodo nel tempio di Giove, e siccome
solo il più alto magistrato dello stato poteva compiere questa cerimonia, fu così creato dittatore LUCIO
MANLIO IMPERIOSO.
Dimenticando però questi di essere stato innalzato a quel posto soltanto per la cerimonia del chiodo e
volendo muovere guerra agli Ernici che si erano da qualche tempo dichiarati nemici di Roma, ordinò la leva
e, poiché molti si erano rifiutati di obbedire, sfogò la sua innata violenza condannando i riottosi alla
fustigazione e al carcere.
Prepotenza che provocò la reazione della plebe e i tribuni lo costrinsero a rinunziare alla dittatura, ed uno di
essi anzi, MARCO POMPONIO, lo citò in giudizio, rivelando che l'ex dittatore teneva un figlio confinato in
campagna, che dal padre era costretto a compiere i più duri servizi. Il figlio però, vinto dall'amore del padre,
difendendolo, si precipitò in città e recatosi in casa di Pomponio, lo costrinse con un pugnale a ritirare
l'accusa e, in premio del suo affetto di figlio, fu nominato tribuno di una delle sei legioni.
La guerra contro gli Ernici fu fatta poco tempo dopo, nel 392 A.d.R. (362 a.C.). Fu affidato il comando
dell'esercito per la prima volta ad un console plebeo, LUCIO GENUCIO, cui la fortuna si mostrò avversa fin
dall'inizio della campagna, facendolo cadere in un agguato. Le legioni, sorprese, si lasciarono vincere più
dalla paura che dal nemico e il console, che era stato circondato, rimase ucciso.
Per vendicare lo scacco subìto fu creato dittatore quell'APPIO CLAUDIO che aveva ostinatamente avversato
le rogazioni licinie-sestie e fu formato un nuovo esercito; ma, prima che questo si muovesse, il vecchio
esercito, sotto il comando del legato CAJO SULPICIO, attaccato dal nemico nei propri alloggiamenti,
respinse valorosamente gli Ernici.
Riunite tutte le forze sotto di sé, APPIO CLAUDIO marciò determinato contro i nemici, che disponevano di
quarantotto coorti; il Romano li assali in una pianura che divideva i due accampamenti. Si combatté con pari
accanimento da entrambe le parti per l'intero giornata, con tante perdite e invano la cavalleria romana tentò
con ripetute cariche di rompere il fronte avversario. Vedendo a fine giornata incerte le sorti della battaglia, i
cavalieri smontarono d'arcione e come semplici fanti -e affiancandosi a questi ormai stanchi- si scagliarono
contro il nemico con ostinazione, e ben presto dopo averlo scompaginato, rimontati a cavallo fu messo in
fuga.
Ma la vittoria non poté essere convenientemente sfruttata con un inseguimento, per il sopraggiungere della
sera e gli Ernici trovarono prima riparo dentro il loro campo trincerato, poi inosservati durante la notte lo
abbandonarono. Il mattino dopo i Romani si ritrovarono senza più nemici.
Tuttavia furono molte le perdite degli Ernici, ma non meno gravi furono quelle dei Romani, i quali, secondo
gli storici, lasciarono sul terreno la quarta parte del proprio esercito.
Ma se i Romani era rimasti senza nemici nelle guerre locali, ben altri nemici saranno costretti ad affrontare il
prossimo anno. Infatti, stanno ritornando nel Lazio nuovamente i GALLI.
Ed è la prossima puntata a raccontarci questo nuovo scontro, oltre al resto è il periodo che va dall'anno 361
al 345 a.C. > > >
Fonti, Bibliografia, Testi, Citazioni:
TITO LIVIO - STORIE (ab Urbe condita)
APPIANO - BELL. CIV. STORIA ROMANA
DIONE CASSIO - STORIA ROMANA
PAOLO GIUDICI - STORIA D'ITALIA
UTET - CRONOLOGIA UNIVERSALE
I. CAZZANIGA , ST. LETT. LATINA,
+ altri, in Biblioteca dell'Autore
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
53
LA SECONDA GUERRA GALLICA - 361-345 a. C.
SECONDA GUERRA CONTRO I GALLI - TITO MANLIO TORQUATO - SCONFITTA DEI GALLI SOTTO LE
MURA DI ROMA - I GALLI BATTUTI A PEDO - GUERRE CONTRO GLI ERNICI, PRIVERNO, FALERIA E
TARQUINIA - NUOVE LOTTE TRA IL PATRIZIATO E LA PLEBE - M. POPILIO SCONFIGGE I GALLI - I
GALLI E LUCIO FURIO CAMILLO - MARCO VALERIO CORVO - GUERRA CON I VOLSCI E GLI AURUNCI
- L'ORDINAMENTO MILITARE ROMANO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA SECONDA GUERRA CONTRO I GALLI
Nell'anno 393 di Roma (361 a.C.), essendo consoli LUCIO SULPICIO PETICO II e CAJO LICINIO CALVO,
nonostante molte perdite e con la vittoria completa sfumata per aver dato il tempo nella notte ai nemici di
togliere il campo e di sottrarsi alla successiva battaglia, continuarono le operazioni iniziate contro gli Ernici,
che poi culminarono con l'espugnazione di Ferentino, e s'iniziò una nuova guerra contro i Tiburtini.
Nel frattempo quello stesso anno fecero la loro ricomparsa nel Lazio i Galli, i quali, penetrati nel territorio
romano con grandi forze, si accamparono a tre miglia dalla città, sulla via Salaria, di là dal ponte sull'Aniene.
Erano passati trent'anni dalla prima invasione e a Roma ancora viva quella generazione che li aveva vinti
con Camillo, non si era spento il ricordo delle ingiurie patite e degli incalcolabili danni sofferti con gli incendi
e la distruzione; per questo motivo si cercò di far fronte al grave pericolo ricorrendo alla dittatura.
Fu creato dittatore TITO QUINZIO PENNO e maestro della cavalleria SERVIO CORNELIO MALUGINENSE
e raccolto un numerosissimo esercito, alla testa del quale il dittatore uscì da Roma diretto all'Aniene; e qui le
truppe romane si accamparono.
Divideva i due opposti eserciti solo il fiume, le cui sponde erano unite da un ponte, dove ogni giorno per
occuparlo avvenivano scontri d'avamposti.
Narrano gli storici, che un giorno avanzò sul ponte un Gallo di straordinaria statura
e, ad alta voce, sfidò in un duello il più valoroso dei soldati romani.
La gioventù romana rimase muta e in soggezione per la gigantesca statura del barbaro, ma un giovane
patrizio di nome TITO MANLIO, quello stesso che con il pugnale aveva imposto al tribuno Marco Pomponio
di ritirar l'accusa contro il padre Lucio, uscito dalle schiere, si presentò al dittatore e così gli parlò: "Senza tuo
ordine io non oserei mai misurarmi anche se fossi sicurissimo della vittoria; ma, se tu me lo concedi, a quel
bestione che così ferocemente si vanta io dimostrerò che discendo da quella famiglia, che buttò giù i Galli
dalla rupe Tarpa". Il dittatore ammirato da tanto coraggio "Va, - gli rispose - o Tito, che tutti gli altri superi in
valore, e sii sempre animato da questi sentimenti verso tuo padre e la patria, e mostra con l'aiuto degli dei
che il nome romano è invincibile".
I compagni aiutarono ad armare TITO MANLIO, che imbracciò uno scudo da fante e cinse una pesante
spada, ma molto corta; poi lo accompagnarono fin presso il Gallo, che accolse schernendo il giovane
guerriero.
Un grande silenzio fu fatto nell'uno e nell'altro campo e tutti gli sguardi si fissarono ansiosi su i due guerrieri
che stavano uno di fronte all'altro. Alto e robusto come un gigante, il Gallo con addosso vestiti di vari colori e
belle armi lucenti; di media statura era invece Tito Manlio fornito di armi robuste anziché scintillanti;
ovviamente dalle apparenze i presenti giudicavano che la sorte del duello era indubbiamente favorevole al
barbaro.
Il duello iniziò e si svolse fulmineamente, pochi istanti ed era già finito. Il Gallo, certo di atterrare il nemico al
primo colpo, opponendo al guerriero romano la mano sinistra, armata dello scudo, menò con la destra con la
sua pesante spada un terribile fendente che avrebbe tagliato in due Tito se non l'avesse con scioltezza
schivato; ma questi, con straordinaria agilità, schivò il colpo, e prima che l'altro rialzasse in alto la sua
pesante e lunga spada, percuotendo con il suo scudo la parte inferiore di quello avversario, con uno scatto si
lanciò avanti con la sua corta spada e per ben due volte squarciò il ventre del barbaro, che stramazzò morto
all'istante, ingombrando con il suo immenso corpo il ponte. Tito Manlio si chinò sul cadavere del vinto e,
strappata una collana che il barbaro portava addosso, già bagnata di sangue, se la pose al collo come un
trofeo e dal nome di quella collana, a Tito gli fu dato il soprannome di "Torquato".
Il valoroso guerriero dalle legioni fu accolto con gridi e canti di giubilo e il dittatore per il coraggio dimostrato
volle donargli una corona d'oro. I Galli, vedendo nella sconfitta del loro campione un cattivo augurio o
giudicando da uno solo il valore di tutti i Romani, durante la notte lasciarono gli alloggiamenti e si ritirarono a
Tiburi, poi qui rifornitosi di vettovaglie, lasciarono la cittadina e proseguirono per la Campania.
Fu appunto per l'aiuto fornito ai Galli dagli abitanti di Tiburi -i Tiburtini- che l'anno dopo (394 A, di R. - 360
a.C.) il console CAJO PETILIO BALBO, fu dal Senato inviato con un esercito contro Tiburi per punirli.
Ma essendo dalla Campania ritornati i Galli che in compagnia dei Tiburtini avevano ricominciato a
saccheggiare e devastare i territori del labicano, albano e tusculano, fu creato dittatore QUINTO SERVILIO
ALA e maestro della cavalleria TITO QUINZIO.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
54
Il dittatore ordinò al console PETILIO di tenere a bada con le sue truppe i Tiburtini ponendosi poco distanti
dalla loro città, poi, allestito un altro esercito, uscì incontro ai Galli contro i quali iniziò il combattimento nelle
vicinanze di porta Collina, al cospetto dei vecchi, delle donne e dei fanciulli che dalle mura guardavano come
uno spettacolo la battaglia. Questa fu lunga ed accanita e causò dolorose perdite all'una e all'altra parte, ma
alla fine i Galli furono sbaragliati e, messi in fuga, disordinatamente si rifugiarono nella città dei loro alleati, a
Tiburi, ma qui le legioni di Petilio che li attendevano al varco, prima sgominarono questi poi affrontarono i
Tiburtini che erano usciti fuori per soccorrerli ma caddero pure loro nella trappola.
A questa vittoria un'altra se n'aggiunse, riportata sugli Ernici, quasi contemporaneamente, dall'altro console
MARCO FABIO AMBUSTO, così la gioia a Roma scoppiò due volte.
I Tiburtini non paghi della sconfitta esterna, anziché desistere, vollero prendersi la rivincita e l'anno seguente
(395 A. d R. - 359 a.C.) fecero una scorreria notturna sotto le mura di Roma, nella speranza di conquistare la
città con un assalto di sorpresa. Svegliati dal gran rumore ben presto i Romani in massa corsero alla difesa
e, ordinate le schiere, all'alba i consoli MARCO POPILIO e GNEO MANLIO uscirono da due porte non
assediate e assalirono alle spalle energicamente i nemici scompigliandoli e mettendoli in fuga.
L'anno dopo avendo i Tarquiniesi nuovamente percorso e saccheggiato parte del territorio romano, fu allora
dal Senato decretata contro di loro la guerra per sgominarli definitivamente e distruggere la loro città base e,
poiché pure gli Ernici non se ne stavano tranquilli, contro i primi fu mandato il console CAJO FABIO e contro
questi ultimi l'altro console CAJO PLAUZIO.
Queste due offensive contemporanee, però dava non poco da pensare ai Romani perché si stava
prospettando un minaccioso ritorno di Galli. Ma, essendosi conclusa la pace con i latini ed essendo stata
rinnovata la lega, Roma, raddoppiate le sue forze con i soldati concessi dai Latini stessi, riuscì con
tranquillità a fronteggiare i diversi pericoli.
Investito della dittatura CAJO SULPICIO ed eletto maestro della cavalleria MARCO VALERIO, l'esercito fu
inviato contro i Galli che, passati da Preneste, si erano accampati intorno a Pedo.
CAJO SULPICIO senza tentare subito la fortuna delle armi, usò la tattica del temporeggiare sapendo
d'indebolire con questa il nemico. Però le sue truppe non sopportavano questo sistema, nuovo per loro, e
cominciarono a rumoreggiare; con il passar dei giorni il malcontento divenne tumulto ed una turba di soldati
capeggiata dal prode centurione SESTO TULLIO si portò al padiglione del dittatore, affermò che gli uomini
erano stanchi di oziare e chiese di voler combattere. Penne a quel punto concesse l'iniziativa dell'offensiva e
il giorno seguente si combatté alle falde dei monti una sanguinosa battaglia, la quale, cominciata con lieve
vantaggio del nemico, terminò, per l'intervento tempestivo della cavalleria e per uno stratagemma d
preparato al dittatore, con la sconfitta dei Galli, di cui fu fatta una strage.
GUERRE CONTRO GLI ERNICI, PRIVERNO, FALERIA E TARQUINIA
Con questa clamorosa vittoria ebbe fine la seconda guerra gallica durata tre anni. Continuò invece quella
contro gli Ernici che però ben presto furono pure loro vinti e soggiogati da Cajo Plauzio.
Tuttavia a Roma non si ebbe pace e per tutto l'anno dovette rimanere in armi contro i Privernati e i Velletrani,
che più volte corsero e guastarono il territorio romano, e contro Tarquinia, le cui truppe, riuscite a far
prigionieri trecentosette soldati dell'esercito di Cajo Fabio, barbaramente li trucidarono.
I Privernati, l'anno seguente (397 A. d. R. - 357 a.C.), furono severamente puniti dal console CAJO MARZIO,
che ne saccheggiò il ricco territorio lasciando ai suoi soldati la ingente preda, poi si spinse fin sotto Priverno
e, stimolate le legioni con la promessa di un nuovo bottino, queste misero prima in fuga il nemico poi
assediata la città la costrinse a scendere a patti nella resa.
Le operazioni contro i Tiburtini furono riprese nel 398 (356 a.C.) dal console POPILIO LENATE, il quale
respinti i nemici dentro Tiburi ne saccheggiò il contado. Nello stesso anno fu ripresa anche la guerra contro
l'indomata Tarquinia cui si era alleata questa volta Faleria ed ebbe inizio con uno scacco da parte dei
Romani, dovuto ad uno stratagemma dei nemici, i cui sacerdoti, avanzando con torce accese e tenendo in
mano dei serpenti, atterrirono talmente le schiere di Roma che queste senza combattere indietreggiarono
precipitosamente fino al campo. Qui però, rimproverati aspramente dal console MARCO FABIO AMBUSTO,
si riebbero del superstizioso terrore e ritornarono con tale impeto nella battaglia che misero in fuga i Falisci
ed i Tarquiniesi e, impadronitisi degli alloggiamenti, con un cospicuo bottino se ne ritornarono a Roma
vittoriose.
Non per questa sconfitta i Tarquinesi si diedero però per vinti; radunarono numerose forze in tutta l'Etruria e
tornarono alla riscossa (398).
Parve opportuno allora eleggere un dittatore. Essendo la nomina del dittatore di spettanza consolare e
trovandosi il console patrizio FABIO AMBUSTO in Etruria fu dal Senato incaricato di creare il "magistrato
supremo" il console plebeo POPILIO LENATE, il quale elesse dittatore plebeo CAJO MARCIO RUTILIO, con
il quale, per la prima volta, la plebe partecipò alla più alta carica della Repubblica.
Ovviamente Rutilio scelse come maestro della cavalleria un plebeo, CAJO PLAUZIO. Il dittatore assolse il
suo compito con molta abilità e con pieno successo. Uscito da Roma con l'esercito, costeggiò il Tevere,
attraversandone qua e là il corso su barche e zattere per piombare alle spalle del nemico; sorprese, infatti,
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
55
molti di questi sparsi per le campagne. E anche lui prima conquistò con delle improvvise azioni sparse, molti
alloggiamenti dei nemici nella zona, poi aspettando il rientro delle varie turbe, riuscì in questo modo a
catturare più di ottomila prigionieri.
La guerra fu continuata con varie vicende negli anni seguenti: nell'anno 400 (354 a.C.) dai Tiburtini fu presa
Empulio e saccheggiato il territorio di Tarquinia; nel 401 fu costretta alla resa Sassola, e i Tiburtini
finalmente, deposte le armi, si arresero; l'esercito di Tarquinia fu definitivamente sconfitto e dei molti
prigionieri catturati, 307 furono inviati a Roma e, in mezzo al foro, furono prima fustigati poi decapitati; per
vendicarsi dei trecentosette soldati dell'esercito di Cajo Fabio, barbaramente trucidati dai Tarquini nel 396.
Quell'anno medesimo fu stretto un trattato di amicizia con i Sanniti e nel successivo (402) avendo i Volsci
riprese le armi e Tarquinia, aiutata da Cere, mandati alcuni predatori ai confini del territorio romano, fu creato
dittatore TITO MANLIO, la qual cosa spaventò talmente gli abitanti di Cere che mandarono subito una
delegazione a chiedere la pace ai Romani e, ricordando a loro l'ospitalità che era stata accordata ai
sacerdoti e alle cose sacre di Roma al tempo dell'invasione gallica, la pace e la concordia la ottennero per
cento anni.
Nel 403 (351 a.C.) finalmente, avendo i due eserciti romani devastato con continue scorrerie le campagne di
Faleria e di Tarquinia, queste città, stanche del loro lungo ed infruttuoso guerreggiare, chiesero la pace a
Roma e la ottennero per quarant'anni.
NUOVE LOTTE FRA IL PATRIZIATO E LA PLEBE
Durante questo periodo di guerre non si erano per nulla calmate a Roma le solite lotte civili. La dittatura
RUTILIO, che era plebeo, come da sempre, aveva fortemente indignato i patrizi, i quali avevano deciso di
escludere per sempre dal consolato la plebe.
In quell'anno (era il 398) pertanto si opposero alla convocazione dei comizi consolari sotto la presidenza del
dittatore plebeo e provocarono l'interregno, cui seguirono, dal 399 al 401, tre consolati patrizi.
Riuscì però alla plebe, nel 402 (352 a.C.), di fare eleggere un console del suo ceto, uomo a alla plebe amato
oltre che degno di tale carica, cioè RUTILIO; ma nel 403 per opera del dittatore i consoli tornarono ad esser
patrizi, CAJO SULPICIO PETITO e TITO QUINZIO PENNE, con gran dispetto della plebe, la quale tanto si
adoperò che quello stesso anno fece proclamare censore, per la prima volta da che questa carica era stata
istituita, un plebeo: che era sempre l'amato M. RUTILIO, e l'anno dopo (404) sostenne e fece vincere nelle
elezioni consolari un altro plebeo: MARCO POPILIO LENATE.
MARCO POPILIO SCONFIGGE I GALLI
Quell'anno medesimo (404 A.di R. - 350 a.C.) fecero la loro comparsa nel territorio dei Latini di nuovo i Galli,
ed essendo ammalato il console patrizio Lucio Cornelio Scipione, prese il comando dell'esercito proprio
MARCO POPILIO.
Questi, senza por tempo in mezzo, chiamò alle armi i cittadini, ne formò quattro legioni ed affidò una schiera
di riserva al pretore PUBLIO VALERIO PUBLICOLA. Avendo infine consigliato al Senato di armare un altro
esercito e di tenerlo pronto, lui uscì da Roma per la porta Capena e marciò contro i Galli. Giunto in vista del
nemico, le cui forze erano infinitamente superiori di numero, il console occupò un colle vicino al campo
avversario e lo fortificò con robusti steccati. La prudenza del capitano romano fu dai Galli creduta debolezza
o paura. Usciti dai loro alloggiamenti e schieratisi a battaglia, i barbari mossero risolutamente all'attacco
della collina. Ma vano fu il loro impeto: la natura del luogo e le difese erano favorevoli ai Romani e i loro
dardi non fallivano il segno; sicché i Galli della prima fila, feriti e con gli scudi carichi di dardi, prima si
arrestarono stanchi e dubbiosi, poi premuti dai difensori cominciarono ad arretrare, causando il disordine
nelle schiere retrostanti.
In questo primo fatto d'arme fu ferito MARCO POPILIO. Ritiratosi indietro per fasciarsi la ferita, ritornò poco
dopo nella prima linea e, visti i Romani che, invece di sfruttare il successo ottenuto, si riposavano, li spronò
gridando loro di riprendere la battaglia e rendere più decisiva e definitiva la vittoria.
Lui stesso diede l'esempio per primo; si mossero le insegne, e i Romani precipitarono furiosamente al piano
e qui, schierati in forma di cuneo, diedero contro alla gran moltitudine dei Galli, che non sostennero l'urto
poderoso, ma sbaragliati, si sbandarono per la campagna, lasciarono gli alloggiamenti e cercarono un rifugio
sui monti albani.
Sia per la ferita, sia per la stanchezza dei propri soldati, non ritenne opportuno Popilio di inseguire il nemico
e, distribuita tutta la preda all'esercito, lo ricondusse a Roma.
I GALLI E LUCIO FURIO CAMILLO
Essendo LUCIO CORNELIO SCIPIONE ancora ammalato e MARCO POPILIO ferito, il Senato creò dittatore
LUCIO FURIO CAMILLO, il quale, correndo l'anno 405 (349 a.C.), uscì eletto console con APPIO CRASSO.
Fu un anno il 405 di seri pericoli per i Romani: i Latini, invitati a fornire un contingente di truppe a Roma, si
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
56
rifiutarono e in una dieta tenuta nella selva sacra alla dea Ferentina stabilirono di brandire le armi contro i
Romani.
I Galli intanto, cacciati dal rigore dell'inverno dalle cime dei monti albani, scorazzavano nel territorio romano
saccheggiandolo, e in più numerosi corsari greci erano apparsi minacciosi presso le coste del Lazio ed alle
foci del Tevere e tentavano incursioni nel contado di Anzio e di Laurento.
Sotto la minaccia dei nemici e dei confederati ribelli, il Senato ordinò che si chiamassero i cittadini alle armi e
mobilitassero dieci legioni di quattromila duecento fanti e trecento cavalli ciascuna, le quali, essendo morto
nel frattempo Claudio, furono poste sotto il comando di Furio Camillo.
Questi lasciò due legioni a difesa della città, ne affidò quattro al pretore LUCIO PINARIO con l'ordine di
difendere la Maremma e tener lontani i Greci dalla costa, e con le altre quattro si recò nel territorio pontino
contro i Galli. Sicuro di stancare i nemici sorvegliandoli, passava il tempo con le truppe negli alloggiamenti.
Narrano gli storici di un singolare duello combattutosi tra un Gallo e un Romano, che ha molta somiglianza
con l'altro avvenuto sul ponte dell'Alba.
Anche questa volta il Gallo era di straordinaria statura ed armato di fortissime armi. Avanzò verso gli
alloggiamenti e sfidò a battaglia uno dei soldati romani. Uscì, col permesso del console, ad affrontarlo il
tribuno MARCO VALERIO. Dice la leggenda che un corvo, posatosi sull'elmo di Valerio, aiutasse con il
becco e gli artigli il tribuno nel combattimento contro il Gallo, il quale sbigottito dal prodigio, tormentato dal
corvo e duramente assalito dal Romano, cadde ucciso.
Irritati i Galli dalla vittoria di Marco Valerio gli corsero addosso per impedirgli di spogliare il loro compagno; si
mossero dal canto loro i Romani in aiuto del proprio campione e la mischia si accese furiosa fra i due
eserciti; ma fu brevissima, i nemici, voltate le spalle, si diedero alla fuga verso il territorio di Falerno. Marco
Valerio si ebbe in premio dal console una corona d'oro e dieci buoi e dai soldati il soprannome di Corvino.
GUERRE CON I VOLSCI E GLI AURUNCI
Satrico, distrutta dai Latini, era stata ricostruita dagli Anziati che vi avevano mandato una colonia nell'anno
406 (348 a.C.). Ma la vita della nuova città non doveva durare a lungo. Gli Anziati sobillavano i popoli del
Lazio contro Roma, e questa dichiarata ufficialmente guerra ai Volsci, l'esercito con alla guida il console
MARCO VALERIO CORVINO, nel 408, marciò su Satrico.
Nelle vicinanze della città le legioni romane si scontrarono con i Volsci; questi sbaragliati al primo assalto, si
rifugiarono a Satrico che M. Valerio mise subito sotto assedio; che non fu lungo. I Volsci, poiché i Romani
stavano per costringerli alla resa con la forza, si arresero e un numero di quattromila soldati fu fatto
prigioniero.
Satrico fu completamente distrutta e solo il tempio di Matuta fu risparmiato.
L'anno seguente, avendo gli Aurunci fatte delle scorrerie e temendosi una ribellione del Lazio, fu creato
dittatore LUCIO FURIO CAMILLO e maestro della cavalleria GNEO
MANLIO CAPITOLINO. Ma queste misure furono superiori all'entità della minaccia; infatti, gli Aurunci che
non erano poi molti, al primo scontro furono dispersi o catturati e i consoli, dimessosi il dittatore,
continuarono la campagna e si servirono dell'esercito che avevano a disposizione per assalire
improvvisamente Sora, che in breve tempo anche questa fu costretta alla resa.
L'ORDINAMENTO MILITARE ROMANO NEL V SECOLO
Tutte queste vittorie non si debbono soltanto attribuire al valore personale del soldato romano o all'abilità del
condottiero, ma anche alla sapiente "organizzazione militare" che Roma era riuscita a creare, soprattutto con
le varie esperienze che si continuavano a fare e che si trasmettevano nel corso degli anni dalla base fino agli
alti vertici militari.
La tradizione vuole che sia stato MARCO FURIO CAMILLO a perfezionare quest'organizzazione, ma noi non
possiamo credere che un ordinamento così perfetto sia stato opera di un uomo sia pure molto capace
nell'arte della guerra, ma siamo piuttosto indotti a pensare ad una lunga serie di perfezionamenti suggeriti
come detto sopra dall'esperienza acquistata in tanto battaglie.
Alla fine del quarto secolo di Roma l'organizzazione militare romana era la seguente: L'esercito era formato
dalla fanteria e dalla cavalleria. La fanteria rappresentava la massa dei combattenti su cui incombeva il peso
maggiore della battaglia; la cavalleria era un'arma sussidiaria, che all'inizio doveva sostenere la prima, aprire
i varchi negli ordini avversari, compiere movimenti aggiranti e inseguire il nemico. Alcune volte come
abbiamo visto, in alcune fasi critiche di certe battaglie, abbandonava i cavalli per trasformarsi anch'essa in
fanteria, fornendo utili contributi.
La fanteria si divideva in pesante e leggera a seconda delle armi che aveva in dotazione. La fanteria pesante
come armi di difesa aveva l'elmo, la corazza e lo scudo; questo prima era piccolo e rotondo poi fu quadrato,
di quattro piedi d'altezza e due e mezzo di larghezza; come armi di offesa aveva l'asta, lunga sei piedi, e la
spada corta a doppio taglio.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
57
La fanteria leggera, che era formata da veliti, era armata solo di lancia e di saette, senza scudo e corazza;
dunque meno armata ma spesso più sciolta nei movimenti.
La legione si componeva di cinquemila soldati, di cui forse tremilacinquecento di fanteria pesante, il resto
armati alla leggera, ed era comandata da sei tribuni militari, due dei quali a turno avevano il supremo
comando. La legione era divisa in quarantacinque "manipoli" e questi erano raggruppati in tre ordini di
quindici manipoli ciascuno, detti degli "astati", dei "principi" e dei "triari", cui appartenevano i giovani, gli
adulti e i veterani.
Ogni ordine, in battaglia, costituiva una linea, e tutti e tre erano disposti davanti al nemico nel modo
seguente: Astati Principi Triari
Mentre la cavalleria si disponeva ai due lati dell'esercito che si chiamavano "corni" o "aie".
Iniziavano il combattimento gli astati; questi se erano sopraffatti, si ritiravano tra i manipoli dei principi con i
quali, formando una linea più robusta, ritornavano nuovamente contro il nemico. Se, infine, astati e principi
erano respinti, arretrando si univano ai triari e costituivano un'ultima saldissima linea, che doveva battersi
disperatamente sapendo che non aveva dietro di sé più nessun rincalzo.
I soldati, prima di partire, prestavano il seguente giuramento di rito: "Ubbidirò ai miei capi ed eseguirò i loro
ordini".
Rigorosissima era la disciplina e le pene che si applicavano a coloro che non la rispettavano; andavano dalla
fustigazione alla decimazione, mentre gli atti di valore al contrario erano solennemente premiati. Al manipolo
che aveva preso per primo, assediandola, una città si conferiva la corona ossidionale, a chi salvava la vita
ad un cittadino durante la battaglia la corona civica, a chi scalava per primo le mura nemiche la corona
murale, a chi per primo penetrava nel campo nemico la corona vallare.
Per i capi dell'esercito, oltre le corone, c'erano l'ovazione e il trionfo.
Premio collettivo alle truppe vittoriose era la distribuzione del bottino, il quale qualche volta, soprattutto
quando era ingente, come ad esempio fu a Vejo, era destinato, tutto o, in parte, alle casse dello stato.
Ad eserciti così sapientemente organizzati, comandati inoltre da valenti capitani -che la selezione faceva
automaticamente emergere di volta in volta- ed animati da altissimo amor di patria, da nobili sensi
d'emulazione e di sacrificio, rotti ai disagi e abituati ai pericoli, non poteva, tutte le volte che si cimentavano
con i nemici -molto spesso composti da una improvvisata marmaglia e di occasionali comandanti -non
arridere la vittoria.
Con questa organizzazione, con la seconda decade del suo quinto secolo, Roma inizia non più a tutelare se
stessa dalle aggressioni dei vicini, fino allora avvenute nel Lazio, e che ha ormai quasi interamente
sottomesso, ma dà inizio a guerre di conquista fuori dal Lazio.
E la prima di queste guerre, è quella SANNITICA.
Ed è con questa che diamo inizio alla storia del periodo che va dall'anno 343 al 330 > > >
Fonti, Bibliografia, Testi, Citazioni:
TITO LIVIO - STORIE (ab Urbe condita)
APPIANO - BELL. CIV. STORIA ROMANA
DIONE CASSIO - STORIA ROMANA
PAOLO GIUDICI - STORIA D'ITALIA
UTET - CRONOLOGIA UNIVERSALE
I. CAZZANIGA , ST. LETT. LATINA,
+ altri, in Biblioteca dell'Autore
PRIMA GUERRA SANNITICA - SOTTOMISSIONE DEL LAZIO 343-330 a. C.
I SANNITI - GUERRA TRA CAPUA E I SANNITI - INTERVENTO DI ROMA - LA BATTAGLIA DEL MONTE
GAURO - BATTAGLIA DI SATICOLA - EROISMO DI DECIO MURE - BATTAGLIA DI SUESSULA - TERZA
SECESSIONE DELLA PLEBE - LA "LEX VALERIA MILITARIS" - IL "PLEBISCITO GENUCIO" - NUOVA
GUERRA CONTRO I VOLSCI E I LATINI - SEVERITÀ DEL CONSOLE MANLIO - SACRIFICIO DI DECIO
MURE - LE LEGGI DI PUBLILIO FILONE - FINE DELLA GUERRA CONTRO I LATINI E I CAMPANI ASSEDIO E PRESA DI PRIVERNO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------I SANNITI
Con la seconda decade del quinto secolo di Roma, inizia un nuovo periodo della storia romana. Roma ha
fino a questo momento combattuto per la sua esistenza; ai Latini ha quasi ormai imposto la propria
egemonia; molestata dai Volsci, dagli Equi e dagli Etruschi è stata provocata a portare le sue armi e le
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
58
proprie legioni nel territorio dei suoi nemici, a conquistare le loro città e a stabilirvi colonie; tutto questo più
che dal desiderio d'espansione e di potenza, era dettato dal necessario bisogno di tutelare se stessa.
Ora invece, a partire da questo nuovo periodo, e per i successivi circa sei secoli, le sue guerre hanno
carattere di conquista, le sue mire varcano i confini del Lazio (più tardi della penisola, poi del continente) e le
sue legioni si trovano per la prima volta di fronte ai Sanniti, popolazione allora tra le più forti e bellicose
d'Italia.
Erano i Sanniti un ramo della stirpe Sabellica sparsasi dall'Appennino settentrionale nelle regioni
appenniniche centrali e meridionali. I Sabelli fin da tempi remoti si erano divisi in vari rami, i quali recatisi in
altri paesi della penisola, avevano preso nomi diversi. Un ramo si era stabilito nella valle di Rieti con il nome
di Sabini, un altro era emigrato nelle odierne Marche con i nomi di Picenti, Marrucini e di Frentani, un terzo
ramo era andato nella valle del Fucino prendendo i nomi di Marsi e Peligni, un quarto si era spinto ad oriente
della Campania e si era suddiviso in vari gruppi che si erano chiamati Pentri, Caudini e Irpini, pur
mantenendo il nome comune di Sanniti.
Attratti dal clima e dalle ricchezze della Campania e approfittando delle condizioni di questa regione in gran
parte sotto il dominio degli Etruschi che non avevano saputo assimilarsi gli abitanti ed eliminare perfino al
loro interno il dissidio tra la democrazia e l'aristocrazia, i Sanniti vi erano scesi dalle loro montagne, avevano
sottratto Capua agli Etruschi, Cuma ai Greci e, fatte eccezione altri piccoli insediamenti ellenici, avevano
occupato quasi tutto il territorio campano.
Qui i Sanniti avevano subìto un forte influsso della civiltà greca; con i numerosi contatti, arricchiti con le
industrie e i commerci e con il relativo indotto, avevano a poco a poco perduta l'originaria fierezza e si erano
procurati una vita di agi e di mollezze. Solo i Sanniti ancora isolati sulle montagne del Sannio avevano
conservato i loro costumi, la loro sobrietà, la forza e la fierezza della propria stirpe. Ma proprio per
quest'isolamento era però assente il concetto dell'"unità nazionale" e questo rappresentava la debolezza
della stirpe sabellica; pure loro come gli Etruschi, i vari gruppi erano l'uno all'altro estranei e non di rado
nemici. Poi lo furono ancora di più quando quelli sulla costa abbandonarono tradizioni, costumi e vita.
Nonostante discesi da un ceppo comune non correvano buoni rapporti tra i Sanniti del Sannio e quelli della
Campania e quando i Sidicini, che abitavano tra il Liri e il Volturno, furono assaliti dai Sanniti del Sannio, tra
questi e i Sanniti Capuani scoppiò la guerra che doveva provocare l'intervento di Roma.
I Sidicini, non potendo resistere ai loro nemici, si erano rivolti per aiuti a Capua, che era la principale città
campana, e questa aveva inviato in loro soccorso un esercito che era stato sconfitto presso Teano.
Una seconda e non meno grave sconfitta subirono poco tempo dopo i Capuani. Il partito aristocratico che
governava la città nelle disfatte delle sue armi e nell'avanzarsi dei Sanniti del Sannio, vide più il pericolo che
incombeva sull'interna fazione politica capuana, che quello da cui era minacciata la patria e pur di salvare se
stesso e mantenere il potere non esitò ad affidarsi ad una potenza straniera per combattere i loro stessi
lontani cugini.
Ambasciatori con pieni poteri furono inviati a Roma affinché chiedessero aiuti contro i Sanniti del Sannio; ma
Roma a questi era legata da un trattato di amicizia stipulato nel 400 (354 a.C.) e non poteva né voleva
violare i patti, con il rischio di alimentare inimicizie così vicine e che potevano poi unirsi ai soliti nemici (Volsci
o Latini, mai del tutto sottomessi).
Dichiararono allora i plenipotenziari che Capua si metteva volontariamente sotto la sovranità di Roma. Era
questo un modo per non responsabilizzare i romani di essersi ingeriti in contese locali. Il senato accettò e,
non potendo lasciare i nuovi sudditi sotto la minaccia del nemico, atteggiandosi come intermediaria, inviò
ambasciatori ai Sanniti affinché si astenessero dal recare ai Capuani molestia. Non dissero palesemente
altrimenti cosa sarebbe accaduto, ma gli altri capirono benissimo.
E per tutta risposta i Sanniti, alla presenza degli stessi ambasciatori, ordinarono alle proprie truppe di fare
una scorreria nel territorio di Capua. Era dunque un'aperta sfida.
BATTAGLIA DEL MONTE GAURO
A quel punto -ma ne era ben cosciente, e forse non cercava altro che questo- Roma dichiarò guerra ai
Sanniti e, senza perdere tempo, allestiti due eserciti, furono mandati uno, al comando del console VALERIO
CORVO, in Campania, l'altro, capitanato dal console CORNELIO COSSO, nel Sannio.
Valerio occupò Capua e poiché il partito democratico mostrava apertamente d'essere malcontento del
governo che aveva di sua iniziativa offerto ai Romani il protettorato della città e per questo motivo poteva,
insorgendo, nuocere alle legioni di Roma, Valerio decise di andare ad incontrare il nemico lontano dalla città
e venne a contatto con questo presso il monte Gauro.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
59
Le prime operazioni di guerra furono scaramucce di poco conto, ma furono di molta utilità ai Romani perché
diedero loro modo di conoscere il nemico, il suo modo di combattere e anche capire il carattere di quella
fiera popolazione, audace individualmente, ma spesso insofferente alla disciplina e all'unione.
La battaglia campale avvenne dopo alcuni giorni e fu molto accanita. I fieri montanari del Sannio,
imbaldanziti dalle recenti vittorie riportate sui Capuani, si battevano a loro modo con ardore e per lungo
tempo rimasero incerte le sorti della battaglia. Allora il console, vedendo che non riusciva alle sue legioni di
respingere con la forza il nemico, pensò di fare entrare in azione la cavalleria affinché scompigliasse le linee
dei Sanniti. Ma il campo di manovra era molto ristretto, il terreno ostile, e i cavalieri non riuscirono
efficacemente pur con l'impeto a rompere il fronte avversario.
Deciso a vincere ad ogni costo, VALERIO CORVO smontò da cavallo ed ordinò alla cavalleria di fare
altrettanto, di unirsi ai fanti e di seguirlo. Spronati dall'esempio, i Romani si lanciarono dietro il loro capitano.
L'urto fu terribile, ma i Sanniti, benché decimati dalla furia romana, resistettero impavidi. La giornata volgeva
già al termine e dopo l'intera giornata trascorsa in battaglia, la stanchezza si era impadronita delle legioni di
Roma; tuttavia con un ultimo attacco, e con tutta la rabbia in corpo, tentarono l'ultimo offensiva, e fu tale
l'impeto accompagnata dall'ira, che per i Sanniti, convinti di averli stremati, quest'attacco a fine giornata fu
una spiacevole sorpresa; questa volta furono costretti ad arretrare davanti ai Romani.
La strage sarebbe stata immane e la vittoria delle truppe di Valerio completa se il sopraggiungere della notte
non avesse posto termine al combattimento.
Durante la notte i Sanniti ritennero opportuno darsi alla fuga abbandonando precipitosamente il campo e,
quando spuntò l'alba, i loro alloggiamenti furono occupati dall'esercito vincitore.
BATTAGLIA DI SATICOLA
Quanto sopra avveniva nella zona di Capua, mentre contemporaneamente l'esercito del console CORNELIO
COSSO si era accampato a Saticola, presso il Volturno. Sapendo il console che un esercito sannitico era in
marcia e avanzava contro di lui, preferì togliere il campo muovendogli incontro.
Ma, privo di guide e non conoscendo i luoghi, imprudentemente, guidò l'esercito in una valle boscosa fra
Saticola e Benevento. I Sanniti che avevano spiato le mosse dei Romani approfittarono dell'occasione che si
offriva, con buon anticipo occuparono le alture che fiancheggiavano la valle.
Quando Cornelio Cosso avanzando si accorse d'esser caduto in trappola, era ormai troppo tardi per tornare
indietro e l'esercito sarebbe stato interamente massacrato se non fosse stato salvato dal valore del tribuno
PUBLIO DECIO MURE.
Questi, avendo vista un'altura che dominava le posizioni nemiche e che i Sanniti si erano o dimenticati o
trascurato di occupare, la mostrò al console e, chiesto e ottenutone il permesso di collocarsi su quella, con
una compagnia di fanti armati alla leggera, attraverso un bosco si diresse verso la cima e solo quando prese
posizione i nemici se n'accorsero.
I Sanniti, che non sapevano che si trattava solo di un manipolo di uomini, preoccupati della minaccia che
sopra di loro sovrastava, non osarono né scendere dalle loro alture né quindi di assalire il grosso
dell'esercito, il quale ebbe così il tempo di uscire dalla valle.
Il manipolo dei coraggiosi poteva essere facilmente assalito e fatto a pezzi o bloccato dallo stragrande
numero di nemici, ma questi non seppero neppure questa volta approfittare dell'occasione e poiché era
ormai calata la sera, circondata l'altura, si disposero a passare la notte.
DECIO MURE, sapendo che non era prudente aspettare il nuovo giorno e che solo col favore delle tenebre
sarebbe potuto sfuggire alla stretta nemica in cui volontariamente si era messo, decise di tentare di passare
inosservato durante la notte attraverso il campo dei Sanniti o di aprirsi il varco a viva forza.
Pertanto esplorate le posizioni avversarie ed avendo costatato che non erano state prese misure di
sicurezza, seguito dal suo distaccamento, si pose in cammino, ed avrebbe raggiunto il console senza colpo
ferire se il rumore prodotto dallo scudo di un soldato non avesse svegliato una sentinella sannitica, la quale,
dato l'allarme, mise il campo a rumore.
I Sanniti, improvvisamente svegliati, dubbiosi se assaliti dai Romani discesi dall'altura -di cui non
conoscevano la consistenza- o dall'esercito del console tornato indietro per attaccarli, spaventati dalle grida
dei soldati di Decio che facevano baccano per dare l'impressione che erano in molti, in parte esitarono
troppo, e in parte sgomenti si sbandarono e quelli che tentarono isolatamente di opporsi al passaggio
dell'audace manipolo furono fatti a pezzi.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
60
Rimanevano ancora alcune ore della notte. Rifugiatosi in un luogo sicuro, Decio Mure aspettò lì il giorno e,
spuntata l'alba, avvertì il console degli avvenimenti della notte, ma senza altri impedimenti riuscì subito dopo
a riunirsi al grosso dell'esercito, dove fu accolto trionfalmente.
Decio Mure però troncò le manifestazioni di gioia dei commilitoni e gli elogi che Cornelio Cosso aveva
cominciato a rivolgergli; consigliò che si doveva approfittare dello sbigottimento del nemico attaccandolo
nella stessa mattina in forza. Seguirono il consiglio. L'esercito di Cosso trovò i Sanniti che non si erano
ancora riavuti dalla sorpresa, buona parte per il terrore di essere stati circondati si erano sbandati, di modo
che non fu difficile sbaragliarli del tutto e in buona parte -e questa volta era vero- circondarli manipolo dopo
manipolo e che -considerandosi ormai spacciati- non opponendo resistenza si arresero.
Secondo quello che narrano gli storici, quel giorno furono messi fuori combattimento trentamila nemici. A
Decio Mure, l'eroe della giornata, dal console gli fu data una corona e donati cento buoi, fra cui uno bianco
dalle corna dorate; mentre ai soldati del suo eroico manipolo una doppia razione di viveri, due vestiti e un
bue a testa.
Le stesse legioni donarono a Decio una corona ossidionale ed un'altra la offrirono i soldati del suo stesso
manipolo, ai quali Decio distribuì i cento buoi ricevuti in dono dal console. Il bue bianco invece fu sacrificato
a Marte.
BATTAGLIA DI SUESSULA
I Sanniti, non piegati dalle due sconfitte, che avevano sottratto buona parte del loro esercito, ritentarono la
sorte delle armi e, reclutato un nuovo fortissimo esercito, marciarono su Suessula alle falde del monte Tifata.
Informato dalle vedette di questi nuovi ostili movimenti, Valerio Corvo, lasciati indietro sotto buona scorta i
carriaggi, marciò con il suo esercito, munito dei viveri strettamente necessari, verso Suessula senza dare
troppo all'occhio e mise quasi in sordina il campo nelle vicinanze di quello nemico. I Sanniti si schierarono a
battaglia, ma i Romani senza far scoprire le loro carte, rimasero chiusi nel loro campo. I nemici credevano
che l'esercito consolare fosse poco numeroso o che aveva paura di misurarsi e, siccome l'esercito sannitico
scarseggiava di viveri, i capi lasciarono negli alloggiamenti -non conoscendo la consistenza del nemico- una
sufficiente parte dell'esercito e buona parte lo mandarono nei dintorni a procurarsi e procurare i viveri con
alcune razzie.
Valerio vedendo i nemici disseminati per la campagna e scarsamente protetti gli alloggiamenti, a quel punto
ordinò l'assalto al campo sannitico e fu questo così improvviso e furioso che in breve tempo i pochi difensori
furono sopraffati con gravissime perdite e il campo conquistato.
In questo, a guardia, il console lasciò due legioni e con il resto dell'esercito diede addosso agli altri manipoli
Sanniti, che erano andati ognuno per proprio conto in cerca di viveri e, affrontati uno ad uno ne fecero strage
strage, nella fuga trovarono scampo solo coloro che non perirono sotto il ferro romano.
Narra LIVIO che quarantamila scudi e centosettanta bandiere dei Sanniti caddero in mano delle legioni
Romane, ai quali fu distribuita la preda fatta nel campo.
La notizia delle tre strepitose vittorie si sparse rapidamente e aumentò il "terrificante" prestigio di Roma. La
prima guerra fuori dai confini era - come abbiamo visto per inesperienza dei nemici- stata quasi più facile
che non quelle dentro i propri confini.
I Falisci chiesero ed ottennero di essere alleati dei Romani, i Latini che si preparavano a una nuova guerra
contro Roma, cambiarono le proprie mire e rivolsero invece le armi contro i Peligni, di stirpe sannitica.
Perfino i Cartaginesi si congratularono con Roma e le inviarono in dono una corona di oro del peso di
venticinque libbre che fu posta nel tempio di Giove nel Campidoglio. Erano ancora i tempi dei buoni rapporti
e i contrasti egemonici non erano ancora nati. Cacciati dalla Campania da qualche tempo gli Etruschi, i
Cartaginesi e anche i Greci, pensarono che i Romani proteggendo Capua, avevano fatto solo un comodo
favore ai propri interessi.
TERZA SECESSIONE DELLA PLEBE
Il trionfo dei due consoli e di Decio Mure fu strepitoso e altrettanto grande fu la gioia di Roma per la guerra
vittoriosamente condotta a termine.
Ma la gioia ben presto scomparve al sopraggiungere delle notizie dalla Campania. La ribellione serpeggiava
fra le truppe vincitrici lasciate come presidio a Capua, a Suessula ed in altri luoghi della vagheggiata nuova
provincia romana.
La ribellione era l'effetto del malcontento dei soldati, ai quali, per essersi la guerra svolta in un modo
inconsueto, cioè in un territorio volontariamente datosi a Roma, quindi amico, era dunque mancato il solito
saccheggio delle città, e ai soldati eccetto la gloria non era venuto in tasca proprio nulla.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
61
Di questo malcontento aveva approfittato la democrazia campana per togliere il potere all'aristocrazia. Roma
aveva già esportato le guerre intestine; ed era anche un buon motivo -o un pretesto- per intervenire aiutando
una delle due fazioni; che prima o poi avrebbe poi dominate, o sostituite nel governo della regione.
A sedare l'insurrezione militare della Campania fu mandato il console plebeo CAJO MANIO RUTILO, il quale
licenziò i soldati più turbolenti, sicuro che, epurate le guarnigioni degli elementi sediziosi, la calma e la
disciplina sarebbero tornate nell'esercito.
Ma il rimedio fu peggiore del male. I legionari licenziati si radunarono presso Auxur, in una località chiamata
Lantule, costituirono un proprio esercito - in verità misero insieme una marmaglia- che poi aumentato di
numero, disordinatamente invasero, predandolo, il territorio albano dove piantarono il loro campo.
Mancando un vero capo, prima pregarono poi costrinsero TITO QUINZIO, valoroso patrizio ritiratosi a vita
privata in una villa presso Tuscolo, a comandare le bande dei rivoltosi, poi con la bandiera in testa
marciarono su Roma.
La notizia dell'avvicinarsi dei ribelli - per i motivi detti sopra, di essere stati prima abbandonati poi licenziatiaveva perfino commosso la cittadinanza. Si pensò allora che solo un uomo saggio poteva scongiurare il
pericolo che sovrastava la repubblica: M. VALERIO CORVO, uomo molto amato dai soldati, stimato dalla
plebe e popolare nell'esercito per le vittorie riportate sui Sanniti al Monte Gauro e Suessula.
Fu perciò creato dittatore e creò a sua volta maestro della cavalleria LUCIO EMILIO MAMERCO.
Valerio andò incontro ai rivoltosi sulla via Appia, ad otto miglia dalla città e bastò la sua presenza per
spegnere l'ira dei legionari, che promisero obbedienza al loro antico condottiero, il quale, a sua volta,
promise l'amnistia ai rivoltosi.
Questa rivolta del 412 (342 a.C.) non fu certamente di lieve entità se, per placarla, si ricorse alla dittatura, e i
patrizi non si opposero ad alcune leggi che in quello stesso anno furono fatte in favore dei soldati e della
plebe.
Una di queste leggi, proposta dal dittatore e che da lui si chiamò "lex Valeria militaris", stabiliva che non
potevano essere licenziati i soldati se non a chiedere il congedo fossero stati loro stessi e che dovevano
essere rispettati i gradi conseguiti nell'esercito.
Un plebiscito, detto GENUCIO dal tribuno di questo nome che aveva presentato la proposta, stabiliva che
non si poteva prestare denaro ad usura; un secondo plebiscito stabiliva che nessuno poteva coprire la
medesima carica più volte entro il periodo di dieci anni; un terzo vietava che una persona coprisse
contemporaneamente due cariche; un quarto infine permetteva che entrambi i consoli fossero plebei.
Quest'ultimo caso non si avverò per la prima volta che settantanni dopo, nel 582 (172 a.C.), quando da
molto tempo erano già cessate le contese tra patriziato e plebe.
GUERRA CONTRO I LATINI
Conseguenza della sedizione militare fu che i popoli vicini nemici -sempre pronti a sfruttare le disgrazie dei
romani- rialzarono la testa e fra questi alcuni popoli della confederazione latina che negli anni precedenti si
erano sottomessi ai romani o con la forza o con l'opportunismo.
I primi a prender le armi furono i Privernati che fecero scorrerie nel territorio di Sezia e Norba; seguirono poi i
Volsci capeggiati da Anzio. Contro gli uni e gli altri fu inviato il console CAJO PLAUZIO, il quale mosse prima
contro Priverno e, sconfitti i difensori, s'impadronì della città nella quale mise un grosso presidio romano, poi
marciò contro Anzio e qui un'accanita battaglia fu combattuta contro i Volsci e i loro improvvisati alleati, ma i
due eserciti, dopo aver combattuto a lungo, furono divisi da una furiosa tempesta. Preparandosi il giorno
dopo i Romani a riaccendere il combattimento, i Volsci, sfiduciati e stanchi, fuggirono nella vicina Anzio,
lasciando sul campo gran quantità di armi e numerosi feriti. CAJO PLAUZIO con il suo esercito con il suo
esercito continuò il saccheggio in tutto il territorio fino alla maremma.
All'altro console LUCIO EMILIO MAMERCO fu dato l'incarico di continuare la guerra contro i Sanniti, i quali
però chiesero la pace e la ottennero ed ebbero anche una certa libertà di azione contro i Sidicini (413).
Infatti, dopo aver ritirate le truppe romane dal Sannio, i Sanniti si affrettarono a marciare contro i Sidicini, i
quali questa volta furono loro a chiedere aiuto a Roma che era ormai amica e protettrice dei Sanniti, e
ovviamente essendosi rifiutata, i Sidicini si allearono con quella parte di popoli Latini che avevano ripreso le
ostilità contro Roma.
Da lungo tempo questi sopportavano malvolentieri la supremazia di Roma e cercavano solo un'occasione
propizia per ottenere parità di condizioni. Approfittando della guerra contro i Sanniti, già avevano armato
alcuni eserciti e li avevano mandati a combattere nel Sannio per proprio conto. Ora non esitarono ad allearsi
con i Sidicini e ad intendersi con i Campani, cioè con il partito democratico che aveva abbattuto il regime
aristocratico a Capua scacciandone la guarnigione romana.
Lamentandosi i Romani del contegno ostile dei Latini, questi inviarono a Roma un'ambasceria guidata dai
pretori LUCIO ANNIO di SEZIA e LUCIO NUMIZIO di CIRCEJO.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
62
Presentatisi in Senato, prese la parola ANNIO ed espose le pretese dei Latini, chiedendo che fra le città
latine e Roma vi fosse eguaglianza politica e civile, che latino fosse uno dei due consoli e latini la metà dei
senatori.
Le richieste di Annio provocarono nel Senato una grandissima indignazione. Il console MANLIO
TORQUATO, trascinato da furiosa collera, insorse a parlare e dichiarò che se avessero i Senatori accolte le
domande dei Latini egli sarebbe entrato con le armi in mano dentro la curia ed avrebbe ucciso i Latini che
avessero osato di occupare i legittimi seggi concessi.
Il contegno sprezzante di Annio e certe parole poco riguardose rivolte - secondo la tradizione - da lui agli dèi
furono fatali all'imprudente ambasciatore di Sezia.
Il Senato sollevatosi a tumulto, gli ambasciatori furono cacciati dalla curia, e LUCIO ANNIO, scivolando a
terra, picchiò il capo contro lo spigolo di una pietra rimanendo ucciso sul colpo. A stento i suoi compagni,
protetti dai magistrati, riuscirono tornare incolumi in patria.
La morte di Annio e la cacciata degli ambasciatori equivalse ad una dichiarazione di guerra.
Correva l'anno 414 (340 a.C.). I Latini, privi degli aiuti dei Volsci che non si erano riavuti dalle recenti
sconfitte, ma forti dei soccorsi dei Sidicini e dei Campani, avevano posto il campo nei pressi di Napoli, vicino
il Vesuvio per attirare i Romani nella Campania, più lontano possibile dalle loro basi, sperando che
passassero attraverso il territorio dei Volsci e degli Aurunci, popoli nemici di Roma, ai cui eserciti potevano
recar danni considerevoli durante la marcia.
Erano consoli per quell'anno TITO MANLIO TORQUATO e DECIO MURE, l'eroe di Saticola. Questi
accortamente, anziché condurre i loro eserciti per le terre nemiche dei Volsci e degli Aurunci, risalito il Liri,
attraversarono il territorio dei Marsi e dei Peligni, gente non ostile ai Romani, e, congiuntisi con gli alleati
sanniti, giunsero con le truppe integre presso il campo latino.
Essendo i Latini una popolazione che parlava la stessa lingua di Roma e usava le stesse vesti, i medesimi
costumi, gli stessi metodi di guerra e le stesse armi dei Romani, i consoli per evitare equivoci dolorosi
proibirono con la "pena di morte" che si combattesse fuori delle file.
Accadde un giorno che il giovane figlio dello stesso console Manlio, mandato in ricognizione con un
drappello di cavalleria, si spingesse a un tiro d'arco dal campo latino e si incontrasse con una squadra di
cavalieri tusculani comandata da GEMINIO MEJIO nobile per nascita e famoso per le imprese.
Motteggiato e sfidato da costui, il giovane Manlio dimenticò il divieto dei consoli ed accettò di misurarsi con
l'orgoglioso latino. Ai primi colpi il cavallo di Mejio, ferito alla testa, s'impennò e gettò di sella il cavaliere, il
quale, mentre tentava di rialzarsi, fu colpito alla gola dalla lancia del guerriero romano e abbattuto al suolo.
Lieto della vittoria riportata, il giovane ritornò al campo romano portando con sé le spoglie del nemico ucciso.
Ma il padre lo accolse molto severamente e, radunati i soldati, decretò al loro cospetto la "corona civica" al
figlio per il valore dimostrato, ma dichiarò che non poteva lasciare impunita la disobbedienza del giovane. Ci
voleva un esempio per ammonire l'esercito a rispettare gli ordini del capo e mantenere la disciplina. Davanti
al dovere, il console dimenticava con dolore l'amor di padre e non esitava a condannare il figlio.
Data la sentenza, l'esecuzione fu immediata: i littori legarono al palo il guerriero e la sua testa cadde sotto i
colpi inesorabili della scure fra il doloroso silenzio dei soldati.
II corpo di Manlio dai commilitoni ebbe splendide onoranze funebri, poi ornato delle spoglie nemiche, fu arso
sul rogo fra il compianto di tutti.
Da questo fatto ebbe origine il proverbio "manliana imperia" a significare una legge crudelmente rigorosa. Il
console non ci guadagnò in favore popolare, ma la disciplina nell'esercito fu ferreamente mantenuta e a
questa si deve se la vittoria in quella guerra e in quella circostanza arrise ai Romani.
Intanto dall'una parte e dall'altra si preparava la battaglia decisiva.
Narra la tradizione che una notte comparve in visione all'uno e all'altro console una figura gigantesca
d'uomo, la quale disse loro che avrebbe vinto quell'esercito il cui comandante si fosse spontaneamente
sacrificato alla Madre Terra ed agli Dei Infernali. Richiesto il parere agli aruspici, questi confermarono il
sogno, e i consoli stabilirono che si sarebbe gettato nella battaglia sacrificandosi quello le cui schiere
avessero cominciato per prima ad indietreggiare.
Finalmente giunse il giorno della battaglia; a Decio Mure toccò il comando dell'ala sinistra, a Tito Manlio
quello della destra dell'esercito, schierato sulle rive del Veseri.
Lo scontro fu terribile; dall'una e dall'altra parte si combatté ad oltranza con eguale accanimento e bravura.
Ma ecco che l'ala sinistra dei Romani, fortemente premuta dalle legioni latine, indugia, tenta di resistere e
non riesce a contenere l'impeto nemico. Gli astati sono costretti ad indietreggiare nelle file dei principi. A
quella vista il console Decio chiama a gran voce Marco Valerio, pontefice massimo, e lo prega di dettargli la
formula del sacrificio. Il pontefice gli ordina di indossare la toga, di ricoprirsi il capo con un velo e di ergersi
sopra una lancia distesa a terra e di profferire le parole sacramentali: "Giano, Giove, Marte padre, Quirino,
Bellona, Lari familiari, Dei novensili, Dei indigeti, Dei che avete in potere noi Romani ed i nemici nostri. Dei
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
63
Infernali, vi prego, vi adoro, vi domando perdono e vi scongiuro di dar forza e vittoria al popolo romano e dei
Quiriti e di mettere nell'animo dei suoi nemici, spavento, terrore e morte. Io maledico e meco stesso agli Dei
Infernali e alla terra consacro ed offro le legioni dei nemici per la salvezza delle legioni e della romana
repubblica".
Decio Mure pronuncia solennemente la formula, informa il collega del sacrificio che sta per compiere, monta
armato a cavallo e si lancia perdutamente nella mischia. Spettacolo stupendo! Non un uomo sembra Decio
Mure, ma un essere soprannaturale, una divinità calata sulla terra per rialzare le sorti dell'esercito romano ed
abbassare quelle dei nemici. Egli non si cura di difendersi; cerca anzi di perire e non ha altra mira che quella
di uccidere. Galoppa furiosamente in mezzo alle schiere latine con un ardire superbo, si lancia come una
catapulta, si abbatte come un fulmine, ogni cosa che incontra travolge come una valanga.
I Latini non resistono, cadono intorno a lui, fuggono, si scompigliano pazzi di terrore, mentre i Romani,
animati dal mirabile esempio del console, riprendono forza e coraggio e respingono le schiere avversarie ma
ormai già scompigliate da quella eroica bufera scatenata in mezzo a loro da Decio, che pur colpito da ogni
parte e con il corpo squarciato da numerose ferite continua a galoppare fino all'ultimo sacrificio, quando cade
come un cencio fra i nemici.
Sacrificio che però ha già dato la vittoria per merito proprio di quell'ala sinistra che Decio comandava e che
poco prima aveva dato origine al suo sacrificio.
Nonostante l'immolazione del console, sugli altri settori della battaglia le sorti non volgevano a favore dei
Romani. L'altro console allora ricorse ad uno stratagemma: fece avanzare le riserve anziché i triari, e riservò
questi per l'ultimo cozzo finale.
I Latini che sapevano benissimo come operava l'esercito Romano, furono convinti che si erano buttati nella
battaglia le ultime disponibilità di uomini e a loro volta fecero avanzare i loro triari.
Il combattimento continuò per molto tempo e sempre incerto sull'esito, ma quando Manlio vide che i triari
nemici erano stanchi e che le sue riserve cominciavano a piegare, a quel punto ordinò ai veri triari di entrare
con tutto il loro impeto e la loro esperienza in battaglia (ricordiamo che i "triari" erano composti di veterani).
L'intervento di queste truppe mature ma fresche decise le sorti della giornata. Il nemico respinto in tutti i punti
subì delle perdite ingenti, più della quarta parte delle sue forze, e il resto fu completamente disfatto.
Abbandonati gli alloggiamenti, i Latini superstiti furono da NUMIZIO, che era il loro capo, condotti verso
Minturno, lasciando nelle mani dei Romani gran quantità di bottino e un numero considerevole di prigionieri.
Durante la notte fu cercato invano il corpo di Decio Mure e solo il giorno dopo fu ritrovato sotto un mucchio di
nemici uccisi e fu sepolto con grandissima pompa.
NUMIZIO, sperando in un'immediata rivincita chiamò alle armi quanti più
uomini gli fu possibile di reclutare fra i Latini e i Volsci e con questi e i resti del suo esercito mise insieme un
altro potente nuovo esercito. Ma prima che questo, nella fase preparativi, e prima che si organizzasse e si
armasse, a Trifanno, tra Sinuessa e Minturna, fu sorpreso dal grosso dell'esercito di Manlio e fu
scompaginato prima ancora di entrare in azione; il risultato fu un disastro per i latini, una buona parte senza
nemmeno le armi in mano fu massacrata, una parte nelle stesse condizioni fu facilmente fatta prigioniera,
pochi riuscirono a mettersi in salvo fuggendo.
Dopo questa seconda battaglia il territorio latino fu percorso e dando la caccia al bottino fu completamente
depredato; e Capua vista la disfatte per non farsi punire con un sicuro massacro, si affrettò ad aprire le porte
ai vincitori.
L'agro pubblico del Lazio Latino ribelle, ormai disfatto, fu diviso ai plebei poveri in lotti di due jugeri e mezzo,
quello della Campania in lotti di tre jugeri. I Laurentini, poiché non si erano ribellati, non furono privati
dell'agro e a milleseicento cavalieri capuani, che non avevano preso le armi, fu concessa come premio di
fedeltà la cittadinanza romana ed una pensione annua di quattromilacinquecento assi ciascuno ma carico
della stessa Capua.
Così Roma premiava il partito aristocratico.
LE LEGGI DI PUBLILIO FILONE Tuttavia benché vinti, i Latini superstiti, non deposero le armi e le ostilità
continuarono sotto forma di scorrerie. Parecchie ne subirono i territori di Ostia e di Ardea da parte di Anzio e
poiché Manlio in questo periodo era infermo, fu creato dittatore LUCIO PAPIRIO CRASSO che, senza aver
nulla fatto contro i nemici, cedette il potere ai due consoli TITO EMILIO MAMERCO e QUINTO PUBLILIO
FILONE.
Questi entrambi nel 415 (339 a.C.) sconfissero un esercito latino. Filone, tornato a Roma, ricevette il trionfo;
l'altro marciò contro Pedo nelle cui vicinanze mise in fuga un esercito nemico composto di Pedani, Tiburtini,
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
64
Prenestini, Veliterni ed Anziati, poi si preparò ad investire il campo e la città, ma, essendogli giunta a notizia
del trionfo tributato al collega, lasciò sospese le operazioni di guerra e si recò a Roma a reclamare anche lui
il trionfo, che però dai senatori gli fu rifiutato.
Benché patrizio, EMILIO MAMERCO pieno di rancore, cominciò da quel giorno ad avversare il suo ceto e ad
accusare, con il console plebeo PUBLILIO FILONE, il Senato di avere usato parzialità nella divisione
dell'agro latino e campano.
Avendo la curia deciso la creazione di un dittatore la scelta cadde su di lui, su PUBLILIO FILONE, al quale si
devono le leggi che lo resero famoso. Una di queste stabiliva che le deliberazioni della plebe (plebisciti)
avessero valore per tutti i Romani; un'altra che le leggi proposte nei comizi centuriari fossero approvate
dall'assemblea senatoriale prima che fossero sottoposte al suffragio dei comizi; una terza legge stabiliva che
uno dei censori fosse sempre plebeo.
FINE DELLA GUERRA CONTRO I LATINI E I CAMPANI
Nel frattempo i Latini preparavano la riscossa. Ma fu l'ultimo ed inutile loro sforzo, perché, essendo, nel 416
(338 a.C.), consoli LUCIO FURIO CAMILLO e CAJO MENIO, i Lanuvini, i Veliterni e gli Aricini furono dal
secondo sorpresi e battuti presso il fiume Astura; mentre i Tiburtini, i Prenestini e i Pedani furono sconfitti dal
secondo sotto le mura di Pedo e la città quel giorno stesso fu presa d'assalto e costretta con la forza alla
resa.
Dopo queste vittorie gli eserciti romani iniziarono la conquista metodica dell'intero Lazio: s'impadronirono con
la forza o a patti di tutte le città che le erano ostili, e in ciascuna di queste crearono delle forti guarnigioni.
Così finì questa lunga e immemorabile guerra che era iniziata nella notte dei tempi, e le ostilità fin dalla
fondazione di Roma.
E, affinché il Lazio non potesse più ribellarsi, fu dato ad ogni città un assetto particolare e si fece scomparire
le locali "unità nazionale"; ma anche favorendo diversamente individui, famiglie e partiti e facendo sorgere o
continuando a far sopravvivere diffidenze e rivalità nei soliti due ceti alternativamente dominanti; e che non
solo a Roma, ma in ogni parte del pianeta e in ogni epoca, ha sempre caratterizzato la società umana,
causando innumerevoli guerre sanguinose; mai terminate.
Laurento, in premio della sua fedeltà, fu dichiarata indipendente ed alleata di Roma con parità di diritti e
doveri; Tuscolo, Nomento, Aricia e Lanuvio, che prima delle altre avevano fatto atto di sottomissione,
ottennero la cittadinanza romana; Velletri, Lavinio, Fondi, Forma, Capua, Cuma e Suessula ricevettero la
cittadinanza ma senza i diritti politici; a Tiburi e Preneste fu tolto parte del territorio che diventò agro pubblico
romano; le mura di Priverno e di Velletri furono smantellate; i senatori di Velletri relegati oltre il Tevere; ad
Anzio (allora un apprezzabile porto commerciale sul Tirreno) furono portate via tutte le navi, di cui una parte
fu condotta nell'arsenale di Roma ed una parte distrutta.
Con i rostri delle navi distrutte fu costruita nel foro una loggia. Da ultimo, ad Anzio fu mandata una colonia e
a tutte le città fu fatto divieto di tenere diete e di mantenere o allacciare relazioni politiche e commerciali con
qualsiasi altra città; unica a poterlo fare: Roma.
La conquista del Lazio e di parte della Campania e l'assetto dato a questi nuovi territori da Roma non
produssero un lungo periodo di pace, anzi ben presto le legioni romane dovettero sostenere una nuova
guerra.
Nemici di Roma questa volta furono i Sidicini e gli Ausoni, popoli alleati tra loro; e causa della guerra fu
l'avere i primi invaso il territorio degli Aurunci, amici dei Romani, e di aver costretta alla resa e poi distrutta la
loro città.
La guerra ebbe varie vicende e si trascinò alcuni anni.
Piuttosto debole all'inizio, prese vigore nel 418 (336 a.C.) quando consoli LUCIO PAPIRIO CRASSO e
CESONE DUILIO sbaragliarono un esercito di Sidicini e di Ausoni nelle vicinanze di Cales, posta nel centro
della Campania.
Fra rivalse, rivincite, e ostinazione da entrambe le parti, le operazioni offensive furono riprese con maggiore
vivacità l'anno seguente (419) dal console MARCO VALERIO CORVO, il quale, nuovamente vinti i nemici
nel territorio di Cales, pose l'assedio alla città, il quale chi sa quanto sarebbe durato a causa delle formidabili
fortificazioni se un fortunato caso non l'avesse con gran facilità consegnata in mano ai Romani.
Vi era a Cales prigioniero un romano di nome MARCO FABIO. Questi, in un giornata di grande festa dei
nemici, approfittando delle eccessive libagioni dei suoi carcerieri non meno sobri degli altri, riuscì a fuggire
calandosi per mezzo di una corda dalle mura e indusse il console a dare subito l'assalto alla città. Questa fu
facilmente presa e i nemici furono fatti prigionieri e venduti come schiavi, spopolando così la città.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
65
A Cales fu lasciato un forte presidio e l'anno dopo (420 A. d. R. - 334 a.C.) per ripopolarla fu inviata da Roma
una colonia di duemilacinquecento uomini.
ASSEDIO E CONQUISTA DI PRIVERNO
La potenza di Roma con queste ultime imprese, si andava sempre più affermando nell'Italia centrale e
meridionale. Con una sua oculata politica, Roma castigava esemplarmente le città riottose e su queste
faceva pesare la sua mano di ferro; oppure premiava le fedeli, ne univa a sé alcune per mezzo di trattati
d'alleanza, ad altre concedeva la cittadinanza.
I cittadini romani che nel 415 (339 a.C.) risultavano 160.000, salirono nel 425 (329 a.C.) a 250.000 e le tribù
che erano ventisette raggiunsero nel 422 (332 a.C.) con la creazione delle due nuove tribù, chiamate "Mecia
e Scapzia" il numero di ventinove.
Grande sviluppo prendeva intanto il sistema coloniale; il quale aveva due scopi: quello di alleviare la miseria
della plebe e di eliminare le cause di perturbamenti interni con l'allontanamento dei disoccupati, e quello di
rendere più sicure le conquiste e custoditi i confini.
Pur fra tanto fervore e tanta sapienza di provvedimenti economici, politici e militari, non mancavano le
ribellioni e le spedizioni punitive. Se da una parte l'affermazione della potenza romana attirava nella sua
orbita popoli nemici come i Volsci, Fabratemi e gente lontana come quella dei Lucani, che chiedevano ed
ottenevano la protezione di Roma, dall'altra le ultime scintille d'indipendenza facevano qua e là sorgere
tentativi di riscossa.
Nel 424 (330 a.C.) riprese le armi Priverno spalleggiata da non pochi abitanti di Fondi. La rivolta fu
capeggiata da un patrizio fondano di nome VITRUVIO VACCO, molto noto a Roma perché era uno dei
rarissimi che possedevano case sul monte Palatino. Vitruvio, con le sue soldatesche, aveva invaso e
saccheggiato il territorio di Sezia e di Norba. Contro di lui fu inviato il console LUCIO PAPIRIO CRASSO,
che scontratosi con il nemico, con molta facilità lo sconfisse costringendolo a ritirarsi prima dentro il campo
trincerato, poi dentro le mura di Priverno.
L'altro console, LUCIO PLAUZIO VERNONE, lasciato il collega all'assedio di Priverno, marciò su Fondi, i cui
abitanti fecero subito atto di sottomissione.
Dopo questa resa le forze romane furono concentrate intorno a Priverno, che fu costretta alla resa non molto
tempo dopo e cadde pure questa in potere dei Romani. Alcuni affermano che la città fu presa d'assalto, altri
invece che si arrese consegnando Vitruvio.
Il console Plauzio fu ricevuto a Roma in trionfo; Vitruvio morì sotto le verghe; le mura di Priverno furono
smantellate ed alla città fu imposto un numeroso presidio; le case di Vitruvio sul Palatino furono demolite e ai
senatori privernati inflitte le stesse pene alle quali era stato condannato il senatore di Velletri.
Agli abitanti di Priverno, in premio della loro fierezza e del loro patriottismo, il fine tatto politico di Roma
concesse la cittadinanza.
Ma se il Lazio era ormai tutto sottomesso, una definitiva sistemazione dei territori oltre i confini -dove Roma
era la garante "gendarme"- non era ancora avvenuta; e quella dove le lotte interne andranno ad innescare
una nuova guerra con l'"intervento protettivo" romano, sono nuovamente i SANNITI; poi i lontanissimi amici
di Roma, che erano i LUCANI, che oltre che coinvolgere Roma, nella loro lotta per TARANTO, scomodarono
dalla Grecia come avversario il Re dell'Epiro Alessandro, zio e omonimo dell'allora ventenne condottiero
Macedone.
Inizia insomma la seconda GUERRA SANNITICA che andiamo a narrare nel successivo capitolo il periodo
dall'anno 326 al 312 > > >
Fonti, Bibliografia, Testi, Citazioni:
TITO LIVIO - STORIE (ab Urbe condita)
APPIANO - BELL. CIV. STORIA ROMANA
DIONE CASSIO - STORIA ROMANA
PAOLO GIUDICI - STORIA D'ITALIA
UTET - CRONOLOGIA UNIVERSALE
I. CAZZANIGA , ST. LETT. LATINA,
+ altri, in Biblioteca dell'Autore
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
66
LA SECONDA GUERRA SANNITICA - FORCHE CAUDINE 326-312 a. C.
ALESSANDRO, RE D' EPIRO, IN ITALIA - ASSEDIO DI PALEOPOLI - GUERRA CONTRO IL SANNIO ALIFE, CALIFE, RUFINO E PALEOPOLI CADONO IN POTERE DEI ROMANI - LUCIO PAPIRIO CURSORE
DITTATORE - BATTAGLIA DI IMBRINIO - TREGUA CON I SANNITI - AULO CORNELIO ARVINA BATTE I
SANNITI - SUICIDIO DI BRUTOLO PAPIO - I ROMANI ALLE FORCHE CAUDINE - II SENATO ROMANO
SI RIFIUTA DI RATIFICARE LA PACE CAUDINA - LIBERAZIONE DI LUCERIA - I SANNITI PASSANO
SOTTO IL GIOGO. DISTRUZIONE DI SATRICO E TREGUA CON IL SANNIO - RIPRESA DELLA GUERRA
SANNITICA - RIBELLIONE E ASSEDIO DI SATICOLA - INSURREZIONE DI SORA E BATTAGLIA DI
LAUTULE - INSURREZIONE DI AUSONIA, MINTURNA VESTINA E CAPUA - COLONIE ROMANE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSEDIO DI PALEOPOLI
Mentre Roma era intenta a rafforzare il suo dominio sul Lazio e sulla Campania e si premuniva contro il
Sannio inviando coloni nei confini di questa regione, continue guerre tenevano sconvolta 1'Italia meridionale.
Una lotta accanita si era ingaggiata fra la Lucania e la Messapia da una parte e Taranto dall'altra. ("Messapi"
= antico popolo della Puglia d'origine Illirica).
Taranto era una città d'industriali e di commercianti che si governava a regime democratico. Colonia greca
da oltre quattro secoli, ma con influenze egee già millenarie, era diventata l'emporio più fiorente della
penisola; ma le guadagnate ricchezze cui erano successi agi e mollezze avevano reso apatici gli abitanti,
forse un po' troppo convinti che le invidie non abitavano su questo pianeta; e che la prosperità sarebbe
durata all'infinito.
Assalita dai Messapi e dai Lucani, Taranto, priva di proprie forti milizie, si era servita di alcuni eserciti di
mercenari chiamati nella vicina penisola balcanica e da quella Grecia con la quale i rapporti commerciali
reciproci erano molto stretti. Del resto a Taranto i Greci avevano i loro migliori empori e quindi interessati a
difenderli.
Primo a venire in aiuto di Taranto era stato ARCHIDAMO, re di Sparta, ma questi non aveva avuto molto
fortuna, e nel 416 (dalla fondazione di Roma - 338 a.C.) l'anno stesso in cui FILIPPO II di Macedonia
vinceva a Cheronea, sconfitto dai Lucani era rimasto ucciso in battaglia.
Era giunto poi, chiamato dai Tarantini, ALESSANDRO re d' Epiro (lo zio dell'allora ventenne ALESSANDRO
MAGNO) il quale, più fortunato, aveva presso Pesto, disfatto i Lucani e i Sabini e a Siponto i Messapi.
Schieratosi poi contro la stessa Taranto (la situazione politica in Grecia era completamente mutata - Filippo
la dominava interamente), cui aveva tolto la città di Eraclea, e richiesti invano gli aiuti dei Greci che erano in
Italia, Alessandro si era trovato ad aver come nemici non solo i Tarantini, ma anche i Bruzi, i Lucani, ancora i
Messapi ed i Sanniti, e, trovandosi un giorno a guadare un fiume Acheronte vicino la città di Pandosia, era
stato colpito da un soldato lucano; ferito annegò nel fiume. Erano nel frattempo passati dieci anni dal suo
arrivo.
Le condizioni dell' Italia meridionale e specialmente in quegli anni con la presenza di Alessandro, alleato di
Roma, avevano tenuto a freno i Sanniti, i quali non si erano rassegnati alla perdita del loro predominio sulla
Campania ed aspettavano solo il momento della riscossa.
Schiaritosi l'orizzonte nel mezzogiorno della penisola e morto Alessandro, i Sanniti pensarono che era giunto
il momento di ergersi contro i Romani e cominciarono con il creare a Roma delle difficoltà nella Campania,
istigando Paleopoli a insorgere (alcuni storici, Paleopoli la identificano con Napoli stessa, allora non
sterminata come oggi; forse era quella parte posta più a sud; in ogni caso parlando di Paleopolitani ci si
riferisce ad entrambe le due colonie).
Paleopoli era una città vicinissima alla vera Neapolis sull'omonimo golfo e l'una e l'altra erano due colonie di
Cuma, e, benché sotto un governo comune, non andavano d'accordo essendo democratica la prima e più
aristocratica la seconda (probabilmente erano due insediamenti nel grande golfo, ma divisi dal ceto; e in
mezzo da una fascia di territorio ancora disabitato).
Paleopoli iniziò la lotta contro la Campania romana facendo delle scorrerie nel territorio falerno e in quello di
Capua.
Affinché questi moti iniziati a Paleopoli non si estendessero alle altre città campane, Roma fu dell'avviso di
prendere seri provvedimenti e allestì due eserciti, di cui uno, al comando del console CORNELIO LENTULO,
fu inviato a Capua per contrastare una probabile minaccia sannitica, l'altro, capitanato dal console PUBLILIO
FILONE, fu inviato contro Paleopoli, la quale, nel frattempo aveva ricevuto l'aiuto di quattromila Sanniti e
duemila Nolani.
PUBLILIO FILONE si accampò tra Neapolis e Paleopoli e iniziò le operazioni d'assedio. Questo però non fu
impresa facile e breve, e Paleopoli resisteva ancora quando scaduto il termine del consolato (428 A. di R. 326 a.C.), allo scopo di non interrompere la continuità del comando, a Roma fu dai comizi lasciato in carica
PUBLILIO con il titolo di proconsole per tutta la durata della guerra.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
67
Il Sannio intanto si preparava alla guerra; da una parte cercava di far sollevare Formia, Fondi e Priverno,
dall'altra mobilitava l'esercito e richiedeva aiuti agli altri popoli di stirpe sabellica, i quali però rimasero
neutrali, eccettuati i Vestini.
Venuta a conoscenza di questi preparativi, Roma inviò ambasciatori nel Sannio per chiedere spiegazioni; ma
i Sanniti risposero lagnandosi del contegno ostile della repubblica romana che aveva non molto tempo prima
riedificata Fregelle, dal Sannio tolta ai Volsci e disfatta, e non contenta vi aveva inviato una numerosa
colonia con degli scopi non proprio chiari.
Inoltre i Sanniti fecero sapere che, se i Romani non avessero abbandonata Fregelle, essi avrebbero fatto
ogni sforzo per riaverla; e, poiché gli ambasciatori proponevano di mettere "questa vertenza" al giudizio di
amici comuni, i Sanniti aggiunsero con arroganza: "Nessuno deve essere giudice delle nostre liti; e nella
piano tra Capua e Suessula, dove ci incontreremo, le nostre armi risolveranno "questa vertenza".
Fu pertanto dichiarata guerra al Sannio. I Lucani e gli Apuli si schierarono in favore dei Romani e l'anno
successivo, nel 429 (325 a.C.) prima ancora che i Sanniti fossero pronti a scendere in campo, tre città della
loro regione, Alife, Calife e Rufrio invase caddero in mano dei Romani.
Quel medesimo anno anche Paleopoli cadde in potere dell'esercito romano. Stanchi del lungo assedio e non
volendo sopportare oltre la prepotenza dei Nolani e dei Sanniti loro alleati, gli abitanti di Paleopoli decisero di
consegnar la città al nemico.
Due dei principali cittadini, CARILAO e NINFIO, furono gli autori del tradimento. Il primo, recatosi dal
proconsole romano, promettendo la conquista della città gli fu affidato un contingente di tremila fanti; il
secondo, riuscito a persuadere LUCIO QUINZIO, capo dei Sanniti, di voler fare un'incursione verso Roma, si
allontanò di notte dalla città con la maggior parte della guarnigione, lasciando così la città con poche difese.
In questo modo Carilao riuscì a penetrare con i Romani dentro le mura e offrire la città occupata al
proconsole Filone.
Ottenuti questi successi nel Sannio e a Neapolis, ed essendo gli amici Lucani passati ai Sanniti, Roma
decise di intensificare la guerra e, affinché i Vestini non potessero congiungersi con i Sanniti, diresse
all'inizio del 430 (324 a.C.) contro quelli, il console GIUNIO BRUTO e contro questi, il console LUCIO FURIO
CAMILLO.
Bruto invase il territorio dei Vestini saccheggiandolo e, sbaragliato il nemico, lo costrinse a rifugiarsi dentro le
loro città murate, delle quali due furono in poco tempo costrette alla resa: Cutica, Cingilia.
L'altro esercito, essendosi ammalato Camillo, passò sotto il comando del dittatore LUCIO PAPIRIO
CURSORE, valentissimo capitano, che scelse come maestro della cavalleria QUINTO FABIO RUTILIANO.
Trovandosi quest'esercito nel Sannio, il Dittatore dovette recarsi a Roma per ricevere gli auspici e, partendo,
ordinò a Fabio di non scendere a battaglia con il nemico durante la sua assenza.
FABIO però, appreso che i Sanniti non si adoperavano molto a fare buona guardia, non seppe resistere al
desiderio di sorprendere e vincere i nemici, e, dimenticati gli ordini ricevuti, li assalì ad Imbrinio e li sconfisse
in una battaglia cruentissima. Secondo gli storici, circa ventimila Sanniti caddero in quella loro drammatica
giornata.
Anziché ricevere il premio della vittoria, Fabio scampò a stento, grazie all'aiuto dei soldati, all'ira di Papirio,
che voleva punirlo esemplarmente per aver trasgredito l'ordine, e lui si rifugiò a Roma, dove le preghiere del
Senato e del vecchio padre di Fabio riuscirono a chiedere il perdono per il vincitore d'Imbrinio.
PAPIRIO CURSORE, ritornato al campo, riprese le operazioni nel corso del 431 (323 a.C.) contro i Sanniti;
ma i suoi soldati non erano più quelli di prima; la sua intransigenza in fatto di disciplina aveva da lui alienato
le simpatie delle truppe e queste avrebbero con il loro contegno compromesse le sorti della guerra se
Papirio Cursore non avesse, con molta abilità, riacquistato la loro amicizia e allontanato il rancore.
Le legioni romane tornarono a battersi volentieri e, in una battaglia campale, inflissero al nemico una terribile
disfatta; poi corsero in lungo e in largo il Sannio saccheggiandolo per ottenere il più possibile bottino di
guerra.
Battuti, stanchi, invasi dalle scorrerie, e privi d'aiuti, i Sanniti chiesero la pace, ma avrebbero dovuto
totalmente assoggettarsi, perché i romani l'avrebbero concessa ma senza alcuna condizione; così ottennero
dai Romani solo la tregua per un anno e furono messi sotto osservazione.
DISFATTA E SUICIDIO DI BRUTOLO PAPIO IL CAPO SANNITA
La tregua dai Sanniti non fu rispettata. Non era ancora finito l'anno di tregua, quando nel corso dell'anno 432
(322 a.C.) sotto il consolato di QUINTO FABIO E LUCIO FULVIO, fu riportato a Roma che il Sannio
riprendeva le armi e alcune milizie dei vicini popoli erano state assoldate per organizzare un grande esercito.
Fu creato allora il dittatore AULO CORNELIO COSSO e maestro della cavalleria MARCO FABIO AMBUSTO
e fu allestito un fortissimo esercito.
Le legioni romane, entrate nel Sannio, poiché il paese sembrava tranquillo, si accamparono in una zona non
molto felice, e inoltre trascurando di costruirsi consistenti opere di difesa. Nel tardo pomeriggio, poco
distante, comparve improvvisamente un numeroso esercito sannitico.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
68
Fortunatamente per l'approssimarsi della sera, il nemico non molestò i Romani; ma senza dubbio il giorno
dopo la battaglia non sarebbe mancata e, siccome il dittatore pensava che lo svantaggio del luogo avrebbe
potuto influire sul valore dei propri soldati, ritenne opportuno approfittare delle tenebre per allontanarsi con
tutto l'esercito e condurlo in una posizione migliore.
Calata la notte, CORNELIO per ingannare il nemico, fece accendere numerosi fuochi, ma intanto levava il
campo, e un reparto dopo l'altro senza far rumore lo mise in marcia verso la nuova postazione.
Si accorse però della mossa del dittatore un reparto della cavalleria nemica, che subito si mise sulle tracce
dell'esercito in ritirata; ma non lo molestò per tutta la durata della notte, ma alla prime luci dell'alba, cominciò
a dare noia alla retroguardia, cercando di ritardare la marcia dei Romani e così dare tempo alla fanteria
sannitica di intervenire. Giunta questa e facendosi più minacciosi i nemici e più difficile la ritirata CORNELIO
a quel punto decise di fermarsi, per potersi meglio organizzare a fronteggiare i Sanniti, e fornì le istruzioni di
come schierarsi nell'imminente battaglia.
Il combattimento non tardò ad essere ingaggiato. Imbaldanziti per la ritirata delle schiere romane che i
Sanniti credevano una fuga, si battevano furiosamente sperando di sconfiggere questa volta le odiate milizie
di Roma. Queste, dal canto loro, non combattevano con minore accanimento, desiderose com'erano di
salvar la vita e l'onore delle armi.
Gli opposti eserciti essendo di pari forza e animati dallo stesso desiderio di far soccombere l'avversario, la
battaglia durò quasi fino a sera; e forse la giornata sarebbe finita senza un vincitore, se l'impazienza delle
turbe sannitiche non riuscirono a resistere nell'attaccare - prima che piombasse la notte- i carriaggi romani
che si trovavano poco distanti dal campo e senza guardia. Avevano il timore che durante la notte i Romani
togliessero il campo con una ritirata -come nella precedente- senza poterlo depredare. Ci si avventò la
cavalleria; ma anche la fanteria temendo anch'essa di restare senza bottino era sul punto di sfasciarsi.
Il dittatore lasciò fare e quando fu ben sicuro che i cavalieri nemici erano intenti al saccheggio, mandò
proprio là la propria cavalleria guidata da MARCO FABIO, la quale in un lampo piombò addosso ai predatori
appiedati trasformando il campo dei cariaggi in un macello.
MARCO FABIO non si accontentò di distruggere la cavalleria avversaria. Fatta la strage, con mossa
repentina compiendo un lungo giro, con tutte le forze a disposizione e con lo stesso impeto attaccò l'esercito
nemico alle spalle informando subito il dittatore quali erano le sue intenzioni.
La battaglia, che poco prima languiva, riarse furiosa; la fanteria romana, rianimata dalle grida dei cavalieri
che spingevano alle spalle i Sanniti verso di loro, assalì con furore le prime schiere nemiche, poi cadendo
queste, quelle successive, le quali, prese di fronte e alle spalle, non potendo andare né contro la morte, né
da questa farsi inseguire, sparpagliandosi ognuno cercò di sgusciare ai lati cercando poi la salvezza nella
fuga.
Ma non molti furono quelli che scamparono: la maggior parte ormai intrappolata cadde sul campo; inutile fu
l'eroica resistenza; se alcuni scampavano da quelli che avevano davanti, la cavalleria che sopraggiungeva
da dietro li faceva a pezzi.
Scendeva la sera quando la battaglia cessò. Fu così grande il numero dei morti, dei feriti e dei prigionieri
Sanniti che tutto il Sannio insorse contro i capi, che avevano innanzitutto rotto la tregua, che erano i
responsabili della guerra perché incapaci di farla, e quindi gli "irresponsabili" di quella disfatta e di
quell'ecatombe di soldati portati al macello.
Non potendo sopportare il peso di questa vergogna e le accuse della pubblica opinione, il capo sannita
BRUTOLO PAPIO si uccise e il suo corpo dagli stessi cittadini Sanniti fu consegnato ai Romani. Un gesto
che voleva dire: costui è il responsabile, noi desideriamo la concordia e la pace.
Ma la pace come l'anno precedente fu superbamente rifiutata da Roma.
I ROMANI ALLE FORCHE CAUDINE
Se i Romani si fossero mostrati, anche l'anno prima, meno esigenti e non avessero pretesa dai Sanniti una
resa senza condizioni che equivaleva alla completa perdita dell'indipendenza, forse avrebbero avuto con il
Sannio già da allora una pace duratura. Ma non pensavano i Romani ad una pace, né allora né ora dopo
questa seconda disfatta; sapevano anzi che una lunga pace avrebbe giovato più al Sannio che a Roma; non
volevano vivere in buoni rapporti con i loro vicini, ma solo soggiogarli.
Di questo n'erano coscienti anche i Sanniti. Amareggiati più che dalla disfatta patita, dai propositi di Roma, i
Sanniti ritrovarono l'innata fierezza e stabilirono di difendere fino all'ultimo l'indipendenza della loro nazione;
gli stessi che avevano consegnato ai Romani il corpo di Brutolo Papio ed avevano insistito per la pace
furono i primi a bruciare di sdegno per la pace superbamente rifiutata dal nemico e a sollevare il paese
incitandolo ad una nuova guerra.
Fu proclamato capo supremo delle forze sannitiche GIOVIO PONZIO TELESINO, famoso guerriero ed
accorto capitano, figlio di Erennio venerato da tutti per il suo valore ma anche per la sua prudenza.
Di PONZIO si narra che, vedendo tornare gli ambasciatori senza avere ottenuto la pace, esclamasse: "La
guerra, o Sanniti, è giusta per coloro ai quali è necessaria; le armi sono pie e religiose solo a coloro cui non
rimane speranza di salvezza altrove che nelle armi".
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
69
E le armi furono prese e tutta la gioventù sannita accorse sotto le bandiere.
Roma ovviamente non perse tempo e, armato un poderoso esercito, lo inviò sotto il comando dei consoli
TITO VETURIO CALVINO e SPURIO ALBINO POSTUMIO a Calazia in Campania per sorvegliare le mosse
degli avversari.
Qui ai consoli giunse la notizia che Luceria, nell'Apulia, amica ed alleata, era assediata dai Sanniti e correva
pericolo di cadere nelle loro mani.
La notizia era stata divulgata ad arte da GIOVIO PONZIO, il quale sperava di attirare con questo
stratagemma i Romani nella trappola che lui aveva concepito.
E vi riuscì pienamente. I consoli furono dell'avviso che Luceria non la si doveva abbandonare al nemico ma
bisognava immediatamente soccorrerla.
Quindi, levati in fretta gli alloggiamenti, si misero in marcia verso la fortezza assediata. Due strade portavano
a questa città, una sicura ma piuttosto lunga, l'altra molto più breve ma attraverso il Sannio. Quest'ultima
però, prima di sboccare a Caudio, passava, presso i villaggi di Arpaia e Montesarchio, per una valle
acquitrinosa, stretta e dominata da rocce scoscese, aperta solo alle due estremità da due gole strettissime.
I consoli scelsero questa strada, allo scopo di giungere a tempo utile a Luceria, e imprudentemente
condussero dentro l'insidiosa valle l'intero esercito; all'entrata superata la prima gola, percorsero interamente
la valle, ma quando giunsero all'uscita e videro la stretta gola ostruita da enormi tronchi d'alberi e da grossi
macigni si accorsero troppo tardi di essere caduti in una trappola infernale.
I monti circostanti brulicavano di nemici. Si ripeteva la critica situazione in cui anni prima, combattendo
contro gli stessi nemici, si erano trovate le truppe romane a Saticola. Ma questa volta non c'era un Decio
Mure che salvasse i soldati dal tranello in cui erano cascati.
Per ordine dei consoli l'esercito rifece il cammino della valle in senso inverso, sperando di poter uscire
dall'altra gola per la quale era entrato; ma questa era fortemente custodita dal nemico, che sbarrava il passo
più minaccioso dei tronchi e dei massi perché questo aveva le armi in mano.
Non c'era altra via di scampo che quella di aprirsi un varco a viva forza attraverso le schiere sannitiche. E
questo fu fatto con una decisa volontà di riuscirci.
Le legioni romane si lanciarono disperatamente addosso al nemico che sbarrava la gola, ma la strettezza del
passo rendeva impossibile ogni manovra e la posizione dei nemici che dominavano tutte le posizioni migliori
rendeva vano ogni sforzo.
Abbandonata l'idea di aprirsi la via con le armi, le legioni cominciarono a fortificare la valle in cui si trovavano
scavando fossati e costruendo steccati: questi lavori erano del tutto inutili, perché il nemico non aveva
nessuna intenzione di assalirli, volevano costringerli all'umiliante resa senza colpo ferire. Da quella poi
cosiddetta "forca", non c'era per i romani scampo, i nemici anche senza agire, sarebbero periti tutti per fame.
Tuttavia i Sanniti, stupiti di avere ottenuto a così buon mercato quel clamoroso successo, non sapevano
quale decisione prendere. Lo stesso GIOVIO PONZIO, che aveva concepito quella trappola infernale,
indeciso sul partito da seguire, mandò a chiedere consiglio a suo padre ERENNIO; il vecchio giunse al
campo e consigliò al figlio che per la sorte dei Romani c'erano solo due soluzioni: o ucciderli tutti o lasciarli
tutti liberi.
Nel primo caso la pace sarebbe stata assicurata per parecchi anni pur con l'odio degli umiliati Romani; nel
secondo per gratitudine si sarebbe ottenuta una perpetua amicizia con un popolo potentissimo.
A PONZIO non piacquero i consigli del padre e quando giunsero a lui i trafelati ambasciatori romani a
proporgli una pace ragionevole o, se questa non era accettata, battaglia in campo aperto, lui rispose che
considerava la guerra finita e dettò le seguenti singolari condizioni di pace: consegna delle armi e dei
bagagli; il passaggio di ogni uomo delle legioni sotto il giogo predisposto, indossando ciascun soldato
un'umile veste simile a quella degli schiavi; sgombero da parte dei Romani dei territori sanniti occupati e di
tutte le colonie.
Gli ambasciatori tornarono alla base e quando riferirono le condizioni di pace, una grande commozione e
indignazione invase gli animi; si videro le guance di molti legionari solcate da lagrime e dalle bocche dalle
quali erano tante volto uscite grida di trionfo uscirono singhiozzi e lamenti.
Moltissimi urlarono che fossero rifiutati i patti, che si corresse alle armi e si cercasse ancora di salvar la vita e
l'onore combattendo, che era meglio morire tutti piuttosto di accettare condizioni che disonoravano il nome di
Roma in perpetuo.
Ma LUCIO LENTULO, capo dell'ambasceria, disse: "Ma che utile recheremo alla patria nostra con il nostro
sacrificio? In noi c'è tutta la speranza, la riverenza e la potenza nostra. Se noi salviamo tutto questo
salviamo e conserviamo la patria; se perdiamo questo esercito e lo lasciamo fare a pezzi noi tradiamo e
roviniamo la patria nostra. Cosa sozza e vile è il darsi al nemico, ma la carità verso la patria deve essere tale
da indurre a salvarla, quando sia necessario tanto con la morte quanto con la vergogna. Si sopporti dunque
quest'onta, pur essendo così grande, e si ubbidisca alla necessità, che neanche gli dèi possono superare.
Andate, o consoli, e ricomperate con il ferro quella città che i nostri padri dai Galli ricomperarono con l'oro".
I consoli andarono e firmarono la vergognosa pace (il cosiddetto "trattato caudino") e si obbligarono di
osservarla oltre i consoli, i prefetti, i legati, i questori ed i tribuni dei soldati.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
70
Giunto il momento di eseguire i patti della resa, furono consegnati in ostaggio seicento cavalieri, i quali, sotto
buona scorta furono poi condotti dai Sanniti a Luceria; i soldati senza le armi uscirono dagli alloggiamenti;
furono tolti i fasci littori, i gradi e gli ormanenti ai consoli, indi, in testa i comandanti supremi dell'esercito
seguiti dagli ufficiali e dietro i soldati; tutti mezzo nudi e con gli occhi bassi per la vergogna, furono fatti
passare due a due sotto il giogo, al cospetto dei nemici che li schernivano e li insultavano minacciandoli. I
pochi che osarono alzare lo sguardo verso i Sanniti furono da questi feriti, alcuni mortalmente.
Quando la vergognosa cerimonia ebbe termine, i vinti furono lasciati liberi e presero la via del ritorno. A
Capua furono accolti amichevolmente con tanta pietà e furono accompagnati fino alle frontiere da molti
giovani nobili della città.
IL SENATO RIFIUTA DI RATIFICARE LA PACE CAUDINA
A Roma quando giunse la notizia, della pace ottenuta a quelle condizioni e con quella messa in scena
umiliante, l'indignazione fu impressionante; la città piombò nel lutto. Ritornati da Capua, i consoli si dimisero
dalla carica e prima fu creato dittatore QUINTO FABIO AMBUSTO, poi MARCO EMILIO PAPO, ma entrambi
non riuscirono ad assicurare un regolare svolgimento dei comizi; seguirono due interregni, il secondo, di
VALERIO CORVO procedette poi alla nomina d'ufficio e la creazione dei nuovi consoli per l'anno successivo,
il 320 a.C.
Riuscirono eletti QUINTO PUBLILIO FILONE e LUCIO PAPIRIO CURSORE. Questi, il giorno stesso in cui
entrarono in carica, riunirono il Senato e sottoposero all'approvazione il "trattato caudino".
Prima che il Senato si pronunciasse si levò a parlare SPURIO POSTUMIO, il vinto console reduce della
disfatta, il quale, accusandosi colpevole di quella pace, affermò che non doveva essere ratificata perché
stipulata senza il consenso del popolo romano e propose anzi che fosse mandato insieme con il suo collega
a Caudio per essere consegnato ai Sanniti.
Accettò il Senato la proposta di Postumio e ne ammirò lo spirito di sacrificio. Roma respirò liberamente
vedendo la possibilità di lavar l'onta inflitta al suo esercito e, dimenticando l'ignominia di cui si era ricoperto
Postumio, accettando le condizioni della resa, ora rivolse allo stesso la sua infinita ammirazione per ciò che
aveva detto e proposto.
Fu tanto l'entusiasmo dei cittadini che un grandissimo numero corse volontariamente ad arruolarsi e fu
presto formato un poderoso esercito questa volta solo di accompagnatori, che subito si mise in marcia verso
Caudio.
Giunti alle porte della città nemica, - secondo quanto narra LIVIO, i due consoli furono spogliati e legati e
siccome il littore, per rispetto, non aveva stretto con forza le funi intorno a Postumio, è fama che questi gli
dicesse: "Perché non stringi fortemente i legami affinché la consegna sia piena e giusta?".
Condotti i due consoli al cospetto di GIOVIO PONZIO TELESINO, questi non volle accettarli, dicendo che
non loro due ma la repubblica romana, in nome della quale i Sanniti avevano stipulato i patti, doveva
mantenere fede a questi, e aggiungendo che se Roma non voleva ratificare la pace allora dovevano essere
riconsegnati non i soli i due consoli ma tutto l'esercito, chiuso nella valle di Caudio che lui aveva fatto tornare
libero a Roma.
E liberi lasciò andare i due consoli rimandandoli indietro; erano i primi mesi dell'anno 434 di Roma (320 a.C.)
LA LIBERAZIONE DI LUCERIA
Pochi mesi dopo il rifiuto del Senato di ratificare la "Pace Caudina", ricominciò la guerra.
Nel frattempo Satrico si era arresa ai Sanniti e anche Luceria e Ferentino erano cadute in potere del nemico.
La colonia di Fregelle, assalita di notte, si difese accanitamente, ma alla fine pure questa si arrese ai Sanniti
che massacrarono buona parte gli abitanti della colonia.
Ovviamente pure Roma riprese la guerra e i due consoli romani decisero di cominciare le operazioni
liberando Luceria in cui si trovavano chiusi i seicento cavalieri presi dai Sanniti come ostaggi alla stipula
della pace.
Con le numerose legioni arruolate furono formati due eserciti; uno, sotto il comando di PAPIRIO CURSORE,
attraverso la regione sabina e lungo la costa adriatica, marciò verso Luceria; l'altro, comandato dal collega
QUINTO PUBLILIO, puntò verso la medesima mèta per la via del Sannio.
Questo secondo esercito, incontrato il nemico, lo attaccò selvaggiamente con tutto l'odio che i soldati e gli
ufficiali avevano in corpo, lo sbaragliò e lo mise in fuga, poi, occupati i loro alloggiamenti dopo averli distrutti
con altrettanta rabbia, continuò la marcia verso Luceria, dove si congiunse con l'esercito comandato dal suo
collega Papirio Cursore e misero sotto assedio la città da un lato.
Nei primi giorni questo assedio di Luceria non diede che scarsi risultati, poiché dal Sannio e dall'Apulia la
città era rifornita. Perciò fu stabilito di togliere le comunicazioni che univano Luceria con i paesi da cui
provenivano i rifornimenti. A tale scopo Papirio rimase attorno alla città mentre Publilio Filone con le sue
truppe si portò nel territorio circostante allo scopo d'impedire che agli assediati giungessero viveri.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
71
L'effetto non tardò a farsi sentire. Altri Sanniti che si erano raccolti poco lontano intorno a Luceria, vedendo
che non potevano più portare soccorso agli assediati, decisero di rompere l'assedio con la viva forza.
Ma la vittoria non arrise i Sanniti. Avidi di vendetta i Romani assaltarono con impeto irresistibile i Sanniti
nell'aperta campagna e li sbaragliarono; essendosi questi rifugiati nel campo trincerato, anche qui li
assalirono e, penetrati dentro le difese, uccidevano chiunque incontrassero, armato o disarmato, e nessuno
dei nemici sarebbe rimasto vivo se Papirio non avesse fatto suonare a raccolta e fatta cessare la strage
temendo per la vita degli ostaggi che erano rinchiusi nella stessa Luceria.
Dopo questa vittoria, il console Publilio cominciò a scorrere 1'Apulia, sottomettendo con la forza non poche
città, e alcune ingraziandosele amicandosele. Papirio rimase invece ad assediare Luceria, la quale,
sconfortata dalla disfatta recente dei Sanniti e priva di mezzi di sussistenza, non tardò a capitolare. Con i
vinti i Romani usarono la legge del taglione, GIOVIO PONZIO con i suoi settemila soldati fatti prigionieri li
fecero passare sotto il giogo.
L'onta delle Forche Caudine era lavata. Immenso fu il bottino fatto nella città conquistata, dove dopo aver
liberati i seicento cavalieri fu messa come guarnigione mezza legione di soldati romani.
DISTRUZIONE DI SATRICO E TREGUA COL SANNIO
L'anno seguente (435 A.di R - 319 a.C.) PAPIRIO CURSORE fu rieletto console ed ebbe come collega
QUINTO AULIO. Questi si mosse con un esercito contro i Ferentani, li ruppe in battaglia e costrinse la città
ad arrendersi consegnando ostaggi.
Mentre Papirio con un altro esercito marciò su Satrico, la quale, benché godesse della cittadinanza romana,
dopo la disfatta di Caudio si era ribellata a Roma ed aveva accolto dentro le sue mura una guarnigione
sannitica.
All'avvicinarsi dell'esercito romano, Satrico inviò al console un'ambasceria chiedendo la pace, ma Papirio
rispose che l'avrebbe concessa solo se uccidevano o consegnavano nelle sue mani il presidio dei Sanniti.
Avendo gli ambasciatori obbiettato che non era possibile ai cittadini catturare o uccidere una forte e
numerosa guarnigione, è fama che il console rispose: "Andate a chiedere come lo si può fare a coloro che
hanno consigliato di ricevere nella città quel presidio".
Atterrito più da questa risposta che dalla presenza delle legioni romane il Senato di Satrico si riunì per
deliberare; dovendo durante la notte il presidio dei Sanniti eseguire una scorreria fuori Satrico, propose a
quei Senatori che avevano caldeggiato la ribellione, di avvisare i Romani per riscattarsi.
Nella notte le schiere sannitiche uscite dalla città caddero in un agguato loro teso dai Romani e furono fatte
a pezzi; nello stesso momento il grosso dell'esercito, penetrando dentro Satrico, se ne impadroniva.
Vogliono alcuni che Papirio Cursore, condannati alla fustigazione e alla decapitazione i cittadini colpevoli di
ribellione e sottratte le armi a tutti gli abitanti mise poi a Satrico una fortissima guardia; mentre altri narrano
che la città fu rasa al suolo e gli abitanti deportati.
Le vittorie dai Romani riportate e le severe punizioni inflitte produssero grande impressione presso i popoli
vicini, specie negli Apuli che chiesero ed ottennero pace riconoscendo la signoria di Roma su quasi tutta la
regione. Le città invece che tentarono di resistere furono costrette alla resa a viva forza e fra queste Nerulo
in Lucania e Ferento.
Quanto al Sannio, la stanchezza, le vittorie romane e le sottomissioni di tante città, lo consigliarono a
domandare ancora una volta la pace. Non ottenne però -come le due volte precedenti- che una tregua di
due anni (436 - 318 a.C.)), dalla quale erano esclusi i suoi alleati, che Roma uno per volta si proponeva di
combattere e sottomettere allo scopo d'isolare i Sanniti e poterli poi facilmente soggiogare.
RIPRESA DELLA GUERRA SANNITICA
I Sanniti, non domi da tante sconfitte e da tante umiliazioni, anche se le avevano date, seguitano a sognare
la riscossa. I due anni di tregua sono da utilmente impiegati per preparare una nuova guerra e a spingere
con delle trame la Campania alla rivolta.
Le discordie tra l'aristocrazia e la democrazia campana offrono ai Sanniti l'occasione per fare il loro buon
giuoco.
Terminati i due anni di tregua, scoppia, nel 439, la rivolta a Saticula; creato dittatore LUCIO EMILIO, questi
marcia con l'esercito sulla città ribelle e pone il campo nelle sue vicinanze. Le operazioni d'assedio sono
appena cominciate quando un forte esercito di Sanniti avanza; le legioni romane si trovano tra due nemici e
ben presto Lucio si accorge che Saticula e il Sannio hanno preparato da lungo tempo il piano d'azione.
Infatti, al giungere dell'esercito sannitico, gli assediati fanno una vigorosa sortita e contemporaneamente le
truppe del Sannio attaccano.
L'esercito dittatoriale si trova in una posizione difficile, ma Lucio Emilio non è uomo da lasciarsi facilmente
sopraffare. Presa posizione fulmineamente in una favorevole località fa fronte a tutte e due gli avversari, ma
rivolge lo sforzo maggioro contro quelli della città e con vigorosi contrattacchi li costringe a ritornare con non
poche perdite dentro le mura; sferrato l'attacco con tutti i soldati a disposizione contro i Sanniti, li attacca
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
72
violentemente, li preme, li incalza e, infine, ciò che ottiene è quello di permettere ai nemici di rientrare nel
loro accampamento.
L'azione combinata è dunque fallita, ma migliore sorte non hanno i Sanniti. Sopraggiunta la notte e spenti i
fuochi, i Sanniti, disperando di poter difendere Saticula ed infliggere uno scacco ai Romani, si allontanano
alla chetichella e vanno a cinger d'assedio Plistia, città amica di Roma.
La guerra riprese maggior vigore sotto la direzione del nuovo dittatore QUINTO FABIO, che, condotto a
Saticula nuove forze, intensificò le operazioni d'assedio. Anche
i sanniti nel frattempo avevano ricevuto rinforzi e da Plistia erano tornati verso Saticula. Presso il campo
romano si combatté una ferocissima battaglia tra la cavalleria nemica e quella di Roma comandata da
QUINTO EMILIO.
I Sanniti furono dopo una gran mischia respinti, ma rimasero sul campo il capo dei cavalieri nemici ucciso da
Quinto Emilio e lui stesso ammazzato dal fratello di quello.
Dopo questo sanguinoso fatto d'arme i Sanniti ritornarono a Plistia, l'assalirono e la , l'espugnarono pure.
Poco tempo dopo Saticula si arrendeva ai Romani.
INSURREZIONE DI SORA E BATTAGLIA DI LAUTULE
Il tenace ed occulto lavorio dei Sanniti durante gli anni di tregua cominciava a dare i suoi frutti e la guerra si
spostava da sud a nord.
Ecco giungere al dittatore la notizia che Sora, sull'alto Liri, uccisi gli abitanti romani, si è ribellata dandosi ai
Sanniti. QUINTO FABIO non indugia nemmeno un attimo e da Saticula marcia su Sora. Lungo la via è
informato che un esercito sannitico si trova a Lautule e verso questa località si dirige il dittatore per
affrontarlo.
Ma pare che la sorte della battaglia non fu benigna ai Romani. LIVIO invece racconta che la notte divise i
combattenti e che, essendo rimasto ucciso il maestro della cavalleria, ne fu inviato un altro da Roma e
precisamente CAJO FABIO, che si portò dietro un altro grosso contingente di soldati. Il dittatore, che stava
chiuso nel campo, quando seppe dell'arrivo dei soccorsi, uscì dagli alloggiamenti ed assalì il nemico, il quale
combattuto dal vecchio e dal nuovo esercito romano, dopo una forte resistenza fu sbaragliato e gran parte di
fu fatto a pezzi.
Così TITO LIVIO narra la battaglia di Lautule. "È da credersi - per testimonianza di altri storici e per gli
avvenimenti che seguirono - che i Romani subissero uno scacco. Difatti il dittatore fu sostituito dai nuovi
consoli MARCO PETILIO e CAJO SULPICIO che a verso sera condusse sul posto altre truppe.
La città fu presa con 1'inganno e grazie al tradimento di uno dei suoi abitanti, il quale, fatto allontanare di
alcune miglia l'esercito consolare per far credere ai suoi concittadini che l'assedio fosse stato levato e messi
alcuni drappelli presso una porta in agguato, durante la notte introdusse dieci soldati romani nella rocca, poi
diede l'allarme. I cittadini, svegliati improvvisamente e saputo che la rocca era caduta in potere del nemico,
si diede inerme e precipitosamente alla fuga, mentre i drappelli appostati penetravano in città compiendo
una grande strage. All'alba il grosso dell'esercito Romano avanzava contro Sora e l'occupava
definitivamente, stabilendovi un forte presidio (440 A. di R. - 314 a.C.).
Duecentoventicinque uomini che risultarono autori della insurrezione furono arrestati e condotti a Roma, e
nel Foro, dopo di essere stati fustigati, furono decapitati".
INSURREZIONE DI AUSONIA, MINTURNA, VESTINA, LUCERIA E CAPUA
Che a Lautule la sorte non fosse favorevole ai Romani lo dimostra 1'insurrezione di varie città nei dintorni.
Ausonia, Minturna e Vestina ribellatesi, avevano fornito aiuto ai Sanniti; Luceria, essendo stata tradita la
guarnigione romana, si era data ai Sanniti e a Capua parecchi notabili avevano pure loro ordito delle
(traditrici) congiure.
Levati gli eserciti da Sora, i consoli marciarono sopra Ausonia, Minturna e Vestina. Alcuni soldati camuffati
con delle toghe, ma che nascondevano sotto quelle delle armi, riuscirono a penetrare nelle suddette città e,
massacrate le guardie delle porte, aprirono il passo ai Romani, che, nello stesso giorno, si resero padroni di
tre città facendovi strage degli abitanti.
Nel 441 anche Luceria fu espugnata e passati per le armi tutti i Sanniti che vi si trovavano e un gran numero
di abitanti. A Capua invece fu mandato, allo scopo di esaminare la situazione e scoprire le file della congiura,
il dittatore CAJO MENIO.
La guerra contro il Sannio però non era ancora terminata; tuttavia il piano dei Sanniti di trasportarla fuori
della loro regione era fallito con la presa di Sora e, con la rivolta della Campania domata, le operazioni di
guerra si erano ridotte nello stesso Sannio.
Pur non abbandonando la guerra, Roma trae profitto dal sopravvento che è riuscita ad ottenere sul nemico e
prepara altre basi di operazioni per mezzo di colonie. Nel 440 ne manda una di 2.500 uomini a Luceria; due
anni dopo una di 4.000 ad Interamnae (Terni); altre colonie stabilisce a Suessa Aurunca, all' isola di Ponza e
a Saticola.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
73
Sono le sue sentinelle avanzate nel cuore dei territori conquistati, sono il suggello delle sue conquiste e della
sua potenza, sono nuclei di romanità in mezzo a popoli ancora d' incerta fede, sono infine fortezze che
tuteleranno i nuovi domini e punti di appoggio alle legioni per le future immancabili conquiste.
Nel prossimo capitolo, le ultime azioni guerresche sul Sannio ed infine la pace:
Ma nel frattempo la guerra dei Romani si sposta a nord, verso i pochi Etruschi rimasti.
Andiamo dunque nel periodo dall'anno 313 al 299 a.C. > > >
Fonti, Bibliografia, Testi, Citazioni:
TITO LIVIO - STORIE (ab Urbe condita)
APPIANO - BELL. CIV. STORIA ROMANA
DIONE CASSIO - STORIA ROMANA
PAOLO GIUDICI - STORIA D'ITALIA
UTET - CRONOLOGIA UNIVERSALE
I. CAZZANIGA , ST. LETT. LATINA,
+ altri, in Biblioteca dell'Autore
GUERRA ROMANO-ETRUSCA - UMBRA, DEL SANNIO - LE BATTAGLIE 313-299 a. C.
I SANNITI PRENDONO FREGELLE - I ROMANI RIENTRANO IN FREGELLE E CONQUISTANO ATINA E
CALAZIA - RESA DEI ROMANI A CLUVIANO - BATTAGLIA DI SUTRI - QUINTO FABIO IN ETRURIA - LA
SELVA CIMINIA - PERUGIA, CORTONA ED AREZZO SI DISTACCANO DALLA LEGA ETRUSCA - LA
GUERRA NEL SANNIO: PRESA DI ALIFE - SCONFITTA DI CAJO MARCIO - PAPIRIO CURSORE
DITTATORE - BATTAGLIA DI LONGULA - BATTAGLIA DEL LAGO VADIMONE - SCONFITTA DEI
PERUGINI - PUBLIO DECIO IN ETRURIA - GUERRA CON GLI UMBRI: BATTAGLIA DI MEVANIA QUINTO FABIO, CORNELIO ARVINA E MARCIO TREMOLO NEL SANNIO - BATTAGLIA DI TIFERNO PACE CON IL SANNIO - NUOVE COLONIE ROMANE - ALTRE GUERRE CONTRO GLI EQUI, GLI
ETRUSCHI E GLI UMBRI
----------------------------------------------------------------------------------------------------Prima che il loro consolato finisse, CAJO SULPICIO e MARCO PETILIO riportarono sui Sanniti una grande
vittoria.
Dall'Apulia il nemico, alle notizie delle congiure di Capua, si era concentrato a Caudio poi, sceso verso la
pianura campana, aveva incontrato l'esercito consolare, con il quale, dopo alcuni giorni impiegati in logoranti
scaramucce, era entrato in battaglia.
Il combattimento oltre che aspro fu anche lungo, e alla fine lo scontro terminò con la disfatta dei Sanniti.
Secondo LIVIO, tra morti e prigionieri, perdettero circa trentamila uomini. I Sanniti non avevano più un
esercito.
Questa vittoria apriva ai Romani la via del Sannio e la guerra si trasferiva nel cuore della regione nemica,
intorno a Boviano, capitale dei Sanniti Pentri, i quali cercarono di allontanare l'esercito consolare dal loro
territorio assaltando ed espugnando Fregelle.
La riconquistò poco tempo dopo, senza colpo ferire per la fuga dei Sanniti, il dittatore CAJO PETILIO, che,
lasciatovi un buon contingente di milizie si trasferì in Campania dove riprese Nola al nemico. Più tardi anche
Atina e Calazia caddero in potere dei Romani.
Mentre la guerra sannitica, dopo questi avvenimenti, languiva e i Romani mandavano colonie nel sud e
costruivano strade per rendere più facili le comunicazioni con la Campania (nel 442 (312 a.C.) il console
Appio Claudio fece lastricare la famosa via che porta il suo nome), notizie minacciose giungevano dal nord.
Era terminata la tregua di quarant'anni concessa nel 403 (351 a.C.) agli Etruschi. Questo popolo ora, forse
credendo indebolita Roma dalle guerre, forse credendo, che era giunto il momento di riprendere ai Romani i
territori perduti, sperando di ribellare con il suo intervento la Campania e di indebolire con il concorso delle
sue armi la potenza di Roma, torna nuovamente a brandirle. Solo gli Aretini rimangono spettatori.
Erano consoli CAJO GIUNIO BUBULCO e QUINTO EMILIO BARBULA. Il primo con un esercito passò nel
Sannio, dove i Romani, assediati a Cluviano, si erano arresi per fame, e, appena giunto, assalì la città, la
costrinse alla resa, e passò per le armi tutti gli uomini dai quattordici anni in su, poi, attirato in un agguato
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
74
riuscì abilmente a disimpegnarsi e infliggere al nemico numerose perdite che LIVIO fa giungere alla cifra di
ventimila uomini.
Quinto Emilio Barbula fu invece inviato contro gli Etruschi, i quali con un potente esercito si erano presentati
davanti a Sutri.
Qui si combatté una grande battaglia con la quale fu inaugurata la guerra romano-etrusca. Superanti di
numero erano gli Etruschi, ma più agguerriti e superiori nell'arte militare i Romani. Fu la consumata perizia di
questi ultimi che trionfò sul numero.
Gli Etruschi lanciarono nella mischia fin dall'inizio tutte le loro forze, i Romani invece lasciarono da parte per
il momento decisivo alcune schiere e con altre sostennero l'urto nemico.
La battaglia, cominciata dopo il mezzodì, si protrasse con esito incerto e sanguinosa fino al tardo
pomeriggio; i combattenti erano affaticati e stanchi quando il console ordinò alla riserva di entrare in azione.
Queste truppe fresche decisero le sorti della giornata e pochissimi nemici sarebbero scampati alla strage se
la sera non fosse sopravvenuta ad interrompere la battaglia.
Questo fu l'unico combattimento dell'anno. Entrambi i due eserciti rimasero nei loro campi ad attendere
rinforzi che compensassero le perdite rilevanti che avevano subite. Altre truppe calarono dall' Etruria e
giunse a Sutri da Roma con un altro esercito il nuovo console QUINTO FABIO.
Mentre questi marciava lungo le falde dei monti in soccorso della città, gli si fece incontro un numeroso
esercito nemico. Il console, non credendo prudente affrontarlo al piano, si rifugiò sulla costa, nelle alture.
Fidando nella loro superiorità numerica gli Etruschi, gettati per terra giavellotti e frecce e snudate le spade, si
slanciarono verso il nemico con grande impeto.
Ma questo assalto non fu di lunga durata. I Romani, dall'alto, cominciarono a tempestare gli assalitori con un
abbondante e ininterrotto lancio di dardi e di sassi che fermò prima la fuga dei nemici, poi scompigliò le
prime linee. A quel punto Fabio ordinò ai suoi di contrattaccare e i Romani scesero impetuosamente dalle
alture addosso agli Etruschi, i quali, non riuscirono a sostenere l'urto e, voltate le spalle si diedero alla fuga
verso gli alloggiamenti, che non riuscirono a raggiungerli; la cavalleria romana, lanciata all'inseguimento,
tagliò a loro la via della ritirata e gli Etruschi sbandati, alcuni cercarono scampo su per i monti e la maggior
parte dentro la foresta "selva Ciminia"
Molte migliaia di nemici rimasero uccise sul campo, trentotto bandiere, gli alloggiamenti ed un enorme
bottino caddero in potere dei Romani.
Desideroso di sfruttare la vittoria, QUINTO FABIO decise d'inseguire il nemico e fu una grande impresa la
sua, perché la selva Ciminia era fitta, impenetrabile, paurosa, e temuta per le terribili leggendo che
correvano sul suo conto; ma anche perché poteva prestarsi ad una sorpresa ancora più drammatica di
quella che la valle di Caudio aveva riservato alle legioni romane.
Tuttavia l'impresa fu tentata. Secondo alcuni i Romani superarono l'immensa foresta e portarono oltre i monti
boscosi la guerra e il saccheggio; secondo altri, fecero delle ardite e lontane scorrerie nei territori circostanti.
La verità è che l'effetto fu opposto a quello che il console si era ripromesso di ottenere. Anziché fiaccare il
nemico i Romani allargarono il campo della guerra e si tirarono addosso altri popoli, fra i quali i montanari
dell' Umbria, di modo che, qualche tempo dopo, al campo sotto Sutri nel quale, carico di preda, si era ritirato
l'esercito di Fabio, giunse un'impressionante moltitudine di nemici.
Il console non si sbigottì più di tanto, ed ordinò ai suoi di non uscire dai trinceramenti, ma durante la notte e
prima dell'alba, ordinate le schiere, impartì precisi ordini, ad ogni squadra il suo compito, poi s'avvicinò
furtivamente all'accampamento dei nemici; questi erano svegli ma ancora in quel gran disordine che precede
l'inquadramento dell'esercito; in quell'istante QUINTO FABIO impartì l'ordine d'attacco; con una serie
d'operazioni delle legioni, circondarono il campo e con poca fatica costrinsero alla resa gli sbigottiti nemici.
Nei settori che vollero resistere, non ci fu scampo, ci fu una strage d'Etruschi e d'Umbri. Poi si razziò il
ricchissimo il bottino che completò la disfatta; ma molto più grandi furono le conseguenze di questa vittoria.
Infatti, Perugia, Cortona ed Arezzo, tutti grossi centri, si distaccarono dalla lega etrusca e, chiesta a Roma la
pace, la ottennero con l'impegno di una tregua di trent'anni.
LA GUERRA NEL SANNIO
Mentre successi così clamorosi riportavano nell'Etruria le armi romane, l'altro console CAJO MARCIO, nel
Sannio costringeva alla resa Alife e subito dopo con la forza conquistava molti altri paesi.
Ma ecco giungere la notizia che l'esercito di FABIO, dopo la sua brillante conclusione al campo EtruscoUmbro, inoltratosi nella selva Ciminia era stato circondato dagli Etruschi e dagli Umbri e si trovava in una
situazione critica
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
75
La notizia era del tutto falsa, anzi la verità era completamente opposta; ma i Sanniti prestando fede alle
chiacchiere, forse pensando ad un'altra "forca caudina", infiammati dalla presunta disfatta dei Romani e
rammaricandosi solo che era stato per merito degli Etruschi, decisero di fare un grande sforzo e di
sconfiggere le legioni di MARCIO stimolandolo ad iniziare la battaglia. Ma rifiutandosi il console di iniziarla,
invece di attaccare, stavano decidendo di passare in Etruria attraverso la regione dei Marsi e dei Sabini.
Solo a quel punto CAJO MARCIO decise di accettare il combattimento e l'esercito romano si batté con tale
fervore che si sarebbe meritata sorte migliore di quella che invece gli fu riservata.
Scrive TITO LIVIO che furono uguali le perdite dei Sanniti e dei Romani; ma forse la verità, è che questi
ultimi ebbero la peggio. Molti cavalieri, infatti, e parecchi tribuni militari caddero durante questa battaglia e lo
stesso console fu ferito.
Che la sconfitta ci fosse e di una certa gravità lo dimostra chiaramente il fatto che il Senato, appresa la
notizia, decretò di creare un dittatore.
Non c'era miglior capitano a Roma in quel tempo di LUCIO PAPIRIO CURSORE e su di lui cadde la scelta,
ma dovendo approvare il console Fabio la proposta del Senato ed essendo Fabio nemico di Papirio dal
quale, per disubbidienza, come i lettori ricorderanno, era stato condannato a morte, si temeva che la
proposta non fosse approvata.
QUINTO FABIO invece, facendo tacere la voce del personale rancore e solamente ascoltando quella della
patria, si mostrò degno della sua fama di valoroso guerriero e diede l'approvazione.
Nominato GIUNIO BUBULCO maestro dei cavalieri, Papirio Cursore, alla testa di un nuovo esercito, marciò
alla volta del Sannio e raggiunse CAJO MARCIO a Longula. Qui, unito il suo esercito a quello del console,
insieme affrontarono il nemico e in breve tempo fu sbaragliato
BATTAGLIA DEL LAGO VADIMONE ( 444 A. di R. - 310 a.C.)
Nel frattempo non meno fortunati, anzi più decisivi i successi delle truppe romane in Etruria. Sutri fu liberata
e QUINTO FABIO, superata (senza ostacoli - perché la notizia abbiamo detto era falsa) la selva Ciminia, si
preparava a portare la guerra all'interno della regione nemica.
Gli Etruschi, non scoraggiati dalle passate disfatte, radunano un grandissimo esercito; e contro di questo va
incontro il console romano. La battaglia avvenne sulle rive del lago Vadimone (Bolsena) e fu molto
particolare per l'irruenza di entrambi gli eserciti, che fin dall'inizio combattono corpo a corpo con le spade,
gareggiano nell'impeto e nell'ostinazione e quando cedono le prime schiere, quelle più fresche si buttano
nella mischia con lo stesso accanimento delle precedenti.
I Romani non riconoscono più nei loro avversari quegli stessi Etruschi che tante volte hanno sconfitto.
Sembra a loro di avere di fronte un altro popolo tanto è il valore che dimostrano. .
Il combattimento si prolunga per molto tempo; le riserve sono state lanciate nella mischia e sono impiegate
anche le retroguardie. Tutte le forze di cui l'una e l'altra parte dispongono sono impegnate ed incerta è la
sorte dello scontro in fin di giornata.
I cavalieri romani tentano un ultimo sforzo; smontano da cavallo per trasformarsi in fanti e, passando a
stento tra le armi e i cadaveri, si portano nelle prime linee, con la loro presenza e il loro valore rinfrancano gli
stanchi pedoni e fanno sentire il proprio peso sul nemico che anch'esso stanco e affranto, si batte ancora,
ma con la disperazione.
L'intervento della cavalleria appiedata, decide le sorti della battaglia; qualche bandiera nemica inizia a
cedere, poi l'intera prima fila si assottiglia e cede pure questa, e invece di essere aiutata e sostituita dai
rincalzi, questi hanno girato le spalle e si sono dati alla fuga, abbandonandoli al loro destino.
I cavalieri raddoppiano gli sforzi assecondati dai fanti, poi visto il nemico in fuga, rimontano a cavallo e li
incalzano. Su quello che poco prima era un campo di battaglia frastornante, cade il silenzio di un campo
cimitero.
Questa battaglia per gli Etruschi fu l'ultima grande battaglia.
(anche se la critica storica moderna ha posto in dubbio questa "tradizione")
(parleremo ancora di questa battaglia non nel prossimo capitolo ma nel successivo)
Il combattimento (noi seguiamo la tradizione) del lago Vadimone fu, infatti, l'ultimo grande sforzo militare del
popolo Etrusco. Si opporrà ancora alle armi romane e tenterà di rialzare le sue sorti; ma ogni suo tentativo
riuscirà vano davanti alla potenza sempre più crescente dei Romani. E il suo destino è ormai segnato.
Poco tempo dopo, riuscì agli Etruschi di far rompere a Perugia la tregua (dei trentanni) e con l'aiuto di questa
tentò di muovere alla riscossa. Ma il loro esercito era ormai sfiduciato,
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
76
e quando le legioni di Fabio si mossero per affrontarlo, la resistenza fu molto scarsa; la vittoria delle truppe
romane fu facile; poi, dopo averlo annientato, marciarono su Perugia per castigarla severamente per aver
dato -rompendo la tregua- aiuto ai suoi ex alleati.
Ma il castigo fu evitato all'ultimo momento. Lungo la strada incontro a Fabio andarono gli ambasciatori per
chiedere accoratamente la pace e per trattare la resa della città. Perugia evita così di essere punita e
saccheggiata, ma da quel giorno la sua indipendenza è finita. Fabio si è fermato, ma mentre gli ambasciatori
sono inviati a Roma a discutere le condizioni della resa con il Senato, un forte contingente di soldati romani
penetra, occupa e si stabilisce in città. Non andranno più via! Perugia d'ora in avanti è territorio Romano.
QUINTO FABIO assolto il suo compito, torna in patria a ricevere il suo meritato trionfo.
Nello stesso anno le legioni romane colgono altri allori nel Sannio, dove il residuo esercito
nemico soccombe ancora sotto i colpi del dittatore, del maestro della cavalleria di MARCO VALERIO e
PUBLIO DECIO e lasciano nelle mani dei vincitori le splendide armature dei cavalieri sanniti e i magnifici
scudi ornati d'oro e d'argento che più tardi una parte servirà come addobbo del Foro romano nelle sacre
cerimonie; e un'altra parte saranno armati dai Capuani i Gladiatori.
GUERRE CONTRO GLI UMBRI
Nonostante queste vittorie riportate sugli Etruschi e sui Sanniti, la guerra non era del tutto finita. Rieletto
nell'anno 445 (309 a.C.) console, QUINTO FABIO marcia con il suo esercito nel Sannio, sottomette Allife,
poi scontratosi con un esercito di Sanniti -questa volta rinforzato da aiuti forniti dai Marsi e dai Peligni- lo
attacca e lo sconfigge.
Al suo collega PUBLIO DECIO, sono invece affidate le operazioni in Etruria. Costringe Tarquinia a
vettovagliare il suo esercito e a chiedere una tregua di quarant'anni; penetrato nel territorio di Volsinio,
s'impadronisce a viva forza di alcuni castelli ed altri ne rade al suolo, poi esegue scorrerie, bruciando,
devastando e saccheggiando. Mette tanto spavento negli Etruschi che questi chiedono pace; ma è
solamente accordata una tregua di un anno con l'obbligo di corrispondere ad ogni soldato romano la paga
per l'anno medesimo e due vesti.
Dopo questi avvenimenti vi sarebbe stata pace in Etruria se non avessero brandito le armi i vicini Umbri,
trascinando questa volta loro gran parte degli Etruschi.
Voci preoccupanti correvano sulle intenzioni dei nuovi nemici; si sosteneva che avevano allestito un esercito
possente e che, lasciandosi alle spalle l'esercito consolare volevano marciare su Roma.
Furono queste voci che, da una parte consigliarono PUBLIO DECIO MURE a spostarsi verso il sud per
contrastare il passo verso Roma di eventuali appoggi ai nemici; e dall'altra il Senato informò della situazione
l'altro console invitandolo, se le condizioni del Sannio lo permettevano, a trasferirsi prontamente nell'Umbria.
QUINTO FABIO MASSIMO ubbidì senza indugiare e a marce forzate trasferì il suo esercito nei pressi di
Mevania (446 308 a.C.).
L' improvviso arrivo di Fabio, che gli Umbri radunati proprio a Mevania credevano invece impegnato nel
Sannio, atterrì il nemico e ne raffreddò l'audacia; che era quella di marciare su Roma. A marciare erano stati
invece i Romani, e ora li avevano in casa, quindi bisognava difendersi, altro che attaccare!
Alcuni volevano ritirarsi nelle città murate, altri affermavano che bisognava abbandonare una buona volta la
guerra, e altri ancora - e questi erano gli illusi oltre che ingenui promotori - volevano la battaglia, lo scontro,
la guerra a Roma.
Non tutti gli Umbri parteciparono al combattimento e quelli che vi presero parte lo iniziarono così
disordinatamente da comprometterlo irreparabilmente.
I Romani invece - infiammati dagli incitamenti del console - si lanciarono al suono delle trombe addosso al
nemico e lo atterrirono così tanto che gli Umbri -così narra LIVIO- si lasciarono portar via le bandiere, e farsi
catturare come prigionieri senza opporre seria resistenza.
SANNITI ED ERNICI SCONFITTI
Vinti gli Umbri, QUINTO FABIO se ne tornò nel Sannio e nel 447 (307 a.C.) rimasto per la seconda volta
proconsole, affrontò presso Allife, sul Volturno, i Sanniti combatté l'intera giornata, infine li respinse fin dentro
i loro alloggiamenti. La sera era venuta ad interrompere la battaglia, temendo che il nemico durante la notte
abbandonasse il campo, lo fece circondare e, spuntato il giorno, accordò al nemico la resa alla condizione
che (memore delle umilianti "forche caudine") passassero sotto il giogo.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
77
Quelli tra i nemici però che non erano di nazionalità sannitica furono fatti prigionieri e venduti come schiavi. Il
numero di questi ultimi fu di circa settemila e fra loro si trovarono moltissimi Ernici, che subirono la sorte
degli altri.
Il trattamento fatto da Roma ai soldati della loro stirpe indignò gli Ernici, che, ad eccezione di Alatri, Verula e
Ferentino - le quali si mantennero fedeli ai Romani e in premio ottennero la cittadinanza completa - presero
le armi.
Per questi nuovi ed insperati aiuti, riprese animo il Sannio e, riunite insieme le truppe, formando un esercito
piuttosto rilevante, assalì alcune fortezze romane. Sora e Calazia furono costrette alla resa e i presidi romani
che le difendevano fatte a pezzi.
Correva l'anno 448 (306 a. C.) quando avvenivano questi fatti e consoli erano PUBLIO CORNELIO
GRAVINA e QUINTO MARCIO TREMOLO. Il primo fu mandato contro i Sanniti, il secondo contro Anagni e
le altre popolazioni erniche. Non fu difficile a Marcio avere ragione del nemico, benché nei primi giorni della
campagna le comunicazioni tra il suo esercito e quello del collega fossero state interrotte dagli Ernici, con
molta preoccupazione del Senato romano, il quale aveva in gran fretta già allestito due nuovi fortissimi
eserciti, chiamando alle armi tutti gli uomini validi dai diciassette ai quarantacinque anni.
CORNELIO GRAVINA invece si trovò a mal partito per la tattica usata dai Sanniti. Questi, essendo inferiori
di forze e non osando assalire l'esercito consolare in aperta campagna, avevano occupato tutti i passi e,
favoriti dalla posizione dei luoghi che potevano essere tenuti con pochi armati, impedivano al console di
comunicare con le sue basi e di ricevere rifornimenti.
MARCIO TREMOLO, vinti ed assoggettati gli Ernici, volle passare nel Sannio in aiuto del collega rimasto come detto sopra- isolato.
I Sanniti, sicuri di non potere misurarsi con il nemico se avessero lasciato che i due eserciti romani si
riunissero, decisero di assalire Tremolo mentre marciava in soccorso di Cornelio.
Scoperto in tempo che stava per essere attaccato durante la marcia di trasferimento (era quasi arrivato e
stava già per congiungersi all'esercito del suo collega) MARCIO fece prontamente mettere in mezzo i
carriaggi e ordinate come meglio poté le schiere, fece fronte al nemico. Il quale non conseguì i risultati che si
aspettava sia per la sveltezza con la quale il console seppe disporre la difesa sia perché qualche segnale di
cosa stava accadendo poco lontano giunse a CORNELIO ARVINA, il quale, senza perder tempo, uscito dal
suo accampamento, si diresse e attaccò il campo nemico, quasi vuoto perché impegnati con Marcio, e
quindi mal difeso; lo espugnò lo incendiò, poi assalì i Sanniti alle spalle.
Questi attaccati sia davanti sia dietro, non resistettero a lungo e cercarono di salvarsi, fuggendo, ma da ogni
parte si trovarono circondati dai Romani; in quella sacca infernale subirono delle enorme perdite. A
trentamila TITO LIVIO fa ascendere il numero dei morti che i Sanniti lasciarono su quel terreno.
Ma la battaglia non era finita. I Romani, dopo la strage, avevano appena terminato di suonare le trombe per
chiamare a raccolta i reduci della battaglia, quando comparve un secondo esercito nemico, che era quello di
rincalzo ma che giungeva in auto del primo troppo tardi.
Le truppe romane non aspettarono nemmeno l'ordine dei loro consoli e, entusiasmati dalla precedente
vittoria, si lanciarono sui Sanniti come una furia, prima che questi si rendessero conto che cosa era accaduto
poco prima ai loro colleghi.
Lo scontro fu breve e nemmeno fu ingaggiata una vera e propria battaglia: il nemico sgomento e subito
sbaragliato, arretrando cercò riparo sui monti, ma i Romani lo inseguirono cercando non di farlo fuggire ma
di annientarlo.
Non era più una battaglia, era una caccia spietata, senza tregua. Stanchi, feriti, demoralizzati, i Sanniti
implorarono la pace obbligandosi di provvedere le truppe romane di grano per tre mesi, di corrispondere loro
la paga per un anno e dare una veste ad ogni soldato.
Lasciato il collega nel Sannio, MARCIO TREMOLO fece ritorno a Roma preceduto dalle strabilianti notizie
della duplice vittoria; tributatogli il trionfo, per decreto del Senato, gli fu innalzata una statua equestre nel foro
davanti al tempio di Castore.
LA BATTAGLIA DI TIFERNO
L'anno seguente (449 - 305 a. C.), avendo i Sanniti ex capuani, fatte alcune scorrerie nel territorio di Capua,
furono inviati contro di loro due eserciti, comandati l'uno dal console TITO MINUCIO AUGURINO, l'altro dal
collega LUCIO POSTUMIO MEGELLO.
Boviano, la città più importante del Sannio, fu la meta del primo, su Tiferno puntò invece il secondo, che,
preso contatto con il nemico, lo costrinse a battaglia.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
78
Discordanti sono le notizie tramandateci dagli storici sulla giornata di Tiferno. Alcuni riferiscono che il
combattimento, accanito, terminò con una sanguinosa disfatta del nemico che perse, fra morti e prigionieri,
trentamila uomini; altri invece raccontano le cose in un altro modo. Narrano che si combatté tutto il giorno
senza vantaggio di alcuna delle due parti. Giunta la notte, POSTUMIO, fingendo di aver paura e di volere
fortificarsi in una località sicura, condusse il suo esercito sulle vicine montagne e quivi pose il campo e lo
munì di salde difese. I Sanniti lo seguirono nelle nuove posizioni e a loro volta misero gli accampamenti,
poco lontano, a due miglia dai Romani.
POSTUMIO aveva fatto quella manovra perché aveva appreso che il collega, nei pressi di Boviano, era
minacciato da un forte esercito nemico. Prima che spuntasse l'alba, Postumio fece sapere a Minucio che
sarebbe corso in suo aiuto e lo consigliò di attaccare subito i Sanniti; poi, lasciato sotto buona guardia il
campo, di nascosto con il resto dell'esercito partì alla volta di Boviano.
Quando vi giunse, da molte ore tra Minucio e i Sanniti era stata ingaggiata la battaglia e fino a quel momento
era molto incerto l'esito, inoltre entrambi i due eserciti erano spossati dal lungo combattere. Ma giunto
all'improvviso Postumio con l'esercito fresco fu lui a decidere la sorte della battaglia.
I Sanniti, non potendo resistere alle milizie sopraggiunte, tentarono di fuggire, ma, stanchi com'erano, ben
presto furono raggiunti e fatti a pezzi lasciando in mano ai vincitori venti bandiere.
I due consoli anche dopo la vittoriosa battaglia, nonostante fosse già quasi sera, non riposarono. Riunite le
truppe, si avviarono al campo di Postumio, già preceduti dalle notizie della grande vittoria riportata e, non
appena giunti, benché stanchi dal viaggio e dalla precedente lotta, assalirono pure il secondo esercito
nemico, lo sbaragliarono, lo misero in fuga, s'impadronirono di ventisei bandiere e fecero moltissimi
prigionieri fra cui il più importante: STAZIO GELLIO, il comandante e duce dei Sanniti.
Dopo queste strepitose vittorie, la capitale del Sannio, rimasta esposta alle offese di due potenti eserciti
Romani, non aveva alcuna speranza di salvezza, ben presto fu investita dalle truppe consolari e cadeva in
loro potere.
Subito dopo, anche Sora ed Arpinio furono costrette alla resa dai Romani.
LA PACE CON IL SANNIO
Orribilmente provati da una lunga e disastrosa guerra, con gli eserciti distrutti e il paese saccheggiato, ai
Sanniti bellicosi o no, non rimaneva altro da fare che chiedere la pace. La chiesero e la ottennero dopo aver
fornito tutto lo Stato verso i Romani prove di buona volontà alle condizioni da Roma proposte.
TITO LIVIO scrive che le condizioni di pace furono vantaggiose per i Sanniti con i quali Roma rinnovò l'antica
alleanza; DIONISIO invece afferma che Roma impose al Sannio come condizione la propria sovranità e che
non intraprendesse, senza il permesso della repubblica, guerre e stringesse ogni tipo d'alleanze.
L'affermazione di DIONISIO ci sembra più rispondente alla verità. Non si può difatti ammettere che Roma
pur con tanta generosità, abbia stipulato la pace e l'antica alleanza, sulla base della mutua uguaglianza con
un popolo vinto; inoltre sapeva -e i precedenti non mancavano di certo- che il Sannio avrebbe prima o poi
riprese le armi (e così fu - lo leggeremo nel prossimo capitolo-riassunto)
Pensiamo piuttosto che Roma avrebbe rifiutato senz'altro la pace e, approfittando delle sue vittorie, avrebbe
continuata la guerra fino alla definitiva conquista del Sannio se si fosse trovata in migliori condizioni.
Ma anche Roma era stanca; gli sforzi fatti contro i Sanniti, gli Etruschi, gli Umbri e gli Ernici l'avevano
esaurita, rilevanti erano state le perdite di uomini che aveva subito, altissimi i costi, ed aveva perciò bisogno
di ristorarsi con un periodo, più o meno lungo, di quiete.
Tuttavia, sapendo che presto o tardi si sarebbe trovata ancora di fronte ai Sanniti, approfittò della pace per
poter -con un periodo di quiete- consolidare la sua posizione.
Convinta della bontà del suo sistema coloniale, Roma nel 451 inviò ad Alba, sul lago Fucino, una colonia di
6.000 uomini, che doveva assicurare le comunicazioni con l'Apulia, e un'altra, di 4.000 uomini, a Sora
Fucense al confine sannitico e nel 455 due altre colonie, a Marnia nell' Umbria ed a Carseoli nel paese degli
Equi.
NUOVE GUERRE CONTRO GLI EQUI, GLI ETRUSCHI E GLI UMBRI
Sei anni, dal 450 al 455 (304-299 a.C.) durò la pace tra i Romani ed i Sanniti poi scoppiò nuovamente una
lunga guerra (che narreremo nel prossimo capitolo) ma durante questo periodo di tempo le armi di Roma
non riposarono proprio per nulla.
Due spedizioni fu costretta a fare contro gli Equi, e altrettante in Etruria e una nell'Umbria.
La prima spedizione contro gli Equi avvenne l'anno stesso che fu firmata la
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
79
pace con il Sannio. Gli Equi avevano radunato in un campo una grande moltitudine di armati di varie città,
senza disciplina e priva di validi capi e soprattutto di un solo capo. Quando appresero che un esercito
Romano si era fermato a quattro miglia dal loro campo, decisero di abbandonarlo, di sciogliere l'esercito e
tornare alle proprie città a fare resistenza ognuno dentro le proprie mura.
Disciplinati, forti e organizzati com'erano, i Romani si diedero a percorrere la regione in lungo e in largo e in
sessanta giorni -tanto durò la guerra- s'impadronirono a viva forza di oltre quaranta paesi, e la maggior dopo
averli costretti alla resa furono distrutti o incendiati.
Questa guerra sistematica di pulizia, impressionò talmente i popoli vicini che i Marrucini, i Marsi, i Peligni ed i
Ferentini si decisero di chiedere la definitiva amicizia a Roma e con essa strinsero alleanza.
La seconda spedizione fu fatta nel 452 (302 a.C.) che fu breve, durò solo una settimana. Causa della guerra
fu la colonia romana creata a Sora l'anno prima, e che gli Equi assalirono. Pur essendo stati gli assalitori
respinti dagli stessi abitanti della città, Roma, credendo che gli Equi fossero aiutati da altri popoli, piuttosto
allarmata, creò dittatore CAJO GIUNIO BUBULCO BRUTO. Questi con un forte esercito marciò contro il
nemico che ingenuamente accettò battaglia ma fu al primo assalto sgominato e disperso e nei giorni
seguenti, più saggiamente, implorando la pace accettò di sottomettersi a Roma.
Questa breve guerra, oltre che la sottomissione degli Equi, fruttò anche l'alleanza con i Vestini.
La prima spedizione in Etruria fu fatta nel 451 (303 a.C.) e fu causata dalle discordie intestine degli Aretini
culminate con la prevalenza del partito democratico sull'aristocratico (che non erano una novità fra gli
Etruschi)
E siccome contemporaneamente i Marsi intorno all'importante colonia Romana di Carseoli si erano ribellati,
fu creato dittatore MARCO VALERIO MASSIMO e maestro della cavalleria MARCO EMILIO PAOLO.
Il dittatore, passato nel territorio dei Marsi, attaccò i ribelli costringendoli a rifugiarsi entro le mura delle città
ed, avendo in pochi giorni costretto alla resa Milonia, Plistia e Fresilia, riuscì a pacificare la turbolenta
regione. Di là Marco Valerio tornò a Roma per rinnovare gli auspici; l'esercito, rimasto sotto il comando di
Marco Emilio, passò in Etruria, ma qui, uscito imprudentemente dal campo per predare, cadde in
un'imboscata e, dopo avere lasciato sul terreno alcuni morti e qualche bandiera in mano al nemico (o perse
per la strada), fu costretto a rifugiarsi nel suo più protettivo campo.
Poco fu il danno materiale subito dai Romani, ma la notizia dello scacco giunse subito a Roma e in un modo
diverso e fece pensare ad una grande sconfitta. Per questo motivo, allarmistico furono messe guardie alle
porte, ronde nelle vie e furono chiamati i cittadini alle armi.
MARCO VALERIO, partito precipitosamente, costatò che le cose in Etruria non presentavano alcuna gravità.
Il campo era in un luogo sicuro e quei soldati che avevano perso le bandiere erano stati lasciati per
punizione fuori degli alloggiamenti.
Altissimo infine era il morale dell'esercito sempre pronto a combattere.
Tuttavia levato il campo, il dittatore trasferì l'esercito nel territorio di Russelle dove il nemico lo seguì. Qui gli
Etruschi cercarono di trarre in agguato una schiera romana comandata dal legato CAJO FULVIO, ma non
essendovi riusciti, l'assalirono con numerose forze.
FULVIO, riuscì ad informare Valerio, e cercò di sostenere l'urto dei nemici fino a quando comparve il grosso
dell'esercito.
Prima ad attaccare fu la cavalleria che seminò il panico nelle file nemiche; queste sì diedero alla fuga ma
verso il loro campo e vi si trincerarono, e ai Romani non ci volle molto tempo per costringerli alla resa e a
subire così una totale disfatta.
Gli Etruschi chiesero la pace, ma fu loro concessa solo una tregua di due anni.
Della seconda spedizione, la causa fu un'invasione di Galli in Etruria. Gli Etruschi prima subirono il danno
delle razzie dei feroci e possenti barbari, poi con il denaro ingaggiarono i Galli versando loro una grossa
somma. Ma, ricevuto l'oro, i Galli pretesero pure una parte del territorio, ma per il rifiuto degli Etruschi e per
aver appreso che il dittatore MARCO VALERIO marciava con un forte esercito verso l'Etruria,
abbandonarono la regione.
MARCO VALERIO quando vi giunse volle punire gli Etruschi e non avendo questi accettato battaglia
rifugiandosi dentro le mura delle città, si diede ad incendiare e saccheggiare il paese e i dintorni.
Fra la prima e la seconda spedizione romana in Etruria, i Romani nel 455 (299 a.C.) dovettero brandire le
armi contro l'Umbria. Non sono note le cause di questa guerra, solamente si sa che il teatro dove fu
combattuta é Nequino sulla Nera (il famoso fiume che nasce sui Monti Sibillini, e alimenta la cascata delle
Marmore).
La posizione arroccata dove sorgeva la città umbra era forte per natura; quindi gli abitanti erano decisi non
solo a difendersi ma anche sicuri di non capitolare.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
80
Infatti, un contingente romano inviato ad assediarla al comando del console APULEIO, non riuscì a fare
proprio nulla per oltre un anno e soltanto nel secondo riuscì a conquistarla ma grazie al tradimento di due
abitanti che indicarono ai legionari un passaggio segreto per introdursi nella città, che ovviamente non ebbe
scampo.
Sulla Nera, per tenere a freno gli Umbri, in questo medesimo anno, fu inviata una colonia romana che prese
il nome di Narnia (od. Narni).
Così Roma consolidava le sue conquiste, e, crescendo i cittadini di numero, furono aggiunte due nuove tribù
alle vecchie (1'Aniense e la Terentina) le quali, con quelle istituite nel 332 (1'Ufentina e la Falerna.)
diventarono ora trentatre.
Ma intanto nel Sannio, dopo cinque anni di tregua, tornavano a rumoreggiare le armi e una nuova guerra
sannitica si annunciava, non meno accanita delle precedenti.
Questi avvenimenti e altri li leggeremo nel prossimo capitolo il periodo che va dall'anno 299 al 290 a.C. > > >
Fonti, Bibliografia, Testi, Citazioni:
TITO LIVIO - STORIE (ab Urbe condita)
APPIANO - BELL. CIV. STORIA ROMANA
DIONE CASSIO - STORIA ROMANA
PAOLO GIUDICI - STORIA D'ITALIA
UTET - CRONOLOGIA UNIVERSALE
I. CAZZANIGA , ST. LETT. LATINA,
+ altri, in Biblioteca dell'Autore
La FINE DELLA GUERRA SANNITICA - LE ULTIME BATTAGLIE (299-290 a. C.)
ROTTURA DELLA PACE COL SANNIO - BATTAGLIA DI VOLTERRA - PRESA DI BOVIANO - VITTORIA
ROMANA A TIFERNO - GLI APULI SCONFITTI A MALEVENTO - QUINTO FABIO IN LUCANIA CONQUISTE DI PUBLIO DECIO NEL SANNIO - GELLIO EGNAZIO DUCE DEI SANNITI - I SANNITI IN
ETRURIA - LA QUADRUPLICE LEGA - SCONFITTA DEGLI ALLEATI - VOLUMNIO SCONFIGGE I
SANNITI AL VOLTURNO: BATTAGLIA DI SENTINO - MORTE GLORIOSA DI PUBLIO DECIO E GELLIO
EGNAZIO - PACE CON L' ETRURIA - BATTAGLIA DI LUCERIA - LA "LEGIONE LINTEATA" - BATTAGLIA
DI AQUILONIA - PRESA DI COMINIO - FINE DELLA GUERRE SANNITICHE - TRIONFO DI QUINTO
FABIO E MORTE DI PONZIO TELESINO - COLONIA DI VENUSIA - PACE COL SANNIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROTTURA DELLA PACE COL SANNIO
Roma pur con una lunga serie di vittorie, dopo le due clamorose disfatte subite dai Sanniti, concesse al
Sannio la pace, pur non avendola sottomessa del tutto; ma la concesse con uno scopo ben preciso: non
solo il Sannio nella situazione di perdente ma anche Roma la vittoriosa, con gli sforzi fatti quasi
contemporaneamente contro i Sanniti, gli Etruschi, gli Umbri e gli Ernici l'avevano esaurita; rilevanti erano
state le perdite di uomini subite ma anche altissimi erano stati i costi, ed aveva perciò bisogno di ristorarsi
con un periodo, più o meno lungo, di quiete. Tuttavia, sapendo che presto o tardi si sarebbe trovata ancora
di fronte ai Sanniti, concesse malvolentieri quella pace per poter -con un periodo di quiete- consolidare la
sua posizione.
Erano trascorsi sei anni di pace, ma anche per i Sanniti, questi erano stati sufficienti per darsi sollievo delle
perdite subite e degli sforzi poderosi fatti durante le guerre precedenti. Era tempo per il bellicoso popolo di
vendicare i suoi morti, di liberare i lembi di terra sannitica caduti in potere dei Romani, di lavare le onte patite
e riacquistare tutta intera la libertà d'azione che gli era stata tolta dal nemico con i patti dell'ultimo trattato di
pace concluso nel 450 (304 a.C.).
Lo abbiamo visto nel precedente capitolo, a Roma, l'esercito, pur disimpegnato dai Sanniti, non era rimasto
inoperoso ma dovette occuparsi nei successivi sei anni di altri conflitti; vittoriosi, ma pur sempre impegnativi
come uomini e mezzi. Non così i Sanniti, che sgravati dalla guerra con Roma, impiegarono i sei anni per
prepararsi a farne un'altra per vendicarsi delle precedenti disfatte. E dopo i preparativi ritennero che il
momento era giunto, e che non poteva essere migliore.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
81
Siamo nel 299 a.C. L'Etruria da qualche tempo è in armi contro Roma, e i Galli partiti all'avanzarsi delle
legioni di Valerio possono forse tornare, e forse allearsi con gli Etruschi, che questi hanno già tentato di
assoldare. Mordono poi il freno i Marsi per i quali Corseoli (Carsoli) per Roma è come una spina nel fianco.
Poi ci sono gli Umbri, vigilati dai coloni di Narnia, ma che aspettano pure loro l'occasione di insorgere.
Potrà resistere Roma contro tanti nemici?
Il Sannio cerca altri alleati, sapendo quanta sia grande la potenza di Roma. A mezzogiorno ci sono i Lucani.
In parte, quindi non tutti, sono amici dei Romani, è vero, ma la regione è retta dal partito aristocratico e si
può tentare di rovesciare il regime e di acquistare un nuovo alleato aiutando il partito democratico ad
impadronirsi del potere.
Sono pertanto inviati ambasciatori nella Lucania affinché tentino in tutti i modi d'indurre il paese a muovere
guerra contro Roma. Ma i Lucani rifiutano: perché giocare una carta così pericolosa ?
Allora i Sanniti ricorrono alle minacce, poi alla forza: schiere di armati varcano i confini della Lucania e
mettono a ferro e a fuoco il paese.
A quel punto i Lucani un giorno dell'anno 455 (299 a.C.) si presentano al Senato romano ed ai consoli
CUCIO CORNELIO SCIPIONE e GNEO FULVIO MASSIMO degli ambasciatori lucani a lagnarsi che, a
motivo dell'incrollabile volontà di amicizia del loro paese verso Roma, tale affetto ha causato l'inimicizia dei
Sanniti e questi hanno invaso il loro territorio. Rinnovano la loro devozione per la potente repubblica, e
offrono, ove sia necessario, la sudditanza della Lucania a Roma.
I consoli e il Senato non sono sordi all'appello degli ambasciatori e stringono con i Lucani un trattato di
alleanza, poi mandano i Feciali nel Sannio affinché ufficialmente dicano che
siano ritirate le truppe sannitiche dalla Lucania e siano rispettati i nuovi alleati di Roma.
La notizia prima ancora dell'arrivo degli ambasciatori di Roma giunge rapidamente nel Sannio e sono
mandati incontro dei messi che superbamente ammoniscono i messaggeri romani di non entrare nel paese:
perché nessuno si farebbe garante della loro incolumità.
Gli ambasciatori Romani risentiti riprendono la via del ritorno, mentre i Sanniti ben sapendo quale sarà la
reazione a Roma, iniziano a preparare i loro eserciti, fidandosi nel concorso della armi etrusche.
BATTAGLIA DI VOLTERRA (456 A.di R. - 298 a. C.)
Ma gli Etruschi non sono più affidabili alleati sulla cui forza si possa contare come su un coefficiente
importante di vittoria; gli Etruschi, lo abbiamo visto nell'ultimo conflitto, ormai non sono che l'ombra di quel
popolo una volta così potente. Unito veramente non lo era mai stato, ma nemmeno diviso come in questi
ultimi anni.
Un esercito romano, guidato dal console LUCIO CORNELIO SCIPIONE, risale l'Etruria in cerca del nemico,
e già dispera di trovarlo e pensa che la presente campagna sarà simile a quella dell'anno precedente,
quando con sua grande sorpresa gli Etruschi, presso Volterra, gli si fanno incontro.
Gli si offre quella battaglia che lui va del resto cercando. In un attimo le schiere sono disposte in ordine di
combattimento e si scaglia addosso con furia sul nemico.
Pare che gli Etruschi abbiano ritrovato l'antica vigoria e si siano, ad un tratto, ricordati di essere i nipoti dei
famosi guerrieri di Porsenna. Infatti, si battono con valore e di fronte all'incalzare impetuoso delle legioni
romane non cedono di un passo.
La battaglia infuria tutto il giorno, poi cala la sera e le armi tacciono. Quando l'alba spunta si schierano
ancora i Romani per riprendere il combattimento che la notte ha interrotto; ma gli Etruschi non solo più là a
fronteggiarli né stanno chiusi nel campo.
La battaglia del giorno prima, energica ma così impegnativa, li ha sicuramente provati e nel pieno della notte
hanno abbandonato precipitosamente l'accampamento per trovare riparo nelle città murate.
Gli alloggiamenti sono saccheggiati e offrono un bottino ricchissimo. Scipione passa nel territorio dei Falisci,
lascia a Faleria con poca guardia i carriaggi e percorre con le sue legioni il paese nemico mettendo ogni
cosa a ferro e a fuoco.
BATTAGLIA DI TIFERNO (457 A.di R. - 297 a. C.)
Con questa loro defezione, più che su quelle degli Etruschi i Sanniti ora devono contare sulle proprie forze
ed opporsi al console GNEO FULVIO che marcia con un esercito nel Sannio e punta risolutamente verso
Boviano. La loro capitale è minacciata. Le truppe sannitiche escono ad incontrare le legioni consolari e dalla
città si ode il rumore della battaglia; che non dura molto, i Sanniti in ritirata cercano rifugio dentro le mura
della stessa Boviano.
GNEO FULVIO non si accontenta di questa mezza vittoria riportata in aperta campagna, la vuole totale, si
muove ed investe la città, che ben presto cade sotto gli assalti impetuosi dei legionari romani.
Lasciata a Boviano un forte presidio, il console punta verso il Sangro, su Anfidena, che invano si difende con
accanimento ma segue la sorte della consorella.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
82
Dopo queste vittorie romane la guerra langue, ma i Sanniti non dormono; per nulla domati o scoraggiati
preparano nuovi e più poderosi eserciti, e giunge notizia che anche gli Etruschi sono impegnati a fare intensi
preparativi.
Occorre dunque che Roma non riposi sugli allori, che altre legioni siano formate e che si affidi il comando a
capitani più famosi.
QUINTO FABIO MASSIMO RULLIANO, vecchio d'anni e carico di gloria, rivive nel meritato riposo gli anni
eroici del suo passato; ma il popolo, la nobiltà, il Senato vogliono che stringa nel pugno ancora la sua
celebre spada per la grandezza di Roma, e che a lui si affidato l'imperio.
L'illustre vegliardo rifiuta; non ha più la vigoria di una volta; che si riservino ai giovani le imprese gloriose. La
città torna a pregarlo e Fabio a rifiutare. Da tutte le parti si insiste perché egli accetti il consolato. Il famoso
capitano alla fine non resiste agli accorati appelli e cede alle pressioni, ma desidera che gli si dia come
collega PUBLIO DECIO MURE, ardente anima di guerriero ed espertissimo duce.
Ora le legioni romane sono in ottime mani. Nel corso dell'anno 457 (297 a.C.) un console andrà a mietere
allori in Etruria, l'altro nel Sannio. Ma le notizie dei preparativi etruschi risultano false: messaggeri che
giungono da Sutri, da Nepi e da Faleria riferiscono che tutto è quieto da quella parte. A Roma non dispiace,
tanto meglio. Gli sforzi si convergeranno tutti sul Sannio.
Partono i consoli con la stessa meta ma per vie diverse, l'anziano FABIO attraverso il territorio di Sora,
DECIO attraverso il paese dei Sidicini, avanzando con somma prudenza perché sanno che i Sanniti sono
maestri nell'arte di tendere agguati (sono del resto quelli delle "forche caudine"!)
Ed infatti, un agguato è teso, a Tiferno, ma non a Decio, ma al vecchio Fabio; i nemici si sono imboscati
nelle alture che fiancheggiano una valle ed aspettano che le legioni di Roma l'attraversano. Il console, cui
non manca l'esperienza, in qualche modo apprese le intenzioni dei Sanniti; lascia i carriaggi in luogo sicuro
sotto buona guardia ed entra nella valle, ma non in forma sparsa, ma con l'esercito disposto in quadrato
come se si trattasse di una battaglia.
Fallita la sorpresa, i nemici, desiderosi di battersi, a quel punto scendono al piano. Numerosi sono gli uomini
che motivati dall'odio si battono oltre ogni limite; tuttavia pur ostinata la battaglia, per qualche tempo è
incerto l'esito; anzi il console teme di essere sopraffatto. Soltanto la cavalleria può compiere il miracolo di
rompere le prime linee nemiche. Ordina perciò ai tribuni MARCO FULVIO e MARCO VALERIO di far entrare
in azione i cavalieri, e nello stesso tempo ordina al luogotenente SCIPIONE di mettersi alla testa degli astati
della prima legione e con un'intelligente manovra di aggirare i Sanniti per portarsi alle loro spalle.
I suoi ordini sono prontamente eseguiti: la cavalleria sferra con impeto il fronte avversario; purtroppo questo
non cede. I cavalieri si ritirano e cresce la fiducia nei Sanniti che hanno avuto in quello scontro il
sopravvento. E lo avrebbero mantenuto se i principi (la seconda linea del rincalzo del quadrato) freschi di
forze, non fossero entrati nella mischia ad arginare l'impeto dei nemici, non proprio risolutivo ma sufficiente
per tenere impegnati i Sanniti per qualche tempo, nell'attesa della "fortuna".
Che arriva! Infatti, improvvisamente, un rumor d'armi sorge alle spalle dei Sanniti: sono gli astati di
SCIPIONE, ma Fabio grida che è l'esercito di DECIO MURE che corre al soccorso.
Si rinfrancano i Romani e lo sgomento invade gli animi dei nemici, che si danno alla fuga. Si vorrebbe
incalzarli per annientarli, ma i Sanniti fuggendo si sono sparsi in così tante direzione che gli inseguimenti
risultano tutti inconcludenti. Tuttavia lasciano sul terreno 3.400 morti, ventitre bandiere, e solo 330
prigionieri.
BATTAGLIA DI MALEVENTO
Se il vecchio ma astuto FABIO avesse indugiato nella valle a predisporsi in battaglia con i Sanniti e si fosse
trovato al suo posto un altro esercito consolare, forse a Tiferno non avrebbero vinto i Romani.
I Sanniti erano riusciti a trascinare alla guerra gli Apuli ed un esercito di questi muoveva alla volta di Tiferno
per congiungersi con gli Alleati.
Però il console DECIO che aveva preso la via del paese dei Sidicini faceva buona guardia. Giuntagli la
notizia di questo nuovo esercito che avanzava, marcia risolutamente con le sue legioni contro gli Apuli e
giunge a prender contatto con questi a Malevento.
Gli Apuli non rifiutano di battersi e la battaglia si accende furiosa, ma la fortuna arride all'esercito di DECIO
MURE. Duemila nemici cadono sul campo e maggiore sarebbe stato il numero dei morti se gli Apuli,
sgomenti per l'andamento della battaglia non avessero abbandonato il campo per darsi alla fuga e mettersi
in salvo.
La via del Sannio era aperta. I due eserciti consolari invasero la regione e vi portarono la devastazione.
Quarantacinque - scrive TITO LIVIO - furono i luoghi dove Publio Decio si accampò ed ottantasei quelli dove
Quinto Fabio pose il campo. Né dopo la loro partenza rimasero soltanto le tracce degli steccati e dei fossati,
ma i segni ben più gravi della devastazione nei paesi dove avevano sostato un solo giorno.
Fabio assalì poi la città di Cimetra prendendola d'assalto e la resistenza dovette essere stata accanita a
giudicare dalle perdite nemiche: mezzo migliaio di morti e un migliaio e mezzo di prigionieri.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
83
L'anno seguente (458 - 296 a.C.), la guerra nel Sannio non ebbe un momento di tregua. Sono consoli
APPIO CLAUDIO CIECO II, astuto uomo politico, più che valoroso capitano, e il plebeo LUCIO VOLUMNIO
FLAMMA VIOLENTE II; ma sono stati lasciati come proconsoli per sei mesi i due valorosi reduci delle vittorie
QUINTO FABIO e PUBLIO DECIO.
Il vecchio FABIO passa con le sue legioni in Lucania dove il partito democratico ha avuto il sopravvento
sull'aristocratico, e rimette con le armi il potere in mano della nobiltà amica di Roma; Decio rimane invece nel
Sannio a guerreggiare.
Ma non è più una guerra in campo aperto, esercito contro esercito; sono solo scorrerie, devastazioni, incendi
e saccheggi per le campagne.
PUBLIO DECIO vuole, così operando, portare solo lo sgomento nel territorio nemico e impoverirlo affinché
non possa per lungo tempo con uomini e mezzi riorganizzarsi. E vi riesce; poi prende di mira le città dove le
truppe sannitiche si sono concentrate.
Murganzia, nonostante città potente, è investita e in un solo giorno è costretta con la forza alla resa; che
procura 2.100 prigionieri e un ricchissimo bottino.
E poiché le prede, bottino e uomini non si possono trascinare dietro, ogni cosa si vende. E siamo al punto
che i mercanti, abili a gestire questo lucroso mercato, seguono a breve distanza l'esercito, nell'attesa della
più che sicura "abbondanza" di lauti guadagni.
Dopo Murganzia cade Romulea: 2.300 sono i nemici uccisi, ma 6.000 sono i prigionieri che vanno in mano ai
mercanti di schiavi. Cade Ferentino, dove accanita e non breve fu la resistenza favorita dalla fortezza del
luogo e delle opere di difesa; qui l'immenso bottino - avviene ogni tanto per rinnovare l'audacia e motivare gli
assalti- è lasciato ai soldati Romani, e sono allora loro a fare affari con i mercanti, non potendosi trascinare
dietro l'ingombrante bottino.
I SANNITI IN ETRURIA - LA QUADRUPLICE LEGA
Ma i Sanniti non sono per nulla scossi da tutti questi disastri. Capo supremo della bellicosa nazione è ora
GELLIO EGNAZIO, forse figlio di STAZIO caduto a Boviano nel 449, patriota insigne e guerriero
valorosissimo.
GELLIO capisce che da solo il Sannio non può sperare di tenere testa alla potente Roma e che prima o poi
finirà con il soccombere e cadere sotto il giogo della repubblica; e pensa di opporre al nemico una forte
coalizione di popoli dell'Italia centrale. Gli Apuli, è vero, non hanno più il coraggio di tornare a brandire le
armi contro Roma, né i Lucani vogliono mancarle di fede; ma ci sono ancora fra gli insofferenti di Roma, gli
Umbri, i Galli e gli Etruschi.
GELLIO EGNAZIO raccoglie quante più forze possibili, lascia la patria in balia degli eserciti romani vittoriosi
e convinto di operare meglio fuori dei propri confini passa in Etruria.
Gli Etruschi sono stanchi della guerra e i rappresentanti delle varie città sono riuniti e stanno per decidere di
chiedere la pace ai Romani. L'arrivo del duce sannita fa tuttavia abbandonare le idee di pace e, mentre
s'inviano messi nell'Umbria e presso i Galli, si stabilisce d'intensificare la guerra contro la vicina repubblica.
È il momento per Roma di agire con la massima prontezza e risolutezza. In Etruria vi è già un esercito al
comando del console APPIO CLAUDIO, ma la perizia del console nell'arte militare non è molta, rispetto a
quella del suo anziano ex collega Quinto Fabio, e più volte l'esercito combatté contro gli Etruschi con esito
poco felice.
Fu così chiamato in Etruria dal Sannio, dove si trovava con un altro esercito, il console plebeo LUCIO
VOLUMNIO.
Il suo arrivo per APPIO CLAUDIO fu come un'offesa. Questa frivola questione di prestigio, di amor proprio e
di risentimento personale, avrebbe gravemente danneggiato i supremi interessi della patria in guerra se i
nemici, decidendo di assalire le legioni Romane, non avessero fatto sopire i rancori e fatto nascere una
nobile gara nell'animo dei due consoli.
EGNAZIO GELLIO, il duce Sannita, non è presente, essendo andato in cerca di vettovaglie, e la sua
assenza favorisce i Romani per sferrare un attacco; quando il duce sannita rientra è troppo tardi; Etruschi e
Sanniti, dopo un furioso combattimento sono stati respinti negli alloggiamenti, poi attaccati con estrema
violenza dagli eserciti consolari, sono caduti in loro potere. Settemila e trecento nemici sono rimasti uccisi e
oltre duemila fatti prigionieri. Il duce al suo rientro a stento riesce ad evitare la cattura.
LUCIO VOLUMNIO SCONFIGGE I SANNITI
Tuttavia questo scacco non scoraggia EGNAZIO GELLIO.
Poiché Fabio e Decio, terminato il loro proconsolato, sono tornati a Roma, e VOLUNNIO si trova in Etruria
lasciando sguarnito di truppe il Sannio, Gellio ordina che un nuovo esercito sia allestito in patria; e n'assume
il comando STAJO MINACIO, il quale, attraverso il paese dei Vestini, scende nella Campania e nel territorio
Falerno, razziandolo.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
84
Appresa la novità, a marce forzate, con il suo esercito torna il console VOLUMNIO verso il Sannio e non
appena entra nel territorio campano gli si mostrano le testimonianze dei saccheggi. Per mezzo di spie e di
prigionieri apprende che un esercito sannitico, ricco di bottino fatto in Campania, di ritorno nel Sannio è
accampato sul Volturno; decide subito di mettersi in marcia verso quello e di sorprenderlo.
Favorito dalle tenebre si avvicina ai Sanniti; qui apprende che le bandiere e il meglio degli armati nemici
sono partiti da poco e che il resto dell'esercito che ha con sé il bottino, lascerà il campo prima dell'alba.
Le informazioni sono esatte. Non è ancora l'alba quando in gran disordine inizia la partenza del nemico. Non
c' è miglior momento per assalirlo. L'assalto è sferrato con così estrema violenza che nella confusione,
numerosi Campani fatti prigionieri dai Sanniti nelle precedenti scorrerie, riescono a liberarsi e in un baleno
tutti riuniti, essendo dentro il campo nemico, riescono a catturare STAJO MINACIO che sotto la minaccia di
ucciderlo è costretto ad impartire ordini di resa.
Le schiere nemiche, partite durante la notte, informate degli avvenimenti, tornano indietro, ma là battaglia è
ormai perduta; tutta la preda è caduta in mano dei vincitori, trenta bandiere, quattro tribuni militari e duemila
e cinquecento uomini sono prigionieri e altri seimila giacciono morti nel campo.
BATTAGLIA DI SENTINO
Questa vittoria comunque non tranquillizza Roma, allarmata sia dai preparativi che i nemici fanno in Toscana
e sia dalle informazioni che da quella regione fornisce Appio Claudio. Gli Umbri, infatti, hanno preso le armi,
e lo stesso hanno fatto i Galli.
Mai Roma ha avuto tanti nemici contro di sé ed è necessario ricorrere a misure eccezionali. Il consolato di
CLAUDIO e VOLUNNIO è al suo termine. Occorre che i nuovi consoli siano i migliori capitani di cui Roma
disponga.
Chi più valoroso, più prudente, più esperto nelle armi di Fabio e di Decio? I due famosi generali sono assunti
al consolato e questi chiamano sotto, le bandiere Romani e Latini; circa novantamila uomini sono ripartiti in
cinque eserciti, al comando dei due consoli e dei tre vicepretori LUCIO SCIPIONE, GNEO FULVIO e LUCIO
POSTUMIO MEGILLO.
QUINTO FABIO corre in Toscana per rendersi conto personalmente della situazione e vi rimane per qualche
mese, poi, lasciato a presidio di Chiusi LUCIO SCIPIONE con due legioni, torna a Roma.
Verso Chiusi intanto si dirigono i Galli e SCIPIONE, stimando svantaggioso attendere nel campo un nemico
infinitamente superiore di numero, conduce le sue legioni verso un colle che sorge tra gli alloggiamenti e la
città, ma nello spostamento sorpreso dai Galli durante il cammino, ha l'esercito interamente distrutto.
Altri raccontano in modo diverso quest'avvenimento, scrivendo che fu il legato LUCIO MANLIO, inviato con
un distaccamento in cerca di vettovaglie, ad esser sorpreso e battuto e che, accorso Scipione, questi poi
sconfisse i nemici.
Ma questo è un episodio che non ha peso nella grande guerra. La parola decisiva sarà detta fra poco a
Sentino. Qui si sono raccolte le truppe dei popoli coalizzati, che si fanno ascendere a circa centomila uomini;
loro duce supremo è GELLIO EGNAZIO.
Verso Sentino marciano FABIO e DECIO, ma non hanno tutte le forze mobilitate; gli eserciti dei vicepretori
Fulvio e Postumio sono stati lasciati, come riserva e guardia della via di Roma, presso Faleria.
A quattro miglia dal nemico FABIO pone il campo romano e solo allora si accorge della superiorità numerica
degli avversari. La vecchia "volpe", non perde la sua freddezza, e cerca con uno stratagemma di pareggiare
le forze. Ordina a FULVIO e a POSTUMIO con una parte dell'esercito di marciare verso Chiusi, devastando,
al passaggio, il territorio etrusco. Lo stratagemma riesce: gli Etruschi abbandonano gli alleati e corrono a
difendere le loro terre, invase e saccheggiate dalle truppe, romane.
Allora Fabio incita alla battaglia i nemici e la battaglia avviene il terzo giorno dalla partenza degli Etruschi. Da
una parte e dall'altra i due avversari si dispongono in ordine di combattimento: i Galli formano l'ala destra
dello schieramento nemico, i Sanniti e gli Umbri la sinistra. Contro i primi sta l'esercito di DECIO MURE,
contro gli altri quello di QUINTO FABIO MASSIMO.
Prima che il combattimento abbia inizio, avviene un fatto che dai Romani è interpretato come segno di
propizio augurio: una cerva è inseguita da un lupo, e, cercando rifugio verso i monti, passa in mezzo tra le
opposte schiere. Qui la cerva, avvicinandosi ai Galli, è uccisa da questi a colpi di saetta; il lupo invece,
andando verso i Romani, riceve da questi il passo libero.
Un soldato romano grida: "La fuga e la morte sono dalla parte dove uccisa giace la fiera sacra a Diana; il
lupo, sacro a Marte, ci annunzia che la salvezza sarà con noi e ci ammonisce di ricordarci del dio, nostro
progenitore".
Il grido fu come un segnale di inizio della battaglia che, infatti, si scatena su tutto il fronte.
IL SACRIFICIO DI DECIO MURE
QUINTO FABIO ordina che le sue legioni si difendano solo, in modo da lasciare che il nemico si logori e si
stanchi assalendo. L'accorto generale vuole prolungare più possibile la battaglia onde evitare di logorare le
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
85
proprie truppe per lanciarle poi decisamente contro i Sanniti e gli Umbri quando questi sono prostrati dalla
fatica.
PUBLIO DECIO, al contrario, giovane ed irruente, lasciandosi vincere dalla foga e dall'ardore, scaglia
furiosamente le sue legioni contro i Galli e poiché gli sembra che la fanteria non assalga con l'impeto con cui
egli vorrebbe che si combattesse, fa entrare in azione la cavalleria, e lui stesso, con un manipolo di valorosi
cavalieri, fa prodezze inaudite sulla prima linea. Due volte mettono in rotta la cavalleria nemica e si spingono
arditamente in mezzo ai pedoni e li avrebbero senza dubbio sbaragliati se non gli fossero venuti incontro i
carri da guerra dei Galli, mezzi mai visti prima d'allora dai Romani, i cui cavalli, spaventati dallo frastuono
delle ruote, si irritano, si imbizzarriscono, indietreggiano senza più il controllo del cavaliere, mettendo in
disordine la stessa retrostante fanteria.
E' la rotta. I cavalieri e i fanti dell'esercito nemico intanto incalzano, perfino increduli di quella facile vittoria.
Invano DECIO MURE va in giro a rivolgere a suoi incitamenti per la battaglia; più nessuno gli bada. Allora si
ricorda del padre, che al fiume Veseri -come abbiamo ricordato noi nelle precedenti pagine- aveva fatto
sacrificio della propria vita per salvare l'esercito vacillante. Chiama il pontefice MARCO LIVIO e davanti a lui
pronuncia la formula rituale e, votando se stesso e i nemici alla madre Terra ed agli dèi Infernali, spronato il
cavallo, si lancia disperatamente nel folto delle schiere galliche, dove, colpito da innumerevoli dardi,
squarciato il corpo da numerose ferite, finisce la sua corsa stramazzando al suolo.
Il sacrificio del console non è del tutto vano. Stimolati dall'esempio eroico del loro capo, aiutati dalla
retroguardia giunta con Cornelio Scipione e Cajo Marcio al soccorso, i Romani tornano alla battaglia e prima
tempestano di dardi e giavellotti la fronte nemica, poi come una furia piombano addosso ai Galli e prendono
in un baleno il sopravvento su truppe che ormai sono stanche.
La lotta non è finita, ma manca pochissimo al suo termine, perché quello è il momento che aspettava l'astuto
Quinto Fabio. Vedendo quella debole difesa, intuito che i Sanniti e gli Umbri sono stanchi, il vecchio lancia
all'assalto tutte le sue riserve fresche, ordina alla cavalleria capuana di aggirare i Galli e le manda dietro, di
rincalzo, i principi della terza legione anche loro freschissimi.
La moltitudine nemica non resiste, vacilla, cede, fugge verso gli accampamenti, si fa una ressa indescrivibile
intorno alle porte, troppo strette per dare passaggio a tanta gente. GELLIO EGNAZIO tenta di frenare
l'impeto romano davanti gli steccati, facendo un'ultima resistenza, ma non resiste neppure lui, e mentre
eroicamente combatte, il duce cade ucciso.
La disfatta degli eserciti alleati è completa: 30.000 nemici uccisi giacciono sul terreno e più di 8.000 sono
fatti prigionieri; ma anche dalla parte romana le perdite sono molto gravi, che TITO LIVIO fa ascendere a
8.200 morti.
Il giorno dopo imponenti funerali sono tributati al console DECIO MURO.
Nello stesso giorno i resti dell'esercito sannitico, fuggendo attraverso il territorio dei Peligni, sono da questi
assaliti e lasciano lungo il percorso oltre 1.000 morti. Nei successivi giorni, gli Etruschi, affrontati dalle truppe
di GNEO FULVIO, subiscono presso Chiusi una grave sconfitta e lasciano sul campo 3.000 morti e nelle
mani dei Romani venti bandiere; correva l'anno di Roma 459 (295 a. C.).
PACE CON L'ETRURIA - LA BATTAGLIA DI LUCERIA
Dopo la sconfitta di Sentino si sciolse la confederazione dei quattro popoli nemici di Roma.
In Etruria la guerra ebbe qualche ripresa, ma dai risultati poco efficaci per non dire disastrosi; oltre che i
cittadini, nelle stesse truppe la voglia di combattere era di molto scemata e non era questa una buona
garanzia per coloro che volevano ad ogni costo condurre scellerate operazioni belliche, senza però esserne
capaci, pur potendo contare - come abbiamo visto a Sentino- su oltre centomila uomini, che erano tali, ma
non soldati; spesso erano civili costretti a fare il combattente senza averne le capacità oltre che la volontà
necessaria.
Per prima fu Perugia che pagò le spese di questa inefficienza e passività diffusa. Le sue milizie mandate al
macello, furono, infatti, sbaragliate in un istante, dallo scaltro QUINTO FABIO ed ebbero 4.500 e
cinquecento morti e circa 2.000 prigionieri che furono - per non restare senza necessari e operosi cittadinipoi riscattati pagando 310 assi ciascuno.
Poi venne la volta di Volsinio che, combattuta dal console POSTUMIO, perdette oltre 2.000 uomini, e di
Russelle che fu costretta alla resa e si ebbe il territorio saccheggiato.
Esausta, l'Etruria chiese a Roma l'anno dopo, nel 460 (294 a. C.) la pace per quarant'anni e le principali città
Volsinio, Perugia ed Arezzo, furono obbligate a pagare cinquantamila assi ciascuna come indennità di
guerra ed a ricevere dentro le loro mura e rifornire di viveri e vesti le guarnigioni romane.
Il Sannio invece non si diede per vinto. Radunato un esercito, lo mise in marcia contro il pretore APPIO
CLAUDIO e il proconsole VOLUNNIO; ma la sorte piuttosto ovvia gli fu contraria e il valore spiegato in
battaglia non fu compensato dalla dea fortuna. 16.000 Sanniti perirono ed oltre 2.000 furono catturati.
Benché disfatto, il fiero popolo ha ancora la forza di mettere in campo tre eserciti. Con uno intende custodire
i confini della regione, con il secondo tentar la fortuna in Etruria, con il terzo invadere la Campania.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
86
Contro quest'ultimo fu mandato il console ATTILIO REGOLO che incontrò il nemico in una località infame
per ingaggiare una battaglia e poco mancò di finire soccombente.
Era una notte di gran nebbia e le guardie romane facevano scarsa vigilanza alle porte del campo, quando i
Sanniti, prima che spuntasse l'alba, scatenarono l'assalto e riuscirono a penetrare nel recinto addirittura fino
al padiglione del questore LUCIO OPIMIO PANSA che uccisero. Nella confusione che seguì il console non
perse il sangue freddo, e, dato l'allarme, riuscì opporre al nemico un'energica difesa e a ricacciarlo.
Però dalla critica posizione in cui l'esercito di Attilio si era venuto a trovare, ci pensò il collega POSTUMIO
MEGILLO, il quale, poi divisosi da Regolo, dopo un accanito combattimento, costrinse alla resa Milonia e,
senza colpo ferire, Ferentino ed altre città, che erano state abbandonate dai loro abitanti.
LUCERIA
MARCO ATTILIO REGOLO con le sue legioni passò in Apulia e si scontrò al confine del territorio di Luceria
con un esercito sannitico. La battaglia fu tremenda e le perdite romane superarono quelle del nemico. Alla
stanchezza della lotta subentrò nelle truppe di Regolo lo sconforto e se, durante la notte o sul far del
mattino, i Sanniti avessero assalito il campo non avrebbero avuto certamente difficoltà a conquistarlo.
Per fortuna anche il nemico era stanco e non meno sfiduciato di quello romano e, giunto il giorno, anziché
riprendere il combattimento, avevano deciso di abbandonare il campo per rientrare nel Sannio.
Il console vedendo quel movimento pensò che i Sanniti volessero assalire l'accampamento romano e con le
preghiere e con le minacce riuscì a far riprendere le armi agli stanchi e svogliati soldati per schierarli contro il
nemico.
Benché né gli uni né gli altri avessero voglia di tornare a combattere, spinti dai loro comandanti, s'ingaggiò
nuovamente la battaglia e stava questa per volgere in favore dei Sanniti con i Romani che già ripiegavano
verso il campo, quando Regolo, fatto voto a Giove Statore di edificargli un tempio se la vittoria fosse stata
delle armi della repubblica, con un manipolo di cavalieri, prima riunì i soldati che tentavano di rientrare negli
alloggiamenti, poi li persuase che quello era il momento migliore per attaccare; infine insieme sferrarono
l'attacco decisivo con una vittoria strepitosa.
La giornata fu più sanguinosa della precedente, ma questa volta la disfatta del nemico fu completa, avendo
lasciati sul terreno circa 5.000 morti. Oltre 7.000 furono i prigionieri che Regolo fece poi passar nudi sotto il
giogo.
Dopo questa vittoria un'altra molto facile la conseguì l'esercito di Regolo, che, ritornando da Luceria,
imbattutosi in un esercito carico di bottino fatto nel territorio di Interamnae, lo attaccò, lo fece a pezzi e
recuperò anche il bottino
BATTAGLIA DI AQUILONIA
Nell'anno 461 (293 a. C.) i Sanniti tentano con un grande sforzo la riscossa.
Tutti gli uomini validi furono chiamati alle armi e si minacciò di morte coloro che non rispondevano all'appello
della patria.
Ma il Sannio rispose generosamente non perché c'era la minaccia, ma solo perché si trattava di salvare
l'onore della nobile e sfortunata nazione.
Quarantamila uomini si concentrano ad Aquilonia (Lacedogna). Qui, in un recinto di legno coperto di tela, il
sacerdote OVIO PACCIO, compie il sacrificio secondo l'antico rito sannitico chiamando le divinità a difesa
della patria e della stirpe. Il duce supremo poi chiama, ad un per volta, dentro il recinto gli uomini più nobili
per sangue e per imprese e singolarmente li conduce davanti all'altare. Presso l'ara innalzata agli dèi
giacciono sanguinanti gli animali immolati e ritti stanno attorno i centurioni con le spade sguainate. I soldati
pronunciano ad uno ad uno, un'orribile formula, invocando che sulla propria vita e su quella della loro
famiglia e della loro stirpe cada la maledizione se non seguono ciecamente i loro capi se fuggono, o se
lasciano impuniti quelli che di faccia al nemico voltano le spalle.
Sedicimila uomini fanno questo giuramento solenne e con loro si forma una legione disperata di guerrieri
votati alla morte, la cosiddetta legione "linteata". Le loro vesti sono bianche, di lino, impennacchiati gli elmi e
dorate le armature dei legionari, perché si distinguano dai rimanenti soldati.
Contro il Sannio in armi Roma allestisce due poderosi eserciti. Li comandano SPURIO CARVILIO e LUCIO
PAPIRIO CURSORE, il figlio del vincitore di Longula. Marciando verso il Sannio, il primo conquista Amiterno,
il secondo costringe alla resa Duronia; saccheggiando lungo la via, il primo giunge a Cominio che cinge
d'assedio l'altro ad Aquilonia, in mano all'esercito Sannita.
Venti miglia separano i due consoli, e giorno e notte sono percorse da messi che mantengono il contatto tra i
due campi romani.
Presso Aquilonia, per molti giorni si scaramuccia soltanto, ma infine si arriva alla giornata della grande
battaglia, desiderata dal duce, desiderata dai capitani, dai legionari, dagli auguri.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
87
E' tanto il desiderio dell'áugure "pullario" che, per affrettare il combattimento, senza pigliare gli auguri, li
annuncia favorevoli. Si schiera a battaglia l'esercito romano: LUCIO VOLUNNIO comanda l'ala destra,
LUCIO SCIPIONE la sinistra, CAJO CEDEZIO e TREBONIO la cavalleria.
SPURIO NAUZIO, escogita un singolare stratagemma; privati delle bardature i somari del carreggio li
conduce di nascosto sopra un'altura alle spalle del nemico e, a combattimento inoltrato, farà scendere giù
per la china gli animali sollevando un fitto polverone come se si trattasse di un terribile grande esercito al
galoppo.
Davanti, l'esercito nemico luccicava d'oro e d'argento, svolazzavano i pennacchi degli elmi, e le candide
vesti della legione linteata formavano una scena stupenda.
Si aspettava più solo che sia da una parte sia dall'altra che i capi impartissero il segnale dell'inizio della
battaglia; ed ecco che davanti al console Papirio, come propizio augurio, andò a posarsi e a gracchiare un
corvo. Fu a quel punto che suonarono le trombe e dai legionari si levò il grido della battaglia.
La battaglia inizia con violenza inaudita; il desiderio di combattere o l'ira spingono i Romani, assetati di
sangue nemico; mentre gran parte dei Sanniti erano costretti più dal giuramento a resistere che non ad
assalire ed essendo abituati ad essere vinti non
avrebbero retto al primo scontro dei Romani se una potente paura non li avesse trattenuti dal fuggire,
avendo sempre davanti agli occhi l'orribile rito del giuramento, l'altare circondato di vittime e nella memoria le
maledizioni invocate sulla loro vita, su quella della famiglia e sulla stirpe.
Ed infatti, i bianchi linteati vincolati dal giuramento, non indietreggiano di un solo passo, nemmeno quando i
legionari di Roma irrompono su di loro sciabolando a destra e a manca come dei seminatori di morte. Ed
ecco, a un tratto, alle spalle del nemico sorge un sordo rumore come di cavalleria che avanza al galoppo e
un nugolo fitto di polvere si alza al cielo. "È l'esercito di SPURIO CARVILIO, che, vinto Cominio, viene in
nostro aiuto", urla Papirio ai suoi. Era invece lo stratagemma di SPURIO NAUZIO, e il polverone era quello
dei somari al galoppo giù per la china alle spalle del nemico.
I legionari e i Sanniti hanno udito il grido del console; i primi raddoppiano gli sforzi, i secondi sbigottiti,
perdono vigore nella resistenza. A questo punto Papirio alza una lancia al cielo, è il segnale convenuto; si
aprono le schiere romane e attraverso il varco da dietro irrompe la cavalleria che cozza furiosamente contro
il baluardo vivente dei linteati, poi subito seguita dalla fanteria.
Ora la battaglia ha il suo tragico epilogo. La disfatta dei difensori del Sannio è irreparabile. I pedoni superstiti
sono respinti agli alloggiamenti, i nobili e i cavalieri sanniti fuggono verso Boviano; e gli uni e gli altri sono
inseguiti dai vincitori; ma gli steccati del campo sono un debole riparo per i vinti, travolti e superati dalle
schiere di Volumnio per i Sanniti non c'è più scampo.
Scipione, oltrepassato il campo con un distaccamento dei suoi, giunge sotto le mura di Aquilonia che non
può fare altro che arrendersi.
Trentamila Sanniti giacciono sul campo e altre migliaia fatti prigionieri.
Né questa è la sola sconfitta di quella giornata. All'alba l'importante città Cominio è stata attaccata da
SPURIO CARVILIO e, dopo una resistenza accanita e dove sono caduti quattromila uomini, si è arresa a
discrezione con tutta la guarnigione di quindicimila Sanniti.
Aquilonia e Cominio sono prima saccheggiate, poi ad entrambe è appiccato il fuoco; nello stesso giorno le
due città sono ridotte in cenere.
Più tardi anche Sepino, Volana, Palumbino ed Erculaneo cadono nelle mani degli eserciti consolari. In un
solo anno, nella disastrosa guerra i Sanniti hanno lasciato sul terreno oltre cinquantamila morti ed hanno
avuto più di ottantamila prigionieri, e gran parte della ricchezza del Sannio è stata preda delle legioni
romane.
Nel trionfo, che più tardi celebrerà a Roma, Papirio porterà in moneta due milioni e cinquecentotremila assi,
tratti dal ricavato dei prigionieri venduti ai mercanti, e mille e cento trenta libbre fra oro e argento.
FINE DELLE GUERRE SANNITICHE
Nelle condizioni in cui era ridotto, pareva che il Sannio non dovesse più rialzarsi e invece un anno dopo nel,
462 (292 a.C.) è di nuovo in armi; ma è l'ultimo sforzo, vano ed eroico insieme.
Capo delle truppe Sannite è PONZIO TELESINO, che comincia la lotta con una vittoria. Nella Campania gli
si offre l'occasione di sorprendere l'esercito del console FABIO MASSIMO GURGITE, figlio del grande Fabio
Rulliano, e di sconfiggerlo. Ma a vendicare la sconfitta delle legioni romane e a cancellare l'onta recata al
glorioso nome dei Fabii, parte il vecchio QUINTO FABIO, che in una memorabile battaglia, non sappiamo in
quale luogo combattuta, sconfigge i Sanniti, i quali lasciano migliaia di morti sul campo e fra le mani dei
Romani quattromila prigionieri.
Fra questi è PONZIO TELESINO che, carico di catene, segue a Roma il carro trionfale di RULLIANO, poi
terminata la cerimonia è messo a morte.
L'anno seguente, nel 463 (291 a. C.) il console L, POSTUMIO MEGELLO, conquista Venusia, nell'Apulia, e
vi si stabilisce una colonia di ventimila uomini. E' l'ultimo atto!
Il Sannio ha finito di lottare.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
88
Dopo cinquant'anni circa di ostinate guerre, l'anno dopo, nel 464 (290 a.C.) si arriva alla pace definitiva con
Roma e mette la parola fine alla sua indipendenza.
Tuttavia alcuni Sanniti irriducibili, continueranno a opporsi ai Romani, partecipando a tutte le coalizioni
militari che saranno promosse contro Roma. Non sono grandi battaglie storiche, ma ne fa fede la menzione
di trionfi registrati dai Fasti ancora per gli anni 279, 276, 275, 273, e 272 a.C.
Con la fine della terza guerra sannitica, sono ormai sotto il dominio romano, oltre al Lazio, il Sannio, l'Etruria,
l'Umbria, la Sabina e la Campania.
Ma nominando per ultima la Campania, che fin qui abbiamo menzionato nel conflitto dei Sanniti con Roma,
nel frattempo altri avvenimenti erano avvenuti nell'intero Meridione e in Sicilia; con i Greci e i Cartaginesi.
Ce ne occupiamo nel prossimo capitolo, tornando di qualche anno indietro, e menzionando pure alcune fasi
della guerra Sannitica in Etruria, con i Galli e i Boi.
Passiamo dunque al periodo dall'anno 290 al 280 a. C. > > >
Fonti, Bibliografia, Testi, Citazioni:
TITO LIVIO - STORIE (ab Urbe condita)
APPIANO - BELL. CIV. STORIA ROMANA
DIONE CASSIO - STORIA ROMANA
PAOLO GIUDICI - STORIA D'ITALIA
UTET - CRONOLOGIA UNIVERSALE
I. CAZZANIGA , ST. LETT. LATINA,
+ altri, in Biblioteca dell'Autore
I SABINI - MERIDIONE E SICILIA PREROMANA - MAGNA GRECIA -290-281 a. C.
GUERRA CONTRO I SABINI - MARCO CURIO DENTATO - QUARTA SECESSIONE DELLA PLEBE - LA
LEGGE ORTENSIA - LEGA ETRUSCO-GALLICA - ASSEDIO DI AREZZO - CECILIO METELLO
SCONFITTO - ECCIDIO DEGLI AMBASCIATORI ROMANI - GUERRA CONTRO I GALLI LENONI E LORO
STERMINIO - ETRUSCHI E GALLI BOI SCONFITTI AL LAGO VADIMONE - BATTAGLIA DI POPULONIA PACE CON L' ETRURIA E COI BOI - LE COLONIE GRECHE DELL' ITALIA MERIDIONALE - LA SICILIA GUERRE, RIVOLUZIONARI E TIRANNI - AGRIGENTO - SIRACUSA - IL TIRANNO GELONE - BATTAGLIA
DI IMERA - GERONE E TRASIBULO - DUCEZIO: L'EROE SICILIANO - I GRECI SCONFITTI IN SICILIA IL TIRANNO DIONISIO - GUERRE CONTRO CARTAGINE - DIONISIO ALLA CONQUISTA DELL' ITALIA
MERIDIONALE - MORTE DI DIONISIO - IL FIGLIO DI DIONISIO - DIONE - TIMOLEONE IN SICILIA AGATOCLE - AGATOCLE IN AFRICA - AGATOCLE E L' ITALIA MERIDIONALE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUERRA CONTRO I SABINI
I Sabini, quest'antica popolazione italica centrale, assai affine ai Sanniti (la loro capitale era Reale -od. Rieti),
una parte si era stanziata sul colle Quirinale fin dalle origini di Roma, poi (leggenda o no del "ratto delle
Sabine") si era fusa con i Romani. Ma il proprio territorio nei successivi cinque secoli era rimasto sempre
indipendente, non era stato mai sottomesso, pur essendo i Sabini alleati dei Romani; ciononostante nelle
guerre che Roma aveva dovuto sostenere contro il Sannio non solo non si erano schierati in suo favore, ma
non avevano neppure - specialmente nell'ultima guerra - mantenuta una bonaria neutralità.
Anzi, sia per i vincoli di parentela che li stringevano al Sannio con il quale avevano in comune la stirpe, sia
perché pensassero che Roma dovesse soccombere nell'impari lotta contro quattro bellicosi popoli, sia
perché, costretti dalla posizione geografica del loro paese, non potevano o, non fidandosi delle proprie forze,
non volevano impedire che gli eserciti sannitici passassero attraverso il loro territorio, nelle ultime -per
Roma- decisive guerre, avevano lasciato che le truppe del Sannio si trasferissero nell'Etruria attraversando
la Sabina.
Roma tutto questo lo sapeva benissimo, ma, impegnata com'era contro tanti nemici, non voleva certo
farsene un altro vicinissimo, quasi alle porte della città, e aveva aspettato per protestare, che la guerra
sannitica terminasse. Poi sarebbe venuto in qualche modo il castigo.
Non aspettarono invece i Sabini che Roma alla fine avrebbe chiesto a loro conto della violazione
dell'alleanza, e nel 464 (290 a.C.) e imbracciarono le armi ribellandosi alla potente vicina e, poiché presto
giunse la notizia che un esercito consolare avanzava, anziché muovere ad incontrarlo con tutte le forze che
avevano riunito, pensarono meglio di frazionarle presidiando i punti più deboli e importanti della regione
(Reale (Rieti). Nursia (Norcia), Amiternum, Tremula Mutusca ecc.).
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
89
L'esercito che da Roma era stato inviato contro i Sabini, guidato dal console MANLIO CURIO DENTATO,
quest'ingenuo piano di difesa messo in opera dai Sabini, invece di metterlo in difficoltà, gli facilitò
enormemente il compito.
Se un esercito numeroso e compatto, guidato da un solo capo, poteva lottare contro l'invasore con
probabilità di successo, niente potevano sperare i Sabini di ottenere tanti piccoli distaccamenti di fronte a
delle legioni forti, agguerrite, compatte e con capitani che provenivano da una scuola che aveva alle spalle
una lunga esperienza di guerra, di assedi, di strategie.
Infatti, il console assalì una dopo l'altra queste sparse forze sabine sconfiggendole, e in brevissimo tempo,
sottomise al dominio della repubblica tutta la regione.
Celebri sono rimaste le parole di CURIO DENTATO quando aveva annunciato al Senato i risultati ottenuti:
"…ho preso un territorio così vasto da rimanere deserto se non avessi insieme fatti tanti prigionieri; ho
catturato un numero così grande di uomini che perirebbero di fame se non avessi preso tanto terreno".
Roma, dopo la spedizione vittoriosa trattò molto duramente i vinti; offrì loro, è vero, la cittadinanza, ma li
escluse però dai diritti civili e politici (sine suffragio), inoltre sottrasse tutto il loro l'agro pubblico che, in lotti di
sette jugeri l'uno, distribuì ai più poveri fra i plebei e come il solito anche a quelli non poveri, o che
sottrassero poi i terreni dopo che i poveri avevano contratto con loro prestiti a usura.
Al console; il Senato, in premio di avere ottenuto così magnifici risultati, assegnò cinquanta jugeri dell'agro
sabino, ma Curio Dentato non ne volle accettare che sette, come tutti gli altri, dando esempio mirabile di
onestà.
Un altro fatto ci mostra quanto grande era in Curio il sentimento di onestà. Per ingraziarselo ed indurlo ad
intercedere presso la repubblica perché le condizioni di pace fossero miti, i Sabini cercarono di corromperlo
mandandogli, per mezzo di ambasciatori, una somma rilevante. Sdegnosamente rifiutando, Curio Dentato
rispose che "come le armi dei Sabini non avevano saputo vincerlo, così non poteva l'oro Sabino piegarlo, e
che amava di più rendere ricca e grande la patria che non se stesso".
La sottomissione dei Sabini fu una delle più facili vittorie, ottenuta senza sacrifici, con un vantaggio enorme,
e in una sola guerra, che guerra non era, semmai solo un'occupazione punitiva.
QUARTA SECESSIONE DELLA PLEBE
Alla guerra sabinica, a Roma, successe un periodo di pace di oltre un lustro con i soliti nemici esterni, ma
questa pace fu turbata da malumori interni, che divennero così intensi da provocare un'aperta ribellione.
Nonostante le enormi prede fatte nelle guerre precedenti, le spese sostenute per mantenere tanti eserciti
avevano svuotato le casse dello Stato. Si ricorse allora a tributi, che gravarono specialmente sulla parte più
povera della plebe ("infima plebs"- anno 461 - 293 a.C.), la quale non nascose il suo malcontento.
Le condizioni in cui versava la plebe erano molto tristi; più di una carestia aveva costretto i plebei a contrarre
debiti con i ricchi e, l'usura dei creditori infuriando peggio del flagello, i tribuni avevano alzato la voce
invocando severi provvedimenti in favore dei miseri. Ma invano: i senatori e i consoli (che facevano parte
della categoria dei ricchi) si erano sempre opposti.
Quest'insopportabile stato di cose spinse la plebe alla rivolta.
Questa avvenne nel 467 (287 a.C.). I ribelli, anziché sull'Aventino, questa volta si accamparono
minacciosamente sul Gianicolo. Fu tale la preoccupazione prodotta dalla sedizione popolare, che il Senato
ricorse (come se si trattasse di una grave guerra esterna) alla dittatura, ma ebbe la furbizia, da creare
QUINTO ORTENSIO, che era di famiglia plebea, ma era pur sempre legato al regime.
Il dittatore pensò prima d'ogni altra cosa di calmare gli animi degli insorti e fece credere che la repubblica
fosse minacciata da eserciti nemici. I plebei, in cui non si era mai smentito l'amore per la patria, si misero a
disposizione del magistrato e si dichiararono pronti a marciare contro il nemico.
Ottenuto questo, Quinto Ortensio indusse la plebe della ribellione a deporre le armi e promise di non punire i
ribelli e di interessarsi in favore dei debitori.
La calma ritornò ben presto e il dittatore propose e fece approvare una legge con la quale si conferiva valore
legale, senza alcuna restrizione, ai plebisciti.
Con questa, che dal suo autore si chiamò "Legge ortensia", la giurisdizione del Senato, al quale era riservato
il diritto di sanzionare i plebisciti cessava, e la plebe ("concilia plebis") poteva chiedere, con sicurezza di
ottenere, quello che prima della secessione le era stato negato e cioè l'alleviamento dei debiti. La cosa era
più formale che sostanziale.
GUERRA CON I GALLI E GLI ETRUSCHI
Roma tuttavia per quattro anni ebbe pace fino al 471 (283 a.C.) nel quale anno dovette riprendere le armi e
far marciare le sue legioni verso l'Etruria.
Di questa regione soltanto Arezzo aveva interesse a mantenere i vincoli d'amicizia che la stringevano a
Roma, questo perché solo la potenza della repubblica romana poteva salvarla dalla cupidigia dei vicini Galli;
le altre città etrusche invece non avevano abbandonato l'idea, ormai diventata atavica, della riscossa e di
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
90
una rivincita contro l'odiata nemica del sud dell'Etruria, e non guardavano perciò di buon occhio la
consorella.
Già nel corso del 470 gli Etruschi nemici di Roma si alleano con i Galli Senoni e mettono l'assedio ad
Arezzo. Gli Aretini mandano ambasciatori a Roma chiedendo soccorso e l'ottengono prontamente: un
esercito comandato dal pretore LUCIO CECILIO METELLO è immediatamente inviato in Etruria; ma la sorte
non favorisce le armi romane. Sotto le mura di Arezzo si svolge una terribile battaglia contro i collegati e alle
legioni di Roma tocca subire una sanguinosa disfatta. Eloquenti sono le cifre dei caduti romani: tredicimila; e,
fra questi, sette tribuni militari e lo stesso Cecilio Metello.
La notizia di una simile disfatta, produce a Roma una profonda impressione. Molti sono i prigionieri caduti
nelle mani dei Galli e si sa quanto grande sia la crudeltà di questo popolo. Prima ancora di pensare a
vendicare lo scacco militare subito, il Senato pensa alla sorte dei prigionieri e manda ai Senoni alcuni
ambasciatori perché trattino il riscatto.
I Galli, in quest'occasione, non smentirono la fama della loro barbarie: gli ambasciatori furono presi e
trucidati.
Il dolore della sconfitta di Arezzo fu reso più intenso dalla notizia dell'uccisione degli ambasciatori. Lo sdegno
della cittadinanza non poteva esser calmato che da un'esemplare vendetta, che era anche orgogliosamente
voluta dalla dignità offesa della repubblica.
Il console PUBLIO CORNELIO DOLABELLA fu scelto come capo della spedizione punitiva e gli furono
affidati pieni poteri. Dolabella ritenne opportuno non condurre le legioni attraverso l'Etruria, né ritenne di
andare a combattere i Galli ad Arezzo.
Ad un nemico che si era macchiato di così efferato delitto, non si doveva offrire una leale, onorevole
battaglia, ma mettere in pratica la legge del taglione.
Il console prese la via della Sabina e del Piceno, e, senza che al nemico giungesse la notizia della marcia
dell'esercito romano, piombò nel paese dei Senoni.
I SENONI, facevano parte di un'antica popolazione Celtica, insediatasi nel V secolo ca. sulla costa adriatica
tra Rimini e Ancona, Altri Senoni rimasti in Gallia erano invece stanziati lungo la Senna (ricordiamo che Galli
era il nome latino dato dai Romani ai Celti).
La regione fu messa a ferro e a fuoco, campagne e paesi furono saccheggiati e devastati. Dove passavano
le legioni di Roma, se prima esisteva il rumore e la vita delle genti, dopo vi piombava il silenzio e la
desolazione. Occhio per occhio, dente per dente! Gli uomini, che non riuscirono a salvarsi con la fuga,
furono spietatamente uccisi, le donne e i fanciulli fatti schiavi. La vendetta romana fu inesorabile.
Giunta ad Arezzo la notizia che la loro patria era stata invasa ed era sotto il sistematico sterminio, i Galli
rimossero l'assedio e si affrettarono verso il loro paese, ma, scontratisi più di una volta con le truppe
inferocite di Dolabella, furono disfatti (471 - (283 a.C.).
Quell'anno medesimo, sul litorale adriatico, a sud della foce del fiume Sena, i Romani inviarono una forte
colonia fondando Sena Gallica (Senigallia), che da quel momento fu la sentinella avanzata delle conquista
verso nord-est; con il nome che era tutto un programma.
BATTAGLIE AL VADIMONE E A POPULONIA (471-472 - 283-282 a.C.)
Le vittorie riportate sui Senoni e la devastazione del loro paese procurarono a Roma, anziché la pace, altri
nemici.
I Galli BOI, confinanti a Sud verso Rimini, con i Senoni, videro in queste imprese belliche di Roma una
minaccia contro la loro regione.
I Galli Boi, pure loro erano una popolazione Celtica, provenienti da quella regione tuttora chiamata Boemia.
Una parte emigrò a Bordeaux, un'altra intorno al 400 a.C. scese in Italia occupando il territorio fra il Po e
l'Appennino, comprendente l'antica città Etrusca di Felsina che divenne poi la loro capitale con il nome di
Bonomia (Bologna).
Decisi a difendere nella loro regione la propria indipendenza, raccolsero le schiere superstiti dei Senoni e,
stretta alleanza con gli Etruschi, presero la via di Roma.
Fu affidato ancora a CORNELIO DOLABELLA l'incarico di arginare l'avanzata dei nemici e di ricacciarli.
Accanto a lui fu l'altro console, GNEO DOMIZIO CALVINO.
Le legioni romane incontrarono i Galli e gli Etruschi presso il lago Vadimone, dove Fabio aveva, circa
quindici anni prima, riportata una memorabile vittoria, e li attaccarono violentemente.
Nonostante il nemico si battesse con valore e con un accanimento disperato, quel gíorno il violento impatto
dell'esercito romano e fu incontenibile.
Di quell'esercito che superbamente voleva scendere su Roma con il proposito di distruggerla, dopo la
battaglia non rimase che miseri avanzi e a stento molti si salvarono solo dandosi alla fuga.
Ciononostante, i Boi e gli Etruschi non disarmarono e l'anno seguente scesero ancora in campo.
Le legioni, che Roma inviò contro di loro, erano comandate dal console EMILIO PAPO. Il nemico, non
fidandosi delle sole sue forze, cercò d'avere ragione dell'esercito romano con l'insidia, ma l'accorto console
non cadde nel tranello che gli era stato teso e costrinse i Galli-Etruschi a una battaglia in campo aperto.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
91
Il combattimento avvenne a Populonia (Piombino) e i nemici subirono una tale sconfitta al primo attacco, da
esser costretti subito a deporre le armi e arrendersi.
I Boi chiesero la pace, la ottennero a buone condizioni e la rispettarono per circa quarantacinque anni; gli
Etruschi, essendo state vinte le città di Volsinio e di Vulci, chiesero pace pure loro e trovarono i Romani così
ben disposti da stringere un trattato di alleanza che ebbe una lunga durata: circa due secoli.
Da questo momento la nazione Etrusca scompare dalla storia come potenza militare, ma anche il nome
"etrusco" cessa di esistere, in breve tempo la regione è romanizzata, e la sua popolazione, non pensando
più alle guerre, rivolge alle arti ed all'industria quasi tutta la sua attività.
LA MAGNA GRECIA
Roma forse con i Boi e con gli Etruschi non sarebbe stata così generosa da dare subito ai primi equa pace
ed agli altri alleanza, se gli avvenimenti dell'Italia meridionale non le avessero consigliato di esser clemente
con i popoli del nord.
Al mezzogiorno d'Italia è necessario che ora noi rivolgiamo l'attenzione, come pure a quel popolo di stirpe
Aria che di tanta luce fece risplendere la penisola e che se non fosse stato lacerato da discordie intestine
sarebbe forse diventato il dominatore d'Italia.
Parliamo del popolo Greco. Rivolgimenti politici, guerre civili ed esterne, la necessità di estendere il loro
commercio e un'innata tendenza all'espansione, spinsero i Greci delle varie stirpi, forse nell'VIII secolo a. C.
- quando cioè l'emigrazione in Oriente cominciò a trovare seri ostacoli - verso l'Occidente sulle coste
specialmente della Sicilia e dell'Italia meridionale.
Come abbiamo già narrato in altre pagine, in precedenza, uno, due, tre secoli prima, da quell'aerea (forse
dalla Lydia) i Greci erano stati già preceduti dagli Etruschi; e sempre da quella zona, circa 1500-2000 anni
prima, risalendo l'intero corso del Danubio, dal Mar Nero, dalla Tracia, nel nord-est della penisola era già
giunti i Venedi, e a nord delle Alpi, nel medio e alto Danubio i Palafitticoli (a Varna sul Mar Nero esistono
reperti di villaggi su palafitte di oltre 4000 anni a.C. molto simili al villaggio palafitticolo del Lago di Ledro).
Poi scesero nei laghi prealpini, nel 1200 a.C. nella pianura Padana, e senza conservare un nome ben
preciso, e fortemente integrandosi con i locali, nel 1000-800 a.C., la loro presenza è perfino segnalata nel
Lazio, e nella stessa zona dove poi sorgerà Roma.
Lasciamo da parte questi, e torniamo ai Greci. Approdati iniziando dagli anni dell'VIII-VII sec. a.C., si
fermarono nei punti migliori del litorale Jonico, Tirrenico ed Adriatico e vi fondarono numerose colonie, che,
ingrandendosi per mezzo di successive immigrazioni dalla madre patria, fondarono a loro volta altre colonie,
ed estesero le loro conquiste, qualche volta guerreggiando, con le popolazioni indigene.
Sorsero, sulle coste dei tre mari, città che in poco volgere d'anni raggiunsero un alto livello di ricchezza, di
civiltà e di potenza. Prime fra queste, Locri, Crotone, Sibari, Cuma, Caulonia, Metaponto, Siri, Eraclea,
Posidonia, Taranto, le quali rivaleggiarono con le città medesime della Grecia ed attirarono con il loro
fascino, con la loro fama, con il clima dolcissimo delle feconde terre in cui sorgevano, non soltanto i
commercianti stranieri, ma filosofi e poeti di grido, e molti esuli, tutti coloro che la rivoluzionaria politica di
Atene o di Sparta, aveva cacciato dal seno della madre patria.
Pitagora, Archiloco, Saffo, Epicarmo, Senofane, Erodoto, Pindaro vi si recarono e ne magnificarono le
meravigliose bellezze; alcuni non vollero nemmeno più far ritorno alla loro madre patria; e non pochi uomini
illustri vi nacquero e le resero famose queste contrade con la loro arte e la loro dottrina.
Zaleuco e Caronda, grandi legislatori del loro tempo, resero illustrissima la città di Locri; Crotone, la superba
città sul fiume Esaro, dalle mura gigantesche, andò famosa per Pitagora; Taranto vantò il matematico
Archita, oltre moda e arte che anticipa di 2000 anni, l'arte ottocentesca europea.
(oggi lo straordinario Museo Archeologico di Taranto ci offrono testimonianze perfino incredibili..
Né soltanto per i grandi ingegni furono illustri le città della Magna Grecia, ma anche per le industrie che vi
fiorivano per i commerci che vi facevano affluire ricchezze da ogni porto del Mediterraneo, per le feste che vi
si celebravano, per l'arte che aveva saputo innalzarvi teatri vasti e templi maestosi adorni di mirabili sculture;
e per le delizie e il lusso sfrenato che vi era andò famosa la "molle" Sibari.
Peccato però che mancasse in tutte le città greche dell'Italia meridionale l'unità politica; questa mancanza
rese effimera la loro potenza e fu la causa principale della loro rovina. I coloni avevano portato nelle nuove
gli ordinamenti politici delle città da cui provenivano e in Italia erano stati trapiantati i partiti, le istituzioni, i
governi della Grecia, che furono poi le cause di contrasti e di guerre.
Guerre tra città e città, tra partito e partito, per la prevalenza di un paese o di una forma di governo. Una
delle guerre che maggiormente influì sui destini della Magna Grecia, fu quella combattuta tra la democrazia
e l'aristocrazia.
Scaturì proprio nella "molle" Sibari la prima scintilla, dove il popolo, insorto contro i ricchi che sperperavano
in piaceri le ricchezze, cacciò cinquecento nobili che furono ospitati poi a Crotone. Fra Crotone, retta a
regime aristocratico, e Sibari, caduta in mano della democrazia, si accese accanita la guerra che si decise
sulle rive del Tronto.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
92
L'esercito crotonese, capitanato da MILONE, sconfisse i nemici e distrusse Sibari dalle fondamenta. Effimera
vittoria dell'aristocrazia perché, ben presto, in quasi tutte le altre città la democrazia, insorta, ebbe il
sopravvento e stabilì il suo predominio.
Causa della debolezza delle città greche furono, oltre che la lotta fra i vari partiti, la quale spesso sacrificò gli
interessi della patria (quasi del tutto dimenticata) la mancanza di solidarietà tra le varie città, gli odi che le
tennero divise, le rivalità che le spinsero l'una contro l'altra; la ricchezza, ottenuta con i commerci, che rese
apatici gli abitanti e ostili o incapaci alla creazione di eserciti propri; cause queste tutte che dovevano
rendere un popolo, forte in origine e civile, facile preda -come vedremo in altri capitolo- delle rapaci aquile
romane.
LA SICILIA
Le colonie greche della Sicilia invece, conseguirono maggior splendore, ebbero più forte vitalità e maggior
peso negli eventi, fino al punto che decisero in modo decisivo i destini di Roma e del Mediterraneo.
Posta nel centro del Mediterraneo, dotata di un clima meraviglioso e di un suolo fertilissimo, ricca di comodi
porti naturali, circondata da mari pescosi, ebbe fin dai tempi più antichi una parte importantissima nella storia
della umana civiltà, attirò nella sua splendida isola, dai tre continenti popoli di razza diversa, e con l'Africa,
con il continente europeo e con l'Asia ebbe intense relazioni di commercio, oltre che culturali.
Siculi, Sicani, Elimi e forse Fenici popolavano l'isola, in possesso d'una civiltà non indifferente, quando nel
secolo VIII a. C., cominciarono a stabilirsi i primi coloni greci; e non poche e non brevi furono le lotte che
questi dovettero sostenere con i fieri abitatori della Sicilia, prima di potersi affermare ed imporre la propria
civiltà.
Numerose città sorsero su tutte le coste e molte nell'interno dell'isola
Nasso, Zancle (poi Messana), Leontini, Catana, , Megara Iblea, Mile, Imera, Selinunte, Agrigento, Gela,
Acre, Siracusa (fondata nel 733 a-C. dal Corinto Archia); queste le principali, ma molte altre scomparvero in
seguito dalla storia.
Come nell'Italia meridionale cosi nella Sicilia, manca fra le colonie greche l'unità nazionale; le città sono rivali
tra loro, spinte l'una contro l'altra da odi e da interessi economici e politici contrastanti e, per giunta, tutte, o
quasi, hanno da lottare contro l'elemento indigeno che orgoglioso della sua terra, non vuole rassegnarsi alla
perdita della propria indipendenza.
(Così caratteristica questa volontà d'indipendenza, che nei successivi 2700 anni, cioè fino ai nostri giorni,
non cesserà mai di manifestarla).
Oltre a questo, in ogni singola città i partiti si dilaniano tra loro; la democrazia è in perpetua guerra con
l'aristocrazia e da questo stato di cose nascono sommosse, congiure, eccidi, mutamenti di governo, alleanze
temporanee e talvolta ibride di una città con l'altra, rivoluzioni di cui approfittano uomini arditi e spregiudicati
per impadronirsi del potere ed instaurare la tirannide, che lascia tracce sanguinose dietro di sé e produce
altre guerre ed altre rivolte.
Ad Agrigento e a Siracusa, che sono le più grandi città dell'isola, periodi di splendore si avvicendano con
periodi di turbolenza, e le rivolte si alternano con la tirannide.
Tristemente famosi sono FALARIDE, ALCMENE, ALCANDRO e TERONE che dilaniano Agrigento:
CLEANDRO, IPPOCRATE e GELONE che tiranneggiano a Gela; TERILLO che infierisce nella città di Imera.
Non tutti i tiranni però si distinsero solamente per la crudeltà del loro carattere e per il modo spietato con cui
trattarono i loro sudditi. C'è fra di loro chi fra i delitti e le sevizie, fra la durezza e la ferocia ha momenti di
bontà e di nobiltà ed opera per la grandezza della patria.
Fra questi è GELONE con il quale Siracusa si mette in prima fila tra le città greche di Sicilia. Chiamato dalla
nobiltà siracusana, che è stata scacciata dalla plebe, Gelone si impadronisce di Siracusa, la espande, ne
moltiplica la popolazione attirandovi coloni, la rende ricca e potente e unifica sotto il suo scettro gran parte
delle colonie greche della zona occidentale dell'isola; mentre TERONE, suo suocero, amplia lo stato
agrigentino.
È il secolo in cui sembra che i Greci di Sicilia stiano per raggiungere l'unità nazionale. Infatti, le città greche
dell'isola, salvo pochissime, si raggruppano intorno a Siracusa ed Agrigento e anche queste due stringono
alleanza.
Immensa è la potenza raggiunta da entrambe; nel frattempo Atene, minacciata dai Persiani, chiede aiuto a
Siracusa e questa manda duecento navi, ventiquattromila fanti e duemila cavalieri (da queste cifre,
possiamo immaginare quanta ricchezza circolava, per permettersi il lusso di inviare duecento navi)
I Persiani (era l'anno 480 a.C. - Serse ha invaso la Grecia - anno della battaglia delle Termopoli) sono alleati
dei Cartaginesi, i quali allo scopo d'impedire che le colonie siciliane inviano soccorsi alla madre patria, sono
loro a inviare in Sicilia un poderoso esercito comandato da AMILCARE che assedia Imera.
Siracusa ed Agrigento prontamente muovono contro gli aggressori con un esercito di cinquantamila fanti e
cinquemila cavalieri che però sono duramente sconfitti.
Cinquantamila Africani, fra cui AMILCARE, sono uccisi, gli altri sono fatti prigionieri.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
93
(questa battaglia costituisce quasi il corrispettivo ad Occidente della vittoria greca su Salamina. I Persiani di
Serse sono costretti ad abbandonare l'Attica; i Cartaginesi di Amilcare ad abbandonare la Sicilia per un
settantennio, per dedicarsi all'Africa, pur conservando il possesso della Sicilia occidentale.
A GELONE succede il fratello GERONE, che muove guerra ad Agrigento, e uscitone vincitore, volge le armi
contro gli Etruschi sui quali riporta una grande vittoria navale.
Siracusa si libera dalla tirannide scacciando TRASIBULO, successore di Gerone, e instaurando un governo
democratico.
Un periodo di pace e di libertà pare che inizi nella grande città, ma ben presto la guerra è nuovamente
davanti alle sue porte. Gli indigeni dell'isola bandiscono una crociata contro i Greci usurpatori. DUCEZIO il
più famoso capopopolo innalza il vessillo dell'indipendenza nazionale, espugna Etna, assedia Motia e
sconfigge Agrigentini e Siracusani.
Ma la lotta è impari e Ducezio non può continuarla, ben presto è costretto a cedere le armi e relegato in
esilio a Corinto; ma qui ricomincia a sognare la riscossa della sua patria; vi ritorna, fonda la città di Cale
Acte, ma mentre organizza gli isolani per iniziare una nuova guerra, l'eroe siciliano muore.
A sostenerla e ad essere fiera di scatenarla la guerra, è Trinacria, una potente città sicula rimasta
indipendente (che prese il nome che i greci allora davano alla Sicilia, per la sua forma "triangolare"). Assalita
da un poderoso esercito siracusano, Trinacria si difende eroicamente. Vecchi, giovani, fanciulli, uomini e
donne si battono disperatamente e solo il numero infinitamente superiore degli avversari ha ragione dello
sconfinato valore degli isolani.
I superstiti però non si sottomettono e si rifugiano sulle montagne, da cui sperano di scendere per scacciare i
Greci (o chicchessia) dalla loro terra (e così faranno in seguito, fino a Garibaldi)
Con la vittoria ottenuta sugl'indigeni dell'isola cresce ancora la potenza di Siracusa, e cresce ancora di più
quando ottiene altre vittorie sugli Agrigentini e sugli Etruschi. Ma questa supremazia siracusana sulle vicine
città greche pesa non poco e queste o isolatamente o unite tentano di liberarsene.
Prima a ribellarsi è Leontini, la quale, non potendo da sola competere con Siracusa, chiede aiuto ad Atene e
si allea con Reggio. Atene invia navi in soccorso, ma prima del loro arrivo, Leontini era già stata vinta e si
era arresa.
Ad Atene si rivolge, dieci anni dopo (siamo nel 415 a.C.), Segesta, trovandosi in guerra contro Selinunte che
è spalleggiata da Siracusa; ed Atene, che da qualche tempo cerca di sottomettere e vuole allargare il suo
dominio in Sicilia, non si lascia sfuggire l'occasione: allestisce una potente flotta (con a capo Alcibiade ma
che appena arriva è richiamato ad Atene con un'infamante accusa) e pone l'assedio a Siracusa.
In soccorso di quest'ultima si schiera Dori, che invia un poderoso esercito comandato dallo spartano
GILIPPO (Con Sparta in lotta con Atene, Siracusa ha ottimi rapporti).
Gli Ateniesi sono costretti a levare l'assedio e si preparano a partire, ma, impediti da una tempesta, sono
improvvisamente assaliti dai Dorici e dai Siracusani e sanguinosamente sconfitti. Settemila superstiti cadono
prigionieri e chiusi nelle Latomie (cave di pietra) dove molti soccombono tra sofferenze inenarrabili.
La sfortunata spedizione siciliana costa agli Ateniesi la perdita di duecento navi e più di quarantamila uomini.
IL TIRANNO DIONISIO
Dopo questa vittoria, Siracusa è la città più potente dell'isola; ma per la rivalità delle colonie greche, la Sicilia
rischia di cadere in potere di uno straniero che da tanto tempo le ha messo gli occhi addosso: Cartagine.
Segesta e Selinunte sono di nuovo in lotta e, questa volta, la prima si rivolge per aiuti ai Cartaginesi (344 A.
di R. - 410 a.C.), che sbarcano numerosi sull'isola e saccheggiano e distruggono Selinunte ed Imera. La
ferocia degli Africani, che tutto al loro passaggio mettono a ferro e a fuoco, commuove Siracusa; in questa
città affluiscono spaventati gli abitanti dei territori invasi, raccontando orribili episodi di stragi e di violenze; e
inoltre affermano che il nemico non si accontenterà di ciò che ha già conquistato e sicuramente marcerà
sulla ricca Siracusa. E' necessario quindi correre ai ripari.
Ma il governo è perplesso e l'esercito inoperoso. Di questo stato di cose approfitta un uomo furbo, audace,
ambizioso, di nome DIONISIO, il quale fa credere al popolo che i capi dell'esercito hanno intenzione di
cedere la città al nemico. La plebe si solleva e Dionisio, è a furor di popolo nominato capo delle milizie. Poco
dopo anche il governo cade nelle sue mani e Dionisio, anziché rivolgere le cure alla guerra contro gli
invasori, si preoccupa solo di rafforzare la sua posizione, raduna intorno a sé schiere prezzolate e usa il
braccio di ferro sui più influenti cittadini, esautorandoli dalle più importanti cariche.
Questa sua condotta provoca un ammutinamento dell'esercito, che, assalito il palazzo del suo capo, ne
uccise la moglie; ma Dionisio con le sue schiere prezzolate, seppe domare la rivolta, poi rivolse la sua
attenzione alla guerra contro i Cartaginesi e fu così abile nello sconfiggerli, che riuscì perfino a farsi restituire
o a recuperare tutto ciò che avevano saccheggiato.
Ma ben presto a Siracusa torna a scoppiare una rivolta, ma di nuovo Dionisio riesce a reprimerla con tutta la
ferocia delle milizie che sono ai suoi ordini.
Poi mosso da uno sfrenato desiderio di potenza, assoggetta Catana, Etna e Nasso e, poiché i Cartaginesi
sono ritornati minacciosi, Dionisio raduna un esercito di ottantamila fanti e tremila cavalieri ed una flotta di
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
94
trecentocinquanta navigli. Ma superiori di numero sono le forze nemiche: trecentomila soldati e quattrocento
navi.
La guerra si svolge accanita ma con alterna vicenda, ma alla fine fu il numero a vincere: nelle acque di
Catana la flotta di Dionisio è distrutta e Siracusa, investita da tutte le navi di Cartagine, sta per capitolare.
Ma accadono due fatti; il primo è una provvidenziale peste che, improvvisamente scoppia fra i nemici, che
ne diminuisce sensibilmente le forze e terrorizza demoralizzando le stesse; il secondo è il tempestivo aiuto di
una flotta giunta da Sparta. Le due cose salvano Siracusa ed allontanano i Cartaginesi.
La guerra non tarda ad essere ripresa; segue prima un periodo di conflitti tra Siracusa e Cartagine, durante il
quale l'una e l'altra ottengono vittorie e subiscono sconfitte.
Ma DIONISIO non pensa solamente a fiaccare i Cartaginesi e a cacciarli dalla Sicilia. Le sue mire vanno
oltre l'Isola: nel Tirreno vuole far cessare l'egemonia etrusca, vuole insignorirsi delle colonie greche dell'Italia
meridionale e concepisce perfino l'ambizioso progetto di assoggettare la Grecia.
Agli Etruschi, infatti, non concede un momento di tregua; riesce a cacciarli dalle coste illiriche ed italiche
dell'Adriatico e invia colonie ad Ancona, a Numana ed Hatria (Adria) e nelle isole di Lisso e di Issa; dalla
parte del Tirreno espugna, nel 369 a.C. la florida città di Pirgi.
Maggiore accanimento mette nell'attuare il disegno di conquista delle colonie della Magna Grecia. E prima
fra tutte è Reggio a subire i fieri colpi di Dionisio, che si presenta
con centoventi navi davanti la città e, non riuscendo a costringerla alla resa per l'eroica difesa degli abitanti,
capitanati da ELORI, ne saccheggia e devasta il territorio.
Contro il tiranno siracusano si schierano quasi tutte le città greche, ma DIONISIO, con accorta politica,
riesce a tirare dalla sua parte Locri e i Lucani. Mentre lui torna ad assalire Reggio, i Lucani sconfiggono
l'esercito che difende TURIO. Reggio seguita a resistere; la guerra si estende a Caulonia e Crotone che
affidano ad ELORI un forte esercito.
La sorte favorisce Dionisio: l'esercito nemico cade in un'imboscata, Elori resta ucciso con un gran numero di
combattenti e diecimila soldati sono fatti prigionieri.
La vittoria è schiacciante, decisiva, e molte città cadono sotto il dominio del tiranno; poco dopo pure Reggio,
dopo un'eroica resistenza, si arrende per fame e Caulonia dopo aver subito la stessa sorte, per punizione è
rasa al suolo.
Il terzo e più arduo disegno, la conquista della Grecia, forse sarebbe rimasto solo un desiderio, anche se lui
fosse vissuto più a lungo. Ma la morte lo coglie nell'anno 367 a.C., e con la sua morte non poche città della
terraferma, che erano finite sottomesse alla Sicilia, riacquistano la loro libertà.
IL SECONDO DIONISIO, DIONE ED AGATOCLE
Al tiranno succede suo figlio, con lo stesso nome; (detto "il giovane" o DIONISIO II); meno audace e
ambizioso ed anche di minore ingegno, ma come il padre malvagio e più del padre dissoluto. Contro di lui si
muove lo zio DIONE, cacciato dal nipote, il quale, aiutato da non pochi esuli, sbarca in Sicilia, solleva
Agrigento, Gela e Camarina e marcia su Siracusa, che dopo un aspro combattimento conquista; DIONISIO è
costretto a rifugiarsi in esilio a Locri. Era l'anno 357 a.C.
Ma DIONE resta al potere per poco tempo, nemmeno tre anni: prima osteggiato dal partito favorevole a
Dionisio, infine nel 354 a.C., è ucciso a tradimento da un certo CALIPPO, lasciando la città in preda al
disordine.
Ritornato a Siracusa dall'esilio, Dionisio ben presto si rende inviso ai cittadini a causa delle
sue scelleratezze. Si congiura contro di lui e si chiede aiuto a Corinto. Nel 344 a.C., è inviato sull'isola
TIMOLEONE che libera dalla tirannide Siracusa, Catana, Leontini e Messana:
Dionisio II assediato in Ortigia, si arrende. Inviato in esilio in Grecia vivrà ancora a lungo come privato,
morendo infine, sembra, a Corinto.
TIMOLEONE instaura governi democratici, poi nel 341 a.C., dichiara guerra a Cartagine, sostenitrice dei
tiranni dell'isola, e con dodicimila uomini affronta un esercito di settantamila Cartaginesi e lo sconfigge sul
Simoenta (fiume Crimiso).
Libera dalle insidie straniere, tutelata dall'onestà di Timoleone, che procede alla riorganizzazione di molte
città sotto il dominio di Siracusa, tra le quali Selinunte, da lui ricostruita, la Sicilia respira e gode alcuni anni
di pace e di benessere, ma, a causa della cecità da cui è stato colpito, si ritira a vita privata nel 337 a.C.,
dopo aver costituito un sinedrio di 600 cittadini. Ma la bellissima opera rinnovatrice da lui costruita in breve
tempo si sfascia e la libertà è spenta dalle milizie mercenarie, che proclamano tiranno AGATOCLE, un turpe
avventuriero il quale era riuscito a diventar loro capo.
Comincia con lui, in Sicilia, un periodo di violenze, di persecuzioni, di sangue, che ha un momento di tregua
solo quando (310 a.C.) nell'Isola sbarca un grosso esercito di Cartagine.
AGATOCLE gli dà battaglia al monte Ecnomo, presso Imera, ma è sconfitto e lascia al campo settemila
uomini. La sua disfatta segna per i Siciliani l'ora della riscossa; molte città, pur di liberarsi dalla tirannide di
quel mostro, si alleano con i Cartaginesi, che marciano contro Siracusa.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
95
Ma AGATOCLE ritorna all'offensiva; pone in stato di difesa Siracusa e, raccolto un esercito, eludendo la
vigilanza della flotta cartaginese, sbarca in Africa con lo scopo di far allontanare dalla Sicilia i Cartaginesi
portando la guerra in casa loro (311 a.C.)
Sbarcati con i suoi uomini, AGATOCLE distrugge le navi per costringere i soldati a combattere strenuamente
togliendo loro i mezzi per una ritirata; poi, saccheggiando e devastando, giunge in Libia. Per accrescere il
suo esercito, ricorre ad un ignobile stratagemma. Ad OFELLA, governatore di Cirene (che si è reso quasi
indipendente da Tolomeo) promette di metterlo sul trono di Cartagine, futura capitale di un suo grande
impero greco-africano. L'ingenuo Ofella raggiunge Agatocle con un esercito di diecimila uomini, ma il tiranno
lo fa trucidare (309 a.C.) e con le nuove milizie di Cirene e le vecchie di Sicilia continua la sua marcia.
Intanto Siracusa, assediata dal nemico, resiste eroicamente, anzi infligge perdite considerevoli ai
Cartaginesi, il cui capo, è ucciso. Mentre continua l'assedio, le città greche dell'isola che sono sotto la
tirannide di Agatocle, capeggiate da Gela ed Agrigento, si proclamano indipendenti.
AGATOCLE capisce che, rimanendo lontano, rischia di perdere la Sicilia; lasciato parte dell'esercito in Africa
sotto il comando del figlio ARCAGATO, con un forte contingente di truppe ritorna nell'isola e doma
ferocemente la rivolta, poi fa vela ancora per l'Africa e punta su Cartagine.
Ma i soldati di Cirene lo abbandonano e passano al nemico; i suoi stanchi di stare in Africa, si ammutinano;
Agatocle si nasconde; scoperto, è fatto prigioniero, ma riesce a fuggire a Siracusa lasciando in balia delle
truppe, che poi li uccidono, i figli Arcagato ed Eraclito.
Costretto e conclusa la pace con Cartagine, Agatocle in Sicilia continua nella sua vita di scelleratezze fino a
quando, padrone di tutta l'isola, già avanti con gli anni, volge le sue mire all'Italia; stringe e scioglie alleanze
con gli Apuli e Iapigi; dà in sposa la figlia LANASSA a PIRRO, re dell'Epiro; assedia ed espugna Crotone,
s'impadronisce d'Ipponio, fa scorrerie sulla costa dei Bruzii, ne cattura la flotta e medita una nuova guerra
contro Cartagine.
Ma la sua ultima ora è suonata: un suo nipote, ambizioso quanto lui, desideroso di regnare, lo fa avvelenare
(289 a.C.). Alla morte di Agatocle l'anarchia succede in Sicilia e la libertà, improvvisamente ottenuta dopo
tanti anni di tirannide, di schiavitù e di degrado, genera l'abuso di libertà, rinascono le discordie intestine, e
n'approfitta Cartagine, che dalla sponda dell'Africa sorveglia gli avvenimenti dell'isola e risuscita le sue
cupidigie.
In non più liete condizioni versano intanto le città dell'Italia meridionale, prima oppresse ed impoverite dai
tiranni siciliani, combattute ora dagli abitatori indigeni e specialmente dai Lucani. Con questi è in continua
lotta Taranto, che, città di mercanti com'è, non potendo da sola frenare l'audacia dei nemici, seguita a
chiamare in aiuto capitani di ventura e truppe mercenarie.
Ad ARCHIDAMO segue - come abbiamo visto - Alessandro Re d'Epiro (zio dell'allora ventenne Alessandro
Magno); ad Alessandro si allea lo spartano CLEONIMO, che viene in Italia al soldo di Taranto e, dopo aver
combattuto contro i Lucani, si allea con gli stessi contro Metaponto.
Abbattuta l'aristocrazia lucana, Taranto spinge la democrazia di quel popolo, che ha aiutato ad acquistare il
potere, contro la città italiota-greca di Turio (o Turi - la odierna Bari).
Turio è una città fondata dai superstiti abitanti di Sibari mezzo secolo circa dopo la distruzione di questa città
da parte di Crotone ed è l'unica colonia greca nel circondario in mano ad un governo aristocratico. Assediata
da un esercito lucano capitanato da STATILIO, Turio non vede altra salvezza che chiedere aiuto a Roma, la
tenace sostenitrice di tutte le aristocrazie dell'Italia meridionale.
Dal giorno che gli ambasciatori di Turio mettono piede nel Senato romano il destino del mezzogiorno d'Italia
è segnato: le legioni di Roma, chiamate in aiuto, andranno in Meridione, ma da quel terreno che bagneranno
con tanto sangue, non torneranno più indietro.
A Roma, i governanti da qualche tempo preoccupati per la politica espansionistica dei Tarantini, e irritati per
il loro intervento a favore di Turi, per entrare in guerra, come pretesto ricorrono ad un incidente vecchio
quanto il mondo: alcune navi romane sconfinano a N del capo Lacinio (od. Capo delle Colonne); era quello il
limite invalicabile delle navi romane, indicato in un trattato bilaterale del 301-303 a.C.
Alle proteste del governo tarantino, non solo le navi Romane superano il limite violando i patti, ma
provocatoriamente, quattro navi entrano dentro il porto di Taranto sfacciatamente in un giorno di gran festa
per la città affacciata sul mare. La popolazione furibonda accorsa sul porto fa a pezzi l'equipaggio,
l'ammiraglio e infine incendia le navi romane.
Era quello che voleva Roma, per iniziare la guerra "Guerra Tarantina" per le sue mire espansionistiche; ed è
il prossimo capitolo, dall'anno 282 al 267 a.C. > > >
Fonti, Bibliografia, Testi, Citazioni:
TITO LIVIO - STORIE (ab Urbe condita)
APPIANO - BELL. CIV. STORIA ROMANA
DIONE CASSIO - STORIA ROMANA
PAOLO GIUDICI - STORIA D'ITALIA
UTET - CRONOLOGIA UNIVERSALE
I. CAZZANIGA , ST. LETT. LATINA,
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
96
+ altri, in Biblioteca dell'Autore
LA GUERRA TARANTINA - PIRRO - LE BATTAGLIE - ROMA UNIFICA (281-267 a. C.)
TURIO ASSEDIATA DAI LUCANI, E' LIBERATA DAI ROMANI - LA FLOTTA ROMANA NELLE ACQUE DI
TARANTO ASSALITA - POSTUMIO, AMBASCIATORE, OLTRAGGIATO DAI TARANTINI - EMILIO
BARBULA CONTRO TARANTO - PIRRO, RE DELL'EPIRO, IN ITALIA - BATTAGLIA DI ERACLEA - PIRRO
MARCIA VERSO ROMA - RITORNO DI PIRRO A TARANTO - PIRRO E FABRIZIO - CINEA A ROMA APPIO CLAUDIO "CIECO" - BATTAGLIA DI ASCOLI - FABRIZIO E IL MEDICO DI PIRRO - PIRRO IN
SICILIA - VITTORIE E CONQUISTE ROMANE NELL' ITALIA MERIDIONALE - RITORNO DI PIRRO IN
ITALIA - BATTAGLIA DI MALEVENTO - PIRRO LASCIA L' ITALIA; SUA MORTE - CADUTA DI TARANTO LA MAGNA GRECIA SOTTO IL DOMINIO DI ROMA - ORDINAMENTO POLITICO D'ITALIA
------------------------------------------------------------------------------------------ORIGINE DELLA GUERRA TRA ROMA E TARANTO
Ritorniamo per un attimo, a ciò che accadeva pochi mesi prima dell'intervento dei Romani in Meridione (e
che abbiamo narrato nelle pagine del precedente capitolo).
Turio (o Turi - l'odierna Bari) la città fondata dai superstiti abitanti di Sibari mezzo secolo circa dopo la
distruzione di questa città da parte di Crotone era l'unica colonia greca nella zona rimasta in mano ad un
governo aristocratico. Fu assediata da un esercito lucano capitanato da STATILIO. A quel punto, Turio non
vide altra salvezza che chiedere aiuto a Roma, la tenace sostenitrice di tutte le aristocrazie dell'Italia centrale
e meridionale.
Roma non aspettava altro che una richiesta d'aiuto da una popolazione meridionale per scendere a sud della
penisola; e agli ambasciatori giunti a Roma, l'aiuto fu subito concesso.
Il console CAJO FABRICIO LUSCINO, con un esercito parte dirigendosi a Turio contro le truppe che
assediavano la città greca; le sorti della battaglia furono subito a favore dei Romani; i Lucani furono
clamorosamente sconfitti e lo stesso STATILIO che li guidava, cadde prigioniero dei Romani. Era l'anno di
Roma 472 - (il 282 a.C.):
A Turio fu lasciato un presidio. Furono le prime milizie di Roma che posero lo sguardo sul Mar Adriatico e
subito dopo sullo Jonio, il manipolo di soldati più lontano della repubblica nel mezzogiorno d'Italia; in una
città, posta in vicinanza di Taranto, città importante, operosa, e spettatrice non indifferente e piuttosto
preoccupata, dei progressi romani verso il sud.
Né del solo presidio di Turio, Roma si accontentò. Quello stesso anno, pur avendo fin dal 453 (301 a.C.)
concluso con Taranto un trattato con il quale si impegnava di non oltrepassare con le sue navi il promontorio
Lacinio (od. (od. Capo delle Colonne), Roma, costretta dalle condizioni precarie in cui si trovava il presidio,
forse anche spinta dalla necessità di inviare navi in Adriatico (ricordiamo che aveva da poco (283) fondato a
sud del territorio dei Senoni, la colonia Sena Gallica - od. Senigallia) inviò una flotta nelle acque dello Jonio e
questa commise l'imprudenza (o volutamente per scatenare le proteste e quindi avere un pretesto) non solo
di superare il promontorio, ma di entrare nel porto di Taranto, sfacciatamente violando i patti.
A Taranto era un giorno di festa, e la popolazione assisteva ai giochi nell'anfiteatro che sorgeva vicino e che
quindi guardava il mare, quando un demagogo, di nome FILOCARI, viste all'orizzonte le navi romane che si
dirigevano al porto, cominciò ad urlare come un forsennato, aizzando il popolo a castigare i violatori del
trattato.
Il popolo tarantino che da qualche tempo odiava Roma per le sue mire espansionistiche e per gli aiuti che
sempre aveva prestato ai governi aristocratici del sud della penisola, sollevatosi a tumulto, si diresse al porto
e assalì le navi che alcune erano già attraccate e altre stavano ancorandosi; uccise l'ammiraglio, catturò la
sua nave, ne affondò un'altra, le altre a stento riuscirono a fuggire lasciando a terra molti uomini fatti subito
prigionieri.
Non appagati da questo gesto, nell'esaltazione bene strumentalizzata dai demagoghi, i Tarantini marciarono
contro la vicina Turio, costrinsero alla resa l'esiguo presidio romano, poi si diedero al saccheggio della città.
Per i Romani tutto questo era un oltraggio -oltre che essere un atto cruento- alla dignità della repubblica e
doveva esser vendicato; ma Roma era ancora impegnata nel nord con i Galli e gli Etruschi e voleva avere le
mani libere prima di cimentarsi con Taranto, suscitando una guerra che avrebbe certamente messo in armi
le colonie greche o richiamate in Italia milizie greche o cartaginesi.
Cercò perciò di guadagnar tempo e mandò un'ambasceria, guidata da POSTUMIO, a chiedere
amichevolmente che si restituissero i prigionieri e la nave catturata, che si sgombrasse Turio e di
consegnare i responsabili dell'offesa.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
97
Ma gli ambasciatori furono accolti con dileggi, ed avendo Postumio pronunciato delle minacce, furono pure
invitati a lasciare subito la città.
Mentre i legati si allontanavano, un tarantino, chiamato FILONIDE, fra le risa di scherno del popolo, imbrattò
la toga di Postumio.
È fama che questi, ripulendo la veste, disse sdegnato: "Per lavare questa macchia spargerete una gran
quantità di sangue e verserete molte lacrime".
Il Senato romano, davanti alla nuova offesa, usò ancora moderazione, ma nel frattempo al console EMILIO
BARBULA, che si trovava nel Sannio, affidò l'incarico di andare a Taranto con le sue legioni a chiedere
soddisfazione alle stesse condizioni proposte da Postumio e, se rifiutate, iniziare le ostilità. Era l'anno di
Roma 473 (il 281 a.C.).
Taranto oppose un reciso rifiuto alle richieste di Roma e la guerra fu ovviamente dichiarata.
All'inizio non ci furono azioni di grande importanza. BARBULA diverse volte si scontrò con i Tarantini
sconfiggendoli, ma non volle sfruttare i successi riportati né spingere la guerra fino in fondo, sperando
sempre che Taranto, intimorita, chiedesse la pace.
Ma forse anche Roma gli aveva raccomandato di agire così; era ancora troppo impegnata a tenere a bada i
soliti nemici, né voleva contro gli eventuali alleati di Taranto(di cui già c'era qualche notizia) subire una
clamorosa sconfitta che avrebbe fatto rialzare la testa ai primi.
PIRRO, RE DELL'EPIRO, IN ITALIA
Taranto invece, non avendo i problemi che assillavano Roma, si preparava a resistere alla pressione
romana e, in quanto ad alleanze, già prima che le ostilità fossero cominciate aveva chiesto soccorsi ad uno
dei più celebrati capitani del tempo. Questi era PIRRO, Re dell'Epiro, nipote di Alessandro Magno e
discendente - come lui affermava - di Achille.
Si era acquistata fama di abile condottiero, aveva fornito prove magnifiche del suo valore nella battaglia d'
Isso, era stato per sette mesi sovrano della Macedonia e, ambizioso anche quanto gli altri, sognava di
conquistarsi un regno con la sua audacia e i suoi talenti militari. Astuto oltre che ardito, si era imparentato
con Agatocle, sposandone, come abbiamo detto, la figlia, ed ora che il suocero era morto, guardava alla
Sicilia, sulla quale accampava diritti in nome di suo figlio.
PIRRO, come Roma, non aspettava altro che qualcuno gli chiedesse aiuto, e accettò con entusiasmo la
richiesta dei Tarantini che gli porgevano l'occasione di tradurre in realtà il suo sogno, e proprio nell'anno 473
(281 a.C. - quando le richieste di Barbulo furono rifiutate) inviò subito in Italia come suo luogotenente,
MILONE con tremila Epiroti affinché aiutassero con un presidio la cittadella di Taranto.
L'anno dopo, PIRRO raggiunse le coste della penisola. Aveva con sé un esercito di ventimila fanti, duemila
arcieri, cinquecento frombolieri, tremila cavalieri e venti elefanti, ma durante il viaggio alcune navi e
numerosi soldati fecero naufragio.
Lui credeva di trovare in Italia un poderoso esercito promesso dalle città greche ed invece non solo non vi
trovò neppure una schiera, ma gli stessi Tarantini si mostrarono meravigliati quando Pirro disse loro che
l'esercito condotto dall'Epiro non era sufficiente ed occorreva arruolare delle truppe mercenarie.
E siccome questa idea non era per nulla gradita a Taranto, che si vedeva costretta a sborsare dell'altro
denaro e a mandare sotto le armi i propri cittadini, Pirro ricorse alla violenza; obbligò i Tarantini validi ad
arruolarsi, acquartierò i soldati nelle case, proibì le adunanze pubbliche, fece chiudere il teatro, i bagni, il
ginnasio e fece custodire le porte della città. Trattò insomma Taranto non come una città alleata, ma come
una città conquistata e mostrò chiaramente di esser venuto non come capo di un esercito mercenario a
servizio di una repubblica di mercanti, ma come un re che voleva insignorirsi dell'Italia e della Sicilia.
Non era questa un'impressione dei tarantini, che ci misero poco a capirlo; perché del resto Pirro a questo
mirava in modo palese.
BATTAGLIA DI ERACLEA (280 a.C.)
L'arrivo di PIRRO in Italia, gli ambiziosi disegni di cui lui non faceva mistero, la fama di guerriero audace e di
abile capitano, gli elefanti che aveva con sé condotti, che nella penisola nessuno fino allora aveva mai visto,
preoccuparono non poco Roma, consapevole della gravità della guerra che doveva sostenere.
Temendo che la presenza del re dell'Epiro provocasse ribellioni nelle città sottomesse o tradimento in quelle
alleate, Roma inviò forti guarnigioni nelle città di incerta fede e obbligò altre a consegnare ostaggi. Fra
queste ultime ci fu Preneste che fu costretta a dare a Roma i suoi magistrati.
Né meno energici furono i preparativi di guerra. Fu messa un'imposta straordinaria di guerra e si chiamarono
sotto le insegne tutti i cittadini idonei alle armi, compresi i proletari. Con tutte le forze raccolte furono formati
quattro eserciti dei quali uno -temendo delle rivolte- doveva restare a Roma --si disse- come riserva, ma in
effetti, era stata messa a guardia della capitale e in pieno assetto di guerra, pronto a intervenire.
Il secondo esercito, comandato da T. CORUNCANIO, doveva essere inviato in Etruria per tenere a bada
quelle popolazioni, il terzo, al comando del proconsole EMILIO BARBULA, doveva recarsi nel Sannio, di cui i
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
98
Romani, nonostante la pace, poco si fidavano, e il quarto, capitanato dal console P. VALERIO LEVINO,
aveva il compito più difficile: quello di marciare contro Pirro.
Questi si era accampato sulle rive del Liri e non dimostrava di aver fretta di dare inizio a una battaglia,
poiché aspettava rinforzi. Tuttavia la posizione che si era scelta era ottima: tra Pandosia ed Eraclea e il
fiume, protetto quindi da un improvviso attacco del nemico; inoltre se i Romani avessero tentato di passare il
fiume avrebbe potuto arrecar loro gravissimi danni.
Il console LEVINO, si rese subito conto quante difficoltà presentasse il guado delle sue legioni sotto la
molestia del nemico e cercò di ovviare a quest'inconveniente. Fece passare per prima la cavalleria in una
località abbastanza lontana dal campo avversario e ordinò di assalire ai fianchi l'esercito di Pirro per tenerlo
impegnato quel tanto per dar dare tempo alle fanterie di guadare il fiume.
Gli ordini del console furono eseguiti con precisione e l'esercito riuscì senza alcuna difficoltà ad effettuare il
passaggio, mentre la cavalleria romana assaliva e teneva impegnato il nemico.
Prese le posizioni, l'urto dei due eserciti e la battaglia ben presto fu generale. Nonostante fosse mercenario
e formato di soldati di diverse nazionalità, l'esercito di Pirro era una compagine salda, composta di veterani
di molte battaglie, che si mostrarono ben degni di stare di fronte ai Romani.
Fu una giornata durissima, con una vittoria sempre incerta; il terreno ceduto da una parte era subito dopo
con accanimento riconquistato dall'altra, lasciandolo ognuno ingombro di morti e di feriti.
Ma a poco a poco il combattimento cominciò a delinearsi a favore dei Romani, soprattutto non per le armi
ma per lo sgomento degli avversari; ciò avvenne quando la cavalleria di Levino avuto il sopravvento su
quella tessalica, cadde un capitano dell'esercito greco, MEGACLE; ma siccome costui indossava
un'armatura simile a quella di Pirro, si sparse la voce che questi era stato ucciso.
La notizia diffusasi a entrambi i due esercito, diede maggior forza ai legionari ma portò allo sgomento le
falangi greche, le quali iniziarono a vacillare, alcune a cedere; a quel punto Pirro intuì la gravissima crisi
morale in cui si trovava l'esercito, e per smentire la falsa notizia che si era diffusa, a capo scoperto per farsi
riconoscere, fu costretto a percorrere tutto il campo di battaglia, incitando le truppe a riprendere con
accanimento la battaglia.
E fu a questo punto, che Pirro per infondere coraggio ai suoi e per ottenere l'effetto opposto ai nemici
romani, improvvisamente diede il segnale di buttare nella mischia della battaglia gli elefanti.
L'aria del campo di battaglia iniziò a risuonare di loro feroci barriti che coprivano ogni altro rumore; sull'alta
groppa di questi animali vi erano torri con dentro arcieri, e mentre gli elefanti avanzavano travolgendo gli
impietriti romani, quelli saettano nugoli di frecce.
La comparsa degli elefanti, atterrì i legionari romani che mai prima di allora avevano visto così imponenti e
terribili animali. Ci fu lo scompiglio nella cavalleria, con i cavalli imbizzarriti, che fuggendo all'indietro
causarono oltre che la confusione il terrore nelle schiere dei fanti, trascinando così pure loro ad una fuga
isterica e disordinata, e incalzati poi dalla cavalleria tessalica, questa, inizia a farne un macello. Pochi minuti
ancora e il disastro delle truppe consolari fu completo.
Ecco il doloroso bilancio della battaglia: dei Romani, morti settemila, prigionieri duemila, feriti quindicimila;
dei Greci, morti quattromila e un gran numero di feriti.
Le gravi perdite subite dai Romani non furono dovute alla novità degli elefanti, ma ci fu quel giorno a Eraclea
un'altra cosa nuova nelle file del nemico (di importanza fondamentale nella storia dell'arte militare). Ci fu il
primo scontro diretto tra falange macedone (adottata dagli Epiroti) e legione romana.
La tecnica piuttosto recente -attribuita a Filippo II di Macedonia- era di disporre in schiere serrate un
contingente di fanteria, il che permetteva la formazione di un vero muro compatto, offensivo e difensivo, di
cui elemento fondamentale era lo scudo. Fu uno dei principali strumenti della strategia macedone, con
Filippo II e suo figlio Alessandro Magno.
PIRRO E FABRIZIO
La vittoria a Eraclea ha premiato Pirro, ma è una vittoria pagata a carissimo prezzo; eppure il re dell'Epiro è
quasi convinto che il suo sogno inizia felicemente a tradursi in realtà.
I Romani dopo la terribile disfatta, hanno sgombrato la Lucania e si sono portati nella Campania e
nell'Apulia, e Pirro - che conosce la situazione in Italia, ma non abbastanza, non è aggiornato- nella
speranza di ribellare i Latini, invia emissari nelle loro città invitandoli ad unirsi a lui.
Ma, con sorpresa, da tutte riceve rifiuti e solo allora Pirro si accorge di avere a che fare con una potentissima
nazione e che gli darà del filo da torcere.
Un'altra speranza però lo sorregge: l'Etruria è in guerra con Roma e l'annuncio della clamorosa sconfitta di
Eraclea darà agli Etruschi forza e coraggio e avrà per conseguenza l'intensificazione delle operazioni alle
frontiere settentrionali dello stato romano.
Con questa speranza Pirro muove il campo e marcia verso Roma conquistando facilmente Fregelle, Anagni
e Preneste, ma, giunto in questa città, un'improvvisa e sgradevole notizia gli toglie molta fiducia: l'Etruria ha
concluso la pace con Roma e l'esercito di T. CORUNCANIO marcia verso il sud.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
99
Né questa è la sola notizia spiacevole: la repubblica compie sforzi giganteschi e prepara altri eserciti che
presto entreranno in azione.
Lo sconforto si sostituisce alla speranza ed alla fiducia. Quantunque vittorioso, Pirro sa di essere in un
paese nemico, di fronte ad un popolo fiero, militarmente forte, risoluto a battersi fino all'ultimo. Non crede
opportuno di rimanere lontano dalla sua base e si ritira a Taranto, dove qui passa l'inverno 474-475 (280-279
a.C.)
Durante questa sosta, giunse a Taranto un'ambasceria, inviata dal Senato per chiedere il riscatto dei
prigionieri. A capo di questa vi era il prode CAJO FABRIZIO LUSCINO e Pirro, sapendo quanto quest'uomo
fosse influente in Roma, pensò di farselo amico e quindi a persuadere il Senato a chieder la pace.
Lo ricevette e lo ospitò pertanto con gran pompa e lo invitò ad un lauto banchetto, poi, rimasto solo con
l'ambasciatore, gli offrì ricchissimi doni e gli promise ingenti somme ed onori se avrebbe esortato i Senatori
alla pace.
Ma Fabrizio non si lasciò corrompere dall'oro né dalle promesse.
"Offri il tuo oro agli schiavi, i quali non hanno amor di patria" - rispose al re.
Non potendo Pirro vincere Fabrizio con l'oro cercò di vincerlo con il terrore. Il giorno dopo l'ambasciatore
romano si trovava nella tenda del re e conversava con lui quando, improvvisamente, un gigantesco elefante
apparve sulla soglia, ed emettendo un terribile barrito, alzò minaccioso la proboscide sul capo di Cajo
Fabrizio.
Anche lui non li aveva mai visti i terribili elefanti, ma rimase impassibile e, rivoltosi a Pirro, gli disse:
"Tu oggi mi vedi quale io ero ieri; e come ieri non mi vinse la potenza del tuo oro così oggi non mi atterrisce
la minacciosa presenza del tuo bestione".
Vedendo che né con le lusinghe né con la paura gli riusciva di piegar l'animo di Fabrizio, Pirro concesse che
i prigionieri della battaglia di Eraclea tornassero a Roma a patto però che se, entro un termine stabilito, il
Senato non avesse concluso la pace, sarebbero ritornati a lui.
Con quest'espediente di fare il generoso, Pirro sperava di accattivarsi l'opinione pubblica romana, e che
questa spingesse a fare trattative di pace. Ma il Senato rimase fermo nel proposito di continuare la guerra e,
scaduto il termine fissato dal re dell'Epiro, pur essendo una decisione affliggente, tenendo fede al patto, gli
rimandò indietro i prigionieri.
Pirro non abbandonò la speranza di riuscire nel suo intento e spedì a Roma CINEA, un tessalo di origine,
suo segretario, uomo astutissimo ed eloquente. Questi, giunto a Roma, prima di fare tentativi presso il
Senato, visitò le case dei più influenti cittadini e si profuse in regali alle loro donne; recatosi poi al Senato,
pronunciò un discorso abilissimo, in cui, dopo aver lodato le virtù militari e civili dei Romani, rinnovò le
proposte del suo re.
Pirro chiedeva che non si attentasse alla libertà delle colonie greche dell'Italia meridionale e che fossero
restituiti ai Sanniti, ai Lucani, ai Bruzii, ai Dauni ed agli Apuli i territori che erano stati a loro strappati,
comprese Venusia e Luceria.
Erano condizioni impossibili. Accettandole, Roma avrebbe rinunziato al sogno di unificare la penisola sotto il
proprio dominio, avrebbe frustrato tanti anni di lotte sanguinose, avrebbe cancellato circa un secolo della sua
storia.
Tuttavia i Senatori rimasero dubbiosi, altri critici nell'agire in un modo o nell'altro. L'eloquenza di Cinea e, più
di questa forse, i doni prodigati in precedenza, stavano forse producendo il loro effetto.
Ma a togliere ogni indecisione, ricomparve sulla scena APPIO CLAUDIO, il cieco, uomo carico di anni, pieno
di autorità e rispettato da tutti. Il suo passato leggendario non era solo leggenda, ma faceva ormai parte
della storia di Roma. Sempre parte di rilievo nei conflitti contro etruschi, sanniti, sabini. Poi c'erano a
ricordarlo le sue opere, il primo acquedotto romano, la via Appia, teatri, basiliche, palazzi; e, pur essendo
patrizio, lui a dare l'accesso al senato ai cittadini di bassa estrazione e ai figli dei liberti.
Oltre le vittorie militari, una volta era stato censore e due volte console, ingraziandosi la parte più povera
della plebe.
Entrato nella Curia, Appio Claudio rivolse parole roventi ai Senatori, vedendoli disposti a discutere le
proposte del nemico, rimproverò duramente la loro viltà, ricordò il valore delle legioni e le passate, gloriose
imprese di Roma e così caldo fu il suo discorso che il Senato, uscito dall'indecisione che tanto fatale poteva
riuscire alla repubblica, rispose che non intendeva discutere nessuna proposta di pace se prima, Pirro, con il
suo esercito, non si fosse allontanato dall'Italia.
ATTAGLIA DI ASCOLI (o di APULIA) (279 a.C.)
Ricominciarono le ostilità e Roma e Pirro intensificarono i loro sforzi per porre fine alla guerra con una
grande vittoria decisiva.
Pirro aveva triplicato il suo esercito. Delle truppe condotte dall'Epiro non gli rimanevano che circa
quindicimila soldati, ma oltre cinquantamila uomini aveva potuto reclutare fra le colonie greche, tra i Lucani, i
Bruzii ed i Sanniti ed ai tremila cavalieri di Tessaglia aveva aggiunti cinquemila cavalieri raccolti in Italia. I
suoi fanti sommavano a quasi settantamila e ad ottomila i cavalieri. Diciannove erano gli elefanti.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
100
Non meno potenti erano le forze romane. La città aveva risposto generosamente all'appello della patria,
offrendo ventimila uomini; mentre gli alleati, Umbri, Arpani, Marrucini, Peligni, Frentani, Latini, Volsci, Sabini,
Campani, avevano fornito oltre cinquantamila soldati. Questo rilevante numero di armati e il rifiuto opposto a
Pirro di ribellarsi dimostrano come Roma in poco tempo avesse saputo imporsi ai suoi alleati e farsi
rispettare e preferire agli stranieri.
Pari di forze alla nemica era la cavalleria romana, e né l'uno e né l'altro esercito poteva vantare la superiorità
numerica. Ma senza dubbio più omogeneo e meglio addestrato da tante guerre era il romano, il quale aveva
inoltre il vantaggio della snellezza della formazione essendo le sue legioni divise in manipoli.
Quello di Pirro invece, era in massima parte formato di gente raccogliticcia e il suo vero nerbo era costituito
dalle truppe d'oltremare, ma la disposizione in lunga e rigida falange toglieva all'esercito elasticità di
movimenti e se lo rendeva saldissimo nella difesa non ne faceva uno strumento ottimo per l'offesa.
Pirro, che conosceva le deficienze delle sue truppe, aveva stabilito di alternare con le sue falangi i soldati
raccolti in Italia e di formare il centro con i suoi Epiroti. Ma era sugli elefanti che lui contava di più, su quegli
elefanti che, salvandolo dalla sconfitta, gli avevano procurato la vittoria ad Eraclea.
I Romani però avevano prese delle misure valide a neutralizzare l'azione degli elefanti ed avevano, per
opporli a loro, appositamente costruito dei carri armati con delle sbarre mobili che sostenevano all'estremità
dei bracieri, avendo appreso che gli animali si spaventavano alla vista del fuoco.
I due eserciti si scontrarono in Apulia presso Ascoli. Comandavano le truppe romane i consoli PUBLIO
SULPICIO e PUBLIO DECIO MURE.
La località dove si svolse la battaglia era boscosa ed accidentata e la cavalleria dell'uno e dell'altro esercito
non riuscì ad esprimersi al meglio, ma accanitissimo fu il combattimento delle fanterie. Il console Mure,
vedendo i suoi piegare davanti agli elefanti, contro i quali non poterono forse esser messi in azione i carri
armati, imitando il padre e il nonno, si offrì in sacrificio per rialzare le sorti dei Romani, ma vu vano e non
terminò allo stesso modo.
Non fu tuttavia una sconfitta come quella di Eraclea. I Romani si ritirarono a poca distanza dal campo, oltre il
fiume di Ausculum e pronti sempre a contendere il terreno al nemico, ma le perdite subite furono più gravi di
quelle del nemico. Seimila legionari rimasero uccisi quelli di Pirro soltanto tremila e cinquecento. Poco
mancò che Pirro non lasciasse la vita sul campo essendo stato ferito ad un braccio da un giavellotto.
È fama che Pirro, dopo la giornata di Ascoli, esclamasse: "Ancora una vittoria come questa e tornerò in
Epiro senza soldati".
Alcuni storici affermano che queste parole furono da Pirro dopo la battaglia di Eraclea; altri affermano che la
battaglia presso Ascoli si combatté con esito incerto e forse hanno ragione questi ultimi perché se Pirro
veramente avesse sconfitto i Romani avrebbe continuato le sue operazioni e non avrebbe indugiato a
conquistar l'Apulia e il Sannio.
Invece il re dell'Epiro rimase inoperoso ed alla sua inazione - dovuta all'incerto esito della battaglia o ad un
successo che per le sue misere proporzioni non poteva chiamarsi vittoria - fece seguito la risoluzione di
troncare la guerra, una guerra difficilissima da sostenere e che ora chiaramente mostrava a Pirro come fosse
inattuabile il suo sogno di abbattere la potenza romana e crearsi in Italia un vasto e stabile regno.
La tradizione attribuisce questa risoluzione alla virtù di FABRIZIO console ed alla cavalleresca riconoscenza
del re dell'Epiro.
Si racconta infatti, che un giorno a Fabrizio si presentò il medico di Pirro e gli propose di avvelenare il suo
sovrano, dietro il compenso di una forte somma di denaro.
Fabrizio, sdegnato, rifiutò l'infame offerta del traditore e informò del fatto Pirro, consigliandolo a scegliere
meglio per l'avvenire le persone su cui doveva riporre tutta la fiducia. Il re, fu commosso dal generoso e
nobile atto del nemico, e restituì -senza riscatto- tutti i prigionieri romani.
PIRRO IN SICILIA (278 a.C.)
Forse nel numero delle leggende dobbiamo mettere anche l'episodio in cui emerge la generosità e
magnanimità di Fabrizio, e seppure questo accadde, sarebbe un'ingenuità voler credere che un atto di
generosità, sia pur grande, prevalesse sui disegni ambiziosi da lungo tempo vagheggiati da Pirro.
La verità è che Pirro aveva perso la fiducia di vincere e la speranza di conseguire i suoi scopi; forse aveva
pure appreso che Cartagine era disposta ad aiutare i Romani e temeva perciò di andare incontro ad una
sconfitta.
Roma infatti, aveva chiesto aiuti ai Cartaginesi contro Pirro, e Cartagine, alla quale non erano ignoti i disegni
che Pirro aveva fatto contro la potente repubblica Africana - per arrecare un grave colpo al re dell'Epiro che
prima o poi sarebbe passato in Sicilia, dove Cartagine era già padrona di Agrigento e della parte
occidentale, aveva prontamente inviato nel porto di Ostia una forte flotta con numerose milizie.
Gli aiuti cartaginesi giunsero quando Pirro aveva già segretamente stipulato un trattato con i Romani con i
quali si obbligava di lasciare l'Italia a patto però che si lasciasse tranquilla Taranto. Fu per questo motivo che
le truppe di Cartagine non furono fatte sbarcare.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
101
Pirro si allontanava dall'Italia spinto da due motivi: l'impossibilità di condurre a termine vittoriosamente la
guerra contro Roma e l'occasione che improvvisamente gli si offriva di insignorirsi della Sicilia.
L'Isola era caduta in gran parte in mano dei Cartaginesi, i quali, assediando Siracusa, stavano per diventare
padroni di tutta l'isola.
A Pirro aveva chiesto aiuti la nobiltà siracusana, e Pirro aveva accettato.
Lasciate in Italia due guarnigioni, una a Taranto comandata da MILONE, l'altra a Locri sotto il comando di
suo figlio Alessandro, Pirro s'imbarcò per la Sicilia.
Sbarcato, gli furono fatte a TAUROMENIO e a Catana accoglienze festose, e i due capi della nobiltà di
Siracusa, SOSTRATO e SENONE, si misero sotto il suo comando. Pirro approdava in Sicilia, accolto come
un liberatore, e fu per questo motivo che gli riuscì di raccogliere molti uomini per l'esercito, e si trovò in grado
di fronteggiare i Cartaginesi. La stessa Agrigento, insorta, cacciò il presidio Cartaginese e inalberò il vessillo
della libertà.
Le imprese di Pirro, fin dall'inizio, furono buone; sconfitti in diversi luoghi, i Cartaginesi furono costretti a
lasciare nelle mani del re molte città e, rimosso l'assedio a Siracusa, fecero ritorno all'estrema punta
occidentale dell'isola.
Reso baldanzoso dalle sue vittorie, Pirro li seguì e investì la piazza forte di Lilibeo
(Marsala). Ma questa resistette e, dopo due mesi d'inutile assedio, Pirro, impaziente, pensò di portare la
guerra in Africa, imitando Agatocle.
Ma non vi riuscì. La flotta cartaginese era incontrastata dominatrice del Mediterraneo e a Pirro, se non
mancavano le navi, facevano difetto i rematori, né i Siciliani vollero prestarsi.
Da allora cominciarono le disavventure del re in Sicilia. Mostrandosi uomo politico poco accorto, Pirro
danneggiò se stesso; estraniandosi dagli abitanti dell'isola, i suoi mercenari vi esercitarono ogni tipo di
violenza.
In poco tempo la sua posizione si rese talmente insostenibile che si vide costretto ad abbandonare la Sicilia
e cercare fortuna altrove.
Nel frattempo, mentre lui si trovava in Africa contro i Cartaginesi (A. di R. 476-478 - 278-276 a.C), importanti
avvenimenti accadevano in Italia.
Roma era tornata in campo contro i popoli del Mezzogiorno. Il console FABRIZIO, nel 476, aveva
vittoriosamente combattuto contro i Lucani, i Bruzii, i Salentini e i Tarentini ed Eraclea, quell'anno stesso, si
era consegnata ai Romani.
Nel 477 il console PUBLIO CORNELIO RUFINO aveva espugnato Locri cacciando il presidio lasciato da
Pirro.
Le operazioni erano continuate nel 478 ed avevano procurato ai Romani, molte vittorie contro i Sanniti, i
Bruzii e i Lucani.
Fu proprio nel 478 che a Pirro giunsero messi dall'Italia meridionale che lo invitavano
di recarsi in Puglia. Il re lasciò la Sicilia, dopo averne saccheggiato parecchie città, portandosi dietro un
ricchissimo bottino; ma nel passare lo stretto ne perdette una buona parte insieme con sessanta navi
affondategli dai Cartaginesi.
Gli riuscì alla fine di approdare nella penisola. Ma questa volta Pirro entrava in Italia come un avventuriero
senza cuore e senza scrupoli, e per giunta preceduto dalla fama degli insuccessi navali e delle violenze da
lui commesse sulle popolazioni siciliane.
BATTAGLIA DI MALEVENTO (275 a.C.) - SCONFITTA DI PIRRO
Fra Reggio e Locri, PIRRO fu assalito dai Mamertini. Entrato a Locri, non rispettando le cose sacre,
saccheggiò il ricco tempio di Proserpina, asportandone i tesori in questo contenuti, poi s' imbarcò per
Taranto.
La ricomparsa di Pirro in Italia, preoccupò non poco Roma. Sapendo che tipo di nemico era, chiamò i
cittadini alle armi; molti però si rifiutarono di arruolarsi e la repubblica si vide costretta ad obbligarli
confiscandone i beni.
Le riuscì alla fine di formare due eserciti che affidò al comando dei consoli MANIO CURIO DENTÁTA e
LUCIO CORNELIO LENTULO; il primo si recò nel Sannio, il secondo nella Lucania.
PIRRO, con mossa rapida, cercò di impedire che le forze dei due consoli si congiungessero, e volle
combatterle e batterle separatamente.
Con una veloce marcia trasferì il suo esercito nel Sannio e, appreso che l'esercito nemico si era accampato
sulle alture di Malevento, cercò di sorprenderlo di notte; ma al campo romano si faceva buona guardia e,
fallito il tentativo, Pirro si accampò nella pianura.
Qui lo assali CURIO DENTATO come una furia, deciso di vendicare le sconfitte che i Romani avevano
ricevute, e la battaglia fu molto accanita. Da entrambe le parti si combatté fino all'estremo delle proprie forze;
questa volta però i legionari non si lasciarono sgomentare dagli elefanti; anzi, appena entrarono nella lotta,
cominciarono a tempestarli di saette roventi, che era l'unico modo per far perdere il controllo di chi li
governava.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
102
L'effetto di queste armi fu micidiale: feriti dai dardi, gli elefanti si misero in fuga come impazziti, e arretrando
sfogarono il loro furore contro le stesse schiere di Pirro, causando una babele, nella falange, nella fanteria e
nelle riserve.
I Romani poi fecero il resto; si slanciarono furiosamente contro il nemico e lo sbaragliarono procurandogli
enormi perdite. A Malevento, che da allora prese il nome di Benevento furono fatti prigionieri mille e trecento
Epiroti e catturati quattro elefanti.
Quelli e questi, CURIO DENTATO nel far ritorno a Roma a godersi i Fasti trionfali, li condusse a Roma come
trofeo; diverso dai soliti, perché a Roma mai nessuno aveva visto nella sua vita gli elefanti. Ma anche gli
Epiroti destarono l'ammirazione, finalmente vedevano da vicino gli uomini della "Falange Macedone" resa
famosa da Alessandro Magno. L'orgoglio di vederli sfilare prigionieri di Roma, diede l'impressione a molti che
Roma, stesse superando la fama del macedone, e che i Romani avevano davanti a sé un avvenire
affascinante, con tante altre battaglie invincibili.
Ingente fu anche il bottino conseguito e il denaro da questo ricavato fu impiegato per la costruzione
dell'acquedotto che porta le acque dell'Aniene, da Tivoli a Roma.
MORTE DI PIRRO E CADUTA DI TARANTO
La vittoria di CURIO DENTATO fu decisiva per le sorti della guerra e della stessa sorte di Pirro. Rimasto con
un esercito debolissimo e demoralizzato, cercò aiuti in Macedonia; ma nessuno lo ascoltò e nessuno si
mosse. L'Italia per lui era perduta per sempre. Decise allora di cercar fortuna in Grecia, ma non volle
abbandonare del tutto la penisola, forse sperando in un avvenire migliore.
Lasciato a Taranto una piccola guarnigione al comando di MILONE, Pirro fece vela per la Grecia, dove
guerreggiò per tre anni in un conflitto con ATIGONO GONATA re di Macedonia, e con una serie di fortunate
operazioni gli sottrae gran parte del regno; ma non raggiunse mai lo scopo di tutte le azioni della sua vita: un
vasto e potente impero.
Non aveva compiuti ancora i cinquant'anni quando nel 482 (272 a.C.), ad Argo, mentre proseguiva le
operazioni militari, una tegola lanciatagli per vendetta da un'anonima donna lo colpì in pieno e gli troncò la
vita e le speranze.
Gli successe il figlio, Alessandro II, ma questi in breve perse il controllo di tutte le regioni greche e macedoni
conquistate dal padre.
Morto Pirro, la situazione di MILONE a Taranto divenne insostenibile. Un bel giorno nel golfo di Taranto fece
la sua comparsa una flotta cartaginese. Erano stati i Tarentini a chiamarla, perché li aiutasse a cacciare il
presidio epirota.
MILONE però consegnò la cittadella al console romano PAPIRIO che si trovava poco lontano dalla città con
numerose milizie, e così Taranto cadde in potere dei Romani, i quali costrinsero poi i Cartaginesi ad
allontanarsi e lasciarono partire Milone con il presidio.
Papirio fece subito smantellare le mura della città, le impose un tributo di guerra e gli sottrasse tutte le armi e
le navi.
Queste ultime, furono utilizzate per caricare tutto ciò che c'era di bello, e che ornava la ricca e opulenta
Taranto; stupende statue dell'arte greca, pregevoli quadri, oggetti preziosi, ogni cosa di gran valore, fu
inviato tutto a Roma, che in certi ambienti, stupirono più che gli elefanti.
Ma la cosa più importante, fra le tante meraviglie, e tanti oggetti d'arte, a Roma giunsero anche i "cervelli", i
matematici, i filosofi, i letterati.
Basta qui ricordarne uno: fra i prigionieri tarantini condotti a Roma vi era LIVIO ANDRONICO; aveva già 68
anni. E' considerato l'iniziatore della LETTERATURA LATINA. Introdusse la drammatica, e fu lui con la
traduzione dal greco dell'ODISSEA a far conoscere ai Romani l'Epica greca.
Forse per questo motivo Roma si astenne dal fare a Taranto vendette, di infliggere punizioni, e mise la città
nel novero delle alleate.
LA MAGNA GRECIA SOTTO IL DOMINIO DI ROMA
Subito dopo la conquista di Taranto, la repubblica volse l'attenzione a Reggio, nella quale da alcuni anni era
stata inviata come presidio una legione campana. Questa però, approfittando della guerra nella quale Roma
era impegnata, si era da sola insignorita del governo della città e non solo spadroneggiava, ma non
rispondeva più a Roma.
A punire i ribelli fu mandato un esercito comandato dal console GENUCIO; ma non fu impresa breve e facile.
I legionari che erano diventati padroni, consapevoli della sorte che era loro riservata, si erano preparati bene
e si difesero disperatamente per un anno intero; ma alla fine, rimasti in meno di trecento, furono costretti a
cedere di fronte alla superiorità dei loro ex commilitoni e nel 483 (271 a.C.) Reggio fu presa d'assalto.
La punizione dei ribelli fu esemplare. Fatti prigionieri e condotti a Roma, i trecento furono prima nel Foro
flagellati, poi decapitati.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
103
Dopo Reggio ad uno ad uno, tutti i popoli del Mezzogiorno, Lucani, Bruzii, Calabri, Picentini si sottomisero e
l'ultima resistenza dei Sanniti fu definitivamente domata.
Lo stesso avvenne di tutte le città della Magna Grecia. L'ultima città a cadere in mano dei Romani fu
Brundisium (Brindisi) nel Salento, che fu costretta alla resa e occupata nel 487 (267 a.C.).
I Romani già avevano prolungato (dopo la battaglia di Malevento) la via Appia da Capua fino alla ribattezzata
Beneventum, ora la fanno proseguire fino a Brindisi, per assicurarsi una via di penetrazione verso le regioni
della Magna Grecia (ma fra breve in Illiria, poi nella stessa Grecia).
L'UNIFICAZIONE
In questo stesso anno, l'unificazione della penisola era un fatto compiuto e il territorio sotto il dominio di
Roma si estendeva per 130.000 chilometri quadrati da Rimini a Reggio.
Ingrandito il suo territorio, Roma estese il suo sistema coloniale: colonie furono inviate nel Sannio a
Beneventum nel 268 a.C. ed Aesernia nel 263 a.C., nel Piceno (Ariminum nel 268 a.C. e Firmum nel 264
a.C.), nell'Etruria (Alsium nel 247 a.C. e Fragenae nel 245 a.C.) e nell'Umbria (Aesis nel 247 a.C. e
Spoletum nel 241 a.C.).
Le vie consolari esistenti furono migliorate e prolungate e ne furono costruite delle nuove: Roma e Rimini
furono allacciate dalla Via Flaminia.
ORDINAMENTO POLITICO DELL'ITALIA
Roma non soltanto riuscì a mettere sotto la sua sovranità per mezzo delle sue armi tutta la penisola, ma
seppe anche riunire i vari popoli e le numerose città in un organismo vitale e potente, in uno stato di cui essa
fu il centro motore, la capitale, la signora, che aveva diritto di fare guerra, di stipulare trattati e di coniare
monete.
Tutto il resto della penisola rappresentava il corpo della repubblica, con un assetto politico che variava da
città a città, ma con doveri precisi verso il centro, e con diritti che costituivano quasi una scala graduale di
premi o di punizioni, che però non potevano ergersi al disopra dei diritti supremi riservati a Roma e con
questi contrastare o recar danno.
Di varie specie erano le città della penisola, le quali furono classificate nel modo seguente:
1° I MUNICIPI. Erano questi di due categorie; alla prima appartenevano quei comuni i cui abitanti avevano
gli stessi diritti di quelli di Roma; alla seconda quelli che avevano tutti i diritti meno quello di suffragio. I
municipi della seconda categoria avevano magistrati locali, un proprio Senato e comizi.
2° COLONIE LATINE. Erano autonome, ma gli abitanti non avevano tutti i diritti di cittadinanza romana. A
capo di queste stavano due pretori o duoviri.
3° COLONIE ROMANE. Godevano d'autonomia, ma il governo era sotto la diretta sorveglianza di Roma. I
coloni potevano, recandosi a Roma, esercitarvi tutti i diritti di cittadinanza.
4° CONCILIABOLI. Erano nuclei di cittadini romani, che vivevano fuori dei municipi e delle colonie e
dipendevano dai magistrati di Roma.
5° FORI. Colonie romane fondate sulle grandi vie di comunicazione (Es. Forum Flaminii).
6° CITTÀ FEDERATE. Queste erano di due categorie. Quelle della prima avevano parità di diritto, quelle
della seconda no. Le città federate con l'andar del tempo furono considerate come veri e propri municipi.
7° PREFETTURE. In queste la giustizia era esercitata da un prefetto, che Roma vi mandava ogni anno
8° CITTÀ DEDITIZIE. Erano completamente soggette e presidiate da soldati di Roma alla quale pagavano
tributi e consegnavano ostaggi.
Questo assetto politico fu dato progressivamente, a mano a mano che Roma attirava a sé popoli o li
assoggettava, ed è il documento più eloquente del cammino percorso dalla repubblica in cinque secoli
d'esistenza.
Non è un assetto perfetto, perché la penisola non è una nazione i cui elementi siano perfettamente fusi in
uno. Anzi per evitarla questa fusione per questo è vario l'assetto politico; ma se questo ha lo scopo di
disgregare gl'interessi, di impedire coalizioni, di proibire intromissioni straniere, di tenere a freno le città di
dubbia fede, mostra anche in modo chiaro il proposito di fare scomparire con il tempo la diversità di
fisionomia e fare della penisola una compagine salda che pensi, viva, operi in comunità d'intenti e d'ideali
con Roma e sotto la guida di Roma.
Ma oltre a questa unificazione, a questo assetto, il fattore più importante è che Roma, ora affacciata su tre
mari, diviene una potenza mediterranea a tutti gli effetti. Una situazione che da questo momento accresce
enormemente i motivi d'attrito con l'altra potenza finora in questo mare egemone: la Cartaginese.
Dagli attriti alla guerra il passo è molto breve
e il passo da Roma fu fatto quasi subito dopo l'ultima conquista nella Magna Grecia.
Passiamo appunto al periodo dall'anno 265 al 241 a.C. > > >
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
Fonti, Bibliografia, Testi, Citazioni:
TITO LIVIO - STORIE (ab Urbe condita)
APPIANO - BELL. CIV. STORIA ROMANA
DIONE CASSIO - STORIA ROMANA
PAOLO GIUDICI - STORIA D'ITALIA
UTET - CRONOLOGIA UNIVERSALE
I. CAZZANIGA , ST. LETT. LATINA,
+ altri, in Biblioteca dell'Autore
F. D’Alessi © 2002
104
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
105
Bibliografia
===========
M
Sulla storia romana:
The Cambridge Ancient History, a cura di Bury - Cook - Adcock - Charlesworth; tr. it. Storia antica,
Milano 1967 segg. (19892 segg.).
A.Momigliano - A. Schiavone, Storia di Roma, Torino 1988-1993.
L. Pareti, Storia di Roma, Torino 1952-1961.
==========
Mariotti
AL Anthologia Latina, Riese 2
CRF Comicorum Romanorum Fragmenta, Ribbeck 3
FIRA Fontes iuris Romani antesiustiniani, Riccobono
FPL Fragmenta poetarum Latinorum, Morel e Blansdorf
FPL Fragmenta poetarum Latinorum, Morel, Blansdorf, Buechner, 1995
GRF Grammaticae Romanae fragmenta, Funaioli e Mazzarino
HRF Historicorum Romanorum reliquiae, ed. H. Peter,1, Leipzig 18701, 12 Leipzig 1914 e 2,
Leipzig 1906, rist. Stuttgart 1967 e 1993 (riv. J. Kroymann - W. Schaub).
ORF Oratorum Romanorum fragmenta, ed. H. Malcovati, Torino 19663.
PLM Poetae Latini minores, Baehrens-Vollmer
TRF Tragicorum Romanorum fragmenta, Ribbeck 3.
H. Funaioli, Grammaticae Romanae Fragmenta, I, Leipzig, Teubner, 1907.
A. Mazzarino, Grammaticae Romanae fragmenta aetatis Caesareae, 1, Torino 1955.
Paolo Cugusi, Epistolographi Latini minores. voll. 2, Padova, 1970-79.
Hermann Peter, Historicorum Romanorum reliquiae, II, Stuttgard, Teubner, 19672.
===================
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
106
Primi documenti
Inserire carta con popolazioni Italia dal X secolo.
I Protolatini, indoeuropei originari dell’Europa centrale, entrarono in Italia verso la fine del II
millennio a.C. e giunsero nel territorio del Lazio circa nel X secolo e fondarono diverse comunità
ciascuna parlante dialetti similari.
I primi documenti scritti relativi alla lingua latina si possono identificare in iscrizioni epigrafiche di
varia natura, le più antiche delle quali risalgono alla fine del VI secolo, e pertengono al territorio di
Faleri (civita Castellana) e Preneste, dove si parlano i dialetti latini più vicini a quello di Roma..
Solo con il 338 a.C. Roma ridusse ad alleati soggetti le popolazioni latine e sabine vissute nel
Lazio fin dal X secolo.
Inserire carta con popolazioni Italia centrale.
Iscrizioni
I più antichi testi epigrafici latini furono scoperti solo alla fine del secolo XIX; nel 1871 la fibula
prenestina, nel 1880 il vaso di Dueno e nel 1899 il cippo del Foro con iscrizione bustrofedica.
Le iscrizioni più antiche risalgono alla fine del VI secolo o agli inizi del V, ma una regolarità nel loro
utilizzo e soprattutto nella loro conservazione in numero significativo si ha sostanzialmente solo
con il III secolo a.C..
Mancano norme scrittorie, quindi uniformità, non solo nei caratteri (l’alfabeto latino arcaico è molto
vicino a quello greco-calcidico della Campania e non poche sono le mediazioni etrusche, come
quella dell’utilizzazione di un unico segno, C, per C e G), ma anche nell’andamento del verso,
destrorso, sinistrorso, o bustrofedico, (cioè da sinistra a destra e da destra a sinistra, come
l’andamento dei buoi durante l’aratura).
Come è lecito aspettarsi da un popolo in rapporto con vicini almeno sotto questo aspetto più
evoluti e attivi non sono infrequenti commistioni di forme dialettali diverse.
Si nota già una tendenza ad assonanze ed alliterazioni, caratteri questi che avranno in tutto il
periodo arcaico, anche nelle forme letterarie più evolute, una diffusione notevole.
Bibliografia
Corpus Inscriptionum Latinarum consilio et auctoritate Academiae litterarum Borussicae editum,
Berolini. (vedi in Appendice le materie dei singoli volumi).
Inscriptiones Latinae Selectae, edidit H. Dessau, Berolini 1892-1916 (1954-55).
De Ruggiero, E., Dizionario epigrafico di antichità romane (Roma 1886-).
A.Degrassi, Inscriptiones Latinae liberae rei publicae, Firenze 1963-65.
E. Diehl, Altlateinische Inschriften, Berlin 19645.
A. Ernout, Recueil de textes latins archaiques, Paris 19673.
V. Pisani, Testi latini arcaici e volgari con commento, Torino 19602.
Remains of Old Latin, 4, Archaic Inscriptions, ed. E.H.Warmington, Loeb, London Cambridge
Mass., 1960.
C. Carena, Iscrizioni latine arcaiche, Firenze 1954 (scelta con tr. It.)
A. De Rosalia, Iscrizioni latine arcaiche, Palermo 1972, 19782..
Per notizie di orientamento e bibliografia di base sull'epigrafia I. Calabi Limentani, Epigrafia latina,
Milano, Ist. Edit. Cisalpino, 1967, 1991 sembra la più aggiornata, sempre Cisalpino)
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
107
. controllo ICCU ristampe
L. Braccesi, Appunti di epigrafia latina, Pàtron, Bologna, 1966
Susini, Giancarlo, Roma : Jouvence, c. 1982
Susini, Giancarlo, Il lapicida romano : introduzione all'epigrafia latina, Bologna : [s. n.], 1966
(Bologna : Arti grafiche Tamari)
Donati, Angela, Epigrafia romana : la comunicazione nell'antichità, Bologna : Il mulino, [2002]
Cercare di nuovo Internet Manuale epigrafia latina più aggiornato.
Ricerca estremi ICCU per S. RODA, Le fonti epigrafiche latine
S. RODA, Le fonti epigrafiche latine, in Storia antica. Come leggere le fonti a cura di L.Cracco
Ruggini, Bologna 2000, pp.185-224.
ICCU Iscrizioni latine arcaiche generale
Iscrizioni latine arcaiche / [a cura di Carlo Carena]
Firenze, Fussi e Sansoni, Il melagrano, 1954
Testo originale a fronte
Titolo: Inscriptione latinae antiquissimae selectae : (Iscrizioni latine arcaiche) : [testo latino con
traduzione italiana a fronte] / a cura di Carlo Carena
Ed. Fussi e Sansoni, Il melagrano, 1954 (Sancasciano Val di Pesa, Tip. F.lli Stianti.
Iscrizioni latine arcaiche / a cura di Antonino De Rosalia
Palermo : Palumbo, Hermes, 1972
Contiene i testi originali tradotti e annotati.
Soggetti: Iscrizioni latine - Sec. 7.-1. a. C.
Iscrizioni latine arcaiche / a cura di Antonino De Rosalia
Palumbo, Hermes, 2. ed. riveduta, stampa 1978
Riposati
Da questi esempi e da altri, che potremmo addurre, appare evidente che non si può parlare ancora di
letteratura e di arte. Siamo dx fronte a testimonianze che interessano esclusivamente la stona della lingua
nella sua fase originaria, con la formazione del suo alfabeto sotto l'influsso di quello greco-calcidico della
costa campana dell'ltalia meridionale, con i suoi arcaicissimi fenomeni fonetici e morfologici, con la
commistione di forme dialettali di varia natura. Giova tuttavia osservare che già qui si awerte una spiccata
tendenza a certi procedimenti tecnici di strutture e a certe forme di assonanze e di allitterazioni, che si
risentiranno a lungo nell'evoluzione storica della lingua latina.
La fibula Praenestina
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
108
L'iscrizione, su una spilla aurea ritrovata in una tomba a Preneste nel 1871, è una delle più antiche
iscrizioni latine e risale forse anche al secolo VII; è sinistrorsa, con lettere molto arcaiche.
MANIOS:MED:FHE:FHAKED:NUMASIOI.
Manio mi fece per Numasio (=Numerio).
La lingua presenta molti influssi della lingua osca, come ci si può aspettare da un manufatto
proveniente da Preneste, ai confini, appunto, con l’area linguistica osca.
MANIOS è forma di nominativo singolare maschile, con l’antica terminazione in –OS
MED è forma di accusativo singolare pronominale, con l’antica terminazione in –D, poi caduta sia
all’accusativo, sia all’ablativo
FEFACED è perfetto a raddoppiamento e sta per FECIT .
NUMASIOI è forma arcaica di dativo.
La fibula è conservata al Museo di Villa Giulia di Roma. (Museo Preistorico-Etnografico Pigorini di
Roma per Bettini).
La sua autenticità è stata seriamente messa in dubbio a partire dai primi del 900, e dopo gli studi di
M. Guarducci molti sono a sostenere che si tratti di un falso. Altri studi provano comunque l’utilizzo
di materiali e strumenti non antichi nella lavorazione del manufatto.
Ricerca Internet per iconografia
Bibliografia
Il testo dell'iscrizione è in CIL 1, 3; ILS 8561; ILLRP 1; Pisani Testi A 3.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
109
M. Guarducci, La cosiddetta fibula prenestina. Antiquari, eruditi e falsari nella Roma dell'Ottocento,
Roma 1980 (Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di scienze morali,
storiche e filologiche. Serie VIII - Volume XXIV, fascicolo 4). (per la falsità)
M. Guarducci, La cosiddetta fibula prenestina. Elementi nuovi, Roma 1984 (Atti della Accademia
Nazionale dei Lincei. Memorie, Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie VIII - Volume
XXVIII, fascicolo 2).
M. Guarducci, Nuova appendice alla storia della "Fibula prenestina", "Rendiconti dell'Accademia
Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche", ser. IX, 2 (1991), pp. 139146.
H. Solin, Epigrafia repubblicana. Bilancio, novità, prospettive, "XI Congresso Internazionale di
Epigrafia Greca e Latina. Roma, 18-24 settembre 1997. Atti", I, Roma 1999, p. 397
(per autenticità
==========
modificare in senso semplificante o eliminare
La bibliografia sulla fibula Praenestina è sterminata; mi limito qui a riportare, in ordine cronologico,
una scelta di contributi posteriori alla pubblicazione della monografia di A.E. Gordon, The Inscribed
Fibula Praenestina. Problems of Authenticity, Los Angeles 1975, nella quale si troverà un'utile
messa a punto dello status quaestionis precedente; dai titoli citati credo sarà agevole risalire ad
altri contributi rilevanti sul soggetto.
F. Lo Schiavo, La "Fibula prenestina": considerazioni tipologiche, "Bullettino di Paletnologia
Italiana", 82 (1975-1980), pp. 287-306.
D. Ridgway, Manios Faked?, "Bulletin of the Institute of Classical Studies", 24 (1977), pp. 17-30.
G. Colonna, Ancora sulla fibula prenestina, "Epigraphica", 41 (1979), pp. 119-130.
E.P. Hamp, Is the fibula a Fake?, "American Journal of Philology", 102 (1981), pp. 151-153.
R. Lazzeroni, Nota sulla fibula prenestina, "Studi Classici e Orientali", 31 (1981), pp. 227-232.
H. Krummrey, Die Fibula Praenestina als Fälschung erwiesen?, "Klio", 64 (1982), pp. 583-589.
C. Truempy, La fibule de Préneste. Document inestimable ou falsification?, "Museum Helveticum",
40 (1983), pp. 65-74.
G. Radke, Zur Echtheit der Inschrift auf der Fibula Praenestina, "Archäologisches
Korrespondenzblatt", 14 (1984), pp. 59-66.
E. Campanile, Pe:parai modello di fhe:fhaked? (Nota sulla iscrizione della Fibula Praenestina),
"Studi Classici e Orientali", 36 (1986), pp. 13-16.
R. Wachter, Altlateinische Inschriften. Sprachliche und epigraphische Untersuchungen zu den
Dokumenten bis etwa 150 v. Chr., Bern 1987, pp. 55-65.
E. Formigli, Indagini archeometriche sull'autenticità della fibula Prenestina, "Mitteilungen des
Deutschen Archäologischen Instituts (Römische Abteilung)", 92 (1992), pp. 329-343.
M. Guarducci, Per la storia dell'Istituto Archeologico Germanico. 1. 1887: la Fibula Prenestina e
Wolfgang Helbig, "Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts (Römische Abteilung)",
92 (1992), pp. 307-313.
M. Guarducci, Per la storia dell'Istituto Archeologico Germanico, "Rivista di Filologia e Istruzione
Classica", 121 (1993), pp. 110-117.
F. Delpino, La Fibula prenestina contesa fra due musei, "Strenna dei Romanisti", 59 (1998), pp.
95-116.
"Principi etruschi tra Mediterraneo ed Europa", Venezia 2000, pp. 325-326 (scheda nel catalogo
della mostra, a cura di E. Mangani).
annuncia uno studio a sostegno dell'autenticità della fibula. Sembra dunque che il dibattito intorno
a questo discusso documento continuerà ad essere vivace anche nei prossimi anni.
=========
Riposati
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
110
La Fibula Praenestina: una spilla d'oro, rinvenuta in una tomba di Praeneste (Palestrina). Nellabrevissima
iscrizione, in caratteri greci, procedenti da destra a sinistra, figura il nome dell'artefice e del destinatario:
Manios mel fheShaked Numasioi= Manius me fecit Numerio (" Manio mi fece per Numerio )>; parla la spilla).
L'arcaicità provinciale dei fenomeni linguistici ci riporta ad epoca assai remota, al VII o VI sec. a. C.
ICCU Niente per soggetto fibula praen- pren-estina
Il cippo del Foro Romano
E’ un cippo quadrangolare di tufo con un’iscrizione bustrofedica (che procede dall’alto in basso e
viceversa) sulle quattro facce, per circa una trentina di parole. Fu scoperto nel 1899, sotto il
cosiddetto Lapis Niger , un frammento di pavimentazione (verosimilmente resto di un piccolo
tempio a Vulcano) che si riteneva contrassegno della tomba di Romolo e con il nome del quale
spesso viene indicato.
La datazione è incerta e oscilla tra la fine del VI e la metà del V secolo a.C..
Diverse le interpretazioni (privilegi del rex sacrorum, legge di Tarquinio Prisco in saturni, legge di
Tarquinio il superbo sui bottini di guerra).
Testo (Semi)
QVOI HON ………..
…………. SAKROS ES
ED SORD………..
..........IA.....IAS
RECEI L ...........
..............EVAM
QVOS R ………….
…..M KALATO
REM HA(PEA
T)OD IOVGMEN
TA KAPIADOT AV...
M ITER PE....
.... M QVOIHA
VELOD NEQV….
….OD IOVESTOD
OIQVI OD ….
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
111
Traduzione in latino classico con integrazioni (Semi)
cui hon(orandi
Manes) sacros erit sor(titio) …
……. ia.. ias
regi l ……
……………. evam
quos r……
…m calatorem ha(beaat) iumenta capiat au(te)m iter p(ergat) ..m cuija
velit neque
….t iusto
( c )uique ut(ile)
Traduzione (di chi?)
Chi romperà o profanerà questa pietra sarà vittima di Giove.
Per chi farà lordume, la multa sarà di trecento assi…
L'esazione della multa competerà al re.
Quando il re li guiderà al rito, gli auguri condotti ordinino al suo banditore di bandire questi ordini:
se qualcuno giunge con giumenti, prenda i giumenti dal giogo, finchè re ed auguri proseguano,
secondo il rito, il loro cammino.
Se dal ventre di un giumento cadrà lordume e non sarà disciolto sarà colpa, se sciolto sarà di retto
auspicio sicuramente.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
112
Bibliografia
Riposati
Il cippo del Foro Romano (sotto il Lapis niger), di tufo, quadrangolare, scoperto nel 1899: reca sulle quattro
facce una scrittura greca assai mútila, a sistema bustrofèdico (da sinistra a destra e viceversa,
alternativamente), di data controversa (circa la fine del VI sec. a. C.) e di dubbia interpretazione. Delle circa
trenta smozzicate parole rimaste poche soltanto sono piú o meno intelligibili(l);
Palmer 76-77
Internet da utilizzare
Il nome Lapis Niger deriva dal marmo nero presente in questo recinto delimitato da lastre di marmo
posizionate verticalmente, il tutto per ricordare il luogo dove si presume sia stato ucciso Romolo dai senatori
a causa del suo dispotico esercizio dei poteri. Riprendendo la tradizione letteraria, sappiamo che Romolo
venne ucciso presso un santuario dedicato al dio Vulcano, per cui è stato possibile identificare i resti arcaici
rinvenuti negli scavi svolti nel 1899. In questi scavi infatti erano stati trovati i resti di un complesso
monumentale composto da una piattaforma su cui si trovano un altare di tufo a tre ante è un basamento
circolare destinato con buona probabilità a sostenere una statua e un cippo dalla forma trapezoidale sui cui
lati era inciso un testo in latino arcaico con andamento detto bustrofedico (alternativamente dall'alto in
basso e dal basso in alto). Sembra che sul testo ci fossero riferimenti a una qualche forma di legge sacra
per regolamentare i riti da svolgere presso l'altare dedicato a Vulcano, il tutto sotto il controllo del re. In ogni
caso il tipo di caratteri di questo testo ha portato a datarlo all'età regia, quindi intorno al VI secolo a.C.
Dalle ultime ricerche effettuate è stato escluso che questo fosse il luogo di sepoltura di Romolo.
Riportata qui di fianco potete vedere una ricostruzione ipotetica del Lapis Niger:
1) la piattaforma con altare ad ante in blocchi di tufo privo della parte superiore
2) colonna dalla forma tronco-conica che doveva presumi bilmente servire a sostenere una statua (o di
Romolo oppure del dio Vulcano al quale era probabilmente dedicato anche l'altare).
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
3) il cippo di tufo dalla forma trapezoidale, anch'esso privo
latino arcaico
di epoca regia (VI secolo a.C.)
113
della parte superiore recante l'iscrizione in
Altro Internet da utilizzare
DESCRIZIONE: Si ritiene che fosse l'antichissimo santuario di Vulcano nei pressi del quale Romolo
scomparve efu ritenuto un luogo nefasto e quindi segnato, in età sillana, da una pavimentazione in marmo
nero cinto da una transenna (da cui il nome Niger Lapis). Il luogo trova menzione anche in un passo mutilo
di Festo. Attraverso una scaletta si perviene alla zona dove furono effettuati gli scavi che hanno rilevato un
complesso monumentale di epoca arcaica costituito da una piattaforma dove si collocava l'altare. Nelle
vicinanze di questo altare vi era una colonna, o forse la base di una statua, e un cippo di cui si conserva
l'iscrizione in latino arcaico. Attualmente sono visibili i resti della presunta colonna e del cippo con
l'iscrizione. L'iscrizione contiene diverse informazioni, ma l'unica frase di senso compiuto afferma: "chiunque
violerà quesrto luogo sia consacrato agli dei infernali, in COARELLI, cit, pp. 50-51
[Roma arcaica. I quadratini indicano i santuari, i pallini le tombe. La città entro le mura Serviane
era divisa in quattro regioni urbane, secondo il tracciato delle linee tratteggiate Fonte: F.Conti,
Atlante dell’antica Roma, Novara, De Agostini, 2002, p.15. BCTV]
ICCU Niente per soggetto Lapis niger
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
114
Intratext ?
Ricerca Internet anche iconografica
Il vaso di Dueno
Il vaso di Dueno, a tre scomparti, fu ritrovato a Roma nel 1880. Può essere datato tra il VI secolo e
i primi decenni del successivo.
Eccone il testo:
[Testo da Concentus]
IOVESAT DEIVOS QOI MED MITAT NEI TED ENDO COSMIS VIRCO SIED
ASTED NOISI OPETOITESIAI PAKARI VOS
DUENOS MED FAKED AN MANOM EINOM DUENOI (?) NE MED MALO STATOD
[Testo da Bettini]
IOUESAT DEIUOS QOI MED MITAT NEI TED ENDO COSMIS VIRCO SIED
†ASTED NOISI OPE TOITESIAI† PAKARI VOIS
DUENOS MED FECED EN MANOM †EINOM DUENOI† NE MED MALO STATOD
A lungo DVENOS è stato interpretato come nome dell’artigiano autore del vaso, ma ora lo si
intende come aggettivo sostantivato, quindi “persona buona”..
L’interpretazione non è tuttora chiara e concorde, soprattutto per quanto concerne la seconda
parte.
Si è pensato a un contenitore per un filtro d’amore con relative istruzioni.
Eccone una versione in latino classico con relativa traduzione:
[1] iurat divos qui me mittat ne in te comis virgo sit
"chi mi offre scongiura che la fanciulla non ti sia favorevole"
[2]
pacari vis
…………………….vuoi essere appagato
[3] Bonus me fecit in bonum enim Bono ne me malo stato
"Buono mi ha fatto infatti per il bene, affinchè a Buono non capiti del male per colpa mia.
Altra traduzione (Piazzi, Rampioni, Apertis otia portis, p. 1)
Chi mi invia in dono giura per gli dei che se una ragazza non sarà dolce con te…
Vuoi diventarle amico. Dueno mi fece con intenzione buona. Non usarmi per un fine malvagio.
Altra traduzione (Bettini)
Giura per gli dei, colui che mim manda, che se una ragazza non sarà carina con te,
…vuoi diventarle amico
Una persona onesta mi ha fabbricato per un buon uso: … non usarmi per un fine cattivo.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
115
Testi e testimonianze
variante per 3: EN MANOMEINOM (Carotenuto, Gallo, Letteratura, Treviso 1997.
Bibliografia
Palmer, 77
IntraText
O387
Riposati
Il vaso di Duèno, di argilla, a tre cavità, trovato a Roma nel 1880: I'iscrizione, in caratteri greci, procedenti da
destra a sinistra, presenta non poche oscurità, che hanno dato luogo a svariate interpretazioni. Abbastanza
chiare sono la prima e l'ultima parte (2), dove paiono indovinarsl slgmficatl sacri, o piuttosto magici. Siamo
ancora in epoca assai remota, forse ai primi decenni del sec. V a C
ICCU Niente per soggetto
Ricerca Internet anche iconografica
La coppa di Civita Castellana
Civita Castellana era l’antica Faleri.
Testo Riposati
FOIED VINO PIPAFO CRA CAREBO
Traduzione in latino classico
Hodie vinum bibam cras carebo
Oggi berrò del vino, domani non ne avrò.
Bibliografia
Riposati
La Coppa di Civita Castellana (città del Lazio superiore) con la scritta: fofed vino pipafo, cra carefo= hodie
vinum bibam, cras carebo (=mortar?. Evidente è la nota simposiaca. Gli elementi fonetici latini e falischi Ci
nportano al V-IV sec. a. C e) la Cista Picoroni: un recipiente d, forma cilindrica, che prende il nome dallo
scopritore Nella breve iscrizione latina, di età piú recente delle precedenti e di chlara lettura, un certo Novio
Plàuzio aflerma di averla costruita a Roma: Novios Plautios med Romai (= Romae) fecid (= feclt) ( );
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
116
Palmer, Storia, 73
ICCU ?
Intratext ?
Estremi bibliografici
Iscrizione di Tivoli
Testo Riposati
KATIILO MITAT
Bibliografia
Remains of Old Latin, 4, Archaic Inscriptions, ed. E.H.Warmington, Loeb, London Cambridge
Mass., 1960.
Riposati, 6
L'Iscrizione di Tivoli, leggibile soltanto in due parole: Katfilo nome proprio, e mitat = mittat; pare posteriore
almeno di un secolo nspetto alla precedente.
Cista Ficoroni
L'iscrizione Ficoroni (dal nome dello scopritore) è incisa sul coperchio di un cofanetto bronzeo per
cosmetici, proveniente da Preneste, ove fu ritrovato nel 1738, e databile al periodo 250-235 ca.
a.C.. Qualcuno propone datazioni più estreme tra il IV e il II secolo.
Il cofanetto è conservato al Museo di Villa Giulia.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
117
DINDIA MACOLNIA FILEAI DEDIT.
NOVIOS PLAUTIOS MED ROMAI FECID.
Dindia Macolnia è il nome della committente, Novio Plauzio quello dell’artigiano; la segnalazione di
quest’ultimo è da ritenersi caso eccezionale.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
118
Trad. lat. Classico e italiano:
Dindia Macolnia filae dedit; Novius Plautius me Romae fecit.
Dindia Macolnia (mi) diede alla figlia
Novio Plauzio mi fece a Roma.
Bibliografia
Bettini, I, 20
Controllo per correttezza rif. = (C.I.L., I, 561, 14, 4112)
ICCU Niente per soggetto
Internet da utilizzare
C'est ce dernier qui est représenté dans la gravure ci-jointe. Il a trois pieds ; on voit, aux côtés, les poignées
par lesquelles on le portait ; le couvercle est surmonté de deux figures, une bacchante et un faune, et le
dehors est recouvert d'un dessin représentant la réception des Argonautes à l'arsenal de Cyzique.
A l'intérieur, on trouva les objets suivants : une autre petite boîte, une figure de chevreau, une de panthère,
une patera, une ligula, un instrument affilé et pointu comme le stylus, et un morceau de métal de forme
triangulaire, la pyramide (puramiV), citée par Clément d'Alexandrie comme un des objets contenus
d'habitude dans ces boîtes. L'autre corbeille, trouvée à labicum, a la même forme, présente la même matière
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
119
et le même travail ; seulement elle a trois figures sur le couvercle ; Bacchus au centre, drapé dans une robe
couverte d'étoiles pour indiquer qu'il était le Bacchus nocturne (Nyctelius Pater, Ovid. A. Am. I, 567), la nuit
étant le moment où on célébrait les orgies (Serv. ad Aen. IV, 303 ; cf Liv. XXXIX, 8 et sqq), et de chaque
côté un faune revêtu de la nebris. L'intérieur contenait une patera, sur laquelle la lutte entre Pollux et
Amycus, roi de Bébrycie, avec Diane entre eux, était représentée en figures contournées, dont les noms
étaient inscrits au-dessus dans une forme latine très ancienne, POLUCES, AMUCES et LOSNA, nom
antique pour Diana. Sous les pieds des figures, sur le couvercle, il y a une inscription ressemblant, pour
l'orthographe et la langue, à celle de la colonne de Duilius, et attestant que le vase fut offert par une femme
et fait par un artiste romain du nom de Novius Plautius :
DINDIA MACOLNIA FILEA DEDIT
NOVIOS PLAUTIOS MED ROMAI FECID
Lapis Satricanus
Della fine del VI secolo. Satrico, luogo di ritrovamento, è vicino ad Anzio.
Raccoglie un frammento di dedica di vono votivo a Marte da parte di un certo Publio Valerio
(Publicola).
Testo e traduzione (Bettini)
IEI STETERAI POPLIOSIO VALESIOSIO
SUODALES MAMARTEI.
I compagni di Publio Valerio dedicarono a Marte.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
120
==================
Internet
Un esempio di iscrizione arcaica: il Lapis Satricanus (fine VI sec. a.C.)
Luogo di ritrovamento: dalla località detta Le Ferriere, nei pressi di Campoverde (l'antica
Satricum), reimpiegata nelle fondamenta del tempio dedicato a Mater Matuta.
Tipologia del monumento: base di un donario.
Edizioni: C.M. Stibbe - G. Colonna - C. De Simone - H.R. Versnel, Lapis Satricanus.
Archaeological, Epigraphical, Linguistic and Historical Aspects of the New Inscription from
Satricum, s'Gravenhage 1980; CIL I2, 2832 a.
Testo: [---]uiei steterai Popliosio Valesiosio / suodales Mamertei.
Traduzione: ... posero i compagni di Publio Valerio a Marte.
Bibliografia: C. De Simone, L'iscrizione latina arcaica di Satricum. Problemi metodologici ed
ermeneutici, «Giornale Italiano di Filologia», 12 (1981), pp. 25-56; H.S. Versnel, Die neue Inschrift
von Satricum in historischer Sicht, «Gymnasium», 89 (1982), pp. 193-235; A. Prosdocimi,
Sull'iscrizione di Satricum, «Giornale Italiano di Filologia», 15 (1984), pp. 183-230; C. De Simone,
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
121
Ancora sull'iscrizione satricana di P. Valerio, «Studi Etruschi», 61 (1995), pp. 247-253; L. Arcella,
L'iscrizione di Satrico e il mito di Publio Valerio, «Studi e Materiali di Storia delle Religioni», n.s. 16
(1992), pp. 219-247; A. Prosdocimi, Satricum. I sodales del Publicola steterai a Mater (Matuta?),
«La Parola del Passato», 49 (1994), pp. 365-377; G. Colonna, Ancora sul lapis Satricanus, «Studi
Etruschi», 61 (1995), pp. 350-351; M.A. Levi, Il lapis satricanus e le genti romane, «Revue
Internationale des Droits de l'Antiquité», 42 (1995), pp. 195-219; J.A.K.E. de Waele, The Lapis
Satricanus and the Chronology of the Temples of Mater Matuta at Satricum, «Ostraka», 5 (1996),
2, pp. 231-242; E. Flores, Il lapis Satricanus e la dedica a Marte, «Sileno», 23 (1997), pp. 253-255;
C. Santi, Note al margine del convegno su Satricum, «Studi e Materiali di Storia delle Religioni»,
n.s. 21 (1997), pp. 257-261; E. Hermon, Le Lapis Satricanus et la colonisation militaire au début de
la République, «Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité», 111 (1999), pp. 847-881; R.
Friggeri, La collezione epigrafica del Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, Milano
2001, p. 23.
Immagine inserita sopra: Hermon, art. cit., p. 854, fig. 3; cf. anche De Simone, Ancora
sull'iscrizione satricana, cit., tavv. XXXVII-XXXVIII; Friggeri, op. cit., p. 23, fig. 8.
===================
Bibliografia
Bettini,1,20
ICCU
Autore: Lucchesi, Elisa
Titolo: Vecchie e nuove (in)certezze sul Lapis Satricanus / Elisa Lucchesi, Elisabetta Magni
Pubblicazione: Pisa : ETS, [2002]
niente intratext per Satricanus
Descrizione fisica: 104 p. ; 24 cm. , Collezione: Testi universitari
Internet da utilizzare
Il primo reperto e' un lastrone di pietra rinvenuto nei primianni '80 dagli archeologi dell'Istituto Olandese,
a Satricum,citta' nei pressi di Anzio,in un tempio dedicato alla dea dellafertilita', Mater Matuta. Sulla
pietra e' incisa un'iscrizione inlatino arcaico:
IEI STETERAI POPLIOSIO UALESIOSIO
SUODALES MAMARTEI
"I seguaci di Publio Valerio posero -questa pietraa Marte"
Publio Valerio Publicola, cui si riferisce l'iscrizione delLapis, fu console romano nel 509 a.C., fondatore
della Libera respublica e promotore di una serie di leggi a sfondo democratico, mala sua realta' storica fu
per
molto tempo discussa fino a quandonon fu
rinvenuto il
Lapis Satricanum,
che provo'
l'infondatezzadelle considerazioni di chi riteneva Publio Valerio un personaggioleggendario.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
122
Intratext ?
Ricerca Internet anche iconografica
Carmina
Il termine carmen è polivalente. Etimologicamente riportabile a cano, io canto.
Indica sostanzialmente una prosa fortemente marcata da una tessitura ritmica, con ripetizioni
foniche e morfologiche (in primis alliterazione): il carmen “non è tale per il suo contenuto, ma per la
sua forma” (Conte).
Sequenze ritmiche con struttura basata sulla ricorrenza di accenti. Può esserci anche rima.
Del resto la sua forma è paradossalmente più strutturata di quanto non sia il verso antico romano
per eccellenza, cioè il saturnio.
Cicerone definisce carmina le 12 tavole (De leg., 2,59).
Iam cetera in XII minuendi sumptus [sunt] lamentationisque funeris, translata <sunt> de Solonis fere legibus.
'Hoc plus', inquit, 'ne facito'. 'Rogum ascea ne polito.' Nostis quae sequuntur. Discebamus enim pueri XII ut
carmen necessarium, quas iam nemo discit. Extenuato igitur sumptu tribus reciniis et tunicula purpurea et
decem tibicinibus, tollit <nimiam> lamentationem: 'mulieres genas ne radunto neue lessum funeris ergo
habento'. Hoc ueteres interpretes, Sex. Aelius, L. Acilius, non satis se intellegere dixerunt, sed suspicari
uestimenti aliquod genus funebris, L. Aelius 'lessum' quasi lugubrem eiulationem, ut uox ipsa significat. Quod
eo magis iudico uerum esse quia lex Solonis id ipsum uetat. Haec laudabilia et locupletibus fere cum plebe
communia. Quod quidem maxime e natura est, tolli fortunae discrimen in morte.
Controllo
Le 12 tavole mettono del resto al bando i carmina intesi come formule magiche (Cic. de rep. 4,12).
Tito Livio parla di carmen per un trattato con i Latini (recupera fonte e riporta).
Controllo per e altri
10,38,10
3,64,10
CASTIGLIONI-MARIOTTI
1. carmen, inis, n.,
1 canto, suono, canzone (di voce e di strumenti): carmina vocum, canti, canzoni, carmine vocali
clarus, famoso per (i suoi) canti melodiosi, OV. Met. 12, 157; 11, 317; carmen canere, CURT.;
arundineo carmine, col suono della zampogna, OV. Trist. 4, 1, 12;
2 poesia, versi, carme, canto (lirico), poema (epico): carmina fundere, condere, contexere,
componere (HOR.), comporre carmi, versi, CIC.; anche = canto, libro di poema, LUCR. 6, 937;
3 iscrizione (in versi o no), profezia, formula magica, incantesimo, formula religiosa o giuridica (per
l'uso antico di scriverle in versi); testo, tenore di legge: carmina possunt deducere lunam, gli
incantesimi possono tirar giù la luna, VERG. Buc. 8, 69; verbis et carmine, con parole magiche,
OV.; carmine iurare, giurare su una formula, LIV. 10, 38, 10; lex horrendi carminis, legge di
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
123
orrendo tenore, LIV. 1, 26, 6; carmen rogationis, formula, testo della legge (per l'elez. dei tribuni),
LIV. 3, 64, 10
[cano + -men].
==========================================================================
va bene per fescennini.
Cic., de rep. 4,12
Nostrae contra duo decim tabulae cum perpaucas res capite sanxissent, in his hanc quoque sanciendam
putaverunt, si quis occentavisset sive carmen condidisset, quod infamiam faceret flagitiumve alteri.
Praeclare; iudiciis enim magistratuum, disceptationibus legitimis propositam vitam, non poetarum ingeniis,
habere debemus nec probrum audire nisi ea lege, ut respondere liceat et iudicio defendere.
Cic., Tusc., 4,3
Vestigia autem Pythagoreorum quamquam multa colligi possunt, paucis tamen utemur, quoniam non id
agitur hoc tempore. nam cum carminibus soliti illi esse dicantur [et] praecepta quaedam occultius tradere et
mentes suas a cogitationum intentione cantu fidibusque ad tranquillitatem traducere, gravissumus auctor in
Originibus dixit Cato morem apud maiores hunc epularum fuisse, ut deinceps, qui accubarent, canerent ad
tibiam clarorum virorum laudes atque virtutes; ex quo perspicuum est et cantus tum fuisse discriptos vocum
sonis et carmina. Quamquam id quidem etiam duodecim tabulae declarant, condi iam tum solitum
esse carmen; quod ne liceret fieri ad alterius iniuriam, lege sanxerunt.
Testi e testimonianze
Serv. Verg.Aen. 3,287
Varro, L.L., 7,36
Mar.Vict., GLK 6,138
Caes.Bass., GLK 6,265
Serv., Georg., 2,385
Cic., Brutus 75
Val.Max. 2,1,10
Quint., inst. 1,10,20
Nonius 107 L
Bibliografia generale
F. Buecheler, Carmina Latina epigrafica, 1895. Supplementum, ed. E. Lommatzsch, Leipzig 1926.
Concordantiae in Carmina Latina Epigraphica, ed. Maria Luisa Felé, Cristina Cocco, Egidia Rossi,
Attilio Flore, 2 voll., Hildesheim 1988.
Peter Kruschwitz, Carmina Saturnia Epigraphica. Stuttgart: F. Steiner, 2002.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
124
Carmina sacri
Il Carmen Saliare
Secondo la narrazione di Livio i Salii erano un sacro collegio fondato da Numa Pompilio.
Ogni anno, a maggio (verificare… era invece a marzo ed ottobre, inizio e fine periodo guerra?),
portavano in processione i dodici scudi sacri, gli ancilia, pronunciando formule rituali.
I carmina dei Salii erano rivolti a Marte, Ercole e altre divinità.
Quintiliano (I sec. d.C.) osserva che il linguaggio del carmen era già oscuro agli stessi sacerdoti
del collegio della sua epoca.
Testo (di chi?)
Fragmenta I-III
I.
divum +empta+ cante, divum deo
supplicate
II.
cume tonas, Leucesie, prae tet tremonti
+quot+ ibet etinei de is cum tonarem
III.
cozeulodorieso. omnia vero adpatula
coemisse.
ian cusianes duonus ceruses dunus Ianusve
vet pom melios eum recum
Il Carmen arriva attraverso tradizione letteraria (Varr.,L.L., 7,26 e 27) e Terent.Scaur., K 8,28)
Notizie in Festo 3,12 (non c'è in PHI)
Varro, de ling. Lat., 7,26 ?
menae ab eadem origine sunt declinatae. in multis verbis in quo[d] antiqui dicebant S, postea dicunt R, ut in
carmine Saliorum sunt haec: 'cozeulodorieso. omnia vero adpatula coemisse. ian cusianes duonus ceruses.
dunus Ianusue uet pom melios eum recum'
quo in Saliari versu scriptum est cante, hoc versu: 'divum empta cante, divum deo supplicante.' in carmine
Priami
Terent.Scaur. , K 8,28
Cum quidam per cum, non nulli per quom; quidam etiam esse differentiam putant, quod praepositio quidem
per c, <cum> illo, cum Claudio, cum Camillo, adverbium autem per q debeat scribi, ut quom legissem, quom
fecissem, quoniam antiqui pro hoc adverbio cume dicebant, ut Numa in Saliari carmine
cuine ponas Leucesiae praetexere monti
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
125
quot ibet etinei de is cum tonarem.
Fest., 3,12
Parla di axamenta, -orum, inni sacri cantati dai Salii e scritti sopra una tavola di legno (axis).
Cic., de or. 3,197
Varro, L.L. 7,2
Hor., ep. 2,1,186
Liv., 1,20,2-5
Huic duos flamines adiecit, Marti unum, alterum Quirino, uirginesque Uestae legit, Alba oriundum
sacerdotium et genti conditoris haud alienum. his ut adsiduae templi antistites essent stipendium de publico
statuit; uirginitate aliisque caerimoniis uenerabiles ac sanctas fecit. Salios item duodecim Marti Gradiuo legit,
tunicaeque pictae insigne dedit et super tunicam aeneum pectori tegumen; caelestiaque arma, quae ancilia
appellantur, ferre ac per urbem ire canentes carmina cum tripudiis sollemnique saltatu iussit.
Quint., 1,6,39
Verba a uetustate repetita non solum magnos adsertores habent, sed etiam adferunt orationi maiestatem
aliquam non sine delectatione: nam et auctoritatem antiquitatis habent et, quia intermissa sunt, gratiam
nouitati similem parant. Sed opus est modo, ut neque crebra sint haec nec manifesta, quia nihil est odiosius
adfectatione, nec utique ab ultimis et iam oblitteratis repetita temporibus, qualia sunt 'topper' et 'antegerio' et
'exanclare' et 'prosapia' et Saliorum carmina uix sacerdotibus suis satis intellecta. Sed illa mutari uetat religio
et consecratis utendum est: oratio uero, cuius summa uirtus est perspicuitas, quam sit uitiosa si egeat
interprete! Ergo ut nouorum optima erunt maxime uetera, ita ueterum maxime noua.
Quint., 1,10,20
Fronto, epist., 3,6
Quid? Numa senex sanctissimus nonne inter liba et decimas profanandas et suovetaurilia mactanda
aetatem egit epulorum dictator, cenarum libator, feriarum promulgator?
E Numa, il vecchio santissimo, non passò la vita a consacrare libagioni e offerte, a sacrificare
maiali, pecore e tori, indicendo banchetti sacri, dedicando cene, promulgando festività?
Trad. F. Portalupi, Torino Utet 1974.
Tac., hist., 4,53 (per la sopravvivenza dei suovetaur. In epoca imperiale)
Tum Helvidius Priscus praetor, praeeunte Plautio Aeliano pontifice, lustrata suovetaurilibus area et super
caespitem redditis extis, Iovem, Iunonem, Minervam praesidesque imperii deos precatus uti coepta
prosperarent sedisque suas pietate hominum inchoatas divina ope attolle-rent, vittas, quis ligatus lapis
innexique funes erant, contigit; simul ceteri magistratus et sacerdotes et senatus et eques et magna pars
populi, studio laetitiaque conixi, saxum ingens traxere.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
126
Tac., ann., 6,37
At Vitellius profugo Artabano et flexis ad novum regem popularium animis, hortatus Tiridaten parata capessere, robur legionum sociorumque ripam ad Euphratis ducit. sacrificantibus, cum hic more Romano
suovetaurilia daret, ille equum placando amni adornasset, nuntiavere accolae Euphraten nulla imbrium vi
sponte et immensum attolli, simul albentibus spumis in modum diadematis sinuare orbis, auspicium prosperi
transgressus.
Bibliografia
Il testo è in Fragmenta poetarum Latinorum, ed. Jürgen Blänsdorf, W. Morel, K. Büchner,
Stuttgard, 19822 19953, pp. 2-9.
TV0114 - Biblioteca comunale - Treviso – TV sia 1982 che 1995
Testo
IntraText 0261
ICCU ? Niente per soggetto Carmen Saliare
=======================
Testo PHI
CARMEN SALIARE
divum empta cante, divum deo supplicate.
quome tonas, Leucesie, prae tet tremonti
quot ibet etinei de is cum tonarem.
cozeulodorieso. omnia vero adpatula coemisse.
ian cusianes duonus ceruses dunus Ianusve
vet pom melios eum recum.
Cerus manus
Manuos
Praeceptat
pa . . . po
promenervat
praedotiont
prospices
pesnis . . . Casmenas . . . caesnas
polteo
polet
plisima
pretet tremonti praetemunt pe
perfines
promeriom
priviclois
petilam
pilumnoe poploe
Pescia
Pennatas impennatasque agnas
insicia
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
127
foedesum . . . plusima . . . meliosem . . . asenam . . . ianitos
Molucrum
cardens
Axamenta
tintinat
mamuri veturi
Luciam Volaminiam
Tame
<So>nivio
sopia
Agonensium
Redantruare
===================
Riposati
a) Carmina Saliaria: canti guerrieri dei Salii, sacerdoti di Marte (1), eseguiti a passo di danza (salto =
"danzo") nelle processioni, che annualmente si svolgevano in suo onore, durante il mese di marzo, per le vie
di Roma. All'antichissimo collegio dei dodici Salii Numa Pompilio affidò secondo la tradizione, la custodia dei
dodici scudi sacri (ancilta), di cui uno si credeva caduto dal cieló, simbolo e garanzia della futura eterna
grandezza di Roma. Nel tripudio danzante della rituale processione, i Salii scandivano i loro inni con
accompagnamento di tibia e percuotevano con un'asta lo scudo, che imbracciavano colla sinistra. Axarnenta
(da axare " nominare)>) venivano chiamate le loro invocazioni, se rivolte a tutti gli dèi, in generale; altrimenti
si qualificavano dal nome della singola divinità invocata (versus lovii, versus lanfi, ecc.).
Di essi, attraverso Varrone ed altri eruditi dell'antichità(l), ci sono giunti soltanto tre miseri, laceri frammenti,
incomprensibili già agli stessi antichi (2), piú incomprensibili a noi, che li leggiamo su testi corrotti e
variamente ricostruiti dagli studiosi. Per quanto lasciano intra vedere, essi hanno tono litànico: contengono,
cioè, una sequèla di invocazioni, che non si sa se riferire a divinità distinte (Giove, Sole, Giano) o
considerare come attributo di una stessa divinità, precisamente di Giove (" padre degli dèi, dio degli dèi,
apportatore di luce )); quando esso tuona, "tremano dinanzi )> a lui "quanti uomini sono in ogni luogo e gli
dèi e il mare tutto )>), oppure di Giano (il dio piú ricordato nelI'antica liturgia, il "Patúlco", cioè l'"apertore", il "
Clusio", cioè il e chiuditore ", il " buon creatore ". il " massimo tra gli dèi ").
Noi siamo generalmente preoccupati di considerare queste reliquie come puro materiale linguistico,
documentario. In verità, le loro singolarità fonetiche e morfologiche, il tono rítmico, le allitterazioni ed altro
ancora, offrono senza dubbio elementi preziosi per la storia della lingua e della versificazione latina. Ma non
è male che si cerchi sotto il velo della lingua anche lo spiritO che anima questi fervidi primitivi canti di
preghiera; questa, nelle note dello stile sacrale, ripete agli dèi, che tutto sono e tutto possono nel mondo, i
sentimenti della pietà, della soggezione e del timore dell'umile e quasi smarrita creatura úmana. Qui è
l'essenza stessa della religione romana.
Il Carmen Arvale o Carmen Fratrum Arvalium
Del collegio dei Fratres Arvales sono avanzati molti atti per un periodo che va dal 21 a.C. al 241
d.C.; alcuni erano noti già nel secolo XV, altri furono ritrovati successivamente sia a Roma, sia nei
pressi del tempio alla dea Dia, situato a 5 Km dalla città sulla via Campana (attuale Magliana, sulla
strada per Fiumicino).
Il Carmen veniva cantato durante la cerimonia finale del secondo giorno dei riti che si celebravano
a fine maggio.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
enos Lases iuvate
enos Lases iuvate
enos Lases iuvate
neve lue rue Marmar sins incurrere in pleoris
neve lue rue Marmar sins incurrere in pleoris
neve lue rue Marmar sins incurrere in pleoris
satur fu, fere Mars, limen sali, sta berber
satur fu, fere Mars, limen sali, sta berber
satur fu, fere Mars, limen sali, sta berber
semunis alterni advocapit conctos
semunis alterni advocapit conctos
semunis alterni advocapit conctos
enos Marmor iuvato
enos Marmor iuvato
enos Marmor iuvato
triumpe triumpe triumpe triumpe triumpe
Testo
IntraText 0619
Testo Bibliotheca Augustana
Teoricamente basato basato su:
CIL I² 2, Berlin 1893 sq.
ed. M. Nacinovich, Roma 1934Acta fratrum Arvalium quae supersunt
ed. W. Henzen, Berlin 1874/Darmstadt 1967
Enos Lases iuvate
Enos Lases iuvate
Enos Lases iuvate
Neve lue rue Marmar sins incurrere in pleoris
5
Neve lue rue Marmar sins incurrere in pleoris
Neve lue rue Marmar sins incurrere in pleoris
Satur fu, fere Mars, limen sali, sta berber
Satur fu, fere Mars, limen sali, sta berber
Satur fu, fere Mars, limen sali, sta berber
10
Semunis alterni advocapit conctos
Semunis alterni advocapit conctos
Semunis alterni advocapit conctos
F. D’Alessi © 2002
128
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
129
Enos Marmor iuvato
Enos Marmor iuvato
15
Enos Marmor iuvato
Triumpe
Triumpe
Triumpe
Triumpe
20
Triumpe
____________
enos = nos
Lases = Lares
Marmar/Marmor = Mars
sins = sinas (?)
pleores = plures
lue = luem
rue = ruem
Semunis = Semones
advocapit = advocabite (imp. fut.)
conctos = cunctos
Traduzione
Aiutateci Lari (3 volte)
e non permettere Marmar (3 volte)
che peste e rovina cadano su molti,
sii soddisfatto, fiero Marte, balza sulla soglia,
fermo percuoti (3 volte)
A turno invocherà tutti i Seminatori (3 volte)
aiutaci Marmar (3 volte)
Un balzo un balzo un balzo un balzo un balzo
Altra traduzione (Conte, Il libro della lett. Latina, 2000)
Oh, Lari, aiutateci,
E tu non permettere, Marmar, che peste e rovina aggrediscano il popolo ancora.
Sii sazio , Marte feroce, balza sulla nostra soglia e là, là sta a nostra difesa.
Tutti i Semòni, a turno, egli chiamerà a sé.
O Marmar aiutaci! Trionfo, trionfo!
Lares sono gli spiriti buoni dei defunti.
Marmar è una forma del nome di Marte, attestata solo in questo carmen e di origine forse sabina;
cf. quella osca Mamers e il doppione latino arcaico Mavors.
I semòni erano divinità delle sementi.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
130
(Frammento marmoreo contenente sulle due facce il resoconto delle cerimonie della dea Dia
svolta dal collegio dei Fratres Arvales i giorni 27 e 29 maggio del 218 a.C. d.C.. Ritrovato nel 1778
a Roma. Attualmente al Museo Pio Clementino.
In una faccia il Carmen Arvale (CIL VI, 2104).)
Bibliografia
ed. Gaetano Marini, 1795
Pisani, Testi A 3.
Calabi Limentani, 389 segg.
Per l’analisi linguistica, Palmer, Storia della lingua latina 77-78.
218 p. Chr. n., CIL I² 2
CIL I² 2, Berlin 1893 sq.= CIL VI 32338
ed. M. Nacinovich, Roma 1934, Acta fratrum Arvalium quae supersunt
ed. W. Henzen, Berlin 1874/Darmstadt 1967
ed. Dessau, ILS, Berlin 1892-1916, n. 5039
FPL Blansdorf 1995, pp. 9-11.
ICCU
Autore: Nacinovich, Mario
Titolo: 1: Il testo / Mario Nacinovich
Pubblicazione: Roma : Tip. Del Senato di G. Bardi, 1933
Fa parte di: Carmen Arvale / Mario Nacinovich
Autore: Nacinovich, Mario
Titolo: 2: I fonemi e le forme. Con un excursus ed Indici / Mario Nacinovich
Pubblicazione: Roma : Tip. Del Senato di G. Bardi, 1934
Autore: Fitzhugh, Thomas
Titolo: Carmen Arvale seu Martis verber, or The tonic laws of Latin speech and rhythm :
supplement to the Prolegomena to the history of Italico-Romanic rhythm / by Thomas Fizhugh
Pubblicazione: Charlottesville : Anderson : University of Virginia, 1908
Autore: Roselli, R.
Titolo: Il Carmen fratrum Arvalium / R. Roselli
Pubblicazione: <S.l.> : <s.n.>, 1901 (Acireale : Tipografia Dell'Etna)
Autore: Cocchia, Enrico
Titolo: Saliare numae carmen
Pubblicazione: Napoli : Rivista Indo-greco-italica, 1917
Descrizione fisica: 19 p. ; 25 cm
Note Generali: Estr. dalla rivista Indo-greco-italica di filologia-lingua-antichita, A.1, fasc.2, 1917 .
Comprende: 1: Elementi sabini nel culto dei salii
2: Tentativi ermeneutici
3: I versus ianuli nei frammenti varroniani
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
131
Riposati
b) II Carmen Arvale (o Carmen fratrum Arvaltum): un canto sacro, accompagnato anch'esso da rítmica
danza, non per le vie della città, come nella celebrazione saliare, ma lungo i sentieri fioriti dei campi feraci
(arva). Dodici, come i Salii, erano i fratrcs, i sacerdotij che componevano il collegio degli Arvales, ai quali sin
dai tempi plÚ antichi era afiidato il solennissimo rito della purificazione delle campagne (lustratio agrorum),
inteso a propiziarsi il favore divino per gli abbondanti raccolti (1). Una solenne processione, riti lustrali
agresti, libazioni, offerte di vittime opíme, caratterizzavano l'annuale celebrazione, che, nel bel mese di
maggio, per tre giorni consecutivi, si ripeteva attorno al santuario della dea Dia (Cerere), posto su una
boscosa collina, a poche miglia da Roma. Gnti e invocazioni (axamenta) accompagnavano il sacro rito, che
toccava il momento piú alto nel secondo giorno, quando gli Arvali, rientrati nel tempio, a ritmo di danza in tre
tempi (tripodatio? intonavano I inno solenne, composto di cinque versi,
npetutl ciascuno tre volte:
Enos Lases iusate (ter), neve lue rue Marmar sins incurrere in pleores (ter) satur fu fere Mars limen sali sta
berber (ter). semunis alternei alvocapit conctos (ter). Enos Marmor iuvato (ter). triumpe triumpe triumpe
triumpe triumpe (ter) (2).
1 Lo svolgimento delle cerimonie anàliche è perfettamente ricostruibile dalle notizie degli Acta del collegio
nell'epoca imperiale, che gli scavi hanno via via messe in luce nei secoli scorsi. II nostro frarnmento, inciso
nel marmo, fu trovato a Roma nel 1778. Oscura, comunque antichissima e forse italica, è l'origine del
sacerdozio anàIiCO, che decadde durante la Repubblica e venne ripristinato da Cesare Augusto.
2 Il testo è sostanzialmenk quello del BUECHELER (Carmrna Latina EpigraphrVca, p. I); eccone una delle
interpretazioni piú probabili: Nos, Lares, iuvate, neve luem ruinam, Mars, sinas incurrere in plures. Satur sis,
fere Mars; limen sali; sta, verber. Semunes alterne (quisque) invocabit cunctos. Nos, Mars, iuvato; triumpe,
triumpe. . . " Noi proteggete, o Lari; né peste e rovina, o Marte, lascia abbattersi sui piú. Sii sazio (= ti basti),
o fiero Marte; balza sulla soglia, e 1i a custodia, lí rimani. Ciascuno invocherà alternativamente i Semóni tutti
quanti; noi, o Marte, proteggi ! Trionfo ! trionfo ! trionfo I trionfo I trionfo I D.
Testo di difficile interpretazione anche questo, che, per esserci giuntouattraverso una redazione epigrafica
del 218 d. C., dato il suo carattere sacro, deve ritenersi presumibilmente autentico (1). Ma nella scabrosXà
del suo linguaggio preistorico, nella solenne rudezza delle sue formuleXsacrali, lascia carpire a mala pena il
significato che vi si na, sconde. Comunque, anche qui in ordine alle antiche sensibilità religiose e alla finWlità
del vetusto rito, si riascoltano le voci piú vive e piú pure del primitivo spirito latino: la famiglia, il focolare, la
terra, le divinità. E tra queste appaiono invocate le piú note ed importanti dell'antico calendario romano: i
Lari, protettori della famiglia e del focolare, perché concedano salute, prosperità e pace (Enos, Lases,
iusate), Marte, I'antico Marte latino, dio della campagna e della fertilità della terra, e i Sernóni tutti, vetuste
divinità delle mèssi, perché lontani tengano malanni e ro, vine, e accordino prosperosi e abbondanti raccolti
o Ia quintúplice acclamazione finale suggella il grido della gioia festosa nella fiducia della protezione divina.
Internet da utilizzare
Noctes Gallicanae
Epigraphie latine
Rituel des Frères Arvales
Le collège des frères Arvales célébrait un culte agraire dans le bois sacré de la dea Dia à 7,5 km de Rome
sur la via Campana. Il comprenait notamment les Ambarvalia, trois jours de fête autour du 29 mai. Les
fragments retrouvés de leur rituel restent énigmatiques.
Arvalis dérive du substantif arva, « terre labourée » et Varron (Ling. Lat., 15) définit les Fratres Arvales
comme qui sacra publica faciunt propterea ut fruges ferant arva ceux qui font des sacrifices pour que les
champs labourés donnent des récoltes.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
132
Dans son Histoire naturelle, XVIII, 2, Pline attribue l’origine de cette confrérie à Romulus : Arvorum
sacerdotes Romulus in primis instituit seque duodecimum fratrem appellavit inter illos Acca Larentia nutrice
sua genitos Romulus institua en premier lieu les prêtres Arvales et se nomma lui-même le douzième frère en
même temps que ceux qu’avait mis au monde sa nourrice Acca Larentia.
Aulu-Gelle confirme cette tradition :
Sed Acca Larentia corpus in vulgus dabat pecuniamque emeruerat ex eo quaestu uberem. Ea testamento,
ut in Antiatis Historia scriptum est, Romulum regem, ut quidam autem alii tradiderunt, populum Romanum
bonis suis heredem fecit. Ob id meritum a flamine Quirinali sacrificium ei publice fit et dies e nomine eius in
fastos additus. Sed Sabinus Masurius in primo Memorialium, secutus quosdam historiae scriptores, Accam
Larentiam Romuli nutricem fuisse dicit. Ea, inquit, mulier ex duodecim filiis maribus unum morte amisit. In
illius locum Romulus Accae sese filium dedit seque et ceteros eius filios fratres Arvales appellavit. Ex eo
tempore collegium mansit fratrum Arvalium numero duodecim, cuius sacerdotii insigne est spicea corona et
albae infulae.
Mais Acca Larentia livrait son corps au public et elle avait gagné à ce commerce beaucoup d’argent. Dans
son testament elle institua héritier de ses biens le roi Romulus, comme l’écrit dans son Histoire Valerius
Antia, le peuple romain, selon d’autres traditions. Pour ce mérite un sacrifice lui est fait au nom de l'État par
le flamine de Quirinus et un jour à son nom fut ajouté aux fastes. Mais Sabinus Masurius dans le premier
livre de ses Memorialia à la suite de certains historiens, dit qu'Acca Larentia fut la nourrice de Romulus. «
Cette femme, dit-il, avait douze fils mâles, elle en perdit un qui mourut. A sa place Romulus se donna pour
fils à Acca Larentia et ils s'appelèrent, lui et les autres fils, frères Arvales. Depuis ce temps le collège des
frères Arvales compte douze membres ; l'insigne de cette prêtrise est la couronne d'épis et les bandelettes
blanches.
Aulu-Gelle, VII, 7 : De Acca Larentia et Gaia Taracia deque origine sacerdotii fratrum arvalium
-------------------------------------------------------------------------------Leur rituel, très complexe et sans doute très archaïque, a été conservé dans de nombreuses inscriptions.
Voici deux extraits de l’une d’entre elles, qui date du règne de Gordien, 238-240 ap. J.-C. (AE 1915, 0102).
PR KAL APRIL
[FR]A[T]RES ARVALES IN LVCO DEAE DIAE VIA CAMP APVD LAP V CONV
PER FAB FORTVNATVM VICTORINVM PROMAG VICE FL LVCILIANI
MAG OP INCHOANDI CAVSA LVCI SVBLVCANDI ET ARBORVM
OBLAQVEAND ET ALIAR RESTITVENDARVM HVIVS REI LVSTRVM
MISSVM SVOVETAVR MAIORIB ET ANTE AED DEAE DIAE B F AV
IVNCTAS ALB N II IANO PATR AR N II IOV VERB N II SIVE
DEO SIVE DEAE VERB N II VIRG OV N II FAMVL DIS VERB N II
LAR VERB N II MATRI LAR OV N II FLOR OV N II VEST M OV N II
ITEM ANTE CAES GEN D N IMP M ANTONI GORDIANI P F A T A
SOLEMN SACRIF FACTIS FELICIA DIX
Pridie Kalendas Apriles. Fratres Arvales in luco deae Diae via Campana apud lapidem V convenerunt per
Fabium Fortunatum Victorinum promagistrum vice Flavi Luciliani magistri, operis inchoandi causa luci
sublucandi et arborum
oblaqueandarum et aliarum restituendarum. Huius rei lustrum missum
suovetaurilibus maioribus et, ante aedem, deae Diae boves feminas auro iunctas albas numero II, Iano Patri
arietes numero II, Iovi verbeces numero II, sive deo sive deae verbeces numero II virginibus oves numero II,
famulis dis verbeces numero II, Laribus verbeces numero II, matri Larum oves numero II, Florae oves
numero II, Vestae matri oves numero II. Item, ante caesareum, Genio domini nostri Imperatoris Marci Antoni
Gordiani Pii Felicis Augusti taurum auratum. Solemnibus sacrificiis factis felicia dixerunt
La veille des calendes d’avril (31 mars). Les frères Arvales se sont réunis dans le bois sacré de la déesse
Dia sur la voie Campana à la borne 5, sous la présidence de Fabius Fortunatus Victorinus, Vice-maître,
remplaçant le Maître Flavius Lucilianus, pour commencer les opérations : éclaircir le bois sacré, déplacer
des arbres et en remettre d’autres. La cérémonie de purification de cette action commença par un
suovétaurile solennel puis, devant le temple, à la déesse Dia on sacrifia des génisses blanches au nombre
de deux attelées d’un joug d’or, à Janus Pater des béliers au nombre de deux, à Jupiter des moutons au
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
133
nombre de deux, à la divinité masculine ou à la divinité féminine des moutons au nombre de deux et de
jeunes brebis au nombre de deux, aux dieux subalternes des moutons au nombre de deux, aux Lares des
moutons au nombre de deux, à la Mère des Lares des brebis au nombre de deux, à Flora des brebis au
nombre de deux, à Vesta Mère des brebis au nombre de deux. Ensuite, devant l’autel des Césars, au Génie
de notre maître l’empereur Marcus Antonius Gordianus Pius Felix Auguste un taureau aux cornes
recouvertes d’or. Les sacrifices rituels accomplis, les frères Arvales prononcèrent les formules de
bénédiction.
III KAL IVN
[IN LVCO DEAE DIAE FAB FORTVNATVS VICTORINVS PROMAG AD ARAM]
[IMMOLAVIT PORCILIAS PIACVLARES N II LVCI COINQVIENDI]
[ET OPERIS FACIVNDI IBI VACCAM HONORARI]AM DEAE DIA[E IM]
[MOLAVIT ET INDE IN TETRASTY]LO REVERSVS SVBSELLIS CONSE[DIT]
[DEINDE REVERSVS AD AR]AM DEAE DIAE EXTAS PORCILIARVM II
REDDIDIT ET AD FOCVLVM ARG EXTA BACCHAE REDDIDIT [FEL]
DIX ET IN TETRASTVLVM REVERSVS EST ET SVBSELLIS C[ONSED]
ET IN CODICE CAVIT SE ADFVISSE ET SACR FECISSE ET EXTAS [RED]
DIDISSE PRAETEXTA DEPOSVIT ET IN BALNEO IBIT REVER[SVS]
COLLEGAS SVOS VENIENTES EXCEPIT POSTQVAM PLENVS NV[MER]
VS COLLEGARVM CONVENIT TVNC VTRIQVE PRAETEXTA PO[S)]
ET IN TETRASTVLO SVBSELL CONS ET IN CODICE CAVER SE ADFV
ISSE ET SACR FECISSE ET MENSA PVMILA SINE FERRO ANTE IPSOS
POSITA EST ET PANES SILIGINEOS ACCEP ET DE SANGVNCVLO
PORCILIARVM VESCITI SVNT ET DE PORCILIAS PARTITI ET EPV
LATI SVNT ET IN TETRASTVLO CAPITA VELAVERVNT ET LVCVM
ASCENDER ET PROMAG ET FLAM STRVIB ET FERT FECER ET
IMMOL AGNA OP ALBA AD LITATIONE EXTA INSPEXERVNT ET
III Kalendas Iunias. In luco deae Diae, Fabius Fortunatus Victorinus promagister ad aram immolavit porcilias
piaculares numero II, luci coinquiendi et operis faciundi. Ibi vaccam honorariam deae Diae immolavit et inde
in tetrastylo reversus subsellis consedit. Deinde reversus ad aram deae Diae, extas porciliarum II reddidit et
ad foculum argenteum extam bacchae reddidit. Felicia dixit. Et in tetrastulum reversus est et subsellis
consedit et in codice cavit se adfuisse et sacrum fecisse et extas reddidisse. Praetextam deposuit et in
balneo ibit. Reversus collegas suos venientes excepit. Postquam plenus numerus collegarum convenit, tunc
utrique praetextas posuerunt et in tetrastulo subsellis consederunt et in codice caverunt se adfuisse et
sacrum fecisse. Et mensa pumila sine ferro ante ipsos posita est et panes siligineos acceperunt et de
sangunculo porciliarum vesciti sunt et de porcilias partiti et epulati sunt. Et in tetrastulo capita velaverunt et
lucum ascenderunt. Et promagister et flamen struibus et fertis fecerunt et immolaverunt agnam opimam
albam ad litationem extas inspexerunt.
Le 3 des calendes de juin (30 mai). Dans le bois sacré de la déesse Dia, Fabius Fortunatus Victorinus, Vicemaître, immola à l’autel les jeunes truies expiatoires au nombre de deux en raison de l’émondage du bois et
des travaux accomplis. Il y immola une vache en l’honneur de la déesse Dia et de là, revenu dans le
tétrastyle, il siégea sur les bancs. Puis, revenu à l’autel de la déesse Dia, il offrit en sacrifice les entrailles
des deux jeunes truies et sur un brasero argenté les entrailles de la vache, et il prononça les formules de
bénédiction. Et il revint dans le tétrastyle, et il siégea sur les bancs et il prit soin de consigner dans le registre
qu’il était présent et qu’il avait fait le sacrifice et qu’il avait offert les entrailles. Il ôta sa toge prétexte et il alla
se baigner. De retour, il accueillit ses collègues qui venaient le rejoindre. Lorsque le nombre total de ses
collègues fut réuni, alors ses collègues et lui endossèrent leur toge prétexte et allèrent siéger dans le
tétrastyle sur les bancs et prirent soin de noter dans le registre qu’ils étaient présents et qu’ils avaient
accompli le sacrifice. La table en bois de vigne sans fer fut déposée devant eux et ils reçurent les pains
blancs et consommèrent le boudin des jeunes truies et festoyèrent de morceaux des jeunes truies. Et dans
le tétrastyle, ils se couvrirent la tête et montèrent au bois sacré et le Vice-maître et le flamine firent les
prémisses de gâteaux et de pains sacrés et immolèrent une grasse agnelle blanche et examinèrent les
entrailles pour savoir si le sacrifice était heureux.
-------------------------------------------------------------------------------Une cérémonie en 37 ap. J.-C. : des participants illustres.
] T(ITI) SE]XTI AFRICANI CONLEGI(I) FRA
[TR]VM ARVALIVM NOMINE
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
134
[AD] ARAM IMMOLAVIT DEAE
DIAE VACCAM DEINDE IN AE
DE IN FOCO SACRIFICIO FACTO
IMMOLAVIT DEAE DIAE AGNAM
OPIMAM QVO PERFECTO E
CARCERIBVS RICINIATVS CO
RONATVS SIGNVM QVADRIGI[S]
ET DESVLTORIBVS MISIT
ADFVERVNT M SILANVS P MEMMIVS REGVLV[S]
L SALVIVS OTHO MESSALA
CORVINVS
Q CAECINA PRIMO
P TREBONIO COS
IIII IDVS OCTOBR AVGVSTA
IBVS IN TEMPLO NOVO
[[A VITELLIVS]] PROMAGISTER
MAGISTERIO T SEXTI AFRICANI
CONLEGI FRATRVM ARVALIVM
NOMINE IMMOLAVIT DIVO
AVGVSTO BOVEM MAREM
DIVAE AVGVSTAE VACCAM
IN COLLEGIO ADFVERVNT
NERO CAESAR PRINCEPS
IVVENTVTIS P MEMMIVS
REGVLVS L SALVIVS OTHO
M SILANVS C PISO MESSALA CORVINVS
] Titi Sexti Africani, conlegii fratrum Arvalium nomine, ad aram immolavit deae Diae vaccam. Deinde in aede
in foco sacrificio facto immolavit deae Diae agnam opimam. Quo perfecto e carceribus riciniatus coronatus
signum quadrigis et desultoribus misit. Adfuerunt Marcus Silanus, Publius Memmius Regulus, Lucius Salvius
Otho, Messala Corvinus.
Quinto Caecina Primo Publio Trebonio consulibus, (ante diem) IIII Idus Octobres, Augustalibus, in templo
novo, Aulus Vitellius promagister, magisterio Titi Sexti Africani, conlegi fratrum Arvalium nomine, immolavit
divo Augusto bovem marem, divae Augustae vaccam. In collegio adfuerunt Nero Caesar princeps iuventutis,
Publius Memmius Regulus, Lucius Salvius Otho, Marcus Silanus, Gaius Piso, Messala Corvinus.
AE 1977, 18
… de Titus Sextus Africanus, au nom du collège des frères Arvales, il immola à l’autel de la déesse Dia
(Junon) une vache. Ensuite, dans le temple, sur le foyer, ce sacrifice terminé, il immola à la déesse Dia une
grasse agnelle. Ceci accompli, la tête couverte et couronné, il donna du haut des stalles le signal aux
quadriges et aux voltigeurs. Étaient présents Marcus Silanus, Publius Memmius Regulus, Lucius Salvius
Othon, Messala Corvinus. Sous le consulat de Quintus Caecina Primus et de Publius Trebonius, le 4 des
ides d’octobre (12 octobre), pour les Augustales, dans le temple neuf, le vice-président Aulus Vitellius, sous
la présidence de Titus Sextus Africanus, au nom du collège des frères Arvales, il immola au divin Auguste
un bovin mâle, à la divine Augusta une vache. Étaient présents Néron César, prince de la Jeunesse, Publius
Memmius Regulus, Lucius Salvius Othon, Marcus Silanus, Gaius Pison, Messala Corvinus.
Nero Caesar
Le « Nero Caesar » dont il est question ici était le petit-fils de Tibère, Tiberius Claudius Drusus Nero, né vers
20.
eäxe m¢n gŒr kaÜ tòn Tib¡rion tò ¦kgonon: Žll' ¤keÝnon m¢n di‹ te t¯n ²likÛan (¦ti gŒr paidÛon ·n) kaÜ diŒ
t¯n êpocÛan (oé gŒr ¤pisteæeto toè Droæsou paÝw eänai) pareÅra (Tibère) avait aussi un petit-fils, Tibère,
mais du fait de son âge (c’était [en 33] encore un enfant) et par méfiance, il pensait en effet que ce n’était
pas le fils de Drusus, il le dédaignait. Dion Cassius, LVIII, 23. De ce fait, Tibère choisit Caligula pour
successeur, persuadé aussi, ajoute Dion Cassius, que Caligula n’attendrait pas longtemps pour se
débarrasser de ce rival possible : sæ te toèton ŽpokteneÝw kaÜ s¢ •lloi tu le tueras (dit Tibère à Caligula),
et toi, d’autres te tueront (ibid.).
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
135
Tibère, finalement, décide de laisser l’empire à Caligula tout en lui associant son petit-fils.
Fratrem Tiberium die virilis togae adoptavit appellavitque principem iuventutis [Caligula] adopta son frère
Tibère le jour où il prit la toge virile et lui donna le titre de Prince de la Jeunesse. Suétone, Caligula, 16.
Les apparences étant sauves, Caligula peut tranquillement poursuivre ses desseins et réaliser la prédiction
de Tibère :
Fratrem Tiberium inopinantem repente immisso tribuno militum interemit Silanum item socerum ad necem
secandasque novacula fauces compulit, causatus in utroque, quod hic ingressum se turbatius mare non
esset secutus ac spe occupandi urbem, si quid sibi per tempestates accideret, remansisset, ille antidotum
obol[e]visset, quasi ad praecavenda venena sua sumptum, cum et Silanus inpatientiam nauseae vitasset et
molestiam navigandi, et Tiberius propter assiduam et ingravescentem tussim medicamento usus esset Il fit
tuer à l’improviste par un tribun militaire son frère Tibère. De même, il força son beau-père Silanus à se tuer
en se tranchant la gorge avec un rasoir. Il reprochait à ce dernier de ne pas l’avoir suivi un jour qu’il
s’embarquait par gros temps et d’être resté à Rome avec l’espoir de s’en rendre maître si quelque chose
était arrivé à l’empereur dans la tempête ; il reprochait au premier de sentir l’antidote, antidote qu’il aurait
pris pour se protéger de ses poisons. En réalité, Silanus avait voulu éviter les désagréments du mal de mer
et les fatigues d’une traversée, Tibère avait pris un remède contre une toux opiniâtre qui s’aggravait.
Suétone, Caligula, 23.
Dion Cassius (LIX) précise que Caligula avait pris soin de faire auparavant annuler le testament de son
prédécesseur, sous prétexte qu’il ne jouissait plus au moment de la rédaction de toutes ses facultés et que
le jeune Tibère, n’ayant même pas l’âge d’entrer au sénat, ne pouvait pas raisonnablement être associé au
pouvoir suprême.
Drusus, le fils de Tibère, est mort en 23. Le jeune Tibère, qui a pris la toge virile en 37 à 16 ou 17 ans, est
donc né entre 20 et 22. Il a été assassiné fin 37 ou début 38. Il ne faut pas le confondre avec Drusus, le fils
de Germanicus qui a été condamné par l’empereur Tibère.
Les autres participants à cette cérémonie :
On les retrouve tous, sans surprise, dans l’entourage immédiat de Tibère et de Caligula.
P. Memmius Regulus (consul en 31) :
Lolliam Paulinam, C. Memmio consulari exercitus regenti nuptam, facta mentione aviae eius ut quondam
pulcherrimae, subito ex provincia evocavit ac perductam a marito coniunxit sibi brevique missam fecit
interdicto cuiusquam in perpetuum coitu En ce qui concerne Lollia Paulina, mariée à l’ancien consul et chef
d’armées Gaius Memmius, comme il avait entendu dire que sa grand-mère avait été autrefois d’une grande
beauté, il la fit revenir immédiatement de sa province, se la fit céder par son mari et l’épousa. Il la répudia
rapidement mais lui fit interdire à jamais d’appartenir à qui que ce soit. Suétone, Caligula, 25.
Malgré l’erreur des manuscrits de Suétone sur le prénom, il s’agit bien de Publius Memmius. Cf. Dion
Cassius, LXIX, 12.
L. Salvius Otho :
Pater L. Otho, materno genere praeclaro multarumque et magnarum propinquitatum, tam carus tamque non
absimilis facie Tiberio principi fuit, ut plerique procreatum ex eo crederent Le père (de l’empereur Othon),
Lucius Othon, issu du côté maternel d’une famille illustre aux alliances nombreuses et importantes, fut si
cher à l’empereur Tibère et lui ressemblait tellement de visage que beaucoup de gens croyaient qu’il était
son fils. Suétone, Othon, 1.
M. Silanus sera consul en 46, sous le règne de Claude.
C. Piso :
Matrimonia contraxerit turpius an dimiserit an tenuerit, non est facile discernere. Liviam Orestillam C. Pisoni
nubentem, cum ad officium et ipse venisset, ad se deduci imperavit intraque paucos dies repudiatam biennio
post relegavit, quod repetisse usum prioris mariti tempore medio videbatur. Alii tradunt adhibitum cenae
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
136
nuptiali mandasse ad Pisonem contra accumbentem : Noli uxorem meam premere, statimque e convivio
abduxisse secum ac proximo die edixisse : matrimonium sibi repertum exemplo Romuli et Augusti Quant à
ses mariages, il n’est pas facile de décider s’il s’est comporté de façon plus méprisable à les contracter, à les
rompre ou à les faire durer. Lorsque Livia Orestilla épousa Gaius Pison, il avait lui aussi été invité à la
cérémonie. Il donna l’ordre de l’emmener chez lui et la répudia quelques jours après. Il l’exila deux ans après
parce qu’il pensait qu’elle avait repris entre temps la vie commune avec son premier mari. D’autres
rapportent que pendant le repas nuptial, il fit dire à Pison qui était placé en face de lui : « Ne serre pas ma
femme de trop près ! », qu’il lui avait aussitôt fait quitter le banquet avec lui et qu’il avait fait annoncer
publiquement le lendemain qu’il avait trouvé à se marier selon l’exemple de Romulus et d’Auguste. Suétone,
Caligula, 25.
Quinto Caecina Primo Publio Trebonio consulibus :
La cérémonie a bien eu lieu en 37, mais je ne trouve comme consuls cette année-là que Gn. Acerronius
Proculus et G. Petronius Pontius Nogrinus, avec comme consul suffectus A. Caecina Paetus. Problème !
Ce Caecina devait être le fils de celui dont parle Tacite dans le premier livre des Annales, duo apud ripam
Rheni exercitus erant : cui nomen superiori sub C. Silio legato, inferiorem A. Caecina curabat on avait deux
armées sur la rive du Rhin, celle que l’on appelait « supérieure » était commandée par le légat C. Silius,
Aulus Caecina dirigeait l’armée « inférieure » (23).
Quoi qu’il en soit, lorsque sous le règne de Vespasien Titus commandait la garde prétorienne, Aulum
Caecinam consularem, vocatum ad cenam ac vixdum triclinio egressum, confodi iussit ; sane urgente
discrimine, cum etiam chirographus eius praeparatae apud milites contioni deprehendisset il ordonna de tuer
Aulus Caecina, ancien consul, qu’il avait invité à dîner, dès sa sortie de la salle à manger : il est vrai que le
danger était pressant, puisque Titus avait saisi jusqu’au texte autographe du discours que Caecina se
préparait à adresser à l’assemblée des soldats. Suétone, Titus, 6.
-------------------------------------------------------------------------------Une autre cérémonie sous le règne de Domitien
[DEINDE AD SVMMOTVM IN AEDE SACRIFICIO FACTO IMMOLAVIT DEAE DIAE AGNAM]
OP[IMAM QVO SACRIFICIO PERACTO IN CAESAREO EPVLATI SVNT AD MAGISTRVM IN]
DE P SALLVSTIVS BL[AESVS MAG CORONATVS RICINIATVS DE CARCERIBVS SIGNVM]
QVADRIGIS ET DESVLTORIBVS MISIT Q[VOS CORONIS ARGENTEIS ORNAVIT]
IN COLLEGIO ADFVERVNT [P] SALLVSTIVS B[LAESVS . . . C TADIVS]
MEFITIANVS L VERATIVS QVADRATVS C [VIPSTANVS APRONIANVS C SALVIVS]
LIBERALIVS NONIVS BASSVS [ISDEM COS . . . K IVN
DOMI AD PERAGENDVM SACRIFICIVM [EPVLANTES AD MAGISTRVM ET FRVGES EXCI]
[PI]ENTES A SACERDOTIBVS ET AD AR[AM REFERENTES PVERI INGENVI PATRIMI ET]
[MATRIMI SENAT]ORVM FILI½ [CAECIN]O PAETO [
Deinde ad summotum in aede sacrificio facto, immolavit deae Diae agnam opimam. Quo sacrificio peracto,
in Caesareo epulati sunt ad magistrum. Inde Publius Sallustius Blaesus magister coronatus riciniatus de
carceribus signum quadrigis et desultoribus misit. Quos coronis argenteis ornavit. In collegio adfuerunt
Publius Sallustius Blaesus . . . Gaius Tadius, Mefitianus, Lucius Veratius Quadratus, Gaius Vipstanus
Apronianus, Gaius Salvius Liberalius, Nonius Bassus. Isdem consulibus . . . Kalendas Iunias domi ad
peragendum sacrificium epulantes ad magistrum et fruges excipientes a sacerdotibus et ad aram referentes,
pueri ingenui patrimi et matrimi senatorum filii Caecino (?) Paeto [
AE 1898, 141
Ensuite, dans le temple, ce sacrifice terminé, il immola à la déesse Dia une grasse agnelle. Ceci accompli,
ils prirent le repas rituel dans le temple des Césars auprès du président. De là, Publius Sallustius Blaesus,
couronné et la tête couverte donna du haut des stalles le signal aux quadriges et aux voltigeurs, qu’il
récompensa de couronnes d’argent. Étaient présents à la réunion Publius Sallustius Blaesus, …, Gaius
Tadius Mefitianus, Lucius Veratius Quadratus, Gaius Salvius Liberalius, Nonius Bassus. Sous le consulat de
ces derniers (85 ap. J.-C.), le 3 des calendes de juin (30 mai), à domicile, se réunirent pour accomplir le
sacrifice, prirent le repas rituel chez le président, reçurent les prémisses des moissons des mains des
prêtres et les apportèrent à l’autel. Des enfants libres, orphelins ni de père ni de mère, fils de sénateurs, à
Caecinus Paetus…
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
137
Formule augurali e proverbi
Sono di carattere religioso o pratico-sapienziale e vengono trasmessi per tradizione letteraria.
L’ambito è quello rurale della coltivazione dei campi o dedicazione di templi, ma formule rituali
investono anche l’ambito militare (Livio).
Varr., L.L. 7,7-8 (Testo PHI)
Eius templi partes quattuor dicuntur, sinistra ab oriente, dextra ab occasu, antica ad meridiem, postica ad
septemtrionem. in terris dictum templum locus augurii aut auspicii causa quibusdam conceptis verbis finitus.
concipitur verbis non [h]isdem usque quaque; in arce sic: '[i]tem<pla> tescaque me ita sunto quoad ego eas
te lingua[m] nuncupavero. ullaber arbos quirquir est, quam me sentio dixisse, templum tescumque[m] festo
in sinistrum. ollaner arbos quirquir est, quod me sentio dixisse te<m>plum tescumque[m] festo dextrum. inter
ea conregione conspicione cortumione utique ea erectissime sensi.'
Testo della formula ricostruito da Norden in Palmer 80
Bibliografia
Palmer 80
Cantio
Ricerca lessico cantio
Testi e testimonianze
Cat., de agr., 167,160
CLXVIII Luxum ut excantes
Luxum si quod est, hac cantione sanum fiet. harundinem prende tibi uiridem p. IIII aut quinque
longam, mediam diffinde, et duo homines teneant ad coxendices. incipe cantare [in alio s. f. 'moetas uaeta
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
138
daries dardaries asiadarides una pe tes' usque dum coeant]: 'motas uaeta daries dardares astataries
dissunapiter', usque dum coeant. ferrum insuper iactato. ubi coierint et altera alteram tetigerint, id manu
prehende et dextera sinistra praecide; ad luxum aut ad fracturam alliga: sanum fiet. et tamen cotidie cantato
[in alio s. f. uel luxato uel hoc modo 'huat hauat huat ista pista sista dannabo dannaustra'] et luxato uel hoc
modo: 'huat haut haut istasis tarsis ardannabou dannaustra'.
[Testo PHI]
PER ELIMINARE LA LUSSAZIONE CON INCANTESIMI
160. Se si verifica una qualche lussazione, la si potrà guagrire con questo incantesimo:
prendi una canna fresca lunga quattro o cinque piedi, sezionala nel senso della lunghezza e
due uomini tengano la parti vicino all'anca; incomincia a recitare:
«moetas uaeta daries dardares astataries dissunapiter»
finché le parti combacino. Ai gitavi sopra un coltello. Quando le due sezioni della canna si saranno
sovrapposte sino a combaciare reciprocamente, afferra la canna e tagliala alle estremità destra e
sinistra; legala strettamente alla parte lussata o fratturata: guarirà. Tuttavia continua a recitare ogni
giorno †…† usando soprattutto questa formula:
“huat huat huat istasis tarsis ardannabou dannaustra”.
Trad. Cugusi Sblendorio, Utet 2001 BCTV
Carmen ad Martem
Catone ci trasmette il testo di un carmen che il pater familias pronunciava al momento di purificare
i campi con il rito della lustratio durante la cerimonia degli Ambarvalia.
Lustratio CM
Cerca Ambarvalia Internet generico
Cat., de agri cult., 141
Agrum lustrare sic oportet: impera suouitaurilia circumagi: 'cum diuis uolentibus quodque bene eueniat,
mando tibi, Mani, uti illace suouitaurilia fundum agrum terramque meam, quota ex parte siue circumagi siue
circumferenda censeas, uti cures lustrare.' Ianum Iouemque uino praefamino, sic dicito:
'Mars pater, te precor quaesoque, uti sies uolens propitius mihi domo familiaeque nostrae: quoius rei ergo,
agrum terram fundumque meum suouitaurilia circumagi iussi; uti tu morbos uisos inuisosque, uiduertatem
uastitudinemque, calamitates intemperiasque prohibessis defendas auerruncesque; utique tu fruges,
frumenta, uineta uirgultaque grandire beneque euenire siris; pastores pecuaque salua seruassis duisque
bonam salutem ualetudinemque mihi domo familiaeque nostrae. harunce rerum ergo, fundi terrae agrique
mei lustrandi lustrique faciendi ergo, sicuti dixi, macte hisce suouitaurilibus lactentibus immolandis esto:
Mars pater, eiusdem rei ergo, macte hisce suouitaurilibus lactentibus esto.'
Testo Norden
Agrum lustrare sic oportet: impera suouitaurilia circumagi: 'cum diuis uolentibus quodque bene eueniat,
mando tibi, Mani, uti illace suouitaurilia fundum agrum terramque meam, quota ex parte siue circumagi siue
circumferenda censeas, uti cures lustrare.' Ianum Iouemque uino praefamino, sic dicito:
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
139
'Mars pater, te precor quaesoque, uti sies uolens propitius mihi domo familiaeque nostrae: quoius rei ergo,
agrum terram fundumque meum suouitaurilia circumagi iussi;
uti tu morbos | uisos inuisosque
uiduertatem | uastitudinemque
calamitates | intemperiasque
prohibessis defendas | auerruncesque
ut fruges, frumenta | uineta uirgultaque
grandire dueneque | euenire siris,
pastores pecuaque | salua seruassis
duisque bonam salutem | ualetudinemque
mihi domo | familiaeque nostrae.
harunce rerum ergo, fundi terrae agrique mei lustrandi lustrique faciendi ergo, sic uti dixi, macte hisce
suouetaurilibus lactentibus immolandis esto: Mars pater, eiusdem rei ergo, macte hisce suouetaurilibus
lactentibus esto.'
"Perché tu i morbi veduti e non veduti, la desolazione e la devastazione, i mali delle piante e i
maltempi fermi allontani e storni, e perché i raccolti e le biade, i vigneti e i virgulti tu lasci aggredire
e venir bene, i pastori e il bestiame conservi sani e dia benessere e salute a me alla nostra casa e
famiglia"
Traduzione parte centrale da G.B.Pighi, La poesia religiosa romana, Bologna 1958, p. 139.
Marte, padre, ti prego e ti chiedo
Deh, sii benigno, propizio
A me alla casa e alla servitù nostra,
a cagion della qual cosa
attorno al campo, alla terra e al mio fondo
ho fatto condurre i suovitaurili:
deh, tu i morbi visibili ed invisibili,
la desolazione e la devastazione,
le tempeste e gli uragani
arresta, ricaccia e spazza via;
deh, tu i frumenti ed i frutti, i vigneti ed i virgulti
fa’ che crescano e vengan su bene
i mandriani e le mandrie serbale salve
e dà buona salute e vigoria
a me, alla casa e alla servitù nostra,
a cagione di queste cose
di purificare il fondo, la terra e il mo campo
e fare il sacrificio purificatorio,
così come ho detto,
onorato dall’immolazione di questi suovitaurili
lattanti tu sia!
Marte padre
A cagion della medesima cosa,
onorato dall’immolazione di questi suovitaurili
lattanti tu sia!
Traduzione di P. Ferrarino, raccolta in Piazzi-Rampioni, Apertis..,1,10
I suovitaurilia erano il sacrificio a Marte di un porco (sus), una pecora (ovis) e un toro (taurus).
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
140
Traduzione da ediz. Catone Cugusi Utet.
141. [I] Bisogna effettuare la purificazione del campo con il seguente rito: ordina che si conducano
tutto intorno i “suovitaurilia”, cioè un porcello, un agnello, un torello:
“Con la benevolenza degli dei- e che la cosa abbia buon esito-, ti affido o Manio, il compito di
occuparti della lustratio, cioè di condurre quei suovitaurilia intorno al mio podere, al mio campo e al
mio terreno in ogni parte in cui tu ritenga opportuno condurli o portarli di peso.”
[2] Invoca preliminarmente Giano e Giove, offrendo vino.
Poi di’ così:
“O marte padre, tiprego e ti scongiuro, sii favorevole e propizio a me, alla mia casa e a tutti i miei: è
per questa ragione che ho fatto condurre i suovitaurilia intorno al mio campo, al mio terreno e al
mio podere; che tu possa tenere lontano, respingere, stornare mali visibili e invisibili, sterilità e
devastazione, calamità e intemperie; e che tu consenta che biade, frumento, vigne e piante
crescano e diano buoni frutti; [3] che tu conservi sani i pastori e le greggi e conceda condizione di
salute e prosperità a me, alla mia casa e ai miei; a questi fini, per la purificazione del mio podere,
del mio terreno, del mio campo e per effettuare il sacrificio lustrale, come ho detto, gradisci
l’immolazione di questi suovetaurilia da latte; o Marte padre, allo stesso fine sii onorato con questi
suovetaurilia da latte”.
Parimenti, ‹ripeti una seconda volta, con le modalità precedenti (?) › [4] Poni mano al coltello (scil.
Per immolare la vittima); che siano a disposizione focaccine e focaccia, con queste fa’ l’offerta.
Quando immolerai il porcello, l’agnello e il vitello, bisogna dire così:
“Per queste ragioni gradisci il sacrificio di questi suovitaurilia”.
Vieta di nominare Marte … né l’agnello né il vitello. Se il sacrificio sarà sfavorevole per tutti gli
animali immolati, si formuli l’invocazione così;
“O Marte padre, se qualcosa nell’immolazione dei precedenti suovitaurilia da latte non ti è risultato
accetto, ti offro in espiazione questi nuovi suovitaurilia”.
Se c’è dubbio per uno o due degli animali immolati, si formuli l’invocazione con le seguenti
modalità:
“O Marte padre, in considerazione del fatto che non ti ha soddisfatto il porcello immolato prima, ti
offro in espiazione questo nuovo porcello”.
Macrobio, sat, 5, 20, 18
In libro enim vetustissimorum carminum, qui ante omnia quae a Latinis scripta sunt compositus
ferebatur, invenitur hoc rusticum vetus canticum:
hiberno pulvere, verno luto
grandia farra, camille, metes.
“In una raccolta di antichissimi carmi, che si riteneva anteriore ad ogni manifestazione letteraria dei
Latini, si trova questa antica canzone di contadini:
con la polvere d’inverno e il fango in primavera
mieterai grani grossi, ragazzo mio.”
[Trad. N. Marinone, Torino, Utet, 1967]
Testo ricostruito in forma arcaica proposto da Norden
hibernod polverid | vernod lutod
grandia fara | casmile metes.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
141
Potrebbe corrispondere al latino classico:
hiberno pulvere verno luto
grandia farra, camille, metes
Quando è polvere d’inverno, quando è fango a primavera, grandi farri, ragazzo mieterai
(Trad. e equivalente classico in Conte, il libro, 2000, p. 8)
Controllo Festo, 123 per incantamentum
vetus novum vinum bibo | veteri novo morbo medeor
[Testo Norden, p. 171]
novum vetus vinum bibo, novo veteri morbo medeor
bevo il vino nuovo (come fosse) vecchio, curo la nuova malattia (come quella) vecchia
(Secondo testo e Trad. fornita con riserva da Conte, Il libro della lett.lat. 2000, p. 8)
niente ICCU per Carmen ad Martem
=================
Giuramenti e formule in ambito militare
Con il termine di carmen vengono indicate in epoca letteraria anche “formule” di
accompagnamento per i giuramenti in ambito militare.
Testimonianze vengono da Livio, per il giuramento che precede il combattimento tra Orazi e
Curiazi (1,24). Sempre Livio (10, 38) racconta di una cerimonia sacra con giuramento, sacrificio e
recita di formule sacre da un vecchio libro, compiuto dai Sanniti prima di combattere con i Romani.
Liv., 1,24 (Giuramento e formule prima del combattimento tra Orazi e Curiazi)
Tum ita factum accepimus, nec ullius uetustior foederis memoria est. fetialis regem Tullum ita rogauit:
'iubesne me, rex, cum patre patrato populi Albani foedus ferire?' iubente rege, 'sagmina' inquit 'te, rex,
posco.' rex ait: 'pura tollito.' fetialis ex arce graminis herbam puram attulit. postea regem ita rogauit: 'rex,
facisne me tu regium nuntium populi Romani Quiritium, uasa comitesque meos?' rex respondit: 'quod sine
fraude mea populique Romani Quiritium fiat, facio.' fetialis erat M. Ualerius; is patrem patratum Sp. Fusium
fecit, uerbena caput capillosque tangens. pater patratus ad ius iurandum patrandum, id est, sanciendum fit
foedus; multisque id uerbis, quae longo effata carmine non operae est referre, peragit. legibus deinde
recitatis, 'audi' inquit, 'Iuppiter; audi, pater patrate populi Albani; audi tu, populus Albanus. ut illa palam prima
postrema ex illis tabulis ceraue recitata sunt sine dolo malo, utique ea hic hodie rectissime intellecta sunt,
illis legibus populus Romanus prior non deficiet. si prior defexit publico consilio dolo malo, tum tu ille
Diespiter populum Romanum sic ferito ut ego hunc porcum hic hodie feriam; tantoque magis ferito quanto
magis potes pollesque.' id ubi dixit porcum saxo silice percussit. sua item carmina Albani suumque ius
iurandum per suum dictatorem suosque sacerdotes peregerunt.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
142
Ecco, secondo quanto ci è stato tramandato, il cerimoniale seguito per questo trattato che è
più antico che si ricordi. Il feziale chiese a Tullo: «O re, desideri e io stringa un trattato col
padre patrato del popolo albano?».Il re espresse questa volontà e il feziale aggiunse: «O re,
ti chiedo l’erba sacra». Il re rispose: «Prendila pura». Il feziale portò dalla rocca un cespo di
erba pura e poi interrogò il re: «O re, vuoi tu dichiararmi nunzio regale del popolo romano
con gli oggetti sacri e miei accompagnatori?». Questa fu la risposta del re: «Sì, per quanto
possa avvenire senza danno mio o del popolo romano dei Quiriti».
Il feziale era Marco Valerio; egli scelse come padre patrato Spurio Fusio toccandogli con
l'erba verbena il capo e i capelli. II padre patrato viene scelto a pronunciare il giuramento e a
sancire il trattato, recitando una lunga formula in versi che qui non mi pare opportuno riferire.
Diede lettura delle condizioni e aggiunse: «Ascolta o Giove, ascolta o padre patrato del
popolo albano, ascolta tu stesso popolo di Alba: allo stesso modo in cui q u e s t i patti sono
stati letti chiaramente e senza inganno, dal primo all’ultimo, sulle tavolette di cera e, in questo
luogo e in questo giorno, sono stati correttamente intesi, così il popolo romano non verrà mai meno
per primo ad essi. Se il popolo romano per primo verrà meno con l'inganno all'impegno di astenersi
da offese publiche, allora, in quel giorno, o Giove, colpisci il popolo romano come io oggi colpisco
questo porco; colpisci il popolo romano con maggior forza quanto più sei forte e potente». Aveva
appena pronunciato questa formula e subito colpì il porco con la pietra silice. Allo stesso modo gli
Albani pronunciarono le loro formule e il loro giuramento per bocca del loro dittatore e dei loro
sacerdoti.
Trad. Mazzocato
Liv., 10,38
Sequitur hunc annum et consul insignis, L. Papirius Cursor, qua paterna gloria, qua sua, et bellum ingens
uictoriaque quantam de Samnitibus nemo ad eam diem praeter L. Papirium patrem consulis pepererat. et
forte eodem conatu apparatuque omni opulentia insignium armorum bellum adornauerant; et deorum etiam
adhibuerunt opes ritu quodam sacramenti uetusto uelut initiatis militibus, dilectu per omne Samnium habito
noua lege, ut qui iuniorum non conuenisset ad imperatorum edictum quique iniussu abisset caput Ioui
sacraretur. tum exercitus omnis Aquiloniam est indictus. ad sexaginta milia militum quod roboris in Samnio
erat conuenerunt. ibi mediis fere castris locus est consaeptus cratibus pluteisque et linteis contectus, patens
ducentos maxime pedes in omnes pariter partes. ibi ex libro uetere linteo lecto sacrificatum sacerdote Ouio
Paccio quodam, homine magno natu, qui se id sacrum petere adfirmabat ex uetusta Samnitium religione,
qua quondam usi maiores eorum fuissent cum adimendae Etruscis Capuae clandestinum cepissent
consilium. sacrificio perfecto per uiatorem imperator acciri iubebat nobilissimum quemque genere factisque;
singuli introducebantur. erat cum alius apparatus sacri qui perfundere religione animum posset, tum in loco
circa omni contecto arae in medio uictimaeque circa caesae et circumstantes centuriones strictis gladiis.
admouebatur altaribus magis ut uictima quam ut sacri particeps adigebaturque iure iurando quae uisa
auditaque in eo loco essent non enuntiaturum. iurare cogebant diro quodam carmine, in exsecrationem
capitis familiaeque et stirpis composito, nisi isset in proelium quo imperatores duxissent et si aut ipse ex acie
fugisset aut si quem fugientem uidisset non extemplo occidisset. id primo quidam abnuentes iuraturos se
obtruncati circa altaria sunt; iacentes deinde inter stragem uictimarum documento ceteris fuere ne
abnuerent. primoribus Samnitium ea detestatione obstrictis, decem nominatis ab imperatore, eis dictum, ut
uir uirum legerent donec sedecim milium numerum confecissent.
38. L'anno seguente vide l'elezione di un console, Lucio Papirio Cursore, famoso per la gloria
personale e per quella del padre. Si registrarono poi una grande guerra e una grande vittoria
come mai sui Sanniti nessuno aveva riportato, se si esclude proprio Lucio Papirio, padre del
console. Anche in quell'occasione, per coincidenza, i Sanniti scesero in campo con lo stesso
apparato sfarzoso, rivestendo i soldati con le armature più ricche e splendenti; e anche allora
invocarono l'aiuto degli dèi con un antico rito di giuramento rivolto ai soldati quasi questi fossero
degli iniziati. Si procedette ad un arruolamento in tutto il Sannio, secondo una nuova norma: i
giovani che non si fossero presentati all'editto dei comandanti o che si fossero allontanati senza
permesso sarebbero stati consacrati a Giove. Il luogo di raduno di tutte le forze fu fissato ad
Aquilonia, dove convennero circa quarantamila soldati, il nerbo della gioventù sannita. Là, nel
mezzo del campo, fu delimitato, con graticci e parapetti, un recinto lungo circa duecento piedi e
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
143
largo altrettanto che fu poi ricoperto da tela di lino. All'interno, leggendo le formule da un vecchio
libro di tela, compì sacrifici un tale Ovio Paccio, sacerdote vecchissimo, il quale sosteneva che
quel rito proveniva da una antica usanza religiosa sannita, praticata tanti anni prima dai loro
antenati, quando avevano concepito in gran segreto il disegno di strappare Capua agli Etruschi.
Una volta compiuto il sacrificio, il generale convocava con un messo gli uomini più meritevoli per
discendenza e valore personale facendoli entrare ad uno ad uno. A insinuare timore religioso
nell'animo era tutto l'apparato liturgico, ma in modo particolare gli altari elevati in quello spazio
tutto ricoperto e recintato, le vittime sacrificali che giacevano intorno, i centurioni con la spada in
pugno che formavano un cerchio. Il soldato veniva fatto avanzare verso gli altari, più vittima che
partecipe del sacro rito; subito lo si vincolava con un giuramento a non rivelare mai ciò che
aveva visto e udito in quel luogo. Poi, con una formula brutale e spietata, veniva obbligato a
giurare che sarebbe andato in battaglia dove il suo comandante avesse voluto condurlo, a non
ritirarsi dalla lotta, a uccidere immediatamente chi avesse visto fuggire: altrimenti la maledizione
sarebbe ricaduta sul suo capo, sulla sua famiglia, sulla sua discendenza. Qualcuno, all'inizio, si
rifiutò di prestare un simile giuramento ma fu ucciso intorno agli altari e il cadavere, buttato tra i
mucchi delle vittime, fu di monito agli altri a non tirarsi indietro. Dopo il rito, che legava con una
maledizione tutta la nobiltà sannita, il comandante chiamò dieci soldati, disponendo che ogni
uomo scegliesse un altro uomo fino ad arrivare al numero di sedicimila.
Trad. Mazzocato
A questa testimonianza se ne ricollegano altre relative alla evocatio e alla devotio. Prima di
esaminarle, può essere notato come carmen valesse nella cultura romana antica anche come
“profezia”, secondo quanto ricordato dal medesimo Livio.
Liv., 25,12
Romae consules praetoresque usque <ad> ante diem quintum kalendas Maias Latinae tenuerunt; eo die
perpetrato sacro in monte in suas quisque prouincias proficiscuntur. religio deinde noua obiecta est ex
carminibus Marcianis. uates hic Marcius inlustris fuerat, et cum conquisitio priore anno ex senatus consulto
talium librorum fieret, in M. Aemili praetoris [urbem], qui eam rem agebat, manus uenerant; is protinus nouo
praetori Sullae tradiderat. ex huius Marci duobus carminibus alterius post rem actam editi comperto
auctoritas euentu alteri quoque, cuius nondum tempus uenerat, adferebat fidem. priore carmine Cannensis
praedicta clades in haec fere uerba erat: 'amnem, Troiugena, fuge Cannam, ne te alienigenae cogant in
campo Diomedis conserere manus. sed neque credes tu mihi, donec compleris sanguine campum, multaque
milia occisa tua deferet amnis in pontum magnum ex terra frugifera; piscibus atque auibus ferisque quae
incolunt terras iis fuat esca caro tua; nam mihi ita Iuppiter fatus est.' et Diomedis Argiui campos et Cannam
flumen ii qui militauerant in iis locis iuxta atque ipsam cladem agnoscebant. tum alterum carmen recitatum,
non eo tantum obscurius quia incertiora futura praeteritis sunt sed perplexius etiam scripturae genere.
'hostes, Romani, si ex agro expellere uoltis, uomicam quae gentium uenit longe, Apollini uouendos censeo
ludos qui quotannis comiter Apollini fiant; cum populus dederit ex publico partem, priuati uti conferant pro se
atque suis; iis ludis faciendis praesit praetor is quis ius populo plebeique dabit summum; decemuiri Graeco
ritu hostiis sacra faciant. hoc si recte facietis, gaudebitis semper fietque res uestra melior; nam is deum
exstinguet perduelles uestros qui uestros campos pascit placide.' ad id carmen expiandum diem unum
sumpserunt; postero die senatus consultum factum est ut decemuiri libros de ludis Apollini reque diuina
facienda inspicerent.
12. I consoli e i pretori furono trattentuti a Roma dalle Ferie latine fino al ventisette aprile: in
quel giorno, celebrato il sacrificio sul monte Albano. ripartirono per le rispettive zone di
operazioni. Un nuovo scrupolo religioso nacque poi dalle profezie di Marcio. Questo Marcio
era stato un vate rinomato: quando l'anno prima un senatoconsulto aveva disposto la ricerca
di libri di quel genere, i suoi vaticini erano giunti nelle mani del pretore urbano Marco Emilio
che si occupava di quella faccenda. Egli le aveva subito consegnate al nuovo pretore Silla.
Due erano le profezie di Marcio: l'autorità della prima - venuta alla luce dopo che il fatto era
accaduto e dunque avvalorata dal fatto di essersi dimostrata veritiera - aggiunse credibilità
anche alla seconda, il cui tempo non era ancora venuto. La prima profezia vaticinava il
disastro di Canne pressappoco con queste parole: «O discendente dai Troiani, fuggi il fiume
Canna, perché gente straniera non ti costringa a venire a battaglia nella pianura di Diomede.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
144
Tuttavia tu non mi crederai, finché non avrai riempito di sangue la pianura, finché il fiume non
porterà dalla terra feconda al vasto mare molte migliaia di tuoi morti; la tua carne deve
diventare cibo per i pesci, per gli uccelli, per le fiere che popolano le terre». E quelli che
avevano militato in quei luoghi riconoscevano i campi di Diomede di Argo e il fiume Canna,
così come riconoscevano il disastro stesso. In quell'occasione fu letta anche l'altra profezia:
fu più difficile intenderla non solo perché il futuro è meno decifrabile del passato, ma anche
perché era più incomprensibile quel modo di scrittura. «Romani, se volete cacciar via i
nemici, tumore giunto da lontano, penso che voi dobbiate far voto ad Apollo di istituire dei
giochi, da celebrare gioiosamente ogni anno in onore di Apollo; ad essi in parte contribuisca
il popolo con denaro dell'erario, in parte contribuiscano i privati per loro e per le loro famiglie.
La celebrazione di quei giochi sarà presieduta dal pretore che eserciterà, al più alto grado, la
giustizia per la cittadinanza e per la plebe. I decemviri celebrino dei riti sacrificando vittime
secondo la liturgia greca. Se così, correttamente, agirete, ne trarrete gioia per sempre e la
vostra sorte andrà sempre migliorando. Infatti quel dio che gioisce nel fecondare i vostri
campi, distruggerà i vostri nemici». I pontefici spesero un giorno per interpretare quella
profezia. Il giorno dopo, fu stabilito da un senatoconsulto che i decemviri consulta ssero i libri
Sibillini sull'istituzione dei giochi di Apollo e sulla celebrazione del sacrificio. Quando tali
questioni furono esaminate e ne fu fatta relazione al senato, i senatori espressero il parere
che si dovesse far voto di giochi ad Apollo e che si dovessero celebrare; quando i giochi
fossero stati celebrati, si sarebbero dovuti dare al pretore dodicimila assi per il sacro rito e
due vittime adulte. Fu fatto anche un altro senatoconsulto: i decemviri avrebbero compiuto un
sacrificio secondo la liturgia greca e immolando queste vittime: un bue ornato d'oro e due
capre bianche ornate d'oro, in onore di Apollo; una vacca ornata d'oro, in onore di Latona.23
Il pretore, mentre si accingeva a celebrare i giochi nel Circo Massimo, dispose mediante un
editto che il popolo durante quei giochi contribuisse con un'offerta ad Apollo, secondo le
possibilità di ognuno. È questa l'origine dei giochi Apollinari. offerti in voto e istituiti non in
seguito ad una pestilenza, come sostengono i più, ma ad una vittoria. Il popolo vi partecipò
col capo coronato; le matrone effettuarono delle suppliche; ovunque, nei cortili furono tenuti
dei banchetti a porte aperte; quel giorno fu reso solenne da ogni tipo di cerimonie.
Trad. Mazzocato
Macr., sat., 1,17,25: non è pertinente; parla infatti di carmineque Sibyllino, che vale in questo
contesto “profezia”.
Serv., Verg.Aen., 6,70
festosqve dies de nomine phoebi ludos Apollinares dicit,
qui secundum quosdam bello Punico secundo instituti sunt, secundum alios tempore Syllano ex responso
Marciorum fratrum, quorum extabant, ut Sibyllina, responsa.
Plin., nat., 7,119
Divinitas et quaedam caelitum societas nobilissima ex feminis in Sibylla fuit, ex viris in Melampode apud
Graecos, apud Romanos in Marcio.
Cic., div., 1,89
Asiae rex Priamus nonne et Helenum filium et Cassandram filiam divinantes habebat, alterum auguriis,
alteram mentis incitatione et permotione divina? Quo in genere Marcios quosdam fratres, nobili loco natos,
apud maiores nostros fuisse scriptum videmus. Quid?
Cic., div., 2,113
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
145
Eodem enim modo multa a vaticinantibus saepe praedicta sunt, neque solum verbis, sed etiam Versibus,
quos olim Fauni vatesque canebant.
Similiter Marcius et Publicius vates cecinisse dicuntur; quo de genere Apollinis operta prolata sunt.
Credo etiam anhelitus quosdam fuisse terrarum, quibus inflatae mentes oracla funderent.
Porph., Hor.Ep. 2,1, 26
A<nno>sa volvmina va<t>vm. Veter<i>s Marcii uatis Sibillaeque et similium.
Isid., orig., 6,8, 12
Controllo Macrob., sat. 3,8-9
7
Ea quoque quae incuriose transmittuntur a legentium plebe non carent profunditate. Nam cum loqueretur de
filio Pollionis, id quod ad principem suum spectaret, adiecit:
Ipse sed in pratis aries iam suave rubenti
Murice, iam croceo mutabit vellera luto.
Traditur autem in libro Etruscorum, si hoc animal insolito colore fuerit inductum, portendi imperatori rerum
omnium felicitatem. Est super hoc liber Tarquitii transcriptus ex Ostentario Tusco. Ibi reperitur: Purpureo
aureove colore ovis ariesve si aspergetur, principi ordinis et generis summa cum felicitate largitatem auget,
genus progeniem propagat in claritate laetioremque efficit. Huiusmodi igitur statum imperatori in transitu
vaticinatur.
Verbis etiam singulis de sacro ritu quam ex alto petita significet, vel hinc licebit advertere:
Iniecere manum Parcae, telisque sacrarunt
Evandri.
Nam quicquid destinatum est dis sacrum vocatur: pervenire autem ad deos non potest, nisi libera ab onere
corporis fuerit, anima, quod nisi morte fieri non potest. Ita ergo oportune sacratum Halesum facit, quia erat
oppetiturus. Et hic proprietatem et humani et divini iuris secutus est. Nam ex manus iniectione paene
mancipium designavit, et sacrationis vocaulo observantiam divini iuris inplevit. Hoc loco non alienum videtur
de conditione eorum hominum referre quos leges sacros esse certis dis iubent, quia non ignoro quibusdam
mirum videri quod, cum cetera sacra violari nefas sit, hominem sacrum ius fuerit occidi. Cuius rei causa haec
est. Veteres nullum animal sacrum in finibus suis esse patiebantur, sed abigebant ad fines deorum quibus
sacrum esset: animas vero sacratorum hominum, quos * zanas Graeci vocant, dis debitas aestimabant.
Quemadmodum igitur quod sacrum ad deos ipsos mitti non poterat a se tamen dimittere non dubitabant, sic
animas, quas sacras in caelum mitti posse arbitrati sunt, viduatas corpore quam primum ire illo voluerunt.
Disputat de hoc more etiam Trebatius Religionum libro nono, cuius exemplum, ne sim prolixus, omisi. Cui
cordi est legere, satis habeat et auctorem et voluminis ordinem esse monstratum.
8.
Nonnullorum quae scientissime prolata sunt male enuntiando corrumpimus dignitatem, ut quidam legunt:
Discedo ac ducente dea flammam inter et hostes
Expedior,
cum ille doctissime dixerit: ducente deo, non dea. Nam et apud Calvum Aterianus adfirmat legendum:
Pollentemque deum Venerem
non deam. Signum etiam eius est Cypri barbatum corpore, sed veste muliebri, cum sceptro ac natura virili: et
putant eandem marem ac feminam esse. Aristophanes eam 70Afro/diton appellat. Laevinus etiam sic ait:
Venerem igitur almum adorans, sive femina sive mas est, ita uti alma Noctiluca est. Philochorus quoque in
Atthide eandem adfirmat esse lunam, et ei sacrificium facere viros cum veste muliebri, mulieres cum virili,
quod eadem et mas aestimatur et femina.
Hoc quoque de prudentia religionis a Virgilio dictum est:
Decidet exanimis, vitamque reliquit in astris
Aereis.
Hyginus enim de proprietatibus deorum, cum de astris ac de stellis loqueretur, ait oportere his volucres
immolari. Docte ergo Virgilius dixit apud ea numina animam volucris remansisse quibus ad litandum data est.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
146
Nec nomen apud se, quod fortuitum esse poterat, vacare permittit:
— Matrisque vocavit
Nomine Casmillae mutate parte Camillam.
Nam Statius Tullianus de vocabulis rerum libro primo ait dixisse Callimachum Tuscos Camillum appellare
Mercurium, quo vocabulo significant praeministrum deorum. Unde Virgilium ait Metabum Camillam
appellasse filiam, Dianae scilicet praeministram. Nam et Pacubius, cum de Medea loqueretur:
Caelitum camilla, expectata advenis, salve hospita
Romani quoque pueros et puellas nobiles et investes camillos et camillas appellant, flaminicarum et
flaminum praeministros. Hanc quoque observationem eius non convenit praeterire.
Mos erat, inquit, Hesperio in Latio, quem protinus urbes
Albanae coluere sacrum, nunc maxima rerum
Roma colit.
Varro de moribus morem dicit esse in iudicio animi, quem sequi debeat consuetudo. *Iulius Festus de
verborum significationibus libro tertio decimo: Mos est, inquit, institutum patrium, pertinens ad religiones
cerimoniasque maiorum. Ergo Virgilius utrumque auctorem secutus, et primo quidem Varronem, quoniam
ille dixerat morem praecedere, sequi consuetudinem, postquam dixit: Mos erat, subiunxit: Quem protinus
urbes Albanae coluere, et: Nunc maxima rerum Roma colit, quo perseverantiam consuetudinis monstrat. Et
quoniam Festus pertinere ad cerimonias ait, hoc idem docuit Maro adiciendo sacrum:
— Quem protinus urbes
Albanae coluere sacrum.
Mos ergo praecessit et cultus moris secutus est, quod est consuetudo: et hic definitionem Varronis inplevit.
Adiciendo deinde sacrum ostendit morem cerimoniis dicatum, quod Festus adseruit. Idem observavit et in
duodecimo libro, cum ait:
— Morem ritusque sacrorum
Adiciam,
in quo ostendit aperte morem esse ritus sacrorum. Sed historiae quoque fidem in his versibus secutus est:
Mos erat Hesperio in Latio, et reliqua.
Servavit enim regnorum successionem: quippe primi regnaverunt Latini, deinde Albani, et inde Romani.
Ideo: Mos erat, primum dixit, Hesperio in Latio, et postea: Quem protinus urbes Albanae coluere sacrum;
deinde subiecit: Nunc maxima rerum Roma colit.
9.
Excessere omnes adytis arisque relictis
Di quibus imperium hoc steterat.
Et de vetustissimo Romanorum more et de occultissimis sacris vox ista prolata est. Constat enim omnes
urbes in alicuius dei esse tutela, moremque Romanorum archanum et multis ignotum fuisse ut, cum
obsiderent urbem hostium eamque iam capi posse confiderent, certo carmine evocarent tutelares deos:
quod aut aliter urbem capi posse non crederent, aut etiam, si posset, nefas aestimarent deos habere
captivos. Nam propterea ipsi Romani et deum in cuius tutela urbs Roma est et ipsius urbis Latinum nomen
ignotum esse voluerunt. Sed dei quidem nomen nonnullis antiquorum, licet inter se dissidentium, libris
insitum: et ideo vetusta persequentibus quicquid de hoc putatur innotuit. Alii enim Iovem crediderunt, alii
Lunam: sunt qui Angeronam, quae digito ad os admoto silentium denuntiat: alii autem, quorum fides mihi
videtur firmior, Opem Consiviam esse dixerunt. Ipsius vero urbis nomen etiam doctissimis ignoratum est,
caventibus Romanis ne quod saepe adversus urbes hostium fecisse se noverant idem ipsi quoque hostili
evocatione paterentur, si tutelae suae nomen divulgaretur. Sed videndum ne quod nonnulli male
aestimaverunt nos quoque confundat, opinantes uno carmine et evocari ex urbe aliqua deos et ipse devotam
fieri civitatem. Nam repperi in libro quinto Rerum reconditarum Sammonici Sereni utrumque carmen, quod
ille se in cuiusdam Furii vetustissimo libro repperisse professus est. Est autem carmen huiusmodi quo di
evocantur, cum oppugnatione civitas cingitur: SI DEUS SI DEA EST CUI POPULUS CIVITASQUE
CARTHAGINIENSIS EST IN TUTELA, TEQUE MAXIME, ILLE QUI URBIS HUIUS POPULIQUE TUTELAM
RECEPISTI, PRECOR VENERORQUE VENIAMQUE A VOBIS PETO UT VOS POPULUM CIVITATEMQUE
CARTHAGINIENSEM DESERATIS, LOCA TEMPLA SACRA URBEMQUE EORUM RELINQUATIS
ABSQUE HIS ABEATIS, EIQUE POPULO CIVITATI METUM FORMIDINEM OBLIVIONEM INICIATIS,
PRODITIQUE ROMAM AD ME MEOSQUE VENIATIS, NOSTRAQUE VOBIS LOCA TEMPLA SACRA
URBS ACCEPTIOR PROBATIORQUE SIT, MIHIQUE POPULOQUE ROMANO MILITIBUSQUE MEIS
PRAEPOSITI SITIS UT SCIAMUS INTELLIGAMUSQUE. SI ITA FECERITIS, VOVEO VOBIS TEMPLA
LUDOSQUE FACTURUM. In eadem verba hostias fieri oportet auctoritatemque videri extorum, ut ea
promittant futura. Urbes vero exercitusque sic devoventur iam numinibus evocatis, sed dictatores
imperatoresque soli possunt devovere his verbis: DIS PATER VEIOVIS MANES, SIVE QUO ALIO NOMINE
FAS EST NOMINARE, UT OMNES ILLAM URBEM CARTHAGINEM EXERCITUMQUE QUEM EGO ME
SENTIO DICERE FUGA FORMIDINE TERRORE CONPLEATIS, QUIQUE ADVERSUM LEGIONES
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
147
EXERCITUMQUE NOSTRUM ARMA TELAQUE FERENT, UTI VOS EUM EXERCITUM EOS HOSTES
EOSQUE HOMINES URBES AGROSQUE EORUM ET QUI IN HIS LOCIS REGIONIBUSQUE AGRIS
URBIBUSVE HABITANT ABDUCATIS LUMINE SUPERO PRIVETIS EXERCITUMQUE HOSTIUM URBES
AGROSQUE EORUM QUOS ME, SENTIO DICERE, UTI VOS EAS URBES AGROSQUE CAPITA
AETATESQUE EORUM DEVOTAS CONSECRATASQUE HABEATIS OLLIS LEGIBUS QUIBUS
QUANDOQUE SUNT MAXIME HOSTES DEVOTI.
EOSQUE EGO VICARIOS PRO ME FIDE
MAGISTRATUQUE MEO PRO POPULO ROMANO EXERCITIBUS LEGIONIBUSQUE NOSTRIS DO
DEVOVEO, UT ME MEAMQUE FIDEM IMPERIUMQUE LEGIONES EXERCITUMQUE NOSTRUM QUI IN
HIS REBUS GERUNDIS SUNT BENE SALVOS SIRITIS ESSE. SI HAEC ITA FAXITIS UT EGO SCIAM
SENTIAM INTELLEGAMQUE, TUNC QUISQUIS HOC VOTUM FAXIT UBI FAXIT RECTE FACTUM ESTO
OVIBUS ATRIS TRIBUS. TELLUS MATER TEQUE IUPPITER OBTESTOR. Cum Tellurem dicit, manibus
terram tangit: cum Iovem dicit, manus ad caelum tollit: cum votum recipere dicit, manibus pectus tangit. In
antiquitatibus autem haec oppida inveni devota; * Stonios Fregellas Gavios Veios Fidenas, haec intra
Italiam, praeterea Carthaginem et Corinthum; sed et multos exercitus oppidaque hostium Gallorum
Hispanorum Afrorum Maurorum aliarumque gentium quas prisci locuntur annales. Hinc ergo est quod
propter huiusmodi evocationem numinum discessionemque ait Virgilius:
Excessere omnes adytis arisque relictis
Di, et ut tutelares designaret, adiecit:
quibus imperium hoc steterat
Utque praeter evocationem etiam vim devotionis ostenderet, in qua praecipue Iuppiter, ut diximus,
invocatur, ait:
— Ferus omnia Iuppiter Argos
Transtulit.
Videturne vobis probatum sine divini et humani iuris scientia non posse profunditatem Maronis intellegi?
[Testo Internet Lacus Curtius da ricontrollare]
[9] Varrone nella sua opera sui Costumi dice che l'usanza risiede in un giudizio dell'animo, a cui
deve seguire la consuetudine. Sesto Festo nel libro XIII dell'opera sul Significato delle parole
afferma: «L'usanza è un'istituzione patria relativa alla religione e alle pratiche del culto dei nostri
antenati ». [10] Quindi Virgilio seguì entrambi gli autori, e anzitutto Varrone: poiché questi aveva
detto che l'usanza precede e la consuetudine segue, egli, dopo aver detto «c'era un'usanza »,
soggiunse «che poi le città Albane osservarono » e quindi «ora la grandissima Roma osserva »;
con ciò indica la persistenza della consuetudine. [11] E poiché Festo asserisce che è in relazione
con le pratiche del culto, Virgilio Marone dà anche questa nozione aggiungendo “sacra”: o che poi
le città Albane osservarono sacra ». [12] Dunque l'usanza precedette e dopo venne l'osservazione
dell'usanza, cioè la consuetudine: anche qui tenne conto della definizione di Varrone.
Aggiungendo poi “sacra” indica l'usanza applicata alle pratiche del culto, come asserì Festo. [13]
La stessa scrupolosa precisione si nota anche nel libro XII, là dove dice:
usanza e riti sacrificali
aggiungerò,
ove dimostra chiaramente che l'usanza sono i riti sacrificali. [14] Ma si è anche rivelato fedele alla
storia in questi versi « c'era nel Lazio Esperio un'usanza » ecc. Conservò l'ordine di successione
dei regni, in quanto prima regnarono i Latini, poi gli Albani e infine i Romani. Perciò prima disse
“c'era nel Lazio Esperio un'usanza”, quindi “che poi le città Albane osservarono sacra”, infine
aggiunse “ora la grandissima Roma osserva”.
[9,1]
Uscirono tutti, lasciati i templi e gli altari,
gli dèi su cui si reggeva questo impero.
L'espressione è desunta da un'antichissirna usanza dei Romani e dai più segreti misteri sacri. [2] È
noto che tutte le città si trovano sotto la protezione di un dio. Fu usanza dei Romani, segreta e
sconosciuta a molti, che, quando assediavano una città nemica e confidavano di poterla ormai
conquistare, ne chiamassero fuori gli dèi protettori con una determinata formula di evocazione; e
ciò o perché ritenevano di non potere altrimenti conquistare la città o, anche se fosse possibile,
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
148
giudicavano sacrilegio prendere prigionieri gli dèi. [3] Questo è anche il motivo per cui i Romani
vollero che rimanesse ignoto il dio sotto la cui protezione è posta la città di Roma e ìl nome latino
della città stessa. [4] In verità il nome del dio si trova in alcuni libri di antichi autori, per quanto
discordi fra loro, e quindi gli studiosi dell'antichità riuscirono a conoscere ogni opinione in
proposito: alcuni lo credettero Giove, altri Lua, certuni Angerona, che con un dito sulla bocca
intima silenzio; altri infine, e questa mi sembra credenza più fondata, affermarono trattarsi di Ope
Consivia. [5] invece il nome della città è sconosciuto anche ai più dotti, poiché i Romani presero
ogni precauzione: volevano evitare, in caso di divulgazione del name tutelare, di dover subire, in
séguito ad evocazione dei nemici, ciò che sapevano di aver fatto spesso nei confronti di città
nemiche. [6] Però bisogna stare attenti a non incorrere anche noi nell'errore commesso da alcuni,
ritenendo che un'unica formula servisse per evocare gli dèi da una città e renderla maledetta. Nel
libro V delle Cariosiià di Sammonico Sereno ho trovato l'una e l'altra formula di incantesimo: ed
egli dichiara di averle rinvenute in un antichissimo libro di un certo Furio. [7] Ed ecco la formula
usata per evocare gli dèi quando si cinge d'assedio una città': o Se v'è un dio o una dea sotto la
cui protezione si trova il popolo e lo stato cartaginese, e te soprattutto che accogliesti sotto la tua
protezione questa città e questo popolo, io prego e venero, e vi chiedo questa grazia: abbandonate
il popolo e lo stato cartaginese, lasciate i loro luoghi, templi, riti e città, [8] allontanatevi da essi e
incutete al popolo e allo stato timore, paura, oblio, e venite propizi a Roma da me e dai miei, e i
nostri luoghi, templi, riti e città siano a voi più graditi e cari, e siate propizi a me, al popolo romano
e ai miei soldati. Se farete <ciò> in modo che sappiamo e comprendiamo, vi prometto in voto
templi e giochi o. [9] A queste parole bisogna far seguire immolazione di vittime e consultazione di
visceri per ottenerne assicurazione. Quando poi sono già state evocate le divinità, si pronuncia la
maledizione sulle città e sugli eserciti, ma possono farlo soltanto i dittatori e i generali con le
seguenti parole: [10] o O padre Dite, Veiove, Mani, o con qualsiasi altro nome sia lecito nominarvi,
riempite di fuga, di paura e di terrore tutti, la città di Cartagine e l'esercito che io intendo dire, e
quelli che porteranno armi e dardi contro le nostre legioni e il nostro esercito, portate via con voi
quell'esercito, quei nemici e quegli uomini, le loro città e i loro campi e quelli che abitano in questi
luoghi e regioni, nei campi e nelle città, privateli della luce del sole, e così l'esercito nemico, le città
e i campi di coloro che io intendo dire, e voi considerate maledette e a voi consacrate quelle città e
quei campi, le persone e le generazioni, secondo le leggi e i casi per cui soprattutto son maledetti i
nemici. [11] Io li do e li consacro in voto come sostituti per me, per la mia persona e la mia carica,
per il popolo romano, per il nostro esercito e le nostre legioni, affinché lasciate sani e salvi me, la
mia persona e il mio comando, le nostre legioni e il nostro esercito impegnati in questa impresa.
Se farete ciò in modo che io sappia, intenda e capisca, allora chiunque farà questo voto, dovunque
lo faccia, sarà valido se compiuto con tre pecore nere. <Te,> madre Terra, e te, Giove, prendo a
testimoni ». [ia] Quando nomina la Terra, tocca la terra con le mani; quando nomina Giove, inalza
le mani al cielo; quando dice di impegnarsi nel voto, si tocca il petto con le mani. [13] Mi risulta che
nei tempi antichi furono maledette le seguenti città: Turi, Fregelle, Gavi, Veio, Fidene, entro i
confini d'Italia; inoltre Cartagine e Corinto, e molti altri eserciti e città nemiche in Gallia, in Spagna,
in Africa, in Mauritania e in altre regioni, di cui parlano gli antichi annali. [14] Di qui dunque ha
origine la frase di Virgilio per questa evocazione e spostamento di divinità: o uscirono tutti, lasciati i
templi e gli altari, gli dèi... »; e per indicare che si trattava di numi tutelari, aggiunse: o su cui si
reggeva questo impero». [15] E per mostrare, oltre all'evocazione, anche la forza della
maledizione, in cui, come abbiamo detto, si invoca specialmente Giove, dice:
l'aspro Giove ad Argo tutto trasferì.
Trad. N. Marinone, Utet, Torino
Scansione brano successivo
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
149
Bibliografia
I riferimenti e le fonti alle profezie di Marcio in FPL Blansdorf 1995, pp. 14-15.
Evocatio e devotio
Prima di attaccare una città i soldati recitavano un carmen per attirare (evocatio) su di loro il favore
degli dei e un altro per consacrare la città nemica agli dei inferi (devotio).
Testi e testimonianze
Controllo Macrobio per testo di evocatio e devotio relativi alla presa di Cartagine, tratti dalla
raccolta di Lucio Furio Filo, console nel 136 a.C.
3,9,6
Livio, 8,9, 6-8. Un esempio di devotio: Decio Mure
L'episodio risale alla guerra dei Romani contro i Latini (340-338 a.C.), insorti alla conclusione della
prima guerra sannitica, e in particolare alla battaglia presso il Vesuvio (338).
Analogo comportamento tenne il figlio omonimo di P. Decio Mure nel corso della battaglia di
Sentino (295 a.C.), con la quale si concluse la terza guerra sannitica (298-290 a.C.), nonché il
nipote, nel corso della battaglia di Ascoli, persa dai Romani contro Pirro.
In hac trepidatione Decius consul M. Ualerium magna uoce inclamat. 'deorum' inquit, 'ope, M. Ualeri, opus
est; agedum, pontifex publicus populi Romani, praei uerba quibus me pro legionibus deuoueam.'
Pontifex eum togam praetextam sumere iussit et uelato capite, manu subter togam ad mentum exserta,
super telum subiectum pedibus stantem sic dicere: 'Iane, Iuppiter, Mars pater, Quirine, Bellona, Lares, Diui
Nouensiles, Di Indigetes, Diui, quorum est potestas nostrorum hostiumque, Dique Manes, uos precor
ueneror, ueniam peto feroque, uti populo Romano Quiritium uim uictoriam prosperetis hostesque populi
Romani Quiritium terrore formidine morteque adficiatis. sicut uerbis nuncupaui, ita pro re publica <populi
Romani> Quiritium, exercitu, legionibus, auxiliis populi Romani Quiritium, legiones auxiliaque hostium
mecum Deis Manibus Tellurique deuoueo.'
haec ita precatus lictores ire ad T. Manlium iubet matureque collegae se deuotum pro exercitu nuntiare; ipse
incinctus cinctu Gabino, armatus in equum insiluit ac se in medios hostes immisit, conspectus ab utraque
acie, aliquanto augustior humano uisu, sicut caelo missus piaculum omnis deorum irae qui pestem ab suis
auersam in hostes ferret.
In un momento tanto confuso, il console Decio chiama a gran voce Marco Valerio: "Marco Valerio,
abbiamo bisogno dell'aiuto degli dei. Coraggio, pontefice ufficiale del popolo romano, insegnami la
formula ufficiale che devo recitare mentre mi sacrifico per le legioni". Queste le disposizioni del
pontefice: indossare la toga pretesta, velarsi il capo, tirar fuori la mano da sotto la toga e toccarsi il
mento, stare in piedi sopra un giavellotto. E queste erano le parole della formula. "Giano, Giove,
Marte padre, Quirino, Bellona, lari, dei stranieri ed indigeti, dei che avete potere su di noi e sui
nostri nemici, dei mani, voi prego, voi venero, a voi, sicuro di ottenerla, chiedo questa grazia:
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
150
concedete benigni al popolo romano dei Quiriti la forza e la vittoria e colpite col terrore, col panico,
con la morte i nemici del popolo romano dei Quiriti. Come ho annunciato con le parole, così ora
per la repubblica del popolo romano dei Quriti, per l'esercito, per le legioni, per chi aiuta il popolo
romano dei Quiriti, faccio voto agli dei mani e alla Terra, assieme a me, delle legioni amiche e di
chi le aiuta". Pronunciata qiesta formula, ordina ai littori di recarsi da Tito Manlio e di annunciare
subito che egli aveva fatto voto di se stesso per l'esercito. Strettasi attorno la toga come sogliono
fare i Gabini, montò a cavallo armato e si gettò nel folto dllo schieramento nemico. entrambi gli
eserciti videro allora in lui un uomo molto più maestoso del normale, quasi fosse inviato dal cielo
ad espiare tutta l'ira degli dei e ad allontanare la rovina dei suoi gettandola sui nemici.
Traduzione G.D. Mazzocato, Roma, Newton Compton, 1997.
Liv., 8,11,2. Livio spiega la natura della devotio.
Il passo viene a naturale spiegazione di quello precedentemente riportato. Il console P. Decio
Mure si è lanciato tra i nemici e ha perso la vita. Il suo cadavere viene trovato dai Romani solo
dopo tre giorni, in mezzo a un gran cumulo di nemici e coperto di frecce.
Illud adiciendum uidetur licere consuli dictatorique et praetori, cum legiones hostium deuoueat, non utique se
sed quem uelit ex legione Romana scripta ciuem deuouere; si is homo qui deuotus est moritur, probe factum
uideri; ni moritur, tum signum septem pedes altum aut maius in terram defodi et piaculum [hostia] caedi; ubi
illud signum defossum erit, eo magistratum Romanum escendere fas non esse. sin autem sese deuouere
uolet, sicuti Decius deuouit, ni moritur, neque suum neque publicum diuinum pure faciet, siue hostia siue quo
alio uolet. qui sese deuouerit, Uolcano arma siue cui alii diuo uouere uolet ius est. telo, super quod stans
consul precatus est, hostem potiri fas non est; si potiatur, Marti suouetaurilibus piaculum fieri. haec, etsi
omnis diuini humanique moris memoria aboleuit noua peregrinaque omnia priscis ac patriis praeferendo,
haud ab re duxi uerbis quoque ipsis, ut tradita nuncupataque sunt, referre.
Credo di dover aggiungere qualcosa. Il console, il dittatore, il pretore quando fa voto alle legioni dei
nemici, può anche non accumunare al voto se stesso, ma può offrire uno qualunque purchè
cittadino e purchè regolarmente arruolato. Se l'uomo offerto agli dei muore, questo vuol dire che il
voto è accetto agli dei. Se non muore, allora bisogna seppellire in terra un fantoccio alto sette piedi
o più e sacrificare una vittima in espiazione. Nessun magistrato romano può calpestare il terreno
dove è stato sepolto quel fantoccio. Se invece vuole fare voto di se stesso, come nel caso di
Decio, ma poi non muore, non potrà più compiere, senza essere contaminato da sacrilegio, alcun
atto rituale né privato, né pubblico sia che si tratti di un sacrificio sia che si tratti di qualsiasi altro
rito. Colui che ha fatto voto di se stesso, può, didiritto, far voto delle sue armi, a Vulcano o a
qualsiasi altro dio. E' sacrilegio che il nemico si impadronisca del giavellotto stando in piedi sul
quale il console ha invocato gli dei; se quel giavellotto cade in mano ai nemici bisogna offrire un
suovetaurilia in espiazione a Marte. Ho pensato che non fosse estraneo alla narrazione storica
riferire questi atti religiosi con le stesse parole con cui furono istituiti e vengono tramandati, anche
se sono scomparse dalla memoria le antiche tradizioni umane e divine e anche se gli antichi riti
patrii sono stati soppiantati da riti stranieri di recente importazione.
Traduzione G.D. Mazzocato, Roma, Newton Compton, 1997.
Liv., 5, 21, 1. Camillo pronuncia l'evocatio di Giunone prima di attaccare Veio.
L'episodio si riferisce all'attacco con cui si concluse il lungo assedio di Veio (406-395). Camillo
invita Giunone, fatta segno di particolare culto a Veio, ad abbandonare la città etrusca e a seguire i
Romani nella loro città. Livio ci racconta anche come in effetti una statua di Giunone, fosse
trasportata a Roma e collocata in un nuovo tempio sull'Aventino.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
151
Ingens profecta multitudo repleuit castra. tum dictator auspicato egressus cum edixisset ut arma milites
caperent, 'tuo ductu' inquit, 'Pythice Apollo, tuoque numine instinctus pergo ad delendam urbem Ueios,
tibique hinc decimam partem praedae uoueo. te simul, Iuno regina, quae nunc Ueios colis, precor, ut nos
uictores in nostram tuamque mox futuram urbem sequare, ubi te dignum amplitudine tua templum accipiat'.
haec precatus, superante multitudine ab omnibus locis urbem adgreditur, quo minor ab cuniculo ingruentis
periculi sensus esset.
Da Roma partì una folla immensa che si riversò negli accampamenti. Il dittatore, allora, trasse gli
auspici e uscì dalla sua tenda, ordinando ai soldati di prendere le armi e pronunciando questa
invocazione. "Sotto la tua guida, Apollo Pitico, e stimolato dalla tua volontà, mi accingo a
distruggere Veio e faccio voto di consacrare a te la decima parte del bottino. E insieme prego te,
Giunone Regina che ora risiedi in Veio, di seguire noi vincitori nella nostra città che presto
diventerà anche la tua perché lì ti accoglierà un tempio degno della tua grandezza".
Liv. 5, 22, 3
Cum iam humanae opes egestae a Ueiis essent, amoliri tum deum dona ipsosque deos, sed colentium
magis quam rapientium modo, coepere. namque delecti ex omni exercitu iuuenes, pure lautis corporibus,
candida ueste, quibus deportanda Romam regina Iuno adsignata erat, uenerabundi templum iniere, primo
religiose admouentes manus, quod id signum more Etrusco nisi certae gentis sacerdos attractare non esset
solitus. dein cum quidam, seu spiritu diuino tactus seu iuuenali ioco, 'uisne Romam ire, Iuno?' dixisset,
adnuisse ceteri deam conclamauerunt. inde fabulae adiectum est uocem quoque dicentis uelle auditam;
motam certe sede sua parui molimenti adminiculis, sequentis modo accepimus leuem ac facilem tralatu
fuisse, integramque in Auentinum aeternam sedem suam quo uota Romani dictatoris uocauerant perlatam,
ubi templum ei postea idem qui uouerat Camillus dedicauit. hic Ueiorum occasus fuit,
Quando tutte le ricchezze umane erano già state portate via da Veio, si intraprese la rimozione
degli ex-voto e dei simulacri degli dei, ma allora l'atteggiamento dei Romani divenne più simile a
quello dei devoti che a quello dei predoni. Infatti, dei giovni selezionati da tutto l'esercito, lavati e
purificati nel corpo, in veste candida ricevettero l'incarico di trasportare a Roma il simulacro di
Giunone Regina; entrarono con atteggiamento devoto nel tempio e, in un primo momento,
accostarono le mani con un gesto improntato alla massima devozione, perché, secondo la liturgia
etrusca, solo un sacerdote di una determinata famiglia era solito toccare quella statua. Poi uno di
quei soldati, forse ipsirato da un dio forse per uno scherzo tipico nei giovani, ebbe a dire:
"Giunone, vuoi venire a Roma?", e tutti gli altri urlarono che la dea aveva fatto cenno di assenso.
La leggenda aggiunge anche che si udì una parola della dea che affermava essere quella la sua
volontà. E' comunque certo che la statua, rimossa dalla sua sede per mezzo di semplicissime leve,
non richiese grande sforzo e impegno per il suo trasporto, come se consentisse a seguire i
Romani. Fu trasportata assolutamente indenne sull'Aventino, sua sede eterna, dove era stata
chiamata dal voto del dittatore romano.
Traduzione G.D. Mazzocato, Roma, Newton Compton, 1997.
Plin., nat. 28, 3 (10-13)
Ex homine remediorum primum maximae quaestionis et semper incertae est, polleantne aliquid verba et
incantamenta carminum. quod si verum est, homini acceptum fieri oportere conveniat, sed viritim
sapientissimi cuiusque respuit fides, in universum vero omnibus horis credit vita nec sentit. quippe victimas
caedi sine precatione non videtur referre aut deos rite consuli. praeterea alia sunt verba inpetritis, alia
depulsoriis, alia commen<d>ationis, videmusque certis precationibus obsecrasse summos magistratus et, ne
quod verborum praetereatur aut praeposterum dicatur, de scripto praeire aliquem rursusque alium custodem
dari qui adtendat, alium vero praeponi qui favere linguis iubeat, tibicinem canere, ne quid aliud exaudiatur,
utraque memoria insigni, quotiens ipsae dirae obstrepentes nocuerint quotiensve precatio erraverit; sic
repente extis adimi capita vel corda aut geminari victima stante. durat inmenso exemplo Deciorum patris
filiique, quo se devovere, carmen; extat Tucciae Vestalis incest<i d>e precatio, qua usa aquam in cribro tulit
anno urbis DXVIIII. boario vero in foro Graecum Graecamque defossos aut aliarum gentium, cum quibus tum
res esset, etiam nostra aetas vidit. cuius sacri precationem, qua solet praeire XV virum collegii magister, si
quis legat, profecto vim carminum fateatur, omnia ea adprobantibus DCCCXXX annorum eventibus.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
152
Vestales nostras hodie credimus nondum egressa urbe mancipia fugitiva retinere in loco precatione, cum, si
semel recipiatur ea ratio, et deos preces aliquas exaudire aut ullis moveri verbis, confitendum sit de tota
coniectatione.
[3] A proposito dei rimedi tratti dall'uomo, ci si chiede prima di tutto, questione molto importante e sempre
dibattuta, se le formule e gli incantesimi abbiano realmente qualche potere. In caso affermativo, tutto questo
dovrebbe diventare, senza contrasto di opinioni, patrimonio del sapere umano. Ma, individualmente, le
persone piú sagge rifiutano questa credenza, che invece in una dimensione universale, è in tutti i momenti
accolta, anche se in maniera inconscia. Infatti immolare le vittime o consultare gli dèi secondo il rito,
sembrano atti inefficaci, se non sono accompagnati dalla preghiera. Altre poi sono le parole delle preghiere
per ottenere auguri favorevoli, altre quelle delle deprecazioni, altre ancora quelle delle raccomandazioni, e
vediamo che i sommi magistrati usano un linguaggio fisso nelle suppliche, e per evitare l'omissione o
l'inversione di qualche termine, c'è sempre qualcuno che legge prima dal testo scritto, un altro sorvegliante
preposto a controllare l'esattezza, una terza persona con l'incarico di far rispettare il silenzio, mentre un
flautista intanto suona per coprire qualsiasi altra parola estranea alla cerimonia. Infatti si ricordano questi
due eventi notevoli: ogni qualvolta certe imprecazioni hanno disturbato e danneggiato lo svolgimento di un
rito o la preghiera è stata male recitata, subito sono scomparsi il capo delle viscere o il cuore, oppure queste
parti sono state trovate doppie senza che la vittima sia stata mossa. Si conserva come esempio di
eccezionale importanza la formula pronunciata dai Deci padre e figlio nell'atto di offrirsi in olocausto, resta la
preghiera deprecatoria contro l'accusa d'incesto della vestale Tuccia, recitando la quale essa riusci a portare
acqua in uno staccio, l'anno 519 di Roma [235 a. C.]. Anche la nostra generazione ha visto sotterrare vivi nel
foro Boario un greco e una greca o persone appartenenti ad altri popoli con cui si era allora in guerra.
Leggendo la preghiera di questo sacrificio nella forma abitualmente usata dal capo del collegio dei
quindecemviri, si dovrà per forza ammettere il potere di questi incantesimi, ampiamente confermato
d'altronde da 830 anni di storia. Anche oggi crediamo che le nostre Vestali possano con una loro preghiera
bloccare sul posto gli schiavi in fuga non ancora usciti dalla città. Allora, una volta accolta questa opinione e
ammesso che gli dèi esaudiscono certe preghiere o si lasciano influenzare da qualche parola, non resta che
riconoscere la validità della congettura nel suo insieme.
Trad. U. Capitani, Torino, Utet, 1986 [BCTV]
Bibliografia
Bettini, 1, 66
Carmina triumphalia
Quanto sia ampia la gamma di significati del termine carmen sottolineano altre testimonianze che
riportano nuovamente all’ambito militare, segnatamente alla circostanza del trionfo, ove carmen
vale canzone scomposta, talvolta ridotta a semplice strofa, di sapore mordace.
Mentre Livio ne ricorda genericamente il carattere, Svetonio trascrive il testo di alcuni carmina
rivolti all’indirizzo di Cesare dai suoi soldati.
Testi e testimonianze
Liv., 3, 29, 4-6
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
153
Romae a Q. Fabio praefecto urbis senatus habitus triumphantem Quinctium quo ueniebat agmine urbem
ingredi iussit. ducti ante currum hostium duces; militaria signa praelata; secutus exercitus praeda onustus.
epulae instructae dicuntur fuisse ante omnium domos, epulantesque cum carmine triumphali et sollemnibus
iocis comisantium modo currum secuti sunt.
A Roma il senato, convocato dal prefetto della città Quinto Fabio, predispose che Quinzio nello
stesso ordine di marcia con cui si avvicinava alla città, facesse il suo ingresso con gli onori del
trionfo. Davanti al carro trionfale venivano trascinati i comandanti nemici; poi, precedendo
l'esercito che marciava carico di bottino, venivano tutte le insegne militari. Si racconta che,
davanti ad ogni casa, fosse allestito un banchetto: tutti quelli che vi partecipavano poi
prendevano a seguire il carro con canti adatti al trionfo e con gli scherzi rituali che compiono
quelli che usano andare in giro a far baldoria.
Trad. Mazzocato
Liv., 4,20,1
Omnibus locis re bene gesta, dictator senatus consulto iussuque populi triumphans in urbem rediit. longe
maximum triumphi spectaculum fuit Cossus, spolia opima regis interfecti gerens; in eum milites carmina
incondita aequantes eum Romulo canere. spolia in aede Iouis Feretri prope Romuli spolia quae, prima
opima appellata, sola ea tempestate erant, cum sollemni dedicatione dono fixit.
20. L'impresa si concluse dunque felicemente in ogni settore della battaglia; il dittatore, per
decreto del senato e per volontà del popolo, tornò a Roma con gli onori del trionfo. Ma il più
ammirato durante il trionfo fu di gran lunga Cosso che portava le spoglie o pime del re ucciso;
al suo indirizzo i soldati cantavano grossolane canzoni in cui lo paragonavano a Romolo . Le
spoglie furono affisse in dono nel tempio di Giove Feretrio, con la dedica rituale, presso le
spoglie di Romolo, le prime che siano state chiamate opime (e anche le uniche fino a quel
momento).
Trad. Mazzocato
Liv., 7, 10
Iacentis inde corpus ab omni alia uexatione intactum uno torque spoliauit, quem respersum cruore collo
circumdedit suo. defixerat pauor cum admiratione Gallos: Romani alacres ab statione obuiam militi suo
progressi, gratulantes laudantesque ad dictatorem perducunt. Inter carminum prope modo incondita
quaedam militariter ioculantes Torquati cognomen auditum; celebratum deinde posteris etiam familiae honori
fuit. dictator coronam auream addidit donum mirisque pro contione eam pugnam laudibus tulit.
Evitò di arrecare qualsiasi altra offesa al corpo disteso del nemico e si limitò a spogliarlo di una
collana che, ancora grondante sangue, si mise al collo. Terrore e ammirazione insieme,
inchiodarono i Galli al loro posto; i Romani, esultanti, si avanzarono dalle loro posizioni verso il
commilitone: congratulandosi e lodandolo lo portano dal dittatore. Tra le scherzose battute ìn
versi che i soldati sono solitì scambiarsi, si sentì fare il soprannome di Torquato: soprannome
che rimase famoso presso i posteri e costituì tìtolo di onore anche per la famiglia. Il dittatore gli
fece dono di una corona d'oro e lo esaltò con grandi lodi per il suo combattimento davanti
all'assemblea dei commilitoni.
Trad. Mazzocato
Suet., Iul. 50
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
154
Gallico denique triumpho milites eius inter cetera carmina, qualia currum prosequentes ioculariter canunt,
etiam illud uulgatissimum pronuntiauerunt:
Gallias Caesar subegit, Nicomedes Caesarem:
ecce Caesar nunc triumphat qui subegit Gallias,
Nicomedes non triumphat qui subegit Caesarem.
E infine durante il trionfo gallico i suoi soldati, tra le altre strofette scherzose che è costume
intonare seguendo il carro, cantavano anche questi versi che ebbero un'immensa popolarità:
"Cesare conquistò le Gallie, Nicomede Cesare:
ecco ora trionfa Cesare, che conquistò le Gallie,
e non trionfa Nicomede, che conquistò Cesare!"
Suet., Iul , 51
Ne prouincialibus quidem matrimoniis abstinuisse uel hoc disticho apparet iactato aeque a militibus per
Gallicum triumphum:
urbani, seruate uxores: moechum caluom adducimus.
aurum in Gallia effutuisti, hic sumpsisti mutuum.
Che non rispettasse le donne sposate, nemmeno nelle provincie, risulta da questi versi che
parimenti i soldati cantavano durante il trionfo gallico:
"Cittadini, chiudete le vostre donne!
Portiamo con noi un calvo scostumato!"
e anche
"Ti sei fottuto, in Gallia, l'oro;
qui l'hai preso a prestito".
Plin., nat. 19, 144
Nec non olus quoque silvestre est, triumpho divi Iuli carminibus praecipue iocisque militaribus celebratum;
alternis quippe versibus exprobravere lapsana se vixisse aput Dyrrachium, praemiorum parsimoniam
cavillantes. est autem id cyma silvestris.
Cf. anche Vell. 2, 67,3
Eoque inter iocos militares, qui currum Lepidi Plancique secuti erant, inter execrationem ciuium usurpabant
hunc uersum:
De germanis, non de Gallis duo triumphant consules.
Per questo i soldati che avevano seguitoil cocchio trionfale di Lepido e Planco in mezzo
all’esecrazione dei cittadini ripetevano tra i motteggi questo verso :
“Sui germani, non sui Galli i due consoli trionfano”.
Trad. L. Agnes, Torino, Utet, 1969.
Gell. 15,4,3
In isto quaestu notum esse coepisse C. Caesari et cum eo profectum esse in Gallias; tum, quia in ea
prouincia satis nauiter uersatus esset et deinceps ciuili bello mandata sibi pleraque inpigre et strenue
fecisset, non modo in amicitiam Caesaris, sed ex ea in amplissimum quoque ordinem peruenisse; mox
tribunum quoque plebi ac deinde praetorem creatum atque in eo tempore iudicatum esse a senatu hostem
cum M. Antonio; post uero coniunctis partibus non pristinam tantum dignitatem reciperasse, sed pontificatum
ac deinde consulatum quoque adeptum esse, eamque rem tam intoleranter tulisse populum Romanum, qui
Ventidium Bassum meminerat curandis mulis uictitasse, ut uulgo per uias urbis uersiculi proscriberentur:
concurrite omnes augures, haruspices!
portentum inusitatum conflatum est recens:
nam mulos qui fricabat, consul factus est.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
155
Bibliografia
niente ICCU per carmina triumphalia soggetto
Versus populares in Caesarem et similia in FPL Blansdorf 1995, pp. 191-194.
Carmina funebri
Alla circostanza della morte e della cerimonia funebre relativa sono legati altre espressioni della
civiltà romana antica, la maggior parte delle quali molto semplici e di natura essenzialmente orale,
altre più elaborate, almeno nel caso di uomini di rango o di famiglie conosciute, che potevano
configurarsi come veri e propri discorsi funebri di elogio.
Ad essi sono chiaramente collegati dallo scopo gli elogia che vanno ad ornare iscrizioni sepolcrali,
alcune delle quali rimasteci.
Testi e testimonianze
Non., ??
Nenia ineptum et inconditum carmen, quod a conducta muliere, quae praefica diceretur, eis, quibus
propinqui non essent, mortuis exhiberetur, Varro de vita pop. Rom., lib. IIII: ibi a muliere, quae optuma voce
esset, perquam laudari; dein neniam cantari solitam ad tibiam et fides.
Cic., Brutus, 61
Hunc igitur Cethegum consecutus est aetate Cato, qui annis ix post eum fuit consul. eum nos ut perveterem
habemus, qui L. Marcio M'. Manilio consulibus mortuus est, annis lxxxvi ipsis ante me consulem. nec vero
habeo quemquam antiquiorem, cuius quidem scripta proferenda putem, nisi quem Appi Caeci oratio haec
ipsa de Pyrrho et nonnullae mortuorum laudationes forte delectant. et hercules eae quidem exstant: ipsae
enim familiae sua quasi ornamenta ac monumenta servabant et ad usum, si quis eiusdem generis
occidisset, et ad memoriam laudum domesticarum et ad illustrandam nobilitatem suam. quamquam his
laudationibus historia rerum nostrarum est facta mendosior. multa enim scripta sunt in eis quae facta non
sunt: falsi triumphi, plures consulatus, genera etiam falsa et ad plebem transitiones, cum homines humiliores
in alienum eiusdem nominis infunderentur genus; ut si ego me a M'. Tullio esse dicerem, qui patricius cum
Ser. Sulpicio consul anno x post exactos reges fuit.
[61] Dopo questo Cetego viene riguardo al tempo Catone, che fu console 9 anni dopo di lui.
Questi, che per noi è un oratore antichissimo, morì sotto il consolato di L. Marcio e di Manio
Manilio, esattamente 86 anni prima del mio consolato. [16] E in verità non c'è un oratore più antico,
di cui io ritenga che si possano citare i discorsi, a meno che qualcuno non si accontenti di quel
famoso discorso su Pirro di Appio Claudio Cieco e di alcuni elogi funebri. [62] Di questi se ne
conservano parecchi: infatti le stesse famiglie li conservavano come titoli di onore e documenti
storici, perché fossero utilizzati per la celebrazione di qualche loro defunto e nello stesso tempo
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
156
servissero a tramandare la gloria e la nobiltà familiare. Purtroppo la storia del nostro paese è stata
deturpata da simili elogi. In essi sono registrati dei fatti che non sono mai avvenuti: falsi trionfi, un
numero di consolati superiore al reale, perfino false genealogie e passaggi al ceto plebeo, quando
uomini di bassa origine volevano mescolare la propria stirpe con un'altra che portava il medesimo
nome; come se io affermassi di discendere dal patrizio Manio Tullio, che fu console con Servio
Sulpicio dieci anni dopo la cacciata dei re.
Traduzione di G. Norcio, Torino, Utet, 1970.
Polibio, ???
Plin., 7, 139
Q. Metellus in ea oratione, quam habuit supremis laudibus patris sui L. Metelli pontificis, bis consulis,
dictatoris, magistri equitum, XV viri agris dandis, qui p<lu>rim<o>s elephantos ex primo Punico bello duxit in
triumpho, scriptum reliquit decem maximas res optimasque, in quibus quaerendis sapientes aetatem
exigerent, consummasse eum: voluisse enim primarium bellatorem esse, optimum oratorem, fortissimum
imperatorem, auspicio suo maximas res geri, maximo honore uti, summa sapientia esse, summum
senatorem haberi, pecuniam magnam bono modo invenire, multos liberos relinquere et clarissimum in
civitate esse; haec contigisse ei nec ulli alii post Romam conditam.
Quinto Metello nel discorso che tenne durante le onoranze funebri di suo padre Lucio Metello il
Pontefice - il quale fu due volte console, dittatore, comandante della cavalleria, quindecemviro per
l'assegnazione delle terre, e per primo, nella prima guerra punica, portò degli elefanti in trionfo lasciò scritto che egli aveva riassunto in sé le dieci qualità più grandi e belle, nella ricerca delle
quali i sapienti trascorrono la vita: aveva voluto essere un combattente di prim'ordine, un ottimo
oratore, un comandante valorosissimo; sotto il suo comando si erano compiute grandissime
imprese; aveva ricoperto le cariche più alte; era stato sommamente saggio, era stato considerato il
senatore più prestigioso, aveva messo insieme con mezzi leciti un grande patrimonio; lasciava
molti figli, era il cittadino più illustre.
Trad. G. Ranucci, Einaudi, Torino 1983.
L'orazione cui si fa riferimento ebbe luogo nel 221 a.C. A pronunciarla il figlio stesso di Lucio
Metello, Q. Cecilio Metello, console nel 206 a.C., lo stesso che rispose con i versi "Dabunt malum
Metelli Naevio poetae" alle parole di Nevio "Fato Metelli Romae fiunt consules".
Gell., 13,20,17
Gellio e Sulpicio Apollinare discutono con altri sull’identita di Marco Catone Nepote. Alla fine un
accenno a una raccolta di laudationes funebres e a un commentarium sulla famiglia Porcia.
Haec Sulpicius Apollinaris audientibus nobis dixit. Quae postea ita esse, uti dixerat, cognouimus, cum et
laudationes funebres et librum commentarium de familia Porcia legeremus.
Questo ci disse Sulpicio Apollinare a noi che l’ascoltavamo. E ci accorgemmo poi che le cose
stavano come egli le aveva esposte, quando leggemmo gli Elogi funebri e il Commentario sulla
famiglia Porcia.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
157
Bibliografia
Sulle laudationes funebri un'edizione di J.G.Taifacos, Amsterdam 1987.
Autore: Taifacos, Ioannis G.
Titolo: Una laudatio funebris di M. Catone Nepote : dalla testimonianza di Aulo Gellio / Ioannis G.
Taifacos
Pubblicazione: Roma : (s.n.), s.n.
Descrizione fisica: 22 p. ; 25 cm.
Nomi: Taifacos , Ioannis G.
Controllo ICCU inutile per soggetto “laudationes”
Carmina convivalia
Con carmen vengono indicate altre espressioni orali legate all’ambito dei banchetti, canti di lode di
uomini famosi.
Cicerone (Brutus) ne lamenta la perdita e cita, per suffragare la sua affermazione, la testimonianza
di Catone (Origines).
Orazio (carm.) ci ricorda che tali canti erano accompagnati da strumenti e potevano avere come
tema, appunto, gesta e imprese di guerra.
Testi e testimonianze
Cic., Brutus, 75
Recte, inquam, Brute, intellegis. atque utinam exstarent illa carmina, quae multis saeclis ante suam aetatem
in epulis esse cantitata a singulis convivis de clarorum virorum laudibus in Originibus scriptum reliquit Cato.
"Hai pienamente ragione, o Bruto. E volesse il cielo che rimanessero ancora quei carmi che,
stando a Catone nelle Origini, i singoli convitati cantavano nei banchetti in onore degli uomini
illustri!"
Hor., carm., 4, 15, 25-32
nosque et profestis lucibus et sacris
inter iocosi munera Liberi
cum prole matronisque nostris
rite deos prius adprecati
virtute functos more patrum duces
Lydis remixto carmine tibiis
Troiamque et Anchisen et almae
progeniem Veneris canemus.
e noi in giorni comuni e feste grandi
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
158
nella grazia di Dioniso sereno,
insieme ai figli ed alle nostre donne,
dopo le giuste suppliche agli Dei,
canteremo; e accompagnerà il canto
il flauto lidio: condottieri morti
con il cuore dei padri, Troia, Anchise,
e la stirpe di Venere feconda.
Traduzione di E. Mandruzzato, Milano, Rizzoli, 1985.
Bibliografia
Elogia
Elogi degli Scipioni (LL CD d'Anna con Traduzione + Bettini)
Lucio Cornelio Scipione Barbato fu console nel 298 a.C..
Il suo elogium, al pari di quello del figlio, console nel 259, proviene dal sepolcro degli Scipioni sulla
via Appia, fuori Porta Capena. La lastra tombale è mutila sul lato destro. Si tratta di rifacimenti
delle iscrizioni originarie.
L'elogium è scritto in saturni, il cui schema base deriverebbe dall'accostamento di due emistichi, il
primo rappresentato da tre giambi e mezzo o se si preferisce da un dimetro giambico catalettico (
), il secondo da tre piedi trocaici, cioè da un itifallico ( ). In realtà tale schema può subire molte
variazioni, come dimostra anche l'elogium stesso (cf. I. Mariotti, 1, p.25-6 per altri particolari).
Le iscrizioni sono conservate ai Musei Vaticani.
Internet da utilizzare modificando
Lungo il tratto urbano della Via Appia a poche decine di metri dalla porta San Sebastiano del circuito delle
mura di Aureliano, si conservano i resti del sepolcro dell'antica famiglia romana degli Scipioni. Fu scoperto
una prima volta nel 1614 e quindi riesplorato nel 1780 durante lavori di scavo. In origine il mausoleo, scavato
completamente nel banco di tufo, era costituito da una grande sala quadrangolare, ricavata dall'intersezione
di una serie di gallerie e divisa da pilastri. La facciata monumentale si apriva su un diverticolo della Via
Appia; consisteva in un alto basamento con cornice in peperino, che sorreggeva un muro con semicolonne
scanalate su base attica a imitare un porticato. Nei corridoi ipogei si sono rinvenuti molti sarcofagi, oggi ai
Musei Vaticani, alcuni monolitici, altri composti da lastroni. Il più antico e importante è quello di L.Cornelio
Scipione Barbato, console nell'anno 298 a.C: fu il costruttore del sepolcro e vi fu deposto per primo. Si è certi
che il sepolcro, costruito verso l'inizio del III secolo a.C, fu utilizzato con almeno una trentina di deposizioni
fino alla metà del II secolo a.C, quando la nobile famiglia si estinse.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
159
Testi e testimonianze
Testo di C.I.L., I2,2,6
[L. CORNELI]O CN. F. SCIPIO
CORNELIVS LVCIVS SCIPIO BARBATVS
GNAIVOD PATRE | PROGNATVS FORTIS VIR SAPIENSQVE
QVOIVS FORMA VIRTVTEI PARISVMA | FVIT
CONSOL CENSOR AIDILIS QVEI FVIT APVD VOS
TAVRASIA CISAVNA | SAMNIO CEPIT
SVBIGIT OMNE LOVCANAM OPSIDESQVE ABDOVCIT
Traduzione (CD d'Anna)
Cornelio Lucio Scipione Barbato
generato dal padre Gneo
uomo forte e saggio
di prestanza pari al valore
fu tra voi console, edile, pretore
Taurasia e Cisauna prese e il Sannio,
sottomise tutta la terra Lucania
traendone ostaggi.
E’ L. Cornelio Scipione Barbato, console nel 298.
Testo di C.I.L., I2, 2,7 (=Carmina Latina Epigraphica, 6 B)
HONC OINO PLOIRVME COSENTIONT R[OMAI]
DVONORO OPTVMO FVISE VIRO
LVCIOM SCIPIONE FILIOS BARBATI
CONSOL CENSOR AIDILIS HIC FVET A[PVD] VOS
HEC CEPIT CORSICA ALERIAQVE VRBE
DEDET TEMPESTATEBVS AIDE MERETO[D]
Traduzione in latino classico
L. Cornelius L(ucii) filius Scipio aedilis consul censor
Hunc unum plurimi consentiunt Romae bonorum optimum fuisse virorum Lucium Scipionem.
Filius Barbati consul, censor, aedilis hic fuit apud vos.
Hic cepit Corsicam Aleriamque urbem, dedit Tempestatibus aedem merito.
Traduzione
Lucio Cornelio, figlio di Lucio, edìle, console, censore. Moltissimi aRoma sono d'accordo che solo
lui, Lucio Scipione, fu il migliore tra gli uomini buoni. Figlio di Barbato, fu presso di voi console,
censore, edile. Conquistò la Corsica e la città di Aleria e consacrò un tempio in voto alle Tempeste.
Altra traduzione (Conte, Il libro della lett. Lat., 2000)
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
160
Lui solo tutti riconoscono a Roma che fu il migliore di tutti i cittadini, Lucio Scipione Barbato, figlio
di Barbato. Console censore edile egli fu tra di voi. Costui prese la Corsica e la città di Aleria,
dedicò un tempio alle Tempeste, a giusto titolo.
E’ il figlio del dedicatario del precedente elogium.
Aleria, nella costa orientale della Corsica fu conquistata dai Romani ai Cartaginesi nel 259, nel
corso della prima guerra punica.
Cf. Cic., Cato, 60
Quanta fuit in L. Caecilio Metello, quanta in A. Atilio Calatino! in quem illud elogium: 'hunc unum plurimae
consentiunt gentes populi primarium fuisse virum.' notum est id totum carmen incisum in sepulcro. iure igitur
gravis, cuius de laudibus omnium esset fama consentiens.
Bibliografia
F. Coarelli, Il Sepolcro degli Scipioni a Roma, Roma,Palombi, 1988.
D. Mancioli, Il sepolcro degli Scipioni, Roma 1997.
ICCU
Scipioni
Autore: Fraccaro, Plinio
Titolo: I processi degli Scipioni / [Plinio Fraccaro]
Edizione: Ed. anast
Pubblicazione: Roma : L'erma di Bretschneider, 1967 , Collezione: Studia historica
Note Generali: Estr. da: Studi storici per l'antichita classica
Autore: Coarelli, Filippo
Titolo: Il Sepolcro degli Scipioni a Roma / di Filippo Coarelli
Pubblicazione: Roma : F.lli Palombi, [1988] , Collezione: Itinerari d'arte e di cultura. Via Appia
Autore: Mancioli, Danila
Titolo: Il sepolcro degli Scipioni / di Danila Mancioli
Pubblicazione: Roma : Sydaco, 1997 , Collezione: Collana archeologica
Note Generali: Suppl. a: Forma urbis, 1997, n. 12.
Autore: Cocchia, Enrico
Titolo: I monumenti degli Scipioni e l'epigramma sepolcrale di Ennio : memoria letta ... dal socio ...
Enrico Cocchia
Pubblicazione: Napoli : Tip. della R. universita A. Cimmaruta, 1912
Note Generali: Estr. dagli: Atti dell'accademia di archeologia, lettere e belle arti, vol. 2, 1910.
Testi ufficiali
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
161
Trattati
Pochi trattati sono rimasti su epigrafi, soprattutto perché riportati su bronzo, materiale destinato a
fondersi in caso di incendio e spesso deliberatamente fuso per altri usi.
I pochi restati sono relativi a trattati con Greci e sono pervenuti nella redazione estera su pietra:
- trattato romano-etolico del 212 a.C., in CIL 12, 2676
Molte stele relativi a trattati antichi sono ricordate da autori come esposte ai loro tempi in luoghi
pubblici.
Calabi Limentani, 31.
Testi e testimonianze
Polibio in 3,22,3 fornisce un’analisi del trattato stipulato tra Roma e Cartagine ca. il 508.
“Fornisco qui di seguito la traduzione più accurata che mi è possibile. Infatti la differenza fra il
dialetto quale è parlato dagli odierni Romani e l’antica lingua è tale , che è difficile decifrare alcune
sue parti anche per le persone più antiche di talento, dopo un attento studio”.
Controllo
Decretum Hastense
Controllo dati
Decretum Hastense
IntraText CT - Text
LUCIUS AIMILIUS LUCI FILIUS INPEIRATOR DECREIVIT,
UTEI QUEI HASTENSIUM SERVEI
IN TURRI LASCUTANA HABITARENT
LEIBEREI ESSENT; AGRUM OPPIDUMQUE,
QUOD EA TEMPESTATE POSEDISENT,
ITEM POSSIDERE HABEREQUE
IOUSIT, DUM POPULUS SENATUSQUE
ROMANUS VELLET. ACTUM IN CASTREIS
ANTE DIEM XII KALENDAS FEBRUARIAS.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
162
Altro testo da P. F. Girard & F. Senn, Les lois des Romains, Jovene ed., Naples, 1977, pp. 343344, n. 1 (Internet)
L. AIMILIUS L. F. INPEIRATOR DECREIUIT, | UTEI QUEI HASTENSIUM SERUEI | IN TURRI LASCUTANA
HABITARENT, | LEIBEREI ESSENT ; AGRUM OPPIDUMQU<E>, || QUOD EA TEMPESTATE POSEDISENT, | ITEM
POSSIDERE HABEREQUE | IOUSIT, DUM POPLUS SENATUSQUE | ROMANUS UELLET. ACT(UM) IN CASTREIS |
A. D. XII K. FEBR.
Bibliografia
Controllo se si riferisce effettivamente al DH
Bruns, Fontes..., I, p. 240, n. 70 ; CIL : Corpus inscriptionum Latinarum, II, p. 699, n. 5041, I, 22, p.
501, n. 614 ; Costa, Estudios Ibericos, pp. LXXV ss. ; Dessau, I, n. 15 ; d'Ors, Epigr. jur. de la Esp.
Rom., 1953, pp. 349-352 ; English translation in ARS, n. 22, p. 23 ; FIRA : Fontes iuris Romani
anteiustiniani..., I, p. 305, n. 51 ; Hübner, Ein Decret des L. Aemilius Paulus, Hermes, 3, 1869, pp.
243-260 ; Jordan, Zu dem Decret des L. Aemilius Paulus, Hermes, 3, 1869, pp. 458-459 ; Kaser,
Die Typen der römischen Bodenrechte in der späteren Republik, ZSS, 62, 1942, pp. 1-81 ; Livy,
35, 24, 6 / 36, 2, 6 ss. / 37, 2, 11 ; Mommsen, Bemerkungen zum Dekret des Paulus, Hermes, 3,
1869, pp. 261-267 = Ges. Schr., IV, pp. 56-62 ; Renier & de Longpérier, CRAI, 1867, pp. 267-275 ;
Rodriguez Berlanga, Los Bronces de Lascuta, Bonanza y Aljustrel, Malaga, 1881, pp. 491 ss. ;
Szádeczky-Kardoss, Ein Beitrag zur Verwirklichung des Prinzips « divide et impera » in der
rõmischen Geschichte, Antiquitas Graeco-Romana ac tempora nostra, ed. Burian & Vidman, 1968,
pp. 91-114.
► Source : Table of bronze discovered in the area of Cadiz in 1866.
Le leggi
controllo FIRa
Leggi delle dodici tavole
Secondo la tradizione sarebbero state redatte da 10 magistrati (decdemviri legibus scribundis)
intorno al 450-51 .
Secondo quanto narrato da Livio i decemviri, tutti di origine patrizia, si sarebbero ispirati ad
analoghi tipi di legge già scritti nel mondo greco: Licurgo a Sparta (750 a. C.), Zaleuco a Locri (660
a. C.), Dracone (620 a. C.) e poi Solone (594 a. C.) ad Atene, Caronda a Catania (550 a. C.) e,
infine, le leggi di Gortina in Creta nel 500 a. C.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
163
Conte parla di “monumentali assonanze”, assonanze, alliterazioni, “scansione in cola ritmici
“paralleli e staccati”, con “sicuro effetto di sanzione inappellabile”.
Cicerone le definisce anche per questo carmina. Controllo testim..
Da www.filodiritto.com
Da modificare per utilizzo
Le XII Tavole sono il primo diritto scritto di Roma e ben si può dire ex ungue leonem! A differenza
di altre raccolte di disposizioni normative antiche (Codice di Hammurabi, Leggi di Manu), che sono
mere elencazioni di prescrizioni, esse già consentono di individuare i germi di un sistema giuridico,
sostanziale e processuale, che cerca di organizzarsi su di una base razionale. La loro lettura è
perciò di sicuro interesse per gli studenti del diritto e per gli studiosi di storia romana.
Le XII Tavole nascono nel 451 a. C. quando, sotto la pressione dei tribuni della plebe, che
volevano sottrarre ai patrizi il monopolio della giurisdizione, vennero nominati i Decemviri, tutti
patrizi, per la stesura di leggi scritte. Essi erano nominati per la durata di un anno, ogni altra
magistratura era sospesa ed essi giudicavano senza possibilità di ricorso ai comizi (sine
provocatione).
E' abbastanza verosimile quanto narrano Livio ed altri autori romani, e cioè che i Decemviri
abbiano preso a modello, se non per i contenuti, senz'altro per la forma, analoghi tipi di legge già
scritti nel mondo greco: Licurgo a Sparta (750 a. C.), Zaleuco a Locri (660 a. C.), Dracone (620 a.
C.) e poi Solone (594 a. C.) ad Atene, Caronda a Catania (550 a. C.) e, infine, le leggi di Gortina in
Creta nel 500 a. C.
Pomponio e Plinio ci hanno tramandato anche il nome di un certo Hermodoro di Efeso, esiliato dal
suo paese, che avrebbe servito da interprete.
In un anno vennero approntate dieci tavole; a causa di alcune manchevolezze vennero nominati
altri nove Decemviri che nel 450 a. C., assieme al precedente Decemviro Appio Claudio,
completarono l'opera con altre due tavole. Il testo venne scritto su lastre di bronzo (i romani
usavano la parola aes sia per il rame che per il bronzo, ma Dione ci riferisce che in questo caso
trattavasi di bronzo), affisse poi nel Foro.
Non sappiamo quali e quante modifiche abbiano subito le XII Tavole nei secoli successivi per
adeguarsi al mutare dei tempi e dei costumi.
Come si è detto, il testo, che al tempo di Cicerone veniva ancora imparato a memoria dai ragazzi,
ci è pervenuto solo in pochi frammenti e si stima che le disposizioni pervenuteci, in forma diretta o
indiretta, corrispondano a meno di un terzo del testo completo. Quindi è molto incerto il contenuto
delle singole tavole ed anche la ricostruzione del Bruns ha dovuto basarsi su ipotesi: in particolare
che Gaio, nelle sue Istituzioni, abbia seguito la ripartizione della materia come offerta dalle XII
Tavole.
Nel presente testo, seguendo la tradizione del Bruns, i frammenti pervenutici in forma diretta sono
riportati in carattere stampatello; quelli pervenutici in forma indiretta sono riportati in caratteri
normali.
Testi e testimonianze
Cic. de leg. 2, 23, 59)
Discebamus enim pueri XII ut carmen necessarium quas iam nemo discit.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
164
Cic., de or. 1,43, 193-44 195
Accedit vero, quo facilius percipi cognoscique ius civile possit, quod minime plerique arbitrantur, mira
quaedam in cognoscendo suavitas et delectatio; nam, sive quem haec Aeliana studia delectant, plurima est
et in omni iure civili et in pontificum libris et in xii tabulis antiquitatis effigies, quod et verborum vetustas prisca
cognoscitur et actionum genera quaedam maiorum consuetudinem vitamque declarant; sive quem civilis
scientia, quam Scaevola non putat oratoris esse propriam, sed cuiusdam ex alio genere prudentiae, totam
hanc descriptis omnibus civitatis utilitatibus ac partibus xii tabulis contineri videbit: sive quem ista praepotens
et gloriosa philosophia delectat,–dicam audacius–hosce habet fontis omnium disputationum suarum, qui iure
civili et legibus continentur: ex his enim et dignitatem maxime expetendam videmus, cum vera virtus atque
honestus labor honoribus, praemiis, splendore decoratur, vitia autem hominum atque fraudes damnis,
ignominiis, vinclis, verberibus, exsiliis, morte multantur; et docemur non infinitis concertationumque plenis
disputationibus, sed auctoritate nutuque legum domitas habere libidines, coercere omnis cupiditates, nostra
tueri, ab alienis mentis, oculos, manus abstinere. Fremant omnes licet, dicam quod sentio: bibliothecas me
hercule omnium philosophorum unus mihi videtur xii tabularum libellus, si quis legum fontis et capita viderit,
et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate superare.
Liv. 3,32,5
Ab hoste otium fuit. inde consules C. Menenius P. Sestius Capitolinus. neque eo anno quicquam belli externi
fuit: domi motus orti. iam redierant legati cum Atticis legibus. eo intentius instabant tribuni ut tandem
scribendarum legum initium fieret. placet creari decemuiros sine prouocatione, et ne quis eo anno alius
magistratus esset. admiscerenturne plebeii controuersia aliquamdiu fuit; postremo concessum patribus,
modo ne lex Icilia de Auentino aliaeque sacratae leges abrogarentur. anno trecentensimo altero quam
condita Roma erat iterum mutatur forma ciuitatis, ab consulibus ad decemuiros, quemadmodum ab regibus
ante ad consules uenerat, translato imperio. minus insignis, quia non diuturna, mutatio fuit. laeta enim
principia magistratus eius nimis luxuriauere; eo citius lapsa res est repetitumque duobus uti mandaretur
consulum nomen imperiumque. decemuiri creati Ap. Claudius, T. Genucius, P. Sestius, L. Ueturius, C. Iulius,
A. Manlius, P. Sulpicius, P. Curiatius, T. Romilius, Sp. Postumius. Claudio et Genucio, quia designati
consules in eum annum fuerant, pro honore honos redditus, et Sestio, alteri consulum prioris anni, quod eam
rem collega inuito ad patres rettulerat. his proximi habiti legati tres qui Athenas ierant, simul ut pro legatione
tam longinqua praemio esset honos, simul peritos legum peregrinarum ad condenda noua iura usui fore
credebant. suppleuere ceteri numerum. graues quoque aetate electos nouissimis suffragiis ferunt, quo minus
ferociter aliorum scitis aduersarentur. regimen totius magistratus penes Appium erat fauore plebis, adeoque
nouum sibi ingenium induerat ut plebicola repente omnisque aurae popularis captator euaderet pro truci
saeuoque insectatore plebis. decimo die ius populo singuli reddebant. eo die penes praefectum iuris fasces
duodecim erant: collegis nouem singuli accensi apparebant. et in unica concordia inter ipsos, qui consensus
priuatis interdum inutilis est, summa aduersus alios aequitas erat. moderationis eorum argumentum exemplo
unius rei notasse satis erit. cum sine prouocatione creati essent, defosso cadauere domi apud P. Sestium,
patriciae gentis uirum, inuento prolatoque in contionem, in re iuxta manifesta atque atroci C. Iulius decemuir
diem Sestio dixit et accusator ad populum exstitit, cuius rei iudex legitimus erat, decessitque iure suo, ut
demptum de ui magistratus populi libertati adiceret. cum promptum hoc ius uelut ex oraculo incorruptum
pariter ab iis summi infimique ferrent, tum legibus condendis opera dabatur; ingentique hominum
exspectatione propositis decem tabulis, populum ad contionem aduocauerunt et, quod bonum faustum
felixque rei publicae ipsis liberisque eorum esset, ire et legere leges propositas iussere: se, quantum decem
hominum ingeniis prouideri potuerit, omnibus, summis infimisque, iura aequasse: plus pollere multorum
ingenia consiliaque. uersarent in animis secum unamquamque rem, agitarent deinde sermonibus, atque in
medium quid in quaque re plus minusue esset conferrent. eas leges habiturum populum Romanum quas
consensus omnium non iussisse latas magis quam tulisse uideri posset. cum ad rumores hominum de
unoquoque legum capite editos satis correctae uiderentur, centuriatis comitiis decem tabularum leges
perlatae sunt, qui nunc quoque, in hoc immenso aliarum super alias aceruatarum legum cumulo, fons omnis
publici priuatique est iuris. uolgatur deinde rumor duas deesse tabulas quibus adiectis absolui posse uelut
corpus omnis Romani iuris. ea exspectatio, cum dies comitiorum adpropinquaret, desiderium decemuiros
iterum creandi fecit. iam plebs, praeterquam quod consulum nomen haud secus quam regum perosa erat,
ne tribunicium quidem auxilium, cedentibus in uicem appellationi decemuiris, quaerebat. postquam uero
comitia decemuiris creandis in trinum nundinum indicta sunt, tanta exarsit ambitio, ut primores quoque
ciuitatis–metu, credo, ne tanti possessio imperii, uacuo ab se relicto loco, haud satis dignis pateret–
prensarent homines, honorem summa ope a se impugnatum ab ea plebe, cum qua contenderant, suppliciter
petentes. demissa iam in discrimen dignitas ea aetate iisque honoribus actis stimulabat Ap. Claudium.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
165
nescires utrum inter decemuiros an inter candidatos numerares; propior interdum petendo quam gerendo
magistratui erat. criminari optimates, extollere candidatorum leuissimum quemque humillimumque, ipse
medius inter tribunicios, Duillios Iciliosque, in foro uolitare, per illos se plebi uenditare, donec collegae
quoque, qui unice illi dediti fuerant ad id tempus, coniecere in eum oculos, mirantes quid sibi uellet: apparere
nihil sinceri esse; profecto haud gratuitam in tanta superbia comitatem fore; nimium in ordinem se ipsum
cogere et uolgari cum priuatis non tam properantis abire magistratu quam uiam ad continuandum
magistratum quaerentis esse. propalam obuiam ire cupiditati parum ausi, obsecundando mollire impetum
adgrediuntur. comitiorum illi habendorum, quando minimus natu sit, munus consensu iniungunt. ars haec
erat, ne semet ipse creare posset, quod praeter tribunos plebi–et id ipsum pessimo exemplo–nemo unquam
fecisset. ille enimuero, quod bene uertat, habiturum se comitia professus, impedimentum pro occasione
arripuit; deiectisque honore per coitionem duobus Quinctiis, Capitolino et Cincinnato, et patruo suo C.
Claudio, constantissimo uiro in optimatium causa, et aliis eiusdem fastigii ciuibus, nequaquam splendore
uitae pares decemuiros creat, se in primis, quod haud secus factum improbabant boni quam nemo facere
ausurum crediderat. creati cum eo M. Cornelius Maluginensis M. Sergius L. Minucius Q. Fabius Uibulanus
Q. Poetelius T. Antonius Merenda K. Duillius Sp. Oppius Cornicen M'. Rabuleius. ille finis Appio alienae
personae ferendae fuit. suo iam inde uiuere ingenio coepit nouosque collegas, iam priusquam inirent
magistratum, in suos mores formare. cottidie coibant remotis arbitris; inde impotentibus instructi consiliis,
quae secreto ab aliis coquebant, iam haud dissimulando superbiam, rari aditus, conloquentibus difficiles, ad
idus Maias rem perduxere. idus tum Maiae sollemnes ineundis magistratibus erant. inito igitur magistratu
primum honoris diem denuntiatione ingentis terroris insignem fecere. nam cum ita priores decemuiri
seruassent ut unus fasces haberet et hoc insigne regium in orbem, suam cuiusque uicem, per omnes iret,
subito omnes cum duodenis fascibus prodiere. centum uiginti lictores forum impleuerant et cum fascibus
secures inligatas praeferebant; nec attinuisse demi securem, cum sine prouocatione creati essent,
interpretabantur. decem regum species erat, multiplicatusque terror non infimis solum sed primoribus
patrum, ratis caedis causam ac principium quaeri, ut si quis memorem libertatis uocem aut in senatu aut in
populo misisset statim uirgae securesque etiam ad ceterorum metum expedirentur. nam praeterquam quod
in populo nihil erat praesidii sublata prouocatione, intercessionem quoque consensu sustulerant, cum priores
decemuiri appellatione collegae corrigi reddita ab se iura tulissent et quaedam, quae sui iudicii uideri
possent, ad populum reiecissent. aliquamdiu aequatus inter omnes terror fuit; paulatim totus uertere in
plebem coepit; abstinebatur a patribus; in humiliores libidinose crudeliterque consulebatur. hominum, non
causarum toti erant, ut apud quos gratia uim aequi haberet. iudicia domi conflabant, pronuntiabant in foro. si
quis collegam appellasset, ab eo ad quem uenerat ita discedebat ut paeniteret non prioris decreto stetisse.
opinio etiam sine auctore exierat non in praesentis modo temporis eos iniuriam conspirasse, sed foedus
clandestinum inter ipsos iure iurando ictum, ne comitia haberent perpetuoque decemuiratu possessum
semel obtinerent imperium. circumspectare tum patriciorum uoltus plebeii et inde libertatis captare auram,
unde seruitutem timendo in eum statum rem publicam adduxerant. primores patrum odisse decemuiros,
odisse plebem; nec probare quae fierent, et credere haud indignis accidere; auide ruendo ad libertatem in
seruitutem elapsos iuuare nolle; cumulari quoque iniurias, ut taedio praesentium consules duo tandem et
status pristinus rerum in desiderium ueniant. iam et processerat pars maior anni et duae tabulae legum ad
prioris anni decem tabulas erant adiectae, nec quicquam iam supererat, si eae quoque leges centuriatis
comitiis perlatae essent, cur eo magistratu rei publicae opus esset. exspectabant quam mox consulibus
creandis comitia edicerentur; id modo plebes agitabat quonam modo tribuniciam potestatem, munimentum
libertati, rem intermissam, repararent; cum interim mentio comitiorum nulla fieri. et decemuiri, qui primo
tribunicios homines, quia id populare habebatur, circum se ostentauerant plebi, patriciis iuuenibus
saepserant latera. eorum cateruae tribunalia obsederant; hi ferre agere plebem plebisque res, cum fortuna,
qua quidquid cupitum foret, potentioris esset. et iam ne tergo quidem abstinebatur; uirgis caedi, alii securi
subici; et, ne gratuita crudelitas esset, bonorum donatio sequi domini supplicium. hac mercede iuuentus
nobilis corrupta non modo non ire obuiam iniuriae, sed propalam licentiam suam malle quam omnium
libertatem. idus Maiae uenere. nullis subrogatis magistratibus, priuati pro decemuiris, neque animis ad
imperium inhibendum imminutis neque ad speciem honoris insignibus prodeunt. id uero regnum haud dubie
uideri. deploratur in perpetuum libertas, nec uindex quisquam exsistit aut futurus uidetur. nec ipsi solum
desponderant animos, sed contemni coepti erant a finitimis populis, imperiumque ibi esse ubi non esset
libertas, indignabantur. Sabini magna manu incursionem in agrum Romanum fecere; lateque populati cum
hominum atque pecudum inulti praedas egissent, recepto ad Eretum quod passim uagatum erat agmine
castra locant, spem in discordia Romana ponentes: eam impedimentum dilectui fore. non nuntii solum sed
per urbem agrestium fuga trepidationem iniecit. decemuiri consultant quid opus facto sit, destituti inter
patrum et plebis odia. addidit terrorem insuper alium fortuna. Aequi alia ex parte castra in Algido locant
depopulanturque inde excursionibus Tusculanum agrum; legati ea ab Tusculo, praesidium orantes, nuntiant.
is pauor perculit decemuiros ut senatum, simul duobus circumstantibus urbem bellis, consulerent. citari
iubent in curiam patres, haud ignari quanta inuidiae immineret tempestas: omnes uastati agri periculorumque
imminentium causas in se congesturos; temptationemque eam fore abolendi sibi magistratus, ni consensu
resisterent imperioque inhibendo acriter in paucos praeferocis animi conatus aliorum comprimerent.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
166
postquam audita uox in foro est praeconis patres in curiam ad decemuiros uocantis, uelut noua res, quia
intermiserant iam diu morem consulendi senatus, mirabundam plebem conuertit quidnam incidisset cur ex
tanto interuallo rem desuetam usurparent; hostibus belloque gratiam habendam quod solitum quicquam
liberae ciuitati fieret. circumspectare omnibus fori partibus senatorem, raroque usquam noscitare; curiam
inde ac solitudinem circa decemuiros intueri, cum et ipsi suum inuisum consensu imperium, et plebs, quia
priuatis ius non esset uocandi senatum, non conuenire patres interpretarentur; iam caput fieri libertatem
repetentium, si se plebs comitem senatui det et quemadmodum patres uocati non coeant in senatum, sic
plebs abnuat dilectum. haec fremunt plebes. patrum haud fere quisquam in foro, in urbe rari erant. 3,38,11
Traduzione
Liv., 3,34,6
Cum ad rumores hominum de unoquoque legum capite editos satis correctae uiderentur, centuriatis comitiis
decem tabularum leges perlatae sunt, qui nunc quoque, in hoc immenso aliarum super alias aceruatarum
legum cumulo, fons omnis publici priuatique est iuris.
Testo Intratext
tabula I
si in ius vocat, ito. ni it, antestamino. igitur em capito.
si calvitur pedemve struit, manum endo iacito. si morbus aevitasve vitium escit, iumentum dato. si nolet,
arceram ne sternito.
assiduo vindex assiduus esto. proletario iam civi quis volet vindex esto.
nex . . . forti sanati . . .
rem ubi pacunt, orato. ni pacunt, in comitio aut in foro ante meridiem caussam coiciunto. com peroranto
ambo praesentes. post meridiem praesenti litem addicito. si ambo praesentes, solis occasus suprema
tempestas esto.
vades . . . subvades . . .
tabula II
<actor dicito:> ex sponsione te mihi . . . dare oportere aio. quando tu negas, te praetor iudicem sive arbitrum
postulo uti des.
. . . morbus sonticus . . . aut status dies cum hoste . . . quid horum fuit unum iudici arbitrove reove, eo dies
diffissus esto.
cui testimonium defuerit, is tertiis diebus ob portum obvagulatum ito.
tabula III
aeris confessi rebusque iure iudicatis XXX dies iusti sunto.
post deinde manus iniectio esto. in ius ducito. ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum
ducito, vincito aut nervo aut compedibus XV pondo, ne maiore aut si volet minore vincito. si volet suo vivito,
ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras faris endo dies dato. si volet, plus dato.
tertiis nundinis partis secanto. si plus minusve secuerunt, se fraude esto adversus hostem aeterna auctoritas
<esto>.
tabula IV
si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto.
tabula V
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
167
uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto. si intestato moritur, cui suus heres nec escit,
adgnatus proximus familiam habeto. si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento.
si furiosus escit, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto. . . . ast ei custos nec escit . . .
ex ea familia . . . in eam familiam.
tabula VI
cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto.
si qui in iure manum conserunt tignum iunctum aedibus vineave sei concapit ne solvito . . .. duplione . . .
quandoque sarpta, donec dempta erunt.
tabula VII
. . . ambitus . . . sestertius pes . . .
si iurgant . . . tres arbitri . . .
viam muniunto: ni sam delapidassint, qua volet iumento agito.
si aqua pluvia nocet . . .
tabula VIII
qui malum carmen incantassit . . .
si membrum rup<s>it, ni cum eo pacit, talio esto.
manu fustive si os fregit libero, CCC <assium>, si servo, CL <assium> poenam subito si iniuriam faxsit,
viginti quinque poenae <asses> sunto.
. . . rup<s>it . . . sarcito.
qui fruges excantassit . . . neve alienam segetem pellexeris . . . <capite>. . . si nox furtum faxsit, si occisit,
iure caesus esto.
luci . . . si se telo defendit, . . . endoque plorato.
lance et licio <ito>.
si adorat furto, quod nec manifestum erit . . ., <duplione damnum decidito>.
patronus si clienti fraudem fecerit,, sacer esto.
qui se sierit testarier libripensve fuerit, ni testimonium fatiatur, inprobus intestabilisque esto.
si telum manu fugit magis quam iecit, <arietem subicito>.
tabula IX
<privilegia ne inroganto.>
<de capite civis nisi per maximum comitiatum . . . ne ferunto.>
tabula X
hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito.
. . . hoc plus ne facito: rogum ascea ne polito.
mulieres genas ne radunto neve lessum funeris ergo habento.
homine mortuo ne ossa legito, quo post funus faciat.
qui coronam parit ipse pecuniave eius honoris virtutisve ergoduitur ei . . .
neve aurum addito. at cui auro dentes iuncti escunt. ast in cum illo sepeliet uretve, se fraude esto.
tabula XI
<conubia plebi cum patribus>
. . . dies intercalandi . . .
. . . dies fasti . . .
tabula XII
si servo furtum faxit noxiamve no<x>it.
si vindiciam falsam tulit, si velit is . . . tor arbitros tris dato, eorum arbitrio . . . fructus duplione damnum
decidito.
fragmenta incertae sedis
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
168
nancitor
transque dato
detestatum
proquiritata
Traduzione e commento da www.filodiritto.com
TAVOLA I
1. SE È CHIAMATO IN GIUDIZIO, VADA. SE NON VA, SI PRENDANO TESTIMONI: POI LO
CATTURI.
La disposizione stabilisce le modalità di convocazione avanti al magistrato (di regola il Pretore,
almeno in periodo storico): il convenuto citato deve presentarsi; se non compare si fa constatare
ciò da testimoni e poi l'attore può usare la forza fisica per catturarlo e condurlo avanti al giudice.
Non è ben chiaro se i testimoni dovevano essere presenti alla constatazione dell'assenza o alla
cattura o ad entrambe le fasi.
2. SE [IL CONVENUTO] INDUGIA O VUOL FUGGIRE, GLI PONGA LE MANI ADDOSSO.
In questo caso non è richiesta quindi la presenza di testimoni.
3. SE MALATTIA O VECCHIAIA SONO CAUSA DELLA MANCATA COMPARIZIONE, VENGA
DATO [DALL'ATTORE AL CONVENUTO] UN SEMPLICE VEICOLO. SE LO RIFIUTA,
[L'ATTORE] NON È TENUTO A DARGLI UN CARRO COPERTO.
Il termine escit è una forma antiquata per erit. Il termine iumentum, come chiarito da Gellio,
indicava un semplice carro trainato da bestie da soma.
4. PER UNA PERSONA POSSIDENTE, FACCIA DA GARANTE UN POSSIDENTE. PER UN
PROLETARIO FACCIA DA GARANTE QUALUNQUE CITTADINO LO VOGLIA.
Non è chiaro che cosa si intendesse per assiduus. Cicerone fa derivare il termine da assis dare e
quindi si tratterebbe del cittadino che pagava tasse. Il vindex garantiva che il convenuto sarebbe
comparso avanti al magistrato.
5. OBBLIGAZIONE ... PLEBEI PATRIZI ...
Secondo il Mommsen la prima parte del frammento era nexi mancipiique idem ius esto e si voleva
intendere che per le obbligazioni nella forma del nexum o del mancipium vi era eguaglianza di
diritti per i patrizi (fortes) e per i plebei (sanati).
6. SE LE PARTI SI ACCORDANO, [IL MAGISTRATO] DECIDA.
Si deve intendere che se fra le parti si addiveniva ad una pactio, il magistrato poteva e doveva
decidere senz'altro. Questi decideva sulla addictio, vale a dire all'autorizzazione all'attore di tener
prigioniero il convenuto non garantito dal vindex, e la fissazione dei termini della questione da
decidere.
7. SE NON SI ACCORDANO, [LE PARTI] ESPONGANO LA CAUSA NEL COMIZIO O NEL FORO
PRIMA DI MEZZOGIORNO. ESPONGANO LA CAUSA, PRESENTI ENTRAMBI.
8. DOPO MEZZOGIORNO [IL MAGISTRATO] AGGIUDICHI LA LITE A FAVORE DELLA PARTE
PRESENTE.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
169
La disposizione regola il caso di contumacia di una delle parti.
9. SE ENTRAMBE LE PARTI SONO PRESENTI, IL TRAMONTO DEL SOLE SIA IL LIMITE
ULTIMO [PER LA DISCUSSIONE].
10. In quanto scomparvero le antiche denominazioni di proletari e possidenti e clienti, di garanti e
subgaranti, dei 25 assi e della legge del taglione e tutta quell'anticaglia delle XII Tavole rimase
come assopita dopo la pubblicazione della legge Ebuzia ...
Per il significato dei 25 assi, si veda la Tavola VIII, 4
TAVOLA II
1. a) Per le liti che avevano un valore di mille assi o più si scommetteva con giuramento una
somma di cinquecento assi, per le liti di minor valore una somma di cinquanta assi; così era
stabilito infatti nella legge delle XII Tavole. Ma se si trattava di una lite sulla libertà di un uomo,
anche se il suo valore era grandissimo, la stessa legge stabiliva che si scommettessero cinquanta
assi [e ciò perché gli adsertores libertatis non siano troppo onerati].
La disposizione concerneva la legis actio per sacramento con cui le parti scommettevano una
somma confermando con giuramento le affermazioni sul proprio buon diritto. Le questioni sullo
status di libero riguardavano schiavi o persone ritenute tali.
b) Si agiva mediante richiesta di un giudice, se tale tipo di azione era stabilita da una legge, come
avveniva nella legge delle XII Tavole rispetto a ciò che veniva richiesto sulla base di una
stipulazione. Chi agiva così diceva: "IO AFFERMO CHE TU MI DEVI DARE DIECIMILA
SESTERZI IN BASE AD UNA SPONSIO. IO CHIEDO CHE TU AMMETTA O NEGHI". L'avversario
doveva di non dover dare. L'attore diceva: "POICHÉ TU NEGHI, CHIEDO A TE PRETORE DI
ASSEGNARMI UN GIUDICE O UN ARBITRO."
E così in questo tipo di azione ognuno poteva negare senza penalità. Egualmente per la divisione
dell'eredità fra i coeredi, la stessa legge imponeva di agire mediante la richiesta di un giudice.
2. SE VI È UNA MALATTIA GRAVE ... O È STATO FISSATO UN TERMINE CON UNO
STRANIERO ... QUALORA UNO DI QUESTI IMPEDIMENTI VI SIA PER IL GIUDICE, L'ARBITRO
O LE PARTI, DETTO TERMINE VENGA DIFFERITO.
La disposizione riguarda la fase davanti al giudice o all'arbitro (apud iudicem) e stabilisce i casi in
cui è possibile rinviare la trattazione della causa. Il termine reus indica ogni parte dopo la litis
contestatio. Questo è l'unico frammento di cui le fonti indichino l'esatta posizione nella "seconda
tavola, seconda legge".
3. QUEGLI AL QUALE SIA MANCATO IL TESTIMONIO, VADA GIRANDO DAVANTI ALLA CASA
DEL TESTIMONIO OGNI TERZO GIORNO, SVILLANEGGIANDOLO.
La disposizione prevede questa forma di pressione pubblica per costringere il testimonio a
presentarsi avanti al giudice. Il riferimento "ogni tre giorni" può essere inteso come "nei giorni di
mercato".
TAVOLA III
1. IN CASO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO IN GIUDIZIO O DI CONDANNA
PRONUNZIATA, VI SARANNO TRENTA GIORNI FISSATI DALLA LEGGE [PER
L'ADEMPIMENTO].
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
170
2. DOPO TALE TERMINE ABBIA LUOGO LA CATTURA [DEL DEBITORE]. VENGA CONDOTTO
AVANTI AL MAGISTRATO.
3. SE NON ADEMPIE AL GIUDICATO O SE NESSUNO DÀ GARANZIA PER LUI AVANTI AL
MAGISTRATO, IL CREDITORE LO PORTI CON SÉ E LO LEGHI CON CORREGGE O CEPPI DI
QUINDICI LIBBRE; NON PIÙ PESANTI, MA SE VUOLE DI MINOR PESO.
4. SE [IL DEBITORE] LO VUOLE, VIVA A SUE SPESE. SE NON VIVE DEL SUO, CHI LO HA
CATTURATO GLI DIA UNA LIBBRA DI FARRO AL GIORNO. SE VUOLE ANCHE DI PIÙ.
5. Vi era però nel frattempo il diritto di trovare un accordo; se esso non si trovava i debitori
restavano prigionieri per sessanta giorni. Durante questi giorni veniva condotto per tre giorni di
mercato consecutivi avanti al pretore nel comizio e veniva annunziato l'ammontare della somma
che era stato condannato a pagare. Nel terzo giorno di mercato veniva giustiziato oppure mandato
al di là del Tevere per essere venduto.
6. NEL TERZO GIORNO DI MERCATO SIA TAGLIATO IN PARTI. SE [I CREDITORI] NE
TAGLIERANNO PIÙ O MENO DEL DOVUTO, NON ANDRÀ A LORO PREGIUDIZIO.
7. NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO LA VALIDITÀ [DEL POSSESSO] È ETERNA.
La disposizione va riferita all'inusucapibilità perpetua di beni da parte dello straniero.
TAVOLA IV
1. Subito ucciso, come secondo le XII Tavole avviene per un bambino particolarmente deforme.
2. SE IL PADRE HA VENDUTO PER TRE VOLTE IL FIGLIO, IL FIGLIO SIA LIBERO DALLA
PATRIA POTESTÀ.
3.Egli ordinò a quella sua [donna], secondo le XII Tavole, di riprendersi le sue cose, le tolse le
chiavi e la cacciò di casa.
4. Seppi che una donna aveva partorito un figlio nell'undicesimo mese dalla morte del marito e che
questo fatto fosse la causa di ritenere come se avesse concepito dopo la morte del marito; infatti i
decemviri nelle loro leggi hanno scritto che un uomo viene generato in dieci mesi e non
nell'undicesimo.
TAVOLA V
1. Gli antichi vollero che le donne, anche se di età matura, fossero soggette a tutela, eccettuate le
vergini vestali, che vollero fossero libere: e ciò è stabilito anche nella legge delle XII Tavole.
2. Le res mancipi di una donna che era sotto la tutela degli agnati, non potevano essere usucapite,
salvo che esse fossero state consegnate da essa stessa con il consenso del tutore: così anche era
stabilito nella legge delle XII Tavole.
Le res mancipi erano i beni più importanti, immobili, schiavi, bestiame, che potevano essere
trasferiti solo mediante la mancipatio o la in iure cessio.
3. SE IL PATER FAMILIAS HA DISPOSTO CIRCA IL PROPRIO DANARO E CIRCA LA TUTELA
DELLE SUE COSE, CIÒ ABBIA VALORE LEGALE
La disposizione si riferiva al testamento di fronte ai comizi in caso mancassero eredi legittimi.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
171
4. SE CHI NON HA UN EREDE MUORE SENZA TESTAMENTO, ABBIA TUTTA L'EREDITÀ
L'AGNATO PROSSIMO.
5. SE MANCA ANCHE L'AGNATO, ABBIANO L'EREDITÀ QUELLI CHE APPARTENEVANO
ALLA GENS DEL DEFUNTO
6. A coloro a cui nel testamento non è stato indicato un tutore, siano tutori gli agnati, secondo le XII
Tavole.
7. a) SE UNO È PAZZO, ABBIANO POTESTÀ SU DI LUI SUI SUOI BENI GLI AGNATI E [IN
LORO MANCANZA] I GENTILI.
b) ... MA SE PER LUI NON VI È UN CUSTODE.
c) Per legge delle XII Tavole il prodigo viene interdetto dall'amministrazione dei suoi beni.
d) La legge delle XII Tavole stabilisce che il prodigo interdetto dall'amministrazione dei suoi beni,
sia affidato alla curatela degli agnati.
8. a) La legge delle XII Tavole attribuisce al patrono l'eredità del liberto se questi è morto senza
testamento e senza eredi.
b) Quando la legge parla di patrono e di liberto, dice che [i suoi beni ritornano] in quella famiglia
dalla quale era stato liberato
9. a) Quei diritti che consistono in pretese, vengono divisi secondo le quote ereditarie, come
disposto dalle XII Tavole.
b) Secondo le XII Tavole i debiti ereditari vengono suddivisi di diritto tra le singole quote ereditarie.
10. Questa azione (per la divisione della comunione ereditaria) deriva dalle XII Tavole.
TAVOLA VI
1. QUANDO UNO FACCIA UNA SOLENNE PROMESSA DI OBBLIGARSI O UNA MANCIPATIO,
ABBIA VALORE LEGALE CIÒ CHE È STATO DETTO NELLA FORMA SOLENNE.
2. Siccome secondo le XII Tavole era sufficiente di adempiere a ciò che era stato promesso con
dichiarazione solenne ed era punito con una penale pari al doppio del dovuto chi rinnegava [la
dichiarazione], i giureconsulti stabilirono una pena anche per chi semplicemente taceva.
3. L'efficacia dell'usucapione richiede per un terreno due anni, per tutte le restanti cose un anno.
Alcuni leggono "usus et auctoritas" e riferiscono la frase alla garanzia che il venditore doveva
prestare in base all' actio autoritatis.
4. In una legge delle XII Tavole è stabilito che una donna la quale non voleva venire in manus del
marito [in forza dell'usucapione annuale], doveva allontanarsi ogni anno per tre notti [dalla casa del
marito] e così interrompere ogni anno l'usucapione.
5. a) SE ALCUNI IN GIUDIZIO AFFERRANO RECIPROCAMENTE ... [la cosa contesa].
b) Una legge delle XII Tavole conferma sia la mancipatio che la in iure cessio.
La disposizione fa riferimento alla legis actio sacramento in cui le parti davanti al Pretore
solennemente vantavano le loro pretese sulla cosa.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
172
6. I difensori di Virginia chiedono che Appio Claudio, secondo la legge che egli stesso aveva
emanato, lasci la donna provvisoriamente libera.
Il decemviro Appio Claudio, che aveva partecipato all'emanazione delle XII Tavole, si era invaghito
della plebea Virginia e aveva incaricato il proprio cliente M. Claudio di ripetere la donna come sua
schiava. Vigeva però il principio che la persona rivendicata come schiavo restasse libera fino alla
fine del processo. La decisione del Pretore circa questa "libertà provvisoria" era detta vindicia
perché il suo dico si contrapponeva al diritto di farsi giustizia direttamente mediante vis.
7. IL TRAVE O PALO ALTRUI CONGIUNTO CON UNA CASA O AD UNA VIGNA E CHE SERVE
DI SOSTEGNO, NON PUÒ ESSERE TOLTO.
8. La legge delle XII Tavole non consente di togliere un palo o un trave che sia stato impiegato in
una costruzione o in una vigna, né di rivendicarne la proprietà, ma concede azione per il doppio
del suo valore contro chi si prova averlo impiegato.
9. ...E QUANDO TAGLIATE, FINO A CHE NON SARANNO TOLTE...
Forse il frammento si riferisce alla possibilità di rivendicare i pali dopo la vendemmia o la potatura
della vigna.
TAVOLA VII
1. a) Gli interpreti delle XII Tavole spiegano il termine ambitus come la striscia di terreno attorno al
muro della casa.
b) Si chiama ambitus la striscia di terreno attorno agli edifici che ha una larghezza di due piedi e
mezzo.
c) Il sesterzio ha il valore di due assi e mezzo e di ciò sono prova le XII Tavole in cui la misura di
due piedi e mezzo viene detta "piede sesterzio
2. Circa l'azione di regolamento di confini occorre sapere che si deve osservare ciò che era scritto
nelle XII Tavole più o meno secondo il modello di quanto scritto in quella legge che si dice Solone
abbia dato in Atene. Perché in essa si legge: Se qualcuno pianta una siepe vicino al fondo altrui,
non può sporgerla oltre il confine. Se si tratta di un muro egli deve stare lontano un piede dal
confine, se pero è una casa, deve osservare due piedi di distanza. Se egli fa una fossa o uno
scavo, deve stare tanto lontano quanta è la loro profondità. Nel caso di un pozzo la distanza sia di
sei piedi. Un albero di olivo o di fico può essere piantato solo a nove piedi di distanza dal confine
del vicino, le altre piante a cinque piedi di distanza.
3. a) Nelle XII Tavole non si trova mai il termine villa (casa di campagna), ma con quel significato si
dice sempre "hortus"; nel significato di orto o giardino si usava il termine "heredium".
Heredium era un terreno di due iugeri.
b) Tuguri (capanne), parola derivata dal termine tetto, vengono dette miserabili abitazioni dei
contadini, e Messalla nella spiegazione delle XII Tavole dice che quel nome designava anche ...
4. Le XII Tavole non vollero che vi fosse usucapione per lo spazio di cinque piedi [lungo il confine
dei fondi].
5. a) SE DISCUTONO ... ([dicono le XII Tavole].
b) E' sorta una controversia circa i confini in cui noi quali tre arbitri secondo le XII Tavole,
fisseremo i confini.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
173
6. La larghezza delle vie (servitù di passaggio con veicoli) è, secondo una legge delle XII Tavole,
di otto piedi nei tratti rettilinei, di 16 piedi nelle curve.
7. MANTENGANO LA STRADA: SE NON L'HANNO ACCIOTTOLATA, SI FACCIA PASSARE IL
BESTIAME DOVE SI VUOLE.
La disposizione si riferisce alla via pubblica in quanto incompatibile con i principi delle servitù
private.
8. a) SE L'ACQUA PIOVANA ARRECA DANNI ...
b) Se un rivo d'acqua fatto passare in un luogo pubblico reca danno ad un privato, questi, secondo
le XII Tavole, ha azione per il risarcimento del danno al padrone [del fondo danneggiato].
9. a) La legge delle XII Tavole volle fare in modo che venissero tagliati i rami di un albero che
erano a meno di quindici piedi dal suolo [al di sopra del fondo del vicino].
b) Se un albero che cresce sul fondo del vicino, viene piegato sul tuo fondo, potrai legittimamente
agire secondo la legge delle XII Tavole per farlo eliminare.
10. Le XII Tavole stabilirono che è consentito raccogliere le [proprie] ghiande cadute sul fondo
altrui.
E' possibile che il termine ghiande venisse usato per indicare anche altri frutti. Si può anche
supporre che l'estensione del concetto sia avvenuta in epoca successiva, per interpretazione
analogica.
11. Le cose vendute e consegnate non divengono proprietà dell'acquirente se non quando questi
abbia pagato il prezzo al venditore o lo abbia soddisfatto in altro modo, ad esempio avendo dato
un pegno o un terzo che si assume il debito; così stabilisce la legge delle XII Tavole.
12. Se il testatore ha disposto che [il suo schiavo] fosse libero alla condizione "se dà 10.000 [assi]
all'erede", esso ottiene la libertà anche se è stato venduto dall'erede, se dà il danaro all'acquirente:
così ordina la legge delle XII Tavole.
TAVOLA VIII
1. a) CHI AVRÀ CANTATO UN CANTO INFAMANTE [sarà punito con la pena di morte].
b) Anche se le XII Tavole stabiliscono la pena di morte in pochissimi casi, pure ritennero doverla
stabilire in questi: se alcuno avesse offeso pubblicamente o avesse composto una poesia che
fosse di infamia e vergogna per altri.
E' probabile che la disposizione si riferisse piuttosto a formule di maledizione, ad incantesimi.
2. SE UNO ROMPE AD UN ALTRO UN MEMBRO, E NON VIENE AD UN ACCORDO CON LUI,
SUBISCA LA PENA DEL TAGLIONE.
3. CHI CON LA MANO O CON UN BASTONE HA ROTTO UN OSSO DI UN LIBERO PAGHI UNA
PENA DI TRECENTO [ASSI], SE DI UNO SCHIAVO DI CENTO CINQUANTA [ASSI].
4. SE UNO HA ARRECATO UNA LESIONE [MENO GRAVE DELLE PRECEDENTI], SUBISCA LA
PENA DI VENTICINQUE ASSI.
5. [CHI] HA ARRECATO UN DANNO ... DEVE RISARCIRLO.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
174
6. Se un quadrupede aveva cagionato un danno, la legge delle XII Tavole volle che venisse
consegnato l'animale che aveva cagionato il danno o che venisse offerta una somma per il danno.
Secondo altra interpretazione doveva essere offerto il valore dell'animale.
7. Se la ghianda cade dal tuo albero sul mio fondo e io, mandandovi bestiame, la faccia mangiare,
non puoi agire né in base alla legge delle XII Tavole con l'azione per pascolo di bestiame poiché il
pascolo non avviene sul tuo terreno, né con l'azione di risarcimento per danno arrecato da animali.
E' probabile che l'actio de pauperie non venisse concessa perché in questo caso era il proprietario
stesso che provocava il danno lasciando sporgere i rami.
a) CHI AVRÀ FATTO INCANTESIMI SUI FRUTTI DEI CAMPI ...
b) E SE NON AVRAI ATTIRATO A TE [CON MAGIE] BIADE ALTRUI ...
9. Al pubere che di notte avesse fatto pascolare o avesse tagliato i frutti che si raccolgono nei
campi coltivati, toccava la pena di morte in base alle XII Tavole le quali ordinavano di impiccarlo ad
un albero sacro a Cerere; l'impubere, a scelta del pretore, veniva fustigato oppure condannato a
pagare il danno o il doppio del danno.
Non è chiaro se a Cerere fosse consacrato l'albero o la vittima.
10. Chi avrà incendiato una casa o un mucchio di cereali ammucchiato presso la casa, deve,
secondo quanto ordinano le XII Tavole, essere legato, fustigato e bruciato, se egli ha agito
coscientemente e volontariamente; se invece ciò accadde piuttosto per caso ovverosia per
negligenza, verrà ordinato che risarcisca il danno o, se non è in grado, che venga punito con pena
più lieve.
11. Nelle XII Tavole è stabilito che colui il quale avrà illecitamente tagliato alberi altrui, paghi per
ognuno venticinque assi.
12. SE ALCUNO HA COMMESSO UN FURTO DI NOTTE E SE IL LADRO È STATO UCCISO,
L'UCCISIONE SIA LEGITTIMA.
13. DI GIORNO [È LEGITTIMA L'UCCISIONE] SE IL LADRO SI DIFENDE CON UN'ARMA E [IL
DERUBATO] HA LANCIATO GRIDA DI AIUTO.
14. Per gli altri ladri colti in flagrante, i decemviri stabilirono che se essi erano liberi venissero
fustigati e aggiudicati al derubato [come schiavi]; se erano schiavi che venissero prima fustigati e
poi gettati dalla rupe [Tarpeia]; invece i giovani impuberi, a giudizio del Pretore, venivano fustigati e
dovevano risarcire il danno.
15. a) Per le XII Tavole la pena per il furtum conceptum e il furtum oblatum era il triplo del valore
[della refurtiva].
b) CON UN PIATTO E UNA FASCIA ...
Furtum conceptum era il furto provato mediante il rinvenimento della refurtiva in casa del ladro, Il
derubato doveva presentarsi nudo, coperto solo da una fascia (in modo che non potesse occultare
oggetti), e con in mano un piatto, su cui porre poi in mostra la refurtiva e poteva così perquisire la
casa del presunto ladro. Non è chiaro che cosa fosse il furtum oblatum: forse si aveva quando il
ladro riportava la cosa sul fondo del derubato o quando il ladro affermava che altri gli aveva messo
la refurtiva in casa.
16. SE [IL DERUBATO] AGISCE PER UN FURTO NON FLAGRANTE, IL REO SIA
CONDANNATO A PAGARE IL DOPPIO DEL VALORE DELLA COSA.
17. La legge delle XII Tavole proibisce di usucapire la cosa rubata.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
175
18. a) Dalle XII Tavole venne stabilito che nessuno dovesse ricevere quale interesse più di un
oncia per ogni asse. Vale a dire 1/12 del capitale e quindi l'8, 33 % annuo. b) I nostri antenati
stabilirono nelle loro leggi che il ladro fosse condannato a pagare il doppio del valore e l'usuraio il
quadruplo.
19. Nelle XII Tavole se si agisce per il deposito è concessa un'azione per il doppio del valore.
Vale a dire che l'appropriazione indebita della cosa ricevuta in deposito è equiparata ad un furto
non flagrante.
20. a) Si deve sapere che il delitto del tutore sospettato [di essersi approfittato dei beni del pupillo],
deriva dalle XII Tavole.
b) Nel caso di [più] tutori che hanno sottratto i beni del pupillo, dobbiamo vedere se in base a
quell'azione che secondo le XII Tavole può proporsi contro il tutore per il doppio del valore dei
beni, ciascuno di essi sia tenuto in solido [con gli altri].
21. SE IL PATRONO INGANNA IL SUO CLIENTE, SIA CONSACRATO [ALLA DIVINITÀ].
L'espressione "consacrare alla divinità" indicava la condanna a morte mediante sacrificio rituale
della vittima.
22. SE ALCUNO SI SIA OFFERTO PER ESSERE TESTIMONIO O PESATORE CON LA
BILANCIA, SE POI NON RENDE TESTIMONIANZA, SIA CONSIDERATO INFAME E INCAPACE
DI TESTIMONIARE.
Nella mancipatio dovevano essere presenti cinque testimoni e il libripens. E' probabile che l'
incapacità alla testimonianza implicasse anche l'impossibilità di chiamare altri come teste a proprio
favore.
23. E se ancora ora, in base alle XII Tavole, chi si accerta aver fatto falsa testimonianza, viene
gettato dalla rupe Tarpeia ...
Secondo Dione Cassio chi veniva gettato dalla rupe e riusciva a salvarsi, aveva salva la vita.
24. a) SE UN'ARMA SFUGGE DALLA MANO PIUTTOSTO CHE SE DA ESSA VIENE LANCIATA,
SI OFFRA UN ARIETE.
In caso di uccisione dovuta a sola colpa, non si era puniti ma ci si liberava offrendo agli agnati
della vittima un ariete da sacrificare.
b) Raccogliere di nascosto i frutti dei campi altrui era per le XII Tavole delitto capitale, più grave
dell'omicidio.
Pena capitale non era solo quella di morte, ma anche ogni pena che comportava perdita di stato
(capitis deminutio).
25. Chi parla di veleno deve anche aggiungere se si tratta di veleno buono o di veleno cattivo,
poiché anche le medicine possono essere velenose.
26. Sappiamo che dalle XII Tavole era stabilito che nessuno facesse sedizioni notturne nella città
[di Roma].
27. A questi soci di un' associazione la legge delle XII Tavole riconobbe il diritto di darsi le regole
che vogliono purché non violino alcuna legge pubblica; pare però che questa disposizione sia stata
presa dalle leggi di Solone.
TAVOLA IX
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
176
1. 2. "NON SI DEVONO STABILIRE PRIVILEGI; NON DI DEVONO DECIDERE MISURE CHE
RIGUARDANO LO STATO DEL CITTADINO SE NON MEDIANTE LE MASSIME ASSEMBLEE
[DEL POPOLO]." Sono state tramandate due eccellenti leggi delle XII tavole di cui una elimina i
privilegi, l'altra vieta di decidere in merito allo status di un cittadino se non nella massima
assemblea.
La "massima assemblea" erano i comizi centuriati introdotti con la costituzione serviana.
3. Trovi tu che fosse una legge dura quella per cui il giudice o l'arbitro assegnato dal Pretore,
riconosciuto colpevole di aver ricevuto danaro per la questione da giudicare, venisse punito con la
pena di morte?
4. I questori che sovraintendevano alle questioni punite con pena capitale erano chiamati questori
parricidi, e di loro fanno menzione le anche le XII Tavole.
Il questore parricida era una specie di "commissario di polizia" che perseguiva i più gravi reati.
Parricidio, che forse in origine stava ad indicare l'uccisione volontaria di un consanguineo, (quindi
non di un pater familias, ma di un par), poi indicò ogni assassinio; la pena era l'annegamento in un
sacco di cuoio.
5. La legge delle XII Tavole ordina che colui che ha istigato i nemici o che ha consegnato un
cittadino ai nemici, sia punito con la pena di morte.
6. Anche le disposizioni delle XII Tavole vietarono di uccidere chiunque prima che fosse
condannato.
TAVOLA X
1. UN MORTO NON SIA NÉ SEPPELLITO NÉ BRUCIATO ENTRO LA CITTÀ
2. NON SI FACCIA PIÙ DI QUESTO: IL LEGNO DEL ROGO NON VENGA LEVIGATO CON
L'ASCIA.
3. [Voi conoscente le disposizioni che seguono poiché da fanciulli imparavamo per forza le XII
Tavole che ora nessuno più impara]. Dopo aver ridotto la spesa [per il funerale] e cioè a tre teli per
il capo, una piccola tunica di porpora e 10 suonatori di flauto, [la legge] eliminò anche le
lamentazioni [delle prefiche]. Poco più avanti, (de leg. 2, 4, 9), Cicerone scrive ancora: "dall'
infanzia, o Quinto, imparavamo a recitare SI IN IUS VOCAT ed altre simili leggi."
4. LE DONNE NON SI GRAFFINO LE GUANCE E DURANTE LA SEPOLTURA NON INTONINO
LAMENTAZIONI.
5. a) DI UN UOMO MORTO NON SI RACCOLGANO LE OSSA PER FARE POI UN FUNERALE
SOLENNE.
b) Si fa eccezione per la morte in terra straniera o in guerra. In questo caso si usava riportare in
patria un osso e celebrare i funerali.
6. a) Ed ancora le seguenti disposizioni si trovano nelle leggi: "vengono eliminate le unzioni [del
cadavere] da parte degli schiavi e ogni giro di bevute [al banchetto funerario]", "nessuna costosa
aspersione, né lunghe corone né incensieri.
b) Un indizio del fatto che gli antichi usavano bevande alla mirra, è che le XII Tavole vietano di
usarle per un morto.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
177
7. A CHI È STATO INCORONATO PER MERITO SUO O DELLA SUA FAMIGLIA O PER
PARTICOLARE VALORE, PUÒ ESSERE MESSA LA CORONA [sul cadavere].
8. E NON DEVE ESSERE USATO ORO [NELLA SEPOLTURA]. NEPPURE SE [AL DEFUNTO] I
DENTI SONO STATI LEGATI CON ORO. SE PERÒ EGLI VIENE SEPOLTO O BRUCIATO CON
L'ORO, NON SIA CONSIDERATO ILLECITO.
Il termine pecunia o familia pecuniaque stava ad indicare tutti gli averi (il bestiame e le persone
soggette).
9. Vi sono inoltre due leggi sui sepolcri; una che vieta di fare un rogo o di innalzare una nuova
sede per roghi a meno di sessanta piedi dalla casa altrui senza il consenso del proprietario [al fine
di evitare gli incendi]. L'altra che vieta l'usucapione del vestibolo del sepolcro o della sede per i
roghi.
TAVOLA XI
1. Dopo che i decemviri avevano redatto le dieci tavole con somma equità e saggezza, l'anno
successivo fecero eleggere al loro posto altri decemviri i quali, aggiunte due tavole di inique leggi,
ordinarono con una legge assolutamente inumana che non vi fosse diritto di connubio tra plebei e
patrizi.
Il divieto di connubio venne abolito poi dal plebiscito di Canuleio (lex Canuleia).
2. Tuditano riferisce che i decemviri che aggiunsero due tavole alle dieci esistenti, interrogarono il
popolo sull'inserimento di giorni intercalari [nel calendario]. Anche Cassio scrive che essi furono gli
autori [di tale disposizione].
3. Fra questi libri sullo Stato ricerchi uno "istorikòn" su Cn. Flavio, figlio di Annio. Questi però non
visse prima dei decemviri. Che cosa ha quindi ottenuto rendendo pubblici i giorni fasti? Si crede
che quella tavola sia stata tenuta nascosta per un certo tempo, affinché nei giorni in cui si poteva
agire pochi si presentassero a far richiesta.
Si poteva agire davanti al Pretore solo nei giorni fasti il cui elenco era tenuto dai pontefici i quali si
riservavano la sua conoscenza.
TAVOLA XII
1. Con una legge fu poi introdotta la possibilità di prendere il pegno, come già disponevano le XII
Tavole verso colui che aveva comperato un animale da sacrificare e non ne pagava il prezzo;
egualmente verso colui che non pagava la mercede per un animale da soma che qualcuno aveva
dato in affitto per poter impiegare il danaro [ricevuto dall'affitto] per vivande da usare per un
sacrificio.
2. a) SE LO SCHIAVO COMMETTE UN FURTO O ARRECA UN DANNO
b) Per azioni illecite di figli in potestà e di schiavi sono state emanate azioni nossali così che il
padre o [rispettivamente] il padrone potessero subire o la stima del risarcimento oppure
consegnare la persona del responsabile. Le azioni sono stabilite parte in leggi, parte in editti
pretorili; nelle leggi, ad esempio in quella delle XII Tavole concernente il furto.
3. SE QUALCUNO HA OTTENUTO INGIUSTAMENTE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEL
BENE CONTESO [IN ATTESA DELLA DECISIONE DELLA LITE], IL PRETORE, SE LA
CONTROPARTE LO VUOLE, DEVE NOMINARE TRE ARBITRI E IN BASE AL LORO GIUDIZIO
L'ALTRO VENGA CONDANNATO A RISARCIRE IL DANNO PAGANDO IL DOPPIO DEI FRUTTI.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
178
La disposizione regola il problema dei frutti nel caso in cui il bene provvisoriamente assegnato ad
una delle parti in attesa della fine della lite, e quindi da lei percepiti, fosse poi invece aggiudicato
all'altra parte.
4. Ci è vietato (legge delle XII Tavole) di destinare a scopi sacri la cosa oggetto di una
controversia; altrimenti subiamo la pena del doppio del valore del bene; ma non è indicato se
questa somma sia da pagare al fisco oppure all'avversario.
5. Nelle XII Tavole è stabilito che qualunque cosa il popolo avrà sanzionato per ultimo, sia
considerato come diritto approvato.
Come già visto il popolo decideva nei comizi centuriati.
FRAMMENTI DI INCERTA COLLOCAZIONE
1. Il termine nancitor viene usato nelle XII tavole nel senso di "avrà preso".
2. Nelle XII Tavole "quando" viene scritto con la c in fondo (quandoc).
3. Quando nelle preghiere si usa l'espressione "sub vos placo", questa ha lo stesso significato
come "supplico", allo stesso modo che nelle XII Tavole si leggono le espressioni "transque dato",
"endoque plorato" [invece di "tradito", "implorato"].
4. Nell'espressione "con dolo cattivo", l'aggiunta "cattivo" è un arcaismo, poiché così sta scritto
nelle XII Tavole.
5.Le XII Tavole in diverse leggi stabiliscono che è consentito appellarsi al popolo contro ogni
giudizio con cui viene inflitta una pena.
La disposizione si riferisce alle pene stabilite da organi pubblici (magistrati) e non alle pene
stabilite dal giudice civile.
6. I nostri antenati ritennero che non ci fosse vincolo più forte del giuramento per garantire
l'osservanza dei patti; ciò indicano le leggi delle XII Tavole.
7. Nelle XII Tavole si nominano l'alba e il tramonto.
8. Un tempo si usavano solamente monete di rame e cioè gli assi, i dipondi (due assi o due libbre),
i semissi (un mezzo asse), i quadranti (un quarto di asse) e non si usava alcuna moneta d'oro o
d'argento, come si ricava dalla legge delle XII Tavole.
E' incerto se all'epoca delle XII Tavole l'asse corrispondesse ad una moneta oppure ad una barra
di rame, come fa pensare la circostanza che esso veniva pesato.
9. Quando vi sono due parole negative, la legge (XII Tavole) piuttosto consente che vieta: così
osserva anche Servio Sulpicio.
10. Il termine "detestatum" vuol dire dichiarato in presenza di testimoni (oppure intimato a rendere
testimonianza).
11. Quasi nello stesso periodo di tempo, per parlare come i decemviri, la legge sulla prescrizione
trentennale era stata "proquiritata" (pubblicamente resa nota per i quiriti, e cioè i cittadini romani).
Bibliografia
Testo in:
Remains of Old Latin, 4, Archaic Inscriptions, ed. E.H.Warmington, Loeb, London Cambridge
Mass., 1960.
FIRA Fontes iuris Romani antesiustiniani, ed. Riccobono.
IntraText 0285
Bibliothecha Augustana
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
179
Il testo della legge delle XII Tavole è stato ricostruito, per quanto possibile, stante la limitatezza dei
frammenti pervenutici, da Heinrich E. Dirksen (Lipsia 1824), da R. Schöll (Lipsia 1966) e, infine, da
Karl G. Bruns, Theodor Mommsen e Otto Gradenvitz che lo hanno pubblicato nella loro opera
"Fontes Iuris Romani Antiqui" (III ed., Tubinga, 1909). Nel 1941 il Riccobono lo ha ripubblicato
nella sua opera "Fontes Iuris Romani Anteiustinianei", tenendo conto dei frammenti di Gaio
scoperti nel 1933.
In Italia l'unica traduzione pubblicata, ormai quasi introvabile, pare sia quella di Nereo Cortellini
nella Biblioteca Universale Sonzogno, Milano, 1900; in tedesco è disponibile una recente
traduzione di Rudolf Düll (Das Zwölftafelgesetz, 4. ed., Monaco, 1971), con un buon commento.
Palmer, 77-78
Cf. M. Bretone, Storia del diritto romano, pp. 67-106 (Il costume e la legge nell’esperienza arcaica).
ICCU ?
verificare se comprese anche in Fontes Iuris Romani antiqui, edd. C.G. Bruns - Th. Mommsen - O.
Gradenwitz, I-II, Tübingen 19097.
Comprese in:
in: Fontes iuris Romani antiqui I
ed. G. Bruns//O. Gradenwitz, Tübingen 1909
in: Textes de droit Romain
ed. Girard, Paris 1923
Fontes Iuris Romani Antejustinianei I, leges
ed. Riccobono, Firenze 1941
Leges XII tabularum/Zwölftafelgesetz
ed. R. Düll, München 1971
Studi
Riposati
Qui si incontrano le Leggi delle dodici Tavole (Leges X!l tabularum), il piú insigne codice arcaico della
sapienza gluridica romana, fonte di ogni diritto pubblico e privato, testo sacro di procedura civile e penale
sino alla piú tarda latinità. In esso rifluisce, si seleziona e si determina il succo del diritto consuetudinario
tradizionale, e si fissano definitivamente i diritti e i doveri dei cittadini, sempre piú compromessi nella lunga e
combattuta lotta di classe tra patrizi e plebei. La compilazione di queste Leges fu aífidata ad una
commissione di dieci patrizi (decemotri legibus scribundis), esperti nel giure e con pieni poteri anche politici.
La tradizione informa che la redazione e promulgazione del testo avvenne in due periodi successivi: nel 451
a. C. Ie prime dieci Tavole; nell'anno seguente le altre due supplementari. Incise su lastre di bronzo, furono
esposte nel Foro, dove rimasero fino all'incendio gallico; il testo originale andò disperso.
Anche ammesso, come si vuole da alcuni, che alla compilazione delle Leges non fossero estranei influssi
giuridici greci, mutuati forse attraverso gh Etruschl ( ), rlmane sempre vero che le esperienze sociali, il
severo spirito normativo, la saggezza moderatrice, la sostanza umana e la forma espressiva sono
inconfondibilmente romani, anche qui prosa asciutta, formulare, in un periodare breve, secco, incisivo,
caratterizzato da forme allitteranti e simmetriche
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
180
"Dodici tavole - Encarta",
Legge delle Dodici Tavole
Legge delle Dodici Tavole Il più antico codice di diritto romano. Compilato nel 451-450 a.C. da dieci
magistrati, chiamati decemviri, raccoglieva per iscritto il diritto romano, sino ad allora conosciuto e trasmesso
solo oralmente. Le norme, inscritte su dodici tavolette di bronzo o legno ed esposte nel foro romano,
disciplinavano ogni ambito del diritto e, pur con numerose modifiche, rimasero in vigore per quasi mille anni.
Le tavolette furono distrutte dai galli durante il sacco di Roma nel 390 a.C., ma una parte del loro contenuto
ci è pervenuta grazie ai riferimenti e alle citazioni nella letteratura latina successiva.
Ricerca iconografica internet.
Senatus consultum de bacchanalibus
Il senatus consultum de Bacchanalibus è un “editto” (controllo), datato al 7 ottobre del 186 a.C.:
esso vietava ai seguaci di Bacco la pratica del culto e delle feste in onore della divinità, per il
comportamento sfrenato degli adepti ed il conseguente turbamento dell'ordine pubblico. Il divieto
era valido nell'ager Teuranus e nel territorio della Res Publica.
Testi e testimonianze
Testo Intratext ?
Senatus consultum I
Quintus Marcius Luci filius, Spurius Postumius Luci filius consules senatum consoluerunt nonis Octobribus,
apud aedem Duelonai. Scribundo arfuerunt Marcus Claudius Marci filius, Lucius Valerius Publi filius, Quintus
Minucius Cai filius
De Bacanalibus quei foideratei esent, ita exdeicendum censuere:
"Neiquis eorum Bacanal habuise velet. seiques esent, quei sibei deicerent necesus ese Bacanal habere,
eeis utei ad praitorem) urbanum Romam venirent, deque eeis rebus, ubei eorum verba audita esent, utei
senatus noster decerneret, dum ne minus senatoribus C adesent, quom ea res cosoleretur. Bacas vir nequis
adiese velet ceivis Romanus neve nominus Latini neve socium quisquam, nisei praitorem urbanum adiesent,
isque de senatuos sententiad, dum ne minus senatoribus C adesent, quom ea res cosoleretur, iousisent.
Censuere.
Sacerdos nequis vir eset. Magister neque vir neque mulier quisquam eset. neve pecuniam quisquam eorum
comoinem habuise velet. Neve magistratum, neve pro magistratu, neque virum neque mulierem quisquam
fecise velet. Neve post hac inter sed coniourase neve comvovise neve conspondise neve conpromesise
velet, neve quisquam fidem inter sed dedise velet. Sacra in quoltod ne quisquam fecise velet. Neve in
poplicod neve in preivatod neve exstrad urbem sacra quisquam fecise velet, nisei praitorem urbanum
adieset, isque de senatuos sententiad, dum ne minus senatoribus C adesent, quom ea res cosoleretur,
iousisent.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
181
Censuere.
Homines plous V oinvorsei virei atque mulieres sacra ne quisquam fecise velet, neve inter ibei virei plous
duobus, mulieribus plous tribus arfuise velent, nisei de praitoris urbani senatuosque sententiad, utei suprad
scriptum est."
Haice utei in coventionid exdeicatis ne minus trinum noundinum, senatuosque sententiam utei scientes
esetis, eorum sententia ita fuit: "Sei ques esent, quei arvorsum ead fecisent, quam suprad scriptum est, eeis
rem caputalem faciendam censuere". atque utei hoce in tabolam ahenam inceideretis, ita senatus aiquom
censuit, uteique eam figier ioubeatis, ubei facilumed gnoscier potisit. Atque utei ea Bacanalia, sei qua sunt,
exstrad quam sei quid ibei sacri est, ita utei suprad scriptum est, in diebus X, quibus vobeis tabelai datai
erunt, faciatis utei dismota sient.
In agro Teurano.
Senatus consultum II
Q. Marcius Luci filius, Spurius Postumius Luci filius consules senatum consuluerunt Nonis Octobribus apud
aedem Bellonae. Scribendo adfuerunt M. Claudius Marci filius, L. Valerius Publi filius, Q. Minucius Gai filius.
De Bacchanalibus, qui foederati essent, ita edicendum censuere:
"Ne quis eorum Bacchanal habuisse vellet. Si qui essent, qui sibi dicerent necesse esse Bacchanal habere,
ei ut ad praetorem urbanum Romam venirent, deque eis rebus, ubi eorum verba audita essent, ut senatus
noster decerneret, dum ne minus senatoribus centum adessent, cum ea res consuleretur. Bacchas vir ne
quis adisse vellet civis Romanus neve nominis Latini neve sociorum quisquam, nisi praetorem urbanum
adissent, isque de senatus sententia, dum ne minus senatoribus centum adessent, cam ea res consuleretur,
iussissent.
Censuere.
Sacerdos ne quis vir esset. magister neque vir neque mulier quisquam esset. Neve pecuniam quisquam
eorum communem habuisse vellet. Neve magistratum neve pro magistratu neque virum neque mulierem
quisquam fecisse vellet. Neve posthac inter se coniurasse neve convovisse neve conspondisse neve
compromisisse vellet, neve quisquam fidem inter se dedisse vellet. Sacra in occulto ne quisquam fecisse
vellet. Neve in publico neve in privato neve extra urbem sacra quisquam fecisse vellet, nisi praetorem
urbanum adisset isque de senatus sententia, dum ne minus senatoribus centum adessent, cum ea res
consuleretur, iussissent.
Censuere.
Homines plus quinque universi, viri atque mulieres, sacra ne quisquam fecisse vellet, neve interibi viri plus
duobus, mulieribus plus tribus adfuisse vellent, nisi de praetoris urbani senatusque sententia, ut supra
scriptum est."
Haec ut in contione edicatis ne minus trinum nundinum, senatusque sententiam ut scientes essetis, eorum
sententia ita fuit: "Si qui essent, qui adversum ea fecissent, quam supra scriptum est, eis rem capitalem
faciendam censuere"; atque ut hoc in tabulam aeneam incideretis, ita senatus aequum censuit, utque eam
figi iubeatis, ubi facillime nosci possit. Atque ut ea Bacchanalia, si qua sunt, extra quam si quid ibi sacri est,
ita ut supra scriptum est, in diebus decem, quibus vobis tabellae datae erunt, faciatis, ut dimota sint.
Testo da www.Rome.webzone.ru
Q. Marcius L. f., Sp. Postumius L. f. cos. senatum consoluerunt nonis octob. apud aedem
Duelonai. scribendo adfuerunt* M. Claudius M. f., L. Valerius P. f., Q. Minucius C. f. de
bacchanalibus* qui* foederati* essent*, ita exdicendum* censuere: nequis* eorum bacchanal*
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
182
habuisse* vellet*; si* ques essent*, qui* sibi* dicerent* necesus esse* bacchanal* habere, eis* uti*
ad praetorem* urbanum Romam venirent, deque eis* rebus, ubi* eorum verba audita essent*, uti*
senatus noster decerneret, dum ne minus senatoribus c adessent* quom ea res cosoloretur*.
Bacas vir nequis adisse* vellet* civis* Romanus neve nominus Latini neve socium quisquam, nisi*
praetorem* urbanum adissent*, isque de senatus* sententia*, dum ne minus senatoribus c
adessent* quom ea res cosoloretur, iussissent*. Censuere. Sacerdos nequis vir esset*; magister
neque vir neque mulier quisquam esset*. Neve pecuniam quisquam eorum communem* habuisse*
vellet*; neve magistratum, neve pro magistratu*, neque virum neque mulierem quiquam fecisse*
vellet*. Neve post hac inter sed coniurasse* neve commovisse* neve conspondisse* neve
compromisisse* vellet*, neve quisquam fidem inter sed dedisse* vellet*. Sacra in oquoltod ne
quisquam fecisse* vellet*; neve in publico* neve in privato* neve extra* urbem sacra quisquam
fecisse* vellet*, nisi* praetorem* urbanum adieset, isque de senatus* sententia*, dum ne minus
senatoribus c adessent* quom ea res cosoloretur, iussissent*. Censuere. Homines plus* V
oinuorsi* viri* atque mulieres sacra ne quisquam fecisse* vellet*, neve inter ibi* viri* plus* duobus,
mulieribus plus* tribus adfuise* vellent*, nisi* de praetoris* urbani senatusque* sententia*, uti*
supra* scriptum est. Haice uti* in conventioni* exdicatis* ne minus trinum nundinum*, senatusque*
sententiam uti* scientes essetis*, - eorum sententia ita fuit: 'si* ques essent*, qui* adversum* ead
fecissent*, quam supra* scriptum est, iis* rem capitalem* faciendam censuere' - atque uti* hoce in
tabulam* ahenam incideretis*, ita senatus aiquom censuit, utique* eam figier iubeatis*, ubi*
facilumed gnoscier potisit atque uti* ea bacchanalia*, si* qua sunt, extra* quam si* quid ibi* sacri
est, ita uti* supra* scriptum est, in diebus X, quibus vobis* tabulae* datae* erunt, faciatis uti*
dismota sient. - In agro Teurano.
-------------------------------------------------------------------------------| [Q(uintus)] Marcius L(uci) f(ilius), S(purius) Postumius L(uci) f(ilius) co(n)s(ules) senatum
consoluerunt n(onis) Octob(ribus), apud aedem |2| Duelonai. sc(ribundo) arf(uerunt) M(arcus)
Claudi(us) M(arci) f(ilius), L(ucius) Valeri(us) P(ubli) f(ilius), Q(uintus) Minuci(us) C(ai) f(ilius)
de Bacanalibus quei foideratei |3| esent, ita exdeicendum censuere:
«neiquis eorum [B]acanal habuise velet. seiques |4| esent, quei sibei deicerent necesus ese
Bacanal habere, eeis utei ad pr(aitorem) urbanum |5| Romam venirent, deque eeis rebus, ubei
eorum v[e]r[b]a audita esent, utei senatus |6| noster decerneret, dum ne minus senator[i]bus C
adesent, [quom e]a res cosoleretur. |7| Bacas vir nequis adiese velet ceivis Romanus neve
nominus Latini neve socium |8| quisquam, nisei pr(aitorem) urbanum adiesent, isque [d]e senatuos
sententiad, dum ne |9| minus senatoribus C adesent, quom ea res cosoleretur, iousisent.
ce[n]suere.
|10| sacerdos nequis uir eset. magister neque uir neque mulier quisquam eset. |11| neve pecuniam
quisquam eorum comoine[m h]abuise velet. neve magistratum, |12| neve pro magistratu[d], neque
virum [neque mul]ierem qui[s]quam fecise velet. |13| neve post hac inter sed conioura[se nev]e
comvovise neve conspondise |14| neve conpromesise velet, neve quisquam fidem inter sed dedise
velet. |15| sacra in [o]quoltod ne quisquam fecise velet. neve in poplicod neve in |16| preivatod
neve exstrad urbem sacra quisquam fecise velet, nisei |17| pr(aitorem) urbanum adieset, isque de
senatuos sententiad, dum ne minus |18| senatoribus C adesent, quom ea res cosoleretur,
iousisent.
censuere.
|19| homines plous V oinvorsei virei atque mulieres sacra ne quisquam |20| fecise velet, neve inter
ibei virei plous duobus, mulieribus plous tribus |21| arfuise velent, nisei de pr(aitoris) urbani
senatuosque sententiad, utei suprad |22| scriptum est.»
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
183
haice utei in coventionid exdeicatis ne minus trinum |23| noundinum, senatuosque sententiam utei
scientes esetis, eorum |24| sententia ita fuit: «sei ques esent, quei arvorsum ead fecisent, quam
suprad |25| scriptum est, eeis rem caputalem faciendam censuere». atque utei |26| hoce in
tabolam ahenam inceideretis, ita senatus aiquom censuit, |27| uteique eam figier ioubeatis, ubei
facilumed gnoscier potisit. atque |28| utei ea Bacanalia, sei qua sunt, exstrad quam sei quid ibei
sacri est, |29| ita utei suprad scriptum est, in diebus X, quibus vobeis tabelai datai |30| erunt,
faciatis utei dismota sient.
in agro Teurano.
Collegamento a brano di Livio, riportato sub Livio.
Liv., 39, 8-20. L'affare Baccanali.
Insequens annus Sp. Postumium Albinum et Q. Marcium Philippum consules ab exercitu bellorumque et
prouinciarum cura ad intestinae coniurationis uindictam auertit. praetores prouincias sortiti sunt, T. Maenius
urbanam, M. Licinius Lucullus inter ciues et peregrinos, C. Aurelius Scaurus Sardiniam, P. Cornelius Sulla
Siciliam, L. Quinctius Crispinus Hispaniam citeriorem, C. Calpurnius Piso Hispaniam ulteriorem. consulibus
ambobus quaestio de clandestinis coniurationibus decreta est. Graecus ignobilis in Etruriam primum uenit
nulla cum arte earum, quas multas ad animorum corporumque cultum nobis eruditissima omnium gens
inuexit, sacrificulus et uates; nec is qui aperta religione, propalam et quaestum et disciplinam profitendo,
animos errore imbueret, sed occultorum et nocturnorum antistes sacrorum. initia erant, quae primo paucis
tradita sunt, deinde uulgari coepta sunt per uiros mulieresque. additae uoluptates religioni uini et epularum,
quo plurium animi illicerentur. cum uinum animos <incendissent>, et nox et mixti feminis mares, aetatis
tenerae maioribus, discrimen omne pudoris exstinxissent, corruptelae primum omnis generis fieri coeptae,
cum ad id quisque, quo natura pronioris libidinis esset, paratam uoluptatem haberet. nec unum genus noxae,
stupra promiscua ingenuorum feminarumque erant, sed falsi testes, falsa signa testamentaque et indicia ex
eadem officina exibant: uenena indidem intestinaeque caedes, ita ut ne corpora quidem interdum ad
sepulturam exstarent. multa dolo, pleraque per uim audebantur. occulebat uim quod prae ululatibus
tympanorumque et cymbalorum strepitu nulla uox quiritantium inter stupra et caedes exaudiri poterat. huius
mali labes ex Etruria Romam ueluti contagione morbi penetrauit. primo urbis magnitudo capacior
patientiorque talium malorum ea celauit: tandem indicium hoc maxime modo ad Postumium consulem
peruenit. P. Aebutius, cuius pater publico equo stipendia fecerat, pupillus relictus, mortuis deinde tutoribus
sub tutela Duroniae matris et uitrici T. Sempronii Rutili educatus fuerat. et mater dedita uiro erat, et uitricus,
quia tutelam ita gesserat, ut rationem reddere non posset, aut tolli pupillum aut obnoxium sibi uinculo aliquo
fieri cupiebat. uia una corruptelae Bacchanalia erant. mater adulescentem appellat: se pro aegro eo uouisse,
ubi primum conualuisset, Bacchis eum se initiaturam; damnatam uoti benignitate deum exsoluere id uelle.
decem dierum castimonia opus esse: decimo die cenatum, deinde pure lautum in sacrarium deducturam.
scortum nobile libertina Hispala Faecenia, non digna quaestu, cui ancillula adsuerat, etiam postquam
manumissa erat, eodem se genere tuebatur. huic consuetudo iuxta uicinitatem cum Aebutio fuit, minime
adulescentis aut rei aut famae damnosa: ultro enim amatus appetitusque erat, et maligne omnia
praebentibus suis meretriculae munificentia sustinebatur. quin eo processerat consuetudine capta, ut post
patroni mortem, quia in nullius manu erat, tutore ab tribunis et praetore petito, cum testamentum faceret,
unum Aebutium institueret heredem. haec amoris pignora cum essent, nec quicquam secretum alter ab
altero haberent, per iocum adulescens uetat eam mirari, si per aliquot noctes secubuisset: religionis se
causa, ut uoto pro ualetudine sua facto liberetur, Bacchis initiari uelle. id ubi mulier audiuit, perturbata 'dii
meliora.' inquit: mori et sibi et illi satius esse quam id faceret; et in caput eorum detestari minas periculaque,
qui id suasissent. admiratus cum uerba tum perturbationem tantam adulescens parcere exsecrationibus
iubet: matrem id sibi adsentiente uitrico imperasse. 'uitricus ergo' inquit 'tuus–matrem enim insimulare
forsitan fas non sit–pudicitiam famam spem uitamque tuam perditum ire hoc facto properat.' eo magis
mirabundo quaerentique, quid rei esset, pacem ueniamque precata deorum dearumque, si coacta caritate
eius silenda enuntiasset, ancillam se ait dominae comitem id sacrarium intrasse, liberam numquam eo
accessisse. scire corruptelarum omnis generis eam officinam esse; et iam biennio constare neminem
initiatum ibi maiorem annis uiginti. ut quisque introductus sit, uelut uictimam tradi sacerdotibus. eos deducere
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
184
in locum, qui circumsonet ululatibus cantuque symphoniae et cymbalorum et tympanorum pulsu, ne uox
quiritantis, cum per uim stuprum inferatur, exaudiri possit. orare inde atque obsecrare, ut eam rem
quocumque modo discuteret nec se eo praecipitaret, ubi omnia infanda patienda primum, deinde facienda
essent. neque ante dimisit eum, quam fidem dedit adulescens ab his sacris se temperaturum. postquam
domum uenit, et mater mentionem intulit, quid eo die, quid deinceps ceteris, quae ad sacra pertinerent,
faciendum esset, negat eorum se quicquam facturum, nec initiari sibi in animo esse. aderat sermoni uitricus.
confestim mulier exclamat Hispalae concubitu carere eum decem noctes non posse; illius excetrae
delenimentis et uenenis imbutum nec parentis nec uitrici nec deorum uerecundiam habere. iurgantes hinc
mater, hinc uitricus cum quattuor eum seruis domo exegerunt. adulescens inde ad Aebutiam se amitam
contulit, causamque ei, cur esset a matre eiectus, narrauit, deinde ex auctoritate eius postero die ad
consulem Postumium arbitris remotis rem detulit. consul post diem tertium redire ad se iussum dimisit; ipse
Sulpiciam grauem feminam, socrum suam, percunctatus est, ecquam anum Aebutiam ex Auentino nosset.
cum ea nosse probam et antiqui moris feminam respondisset, opus esse sibi ea conuenta dixit: mitteret
nuntium ad eam, ut ueniret. Aebutia accita ad Sulpiciam uenit, et consul paulo post, uelut forte interuenisset,
sermonem de Aebutio fratris eius filio infert. lacrimae mulieri obortae, et miserari casum adulescentis coepit,
qui spoliatus fortunis, a quibus minime oporteret, apud se tunc esset, eiectus a matre, quod probus
adulescens –dii propitii essent–obscenis, ut fama esset, sacris initiari nollet. satis exploratum de Aebutio
ratus consul non uanum auctorem esse, Aebutia dimissa socrum rogat, ut Hispalam indidem ex Auentino
libertinam, non ignotam uiciniae, arcesseret ad sese: eam quoque esse quae percunctari uellet. ad cuius
nuntium perturbata Hispala, quod ad tam nobilem et grauem feminam ignara causae arcesseretur, postquam
lictores in uestibulo turbamque consularem et consulem ipsum conspexit, prope exanimata est. in interiorem
partem aedium abductam socru adhibita consul, si uera dicere inducere in animum posset, negat perturbari
debere; fidem uel a Sulpicia, tali femina, uel ab se acciperet; expromeret sibi, quae in luco Stimulae
Bacchanalibus in sacro nocturno solerent fieri. hoc ubi audiuit, tantus pauor tremorque omnium membrorum
mulierem cepit, ut diu hiscere non posset. tandem confirmata puellam admodum se ancillam initiatam cum
domina ait: aliquot annis, ex quo manumissa sit, nihil quid ibi fiat scire. iam id ipsum consul laudare, quod
initiatam se non infitiaretur: sed et cetera eadem fide expromeret. neganti ultra quicquam scire, non eandem
dicere, si coarguatur ab alio, ac per se fatenti ueniam aut gratiam fore; eum sibi omnia exposuisse, qui ab illa
audisset. mulier haud dubie, id quod erat, Aebutium indicem arcani rata esse, ad pedes Sulpiciae procidit, et
eam primo orare coepit, ne mulieris libertinae cum amatore sermonem in rem non seriam modo sed
capitalem etiam uerti uellet: se terrendi eius causa, non quod sciret quicquam, ea locutam esse. hic
Postumius accensus ira tum quoque ait eam cum Aebutio se amatore cauillari credere, non in domo
grauissimae feminae et cum consule loqui. et Sulpicia attollere pauentem, simul illam adhortari, simul iram
generi lenire. tandem confirmata, multum incusata perfidia Aebutii, qui optime de ipso meritae talem gratiam
rettulisset, magnum sibi metum deorum, quorum occulta initia enuntiaret, maiorem multo dixit hominum
esse, qui se indicem manibus suis discerpturi essent. itaque hoc se Sulpiciam, hoc consulem orare, ut se
extra Italiam aliquo ablegarent, ubi reliquum uitae degere tuto posset. bono animo esse iubere eam consul,
et sibi curae fore dicere, ut Romae tuto habitaret. tum Hispala originem sacrorum expromit. primo sacrarium
id feminarum fuisse, nec quemquam eo uirum admitti solitum. tres in anno statos dies habuisse, quibus
interdiu Bacchis initiarentur; sacerdotes in uicem matronas creari solitas. Pacullam Anniam Campanam
sacerdotem omnia, tamquam deum monitu, immutasse: nam et uiros eam primam filios suos initiasse,
Minium et Herennium Cerrinios; et nocturnum sacrum ex diurno, et pro tribus in anno diebus quinos singulis
mensibus dies initiorum fecisse. ex quo in promiscuo sacra sint et permixti uiri feminis, et noctis licentia
accesserit, nihil ibi facinoris, nihil flagitii praetermissum. plura uirorum inter sese quam feminarum esse
stupra. si qui minus patientes dedecoris sint et pigriores ad facinus, pro uictimis immolari. nihil nefas ducere,
hanc summam inter eos religionem esse. uiros, uelut mente capta, cum iactatione fanatica corporis
uaticinari; matronas Baccharum habitu crinibus sparsis cum ardentibus facibus decurrere ad Tiberim,
demissasque in aquam faces, quia uiuum sulpur cum calce insit, integra flamma efferre. raptos a diis
homines dici, quos machinae illigatos ex conspectu in abditos specus abripiant: eos esse, qui aut coniurare
aut sociari facinoribus aut stuprum pati noluerint. multitudinem ingentem, alterum iam prope populum esse;
in his nobiles quosdam uiros feminasque. biennio proximo institutum esse, ne quis maior uiginti annis
initiaretur: captari aetates et erroris et stupri patientes. peracto indicio aduoluta rursus genibus preces
easdem, ut se ablegaret, repetiuit. consul rogat socrum, ut aliquam partem aedium uacuam faceret, quo
Hispala immigraret. cenaculum super aedes datum est, scalis ferentibus in publicum obseratis, aditu in
aedes uerso. res omnes Faeceniae extemplo translatae et familia arcessita, et Aebutius migrare ad consulis
clientem iussus. ita cum indices ambo in potestate essent, rem ad senatum Postumius defert, omnibus
ordine expositis, quae delata primo, quae deinde ab se inquisita forent. patres pauor ingens cepit, cum
publico nomine, ne quid eae coniurationes coetusque nocturni fraudis occultae aut periculi importarent, tum
priuatim suorum cuiusque uicem, ne quis adfinis ei noxae esset. censuit autem senatus gratias consuli
agendas, quod eam rem et cum singulari cura et sine ullo tumultu inuestigasset. quaestionem deinde de
Bacchanalibus sacrisque nocturnis extra ordinem consulibus mandant; indicibus Aebutio ac Faeceniae ne
fraudi ea res sit curare et alios indices praemiis inuitare iubent; sacerdotes eorum sacrorum, seu uiri seu
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
185
feminae essent, non Romae modo sed per omnia fora et conciliabula conquiri, ut in consulum potestate
essent; edici praeterea in urbe Roma et per totam Italiam edicta mitti, ne quis, qui Bacchis initiatus esset,
coisse aut conuenisse sacrorum causa uelit, neu quid talis rei diuinae fecisse. ante omnia ut quaestio de iis
habeatur, qui coierint coniurauerintue, quo stuprum flagitiumue inferretur. haec senatus decreuit. consules
aedilibus curulibus imperarunt, ut sacerdotes eius sacri omnes conquirerent, comprehensosque libero
conclaui ad quaestionem seruarent; aediles plebis uiderent, ne qua sacra in operto fierent. triumuiris
capitalibus mandatum est, ut uigilias disponerent per urbem seruarentque, ne qui nocturni coetus fierent,
utque ab incendiis caueretur; adiutores triumuiris quinqueuiri uls cis Tiberim suae quisque regionis aedificiis
praeessent. ad haec officia dimissis magistratibus consules in rostra escenderunt, et contione aduocata cum
sollemne carmen precationis, quod praefari, priusquam populum adloquantur, magistratus solent, peregisset
consul, ita coepit. 'nulli umquam contioni, Quirites, tam non solum apta sed etiam necessaria haec sollemnis
deorum comprecatio fuit, quae uos admoneret hos esse deos, quos colere uenerari precarique maiores
uestri instituissent, non illos, qui prauis et externis religionibus captas mentes uelut furialibus stimulis ad
omne scelus et ad omnem libidinem agerent. equidem nec quid taceam nec quatenus proloquar inuenio. si
aliquid ignorabitis, ne locum neglegentiae dem, si omnia nudauero, ne nimium terroris offundam uobis,
uereor. quidquid dixero, minus quam pro atrocitate et magnitudine rei dictum scitote esse: ut ad cauendum
satis sit, dabitur opera a nobis. Bacchanalia tota iam pridem Italia et nunc per urbem etiam multis locis esse,
non fama solum accepisse uos sed crepitibus etiam ululatibusque nocturnis, qui personant tota urbe, certum
habeo, ceterum quae ea res sit, ignorare: alios deorum aliquem cultum, alios concessum ludum et lasciuiam
credere esse, et qualecumque sit, ad paucos pertinere. quod ad multitudinem eorum attinet, si dixero multa
milia hominum esse, ilico necesse est exterreamini, nisi adiunxero qui qualesque sint. primum igitur
mulierum magna pars est, et is fons mali huiusce fuit; deinde simillimi feminis mares, stuprati et
constupratores, fanatici, uigiliis, uino, strepitibus clamoribusque nocturnis attoniti. nullas adhuc uires
coniuratio, ceterum incrementum ingens uirium habet, quod in dies plures fiunt. maiores uestri ne uos
quidem, nisi cum aut uexillo in arce posito comitiorum causa exercitus eductus esset, aut plebi concilium
tribuni edixissent, aut aliquis ex magistratibus ad contionem uocasset, forte temere coire uoluerunt; et
ubicumque multitudo esset, ibi et legitimum rectorem multitudinis censebant esse debere. quales primum
nocturnos coetus, deinde promiscuos mulierum ac uirorum esse creditis? si quibus aetatibus initientur mares
sciatis, non misereat uos eorum solum, sed etiam pudeat. hoc sacramento initiatos iuuenes milites faciendos
censetis, Quirites? his ex obsceno sacrario eductis arma committenda? hi cooperti stupris suis alienisque
pro pudicitia coniugum ac liberorum uestrorum ferro decernent? minus tamen esset, si flagitiis tantum
effeminati forent–ipsorum id magna ex parte dedecus erat–, a facinoribus manus, mentem a fraudibus
abstinuissent: numquam tantum malum in re publica fuit, nec ad plures nec ad plura pertinens. quidquid his
annis libidine, quidquid fraude, quidquid scelere peccatum est, ex illo uno sacrario scitote ortum esse.
necdum omnia, in quae coniurarunt, edita facinora habent. adhuc priuatis noxiis, quia nondum ad rem
publicam opprimendam satis uirium est, coniuratio sese impia tenet. crescit et serpit quotidie malum. iam
maius est, quam ut capere id priuata fortuna possit: ad summam rem publicam spectat. nisi praecauetis,
Quirites, iam huic diurnae, legitime ab consule uocatae, par nocturna contio esse poterit. nunc illi uos singuli
uniuersos contionantes timent: iam ubi uos dilapsi domos et in rura uestra eritis, illi coierint, consultabunt de
sua salute simul ac uestra pernicie: tum singulis uobis uniuersi timendi erunt. optare igitur unusquisque
uestrum debet, ut bona mens suis omnibus fuerit. si quem libido, si furor in illum gurgitem abripuit, illorum
eum, cum quibus in omne flagitium et facinus coniurauit, non suum iudicet esse. ne quis etiam errore labatur
uestrum, Quirites, non sum securus. nihil enim in speciem fallacius est quam praua religio. ubi deorum
numen praetenditur sceleribus, subit animum timor, ne fraudibus humanis uindicandis diuini iuris aliquid
immixtum uiolemus. hac uos religione innumerabilia decreta pontificum, senatus consulta, haruspicum
denique responsa liberant. quotiens hoc patrum auorumque aetate negotium est magistratibus datum, uti
sacra externa fieri uetarent, sacrificulos uatesque foro circo urbe prohiberent, uaticinos libros conquirerent
comburerentque, omnem disciplinam sacrificandi praeterquam more Romano abolerent. iudicabant enim
prudentissimi uiri omnis diuini humanique iuris nihil aeque dissoluendae religionis esse, quam ubi non patrio
sed externo ritu sacrificaretur. haec uobis praedicenda ratus sum, ne qua superstitio agitaret animos uestros,
cum demolientes nos Bacchanalia discutientesque nefarios coetus cerneretis. omnia diis propitiis
uolentibusque [ea] faciemus; qui quia suum numen sceleribus libidinibusque contaminari indigne ferebant,
ex occultis ea tenebris in lucem extraxerunt, nec patefieri, ut impunita essent, sed ut uindicarentur et
opprimerentur, uoluerunt. senatus quaestionem extra ordinem de ea re mihi collegaeque meo mandauit.
nos, quae ipsis nobis agenda sunt, impigre exsequemur; uigiliarum nocturnarum curam per urbem minoribus
magistratibus mandauimus. uos quoque aequum est, quae uestra munia sunt, quo quisque loco positus erit,
quod imperabitur, impigre praestare, et dare operam, ne quid fraude noxiorum periculi aut tumultus oriatur.'
recitari deinde senatus consulta iusserunt, indicique praemium proposuerunt, si quis quem ad se deduxisset
nomenue absentis detulisset. qui nominatus profugisset, diem certam se finituros, ad quam nisi citatus
respondisset, absens damnaretur. si quis eorum, qui tum extra terram Italiam essent, nominaretur, ei
laxiorem diem daturos, si uenire ad causam dicendam uellet. edixerunt deinde, ne quis quid fugae causa
uendidisse neue emisse uellet; ne quis reciperet, celaret, ope ulla iuuaret fugientes. contione dimissa terror
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
186
magnus urbe tota fuit, nec moenibus se tantum urbis aut finibus Romanis continuit, sed passim per totam
Italiam, litteris hospitum de senatus consulto et contione et edicto consulum acceptis, trepidari coeptum est.
multi ea nocte, quae diem insecuta est, quo in contione res palam facta est, custodiis circa portas positis
fugientes a triumuiris comprehensi et reducti sunt: multorum delata nomina. quidam ex iis uiri feminaeque
mortem sibi consciuerunt. coniurasse supra septem milia uirorum ac mulierum dicebantur. capita autem
coniurationis constabat esse M. et C. Atinios de plebe Romana et Faliscum L. Opicernium et Minium
Cerrinium Campanum: ab his omnia facinora et flagitia orta, eos maximos sacerdotes conditoresque eius
sacri esse. data opera, ut primo quoque tempore comprehenderentur. adducti ad consules fassique de se
nullam moram indicio fecerunt. ceterum tanta fuga ex urbe facta erat, ut, quia multis actiones et res peribant,
cogerentur praetores T. Maenius et M. Licinius per senatum res in diem tricesimum differre, donec
quaestiones a consulibus perficerentur. eadem solitudo, quia Romae non respondebant nec inueniebantur,
quorum nomina delata erant, coegit consules circa fora proficisci ibique quaerere et iudicia exercere. qui
tantum initiati erant et ex carmine sacro, praeeunte uerba sacerdote, precationes fecerant, [in] quibus
nefanda coniuratio in omne facinus ac libidinem continebatur, nec earum rerum ullam, in quas iureiurando
obligati erant, in se aut alios admiserant, eos in uinculis relinquebant: qui stupris aut caedibus uiolati erant,
qui falsis testimoniis, signis adulterinis, subiectione testamentorum, fraudibus aliis contaminati, eos capitali
poena adficiebant. plures necati quam in uincula coniecti sunt. magna uis in utraque causa uirorum
mulierumque fuit. mulieres damnatas cognatis, aut in quorum manu essent, tradebant, ut ipsi in priuato
animaduerterent in eas: si nemo erat idoneus supplicii exactor, in publico animaduertebatur. datum deinde
consulibus negotium est, ut omnia Bacchanalia Romae primum, deinde per totam Italiam diruerent, extra
quam si qua ibi uetusta ara aut signum consecratum esset. in reliquum deinde senatus consulto cautum est,
ne qua Bacchanalia Romae neue in Italia essent. si quis tale sacrum sollemne et necessarium duceret, nec
sine religione et piaculo se id omittere posse, apud praetorem urbanum profiteretur, praetor senatum
consuleret. si ei permissum esset, cum in senatu centum non minus essent, ita id sacrum faceret, dum ne
plus quinque sacrificio interessent, neu qua pecunia communis neu quis magister sacrorum aut sacerdos
esset. aliud deinde huic coniunctum referente Q. Marcio consule senatus consultum factum est, ut de iis,
quos pro indicibus consules habuissent, integra res ad senatum referretur, cum Sp. Postumius
quaestionibus perfectis Romam redisset. Minium Cerrinium Campanum Ardeam in uincula mittendum
censuerunt, magistratibusque Ardeatium praedicendum, ut intentiore eum custodia adseruarent, non solum
ne effugeret, sed ne mortis consciscendae locum haberet. Sp. Postumius aliquanto post Romam uenit: eo
referente de P. Aebutii et Hispalae Faeceniae praemio, quod eorum opera indicata Bacchanalia essent,
senatus consultum factum est, uti singulis his centena milia aeris quaestores urbani ex aerario darent; utique
consul cum tribunis plebis ageret, ut ad plebem primo quoque tempore ferrent, ut P. Aebutio emerita
stipendia essent, ne inuitus militaret neue censor ei inuito equum publicum adsignaret; utique Faeceniae
Hispalae datio, deminutio, gentis enuptio, tutoris optio item esset, quasi ei uir testamento dedisset; utique ei
ingenuo nubere liceret, neu quid ei qui eam duxisset ob id fraudi ignominiaeue esset; utique consules
praetoresque, qui nunc essent quiue postea futuri essent, curarent, ne quid ei mulieri iniuriae fieret, utique
tuto esset. id senatum uelle et aequum censere, ut ita fieret. ea omnia lata ad plebem factaque sunt ex
senatus consulto; [et] de ceterorum indicum impunitate praemiisque consulibus permissum est.
[8,1] Consolato di Sp. Postumio Albino e Marcio Filippo. L'anno seguente tenne lontani i due
consoli Sp. Postumio Albino e Q. Marcio Filippo dal ccmando degli eserciti e dalla direzione delle
guerre e delle province, e li volse alla repressione di una congiura interna. [2] I pretori 5 si divisero
a sorte le competerìze: T. Menio la pretura urbana, M. Licinio Lucullo la giurisdizione tra cittadini e
stranieri, C. Aurelio Scauro il governo della Sardegna; P. Cornelio Silla la Sicilia, L. Quinzio
Crispino la Spagna Citeriore, C. Calpilrnio Pisone la Spagna Ulteriore. [3] A entrambi i consoli fu
assegnata la procedura contro le sette segrete.
La cosa partì da un Greco sconosciuto che venne in Etruria non già recando qualcuna di quelle arti
che quel popolo maestro fra tutti diffuse fra noi a delizia dello spirito e del corpo; era un praticante
di riti e un indovino, [4] e non già uno che insinuasse l'errore nelle menti con pubblici riti,
professando apertamente una sua arte a scopo di lucro, ma un sacerdote di riti segreti e notturni:
[5] misteri quelli, a cui pochi in origine furono iniziati, e che poi cominciarono a diffondersi senza
distinzione fra uomini e donne. Al rito si aggiunsero le delizie del vino e dei banchetti, perché
fossero di più le menti attratte nell'errore. [6] Quando i fumi del vino, la complicità della notte e il
trovarsi confusi maschi e femmine, fanciulli e adulti ebbero cancellato ogni limite posto dal pudore
cominciarono a commettersi depravazioni di ogni genere, poiché ognuno vi trovava pronto
sodisfacimento per quello a cui cran più portate dall'istinto le sue voglie. [7] E non ci si limitò a un
solo genere di malefici, come violenze indiscriminate su uomini liberi e su donne, ma anche false
testimonianze, falsificazione di suggelli nei testamenti e delazioni uscivano da una stessa fucina [8]
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
187
e sempre di là azioni di magia e delitti familiari, al punto che a volte non restavano neppure i corpi
da seppellire. Molto si osava con l'insidia, ma di più con la violenza. A nascondere la violenza
valeva il fatto che per le grida e il fragore dei timpani e dei cembali non si poteva udire la voce di
quelli che gridavano aiuto fra gli stupri e le uccisioni.
[9,1] Questo flagello dall'Etruria si propagò a Roma come in un'epidemia. Prima lo tenne celato la
vastità dell'urbe, più atta ad accogliere e lasciar passare simili malanni; finché una denuncia al
console Postumio arrivò più o meno nel modo che segue. [2] P. Ebuzio, il cui padre aveva servito
come cavaliere spesato dall'erario era rimasto orfano in età minore, poi, morti anche i primi tutori
era stato educato sotto la tutela della madre Duronia e del patrigno T. Sempronio Rutilo. [3] Ora,
da una parte la madre era sottomessa al marito, dall'altra il patrigno, che aveva amministrato la
tutela in modo da non poterne rendere conto, cercava un modo di disfarsi del pupillo ovvero di
averlo alla sua mercé con qualche possibilità di ricatto. L'unica via di comprometterlo erano i
Baccanali. [4] Ecco che la madre si rivolge al giovane, per dirgli che, in occasione di una sua
malattia, ella aveva fatto voto di iniziarlo, appena fosse guarito, ai Baccaiìali, e ora, vincolata al
voto dalla bontà degli dèi, voleva soddisfarlo. Si richiedevano dieci giorni di castità; nel decimo
giorno, dopo che avesse cenato e preso il bagno con acqua pura, ella lo avrebbe accompagnato
nel sacrario. [5] Una meretrice famosa, la liberta Ispala Fecennia, non degna veramente del
mestiere cui si era abituata da schiava, anche dopo liberata continuava nella stessa vita. [6] Costei
ebbe con Ebuzio una relazione nata dalla vicinanza, senza portar danno alcuno alle finanze o alla
riputazione del giovane; ché egli aveva trovato in lei amore e affetto disinteressato e anzi, mentre i
suoi lo tenevano a stecchetto di tutto, era aiutato dalla generosità di quella povera sgualdrina. [7] E
tutta presa da questa relazione era arrivata al punto che, mortole il patrono, e non essendo sotto
tutela di nessuno, chiese ai tribuni e al pretore un tutore e nominò Ebuzio unico erede.
[10,1] Quando già erano corsi questi pegni di affetto e ormai l'uno non aveva segreti per l'altro,
ecco che il giovane le dice tra lo scherzo di non meravigliarsi se avesse fatto astinenza per
qualche notte; [2] per una ragione religiosa, cioè per sciogliere un voto fatto per la sua guarigione,
voleva essere iniziato ai Baccanali. Quando la donna sentì questo: " Per carità" esclamò tutta
sconvolta; e lì a dire che era meglio per lei e per lui morire piuttosto che egli facesse una cosa
simile; e che il male e il malanno ricadessero sul capo di chi l'aveva consigliato. [3] Il giovane,
sorpreso dalle parole e da tanta disperazione, la prega di lasciar da parte le imprecazioni: era stata
sua madre a voler così, d'accordo col patrigno. [4] "Ah, è dunque il tuo patrigno ", ribatté lei " (forse
non sarà lecito accusare tua madre) che ha fretta di compromettere così il tuo onore, il tuo nome, il
tuo avvenire, la tua vita! " [5] Quello, più che mai meravigliato, chiedeva che volesse dir ciò: Ispala,
invocato il perdono e l'assenso degli dèi e delle dee se per amore di lui rivelava dei misteri, gli
racconta come fosse entrata, quando era schiava, in quel sacrario per accompagnarvi la sua
padrona; [6] da libera non ci si era più accostata; sapeva bene che fucina di depravazioni di ogni
genere fosse quella, e le risultava pure che da due anni nessuno vi era stato iniziato che avesse
più di venti anni. [7] Via via che uno v'era introdotto era consegnato ai sacerdoti come una vittima;
essi lo accompagnavano in un luogo che diffondeva intorno ululati e un concerto fatto di cembali e
di timpani percossi insieme, perché non si sentisse la voce di chi chiedeva aiuto quando era
violentato. [8] Perciò lo pregava e lo scongiurava di sventare in qualunque modo quella
macchinazione e di non gettarsi a capofitto dove lo aspettavano infamie di ogni genere, prima da
subire e poi da commettere. [9] E non lo lasciò andare prima che il giovane le desse la sua parola
che si sarebbe guardato bene da quei riti.
[11,1] Quando egli fu tornato a casa e la madre fece cadere il discorso sugli atti rituali che si
dovevano compiere in quel giorno e poi di seguito nei successivi, dichiarò che non avrebbe fatto
nulla di tutto ciò e che di farsi iniziare non aveva nessuna intenzione. [2] Al dialogo era presente il
patrigno. Subito la donna si dà a gridare che egli non sapeva stare dieci notti separato da Ispala, e
che, stregato dalle malie e dai filtri di quel serpente, non aveva rispetto né per la madre né per il
patrigno né per gli dèi. Messisi a rampognarlo la madre da una parte e il patrigno dall'altra, lo
cacciarono di casa con quattro servi. [3] Il giovane di lì si recò presso una zia, Ebuzia, e le
raccontò la ragione per cui era stato messo alla porta, poi per consiglio di lei il giorno seguente
denunciò la cosa in udienza privata al console Postumio. [4] Il console lo congedò con l'ordine di
ripresentarsi a lui dopo quattro giorni, quindi dal canto suo interpellò la propria suocera Sulpicia,
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
188
donna molto rispettabile, se mai conoscesse una vecchia Ebuzia dell'Aventino [5] Alla risposta di
lei che la conosceva come una brava donna e all'anitica, soggiunse che aveva bisogno di
incontrarsi con lei; le mandasse un'ambasciata per farla venire. [6] Ebuzia, chiamata, si recò da
Sulpicia, e il console poco dopo, facendo conto di capitare lì per caso, fa cadere il discorso sul
nipote di lei Ebuzio. [7] Alla donna venne da piangere, e cominciò a commiserare la sorte del
giovane, che, spogliato dei suoi beni da chi meno avrebbe dovuto, era ora in casa di lei, scacciato
dalla madre solo perché (che gli dèi lo aiutassero) a dei misteri osceni, a quel che si diceva, lui,
giovane onesto, non voleva saperne dì essere iniziato.
[12,1] Il console, certo di avere abbastanza sondata sul conto di Ebuzio una fonte attendibile,
congedata Ebuzia, prega la suocera di far venire la liberta Ispala, pure dell'Aventino, donna non
sconosciuta al vicinato, perché aveva qualcosa da chiedere anche a lei. [2] A questa notizia Ispala,
turbata dall'idea di esser chiamata davanti a una donna così illustre e autorevole senza saperne il
perché, quando vide nel vestibolo i littori e il seguito del console e anche il console in persona,
poco mancò che non svenisse. [3] Il console, fattala venire in una parte interna della casa, e presa
con sé Sulpicia per vedere se la induceva a dire la verità, le dice che non deve spaventarsi, [4] ma
starsene alla parola di una donna come Sulpicia o di lui stesso; gli rivelasse quello che si soleva
fare, durante i riti notturni dei Baccanali, nel bosco di Stimula. [5] Udito questo, la donna fu presa
da un tale spavento e tremito di tutte le membra, che non riusciva ad aprire bocca. [6] Alla fine,
rinfrancata, dichiara che quand'era schiava si era iniziata ancora bambina con la sua padrona; da
qualche anno, cioè da quando era stata emancipata, non sapeva più che cosa vi si facesse. [7] Il
console disse che intanto la lodava già perché non negava di essere stata iniziata; ma ora
rivelasse anche il resto con la stessa sincerità. [8] E siccome quella diceva di non sapere nulla di
più aggiunse che, se fosse smentita da altri, non avrebbe più trovato lo stesso perdono e la stessa
indulgenza che a confessare da sé; tutto gli aveva raccontato per filo e per segno chi lo aveva
saputo da lei.
[13,1] La donna non avendo dubbi, come realmente era, che Ebuzio fosse stato delatore dei
misteri, si gettò ai piedi di Sulpicia e prima si dette a pregarla [2] di non permettere che le
chiacchiere di una liberta col suo amante si trasformassero in cosa non solo seria ma addirittura
fatale; aveva detto così per fargli paura, non perché sapesse qualcosa. [3] A questo punto
Postumio, preso d'ira, le disse che lei forse credeva ancora di scherzare col suo amante Ebuzio e
non già di parlare in casa di una donna autorevole e con un console; ecco allora Sulpicia a farle
coraggio, e un po' a far raccomandazioni a lei, un po' a calmare le ire del genero. [4] Alla fine,
fattasi animo, dopo essersela presa più volte con la perfidia di Ebuzio, che la ricompensava così
dopo tutto il bene che gli aveva fatto, [5] disse che aveva grande timore degli dèi se rivelava i loro
misteri, ma più ancora degli uomini, che avrebbero fatto scempio di lei con le loro mani se avesse
fatto delle rivelazioni. [6] Perciò questo chiedeva a Sulpicia, questo chiedeva al corsole, che la
confinassero in qualche parte fuori d'Italia dove potesse vivere al sicuro il resto della sua vita. [7] Il
console le raccomandò di star calma, e aggiunse che avrebbe pensato lui a darle un'abitazione al
sicuro a Roma. Allora Ispala rivela le origini di quei riti: [8] in un primo tempo era stato un sacrario
riservato alle donne e c 'era stato l'uso di non ammettervi uomini; avevano tre giorni fissi nell'anno
nei quali si iniziavano di giorno ai Baccanali; come sacerdotesse si eleggevano delle matrone a
turno. [9] La sacerdotessa Paculla Annia, campana, aveva introdotto delle riforme radicali,
adducendo una ispirazione divina; fu essa la prima a iniziare dei maschi (i suoi figli Minio e Erennio
Cerrinio); e mutò il rito da diurno a notturno, e invece dei tre giorni nell'anno per le iniziazioni ne
istituì cinque al mese. [10] Dacché i riti erano promiscui e uomini e donne si trovavano mescolati e
vi si era aggiunta la licenza favorita dalla notte, non c'era azione, non c'era infamia da cui si
astenessero; erano più le violenze tra uomini che quelle su donne. [11] Se qualcuno era meno
facile a adattarsi al disonore o meno deciso a simili azioni, veniva immolato come vittima. Non
avere scrupoli, questo era fra di loro il più sacro degli impegni. [12] Gli uomini come impazziti
vaneggiavano gesticolando da invasati con tutta la persona, le matroiie in atteggiamento di
baccanti, coi capelli sparsi, correvano già fino al Tevere con torce accese e, dopo averle immerse
nell'acqua, poiché queste contenevano zolfo vivo e calce, le estraevano con la fiamma intatta. [13]
Si dicevano rapite dagli dèi persone che invece, legate a un ordigno, erano sottratte alla vista in
spelonche nascoste; ed erano quelle che non avevano voluto congiurare né associarsi a misfatti o
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
189
subire oltraggio. [14] Erano una folla numerosa e ormai quasi un secondo popolo, e, fra questi,
taluni cittadini e donne della nobiltà. Da due anni si era stabilito che nessuno fosse iniziato dopo i
vent'anni di età; si cercava di attirare l'età più facile all'errore e più docile all'oltraggio.
[14,1] Giunta alla fine della sua denunzia e gettatasi di nuovo in ginocchio, ripeté le solite preghiere
per essere confinata lontano. [2] Il console chiede alla suocera di sgombrare una parte della casa,
dove Ispala potesse trasferirsi. Le fu assegnata infatti una soffitta i sopra il palazzo, chiudendo
l'accesso alle scale che portavano sulla via e aprendo un passaggio versa l'interno. [3] Vi furono
trasportate subito tutte le cose di Fecennia e vi furono fatti venire i suoi servi; e Ebuzio fu trasferito
presso un cliente del console.
Mentre in tal modo tutti e due i delatori erano in mano sua, Postumio riferisce la cosa al senato
facendo una ordinata esposizione di tutto, di ciò che prima gli era stato denunziato, e di ciò che in
seguito aveva indagato direttamente. [4] I senatori furono presi da un grande pariico, sia per
l'interesse pubblico, che quelle congiure e quelle conventicole notturne non avessero a portare
occulti pregiudizi o pericoli, sia anche personalmente per i familiari di ognuno, che non ce ne
fossero di implicati in quella colpa. [5] Il senato deliberò di ringraziare il console per aver condotto
l'indagine con particolare oculatezza e evitando ogni disordine. [6] Quindi si affida ai consoli la
procedura straordinaria contro i Baccanali e i riti notturni in genere; si dispone di evitare che ai due
delatori Ebuzio e Fecennia la cosa porti pregiudizio, e di attirare con premi altri delatori. [7] Si fan
ricercare non solo a Roma, ma per tutti i fori e i " conciliaboli " i sacerdoti di quei riti, uomini o
donne che fossero, per darli in mano ai consoli; ancora si fa decretare nella città di Roma, e
analoghi editti si mandano per tutta Italia, [8] che chi fosse già iniziato ai Baccanali si astenga dal
partecipare a riunioni a scopo cultuale e dal compiere atto alcuno di simili riti; soprattutto si
proceda contro coloro che abbiano congiurato o si siano adunati per commettere stupro o altra
infamia. [9] Questo decise il senato. I consoli ordinarono agli edili curuli di ricercare tutti i sacerdoti
di quel culto, e, trattenendoli in libera custodia, tenerli a loro disposizione per l'inchiesta; gli edili
della plebe vigilassero che non fossero celebrati riti in luogo chiuso. [10] Ai triumviri capitali fu dato
incarìco di dislocare qua e là per la città delle guardie e sorvegliare che non si tenessero adunanze
notturne, e, per prevenire incendi, i quinqueviri costituiti al di qua e al di là del Tevere come
ausiliari addetti ai triumviri, dovevano soprintendere ciascuno agli edifici del proprio quartiere.
[15,1] Spediti i magistrati ad attendere a queste varie mansioni, i consoli salirono sui rostri e,
indetta un'adunita, Postumio, dopo che ebbe pronunciata la formula sacramentale della preghiera
che sono soliti premettere i magistrati quando devono parlare al popolo, così incominciò: [2] "Non
ci fu mai adunata, Quiriti, per la quale questa rituale invocazioiie agli dèi fosse non solo altrettanto
indicata, ma senz'altro così indispensabile, per ricordarvi che i veri dèi sono questi che i nostrì avi
ci hanno insegnato a riconoscere, a pregare e venerare, [3] non quelli che spingono le coscienze,
accecate da riti bugiardi e stranieri come da un invasamento diabolico, a commettere qualunque
delitto e a sfogare qualunque voglia. [4] lo stesso non so che cosa devo tacere né sìn dove debbo
pubblicamente parlare; se resterete all'oscuro di particolari di qualche peso, temo di prestare il
fianco alla taccia di indifferenza; se rivelo tutto, temo di spargere troppo terrore fra di voi. [5]
Qualunque cosa io dica, sappiate che sarà sempre poco per la atrocità e la vastità della cosa; che
poi vi basti per stare in guardia, a questo provvederemo noi. [6] Che i Baccanalí sieno diffusi da
tempo in tutta Italia e che ora sieno praticati da più parti anche per Roma, voi, ne son certo, non
solo l'avete sentito dire, ma l'avete anche udito dagli strepiti e dagli ululati notturni che risuonano
per tutta l'Urbe; ma di che cosa precisamente si tratti non lo sapete; [7] c'è chi crede si tratti di
qualche culto reso a degli dèi: altri pensano a feste lecite e tutt'al più sbrigliate, ma in ogni caso
limitate a poche persone. [8] Quanto al numero di questa gente, se vi dirò che sono molte migliaia,
è naturale che subito vi spaventiate prima che io aggiunga chi e di che risma sono. [9] In primo
luogo dunque sono gran parte donne, e da qui è scaturito simile flagello; poi maschi che sembrano
femmine, stuprati e stupratori, forsennati, sconvolti dalle veglie, dal vino, dalle grida, dagli strepiti
notturni. [10] La congiura non ha ancora forze, ma ha in sé grandi possibilità di sviluppo, perché
costoro diventano ogni giorno più numerosi. [11] I vostri antenati neppure a voi permisero di tenere
riunioni casuali e irregolari senza che l'esercito fosse uscito per i comizi issando un vessillo sul
colle o senza che i tribuni avessero indetto il concilio della plebe, o senza che uno dei magistrati vi
avesse convocati; e, ovunque fosse un assembramento, giudicavano che ci volesse anche un
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
190
presidente legalmente costituito. [12] Ora, che idea vi fate voi di riunioni che intanto sono notturne,
e poi anche miste di uomini e di donne? [13] Se sapeste a che età sono iniziati i maschi, non ne
avreste solo pietà, ma vergogna. E voi pensate, o Quiriti, di fare dei soldati da giovani iniziati con
un giuramento come questo? di affidare le armi a questa gente uscita da un sacrario di oscenità?
[14] Costoro, infangati dallo stupro proprio e dall'altrui, difenderanno con le armi l'onore delle
vostre mogli e dei vostri figli?
[16,1] Meno male sarebbe, in ogni modo, se fossero soltanto smidollati dalle loro turpitudini (ché il
disonore cadrebbe in gran parte su loro soli) ma avessero serbato la mano pura dalle violenze, il
pensiero dalle frodi. [2] Mai sulla nostra patria si abbatté tanto flagello né esteso a più persone o a
più oggetti. Tutto ciò che si è commesso in questi anni cedendo a bassi impulsi, con l'inganno, con
la scelleratezza, sappiate che è uscito da quell'unico sacrario. [3] E ancora non hanno dato a
conoscere tutte le imprese per le quali hanno fatto lega.
Per ora l'empia congiura si limita a rovinare singole persone, perché non ha forze sufficienti per
schiacciare lo Stato. Questa peste si estende e si insinua ogni giorno: ormai è troppo diffusa per
essere contenuta nei limiti degli interessi privati: ha come suo bersaglio la sovranità dello stato. [4]
Se voi non prendete le vostre misure, Quiriti, tra poco accanto a questa adunanza diurna
legalmente convocata dal console ce ne potrà essere una non meno numerosa di notte. Ora essi
vi temono; presi uno per uno, temono la vostra assemblea in blocco; tra poco, quando voi vi sarete
sparsi per le vostre case e le vostre campagne, quelli si aduneranno, terranno consiglio insieme
per la propria sicurezza e per la vostra rovina; allora saranno loro, riuniti, a fare paura a voi
singolarmente. [5] Quindi ognuno di voi deve augurarsi che tutti i suoi abbiano conservata sana la
mente; e se qualcuno di essi è stato travolto nell'abisso dalla cecità e dalla follia, ciascuno deve
vedere in lui non più uno dei suoi, ma uno di costoro coi quali si è associato per ogni sorta di
infamie e di delitti. [6] Che ancora tra di voi l'errore non possa sviare qualcuno, io non sono sicuro;
poiché nulla seduce di più verso le proprie apparenze che una falsa religione. [7] Quando i delitti si
riparano dietro la maestà degli dèi, entra nell'aiiimo lo scrupolo che, col reprimere la disonestà
degli uomini, si possa violare qualche norma che vi sia frammischiata delle leggi divine. Dallo
scrupolo vi liberano mille decreti dei pontefici, senatoconsulti, e infine responsi di aruspici.
[8] Quante volte ai tempi dei nostri padri e dei nostri avi non fu già questo incarico ai magistrati, di
vietare culti stranieri di tenerne lontani dal foro, dal circo, anzi da Roma, sacerdoti e indovini, di
requisire e bruciare libri di profezie, di sopprimere ogni rito sacrificale che non fosse secondo l'uso
romano [9] Pensavano, quegli uomini così esperti di tutto il diritto divino ed umano, che nulla
valesse a distruggere la religione quanto il sacrificare non secondo il rito nazionale ma secondo un
rito straniero. [10] Di questo ho creduto bene prevenirvi perché un pregiudizio non turbi le vostre
coscienze nel veder noi intenti a demolire i Baccanali e a disperdere le conventicole infami. [11]
Tutto faremo col volere e il favore degli dèi; i quali, poiché erano indignati che la loro maestà fosse
profanata dalla più sfrenata delinquenza, trassero questi riti dalle tenebre alla luce del sole, e non
certo perché restassero impuniti li vollero palesati, ma perché fossero repressi e soffocati. [12] Il
senato ha affidato a me e al mio collega la procedura straordinaria contro i Baccanali. Noi, quanto
è nostro compito personale, lo adempiremo con prontezza; la direzione delle guardie notturne
sparse per Roma l'abbiamo data ai magistrati minori; [13] ma anche voi è giusto che, secondo le
vostre mansioni, secondo il luogo assegnato a ciascuno, prestiate prontamente la collaborazione
che vi sarà comandata, e vi adoperiate a impedire che per colpa di delinquenti incombano pericoli
o scoppino tumulti ".
[17,1] Dettero quindi lettura dei senatoconsulti, e annunciarono che era bandito un premio per chi
avesse condotto loro dinanzi un colpevole o l'avesse denunciato anche assente; [2] a chi,
accusato, si fosse reso latitante, avrebbero fissato un termine entro il quale, non rispondendo alla
citazione, sarebbe condannato in contumacia: se veniva citato uno di coloro che allora si trovavano
fuori del suolo italico, gli avrebbero dato un termine più ampio, per il caso che volesse venire a
difendersi. [3] Decretarono poi che nessuno doveva vendere o comprare alcuna cosa allo scopo di
espatriare: che nessuno accogliesse, nascondesse. o aiutasse in qualsiasi modo i fuggiaschi.
[4] Sciolta l'adunanza, grande panico si sparse per tutta Roma; e non si limitò alla città e al
territorio latino, ma si cominciò a tremare qua e là per tutta Italia, man mano che vi arrivavano
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
191
lettere di immigrati che parlavano dei senatoconsulto, dell'assemblea e dell'editto dei consoli. [5]
Nella notte che seguì al giorno nel quale la scoperta era stata resa di pubblica ragione dinanzi al
popolo, quelli che tentavano di fuggire, con posti di blocco presso le porte furono fermati dai
triumviri e ricondotti indietro; molti furono denunziati. Alcuni di essi, uomini e donne, si uccisero. [6]
Si diceva che i congiurati fra uomini e donne fossero oltre settemila. Si sapeva che a capo della
congiura erano M. e C. Atinio della plebe romana e il falisco L. Opicernio, e Minio Cerrinio della
Campania: [7] da questi erano partite tutte le iniziative vergognose; erano essi precisamente i
sacerdoti e gli organizzatori di quei riti. Si dettero disposizioni per arrestarli al più presto. Condotti
davanti ai consoli, confessarono per la parte loro e non tardarono a passare alle denunce.
[18,1] Pure, era diventato così generale l'esodo da Roma che molti lasciavan perdere le cause
civili e i relativi diritti; sicché i pretori T. Meiìio e M. Licinio furono costretti, con l'intervento del
senato, a differire gli affari civili fino a trenta giorni, finché i consoli non avessero esaurito i loro
processi. [2] Le assenze costrinsero ancora i consoli, poiché a Roma non comparivano e non si
trovavano quelli che erano denunziati, a andare in giro per i fori e istruirvi processi e esercitare là
la loro giurisdizione. [3] Se uno era stato soltanto iniziato e aveva pronunciato, secondo la formula
sacramentale suggerita dal sacerdote i voti che legavano l'infame setta a delitti e arbitrii di ogni
sorta, ma non aveva macchiato né se né altri di nessuna di quelle onte a cui era obbligato dal
giuramento, allora lo lasciavano in catene; [4] quelli che si erano disonorati con stupri o uccisioni, o
che si erano macchiati di false testimonianze, di alterazione di suggelli, di supposizione di
testamenti o di altre frodi, li condannavano a morte. [5] Furono più gli uccisi che quelli imprigionati:
ma tanto nell'uno che nell'altro caso grande fu il numero, sia di uomini che di donne. [6] Le donne
condannate le consegnavano ai parenti o a chi esercitava su di loro la tutela, perché direttamente
provvedessero contro di loro in privato; se non c'era nessuno che avesse i requisiti di giustiziere si
provvedeva in sede pubblica. [7] Fu dato quindi incarico ai consoli di abbatter gli oggetti del culto
bacchico prima a Roma, poi in tutta Italia, tranne il caso che vi fosse qualche antica ara o qualche
statua consacrata . [8] Per l'avvenire quindi si provvide per senatoconsulto che non si tenessero
Baccanali né a Roma né in Italia; se uno riteneva un tale culto consacrato dall'uso e obbligatorio, e
dichiarava dinanzi al pretore urbano di non potersene astenere senza uno scrupolo religioso e
senza una espiazione, il pretore consultasse il senato; [9] se, presenti in senato non meno di cento
membri, si concedeva l'esenzione, celebrasse il rito, alla condizione che non assistessero al
sacrificio più di cinque persone, e non vi fosse una cassa comune né un presidente del collegio o
un sacerdote.
[19,1] Un altro senatoconsulto connesso con questo fu emesso su proposta del console Q. Marcio
per stabilire che la questione di coloro che ai consoli avevano servito da delatori si rimettesse
impregiudicata al senato quando, terminati i processi, fosse tornato a Roma Sp. Postumio. [2]
Fecero mandare in catene Millio Cerrinio Campano a Ardea con l'avvertenza ai magistrati ardeatini
di tenerlo sotto una sorveglianza speciale, perché non solo non fuggisse, ma non avesse modo di
darsi la morte. [3] Sp. Postumio venne a Roma alquanto dopo; posta da lui in senato la questione
sul premio da dare a P. Ebuzio e a Ispala Fecennia, perché per opera loro erano stati svelati i
Baccanali, fu emanato un senatocoiisulto [4] in base al quale i questori urbani dovevano versare a
ciascuno di essi, a carico dell'erario, centomila assi di bronzo; il console doveva accordarsi coi
tribuni plebei perché alla prima occasione proponessero alla plebe di considerare a Ebuzio come
assolti gli obblighi militari, sicché, se non voleva, non avesse da prestare servizio né il censore gli
assegnasse il cavallo pubblico; [5] e che a Fecennia Ispala fosse accordato il privilegio di alienare
e di manomettere i propri beni, il diritto di sposare fuori della sua gente, e il diritto di scegliere un
tutore con la stessa validità che se le fosse assegnato per testamento da un marito; le fosse
consentito di sposare un nato libero; e chi la sposasse non ne avesse pregiudizio o discredito di
sorta; [6] i consoli e i pretori di allora e i loro successori avessero cura che la donna non subisse
rappresaglie e fosse in ogni caso al sicuro. Così stabiliva il senato e così riteneva conforme a
equità. [7] Tutto questo fu proposto alla plebe ed eseguito secondo il senatoconsulto; per la
impunità e i premi da dare agli altri delatori fu lasciata la decisione ai consoli.
Traduzione di A. Ronconi, Torino, Utet, 1980
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
192
La tavola bronzea di Tiriolo (Cosenza/Catanzaro? Controllo), rinvenuta nel 1600 nelle fondazioni di
un palazzo antico del paese, venne custodita per molto tempo dai Cigala, nobile famiglia del luogo,
per essere pubblicata e commentata in seguito all'acquisto da parte dell'imperatore Carlo VI, nel
1727. La tavola del Senatus Consultum de Baccanalibus è oggi custodita nel Kunsthitsorisches di
Vienna.
Bibliografia
ICCU ?
CIL 1 (ed. 2) 581 (cf. 1.2.4 p. 903) = 10.104 = ILLRP 511 = ILS 18 = FIRA 1 no. 30 = Bruns no.
164 = Gordon no. 8 and plate 6.8 = Warmington IV 254. Foto in A. Degrassi, Imagines, ILLRP
(1965) 392.
Memorie storiche
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
193
Bibliografia
Riposati
I - Atti pubblici 'ufficiali'. Comprendiamo sotto questa rubnca la svariata gamma di memorie, di prescrizioni, di
norme giuridiche e sacrali, di fatti di cronaca e di awenimenti degni di rilievo, che dai pontefici dei vari collegi
sacerdotali e dai pubblici magistrati in carica venivano trascritti nei propri ' libri' o ' registri', costituenti gli acta,
diversamente denominati (commentarii, libri, tabulae, monumenta, fasti, annales) e destinati a formare come
un repertorio legale dei singoli istituti; inoltre, per estensione, anche le leges e i trattati (foedera).
Ricorderemo:
a) i Commentarii regum: non si sa se di carattere storico o sacrale se contenenti, cioè, prescrizioni proprie
delle funzioni dei re o dei ponteficl; in questo caso si identificano con
b) i Libri e Commentarii pontificum: contenenti norme relative al culto sacro e formule rituali, nonché (se
diverse sono le due denominazioni) prescrizioni di diritto pubblico e privato;
c) i diversi atti dei singoli sacerdozi, come i Libri e Commentarfi Augurum (relativi al collegio degli àuguri),
Saliorum (dei Salii), decemvirorum o, meglio, decemvirum (dei decèmviri), ecc.;
d) i Libri e Commentarii magistratuum: contenenti gli elenchi e le cronache annuali dei magistrati in carica, e
detti Libri lintei, se scritti su tela di lino, e conservati nel tempio della dea Giunone Moneta. Inoltre: i registri
delle singole magistrature, come i Commentarii consulum, quaestorum, censorum; questtultimi erano detti
anche Tabulae censoriae se contenevano norme disciplinari per il censimento. Le Tabulae publicae, affisse
nel!e circoscrizioni provinciali, riportavano le disposizioni dx legge, gli edittl pubblici, le volontà insomma dei
magistrati romani;
Bibliografia
F. Sini, Documenti sacerdotali di Roma antica, I. Libri e commentarii, Sassari, Dessì, 1983.
Francesco Sini
Documenti sacerdotali di Roma antica. Cap. I
IL PROBLEMA STORIOGRAFICO DEI DOCUMENTI SACERDOTALI
Sommario: 1. Consistenza e contenuto degli archivi sacerdotali. – 2. Compilazioni sacerdotali e
valore storico-giuridico dei dati provenienti da tali documenti. – 3. Difficoltà ed incertezze nella
distinzione tra libri e commentarii
[p. 15]
1. Consistenza e contenuto degli archivi sacerdotali
Numerose fonti, sia epigrafiche1 sia letterarie2, attestano che nell’antica Roma era prassi usuale
dei grandi collegia e sodalitates3 redigere e conservare nei propri archivi4 tutta una serie di
documenti, in cui erano riposte le memorie di fatti legati alle molteplici attività di ciascun collegio5,
nonché precise istruzioni per l’espletamento delle funzioni sacerdotali6. Il contenuto di questi
archivi7 doveva presentarsi quindi vastissimo, in quanto era assai vario il materiale che in essi si
raccoglieva: si trattava, infatti, di istruzioni generali di culto8; di formule solenni (carmina)9, che
potevano riguardare sia preghiere e regolamenti rituali, sia atti solenni di diritto pubblico e privato;
di raccolte di decreta10 e di responsa11, cioè interventi autoritativi o pareri interpretativi in materia
di competenza dei collegio12. Negli archivi sacerdotali si conservano, inoltre, i fasti13, liste dei
membri del collegio14 (nei quali con molta probabilità era possibile trovare anche un embrione di
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
194
storia e di cronologia, se non altro per esigenze di datazione nell’aggiornamento della lista)15, e gli
acta16, processi verbali degli atti professionali del collegio.
Sebbene in linea di massima vi fosse una certa tipicizzazione nel contenuto degli archivi
sacerdotali, non va tuttavia dimenticato che alcuni di essi superavano di gran lunga gli altri per
importanza e per ricchezza di materiale. È il caso del l’archivio dei pontefici17. Spettava infatti a
questi sacerdoti
[p. 16]
determinare il calendario annuale18, compilare ed aggiornare i fasti consolari19 e registrare - fin
dal periodo più antico20 - le cronache cittadine, annales21, che furono da ultimo raccolte in forma
definitiva intorno al 130 a.C. negli Annales Maximi22, per iniziativa del pontefice massimo P. Mucio
Scevola22a. Inoltre, la tradizione antica riconduceva all’archivio dei pontefici anche le leges
regiae23, i libri e i commentarii dei re24 e le primitive regole del ius civile25.
Questa vasta opera di raccolta e di compilazione dovette svilupparsi dapprima occasionalmente,
legata soprattutto al costante lavoro di interpretazione e di rielaborazione delle diverse branche del
ius26 da parte dei collegi sacerdotali: si venne così a formare, in modo piuttosto casuale, quella
massa eterogenea di materiale documentario che costituiva la grande parte del contenuto degli
archivi. Poi, in epoca più recente27, è probabile che gli stessi componenti dei collegi, ed il
pontefice massimo28, abbiano provveduto ad elaborare una sistemazione interna di carattere
funzionale per tutto il materiale contenuto negli archivi, anche se manca qualsiasi conferma di
fonte sacerdotale o annalistica per un fatto di questo genere, con l’unica eccezione della redazione
definitiva degli Annales Maximi.
Di certo questi archivi dovevano presentarsi riordinati in maniera organica già alla fine del III
secolo29, quando il materiale in essi raccolto cominciò ad essere oggetto di studio e di
sistematizzazione da parte di giuristi30 e antiquari31, i quali ricavarono dagli archivi gli elementi
basilari per le loro opere sul diritto divino32 e sulla teologia33.
La perdita di tutta questa letteratura, che forse avrebbe consentito di capire la sistemazione interna
degli archivi, la divisione della materia e in contenuto dei singoli documenti, costituisce un limite
senza dubbio assai difficile da superare nel lavoro di ricostruzione dei documenti sacerdotali. A ciò
si aggiunga la quasi totale scomparsa dei documenti provenienti direttamente dagli archivi: le
poche eccezioni34 ed i frammenti pervenuti attraverso citazioni annalistiche e antiquarie
[p. 17]
offrono, infatti, un quadro parziale, lacunoso e per molti versi oscuro. Nascono quindi, in primo
luogo, dallo stato delle fonti le disparità di opinioni in seno alla dottrina romanistica su alcuni
importanti problemi, che avremo modo di esaminare più avanti. Basterà qui accennarli appena: a)
probabile datazione dell’inizio delle compilazioni sacerdotali e valore storico-giuridico dei
frammenti; b) determinazione del contenuto dei libri e dei commentarii; c) criterio di sistemazione
elaborato dai sacerdoti per il materiale raccolto negli archivi.
2. Compilazioni sacerdotali e valore storico-giuridico dei dati provenienti da tali documenti
L’esigenza di datare, seppure con una certa approssimazione, l’inizio delle compilazioni
sacerdotali si presenta strettamente legata allo stato lacunoso delle fonti a nostra disposizione. È
noto, infatti, che della grande massa di documenti sacerdotali soltanto alcuni, e per di più assai
recenti, si sono conservati in maniera tale da poter essere ricostruiti nella loro struttura originaria.
In questo modo è possibile conoscere il calendario religioso e civile romano35, i commentarii dei
ludi saeculares celebrati durante i principati di Augusto, di Claudio e di Settimio Severo36, ed
infine gli acta fratrum Arvalium37; il resto del materiale di provenienza sacerdotale è costituito da
qualche frammento epigrafico38 e da molte citazioni contenute in opere scritte tra l’ultimo secolo
della repubblica e il quinto secolo dell’impero39.
Il dato delle fonti si mostra quindi a prima vista inadeguato a confermare le testimonianze degli
scrittori antichi, dai quali apprendiamo che la redazione dei documenti sacerdotali avrebbe avuto
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
195
inizio fin dai primissimi anni della storia cittadina40: da quegli anni, cioè, in cui secondo la
tradizione annalistica si sarebbero enucleate le istituzioni fondamentali
[p. 18]
del sistema giuridico-religioso romano; istituzioni che peraltro, sempre nel racconto annalistico,
appaiono intimamente connesse alle funzioni dei principali collegi sacerdotali41.
Una datazione così alta viene negata dalla maggior parte degli studiosi42: l’opinione dominante
nella dottrina romanistica è più propensa a ritenere che la data iniziale di queste compilazioni non
possa essere anteriore al IV secolo a.C.43, in quanto solo successivamente a tale epoca si
sarebbe provveduto da parte dei pontefici, a redigere con regolarità i fasti consulares e gli
annales44.
Da qualche tempo questa opinione, affermatasi nei primi anni del Novecento - grazie anche al
contributo di Gaetano De Sanctis45 - come reazione alla corrente ipercritica46, è stata oggetto
però di ripensamento da parte di autorevoli studiosi47. Negli ultimi anni, storici come il Pareti48,
comparatisti come il Dumézil49, linguisti come il Peruzzi50, ciascuno nell’ambito della propria
ricerca, hanno apportato nuovi elementi che sembrano in grado di convalidare le testimonianze
degli scrittori antichi sul carattere assai risalente delle elaborazioni storiche, giuridiche e
“teologiche” dei grandi collegi sacerdotali51.
Le testimonianze degli scrittori romani trovano poi indiretta conferma anche nei risultati delle
recenti ricerche sulle “civiltà” dell’antichissimo Lazio52, che, fra le altre cose, rivelano un elevato
grado di utilizzazione della scrittura in tutta l’area laziale, fin dall’epoca che si suole far
corrispondere al periodo monarchico della storia di Roma, specialmente per fissare la memoria di
solenni atti giuridico-religiosi di carattere comunitario53.
Si comprende così il motivo che induce a ritenere i documenti sacerdotali e le formule solenni
materiali di fondamentale importanza per qualsiasi tentativo di ricostruzione delle più antiche
vicende storiche e delle primitive istituzioni; poiché questi documenti contengono gli elementi
basilari per individuare le caratteristiche originarle e la dialettica dello sviluppo delle istituzioni
giuridico-religiose romane e costituiscono al tempo stesso il nucleo più antico e sicuro della
tradizione.
[p. 19]
Per quanto attiene poi alle formule solenni elaborate dai sacerdoti e raccolte nei loro documenti, la
cui funzione consisteva principalmente nell’operare di volta in volta la traduzione nella sfera divina
di tutto il complesso di attività riferibili al popolo romano, va sottolineato che esse rappresentano,
seppure in forma elementare, la primitiva concettualizzazione politico-religiosa e la più antica
sovrastruttura ideologica di questo popolo54.
Resta ancora da risolvere il problema dell’attendibilità delle formule, nel testo in cui sono riportate
dalle fonti a nostra disposizione, e più in generale di tutte le informazioni che sembrano provenire
da documenti sacerdotali, ma per le quali non è fatto esplicito richiamo alle fonti di provenienza.
Per quanto riguarda le formule religiose, ne sostiene la piena attendibilità Georges Dumézil55, il
quale dimostra la sostanziale autenticità di esse sulla base della discussione di alcuni testi liviani;
anche Jean Bayet, per il resto così attento nella valutazione della massa di informazioni storiche
contenute nell’opera di Livio, sottolinea come perfettamente credibili quelle parti dell’opera che
trattano di istituzioni politiche, giuridiche e religiose56.
A sostegno dell’attendibilità della massa di materiale pro- veniente da documenti sacerdotali può
essere addotto un ulteriore argomento. Nella società romana arcaica e repubblicana, a fronte dello
sviluppo dei rapporti economici e politici, si contrapponevano da una parte una più lenta
evoluzione delle istituzioni giuridiche57, dall’altra il carattere fortemente conservativo della
tradizione religiosa58. Ciò ha permesso che il ricupero operato da antiquari e letterati antichi di
gran parte dell’elaborazione dei collegi sacerdotali sia avvenuto nel sostanziale rispetto, se non
della forma, almeno del contenuto più genuino di quell’elaborazione.
L’aver individuato il valore generale di questo tipo di fonti non ci esime, tuttavia, dal valutare caso
per caso il singolo passo; poiché bisogna sempre tener conto della profonda differenza (e quindi
della diversa attendibilità) tra i dati che
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
196
[p. 20]
lo scrittore antico ci tramanda su determinate istituzioni giuridico-religiose più risalenti e
l’interpretazione che egli ne dà, riflettendo la propria ideologia o il proprio grado di
approfondimento scientifico59.
Un’impostazione di questo genere, che pure offrirebbe validi elementi di revisione del cosiddetto
“diritto pubblico romano”, incontra però forti resistenze proprio nel campo degli studi giuridici, in cui
si sente ancora fortemente il peso della sistematica ereditata dalla storiografia giuridica tedesca
dell’Ottocento60: la quale da una parte tendeva a ricostruire la complessa vicenda giuridica del
popolo romano attraverso la contemporanea concezione statualistica del diritto61 e dall’altra
attuava di conseguenza una netta separazione tra religione e diritto, anche a livello di ricerca
scientifica62. In particolare, per quanto riguarda il valore storico-giuridico delle formule solenni e
dell’altro materiale provenienti dagli archivi sacerdotali, nella forma in cui ci sono pervenuti nelle
fonti, domina ancora la valutazione negativa consolidatasi con lo Staatsrecht del Mommsen63. Si
sa, infatti, che il grande studioso tedesco, pur privilegiando nella sua ricostruzione sistematica i
dati giuridico-istituzionali64 nei confronti del racconto annalistico, guardava tuttavia con forte
sospetto alle formule religiose e giuridiche riportate dalla letteratura annalistica e antiquaria,
giudicandole sovente anticipazioni di istituti sviluppatisi in epoche più tarde65.
Su questo punto la prospettiva del Mommsen ha influenzato in modo considerevole anche gli studi
tedeschi sulla religione romana: basterà qui citare l’esempio del Wissowa66, che sostanzialmente
non si discosta dall’opinione del suo maestro e quello più recente di Kurt Latte67.
Perciò fra i giuristi appare ancora oggi poco seguita quella opinione che tende ad individuare nelle
prescrizioni di diritto divino e più in generale in tutte le testimonianze ad esso riferibili, e che in
certo modo possono farsi risalire ai documenti conservati negli archivi sacerdotali, “ciò che di più
serio gli storici di Roma abbiano potuto conoscere per i primi
[p. 21]
secoli”68; come dimostra il recente articolo del Gioffredi69 sulla tradizione antiquaria dei testi
giuridico-sacrali, in cui, a mio parere, vi è una sostanziale adesione alla linea del Latte.
3. Difficoltà ed incertezze nella distinzione tra libri e commentarii
Riguardo agli archivi sacerdotali esiste nella dottrina romanistica un altro motivo di dibattito. La
discussione verte sulla possibilità pratica di determinare, per ciascuno dei diversi generi di
documenti conservati negli archivi e variamente denominati (quali ad esempio acta, fasti,
commentarii, libri, ecc.), l’insieme delle materie che ne costituivano il contenuto specifico. In
proposito, conviene, fin d’ora, sottolineare quanto il termine “genere” appaia di per se stesso
inadeguato ad esprimere. il significato peculiare dei termini latini citati, poiché non è affatto certo
che essi corrispondessero ad un “genere” di documento, potendosi anche trattare di intere
“sezioni” di documenti sacerdotali aventi caratteristiche assimilabili ai fini di una più funzionale
conservazione all'interno dell’archivio.
Attualmente, anche se si sono venute progressivamente appianando le diversità di opinione circa il
contenuto degli acta e degli annales70, permane nella dottrina l’eco di un ampio dibattito, assai
vivace in passato e tuttora senza soluzione definitiva, in merito alla precisazione della natura dei
libri71 e dei commentarii72 sacerdotali e del loro possibile contenuto.
Nelle fonti73 si menzionano libri e commentarii a proposito del collegio dei pontefici e di quello
degli auguri, solo libri a proposito dei Salii e solo commentarii per quanto riguarda fratres Arvales,
septemviri Epulones e quindecimviri sacris faciundis (a proposito di quest’ultimo collegio, non va
dimenticato che essi custodivano nel loro archivio i famosi libri Sibyllini)74; vi è poi la notizia
dell’esistenza di libri e di
[p. 22]
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
197
commentarii di re75 e di magistrati76. Fra i documenti sacerdotali, libri e commentarii sono
certamente quelli più menzionati nelle fonti, dalla cui analisi emerge che essi costituivano la parte
di gran lunga più rilevante degli archivi, poiché sembra che il loro contenuto non solo riguardasse
la regolamentazione del rituale, delle funzioni sacerdotali e gran parte del diritto divino77, ma
anche le più risalenti norme del ius publicum78 e le più arcaiche procedure del ius civile79. Così in
essi si potevano trovare - secondo le fonti - accanto agli indigitamenta80, alle formule solenni, ai
regolamenti rituali, ai decreta e responsa sacerdotali, notizie sulla provocatio in età regia81 o sulla
definizione e sulla gerarchia dei poteri magistratuali82.
Nonostante le frequenti citazioni libri e commentarii sacerdotali non appaiono però facilmente
definibili sulla base di precise differenze di contenuto. Ciò è dovuto principalmente a due ragioni: in
primo luogo allo stato di frammentarietà delle fonti a nostra disposizione; in secondo luogo
all’apparente confusione e alla casualità con cui gli autori antichi, a proposito della stessa materia,
citano ora libri, ora commentarii83. Su questo argomento, perciò, la dottrina romanistica
contemporanea si presenta con opinioni e criteri di valutazione nettamente divergenti.
Esamineremo in seguito, in maniera più approfondita, quali siano state, e siano ancora oggi,
queste opinioni, mentre basterà accennare ora soltanto alle linee generali del dibattito.
Nel secolo scorso, almeno fino agli anni Settanta, era opinione dominante, sulla scia del
Niebuhr84, che fosse possibile definire con precisione il contenuto dei libri e quello dei
commentarii, e che essi fossero due “generi” di documenti ben distinti negli archivi. Naturalmente
spesso variava la ripartizione delle materie proposta dai diversi studiosi: nel senso che ciò che
alcuni collocavano nei libri poteva da altri essere attribuito ai commentarii; tuttavia si riteneva
sempre possibile una netta distinzione di contenuto.
Nella seconda metà dell’Ottocento, il rinnovato interesse
[p. 23]
per lo studio dei materiale proveniente dagli archivi sacerdotali85 contribuì a mettere in crisi questo
modo tradizionale di trattare del contenuto di libri e di commentarii: si constatò da più parti
l’impossibilità di incasellare tutto il materiale all’interno di uno schema che distinguesse
rigidamente tra libri e commentarii, poiché tale schema si presentava per molti versi non
rispondente ai testi antichi. Ci si orientò, piuttosto, per classificazioni che ordinassero direttamente
per materia tutte le fonti di provenienza sacerdotale, rinunciando quindi in pratica a qualsiasi
distinzione tra libri e commentarii, in quanto - si sosteneva da parte di questi studiosi - le fonti sono
talmente incerte e confuse da non consentire altra soluzione scientificamente valida.
Questa nuova tesi, sostenuta fra i primi dal Bouché-Leclercq86 e dal Regell87, si impose in breve
tempo all’attenzione della dottrina, tanto da essere generalmente seguita nei manuali e nelle opere
di vasta consultazione88. Tuttavia la tesi della distinzione tra libri e commentarii continua ad avere
ancora oggi autorevoli adesioni. Né furono in grado di dare una soluzione definitiva all’intera
problematica quegli interessanti tentativi di raccolta sistematica di frammenti di provenienza
sacerdotale89, che pure indicarono nuove prospettive di analisi e di ricostruzione dei documenti
citati. In questo senso si può affermare con sicurezza che il dibattito deve ritenersi tutt’altro che
concluso.
[p. 25]
NOTE
1
Fra le fonti epigrafiche più notevoli, sono da ricordare le iscrizioni riguardanti i ludi saeculares:
Corpus Inscriptionum Latinarum VI, 32323 ss.; gli acta fratrum Arvalium: Corp. Inscr. Lat. VI, 20232119; 32338-32398; 37164-37165 (per la bibliografia vedi infra nn. 36-37) ed alcune liste di
componenti dei collegi sacerdotali: Corp. Inscr. Lat. VI, 1976 ss.; 32318 ss.; certamente agli archivi
sacerdotali risalgono anche le disposizioni del collegio dei pontefici e di quello dei quindecimviri
riportate in Corp. Inscr. Lat. X, 8259 ed ibid. 3698. Più in generale per le iscrizioni latine di
carattere religioso del periodo arcaico e repubblicano, cfr. A. DEGRASSI, Inscriptiones Latinae
liberae rei publicae, 2 voll., Firenze 1957-1963.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
198
2
Per quanto riguarda le fonti letterarie, vedi per tutti G. WISSOWA, Religion und Kultus der
Römer (Handbuch der klassiken Altertumswissenschaft IV, 5), 2a ediz., München 1912 (rist. 1971),
pp. 4 ss., 65 ss.; N. TURCHI, La religione di Roma antica (Istituto di Studi romani. Storia di Roma,
18), Bologna 1939, pp. 337 ss.; K. LATTE, Römische Religionsgeschichte (Handbuch der
Altertumswissenschaft. V, 4), München 1960, pp. 4 ss.; G. B. PIGHI, La religione romana (Lezioni
“Augusto Rostagni”, III), Torino 1967, pp. 27 ss.; 41 ss.
3
In generale, sui collegi sacerdotali romani vedi, oltre G. WISSOWA, Religion und Kultus der
Römer, cit., pp. 479 ss.; J. BAYET, Histoire politique et psychologique de la religion romaine, Paris
1957 (2a ediz. 1969) (trad. ital. di G. Pasquinelli: La religione romana. Storia politica e psicologica,
Torino 1959, pp. 107 ss.); G. DUMÉZIL, La religion romaine archaïque, 2a ediz., Paris 1974, pp.
567 ss. (cfr. trad. ital di F. Jesi, La religione romana arcaica, Milano 1977, pp. 492 ss.). Troppo
numerosi sono invero gli studi monografici su tali collegi (sia di carattere storico-giuridico, sia di
carattere prosopografico) per poter essere citati in questa nota (per la bibliografia più risalente cfr.
J. MARQUARDT, Römische Staatsverwaltung, III, 2a ediz., Leipzig 1885, pp. 235 ss.; G.
WISSOWA, op. loc. cit.); basterà pertanto ricordare qui soltanto alcuni degli studi più recenti: P.
CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, Torino 1960; F. GUIZZI, Aspetti giuridici del
sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta, Napoli 1968; M. W. HOFFMAN LEWIS, The Official
Priests of Rome under the Julo-Claudians. A study of the Nobility from 44 B. C. to 68 A. D. (Papers
and Monographs of the American Academy in Rome, XVI), Roma 1955; G. J. SZEMLER, The
Priests of the Roman Republic. A Study of Interactions between Priesthoods
[p. 26]
and Magistracies, Bruxelles 1972; J. SCHEID, Les frères arvales. Recrutement et origine sociale
sous les empereurs julo-claudiens, Paris 1975.
4
Riguardo alla denominazione di tali archivi la terminologia delle fonti appare piuttosto confusa,
tanto da far supporre che mancasse proprio una denominazione ufficiale: vedi, comunque, infra
nn. seguenti. Peraltro, anche i luoghi in cui venivano conservati gli archivi dei più importanti collegi
risultano di non facile precisazione: su questo punto vedi, comunque, G. WISSOWA, Religion und
Kultus der Römer, cit., pp. 502, 527.
5
Assai significativamente la tradizione romana ricollega i principali collegi sacerdotali ai
primordi della storia delle istituzioni cittadine (cfr. Livio 1, 20). A tale proposito, non mi pare
sostenibile l’ipotesi che questa tradizione sia frutto di più tarde ricostruzioni, di ispirazione
sacerdotale, volte a nobilitare l’altrimenti oscura storia religiosa della città. Difficilmente si può
negare l’esistenza di un rapporto funzionale tra i collegi sacerdotali e la più antica organizzazione
politica cittadina: vedi da ultimo, in questo senso, il convincente studio di L. R. MÉNAGER, Les
collèges sacerdotaux, les tribus et la formation primordiale de Rome, in Mélanges de l’École
française de Rome 88, 1976, pp. 455 ss.
6
Di antichissima redazione doveva essere l’ordo sacerdotum, conservatosi nella sua arcaica
gerarchia ancora ai tempi di Festo, o almeno della sua fonte Verrio Flacco, quando certamente
non corrispondeva più ai reali rapporti di potere all’interno dell’ordinamento sacerdotale: Festo, p.
198 L.: Ordo sacerdotum aestimatur deorum < ordine, ut deus > maximus quisque. Maximus
videtur Rex, dein Dialis, post hunc Martialis, quarto loco Quirinalis, quinto pontifex maximus. Itaque
in soliis Rex supra omnis accumbat licet; Dialis supra Martialem, et Quirinalem; Martialis supra
proximum; omnes item supra pontificem. Rex, quia potentissimus: Dialis, quia universi mundi
sacerdos, qui appellatur Dium; Martialis, quod Mars conditoris urbis parens; Quirinalis, socio
imperii Romani Curibus ascito Quirino; pontifex maximus, quod iudex atque arbiter habetur rerum
divinarum humanarumque; come è attestato dalle attribuzioni ascritte al pontifex maximus, che
appaiono elaborate in età successiva alla definizione dell’ordo. Su materiali d’archivio dovevano
altresì essere improntati i libri sacerdotum populi Romani ed i libri, qui de sacerdotibus publicis
compositi, di cui parla Gellio, Noct. Att. 13, 23, 1; 10, 15, l.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
199
Più complesso è invece il problema della definizione del rapporto tra questi materiali e i libri de
sacerdotibus delle antiquitates rerum divinarum di Varrone: per una prima valutazione circa
probabili utilizzazioni di libri sacerdotali negli scritti dell’antiquario reatino, vedi infra cap. III, § 3.
7
Più in generale, sugli archivi di Roma arcaica, vedi R. BESNIER, Les archives privées,
publiques et religieuses à Rome au temps des rois, in Studi Albertario, II, Milano 1953, pp. 1 ss.
8
Cfr. G. WISSOWA, Religion und Kultus der Römer, cit., pp. 409 ss.; K. LATTE, Römische
Religionsgeschichte, cit., pp. 41 ss.; G. DUMÉZIL, La religion romaine archaïque, cit., pp. 545 ss.
(cfr. trad. ital., cit., pp. 473 ss.).
[p. 27]
9
Sul significato e sull’antichità dei termine vedi A. ROSTAGNI, Storia della letteratura latina, 3a
ediz., I, Torino 1964, p. 41: “Ora noi dobbiamo per l’appunto riportarci a quell’epoca, chiaramente
riconoscibile non solo presso i Latini ma presso gli Italici in generale, quando ancora non era ben
affermata la distinzione fra la Poesia e la Prosa e col nome di carmen s’indicava qualsiasi
espressione un po’ colta (delle preghiere, delle formule magiche, e anche delle leggi),
ritmicamente costruita con varie disposizioni d’accenti e allitterazioni, rime e simili”. Certamente
derivavano dagli archivi sacerdotali non solo il carmen saliare (i frammenti sono stati raccolti da C.
M. ZANDER, Carminis Saliaris reliquiae, Lundae 1888; B. MAURENBRECHER, Carminum
Saliarium reliquiae, Jahrbücher für classische Philologie, Suppl. 21, 1894, pp. 315 ss.; W. MOREL,
Fragmenta poetarum latinorum epicorum et liricorum praeter Ennium et Lucilium, 2a ediz. (rist.
Stutgardiae 1963), pp. 1 ss.: per i problemi di critica testuale, vedi, da ultimi, G. RADKE, Das Zitat
aus dem Salierliede bei Terentius Scaurus, in Gedenkschrift für G. Rohde, Tübingen 1961, pp. 215
ss.; ID., Die Überlieferung archaischer lateinischer Texte in der Antike, in Romanitas 11, 1972, pp.
189 ss.; A. ERNOUT, Numina ignota, in Mélanges Carcopino, Paris 1966, pp. 313 ss.) ed il
carmen arvale (sul quale vedi: M. NACINOVICH, Carmen Arvale, 2 voll., Roma 1933-1934; E.
NORDEN, Aus altrömischen Priesterbüchern, Lund-Leipzig 1939, pp. 99 ss.), ma anche quelle
solenni formule giuridico-religiose di cui le fonti conservano la memoria: cfr. ad esempio Livio 1,
18, 6 ss. (inauguratio); 1, 24, 3 ss. (foedus); 1, 32, 11-13 (indictio belli); 1, 38, 2 (deditio); 8, 9, 6
(devotio); Macrobio, Sat. 3, 9, 7 (evocatio). Per un maggiore approfondimento di tutta questa
problematica, vedi C. M. ZANDER, Versus Italici antiqui, Lundae 1890; C. THULIN, Italische
sakrale Poesie und Prosa. Eine metrische Untersuchung, Berlin 1906; G. APPEL, De Romanorum
praecationibus (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten, 7, 1), Gissae 1909; alcuni testi
sono stati raccolti e tradotti da G. B. PIGHI, La poesia religiosa romana, testi e frammenti per la
prima volta raccolti e tradotti da G. B. P., Bologna 1958.
10 Esempi di decreta sacerdotali in Cicerone: De div. 2, 35; in Vat. 20; Livio 27, 37, 4; 27, 37, 7;
31, 9, 8; 32, 1, 9; 34, 45, 8; 39, 22, 4-5; 40, 45, 2; 4, 7, 3; 45, 12, 10; 21, 1, 15-19; 41, 21, 10-1 l;
31, 8, 2-3; Festo, p. 152 L.
11
Cfr. Cicerone, De domo 39-40; Livio 5, 23, 8-10; 5, 25, 7; 36, 3, 7-12; 41, 18, 8.
12
Non del tutto chiara appare in dottrina la distinzione tra i decreta e i responsa sacerdotali:
vedi, ad esempio, E. DE RUGGIERO, Decretum, in Dizionario epigrafico di antichità romane 2, 2,
1910, pp. 1497 ss. Per quanto riguarda i responsa, non è neppure certo se, e in che misura, essi
vincolassero il magistrato, il senato o il privato richiedenti: tuttavia tale era il prestigio del
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
200
sacerdozio che raramente non venivano seguiti; valga in proposito quanto afferma Cicerone, De
harusp. resp. 6, 12: Quae tanta religio est qua non in nostris dubitationibus atque in maximis
superstitionibus unius P. Servili ac M. Luculli responso ac verbo liberemur? De sacris publicis, de
ludis maximis, de deorum penatium Vestaeque matris caerimoniis, de illo ipso sacrificio quod fit
pro salute populi Romani, quod post Romam conditam huius unius casti tutoris religionum
[p. 28]
scelere violantum est quod tres pontifices statuissent, id semper populo Romano semper senatui,
semper ipsis dis immortalibus satis sanctum, satis augustum, satis religiosum esse visum est. Più
in generale, G. WISSOWA, Religion und Kultus der Römer, cit., pp. 514 s., 527 ss., 551; F.
SCHULZ, History of Roman Legal Science, 2a ediz., Oxford 1953, pp. 15 ss. (cfr. trad. ital. Firenze
1968, pp. 37 ss.).
13
Riguardano i fasti sacerdotali, oltre le iscrizioni già citate in n. 1, anche Corp. Inscr. Lat. VI,
37160, 37161. Fra i numerosi studiosi che si sono impegnati nella ricostruzione delle diverse liste
di sacerdoti, mette conto ricordare: L. MERCKLIN, Die römischen Sacerdotalfasten, appendice a
Die Cooptation der Römer, Mitau und Leipzig 1848, pp. 213 ss.; C. BARDT, Die Priester der vier
grossen Collegien aus römisch-republicanischer Zeit, Berlin 1871; P. HABEL, De Pontificum
Romanorum inde ab Augusto usque ad Aurelianum condicione publica, Vratislaviae 1888; G.
HOWE, Fasti sacerdotum populi Romani publicorum aetatis imperatoriae, Lipsiae 1904; A.
KLOSE, Römischen Priesterfasten I, Diss. Breslau 1910; T. R. S. BROUGHTON, The Magistrates
of the Roman Republic, 2 voll., 1 suppl., New York 1951-1952, 1960; M. W. HOFFMAN LEWIS, Le
Official Priests of Rome under the Julo-Claudians, cit. in n. 2; H. G. PFLAUM, “Sodales
antoniniani” de l’époque de Marc Aurèle, Paris 1966; G. J. SZEMLER, The Priests of the Roman
Republic, cit. in n. 3; J. SCHEID, Les frères arvales, cit. in n. 3.
14
Per indicare queste liste dei membri dei collegi sacerdotali, oltre il termine fasti, nella
dottrina troviamo usato anche il sostantivo album, sebbene non esista una fonte in cui con album
si designi tale lista: comunque, in tal senso, si vedano J. MARQUARDT, Römische
Staatsverwaltung, cit., p. 299 n. 5; Joh. SCHMIDT, Album, in Real-Encyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft 1, Stuttgart 1893, coll. 1332 ss.
15
Oltre le testimonianze epigrafiche, ci sono pervenute due liste di componenti del collegio
dei pontefici: la prima si ricava da un passo di Cicerone, De harusp. resp. 6, 12: At vero meam
domum P. Lentulus, consul et pontifex, P. Servilius, M. Lucullus, Q. Metellus, M.’ Glabrio, M.
Messalla, L. Lentulus, flamen Martialis, P. Galba, Q. Metellus Scipio, C. Fannius, M. Lepidus, L.
Claudius, rex sacrorum, M Scaurus, M. Crassus, C. Curio, Sex. Caesar, flamen Quirinalis, Q.
Cornelius, P. Albinovanus, Q. Terentius, pontifices minores, causa cognita, duobus locis dicta,
maxima frequentia amplissimorum ac sapientissimorum civium adstante, omni religione una mente
omnes liberaverunt; l’altra è riportata da Macrobio, Sat. 3, 13, 11: Refero enim pontificis
vetustissimam cenam quae scripta est in indice quarto Metelli illius pontificis maximi in haec verba:
Ante diem nonum kalendas Septembres, quo die Lentulus flamen Martialis inauguratus est, domus
ornata fuit, triclinia lectis eburneis strata fuerunt, duobus tricliniis pontifices cuberunt, Q. Catulus,
M. Aemilius Lepidus, D. Silanus, C. Caesar, ***** rex sacrorum, P. Scaevola, Sextus ***** Q.
Cornelius, P. Volumnius, P. Albinovanus et L. Iulius Caesar augur qui eum inauguravit, in tertio
triclinio Popilia Perpennia Licinia Arruntia virgines Vestales et ipsius uxor Publicia flaminica et
Sempronia socrus eius.
[p. 29]
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
201
16 Notevoli esempi di acta sono le epigrafi sul marmo collocate dai fratres Arvales nel bosco
della dea Dia a pochi chilometri da Roma, dove si crede finisse l’ager romanus antiquus. Per la
ricostruzione di tali acta, vedi infra n. 37; quanto poi al rapporto tra Arvaks e dea Dia ed al
significato dei suo arcaico rituale vedi I. CHIRASSI, Dea Dia e fratres Arvales, in Studi e materiali
di storia delle religioni 39, 1968, pp. 191 ss.; sui problemi legati all’ager romanus antiquus si
confronta con il dibattito più recente A. ALFÖLDI, Römische Frühgeschichte: Kritik und Forschung
seit 1964, Heidelberg 1976, pp. 202 ss.; per le questioni più strettamente archeologiche e
topografiche vedi, inoltre, S. QUILICI GIGLI, Considerazioni sui confini del territorio di Roma
primitiva, in Mélanges de l’École française de Rome 90, 1978, pp. 567 ss.
17 Per una visione d’insieme dei contenuto dell’archivio dei pontefici, cfr. C. W. WESTRUP,
On the Antiquarian-Historiographical Activities of the Roman Pontifical College, Kobenhavn 1929;
G. ROHDE, Die Kultsatzungen der römischen Pontifices (Religionsgeschichtliche Versuche und
Vorarbeiten 25), Berlin 1936.
18 Cfr. Servio Dan. 1, 270: Sane quae feriae a quo genere hominum vel quibus diebus
observentur, vel quae festis diebus permissa sint, siquis scire desiderat, libros pontificales legat.
19
Per i fasti consulares vedi Corpus Inscriptionum Latinarum, I, 2a ediz., 1 ss.; A.
DEGRASSI, Inscriptiones Italiae, XIII, Fasti et elogia, Roma 1947; ID., Inscriptiones Latinae liberae
rei publicae, I, cit., pp. 15 ss.
Per i problemi di ricostruzione e di datazione, vedi R. STIEHL, Die Datierung der kapitolinischen
Fasten, Tübingen 1957; R. WERNER, Der Beginn der römischen Republik. Historischchronologische Untersuchungen über die Anfangszeit der libera res publica, München-Wien 1963,
pp. 219 ss. (dove sono ampiamente esaminate le opinioni della dottrina contemporanea), 264 ss.
(in cui si affrontano le questioni relative alla ricostruzione dei Fasti fino all’invasione gallica). I dati
prosopografici sono stati raccolti da T. R. S. BROUGHTON, The Magistrates of the Roman
Republic, cit. supra in n. 13.
20 Così Cicerone, De oratore 2, 12, 52-53: erat enim historia nihil aliud nisi annalium
confectio, cuius rei memoriaeque publicae retinendae causa ab initio rerum Romanarum usque ad
P. Mucium pontificem maximum res omnis singulorum annorum mandabat litteris pontifex
maximum efferebatque in album et proponebat tabulam domi, potestas ut esset populo
cognoscendi, ei qui etiam nunc annales maximi nominantur.
21
Sulla redazione di questi annales è piuttosto importante quanto riferito da Servio Dan., Aen.
1, 373: Ita autem annales conficiebantur: tabulam dealbatam quotannis pontifex maximus habuit,
in qua praescriptis consulum nominibus et aliorum magistratuum digna memoratu notare
consueverat domi militiaeque terra marique gesta per singulos dies. Cuius diligentiae annuos
commentarios in octoginta libros veteres retulerunt, eosque a pontificibus maximis a quibus fiebant
annales maximos appellarunt; con il quale concordano, per quanto riguarda l’origine
dell’appellativo maximi, Macrobio, Sat. 3, 2, 17: Pontificibus
[p. 30]
enim permissa est potestas memoriam rerum gestarum in tabulas conferendi, et hos annales
appellant et quidem maximos quasi a pontificibus maximis factos; e Paolo, Fest. ep., p. 113 L.:
Massimi annales appellabantur, non magnitudine, sed quod eos pontifex maximus confecisset.
Mette conto, peraltro, sottolineare il fatto che l’antichità di queste compilazioni non appare
messa in dubbio neanche da parte di quegli autori antichi, che pure le ritenevano prive di valore
storiografico: vedi Catone in Gellio, Noct. Att. 2, 28, 6: Verba Catonis ex originum quarto haec
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
202
sunt: non lubet scribere, quod in tabula apud pontificem maximum est, quotiens annona cara,
quotiens lunae aut solis lumine caligo aut quid obstiterit; cfr. anche Cicerone, De re pub. 1, 25.
22
I frammenti degli annales maximi sono stati raccolti da H. PETER, Historicorum Romanorum
reliquiae, I, Stutgardiae 1914, pp. 3 s. Troppo estensivo mi sembra il criterio di raccolta degli
annalium maximorum fragmenta proposto da J. V. LE CLERC, Des journaux chez les Romains,
recherches précédées d’un memoire sur les annales des pontifices, et suivies de fragments des
journaux de l’ancienne Rome, Paris 1837.
22a
Per la biografia vedi F. MÜNZER, Mucius, in Real-Encyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft 16, 1, Stuttgart 1933, coll. 425 ss.; frammenti in Iurisprudentiae
Antehadrianae quae supersunt, ed. F. P. BREMER, I, Lipsiae 1896 (Leipzig anast. 1985), pp. 32.
ss.
Sulla sua attività di giurista e di politico vedi, E. S. GRUEN, The political allegiance of the P.
Mucius Scaevola, in Athenaeum 43, 1965, pp. 321 ss.; G. GROSSO, P. Mucio Scevola tra il diritto
e la politica, in Archivio Giuridico “Filippo Serafini” 175, 1968, pp. 204 ss.; R. SEGUIN, Sacerdoces
et magistratures chez les Mucii Scaevolae, in Revue des études anciennes 72, 1970, pp. 90 ss.;
M. BRETONE, Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius civile (D. 1. 2. 2. 39), in La
critica del testo. Atti del II Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del diritto, I,
Firenze, 1971, pp. 103 ss.; R. A. BAUMAN, Five Pronouncements by P. Mucius Scaevola, in
Revue internationale des droits de l’antiquité 25, 1978, pp. 223 ss.; e da ultimo, A. GUARINO, La
coerenza di Publio Mucio, Napoli 1981.
23
Per quanto riguarda i testi di tali leges, vedi P. F. GIRARD, Textes de droit romain, 2a
ediz., Paris 1895, pp. 3 ss.; S. RICCOBONO, Fontes iuris romani antejustiniani, pars prima, 2a
ediz., Florentiae 1968, pp. 4 ss. In genere la storiografia giuridica del secolo scorso (a parte poche
eccezioni: M. VOIGT, cit. infra cap. II, § 3; C. FERRINI, Storia delle fonti del diritto romano e della
giurisprudenza romana, Milano 1885, pp. 1 ss.; E. CUQ, Les institutions juridiques des Romains, I,
Paris 1891, pp. 6 ss., 56 ss.) si orientava nel senso di ritenere le leges regiae disposizioni
sacerdotali raccolte in età recente: J. RUBINO, Untersuchungen über römische Verfassung und
Geschichte, Cassel 1839, pp. 399 ss.; Th. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, II, 3a ediz.,
Leipzig 1887, pp. 36 ss.; P. JÖRS, Römische Rechtswissenschaft zur Zeit der Republik, I, Berlin
1888, pp. 59 ss.; E. COSTA, Storia delle fonti del diritto romano, Torino 1909, pp. 1 ss.; P.
KRÜGER, Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts, 2a ediz., Leipzig 1912, pp.
4 ss. La critica
[p. 31]
più recente pare aver superato questa prospettiva (a cui, peraltro, non manca ancora qualche
autorevole adesione: J. CARCOPINO, Les prétendues “lois royales”, in Mélanges de l’École
française de Rome 54, 1937, pp. 344 ss.): vedi in questo senso la posizione di sintesi di P. VOCI,
Diritto sacro romano in età arcaica, in Studia et documenta historiae et iuris 19, 1953, pp. 91-92:
“La critica moderna alla tradizione sulle leges regiae è riuscita a scuotere la credibilità delle notizie
relative a un corpus, quale viene descritto dalle fonti. Ma non pare si possano avere dubbi su
questi tre punti: a) al rex spettò un potere di ordinanza (su questo non pare dubiti nessuno); b) il
rex usò di questo potere, emanando le disposizioni, di cui si è già parlato; c) queste disposizioni
dovettero, necessariamente, essere raccolte e custodite negli archivi dei pontefici”. Da ultimo,
riesamina l’intera problematica S. TONDO, Leges regiae e paricidas, Firenze 1973, sul quale vedi
infra, cap. II, pp. 58 ss.
24
Cicerone, Pro Rabir. perd. 15; Livio 1, 31, 8; 1, 32, 2; 1, 60, 4; Plinio, Nat. hist. 28, 2, 4.
Per una recente messa a punto della questione, vedi S. TONDO, Leges regiae e paricidas, cit., pp.
19 ss.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
203
25
Su questo particolare le testimonianze degli scrittori antichi sono unanimi: cfr. Cicerone,
Brut. 156; Pro Mur. 26; Livio 4, 3, 9; 9, 46, 5; Pomponio, D. 1, 2, 2, 6.
Cfr., inoltre, F. SCHULZ, Storia della giurisprudenza romana, trad. ital. Firenze 1968, pp. 40 ss.;
G. NOCERA, “Iurisprudentia”. Per una storia del pensiero giuridico romano, Roma 1973, pp. 15
ss.; C. A. CANNATA, Lineamenti di storia della giurisprudenza europea (2a ediz.), I. La
giurisprudenza romana e il passaggio dall’antichità al medioevo, Torino 1976, pp. 24 ss.
26
Quest’attività riguardava non solo i pontefici, ma anche gli auguri, i feziali e i decemviri
sacris faciundis. V’era, d’altronde, nel sistema giuridico-religioso romano una profonda
connessione fra ius di esclusiva competenza sacerdotale (pontificium, augurium, fetiale) e il
concreto esplicarsi dei rapporti “interni” ed “esterni” del Populus Romanus: così attraverso la
facoltà di intervenire in materia di ius augurium si attribuiva in pratica agli auguri quasi un potere di
controllo di “legittimità” sull’attività dei magistrati (cfr. ad esempio Livio 8, 23, 4). Né meno
importante è da ritenere il ruolo dei sacerdotes Fetiales, i quali, in quanto competenti
dell’elaborazione del ius fetiale, si ponevano come unici interpreti ufficiali delle norme che
regolavano i cosiddetti “rapporti internazionali” (cfr. Livio 31, 8, 3). Più in generale, vedi W.
KUNKEL, Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen, Weimar 1952, pp. 45 ss.; F.
SCHULZ, Storia della giurisprudenza romana, cit., pp. 19 ss.; G. NOCERA, “Iurisprudentia”, cit.,
pp. 33 ss.
27
L’epoca della sistemazione degli archivi non deve in nessun caso essere confusa con quella
d’inizio dell’utilizzazione della scrittura per scopi rituali da parte dei collegi sacerdotali romani. Di
certo, l’ausilio della scrittura per fissare le minuziose regole del rituale dovette essere necessità
assai risalente, giusta l’osservazione di A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les pontifes de l’ancienne
Rome. Étude historique des institutions religieuses de Rome, Paris 1871, p. 59, il quale notava, a
proposito dell’antichissima organizzazione di culto, che
[p. 32]
«une liturgie si compliquée ne pouvait se transmettre sans le secours de l’écriture». V’è,
d’altronde, in questo senso una precisa tradizione antica, probabilmente di origine pontificale, di
cui si ha notizia in Livio 1, 20, 5-7: pontificem deinde Numan Marcium Marci filium ex patribus legit
(sc. Numa) eique sacra omnia exscripta exsignataque attribuit, quibus hostiis, quibus diebus, ad
quae templa sacra fierent, atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur. Cetera quoque omnia
publica privataque sacra pontificis scitis subiecit, ut esset quo consultum plebes veniret, ne quid
divini iuris neglegendo patrios ritus peregrinosque adsciscendo turbaretur; nec caelestes modo
caerimonias, sed iusta quoque funebria placandosque manes ut idem pontifex edoceret, quaeque
prodigia fulminibus aliove quo visu missa susciperentur atque curarentur. Per una più approfondita
analisi dei testo liviano, vedi da ultimo E. PERUZZI, Origini di Roma. II. Le lettere, Bologna 1973,
pp. 155 ss.
28
Una iniziativa di tal genere da parte dei pontefice massimo non deve intendersi lesiva
dell’autonomia interna dei collegi sacerdotali, poiché, la nota competenza di esso nella
sorveglianza di tutte le forme di culto, permetteva l’accertamento e la definizione nella forma più
esatta non solo dei riti propri del collegio pontificale, ma anche di quelli che, sebbene praticati da
altri collegi, sottostavano tuttavia a quel generale potere di controllo di cui era titolare il pontefice
massimo. Non è questo il luogo per discutere della singolarità e complessità dei poteri del
pontefice massimo; non è, però, inutile ricordare come parte di essi sia risultata di non facile
inquadramento nella prospettiva sistematica del MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, cit., II, pp.
20 ss., il quale, pur favorevole in linea di principio alla netta separazione tra magistratura e
sacerdozio, fu costretto a qualificare “magistratische Befugniss” certe funzioni del pontefice
massimo. Peraltro la tesi del Mommsen, ancora seguita da gran parte della dottrina
contemporanea, trovò qualche opposizione quasi subito dopo la sua formulazione: vedi, ad es., C.
SCHWEDE, De pontificum collegii pontificisque maximi in re publica potestate, Lipsiae 1875.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
204
Fra gli studiosi che da ultimo si sono occupati del problema, vedi J. BLEICKEN, Oberpontifex und
Pontifikalkollegium. Eine Studie zur römischen Sakralverfassung, in Hermes 85, 1957, pp. 345 ss.;
A. CALONGE, El “pontifex maximus” y el problema de la distinción entre magistraduras y
sacerdocios, in Anuario historico del derecho español 38, 1968, pp. 5 ss.
Per quanto riguarda il rapporto magistratura-sacerdozio, cfr. la diversa impostazione di P.
CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, cit., pp. 237 n. 91, 273 ss.; 362 ss.; ID.,
Populus Romanus Quirites, Torino 1974, p. 135; seguita da S. MAZZARINO, Storia e diritto nello
studio delle società classiche, in La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche. Atti del I
Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del diritto, Firenze 1966, pp. 51 ss.; e da
C. NICOLET, Rome et la conquête du monde méditerranéen, 1. Les structures de l’Italie romaine,
Paris 1977, pp. 394 ss.
29
Certo il problema di una sistemazione degli archivi dovette porsi già all’inizio del III secolo,
quando con la lex Ogulnia i plebei ottennero l’accesso ai principali collegi sacerdotali. È peraltro
significativo che proprio in questo periodo si assista al sorgere di una giurisprudenza “laica”, di cui
[p. 33]
Appio Claudio Cieco ed il suo scriba Cn. Flavio sarebbero stati, secondo la tradizione, fra i
principali esponenti: per i rilievi critici a questa tradizione, vedi F. SCHULZ, Storia della
giurisprudenza romana, cit., pp. 24 ss.
30
Per i frammenti dei giuristi in questione, vedi F. P. BREMER, Iurisprudentiae antehadrianae,
cit., pp. 9 ss.; cfr. W. KUNKEL, Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen, cit., pp. 6 ss.;
L. WENGER, Die Quellen des römischen Rechts, Wien 1953, pp. 473 ss.; F. SCHULZ, Storia della
giurisprudenza romana, cit., pp. 78 ss.
31
Cfr. M. SCHANZ - C. HOSIUS, Geschichte der römischen Literatur, I, 4a ediz., München
1927, pp. 234 ss.; L. WENGER, Die Quellen des römischen Rechts, cfr., pp. 206 ss.
32
Degli scritti di “diritto sacro” dei giuristi dell’età repubblicana non ci sono pervenuti che sparsi
frammenti ed alcuni titoli. Cfr., per tutti, SCHANZ-HOSIUS, Geschichte der römischen Literatur, I,
cit., pp. 598 ss.; SCHULZ, Storia della giurisprudenza romana, cit., pp. 163 s.
33
Alla teologia sacerdotale doveva, in qualche modo, rifarsi Varrone nel trattare degli Dei negli
ultimi tre libri delle sue antiquitates rerum divinarum: la stessa suddivisione dell’argomento in: de
dis certis, de dis incertis, de dis praecipuis atque selectis, sembra riflettere la cautela tutta
sacerdotale, e la propensione per definizioni esaustive, nei confronti delle divinità che erano
oggetto di culto. Su Varrone e i documenti sacerdotali, vedi più ampiamente infra, cap. III, pp. 97
ss.
34
Vedi supra n. l.
35
Frammenti epigrafici in Corpus Inscr. Lat., I2, 1, pp. 205 ss.; VI, 32481 ss.; i Fasti Antiates,
cioè ritrovati ad Anzio nel 1915, sono stati pubblicati da A. DEGRASSI, Inscriptiones Latinae
liberae rei publicae, cit., pp. 23 ss. Fra gli studi più recenti vedi, oltre l’importante contributo di A.
KIRSOPP MICHELS, The Calendar of the Roman Republic, Princeton 1967; Ch. GUITTARD, Le
calendrier romain des origines au milieu du Vo s. av. J. C., in Bulletin de l’Association G. Budé,
1973, pp. 203 ss.; E. LÉNARD, Calendrier de Romulus. Les débuts du calendrier romain, in
L’Antiquité classique 50, 1981, pp. 469 ss.; ma, per quanto riguarda il calendario religioso, anche
P. DE FRANCISCI, Primordia civitatis, Roma 1959, pp. 322 ss., e da ultimo G. DUMÉZIL, Fêtes
romaines d’été et d’automne, suivi de dix questions romaines, Paris 1975.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
205
36
Per lo studio delle fonti relative ai ludi saeculares è ancora fondamentale l’opera di G. B.
PIGHI, De ludis saecularibus populi Romani Quiritium. Libri sex, Milano 1941 (rist. Amsterdam
1965). Cfr. inoltre, J. A. HILD, Saeculares ludi. Saeculum, in Dictionnaire des antiquités grecques
et romaines 4, 2, Paris 1908, pp. 987 ss.; M. P. NILSSON, Saeculares Ludi, in Real-Encyclopädie
der classischen Altertumswissenschaft 1 A, Stuttgart 1920, coll. 1696 ss.; J. GAGÉ, Recherches
sur les jeux séculaires, Paris 1934; ID., Apollon romain.
[p. 34]
Essai sur le culte de Apollon et le développement du “ritus Graecus” à Rome des origines à
Auguste, Paris 1955; P. WEISS, Die “Säkularspiele” der Republik, eine annalistische Fiktion? Ein
Beifrag zum Verstendnis der kaiserzeitlichen Ludi Saeculares, in Mitteilungen des Deutschen
Archäologischen Instituts (Röm. Abt) 80, 1973, pp. 205 ss.; P. BRIND’AMOUR, L’origine des Jeux
séculaires, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II, 16. 2, Berlin - New York 1978, pp.
1334 ss.
37
Gu. HENZEN, Acta fratrum arvalium quae supersunt, Berolini 1874; Ae. PASOLI, Acta
fratrum arvalium quae post annum MDCCCLXXIV reperta sunt, Bologna 1950; ne ha annunciato
una nuova edizione J. Scheid, autore di un’opera prosopografica sui fratres arvales, cit., supra in n.
3.
38
Vedi supra n. l.
39
La bibliografia sulle fonti letterarie è citata supra in n. 2.
40
Cfr. Livio 1, 20, 5; 1, 32, 2; Cicerone, De orat. 2, 52.
41
Vedi fra gli altri, J. GUILLÉN, Los sacerdotes romanos, in Helmantica 24, 1973, pp. 5 ss.; L.
R. MÉNAGER, Les collèges sacerdotaux, les tribus et la formation primordiale de Rome, cit. supra
in n. 5.
42
Solitamente nella dottrina si tende a dare maggior rilievo agli annales dei pontefici ed a
operare una sorta di identificazione tra questo genere di documenti ed il restante materiale degli
archivi: ciò anche in ragione della non precisa distinzione che gli stessi autori antichi operavano tra
annali e commentarii. Riguardo agli annales pontificum le posizioni della dottrina precedente sono
ben sintetizzate da C. DE LA BERGE, Annales Maximi, in Dictionnaire des antiquités grecques et
romaines 1, Paris 1877, pp. 272 ss., e da C. CICHORIUS, Annales, in Real-Encyclopädie der
classischen Altertumswissenschaft 1, Stuttgart 1894, coll. 2248 ss.
43
Così, fra gli altri, L. HOMO, L’Italie primitive et les débuts de l’imperialisme romain, Paris
1925, pp. 11 ss.; S. ACCAME, I re di Roma nella leggenda e nella storia, Napoli s. d., pp. 40 s.; S.
MAZZARINO, Il pensiero storico classico, II, 1, Bari 1966, pp. 255 ss.; 271 ss
44
La bibliografia sugli annali dei pontefici è vastissima; ci limiteremo pertanto alle
indicazioni essenziali: A. BOUCHÉ-LECLERCQ, Les pontifes de l’ancienne Rome, cit., pp. 250 ss.;
L. CANTARELLI, Origine degli Annales Maximi, in Rivista di filologia e d’istruzione classica 26,
1898, pp. 209 ss.; A. ENMANN, Die älteste Redaktion der Pontifikalannalen, in Rheinisches
Museum für Philologie, 57, 1902, pp. 517 ss.; W. SOLTAU, Die Anfänge der roemischen
Geschichtschreibung, Leipzig 1909, pp. 10 ss.; E. KORNEMANN, Die älteste Form der
Pontifikalannalen, in Klio 11, 1911, pp. 245 ss.; C. W. WESTRUP, On the Antiquarian historiographical Activities of the Roman Pontifical College, cit. supra in n. 17; M. GELZER, Der
Anfang römischer Geschichtsschreibung, in Hermes 69, 1934, pp. 46 ss. (= Kleine Schriften, III,
Wiesbaden
[p. 35]
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
206
1964, pp. 93 ss.); E. A. CRAKE, The Annals of the Pontifex Maximus, in The Classical Philology
35, 1940, pp. 375 ss.: gli scritti del Gelzer e del Crake sono stati ripubblicati di recente in V.
PÖSCHL (Hrsg. von), Römische Geschichtsschreibung, Wege der Forschung 90, Darmstadt 1969;
A. ALFÖLDI, Early Rome and the Latins, Ann Arbor 1965, pp. 164 ss.; E. GABBA, Considerazioni
sulla tradizione letteraria sulle origini di Roma, in Les origines de la république romaine (Entretiens
sur l’antiquité classique XIII, Fond. Hardt), Genève 1967, pp. 150 ss.; L. ALFONSI, La prosa e lo
stile degli Annales Maximi, in Studii Clasice 15, 1973, pp. 51 ss.; E. PERUZZI, Origini di Roma, II,
cit., pp. 175 ss.; B. GENTILI - G. CERRI, Le teorie del discorso storico nel pensiero greco e la
storiografia romana arcaica, Roma 1975, pp. 81 ss.; da ultimo, B. W. FRIER, Libri Annales
Pontificum Maximorum. The Origins of the Annalistic Tradition, Rome 1979. Vedi, inoltre, infra nn.
45-48.
45
G. DE SANCTIS, Storia dei Romani, I-II, Torino 1907 (2a ediz., Firenze 1960); per la
parte sugli annales vedi I, pp. 16 ss. Sulla figura di questo significativo storico dei nostro secolo
vedi le considerazioni di A. MOMIGLIANO, In memoria di Gaetano De Sanctis, in Rivista storica
italiana 69, 1957, pp. 177 ss. (= Secondo contributo alla storia degli studi classici, Roma 1960, pp.
299 ss.); da ultimo, fra gli altri, G. BANDELLI, Gaetano De Sanctis tra Méthode e ideologia, in
Quaderni di storia 14, 1981, pp. 231 ss.
46
In Italia principale rappresentante di tale tendenza fu E. PAIS, autore della Storia d’Italia dai
tempi più antichi alla fine delle guerre puniche e della Storia critica di Roma: sulla molteplice
produzione storiografica dello storico italiano, sul valore e l’attualità della sua opera, vedi il recente
contributo di R. T. RIDLEY, Ettore Pais, in Helikon 15-16, 1975-76, pp. 500 ss. Per un rifiuto
radicale delle tesi del Pais vedi, soprattutto, C. BARBAGALLO, Le origini di Roma da Vico a noi,
Milano 1926, pp. 93 ss.; ma cfr. anche A. PIGANIOL, La conquête romaine, 5e ediz., Paris 1967,
p. 623; J. HEURGON, Rome et la Méditerranée occidentale jusqu’aux guerres puniques (Paris
1969), trad. ital.: Il Mediterraneo occidentale dalla preistoria a Roma arcaica, Bari 1972, p. 372.
47
47
Cfr., fra gli altri, A. ROSENBERG, Einleitung und Quellenkunde zur römischen
Geschichte, Berlin 1921, pp. 113 ss.; F. ALTHEIM, Epochen der römischen Geschichte, Frankfurt
a. M. 1934, pp. 121 ss.; E. CIACERI, Le origini di Roma. La monarchia e la prima fase dell’età
repubblicana, Milano 1937, pp. 70 ss.
48
L. PARETI, Storia di Roma e del mondo romano, I, Torino 1952, pp. 13 ss., anticipa di
circa un secolo la data d’inizio delle cronache dei pontefici (sostenendo che “nulla vieta di pensare
che le notazioni del Pontefice Massimo risalgano ai primi tempi della repubblica”) basandosi su
una diversa interpretazione del passo di Cicerone, De re publ. 1, 25 (p. 14 n. 4).
49
È troppo nota, ed ormai unanimemente riconosciuta, l’influenza profonda che ha avuto
sugli studi intorno alla religione, e più in generale alle strutture socio-politiche della comunità
romana arcaica, la ricerca di
[p. 36]
G. DUMÉZIL: sulla quale vedi, fra gli altri, H. FUGIER, Quarante ans de recherches sur l’idéologie
indo-européenne: la méthode de M. Georges Dumézil, in Revue d’histoire et de philosophie
religieuses 45, 1965, pp. 358 ss.; C. SCOTT LITTLETON, The New Comparative Mythology. An
Antropological Assessment of the Theories of Georges Dumézil, Berkeley-Los Angeles 1966; M.
MESLIN, De la mythologie comparée à l’histoire des structures de la pensée: l’oeuvre de Georges
Dumézil, in Revue historique 96, 1972, pp. 5 ss.; J. RIES, Héritage indo-européen et religion
romaine. A propos de La religion romaine archaïque de Georges Dumézil, in Revue théologique de
Louvain 7, 1976, pp. 476 ss.; E. B. LYLE, Dumézil’s three Fonctions and Indo-European Cosmic
Structure, in Numen 22, 1982, pp. 25 ss. Per la bibliografia dei lavori del Dumézil (completa fino al
1960), vedi Hommages à G. Dumézil, Bruxelles 1960; fra le opere più recenti (a parte La religion
romaine archaïque, cit. in n. 3, e Fêtes romaines d’été et d’automne cit. in n. 35) sono da ricordare:
Mythe et épopée, I. L'idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens,
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
207
Paris 1968; Idées romaines, Paris 1969; Mythe et épopée, II. Types épiques indo- européens: un
héros, un socier, un roi, Paris 1971; Mythe et épopée, III. Histoires romaines, Paris 1973; Mariages
indo-européens, Paris 1979; vedi anche Discours de réception de M. Georges Dumézil à
l’Académie Française et réponse de M. Claude Lévi-Strauss, Paris 1979.
50
Fra i lavori di E. PERUZZI, oltre le fondamentali Origini di Roma (I. La famiglia, Firenze
1970; II. Le lettere, Bologna 1973), mette conto ricordare: L’iscrizione di Duenos, in La parola del
passato 13, 1958, pp. 328 ss.; Un’antichissima sors con iscrizione latina, in La parola del passato
14, 1959, pp. 212 ss.; I Marsi con Roma, in Maia 13, 1961, pp. 165 ss.; Testi latini arcaici dei
Marsi, in Maia 14, 1962, pp. 117 ss.; Sabinismi dell’età regia, in La parola del passato 22, 1967,
pp. 29 ss.; Onomastica e società nella Roma delle origini, in Maia 21, 1969, pp. 126 ss., 244 ss.;
Romolo e le lettere greche, in La parola del passato 24, 1969, pp. 161 ss.; Livio 1, 20, 5, in Rivista
di filologia e d’istruzione classica 99, 1971, pp. 264 ss.; I Micenei sul Palatino, in La parola del
passato 29, 1974, pp. 309 ss.; Aspetti culturali del Lazio primitivo, Firenze 1978; Myceneans in
Early Rome, Roma 1980.
51 Cfr. PARETI, Storia di Roma e del mondo romano, I, cit., pp. 675 ss.; DUMÉZIL, La
religion romaine archaïque, cit. in n. 3; Idées romaines, cit., pp. 10, 11 ss., 25; Fêtes romaines
d’été et d’automne, cit., pp. 141 ss.; PERUZZI, Origini di Roma, Il, cit., pp. 155 ss., 175 ss.; ID.,
Livio 1, 20, 5, cit., pp. 264 ss.
52
Per quanto riguarda i nuovi scavi, vi è un panorama completo in Civiltà del Lazio
primitivo, Roma 1976; vedi anche, in una prospettiva più specifica, Lazio arcaico e mondo greco La parola del passato 32, 1977 (I. L’area sacra di sant’Omobono; II. L’Esquilino e il Comizio; III.
Castel di Decima; IV. Ficana e Lavinium; V. Il territorio laziale e Gravisca); cfr. inoltre P. G.
GIEROW, The Iron Age Culture of Latium, I. Classification and Analysis (Lund 1966), II.
Excavations and Finds, 1. The Alban Hills (Lund 1964). Importanti contributi alla conoscenza delle
strutture sociale e politiche del Lazio arcaico sono stati dati dai lavori di P. DE FRANCISCI,
Primordia civitatis,
[p. 37]
cit. supra in n. 35; ID., Variazioni su temi di preistoria romana, Roma 1974, pp. 35 ss.; A.
BERNARDI, Dai populi Albenses ai Prisci Latini nel Lazio arcaico, in Athenaeum 42, 1964, pp. 233
ss.; C. AMPOLO, Su alcuni mutamenti sociali nel Lazio tra VIII e il V secolo a.C., in Dialoghi
d’archeologia 4-5, 1970-71, pp. 37 ss.; G. COLONNA, Un aspetto oscuro del Lazio antico: le
tombe del VI- V secolo a.C., in Lazio arcaico e mondo greco, cit., II, pp. 131 ss.
53
Questa tesi già sostenuta, a suo tempo, da B. MODESTOW, Der Gebrauch der Schrift unter
den römischen Königen, Berlin 1871, pp. 42 s., e da C. BARBAGALLO, Il problema delle origini di
Roma da Vico a noi, cit., pp. 47 ss., ha trovato di recente nuove adesioni: cfr. E. PERUZZI, Origini
di Roma, Il, cit., pp. 9 ss., 81 ss.; S. TONDO, Leges regiae e paricidas, cit., pp. 15, 19 ss.; ID.,
Profilo di storia costituzionale romana, I, Milano 1981, pp. 9 ss.
Un esempio particolarmente significativo (per quanto riguarda Roma) di questo tipo di iscrizioni
è costituito dal cippo arcaico rinvenuto nel Foro: la cosiddetta iscrizione del lapis Niger, del cui
carattere risalente, pur tra le differenti datazioni ed interpretazioni proposte, nessuno pare al
momento dubitare. Non è questo il luogo per discutere delle varie letture ricostruttive proposte, fra
le quali mi pare assai stimolante quella di G. DUMÉZIL, Sur l’inscription du Lapis Niger, in Revue
des études latines 36, 1958, pp. 109 ss.; Remarques sur la stèle archaïque du Forum, in
Hommages à Jean Bayet, Bruxelles 1964, pp. 172 ss.; La religion romaine archaïque, cit., pp. 99
ss.; A propos de l’inscription du Lapis Niger, in Latomus 39, 1970, pp. 1038 ss. Ma contra vedi R.
E. A. PALMER, The King and the Comitium. A Study of Rome’s Oldest Public Document,
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
208
Wiesbaden 1969; da ultimo, F. COARELLI, Il Comizio dalle origini alla fine della Repubblica:
cronologia e topografia, in Lazio arcaico e mondo greco, cit., II, pp. 229 ss.
54
Un esempio di utilizzazione delle formule giuridico-religiose per interpretare, al di fuori degli
schemi polibiano e mommseniano, la “divisione dei poteri” nella res publica romana è quello
proposto da P. CATALANO, La divisione del potere in Roma (a. proposito di Polibio e di Catone),
in Studi Grosso, VI, Torino 1974, pp. 680 ss.; Populus Romanus Quirites, cit., pp. 97 ss.
Significativi apprezzamenti del metodo del Catalano in C. NICOLET, Lexicographie politique et
histoire romaine: problèmes de méthode et directions de recherches, in Atti del Convegno sulla
lessicografia politica e giuridica nel campo delle scienze dell’antichità, Torino 1980, p. 29; cfr. ID.,
Notes complémentaires a Polybe, Histoires, livre VI, Paris 1977, pp. 149 s.
55
G. DUMÉZIL, La religion romaine archaïque, cit, pp. 104 ss. (cfr. trad. ital., cit., pp. 93 ss.).
56
J. BAYET, Introduction, in Tite-Live, Histoire romain, livre I, Paris 1965, pp. XXXVIII s.
57
Questo potrebbe spiegare la conservazione dei formalismo dell’antico diritto romano: sul
quale vedi G. GROSSO, Problemi generali del diritto
[p. 38]
attraverso il diritto romano, 2a ediz., Torino 1967, pp. 130 ss.; invece, per la continuità delle
istituzioni di “diritto pubblico”, e la coscienza che gli antichi avevano di essa: cfr. S. MAZZARINO,
Vico, l’annalistica e il diritto, Napoli 1971, pp. 26 ss.
58
Per quanto riguarda la tendenza conservatrice della tradizione religiosa romana, cfr., fra gli
altri, J. BAYET, La religione romana. Storia politica e psicologica, cit., pp. 44 ss.; G. DUMÉZIL, La
religion romaine archaïque, cit., pp. 98 ss. (cfr. trad. ital., cit., pp. 87 ss.).
59
Un caso esemplare di notizie del tutto disuguali dal punto di vista dell’attendibilità, pur
essendo riportate nello stesso luogo, ci è dato da Cicerone, De re publ. 1, 63: Nam dictator ab eo
appellatur quia dicitur. Sed in nostris libris vides eum, Laeli, magistrum populi appellari. Dal passo
si ricavano due informazioni: la prima è attinente al significato del termine dictator (quia dicitur);
l’altra riporta la denominazione solenne di questo magistrato (magister populi); la ragione del
diverso valore di esse è da ricercare nel fatto che Cicerone attinge la prima dalla ricerca antiquaria
del suo secolo, o poco precedente, mentre ricava la seconda da documenti ufficiali del collegio
degli auguri. Cfr. F. SINI, A proposito del carattere religioso del “dictator” (note metodologiche sui
documenti sacerdotali), in Studia et documenta historiae et iuris 42, 1976, p. 419.
60
Vedi, in questo senso, le osservazioni di P. CATALANO, Populus Romanus Quirites, cit., pp.
56 ss.
61
Tipico è il caso dell’assimilazione dei concetto di populus al concetto di Staat, e
dell'interpretazione “statualista” del sistema giuridico-religioso romano, operate dal Mommsen: sul
quale vedi P. CATALANO, Populus Romanus Quirites, cit., pp. 41 ss.
62
Significativo notare al riguardo che già nel Handbuch der römischen Alterthümer di W. A.
BECKER e J. MARQUARDT (Leipzig 1843 ss.) la Staatsverfassung veniva trattata a parte (e da
autore diverso) dal Gottesdienst; la stessa separazione continua ad essere tenuta anche nel
Handbuch der römischen Alterthümer di Th. MOMMSEN e J. MARQUARDT, dove il primo tratta
dello Staatsrecht ed il secondo del Sakralwesen.
63
Th. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, 3a ediz., 3 voll., Lcipzig 1887 (ripr. Basel-Stuttgart
1963).
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
209
64
Sulla Staatsrechtslhre del Mommsen, vedi la recente critica di J. BLEICKEN, Lex publica.
Gesetz und Recht in der römischen Republik, Berlin-New York 1975, pp. 16 ss.
65
Così, ad esempio, per il MOMMSEN, Römischen Staatsrecht, II, 1, pp. 9 s., l’inauguratio di
Numa sarebbe un’invenzione dell’annalistica, che avrebbe utilizzato come modello l’inauguratio del
Flamen Dialis in età repubblicana.
[p. 39]
66
G. WISSOWA, Religion und Kultus der Römer, cit., pp. 5 s.; cfr. pp. 384 s., 490, 510,
524, 552 s.
67
K. LATTE, Römische Religionsgeschichte, cit., p. 5: “Besondere Vorsicht ist bei Verwendung
der in die annalistische Überlieferung eingelegten Dokumente geboten. Sie sind im wesentlichen
von dem Schriftsteller selbst mit Benutzung sakraler und iuristischer Formeln, die ein archaisches
Kolorit geben sollten, entworfen oder seiner unmittelbaren Vorlage entnommen”; nella stessa
pagina n. 1, il Latte cita i casi a cui intende riferirsi: “Die Schilderung des Fetialenritus bei Liv. I 32,
6 bietet ein für die ältere Sprache unmögliches personifiziertes Fas als Subjektsbegriff und den
gräzisierenden Vokativ populus Albanus, das Foedus Liv. I 24, 7 übernimmt die Formel tabulis
cerave aus dem Testament (z. B. Gaius 2, 104), wo sie auf den Unterschied von Testament und
Kodizill geht. Die Devotionsformel Liv. 8, 9, 6 hat ein einhellig überliefertes veniam fero, das der
Bedeutung “Gnade”, “Gunstbezeugung”, die das Wort in der sakralen Sprache allein hat,
zuwiderläuft. Die gleiche Formel ist die einzige Stelle, die Divi Novensiles, Di Indigetes (in dieser
Reihenfolge!) nebeneinanderstellt; Livius verstand offenbar die neuen und die alteingesessenen
Götter”.
Un’impostazione così restrittiva nei confronti delle fonti letterarie è stata oggetto di fondate
obiezioni e di numerose critiche: vedi A. BRELICH, Un libro dannoso: la Römische
Religionsgeschichte di Kurt Latte, in Studi e materiali di storia delle religioni 32, 1961, pp. 329 ss.;
G. DUMÉZIL, La religion romaine archaïque, cit., pp. 104 s.; R. SCHILLING, La situation des
études relatives à la religion romaine de la République (1950-1970), in Aufstieg und Niedergang
der römischen Welt, I, 2, Berlin-New York 1972, p. 327.
68
P. CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, cit, p. 109.
69
C. GIOFFREDI, Il frammento di Fabio Pittore in Gell. N. A., 10, 15, 1, e la tradizione
antiquaria dei testi giuridico-sacrali, in Bullettino dell’Istituto di diritto romano 79, 1976, pp. 28 ss.
70
Sulla distinzione tra acta e commentarii si veda H. PETER, Die geschichtliche Literatur über
die römische Kaiserzeit bis Theodosius I und ihre Quellen, I, Leipzig 1897 (rist. anast. 1967), p.
205. Per quanto riguarda gli annales riassumono l’intera problematica C. DE LA BERGE, Annales
Maximi, in Dictionnaire des antiquités grecques et romaines 1, 1, cit, pp. 272 ss.; C. CICHORIUS,
Annales, in Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 1, 2, cit., coll. 2248 ss.
71
Sullo stato della questione vedi l’articolo del BOUCHÉ-LECLERQ, Libri, in Dictionnaire des
antiquités grecques et romaines 3, 2, Paris 1904, pp. 1235 ss., e quello più recente di R. F.
ROSSI, Libri, in Dizionario epigrafico di antichità romane 4, Roma 1958, pp. 966 ss.
72
Di recente alcuni studiosi, richiamandosi a quanto già sostenuto dal CANTARELLI, Origine
degli Annales Maximi, cit., pp. 214 s., appaiono propensi a ritenere i commentarii piuttosto un testo
di carattere storico: E. Gabba,
[p. 40]
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
210
Considerazioni sulla tradizione letteraria sulle origini della repubblica, cit., p. 150 e n. 3; E.
PERUZZI, Origini di Roma, II, cit., p. 196.
73
Le fonti in questione sono raccolte e discusse infra nel cap. III.
74
Livio 10, 8, 2: Decemviros sacris faciundis, carminum Sibyllae ac fatorum populi huius
interpretes. Per una discussione più approfondita sui libri Sibyllini vedi WISSOWA, Religion und
Kultus der Römer, cit., pp. 536 ss. (ivi bibliogr. precedente); W. HOFFMANN, Wandel und Herkunft
der sibyllinischen Bücher in Rom, Leipzig 1933; R. BLOCH, Les origines étrusques des Livres
Sibyllins, in Mélanges A. Ernout, Paris 1940, pp. 21 ss.; J. GAGÉ, Apollon romain. Essai sur le
culte d’Apollon et le devéloppement du “ritus Graecus” à Rome des origines à Auguste, cit., pp. 21
ss.; K. LATTE, Römische Religionsgeschichte, cit., pp. 160 s.; R. M. OGILVIE, A Commentary on
Livy. Books 1-5, Oxford 1965, pp. 654 s.; G. RADKE, Die Götter altitaliens, Münster 1965, pp. 39
ss.
75 Fra i libri e i commentari dei re (per le fonti vedi infra cap. III n. 2), meritano particolare
attenzione quelli attribuiti a Numa Pompilio, che peraltro già nell’antichità furono al centro di vaste
polemiche. È noto che nel 181 a.C. “in agro L. Petillii scribae sub Ianiculo, dum cultores (agri)
altius moliuntur terram, duae lapidiae arcae, octonos ferme pedes longae, quaternos latae,
inventae sunt, operculis plumbo devinctis. Litteris Latinis Graecisque utraque arca incripta erat, in
altera Numan Pompilium Pomponis filium, regem Romanorum, sepultum esse, in altera libros
Numae Pompilii inesse. Eas arcas cum ex amicorum sententia dominus aperuisset, quae titulum
sepulti regis habuerat, inanis inventa, sine vestigio ullo corporis humani aut ullius rei, per tabem tot
annorum omnibus adsumptis. In altera duo fasces candelis involuti septenos habuere libros, non
integros modo sed recentissima specie. Septem Latini de iure pontificum erant, septem Graeci de
disciplina sapientiae, quae illius aetatis esse potuit” (Livio 40, 29, 3-7); il fatto divenne subito un
caso politico ed i libri, la cui diffusione poteva turbare l’ordine, furono bruciati come apocrifi per
iniziativa del pretore Q. Petillio. Al di là della constatazione della natura politica dell’azione del
pretore, legata di certo alle motivazioni più generali che ispiravano la reazione catoniana di quegli
anni, mette conto sottolineare come alcuni degli annalisti contemporanei, o di poco posteriori, non
sembrano dubitare dell’autenticità di tali libri: le fonti sull’episodio sono state raccolte da G.
GARBARINO, Roma e la filosofia greca dalle origini alla fine del II secolo a.C., Torino 1973, I, pp.
64 ss.
L’intera vicenda dei libri Numae è stata di recente ridiscussa da E. PERUZZI, Origini di Roma,
II, cit., pp. 107 ss., il quale, attraverso un acuto confronto delle diverse versioni, arriva a dimostrare
la sostanziale autenticità dei libri ritrovati nel 181 a.C.; più critica la posizione di M. J. PENA, La
tumba y los libros de Numa, in Faventia 1, 1979, pp. 211 ss.
76
A libri e commentarii di magistrati si riferiscono Varrone, De ling. Lat. 6, 9, 88; Livio 4, 7, 10;
4, 20, 8; 39, 52, 4; Servio Sulpicio Rufo in Gellio, Noct. Att. 2, 10, l.
[p. 41]
77
In generale sul diritto divino, vedi A. BERGER, Ius divinum, in Real-Encyclopädie der
classischen Altertumswissenschaft 10, 1, Stuttgart 1917, coll. 1212 ss.; P. CATALANO, Per lo
studio dello ius divinum, in Studi e materiali di storia delle religioni 33, 1962, pp. 130 ss.; per
quanto riguarda il diritto sacro vedi l’importante contributo di P. VOCI, Diritto sacro romano in età
arcaica, cit. supra in n. 23; limitatamente ad alcuni aspetti di esso R. DÜLL, Rechtsprobleme im
Bereich des römischen Sakralrechts, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, I, 2, BerlinNew York 1972, pp. 283 ss.; cfr., anche, P. NOAILLES, Du droit sacré au droit civil. Cours de droit
romain approfondi 1941-42, Paris 1949.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
211
78
Tali erano, ad esempio, le norme del ius augurium che interferivano nell’attività dei comizi:
Cicerone, De domo 39; De div. 2, 42; Livio 48, 18, 16; Macrobio, Sat. 1, 16, 19.
79
Livio 9, 46, 5. Sull’influenza dei pontefici nell’elaborazione del ius vedi, fra gli altri, M.
KASER, Das altrömische Ius. Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsgeschichte der Römer,
Göttingen 1949, pp. 345 ss.; I. VERNACCHIA, I pontefici nella storia del processo romano arcaico,
in Ciceroniana 1, 1959, pp. 123 ss.; sugli aspetti “religiosi” del ius civile più antico sono
particolarmente significativi i lavori di H. LÉVY-BRUHL, raccolti in Nouvelles études sur le trés
ancien droit romain, Paris 1947.
80
Per quanto riguarda gli indigitamenta è ancora utile il vecchio lavoro di I. A. AMBROSCH,
Über die Religionsbücher der Römer, Bonn 1843; importante anche l’articolo di J. BAYET, Les
“Feriae sementivae” et les indigitations dans le culte de Cérès et de Tellus, in Revue de l’histoire
des religions 137, 1950, pp. 172 ss.; cfr. inoltre G. DUMÉZIL, La religion romaine archaïque, cit.,
pp. 50 ss. (trad. ital., cit., pp. 46 ss.).
81
Cicerone, De re publ. 2, 54; Seneca, Epist. 108, 31.
82
Cfr., in tal senso, i due decreta del collegio degli auguri riportati da Livio 4, 31, 4, e da
Festo, v. maximus praetor, p. 152 L.
83
Per le fonti su libri e commentarii sacerdotali, vedi infra cap. III.
84
La posizione del Niebuhr, con la relativa bibliografia, è esposta nel cap. II, § 2.
85
Le basi per la ricostruzione critica del materiale contenuto negli archivi sacerdotali erano
state poste dalle numerose opere di I. A. AMBROSCH, Studien und Andeutungen im Gebiet des
altrömischen Bodens und Cultus, Breslau 1839, in part. pp. 159 ss.; Observationum de sacris
Romanorum libris particula prima, Vratislaviae 1840; Über die Religionsbücher der Römer, cit. in n.
80; Quaestionum pontificalium caput primum, Vratislaviae 1848; caput alterum, ibid. 1850. Ma vedi
anche F. LÛBBERT, Commentationes pontificales, Berolini 1859.
[p. 42]
86
A. BOUCHÉ-LECLERQ, Les pontifes de l’ancienne Rome, cit. supra in n. 44. Per quanto
riguarda l’esposizione del punto di vista dello studioso francese rimando al § 3 del capitolo
seguente.
87
87
P. REGELL, De augurum publicorum libris, diss. Vratislaviae 1878, in part. pp. 31 ss. Per
una più ampia discussione, vedi infra cap. Il § 3.
88
L’opinione che rifiutava la distinzione tra libri e commentarii sacerdotali, oltre ad essere
raccolta dal WISSOWA nel suo manuale sulla religione romana e dallo SCHANZ nel primo volume
della Geschichte der römischen Literatur, fu anche in genere fatta propria dagli estensori degli
articoli riguardanti collegi ed archivi sacerdotali, pubblicati, tra la fine dell’Ottocento ed i primi anni
dei nostro secolo, nel Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, nella Real-Encyclopädie
der classischen Altertumswissenschaft, e nel Dizionario epigrafico di antichità romane. Sulla
questione vedi infra, cap. II, p. 55.
89
Cfr., in questo senso, alcuni fra i più significativi lavori del genere: P. PREIBISCH,
Fragmenta librorum pontificiorum, Tilsit 1878; R. PETER, Quaestionum pontificalium specimen,
Argentorati 1886; Gu. ROWOLDT, Librorum pontificiorum Romanorum de caerimoniis sacrificiorum
reliquiae, Halis Saxon. 1906.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
212
Calendari
I calendari, il cui nome più corretto sarebbe quello di fasti, riservato peraltro anche a elenchi di
magistrati di cui si parla oltre, avevano lo scopo di indicare i giorni fasti e nefasti, i dies comitiales, i
giorni di mercato, quelli in cui si celebravano i ludi e i dies natales dei templi.
I giorni fasti erano quelli in era possibile (fas) celebrare cause in tribunale, nefasti quelli in cui c'era
appunto la sospensione delle attività giudiziarie e in genere le attività pubbliche. I dies comitiales
erano quelli in cui era possibile convocare i comizi; i giorni di mercato erano i dies nundinales.
Secondo la tradizione il primo calendario sarebbe stato ideato da Numa Pompilio e reso pubblico
da Anco Marcio.
Livio ci dà notizia di un calendario fatto pubblicare nel 304 dall'edile curule Cn. Flavio su una tavola
imbiancata collocata in prossimità del foro.
Altre pubblicazioni di questo genere si ripeterono in altre occasioni, ricordate dalle fonti storiche.
Dei calendari rimasti, uno, il calendario Anziate è databile tra il 65 e il 55 a.C., è quindi anteriore
alla riforma giuliana; gli altri, più di una quarantina, sono successivi. Il calendario Anziate è dipinto
su intonaco, gli altri incisi su tavole marmoree.
[Figura I fasti Anziati]
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
213
[Figura I fasti Anziati]
Testi e testimonianze
Liv., 9, 46,8
Eodem anno Cn. Flauius Cn. filius scriba, patre libertino humili fortuna ortus, ceterum callidus uir et
facundus, aedilis curulis fuit. inuenio in quibusdam annalibus, cum appareret aedilibus fierique se pro tribu
aedilem uideret neque accipi nomen quia scriptum faceret, tabulam posuisse et iurasse se scriptum non
facturum; quem aliquanto ante desisse scriptum facere arguit Macer Licinius tribunatu ante gesto
triumuiratibusque, nocturno altero, altero coloniae deducendae. ceterum, id quod haud discrepat,
contumacia aduersus contemnentes humilitatem suam nobiles certauit; ciuile ius, repositum in penetralibus
pontificum, euolgauit fastosque circa forum in albo proposuit, ut quando lege agi posset sciretur.
46. In quello stesso anno uno scrivano, Gneo Flavio, che era di umile estrazione, in quanto figlio
di un liberto, ma era anche molto accorto e abile nel parlare, fu eletto edile curule. Secondo
alcuni annali, mentre era ancora un funzionario degli edili, gli capitò di constatare di essere
designato edile dalla tribù che esprimeva il suo voto per prima ma poi l'elezione non veniva
convalidata a causa del suo mestiere di scrivano; allora avrebbe buttato via la tavoletta giurando
che mai più avrebbe fatto lo scrivano.
Diverso quanto riferisce Licinio Macro: Gneo Flavio già da tempo aveva smesso l'attività di
scrivano. Era già stato tribuno della plebe e triumviro (la prima volta come triunviro notturno, la
seconda volta come triumviro incaricato della deduzione di una colonia). Comunque su una cosa
tutti sono d'accordo: molto duramente egli lottò contro il disprezzo dei nobili per la sua bassa
condizione sociale; divulgò il diritto civile che veniva tenuto celato dai pontefici nei loro penetrali
e pubblicò su tavole bianche infisse tutto attorno al Foro l'elenco dei giorni fasti in modo che
ognuno sapesse quando si poteva amministrare la giustizia.
Trad. Mazzocato (riportato più estes. Sotto sub Gneo Flavio).
Liv., 1,32,2
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
214
Qui ut regnare coepit et auitae gloriae memor et quia proximum regnum, cetera egregium, ab una parte
haud satis prosperum fuerat aut neglectis religionibus aut praue cultis, longe antiquissimum ratus sacra
publica ut ab Numa instituta erant facere, omnia ea ex commentariis regiis pontificem in album elata
proponere in publico iubet.
32. Morto Tullo, lo stato (questa ormai era una istituzione) ritornò in mano ai senatori i quali
nominarono un interré. Costui indisse i comizi durante i quali il popolo fece re Anco Marzio; i
senatori ratificarono. Anco Marzio era nipote di Numa Pompilio, figlio di una sua figlia. Egli,
fin dagli inizi del suo regno, si dimostrò memore dei titoli di merito dell'avo: siccome il regno
del suo predecessore, validissimo in tutto il resto, in un aspetto era stato poco attento e
fortunato (aveva cioè trascurato i riti religiosi o li aveva mal organizzati), giudicò che si
dovessero mettere in primo piano le antiche cerimonie pubbliche secondo la liturgia stabilita
da Numa. Ordina dunque al pontefice di riproporle al pubblico esponendole all'albo e
traendole direttamente dai libri sacri del re.
Trad. Mazzocato
Prelevare un mese diverso da febbraio o da aprile
Bibliografia
Il testo dei Fasti Antiates in ILLRP 9
I. Calabi Limentani, Epigrafia latina, Milano, 19733, p. 395.
Da utilizzare
The calendar of Republican Rome is represented by the fragmented Fasti Antiates. In the reconstruction
below, the abbreviated names of the months are arranged across the top, preceded by the letter K
(Kalendae), and the days listed vertically below, each represented by a recurring cycle of letters A through H,
every ninth day, counting inclusively, being identified as a market day, nundinae, which was painted in red
(whence a "red-letter day"). The intercalatory days of Intercalaris can be seen as the thirteenth month.
Besides these nundinal letters, the religious significance of the days was identified, either as dies fasti,
indicated by an additional letter (F) in the calendar on which business could be transacted and the courts
were open; dies comitiales (C), on which public assemblies (comitia) could be convened to vote on
legislation, in elections or verdicts; and dies nefasti (N), when neither legal business nor assemblies were
permitted. In another column, the name of the day was given, whether the Kalends, Nones, or Ides, or the
name of the festival day. Finally, at the bottom of the column, the number of days in the month were
indicated. Some days also had a notation in smaller letters, such as the name of a divinity or ludi to note
games held in honor of the gods.
Other letter designations identified days about which less is known. NP probably abbreviated nefastus
publicus and designated public holidays. EN (endotercisus) identified those days that were divided between
the morning and evening, which were nefastus, and the afternoon, which was fastus. There also were days,
although not identified as such in the calendar, in which activity either was restricted in some way (dies
religiosi), avoided altogether as unlucky (dies atri), or, if following the Kalends, Nones, and Ides (dies
postriduani), tainted by historical association, such as Rome's historic defeat by the Gauls.
Among the dies nefasti were counted the dies feriae (holy days or holidays), a word which, although plural in
form (like Kalendae and Nonae), applied to a single day and comprised both private celebrations, such as
birthdays and days of mourning, as well as religious festivals, such as the Lupercalia or Saturnalia. These
public holidays included annual festivals, for which the dates were fixed; movable feasts, which were
determined every year by the pontiffs; and days proclaimed in times of national crisis or to celebrate a great
victory. The days on which feriae were celebrated were dies festi. Religious rites were performed and
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
215
lawsuits prohibited, and there was an opportunity for rest, even for slaves. Although not holidays,
themselves, ludi or public games also were celebrated then.
Listing the dies fasti and dies nefasti when legal business could or could not be conducted, the calendar was
jealously guarded by the pontiffs. Indeed, it was not publicly displayed until 304 BC, when Gnaeus Flavius
had a calendar erected in the Forum. The first son of a freedman to be elected aedile, he also published the
forms of legal procedure (legis actiones), thereby marking the transition from an oral to a written legal
system. Traditionally, the calendar for the month was announced by the pontiff at the first quarter of the
moon. In time, it must have been easier to declare these monthly proclamations in writing and, eventually, to
record them as a complete calendar in stone.
Painted in red and black letters on white plaster, the Fasti Antiates Majores is the only Roman calendar to
date from the Republic. All others are from the time of Augustus and Tiberius, except for two later codex
calendars from the fourth and fifth centuries AD.
Altogether, more than forty calendars survive, some almost complete, others only in fragments. The largest
is the Fasti Praenestini, which measures approximately six by eighteen feet and is named after the town just
east of Rome, where it had been set up in the forum. Inscribed on marble and annotated by Verrius Flaccus,
who, after Varro, was the greatest scholar of the Augustan age, it probably was dedicated to the emperor,
possibly in celebration of Augustus' calendar reform, which took effect in AD 8.
That same year, Ovid was banished from Rome, his work on the Fasti, an account of the religious festivals of
the year, completed only for the first six months of the year. Ovid died in exile, but his own celebration of the
Roman calendar is a reminder of how intimately it reflected the religious, political, and social life of Rome.
Each date provided the poet an opportunity to celebrate the legends and history of Rome, its festivals and
sacred rites, and to evoke elements of the past and link them to the present.
Fasti
I fasti consolari sono elenchi contenenti i nomi di consoli, censori, dittatori, magistri equitum e
tribuni militari di ciascun anno, con poche succinte notizie di avvenimenti relativi all'anno stesso.
Coprono, pur con lacune, il periodo che va dal 483 a.C. al 13 d.C..
Originariamente i fasti erano scolpiti in quattro edicole sulle pareti di un arco trionfale, dedicato ad
Augusto in occasione della battaglia di Azio, ampliato poi nel 19 a.C.
I fasti trionfali raccoglievano i nomi dei generali trionfatori, la data del trionfo e il nome del popolo o
del comandante vinto.
Il periodo è quello compreso tra il 753 a.C. e il 19 a.C., con lacune più o meno gravi.
Anche questi vennero inseriti nell'arco ad Augusto sopra ricordato nel corso del suo ampliamento
nel 19 a.C.
Bibliografia
I. Calabi Limentani, Epigrafia latina, Milano, 19733, pp. 405-10.
Fasti Capitolini, ed. A.Degrassi, Torino, Paravia, 1955.
ICCU per Soggetto (Ricolloca sotto Ovidio quanto di competenza)
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
216
Autore: Pais, Ettore <1856-1939>
Titolo: Fasti triumphales populi romani / editi ed illustrati da Ettore Pais
Pubblicazione: Roma : A. Nardecchia
Comprende: 1 : Testo e commento storico / Ettore Pais
2 : Appendici, indici e tavole / Ettore Pais
Nomi: Pais, Ettore <1856-1939>
Autore: Italia : Soprintendenza archeologica di Ostia
Titolo: I fasti ostienses : documento della storia di Ostia / Ministero per i beni culturali e ambientali,
Soprintendenza archeologica di Ostia ; [a cura di Barbara Bargagli, Cristiana Grosso]
Pubblicazione: [S.l. : s.n.], 1997 (Roma : Cristal)
Descrizione fisica: 77 p. : ill. ; 24 cm. , Collezione: Itinerari ostiensi
Autore: Radke, Gerhard
Titolo: Fasti romani : Betrachtungen zur Fruhgeschichte des romischen Kalenders / Gerhard Radke
Pubblicazione: Munster : Aschendorff, [1990] , Collezione: Orbis antiquus
Autore: Trulli, G.
Titolo: Le feste di Roma antica nel Calendario verolano
Pubblicazione: Terni : Tip. U. Marocchi, 1967
Soggetti: Fasti verulani
Autore: Manni, Eugenio
Titolo: Fasti ellenistici e romani (323-31 a. C.) / Eugenio Manni
Pubblicazione: Palermo : Banco di Sicilia. Fondazione per l'incremento economico culturale e turistico della
Sicilia Ignazio Mormino, stampa 1961 , Collezione: Supplementi a Kokalos
Soggetti: Fasti romani - 323-31 a. C.
Autore: Costa, Giovanni <n. 1875>
Titolo: I fasti consolari romani dalle origini alla morte di C. Giulio Cesare / Editi ed illustrati da Giovanni Costa
Edizione: Ed. anastatica
Pubblicazione: Roma : "L'Erma" di Bretschneider, 1971
Descrizione fisica: 2 v. ; 24 cm , Collezione: Studia juridica
Note Generali: Ripr. dell'ed. di Milano del 1910.
Numeri: Bibliografia Nazionale - 7210945
Comprende: 1: Le fonti : studio delle fonti ; le fonti :materiali per lo studio delle fonti /Giovanni Costa
Nomi: Costa, Giovanni <n. 1875>
Autore: Degrassi, Attilio
Titolo: I fasti consolari dell'Impero romano : dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo / Attilio Degrassi
Pubblicazione: Roma : Edizioni di storia e letteratura, 1952
Descrizione fisica: XVIII, 286 p. ; 26 cm. , Collezione: Sussidi eruditi
Autore: Manni, Eugenio
Titolo: Fasti ellenistici e romani : 323-31 a. C. / Eugenio Manni
Pubblicazione: Palermo : Banco di Sicilia, Fondazione I. Mormino, stampa 1961
Descrizione fisica: 153 p. ; 25 cm.
Fa parte di: Supplementi a Kokalos : studi pubblicati dall'Istituto di storia antica dell'Universita' di Palermo e
diretti da Eugenio Manni
Nomi: Manni, Eugenio
Soggetti: Fasti ellenistici - 323 a.c.-31 a.c.
Fasti romani - 323 a.c.-31 a.c.
Autore: Alfoldy, Geza
Titolo: Fasti Hispanienses : Senatorische Reichsbeamte und Offiziere in den Spanischen Provinzen des
Romischen Reiches von Augustus bis Diokletian / von Geza Alfoldy
Pubblicazione: Wiesbaden : F. Steiner, 1969
Soggetti: Fasti hispanienses - Sec. 1.-3.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
217
Fasti senatorii - Spagna - Sec. 1.-3.
Autore: Mora, Fabio
Titolo: Fasti e schemi cronologici : la riorganizzazione annalistica del passato remoto romano / Fabio Mora
Pubblicazione: Stuttgart : Steiner, 1999
Descrizione fisica: 389 p., [36] p. di tav. : ill. ; 24 cm. , Collezione: Historia. Einzelschriften
Autore: Herbert-Brown, Geraldine
Titolo: Ovid and the Fasti : an historical study / Geraldine Herbert-Brown
Pubblicazione: Oxford : Clarendon Press, 1994 , Collezione: Oxford classical monographs
Autore: Riedl, Rita
Titolo: Mars ultor in Ovids Fasten / von Rita Riedl
Pubblicazione: Amsterdam : Gruner, 1989 , Collezione: Heuremata
Autore: Porte, Danielle
Titolo: L' etiologie religieuse dans les Fastes d'Ovide / par Danielle Porte
Pubblicazione: Paris : Les belles lettres, 1985 , Collezione: Collection d'etudes anciennes
Autore: Newlands, Carole Elizabeth
Titolo: Playing with time : Ovid and the Fasti / Carole E. Newlands
Pubblicazione: Ithaca ; London, 1995 , Collezione: Cornell studies in classical philology
Autore: Merli, Elena
Titolo: Arma canant alii : materia epica e narrazione elegiaca nei Fasti di Ovidio / Elena Merli
Pubblicazione: Firenze : Universita degli studi, Dipartimento di scienze dell'antichita Giorgio Pasquali, [2000]
, Collezione: Studi e testi
Nomi: Merli, Elena
Autore: Gee, Emma
Titolo: Ovid, Aratus and Augustus : astronomy in Ovids Fasti / Emma Gee
Pubblicazione: Cambridge : Cambridge university press, 2000 , Collezione: Cambridge classical studies
Autore: Miller, John F.
Titolo: Ovids elegiac festivals : studies in the "Fasti" / John F. Miller
Pubblicazione: Frankfurt am Main [etc.] : P. Lang, c1991 , Collezione: Studien zur klassischen Philologie
Autore: Prescendi, Francesca
Titolo: Fruhzeit und Gegenwart : eine Studie zur Auffassung und Gestaltung der Vergangenheit in Ovids
Fastorum libri / Francesca Prescendi
Pubblicazione: Frankfurt am Main, etc. , Collezione: Studien zur klassischen Philologie
Autore: Le Bonniec, Henri
Titolo: Etudes ovidiennes : introduction aux "Fastes" d'Ovide / Henri Le Bonniec
Pubblicazione: Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, c1989 , Collezione: Studien zur klassischen Philologie
Riposati
e) i F a s t i: costituivano, insieme con gli annales, I'opera piú importante dei collegi sacerdotali, anzi degli
stessi pontefici, ai quali spettava redigere le memorie piú insigni deAla storia intema di Roma.
I Fasti fissavano il calendario della vita pubblica e religiosa romana: stabilivano, cioè, secondo un'inveterata
tradizione religiosa, quali fossero i giomi, in cui era lecito (dies fasti) o vietato (lies nefasti) trattare la pubblica
giustizia e il disbrigo degli affari comuni(2). Non c'era perciò attività pubblica, come cerimonie religiose,
giòchi, mercati, spettacoli, ecc., che non venisse regolata e disciplinata dal calendario romano. I giomi
"fasti)> venivano indicati con F, i " nefasti)t con N.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
218
II nome si estese ben presto a designare anche liste annuali di magistrature (Fasti consulares), di sacerdozi
(Fasti sacerdotales), oppure an notazioni di trionfi o di fatti rari e di avvenimenti insigni (Fasti trium, phales). I
Fasti Capitolini (cosí detti, perché conservati in scarsi reperti di pietra nel Campidoglio) contenevano anche
nomi di consoli, di dittatori, dl censon e di magistri equitum: materiale tutto di importanza capitale per l'awío
della storiografia di Roma;
Annales
Di riferimento fondamentale per la tradizione consolidata fin dalle origini di annotare in documenti
pubblici i fatti occorsi la testimonianza di Cic. (de orat, 2,52):
“La storia infatti non era altro che una compilazione di annali; per questo, affinché si conservasse il
ricordo di ogni pubblico avvenimento, dall'inizio dello Stato romano fino al pontificato di P. Mucio, il
pontefice massimo registrava tutti gli avvenimenti di ogni singolo anno, trascrivendoli su una tavola
bianca, che esponeva nella sua casa, perché il popolo potesse prenderne visione. Sono gli annali
che anche oggi vengono chiamati Massimi.”
Fu quindi il pontefice Publio Muzio Scevola che, intorno al 123 a.C. decise di far trascrivere e
pubblicare con il nome di Annales Maximi in ottanta libri il materiale archivistico raccolto dal
pontefice massimo anno per anno e affisso in casa sua perché ognuno potesse prenderne visione.
[Bettini 1,35]
I resoconti del pontefice raccoglievano informazioni sui nomi dei consoli dell’anno e sui fatti degni
di nota occorsi nel corso dell’anno stesso.
A confermarlo è Servio (auctus) nel commento all’Eneide (Serv. Auct, ad Verg.Aen. 1,373)
I materiali raccolti negli Annales maximi costituirono la base del lavoro di quelli che in senso più o
meno lato vengono definiti “annalisti” e di cui si parla più avanti nel capitolo Gli annalisti.
Testi e testimonianze
Cic., de orat., 2, 51-53
'Age vero,' inquit Antonius 'qualis oratoris et quanti hominis in dicendo putas esse historiam scribere?' 'Si, ut
Graeci scripserunt, summi,' inquit Catulus; 'si, ut nostri, nihil opus est oratore; satis est non esse mendacem.'
'Atqui, ne nostros contemnas,' inquit Antonius, 'Graeci quoque ipsi sic initio scriptitarunt, ut noster Cato, ut
Pictor, ut Piso; erat enim historia nihil aliud nisi annalium confectio, cuius rei memoriaeque publicae
retinendae causa ab initio rerum Romanarum usque ad P. Mucium pontificem maximum res omnis
singulorum annorum mandabat litteris pontifex maximus referebatque in album et proponebat tabulam domi,
potestas ut esset populo cognoscendi, eique etiam nunc annales maximi nominantur. Hanc similitudinem
scribendi multi secuti sunt, qui sine ullis ornamentis monumenta solum temporum, hominum, locorum
gestarumque rerum reliquerunt; itaque qualis apud Graecos Pherecydes, Hellanicus, Acusilas fuit aliique
permulti, talis noster Cato et Pictor et Piso, qui neque tenent, quibus rebus ornetur oratio–modo enim huc
ista sunt importata–et, dum intellegatur quid dicant, unam dicendi laudem putant esse brevitatem. Paulum se
erexit et addidit maiorem historiae sonum vocis vir optimus, Crassi familiaris, Antipater; ceteri non
exornatores rerum, sed tantum modo narratores fuerunt.' 'Est,' inquit Catulus 'ut dicis; sed iste ipse Caelius
neque distinxit historiam varietate colorum neque verborum conlocatione et tractu orationis leni et aequabili
perpolivit illud opus; sed ut homo neque doctus neque maxime aptus ad dicendum, sicut potuit, dolavit; vicit
tamen, ut dicis, superiores.' 'Minime mirum,' inquit Antonius 'si ista res adhuc nostra lingua inlustrata non est;
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
219
nemo enim studet eloquentiae nostrorum hominum, nisi ut in causis atque in foro eluceat; apud Graecos
autem eloquentissimi homines remoti a causis forensibus cum ad ceteras res inlustris tum ad historiam
scribendam maxime se applicaverunt.
"Dunque " continuò Antonio, "non ti pare che scrivere un'opera storica sia còmpito di un oratore
valente ed espertissimo nell'arte del dire?" E Catulo rispose: "Per scriverla alla maniera dei Greci,
bisogna proprio essere un sommo oratore; per scriverla alla maniera nostra, non occorre alcuna
abilità oratoria: basta saper dire la verità". "Ma non è giusto" disse Antonio, "disprezzare i nostri
autori, perché anche gli storici greci agli inizi componevano le loro opere come i nostri Catone,
Pittore e Pisone. [52] La storia infatti non era altro che una compilazione di annali; per questo,
affinché si conservasse il ricordo di ogni pubblico avvenimento, dall'inizio dello Stato romano fino
al pontificato di P. Mucio, il pontefice massimo registrava tutti gli avvenimenti di ogni singolo anno,
trascrivendoli su una tavola bianca, che esponeva nella sua casa, perché il popolo potesse
prenderne visione. Sono gli annali che anche oggi vengono chiamati Massimi. [53] Questa maniera
di scrivere è stata imitata da molti scrittori, che ci hanno tramandato il ricordo di epoche,
personaggi, luoghi e imprese in opere composte senza alcun ornamento stilistico. Come i Grecì
ebbero Ferecide, Ellanico, Acusilao e moltissimi altri, così noi abbiamo avuto Catone, Pittore e
Pisone: costoro non conoscevano l'arte di abbellire il discorso, perché da poco essa è stata
introdotta nel nostro paese, e consideravano la concisione unita alla chiarezza l'unico pregio
dell'arte del dire. [54] Un intimo amico di Crasso, Antipatro, uomo di grande talento, si è innalzato
un poco sugli altri, dando un certo lustro alla storia: tutti gli altri non hanno pensato ad abbellire i
fatti, limitandosi solo a narrarli". "E' proprio così" disse Catulo, "ma lo stesso Celio non seppe
adornare la sua opera storica con la varietà degli abbellimenti, né seppe levigarla con la felice
collocazione delle parole e con uno stile dolce e costante. Da uomo poco istruito e poco idoneo
all'arte del dire egli l'ha sgrossata come meglio ha potuto: però, come tu giustamente dici, ha
superato gli storici anteriori". [55] "Non mi meraviglio affatto" disse Antonio, "dal momento che
nessuno finora ha scritto un'opera storica in lingua latina con intendimento artistico. Nel nostro
paese nessuno studia eloquenza, eccettuati coloro che vogliono brillare nelle cause del foro:
presso i Greci, invece, uomini eloquentissimi, del tutto estranei alle cause del foro, coltivarono sia
la storia sia le altre nobili arti.
Traduzione di G. Norcio, Torino, Utet, 1976
Serv., in Verg.Aen., 1, 373
Annales inter historiam et annales hoc interest: historia est eorum temporum quae vel vidimus vel videre
potuimus, dicta ¢pÕ toà ƒstore‹n, id est videre; annales vero sunt eorum temporum, quae aetas nostra non
novit: unde Livius ex annalibus et historia constat. haec tamen confunduntur licenter, ut hoc loco pro historia
inquit 'annales'. ita autem annales conficiebantur: tabulam dealbatam quotannis pontifex maximus habuit, in
qua praescriptis consulum nominibus et aliorum magistratuum digna memoratu notare consueverat domi
militiaeque terra marique gesta per singulos dies. cuius diligentiae annuos commentarios in octoginta libros
veteres retulerunt, eosque a pontificibus maximis a quibus fiebant annales maximos appellarunt: unde
quidam ideo dictum ab Aenea 'annales' aiunt, quod et ipse religiosus sit et a poeta tum pontifex inducatur.
Bibliografia
M. Chassignet, L’annalistique Romaine, I, Les annales des Pontifes, L’annalistique ancienne, Paris
1996, pp. XXIII-XLII e 1-16.
B.W. Frier, Libri annales Pontificum Maximorum, Papers and Monographs of the American
Academy in Rome XXVII, Rome 1979.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
220
B.W. Frier, Roman Historiography from the Annales Maximi to Cato Censorius, Princeton
University, Ph.D., 1970.
Riposati
f) gli Annales: paralleli ai fasti, e affidati anch'essi alla compilazione dei pontefici, erano gli annales, i quali
raccoglievano la cronaca degli avvenimenti piú importanti e memorabili, che il pontefice massimo segnava
su una tavola bianca (album) sotto i nomi dei consoli e degli altri magistrati, ed esponeva al principio di ogni
anno davanti alla sua casa, perché il pubblico ne prendesse visione.
Imprese guerresche per terra e per mare, fatti di vita civile e religiosa, celebraziòne di riti e cerimonie
sacerdotali, fenomeni astronomici come eclissi di luna e di sole, pestilenze, carestie, terremoti, alluvioni e
prodlgi, quanto insomma poteva interessare la vita interna ed esterna di Roma, tutto passava davanti alla
curiosità del pubblico attraverso questa veneranda cronaca pontificale, antica quanto la stessa Roma.
L'accumularsi dell'ingente materiale consigliò il pontefice P. Mucio Scevola, circa i1 123 a C., a
raccoglierlo in 80 grossi volumi, che, per la grandezza e per l'importanza del contenuto, furono detti Annales
Maximi: il primo abbozzo di prosa narrativa, le prime fonti sistematiche della storiografia romana, da cui
trassero a piene mani gli annalisti posteriori.
Spettacoli e manifestazioni teatrali preletterarie
Chiarire natura ufficiale di alcune manifestazioni, con organizzazione in occasione di solennità
pubbliche e consapevolezza delle classi elevate, almeno per spettacoli tragici, di celebrazione di
antenati, e per spettacoli comici, con controllo di attacchi personali, come suggerisce il caso di
Nevio (Conte, Il libro della lett. 2000, p. 13 ) .
Ricordare creazione di collegium scribarum histrionumque e figura del dominus gregis.
I poeti dell’età arcaica scrivono tutti (anche) per il teatro.
Tutti i principali generi teatrali romani sono di importazione greca.
Commedie e tragedie sono ambientate in Grecia, i nomi dei personaggi sono in greco, i modelli
precisi sono greci.
Chiarire termini e rapporti con forme letterarie successive
Per la commedia di ambientazione greca, palliata, di ambientazione romana togata; per la tragedia
di ambientazione greca, cothurnata o crepidata , di ambientazione romana praetexta , con relative
etimologie.
I Fescennini versus
Con questo termine si indicano canti rustici improvvisati in occasione di feste per raccolti o per
altre occasioni legate alla vita rurale. Le testimonianze forse più significative ci arrivano da Livio e
Orazio.
Si è discusso sull’etimologia del termine: una prima ipotesi riporterebbe a Fescennia o
Fescennium, cittadina dell’Etruria, identificabile con l’attuale Corchiano in provincia di Viterbo;
Una seconda ipotesi riporterebbe a fascinum, malocchio, e confermerebbe la funzione apotropaica
dei canti stessi.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
221
I canti, in versi rustici che potrebbero essere saturni, erano accompagnati da danze e suono di
flauto e altri strumenti.
L’usanza si diffuse anche nella città e acquisì una aggressività sempre maggiore, fino a indurre
anche la reazione testimoniata da un testo delle Dodici tavole e una relativa autocensura.
Il tipo di licenza prevedibile in occasioni e componimenti del genere è rapportabile a quello che si
riscontrava in occasione di trionfi e soprattutto di matrimoni. Non a caso le tracce letterarie più
significative di ciò che furono i versi fescennini possono essere identificate in Catullo, epitalàmio di
Manlio Torquato e Vinia Aurunculeia (carme 61), in Claudiano (I'epitalàmio per le nozze
dell'Imperatore Onorio) e anche in Seneca (coro nuziale di Giàsone e Creúsa, in Medea), ma
evidentemente lo spirito mordace di tali canti lasciò influssi, assieme all’Atellana, anche nella
Commedia.
Testi e testimonianze
CASTIGLIONI MARIOTTI
fascinum, i, n. o fascinus, i, m.,
1 malia, incantesimo, stregoneria, maleficio, malocchio: fescennina fascinum putabantur arcere, si
pensava che i fescennini tenessero lontano il malocchio, P. FEST.;
2 membro virile, usato come simbolo contro stregonerie e malie, HOR.; personif., Fascinus, i, m. =
Phallus, PLIN.
[cf. gr. báskanos].
1. Fescennia, ae, f.,
Fescennio, città dell'Etruria sul Tevere, ove fiorirono i canti fescennini, PLIN. e a.
2. Fescennia, ae, f.,
Fescennia, nome proprio di donna, MART.
Fescenninus, a, um, agg.,
fescennino, di Fescennio: F. versus, versi fescennini, LIV.; simile ai versi fescennini, impudico,
licenzioso: licentia F., licenza dei versi fescennini, impudica, HOR.; sost. m. pl. Fescennini, orum o
n. pl. Fescennina, orum, i fescennini, MACR., MART. CAP., HIER.; Fescenninus, i, m., scrittore di
libelli, CAT.
Hor., epist., 2,1,139-155. Origine e storia dei fescennini.
Agricolae prisci, fortes parvoque beati,
condita post frumenta levantes tempore festo
corpus et ipsum animum spe finis dura ferentem
cum sociis operum et pueris et coniuge fida
Tellurem porco, Silvanum lacte piabant,
floribus et vino Genium memorem brevis aevi.
Fescennina per hunc inventa licentia morem
versibus alternis opprobria rustica fudit,
libertasque recurrentis accepta per annos
lusit amabiliter, donec iam saevos apertam
in rabiem coepit verti iocus et per honestas
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
222
ire domos inpune minax. doluere cruento
dente lacessiti; fuit intactis quoque cura
condicione super communi; quin etiam lex
poenaque lata, malo quae nollet carmine quemquam
describi: vertere modum, formidine fustis
ad bene dicendum delectandumque redacti.
Anticamente i contadini, uomini quadrati, felici della loro sobrietà,
dopo la raccolta del frumento riposavano, in giorni festivi,
non solo il corpo ma pure lo spirito, reso tenace dall'attesa della festa.
Si riunivano insieme ai figli e alla fedele sposa, compagni di fatica,
offrendo in sacrificio alla terra un maiale, a Silvano un po' di latte
e al Genio, consapevole della brevità del tempo, fiori e vino.
Da questa usanza nacque la spavalderia dei cosiddetti "fescennini":
una poesia che in versi alterni spargeva invettive rusticane.
Anno dopo anno quella libertà gradita giocò
le sue spassose carte, finchè però i suoi scherzi, divenuti ormai
pesanti, si tradussero in aperta virulenza e quelle ingiurie
cominciarono a infiltrarsi impunemente in case signorili. Le vittime
si dolsero del morso sanguinoso, ma anche chi rimase immune
si preoccupò del danno per la società; venne varata, anzi, una legge,
comminata una pena che vietava di prendere di mira
gli individui; ed ecco i fescennini mutarono registro: per timore
del bastone assunsero uno spirito festevolo e bonario.
Traduzione di M. Beck, Milano, Mondadori, 1997.
Liv., 7,2,1
Et hoc et insequenti anno C. Sulpicio Petico C. Licinio Stolone consulibus pestilentia fuit. eo nihil dignum
memoria actum, nisi quod pacis deum exposcendae causa tertio tum post conditam urbem lectisternium fuit;
et cum uis morbi nec humanis consiliis nec ope diuina leuaretur, uictis superstitione animis ludi quoque
scenici–noua res bellicoso populo, nam circi modo spectaculum fuerat–inter alia caelestis irae placamina
instituti dicuntur; ceterum parua quoque, ut ferme principia omnia, et ea ipsa peregrina res fuit. sine carmine
ullo, sine imitandorum carminum actu ludiones ex Etruria acciti, ad tibicinis modos saltantes, haud indecoros
motus more Tusco dabant. imitari deinde eos iuuentus, simul inconditis inter se iocularia fundentes uersibus,
coepere; nec absoni a uoce motus erant. accepta itaque res saepiusque usurpando excitata. uernaculis
artificibus, quia ister Tusco uerbo ludio uocabatur, nomen histrionibus inditum; qui non, sicut ante,
Fescennino uersu similem incompositum temere ac rudem alternis iaciebant sed impletas modis saturas
descripto iam ad tibicinem cantu motuque congruenti peragebant.
2. La pestilenza durò anche nell'anno successivo durante il quale furono consoli Gaio
Sulpicio Petico e Licinio Stolone. Non avvenne nulla di rimarchevole, tranne il fatto che s i
tenne un lettisternio (ed era la terza volta, dalla fondazione di Roma, che questo avveniva)
per riottenere il favore degli dèi. Tuttavia la violenza del morbo non era attenuata né da
provvedimenti umani né dall'aiuto divino e gli animi erano soggetti ad ogni forma di
superstizione: fu allora che per la prima volta (una novità per un popolo abituato alla guerra e
avvezzo soltanto agli spettacoli circensi) furono organizzati degli spettacoli teatrali, uno dei
tentativi di placare l'ira degli dèi. Si trattò di spettacoli di modesto significato (quasi sempre
così funzionano le cose ai loro inizi) e per di più importati da fuori. Dei ballerini fatti venire
dall'Etruria, danzando al suono del flauto, offrivano uno spettacolo non indecoroso su
musiche etrusche: non c'erano testi poetici da seguire e dunque nemmeno gesti con cui
mimare quei testi. I primi ad imitarli furono i giovani che presero a scambiarsi delle battute
costruite su rozzi versi e accompagnando con una particolare gestualità le loro parole.
Questo modo di fare fu dunque recepito e, ripetuto in più occasioni, divenne abituale. Gli
attori locali furono chiamati istrioni (da ister, che è il termine etrusco per designare gli attori):
costoro passarono presto dalle grossolane composizioni simili ai versi Fescennini, piuttosto
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
223
improvvisate e rozze, a delle sature, costruite con molti metri diversi, che eseguivano con un
canto precedentemente adattato all'accompagnamento di un flauto e con danze fatte apposta
per sottolineare il canto.
Tr. Mazzocato
Catull., 61, 119-157
ne diu taceat procax
Fescennina iocatio,
nec nuces pueris neget
desertum domini audiens
concubinus amorem.
da nuces pueris, iners
concubine! satis diu
lusisti: nucibus iuvet
iam servire Talassio.
concubine, nuces da.
sordebant tibi vilicae,
concubine, hodie atque heri:
nunc tuum cinerarius
tondet os. miser ah miser
concubine, nuces da.
diceris male te a tuis
unguentate glabris marite
abstinere, sed abstine.
io Hymen Hymenaee io,
io Hymen Hymenaee.
scimus haec tibi quae licent
soli cognita, sed marito
ista non eadem licent.
io Hymen Hymenaee io,
io Hymen Hymenaee.
nupta, tu quoque, quae tuus
vir petet, cave ne neges,
ni petitum aliunde eat.
io Hymen Hymenaee io,
io Hymen Hymenaee.
en tibi domus ut potens
et beata viri tui!
quae tibi sine serviat–
io Hymen Hymenaee io,
io Hymen Hymenaee–
usque dum tremulum movens
cana tempus anilitas
omnia omnibus adnuit.
Trad. dell’intero carme 61
O del colle d'Elicona abitatore, figlio della celeste Musa, che rapisci la tenera vergine per darla al
marito, oh, Imeneo Imene, oh, Imene Imeneo, cingi le tempie dei fiori dell'odorosa maggiorana,
prendi il velo color fiamma, giulivo qua vieni, qua, il niveo piede calzato nel giallo socco, e brioso
nel felice giorno con noi cantando i nuziali canti con voce argentina, batti in cadenza il suolo, nella
mano agita la fiaccola di pino. Ché Vinia a Alanlio, quale dal bosco Idalio venne al giudice frigio
Venere, buona vergine con buono augurio, si sposa, brillante come nei prati asii mirto coi suoi
ramoscelli in fiore, che le dee degli alberi per loro delizia nutrono con l'umore della rugiada. Suvvia,
per volgere il passo in qua lascia subito le aonie grotte della montagna di Tespie, cui dall'alto
sgorgando irriga la fresca fonte d'Aganippe, e alla sua casa la padrona di casa chiama, l'anima,
desiosa del novello sposo, legandole d'amore a più doppi, come la tenace edera qua e là errando
avvinghia il tronco.
E voi anche, in coro, o pure vergini, alle quali s'avvicina un giorno come questo, in cadenza dite o
Oh, Imeneo Imene, oh, Imene Imeneo o, perché più volentieri, sentendosi chiamare e chiamare al
suo ufficio, qui rivolga il passo egli che conduce la buona Venere, egli che congiunge il buon
amore.
A quale dio dovranno rivolgersi con maggior fiducia gli amati amanti? quale dei celesti onoreranno
con maggior venerazione gli uomini? –
[CORO] Oh, Imeneo Imene, oh, Imene Imeneo! - Te per i suoi il tremulo padre invoca; in grazia tua
le vergini liberano dalla cintura la veste; te, in ansia, con orecchio cupido di sentire il tuo grido,
attende il marito novello; tu al fiero giovane dài in potere, tu, la fanciulla in fiore, tolta dal grembo
della sua mamma. –
[CORO] Oh, Imeneo Imene, oh, Imene Imeneo! - Nessun piacere, senza te, Venere, cui buona
fama approvi, può prendere: ma può, se tu vuoi. Chi a questo dio oserà paragonarsi? Nessuna
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
224
famiglia, senza te, ha modo d'aver figli legittimi, nessun padre d'appoggiarsi ai suoi rampolli: ma
può, se tu vuoi. –
[CORO] Chi a questo dio oserà paragonarsi? - La terra che dei tuoi riti sia priva non avrà modo di
dar difensori alle sue province: ma avrà modo, se tu vuoi. –
[CORO] Chi a questo dio, oserà paragonarsi? IMENEO: INVITO ALLA SPOSA
Le sbarre! spalancate la porta! La vergine è là. Vedi come le fiaccole squassano la chioma di luce.
Ma indugia. Se n'è andato il giorno: vieni fuori, sposa novella, e non voltarti a riguardare la casa
ch'era tua, e i tuoi piedi non tardi pudore di vergine. Pure vuol dargli ascolto, e piange, perché è
necessario partire. Non pianger più. Per te, Aurunculeia, non c'è pericolo che altra donna più bella
sereno dall'Oceano il giorno abbia visto sorgere: come te, nel giardino pieno di colori d'un ricco
signore, sta diritto un fiore di giacinto. Ma indugi. Se n'è andato il giorno. –
[CORO] Vieni fuori, sposa novella! - Vieni fuori, sposa novella, se ormai ti pare, e ascolta le nostre
parole. Vedi, le fiaccole squassano la chioma d'oro. - ,
[CORO] Vieni fuori, sposa novella! - No: non, volubile, il tuo marito dedito a malvagia adultera,
perdendosi in vergognosi disordini, vorrà mai addormentarsi lontano dalle tue giovani poppine;
anzi come la flessuosa vigna avvinghia gli alberi piantati vicino, s'avvinghierà nel tuo abbraccio.
Ma se n'è andato il giorno. –
[CORO] Vieni fuori, sposa novella! - Oh letto, in cui Venere ogni seduzione compose, è presso il
momento, che toccherà ella le coltri, stese sul fusto intarsiato d'avorio, col candido piede: quali si
preparano al tuo padrone e quanto grandi gioie, da godere nella troppo breve notte e a mezzo del
giorno! Ma se n'è andato il giorno. –
[CORO] Vieni fuori, sposa novella! - Alzate, ragazzi, le fiaccole: vedo venire il velo di fiamma. Sù,
con noi cantate in cadenza “Viva, Imene Imeneo, viva!” [CORO] Viva, Imene Imeneo! FESCENNINI
Non tacciano a lungo i procaci scherzi fescennini ; e le noci ai ragazzi non neghi il mignone,
sentendo che il padroncino ha disertato il suo amore. Da' le noci ai ragazzi, disoccupato mignone :
abbastanza a lungo hai giocato con le noci: ora s'è deciso che tu serva a Talassio. –
[CORO] Mignone, da' le noci! - Schifavi le villane, mignone, oggi e ieri; ora quello che ti faceva i
riccioli te li tosa. Ahi, povero, povero –
[CORO] mignone, da' le noci! - Si dice che mal volentieri t'astieni, o profumato sposo, dai tuoi
depilati. Ma astienti! Viva, Imene Imeneo, viva! –
[CORO] Viva, Imene Imeneo! - Sappiamo che le sole cose che sono lecite praticavi. Ma a uno
sposo codeste stesse non sono lecite. –
[CORO] Viva, Imene Imeneo, viva, viva, Imene Imeneo! - Sposa, anche tu, ciò che il tuo marito
chiederà, bada non rifiutargli, che non vada a chiederlo altronde. –
[CORO] Viva, Imene Imeneo, viva, viva, Imene Imeneo! Eccoti la casa, e come potente e come ricca, del tuo marito: permetti che sia ai tuoi ordini, [CORO] Viva, Imene Imeneo, viva, viva, Imene Imeneo! - fino agli anni che la bianca vecchiaia,
movendo le tremule tempie, dice di sì, in tutto, a tutti. –
[CORO] Viva, Imene Imeneo, viva, viva, Imene Imeneo! - Poni oltre la soglia, è buon segno, i
piedini calzati d'oro: entra dalla liscia porta. –
[CORO] Viva, Imene Imeneo, viva, viva, Imene Imeneo! - Vedi, di là c'è un convitato, uno solo: è
tuo marito, che dal cuscino di porpora tutto si protende verso te. –
[CORO] Viva
Trad. G.B.Pighi, Il libro di Catullo e i frammenti dei poetae novi, Torino, Utet, 1974 (rist. 1986)
[Canova]
Sen., Medea, 56-115. Coro nuziale di Giàsone e Creúsa.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
Chorvs - Ad regum thalamos numine prospero
qui caelum superi quique regunt fretum
adsint cum populis rite fauentibus.
Primum sceptriferis colla Tonantibus
taurus celsa ferat tergore candido;
Lucinam niuei femina corporis
intemptata iugo placet, et asperi
Martis sanguineas quae cohibet manus,
quae dat belligeris foedera gentibus
et cornu retinet diuite copiam,
donetur tenera mitior hostia.
Et tu, qui facibus legitimis ades,
noctem discutiens auspice dextera
huc incede gradu marcidus ebrio,
praecingens roseo tempora uinculo.
Et tu, quae, gemini praeuia temporis,
tarde, stella, redis semper amantibus:
te matres, auide te cupiunt nurus
quamprimum radios spargere lucidos.
Vincit uirgineus decor
longe Cecropias nurus,
et quas Taygeti iugis
exercet iuuenum modo
muris quod caret oppidum,
et quas Aonius latex
Alpheosque sacer lauat.
Si forma uelit aspici,
cedent Aesonio duci
proles fulminis improbi
aptat qui iuga tigribus,
nec non, qui tripodas mouet,
frater uirginis asperae,
cedet Castore cum suo
Pollux caestibus aptior.
Sic, sic, caelicolae, precor,
uincat femina coniuges,
uir longe superet uiros.
Haec cum femineo constitit in choro,
unius facies praenitet omnibus.
sic cum sole perit sidereus decor,
et densi latitant Pleiadum greges,
cum Phoebe solidum lumine non suo
orbem circuitis cornibus alligat.
ostro sic niueus puniceo color
perfusus rubuit, sic nitidum iubar
pastor luce noua roscidus aspicit.
Ereptus thalamis Phasidis horridi,
effrenae solitus pectora coniugis
inuita trepidus prendere dextera,
felix Aeoliam corripe uirginem
nunc primum soceris sponse uolentibus.
Concesso, iuuenes, ludite iurgio,
hinc illinc, iuuenes, mittite carmina:
rara est in dominos iusta licentia.
Candida thyrsigeri proles generosa Lyaei,
multifidam iam tempus erat succendere pinum:
excute sollemnem digitis marcentibus ignem.
festa dicax fundat conuicia fescenninus,
soluat turba iocos–tacitis eat illa tenebris,
si qua peregrino nubit furtiua marito.
Traduzione di Seneca
Claud., carm. 11. Epitalàmio per le nozze dell'Imperatore Onorio
I.
Princeps corusco sidere pulchrior
Parthis sagittas tendere certior,
eques Gelonis imperiosior,
quae digna mentis laus erit arduae?
Quae digna formae laus erit igneae?
Te Leda mallet quam dare Castorem;
praefert Achilli te proprio Thetis;
Venus reversum spernit Adonidem;
damnat reductum Cynthia Virbium;
victum fatetur Delos Apollinem;
credit minorem Lydia Liberum.
Tu cum per altas inpiger ilices
praeda citatum cornipedem reges
ludentque ventis instabiles comae,
telis iacebunt sponte tuis ferae
gaudensque sacris vulneribus leo
admittet hastam morte superbior.
Cum post labores sub platani voles
virentis umbra vel gelido specu
torrentiorem fallere Sirium
et membra somno fessa resolveris,
o quantus uret tum Dryadas calor!
F. D’Alessi © 2002
Quot aestuantes ancipiti gradu
furtiva carpent oscula Naides!
Quis vero acerbis horridior Scythis,
quis beluarum corde furentior,
qui, cum micantem te prope viderit,
non optet ultro servitium pati,
qui non catenas arripiat libens
colloque poscat vincula libero?
Tu si nivalis per iuga Caucasi
saevas petisses pulcher Amazonas,
peltata pugnas desereret cohors
sexu recepto; patris et inmemor
inter frementes Hippolyte tubas
strictam securim languida poneret
et seminudo pectore cingulum
forti negatum solveret Herculi
bellumque solus conficeret decor.
Beata, quae te mox faciet virum
primisque sese iunget amoribus.
II.
225
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
Age cuncta nuptiali
redimita vere tellus
celebra toros eriles;
omne nemus cum fluviis,
omne canat profundum.
Ligures favete campi,
Veneti favete montes,
subitisque se rosetis
vestiat Alpinus apex
et rubeant pruinae.
Athesis strepat choreis
calamisque flexuosus
leve Mincius susurret
et Padus electriferis
admoduletur alnis.
Epulisque iam repleto
resonet Quirite Thybris
dominique laeta votis
aurea septemgeminas
Roma coronet arces.
Procul audiant Hiberi,
fluit unde semen aulae,
ubi plena laurearum
imperio feta domus
vix numerat triumphos.
Habet hinc patrem maritus,
habet hinc puella matrem,
geminaque parte ductum
Caesareum flumineo
stemma recurrit ortu.
Decorent virecta Baetin,
Tagus intumescat auro,
generisque procreator
sub vitreis Oceanus
luxurietur antris.
Oriensque, regna fratrum,
simul Occidensque plaudat;
placidae iocentur urbes,
quaeque novo quaeque nitent
deficiente Phoebo.
Aquiloniae procellae,
rabidi tacete Cori,
taceat sonorus Auster.
Solus ovantem Zephyrus
perdominetur annum.
III.
Solitas galea fulgere comas,
Stilicho, molli necte corona.
Riportare traduzione
F. D’Alessi © 2002
Cessent litui saevumque procul
Martem felix taeda releget.
Tractus ab aula rursus in aulam
redeat sanguis. Patris officiis
iunge potenti pignora dextra.
Gener Augusti pridem fueras,
nunc rursus eris socer Augusti.
Quae iam rabies livoris erit?
Vel quis dabitur color invidiae?
Stilicho socer est, pater est Stilicho.
IV.
Attollens thalamis Idalium iubar
dilectus Veneri nascitur Hesperus.
Iam nuptae trepidat sollicitus pudor,
iam produnt lacrimas flammea simplices.
Ne cessa, iuvenis, comminus adgredi,
inpacata licet saeviat unguibus.
Non quisquam fruitur veris odoribus
Hyblaeos latebris nec spoliat favos,
si fronti caveat, si timeat rubos:
armat spina rosas, mella tegunt apes.
Crescunt difficili gaudia iurgio
accenditque magis, quae refugit, Venus.
Quod flenti tuleris, plus sapit osculum.
Dices o quotiens" Hoc mihi dulcius
quam flavos deciens vincere Sarmatas"!
Adspirate novam pectoribus fidem
mansuramque facem tradite sensibus.
Tam iunctis manibus nectite vincula
quam frondens hedera stringitur aesculus,
quam lento premitur palmite populus,
et murmur querula blandius alite
linguis adsidui reddite mutuis.
Et labris animam conciliantibus
alternum rapiat somnus anhelitum.
Amplexu caleat purpura regio
et vestes Tyrio sanguine fulgidas
alter virgineus nobilitet cruor.
Tum victor madido prosilias toro
nocturni referens vulnera proelii.
Ducant pervigiles carmina tibiae
permissisque iocis turba licentior
exultet tetricis libera legibus.
Passim cum ducibus ludite milites,
passim cum pueris ludite virgines.
Haec vox aetheriis insonet axibus,
haec vox per populos, per mare transeat:
"Formosus Mariam ducit Honorius".
226
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
227
Bibliografia
ICCU niente
"Fescennina¸ carmina - Encarta"
Fescennini Nell’antica Roma, canti di natura scherzosa, talora diffamatoria o volgare, che venivano recitati in
occasione di cerimonie nuziali o durante feste rurali. Non è chiaro se l’etimologia fescennini versus, cioè
“versi fescennini”, derivi da Fescennium, città etrusca, oppure dalla parola latina fascinum, cioè “malocchio”.
Quest’ultima ipotesi spiegherebbe il valore propiziatorio e apotropaico di questi lazzi, che avevano la
funzione di stornare gli influssi malefici dagli sposi o dal raccolto agricolo. Attestati fin dagli albori della
letteratura latina, i fescennini, al pari dell’atellana ebbero un certo influsso sul teatro di Plauto.
"Fescennini versus - Treccani"
Fescennini, Versi. Antichi versi di carattere sboccato e licenzioso. Pare ormai certo che il loro nome derivi
dalla città etrusca di Fescennium, dove erano cantati in occasione di feste propiziatrici della fecondità dei
campi. Si trattava di motteggi espressi nel rozzo verso saturnio, nei quali trovava libera sfogo ogni volgarità.
Introdotti a Roma, piacquero al popolino. I f. vanno considerati come la prima manifestazione drammatica
della letteratura latina. L'unico esempio che rimane ci è stato tramandato da Catullo (cfr. carme LXI, I26155).
Riposati
a) Fescennini (o Fescennini versus): canti rustici improwisati, durante i raccolti e le feste villerecce, tra gli
agricoltori della campagna ita!ica, e, in origine, etrusca, se, come vogliono gli antichi grammatlci (Servio,
Festo, ecc.), essi traggono il nome da Fescenntum (o~ meglio, Fescennta), località tra l'Etruria e il Lazio, nei
pressi dei Monti Cimíni, identificata oggi con Corchiano, non lungi da Viterbo.
Dei primitivi fescennini nulla ci è penenuto; ma dalle testi monianze antiche possiamo ricostruire la genesi e
la natura, nonché le reviviscenze e gli sviluppi letterari che essi ebbero nella restaurazione della cultura
augustèa. Rozza e incomposta poesia è detta dl Livio questa schietta espressione rusticana dell anima
italica, sàpida di motteggio, di spirito satirico e di acre realismo. Orazio la chiama fescennina licentia, la
quale generò rustiche insolenze a versi alterni, a battute cioè dialogate, in forma di 'contrasto poetico '. che
finiva quasi sempre nell'insulto personale e nella grossolana maldicenza (3). Appaiono già qui ricchi elementi
drammatici che, disciplinati poi in scenica rappresentazione, con danze e suono di flauto, entrarono dalla
campagna in città e diventarono insolenti e aggressivi, diffamatorii e ingiuriosi, sí da provocare persino la
sanzione della legge delle XII Tavole: si quis malum carmen incantassit (= incantaverit) . . .
È lo stesso Orazio a mettere a punto questo momento evolutivo nella storia del fescennino: " quella libertàdice egli-, facendosi strada anno per anno, scherzò piacevolmente, finché il giuoco, divenuto acerbo,
cominciò a convertirsi in aperto livore e ad andare impunemente minaccioso per le case onorate. Si dolsero i
colpiti dal morso avvelenato. . . - fu promulgata una legge e s'indisse una pena per proi bire che si infamasse
con malèdico carme la gente . . . ". Siamo qui nel pieno dilagare della licentia fescenntna. che diventa procax
fescennma iocatio nelle cerimonie nuziali (Carmina nuptialia), avviando una tradizione letteraria, i cui echi,
raggentiliti dall'arte, si risentono in Catullo (c. 61: I'epitalàmio di Manlio Torquato e Vinia Aurunculeia), e piú
tardi in Seneca (Medea, vv. 56-115: coro nuziale di Giàsone e Creúsa) e nell'ultimo grande poeta latino,
Claudiano (c. 11: I'epitalàmio per le nozze dell'Imperatore Onorio).
Il mimo
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
228
[Studiare una ripartizione nella collocazione considerata la varietà delle forme e la distribuzione nel
tempo, quindi anche in epoca graccana (mimo letterario, Publilio Siro e Decimo Laberio) e
imperiale.]
Riferimenti al mimo ellenistico di Eroda e Teocrito può essere fuorviante, almeno per il pubblico
diverso che il mimiambo presuppone.
Significato della radice greca (
) utilizzata anche dai termini latini ci riporta al concetto di
imitazione della realtà.
Il termine mimus sta a indicare indifferentemente l’attore di mimi, quindi il commediante, sia lo
spettacolo stesso, sia, per estensione, ogni farsa di tipo grossolano o buffonata.
Il mimo come “genere” è del resto difficilmente definibile perché può presentare elementi diversi,
sia nei possibili antecedenti greci sia negli sviluppi storici latini, che prevedono, specie in epoca
tardo repubblicana, anche tentativi di far assurgere a genere letterario ciò che resta pur sempre
“spettacolo”, caratterizzato da danze, intermezzi musicali, ma anche da numeri di spogliarelliste.
Le scene sono in genere a sé stanti, rappresentano amorazzi e litigi, spesso con finali bruschi e a
sorpresa. Ulteriore elemento di distinzione rispetto ad altre rappresentazioni può essere identificato
dal fatto che gli attori recitano senza maschera e senza particolari calzature che identificano invece
attori di altri genere; tra gli attori poi vi sono, appunto, anche donne.
Se uno degli scopi primari è quello di raggiungere effetti di maggior realismo non deve
meravigliare, specie in età imperiale, l’utilizzo di condannati a morte che vengono “sacrificati” sulla
scena.
Le testimonianze relative alla rappresentazione più antica di un mimo ci riportano al 211 a.C.. Non
è casuale che il periodo coincida con quello di una sostanziale decadenza della commedia e della
tragedia, elemento che assicura al mimo un notevole successo anche in epoche successive in cui
commedia e tragedia non riescono per caratteri o motivi contigenti ad assorbire realmente la voglia
di spettacolo.
Il mimo domina la scena in età cesariana anche al posto dell’atellana.
Testi e testimonianze
Fest. 436 L; (testo PHI)
<proxima . . . sa>lutationes; vo. . . <n>unc ludi, scenicos . . . s primum fecisse C. . . . alium, M. Popilium M.
<f. curules a>ediles, memoriae <prodiderunt> historici. Solebant <enim saltare> in o<rc>hestra, dum <in
scaena actus fa>bulae conponeren<tur, cum gestibus ob>scaenis. "Salva res <est dum cantat> senex",
quare parasiti Apollonis in scaena dictitent, causam Verrius in lib. V, quorum prima est p littera, reddidit,
quod C. Sulpicio, C. Fulvio cos., M. Calpurnio Pisone praetore urb. faciente ludos, subito ad arma exierint,
nuntiat[i]o adventu[s] hostium, victoresque in theatrum redierint solliciti, ne intermissi religionem adferrent,
instaurati qui essent: inventum esse ibi C. Pomponium, libertinum mimum magno natu, qui ad tibicinem
saltaret. Itaque gaudio non interruptae religionis editam vocem nunc quoque celebrari. At in hoc libro refert
Sinni Capitonis verba, quibus eos ludos Apollinares Claudio et Fulvio cos. factos dicit ex libris Sibyllinis et
vaticinio Marci vatis institutos, nec nominatur ullus Pomponius. Ridiculeque de ip<sa> appellatione
par<a>sitorum Apollinis hic causam reddit, cum in eo praeterisset. Ait enim ita appellari, quod C. Volumnius,
qui ad tibicinem saltarit, secundarum partium fuerit, qui fere omnibus mimis parasitus inducatur. Quam
inconstantiam Ver<rii> nostri non sine rubore rettuli.
Serv. ad Aen. VIII 110;
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
229
Deni que cum ludi circenses Apollini celebrarentur et Hannibal nuntiatus esset circa portam Collinam urbi
ingruere, omnes raptis armis concurrerunt. reversi postea cum piaculum formidarent, invenerunt saltantem in
circo senem quendam. qui cum interrogatus dixisset se non interrupisse saltationem, dictum est hoc
proverbium 'salva res est, saltat senex'.
Serv. ad Aen., III 279;
Sciendum sane moris fuisse, ut piaculo commisso ludi celebrarentur: nam cum Romani iracundia matris
deum laborarent et eam nec sacrificiis nec ludis placare possent, quidam senex statutis ludis circensibus
saltavit, quae sola fuit causa placationis: unde et natum proverbium est "omnia secunda, saltat senex".
quamvis hoc et alio ordine et alia ex causa narratur sttotian.
Macrob. Sat. 1, 17, 25
[25] Anche nella nostra storia si trova menzionato un caso analogo di intervento dello stesso dio.
Mentre a Roma si celebravano i giochi in onore di Apollo, secondo il vaticinio dell'indovino Marcio
e la profezia della Sibilla, la plebe fu chiamata alle armi per un improvviso attacco nemico e corse
incontro agli assalitori: in quel momento si vide muoversi contro gli avversari una nuvola di frecce
che mise in fuga il nemico e permise ai Romani vincitori di ritornare agli spettacoli del dio salutare.
Di qui si capisce che i giochi furono istituiti in séguito ad una battaglia, non a una pestilenza, come
ritengono certuni.
Trad. N. Marinone, Torino, Utet.
1,17, 23-28 Testo Internet Lacus Curtius: ricontrollo con edizione.
23 Unde et Apollinem, id est solem, modo sospitalem modo pestem significantibus cognominibus adoramus,
cum tamen pestis quae ab eo noxiis inmittitur aperte hunc deum bonis propugnare significet. 24 Hinc est
quod apud Pachynum Siciliae promuntorium Apollo Libystinus eximia religione celebratur. Nam cum Libyes
invasuri Siciliam classem adpulissent ad id promuntorium, Apollo, qui ibi colitur, invocatus ab incolis inmissa
hostibus peste et paene cunctis subita morte interceptis Libystinus cognominatus est. 25 Nostris quoque
continetur annalibus similis eiusdem dei praesentiae maiestas. Nam cum ludi Romae Apollini celebrarentur
ex vaticinio Marcii vatis carmineque Sibyllino, repentino hostis adventu plebs ad arma excitata occurrit hosti,
eoque tempore nubes sagittarum in adversos visa ferri et hostem fugavit et victores Romanos ad spectacula
dei sospitalis reduxit: hinc intellegitur praelii causa, non pestilentiae, sicut quidam aestimant, ludos institutos.
26 Haec est autem huius aestimationis ratio, quod tunc sol super ipsum nostrae habitationis verticem fulget.
Nam Cancer in aestivo tropico est, in quo meante sole radii temperatam nostram non eminus sed superne
demissi rectis fulgoribus lustrant: unde aestimatum est a nonnullis ad propitiandum tunc maxime deum
caloris Apollinaribus litari. 27 Sed invenio in litteris hos ludos victoriae, non valitudinis causa, ut quidam
annalium scriptores memorant, institutos. Bello enim Punico hi ludi ex libris Sibyllinis primum sunt instituti,
suadente Cornelio Rufo decemviro, qui propterea Sibylla cognominatus est, et postea corrupto nomine
primus coepit Sylla vocitari. 28 Fertur autem in carminibus Marcii vatis, cuius duo volumina inlata sunt in
senatum, inventum esse ita scriptum: Hostem, Romani, si ex agro expellere vultis, vomicam quae gentium
venit longe, Apollini censeo vovendos ludos qui quotannis comiter Apollini fiant. His ludis faciendis praesit is
praetor qui ius populo plebique dabit summum: decemviri Graeco ritu hostiis sacra faciant. Hoc si recte
facietis, gaudebitis semper fietque res publica melior: nam is divus extinguet perduelles vestros qui vestros
campos pascunt placide».
Vedi anche II parte
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
230
CASTIGLIONI MARIOTTI
mimus, i, m.,
1 mimo, commediante, attore di mimi, CIC. e a.;
2 mimo, farsa grossolana, commedia, CIC. e a.; mimi obscena iocantes (pieni di allusioni oscene),
OV.;
3 fig. buffonata, SUET. e a.; vitae humanae mimus (farsa), SEN. Ep. 80, 7
[gr.].
Letture critiche. M. Bonaria, Mimografi
Dal mondo ellenico ed ellenizzato il mimo passa al mondo latino in età abbastanza antica,
attingendo temi e situazioni dalla nuova realtà: a questo punto rimane un genere esclusivamente
teatrale. La notizia piú antica di una rappresentazione mimica è del 211 a.C. (Fest. 436 L; Serv. ad
Aen. VIII 110; III 279; Macrob. Sat. 1 17, 25) e si riferisce ad uno spettacolo, che avrebbe avuto
luogo nel momento in cui Annibale, nella II guerra Punica, si presentò davanti a Roma, presso la
porta Collina (Liv. XXVI 10). Allo stesso 211 risale la piú antica iscrizione dedicata ad un mimo
(CIL I 1297). Da allora il mimo dilaga in Italia e fuori, anche per il contemporaneo decadere del
teatro tragico e comico e viene collegato con le feste Florali (Varr. de re r. 12, 6; Lactant. div. inst. I
20. 5). Verso la fine del II sec. il mimo si organizza in modo regolare, assumendo struttura stabile
con parti improvvisate e scritte, parti cantate, danzate e parlate. Fra i preneoterici i mimiambi di
Mazio continuano anche nel titolo la tradizione di Eroda (Gell. X 24, 10; Macrob. Sat. I 4, 24), ma
l'età d'oro del mimo si ha al tempo di Cesare con D. Laberio e Publilio Siro. Il primo (106-43 a.C.)
fu eques Romanus e dei suoi mimi ci rimangono 43 titoli e 176 versi. Nonostante la sbrigativa
condanna di Orazio (sat. I 10, 6), i suoi mimi dovevano essere opera non spregevole. Del secondo
si sa che nacque ad Antiochia: di lui ci rimangono 2 titoli e 5 versi. mentre è sub íudice se siano
suoi i 16 versi a lui attribuiti da Petronio (LV 6; Mimi2 10 e 141-142 Bonaria). Materiale suo è certo
confluito, accanto a versi di eterogenea provenienza, non esclusa quella cristiana, nel Medioevo in
quella silloge nota con il nome di sententiae. Lo scontro fra i due mimografi avvenne nei ludi
Caesaris del 46 a.C.: Cesare, piú volte criticato da Laberio (Suet. Iul. 39; Gell. XVII 14, l; Macrob.
Sat. II 7; Mimi2 104 Bonaria), lo costrinse a cimentarsi in gara con Siro. Al termine della contesa lo
dichiarò soccombente, aggiungendo parole di scherno. Di questo fatto ci rimangono i 27 vv. del
prologo, nei quali Laberio si lamenta amaramente del suo destino, che da cavaliere lo ha fatto
mimo. Mentre il mimo continua la sua via, si presenta alla ribalta un suo pericoloso rivale, il
pantomimo, spettacolo piú vivo e aggressivo, fatto di danza e mimica, senza parole. Tracce ne
sono già nella Grecia classica: nel IV sec. ce ne presenta un esempio Senofonte (symp. IX 2-7),
dedicato agli amori di Dioniso e Arianna. L'ingresso del pantomimo nel mondo latino sarebbe
avvenuto nel 22 a.C. (Suet. de poet. p. 65 R.; Athen. 20 D; Macrob. Sat. II 7, 12), per opera di
Pilade di Cilicia e Batillo di Alessandria, il primo celebre nel comico e il secondo nel tragico. La
data è certo inesatta, perché il pantomimo esisteva in Italia anche prima: per l'anno 38 a.C. lo
attesta in Campania Orazio (sat. I 5, 62). Di Pilade si sa che nel 18 a.C. fu cacciato dall'Italia,
perché aveva additato al pubblico uno spettatore, che lo fischiava (Suet. Aug. 5); del secondo si sa
che fu liberto di Mecenate (schol. Pers. 5, 123; Tac. ann. I 54, 2) e che eseguiva i suoi pantomimi
accompagnato dal flautista L. Cassio Principe (Phaedr. V 7; CIL XIV 4424).
Nell'età augustea la storia del mimo e quella del pantomimo s'intrecciano fra loro, sia in territorio
greco, sia in quello latino, anche se al pantomimo non si può negare maggiore efficacia e píú vasto
successo per la semplicità della sua struttura, per le sue trame pruriginose e per l'eleganza visiva
delle sue esibizioni. Lo confermano le notizie che abbiamo, e anche il fatto che, mentre di autori ed
attori mimici conosciamo pochi nomi, di attori pantomimici conosciamo per via letteraria e per via
epigrafica un vumero molto elevato, tanto che per taluni di essi si poté parlare di vere e proprie
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
231
dinastie. Al pantomimo non si appassionò solo il pubblico normale, ma anche gli imperatori, che
non di rado vi si esibirono personalmente, sia in teatro, sia a corte, come Caligola (Suet. Gai. 54,
2), Nerone Eutrop. VII 14; schol. Iuvenal. VIII 228), Commodo (Lamprid. Comm. 1). Conseguenza
di questo successo fu il periodico ripetersi di disordini e zuffe tra sostenitori di questo o quell'attore
e l'altrettanto periodico ripetersi di divieti e di espulsioni di attori, come nel 15 e nel 23 sotto Tiberio
Tac. ann. I 77, 1; IV 14, 3; Dio Cass. LVII 21, 3), in età neroniana Suet. Ner. 26, 5; 16, 3; Tac. ann.
XIII 25; XIV 20), in età domizianea Suet. Dona. 17, 11), in età traianea (Plin. paneg. 46, 1; Xiphil.
ad Dio. Cass. LXVIII 10, 2), ecc. In età augustea si ha il mimo greco Filistione, che per primo diede
un contenuto prevalentemente amoroso (Suet. de poet., p.10 R.; Mart. II 41, 15; Suda, s.v.
(Philistìon; Mimi2 202 Bonaria). Celebre fu pure Stefanione, cosí longevo da esibirsi nei ludi
secolari del 17 a.C. e del 47 d.C. (Plin. n.h. VII 159). In quella stessa epoca Arbronio Silone scrisse
libretti (fabulae salticae) per pantomimi (Sen. suas. II 19) e lo stesso fece in età neroniana Lucano
(vita Lucani, p. 185, 63 R.). Al tempo di Caligola si attribuisce il mimografo Catullo (schol. Iuven.
13, 111 mentre all'epoca di Claudio fu celebre Mnestere, immischiato in loschi intrighi di corte e
ucciso nell'anno 48 (Dio Cass. LX 31, 5). Per l'età dei Flavi (69-96) si ricorda una mima Lucceia,
che si esibí in teatro alla veneranda età di 100 anni (Plin. n.h. VII 158); nello stesso periodo fu
importato dalla Siria a Roma il mimo acquatico, detto tetimio (Traversari ) o idromimo (d'Ippolito).
Nel II sec. Luciano compose il suo de saltatione, nel quale prende le difese del pantomimo: infatti
da tempo l'opinione pubblica pagana lo osteggiava per la sua aperta immoralità. Ben presto ad
essa si aggiunse l'analoga protesta cristiana, a partire dalla constitutio apostolica (VIII 2) per
passare ai nomi di Minucio Feiice (XII 5) e di Teofilo d'Antiochia (ad Autol. III 15) sino ai grandi
Padri della Chiesa greca e latina del IV sec. Fra il III e il IV sec. all'accusa di immoralità si
aggiunge quella di blasfemia, dato che il mimo e il pantomimo si erano ímpadroniti del filone
antireligioso e portavano in scena parodie delle credenze e dei riti cristiani. È tipico il caso di
Genesio, prima mimo e poi martire cristiano per miracolosn conversione sulla scena nell'agosto
305. Nonostante le polemiche una parte del pubblico continua ad apprezzare questi spettacoli e la
corte imperiale è spesso in prima linea: Elagabalo nominò prefetto di Roma un pantomimo
(Lamprid. Heliogab. XII 1), Carino riempí il Palatino di mimi e pantomimi (Vopisc. Carin. 16, î; 19,
11), Giuliano portò al seguito delle sue spedizioni militari pantomimi (Eunap. in h. G. zninores, vol.
I, p. 226 D.). Si stava, però, appressando la fine: la crisi dell'impero, le invasioni, il crescente
disinteresse per il teatro, la polemica pagana e cristiana a lungo andare non furono senza effetto.
Nel V sec. il mimo tace nella Germania occidentale (Salv. de gub. Dei VI 8), ma è ancora fiorente
nella Gallia meridionale (Paul. Nol. epigr. CSEL; XVI 499) e a Roma (Sid. Apoll. epist. I 2, 9;
Cassiod. var. IV 51). Nel VI sec. si sa di un mimo in Spagna (Greg. Turon. hist. Franc. IV 7),
mentre nel 525 l'imp. Giustino espelle i pantomimi da tutto l'Oriente ad eccezione di Alessandria.
Come nel IV sec. Libanio aveva composto un'orazione sul pantomimo, ora nel VI c'è la voce di
Coricio di Gaza, che nell'apologia mimorum ha lasciato se non una difesa, almeno la
testimonianza preziosa per un'epoca, della quale egli è spesso l'unica fonte. Nello stesso tempo la
guerra greco-gotica (535-553) segna la fine quasi totale di questo spettacolo, anche se i suoi temi
e i suoi motivi rimangono sotto le ceneri in attesa di vita novella.
3. RAPPORTI CON ALTRI GENERI LETTERARI E ARTISTICI. Per Platone si sa (Diog. Laert. III
13, 18) che voleva ethopoièsai in base ai mimi di Sofrone, che gli servirono per dare un'impronta
fortemente realistica ai suoi dialoghi. Eroda (8, 77) imita Ipponatte nei concetti e nel metro e a sua
volta fu imitato da Mazio. I rapporti di Eroda con la commedia sono stati studiati dal Krakert.
Elementi di mimo sono presenti nelle odi di Orazio (Stemplinger) e nelle satire: il teatro mimico in
generale ebbe notevole importanza per satira, bucolica e romanzo e particolarmente in Petronio
(Moeríng; Vretska). Notevole fu anche l'influsso sulle arti figurative: basti ricordate il cratere di
Mandralisca (Wiist), edito dal Rizzo.
4. TECNICA. In Grecia e a Roma i mimi e i pantomimi si rappresentavano tanto sulle piazze,
quanto nelle corti. Ma in Grecia fino a Sofrone non si ha testo scritto. Sofrone usa la prosa ritmica,
Teocrito l'esa metro, Eroda lo scazonte, il fr. Grenfellianum il docmio, mentre gli scrittori latini
adottano i metri della drammatica maggiore e in particolare il senario. Il pantomimo non ha testo
scritto, ma solo un libretto (fabula saltica), che guida l'azione danzata. In età cesariana il mimo
letterario, pur lasciando ampio spazio all'improvvisazione, ha un prologo, parti cantate (cantica) e
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
232
parti dialogate (deverbia). In Grecia la lingua è quella del popolino dorico (Umgangssprache), in
Teocrito il dorico letterario e in Eroda la lingua ionica popolare. Nel mondo latino la lingua è quasi
sempre di livello letterario. I temi sono, più o meno, quelli della commedia: intrighi, adulteri,
avvelenamenti, baruffe, incantesimi, serenate (paraklaysìthyra), donne abbandonate. In Laberio
hanno largo spazio le allusioni politiche e filosofiche, come nelle coeve « Menippee » di Varrone. Il
pantomimo è quasi sempre di contenuto mitologico (cfr. Luciano), ma i temi non variano; in un
secondo tempo, come si vide, c'è anche la parodia della religione. In Grecia fare l'attore era
spesso cosa ambita e non di rado compito di dilettanti; in Roma era vietato ai cives di fare l'attore e
l'autore teatrale. Tale divieto, prima rigidamente osservato, cominciò ad essere disatteso solo in
età cesariana. Quindi, « fare del teatro » era permesso solo agli estranei, agli schiavi e ai liberti. In
Grecia e in Roma tragedia e commedia non ammettevano donne; solo il mimo e il pantomimo le
accolsero (Athen. 129 D; 137 C) e questo fu causa ed effetto della sua spiccata licenziosità.
L'attore, come l'opera, si chiamava mimos (mirnus) e pantòmimos ( pantonaimus). Del mondo
greco si sa pochissimo, mentre siamo meglio informati per il mondo latino: il protagonista era il
mimus (CIL I 1297; XIV 3683), al cui fianco c'era il secundarum partium (Acro ad Hor, epist. I 18,
19), detto anche parasitus (Plaut. mil. 665; Hieron. epist. XXII 29, 4). C'era pure il tertiarum (CIL VI
10103) e il quartarum (CIL VI 10118). nonché lo stupidus, che esilarava il pubblico con le sue
lepidezze (Varr. de l. L. V 137; Apul. apol. 13, 17; Suet. Gai. 57). Era sovente calvo (Arnob. VII 33;
schol. Iuven. VI 66 e 236) e rappresentava il marito tradito (schol. Iuven. VI 770). Sovente gli attori
si riunivano in compagnie (collegia; CIL III 3423) agli ordini dell'archimimus (Sen. fr. 96 H.; Plut.
Sull. 474 E); tali compagnie, come nel caso di quella di L. Acilius Eutvches (CIL XIV 2408),
raggiungevano persino 60 persone, inclusi gli inservienti ed escluse le donne. Non è certo se le
donne avessero una gerarchia analoga e noi conosciamo solo mimae (CIL VI 10110; Plin. nat. hist.
VIII 55) e archimimae (CIL VI 10106).
Forse anche per loro c'era qualche tipo di organizzazione professionale (CIL VI 10109). In Grecia
la maschera è attestata per gli ithyphalloi (Athen. 622 B) e per i phlyakes. Nel mondo latino sembra
che nessun attore di mimo e di pantomimo la usasse. In Grecia si usavano gli abiti della vita
quotidiana; per il territorio latino conosciamo il nome di almeno due capi di vestiario: per le donne il
ricinium, abito quadrato con orlo purpureo, la cui metà si mandava dietro le spalle, donde
l'etimologia (da reicere; Varr. de l. L. V 132; Fest. 342, 20 L.). A volte era detto anche rnafurtium
(Non. 542, 1 L) o maforte (Hieron. epist. XXIII 13; Serv. ad Aen. I 282) o mavorte (Isid. etym. XIX
25, 4). Per gli uomini il centunculus di foggia arlecchinesca (Apul. apol. XIII 27). Per accrescere
l'immoralità gli abiti delle donne erano corti e trasparenti (c. gloss. IV, p. 191, 4): a volte le attrici
(che, per l'occasione, erano sostituite da donne di malaffare), a richiesta del pubblico, deponevano
ogni abito. La nudatio mimarum divenne una tradizione e si narra che nel 55 a.C. Catone Uticense
la impedí con la sua sola presenza (Val. Max. II, 10, 8; Sen. epist. XXXVII 7; Martial. I praef.). In
Italia i mimi erano detti anche planipedes (Diom. III, p. 490, 4 K.) o perché pedibus planis, id est
nudis, proscenium introirent o perché in plano orchestrae actitabant. La prima spiegazione è piú
verosimile, perché confermata da Seneca (epis!. VIII 8), che dice il mimo excalceatus.
M. Bonaria, Mimografi, in Dizionario degli scrittori greci e latini, Milano, Marzorati, 1987, pp. 13591366.
Bibliografia
I frammenti del mimo in CRF Comicorum Romanorum praeter Plautum et Terentium Fragmenta,
Ribbeck 3
Mimorum Romanorum fragmenta, ed. Bonaria M., 2 vol., Genova, 1955-1956, (Pubblicazioni
dell'Istituto di filologia classica, 5).
Romani Mimi, ed. Bonaria M., Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1965, 307 p. (Poetarum Latinorum
reliquiae, VI, 2): Traduzione e commento.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
233
Conte, LettLat, 111 (per il mimo di Laberio e P. Siro)
Riposati
d) Mimo- La terminologia è greca (da miméomai= (e imito "), trapiantata con il suo significato originario in
latino, a dire una specie dl farsa improwisata, breve e senza complicati intrecci drammatici, nella lingua
grossolana ed espressiva della gente del popolo, accompagnata da gesti vivaci e spesso grotteschi, intesi a
cogliere e ad i mitare versi di animali, fenomeni naturali e, soprattutto, scene momentanee burlesche della
vita degli uomini: piccoli bozzetti, vere macchiette caricaturali. Come tale, il ' mimo ' è un fatto istintivo e si
confonde con le stesse spontanee manifestazioni comiche della natura umana.
Per questo esso affonda le sue radici nella piú antica romanità e rispecchia, accanto ai fescenmni, alla
satura e all'atellana, le piú genuine manifestazioni comiche e drammatiche dello spirito italico. Quanto esso
interessasse la curiosità del pubblico, ben si comprende dagli immediati sviluppi in forme sceniche elaborate,
che soppiantarono la stessa atellana e divennero il genere comico preferito allorche tutto il teatro decadde,
soffocato dagli splendori delle nuove forme di poesia e di arte. Perciò anche nel mimo possiamo distinguere
due periodi consecutivi: uno preletterario, caratterizzato da improvvisazioni popolaresche e affidato
esclusivamente alle risorse mimiche degli attori; I'altro letterario, che, continuando gli spiriti del precedente e
disciplinandone l'azione, raggentilita dalla musica e dalla danza, si afferma e fiorisce dall'epoca di Silla in poi,
con Decimo Laberio e Publxlso Siro.
Quanto il mimo romano, specialmente quello letterario, debba ai suoi precedenti greci, non è facile dire.
Indirettamente o direttamente dovette senza dubbio sperimentare gli influssi delle forme similari dell'Oriente,
della Grecia ionica e soprattutto della Magna Grecia, dove fiorí il mimo realistico di Sòfrone e di Senarco, poi
quello di Eròda. Ma la sostanza di esso, I'impronta spirituale del suo piccolo mondo spassoso, I'anima della
sua vita primitiva e popolare, I'istintivo e saporoso senso del realismo e del comico sono italici e latini.
Latino, e del linguaggio popolare, è comunque il termine planipeVdes, che figura nella tradizione, accanto a
quello dl ' mimi ', a significare gli attori " a piedi piani o lisci " cioè " senza calzatura " (excalceati li dice
Seneca, per distinguerli da quelli della commedia, che calzavano i socci, " zòccoli ") (l); italica, inoltre, e tutta
meridionale, è l'impostazione popolaresca e spontanea della scena, la grossolanità dei gesti e della parlata.
Si aggiunga che il mimo non seguiva schemi o intrecci convenzionali, ma era affidato alla bravura e alla
libertà dei singoli attori. E stato ben detto, che, se c'è nella tradizione un prodotto tutto popolare, che risalga
alla piú antica romanità, questo è il mimo (2).
La satura
Testi e testimonianze
Livio, 7, 2
Et hoc et insequenti anno C. Sulpicio Petico C. Licinio Stolone consulibus pestilentia fuit. eo nihil dignum
memoria actum, nisi quod pacis deum exposcendae causa tertio tum post conditam urbem lectisternium fuit;
et cum uis morbi nec humanis consiliis nec ope diuina leuaretur, uictis superstitione animis ludi quoque
scenici–noua res bellicoso populo, nam circi modo spectaculum fuerat–inter alia caelestis irae placamina
instituti dicuntur; ceterum parua quoque, ut ferme principia omnia, et ea ipsa peregrina res fuit. sine carmine
ullo, sine imitandorum carminum actu ludiones ex Etruria acciti, ad tibicinis modos saltantes, haud indecoros
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
234
motus more Tusco dabant. imitari deinde eos iuuentus, simul inconditis inter se iocularia fundentes uersibus,
coepere; nec absoni a uoce motus erant. accepta itaque res saepiusque usurpando excitata. uernaculis
artificibus, quia ister Tusco uerbo ludio uocabatur, nomen histrionibus inditum; qui non, sicut ante,
Fescennino uersu similem incompositum temere ac rudem alternis iaciebant sed impletas modis saturas
descripto iam ad tibicinem cantu motuque congruenti peragebant. Liuius post aliquot annis, qui ab saturis
ausus est primus argumento fabulam serere, idem scilicet–id quod omnes tum erant–suorum carminum
actor, dicitur, cum saepius reuocatus uocem obtudisset, uenia petita puerum ad canendum ante tibicinem
cum statuisset, canticum egisse aliquanto magis uigente motu quia nihil uocis usus impediebat. inde ad
manum cantari histrionibus coeptum diuerbiaque tantum ipsorum uoci relicta. postquam lege hac fabularum
ab risu ac soluto ioco res auocabatur et ludus in artem paulatim uerterat, iuuentus histrionibus fabellarum
actu relicto ipsa inter se more antiquo ridicula intexta uersibus iactitare coepit; unde exodia postea appellata
consertaque fabellis potissimum Atellanis sunt; quod genus ludorum ab Oscis acceptum tenuit iuuentus nec
ab histrionibus pollui passa est; eo institutum manet, ut actores Atellanarum nec tribu moueantur et
stipendia, tamquam expertes artis ludicrae, faciant. inter aliarum parua principia rerum ludorum quoque
prima origo ponenda uisa est, ut appareret quam ab sano initio res in hanc uix opulentis regnis tolerabilem
insaniam uenerit.
2. La pestilenza durò anche nell'anno successivo durante il quale furono consoli Gaio Sulpicio
Petico e Licinio Stolone. Non avvenne nulla di rimarchevole, tranne il fatto che si tenne un
lettisternioz (ed era la terza volta, dalla fondazione di Roma, che questo avveniva) per riottenere
il favore degli dèi. Tuttavia la violenza del morbo non era attenuata né da provvedimenti umani
né dall'aiuto divino e gli animi erano soggetti ad ogni forma di superstizione: fu allora che per la
prima volta (una novità per un popolo abituato alla guerra e avvezzo soltanto agli spettacoli
circensi) furono organizzati degli spettacoli teatrali, uno dei tentativi di placare l'ira degli dèi. Si
trattò di spettacoli di modesto significato (quasi sempre così funzionano le cose ai loro inizi) e
per di più importati da fuori. Dei ballerini fatti venire dall'Etruria, danzando al suono del flauto,
offrivano uno spettacolo non indecoroso su musiche etrusche: non c'erano testi poetici da
seguire e dunque nemmeno gesti con cui mimare quei testi. I primi ad imitarli furono i giovani
che presero a scambiarsi delle battute costruite su rozzi versi e accompagnando con una
particolare gestualità le loro parole. Questo modo di fare fu dunque recepito e, ripetuto in più
occasioni, divenne abituale. Gli attori locali furono chiamati istrioni (da ister, che è il termine
etrusco per designare gli attori): costoro passarono presto dalle grossolane composizioni simili ai
versi Fescennini,3 piuttosto improvvisate e rozze, a delle sature,4 costruite con molti metri
diversi, che eseguivano con un canto precedentemente adattato all'accompagnamento di un
flauto e con danze fatte apposta per sottolineare il canto. Livio,s parecchi anni dopo, fu il primo
che osò abbandonare le sature e comporre un'opera teatrale organizzata attorno ad un soggetto
fisso. Siccome, a quanto si racconta, non diversamente da quanto facevano allora tutti, egli era
anche attore delle sue opere, gli capitò di dover concedere parecchie repliche e di perdere la
voce. In quell'occasione egli chiese perdono e introdusse un fanciullo che cantò davanti al
flautista; poi seguì il canto con dei movimenti molto più appropriati perché non aveva la
preoccupazione di articolare la voce. Da allora in poi gli istrioni presero ad accompagnare con
dei gesti la parte cantata e soltanto le parti dialogate erano lasciate alla loro voce. E dunque,
quando le opere teatrali cominciarono ad avere struttura fissa, l'azione scenica divenne
completamente diversa dalla comicità e dallo scherzo un po' irriverente perché lo spettacolo
stava diventando una vera e propria espressione d'arte. I giovani allora lasciarono la recitazione
delle opere regolari agli istrioni e ritornarono all'uso antico di lanciarsi reciprocamente della
battute comiche in versi; da qui nacquero quelle farse finali che furono accostate sopratutto alle
Atellane. I giovani conservarono per sé questo genere teatrale importato dagli Osci e non
permisero che esso fosse contaminato dagli attori di professione. Per questo fu stabilito allora
che gli attori di atellane non siano espulsi dalle tribù e prestino servizio militare in quanto non si
tratta di attori di professione. Penso di aver fatto bene a ricordare, tra le cose che hanno avuto
inizi modesti, anche le origini degli spettacoli teatrali: in questo modo sarà chiaro da quale
onesto principio essi siano mossi per arrivare a questa pazzia che anche i regni più ricchi a
stento riescono oggi a tollerare.
Trad. Mazzocato
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
235
Val. Max., 2,4,4
Nunc causam instituendorum ludorum ab origine sua repetam. C. Sulpico Petico C. Licinio Stolone
consulibus intoleranda uis ortae pestilentiae ciuitatem nostram a bellicis operibus reuocatam domestici atque
intestini mali cura adflixerat, iamque plus in exquisito et nouo cultu religionis quam in ullo humano consilio
positum opis uidebatur. itaque placandi caelestis numinis gratia conpositis carminibus uacuas aures praebuit
ad id tempus circensi spectaculo contenta, quod primus Romulus raptis uirginibus Sabinis Consualium
nomine celebrauit. uerum, ut est mos hominum paruula initia pertinaci studio prosequendi, uenerabilibus
erga deos uerbis iuuentus rudi atque inconposito motu corporum iocabunda gestus adiecit, eaque res ludium
ex Etruria arcessendi causam dedit. cuius decora pernicitas uetusto ex more Curetum Lydorumque, a quibus
Tusci originem traxerunt, nouitate grata Romanorum oculos permulsit, et quia ludius apud eos hister
appellabatur, scaenico nomen histrionis inditum est. paulatim deinde ludicra ars ad saturarum modos
perrepsit, a quibus primus omnium poeta Liuius ad fabularum argumenta spectantium animos transtulit,
isque sui operis actor, cum saepius a populo reuocatus uocem obtudisset, adhibito pueri ac tibicinis
concentu gesticulationem tacitus peregit. atellani autem ab Oscis acciti sunt. quod genus delectationis Italica
seueritate temperatum ideoque uacuum nota est: nam neque tribu mouetur <actor> nec a militaribus
stipendiis repellitur.
Et quia ceteri ludi ipsis appellationibus unde trahantur apparet, non absurdum uidetur saecularibus initium
suum, cuius [generis] minus trita notitia est, reddere. Cum ingenti pestilentia urbs agrique uastarentur,
Valesius uir locuples rusticae uitae duobus filiis et filia ad desperationem usque medicorum laborantibus
aquam calidam iis a foco petens, genibus nixus lares familiares ut puerorum periculum in ipsius caput
transferrent orauit. orta deinde uox est, habiturum eos saluos, si continuo flumine Tiberi deuectos Tarentum
portasset ibique ex Ditis patris et Proserpinae ara petita aqua recreasset. eo praedicto magnopere confusus,
quod et longa et periculosa nauigatio imperabatur, spe tamen dubia praesentem metum uincente pueros ad
ripam Tiberis protinus detulit–habitabat enim in uilla sua propter uicum Sabinae regionis Eretum–ac luntre
Ostiam petens nocte concubia ad Martium campum appulit, sitientibusque aegris succurrere cupiens, igne in
nauigio non suppetente ex gubernatore cognouit haud procul apparere fumum, et ab eo iussus egredi
Tarentum–id nomen ei loco est–cupide adrepto calice aquam flumine haustam eo, unde fumus erat obortus,
iam laetior pertulit, diuinitus dati remedii quasi uestigia quaedam in propinquo nanctum se existimans, inque
solo magis fumante quam ullas ignis habente reliquias, dum tenacius omen adprehendit, contractis leuibus
et quae fors obtulerat nu trimentis pertinaci spiritu flammam euocauit calefactamque aquam pueris
bibendam dedit. qua potata salutari quiete sopiti diutina ui morbi repente sunt liberati patrique indicauerunt
uidisse se in somnis a nescio quo deorum spongea corpora sua pertergeri et praecipi ut ad Ditis patris <et>
Proserpinae aram, a qua potio ipsis fuerat adlata, furuae hostiae immolarentur lectisterniaque <ac> ludi
nocturni fierent. is, quod eo loci nullam aram uiderat, desiderari credens ut a se constitueretur, aram
empturus in urbem perrexit relictis qui fundamentorum constituendorum gratia terram ad solidum foderent. hi
domini imperium exequentes, cum ad xx pedum altitudinem humo egesta peruenissent, animaduerterunt
aram Diti patri Proserpinaeque inscriptam. hoc postquam Valesius nuntiante seruo accepit, omisso emendae
arae proposito hostias nigras, quae antiquitus furuae dicebantur, Tarenti immolauit ludosque et lectisternia
continuis tribus noctibus, quia totidem filii periculo liberati erant, fecit. cuius exemplum Valerius Publicola, qui
primus consul fuit, studio succurrendi ciuibus secutus apud eandem aram publice nuncupatis uotis
caesisque atris bubus, Diti maribus, feminis Proserpinae, lectisternioque ac ludis trinoctio factis aram terra,
ut ante fuerat, obruit.
Religionem ludorum crescentibus opibus secuta lautitia est. eius instinctu Q. Catulus Campanam imitatus
luxuriam primus spectantium consessum uelorum umbraculis texit. Cn. Pompeius ante omnes aquae per
semitas decursu aestiuum minuit feruorem. Claudius Pulcher scaenam uarietate colorum adumbrauit uacuis
ante pictura tabulis extentam. quam totam argento C. Antonius, auro Petreius, ebore Q. Catulus praetexuit.
uersatilem fecerunt Luculli, argentatis choragiis P. Lentulus Spinther adornauit. translatum antea poenicis
indutum tunicis M. Scaurus exquisito genere uestis cultum induxit. 7. nam gladiatorium munus primum
Romae datum est in foro boario App. Claudio Q. Fuluio consulibus. dederunt Marcus et Decimus filii Bruti
<Perae> funebri memoria patris cineres honorando. athletarum certamen a M. Scauri tractum est
munificentia.
Traduzione di Valerio Massimo
Diomede, ars
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
236
Bibliografia
Riposati
b) Sàtura. Gli spiriti italici e latini, tinti di quel realismo saporoso ed espressivo, che sentimmo nei fescennini,
rifluirono nella satura romana, e, congiunti ad elementi scenici etruschi, crearono la prima forma drammatica
del teatro latino. Sulla sua natura, sul suo nome e perfino sulla sua esistenza molto si è discusso e si discute
ancora, né sempre d'accordo col sentire antico.
La piú ampia e particolareggiata notizia viene da Livio (7, 2), che ritrova l'origine della satbra nei luli scaenici
del 364 a. C., tenutisi a Roma in occasione di riti propiziatorii per una pestilenza scoppiata in città, con il
concorso di giocolièri (luliones) etruschi, i quali, durante le cerimonie espiatorie, danzavano alla loro
maniera, a suon di flauto, senza canto e senza mimica. Piú tardi, i giovani romani presero ad imitarli,
convertendo però quella primitiva rappresentazione religiosa in una vera azione drammatica, carattenzzata
da frizzi mordaci e gesti butoneschi (tocularia), simili ai fescennini: erano le " sature, ricche di metri vari
(impletas molis saturas), con canto fisso e adattato al flauto e con appropriate movenze)>. Quando Livio
Androníco -continua lo Storico-introdusse in questi ludi una fabula con intreccio greco la gioventú romana,
lasciate agli histriones di professione quelle rappresentazioni troppo raffinate, tornò all'antico costume di
improvvisar versi cantati, sàpidi di umorismo e di frizzi mordaci. Accanto alla fabdla palliata di Androníco si
ebbe cosí quella nazionale romana (satura), che, riacquistata la forma e il carattere primitivo, fu considerata
come exoltum, vale a dire co ne rappresentazione allegra e burlesca, che si faceva seguire alla recita di
drammi seri, commedie o tragedie, alla stessa maniera del dramma satiresco greco o della farsa nostrana.
Questa narrazione liviana (che la critica a torto pone in dubbio e che, nonostante le non poche sconnessioni,
può essere sostanzialmente accettata) presenta tre successivi e interessanti momenti nello sviluppo della
satura: a) una fase iniziale, collegata con le rozze e popolaresche intonazioni drammatiche di puro stampo
latino, senza mimica e senza musica; b) un arricchimento di mezzi scenici (canto, danza e musica) e una
impostazione piú organica, che preparano lo schema della commedia propriamente detta recitata da gente di
mestiere; c) un ritorno, infine, alla forma originaria, ma, per cosí dire, emancipata, aggiornata alle esigenze
della progredita spiritualità romana, awiata ormai a formarsi un suo teatro, con attori indígeni (vernaculi
artiftces) e con caratteri propri.
Questo è l'essenziale del testo di Livio, col quale sostanzialmente concorda Valerio Massimo (2, 4, 4). E
vero che esso potrebbe recar tracce di una tradizione annalistica e grammaticale ds età precedente, intesa
ad esemplare la storia dell'origine della commedia latina su quella della commedia greca, come parrebbe far
sospettare l'accostamento del termine satura (sattra o satyra, che però è forma dotta) ai Satyri (gr. sàtyroi)
del dramma satiresco greco, penetrato allora profondamente nello spirito del popolo italico. Ma non una è
l'etimologia di satura, come già vide il grammatico Diomede nel IV secolo d. C. (l). Di esse trovò maggior
credito tra gli antichi e i moderni quella varroniana, la quale riporta il termine a " satura lanx", un piatto fondo,
che, colmo di molte e varie primizie, veniva otTerto nelle sacre cerimonie agli dèi; ed era detta satura
dall'abbondanza e dalla varietà (saturttas) dei vari ingredienti. II termine satura perciò starebbe ad indicare in
origine quel misto di romano e di etrusco con elementi scenici vari, come ci è attestato da Livio, e, in seguito,
quel com ponimento letterario di soggetti, di forme e di metri vari, che ebbe l'avvío con Ennio e Pacuvio, fiorí
con Lucilio, Varrone, Orazio, Persio e Giovenale, e rimase nei secoli col nome stesso di "satira)>. E quando
di essa, piú tardi, Quintiliano si vanterà come di cosa "tutta nostra)> (satura quilem tota nostra est), intenderà
rilevare, con orgoglio romano, il carattere particolare di questa autentica forma d'arte latina, esaltandone
implicitamente anche le sue remote origini nazionali. 13 un vero peccato che della satura non ci sia
pervenuto neppure un frammento.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
237
Il saturnio
In saturni sono l’Odissea di Livio Andronico e il Bellum Punicum di Nevio, ma anche gli elogi degli
Scipioni.
Cf. scheda Conte-Pianezzola, Il libro della lett. Latina 2000, p. 9.
Con tesi di Pasquali e aggiornamenti. Un verso di origine greca, ma importato a Roma sotto forma
di cola in forma autonoma e utilizzati più che altro nella forma sacrale, non in quella epica, almeno
in una prima fase.
Difficile in ogni caso stabilire rapporti precisi tra un verso fluido e con molti aspetti accentuativi
come il saturnio e metri greci più rigidamente quantitativi, pur utilizzati da poeti come Andronico e
Nevio.
Inserire brano critico
Bibliografia
G. Pasquali, Preistoria della poesia romana, 1936.
C. Questa, s.v. Metrica latina arcaica, in Introduzione allo studio della cultura classica, 2, Milano,
Marzorati, 19882.
Controllo Canova
ICCU
Autore: Luiselli, Bruno
Titolo: Il verso saturnio / Bruno Luiselli
Pubblicazione: Roma : Edizioni dell'Ateneo, 1967
Descrizione fisica: 347 p. ; 22 cm . , Collezione: Studi di metrica classica
Autore: Morelli, Giuseppe
Titolo: Una testimonianza del Petrarca sul verso saturnio / Giuseppe Morelli ; con una appendice su
Aristoph.: Nub. 638 e Plat.: Resp. 400b
Pubblicazione: Padova : Imprimitur, 1996
Descrizione fisica: 98 p. ; 24 cm. , Collezione: Studi testi documenti / Dipartimento discienze dell'antichita,
Universita di Padova
TV0114 - Biblioteca comunale - Treviso - TV
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
238
L' atellana
Il nome deriva da Atella, una città della Campania in territorio osco.
E’ originariamente un genere popolare, per definire il quale si sono fatti raffronti con la commedia
dell’arte italiana.
Ebbe sicuramente inizio prima del teatro letterario regolare, ma secondo Conte venne utilizzata
anche con esso, come ”farsa finale” dopo tragedie e commedie e influenzò sicuramente i caratteri
di quest’ultima.
Verosimilmente si recitava a soggetto, con equivoci, bisticci e battute
Prevedeva maschere fisse con nomi altrettanto definiti Bucco (fanfarone), Dossennus (gobbo),
Pappus (vecchio da imbrogliare) controllo delle traduzioni proposte.
Il genere o, secondo altri, il “sottogenere” dell’atellana ebbe una storia piuttosto lunga, con periodi
di minor sviluppo e “ritorni” di fortuna.
Una stagione in cui essa risentì maggiormente di caratteri più colti e letterari può essere collocata
nel i secolo a.C., con autori quali Pomponio e Novio (v..
Dell’atellana troviamo del resto traccia anche in epoca imperiale.
Petronio
Giovenale
Svetonio
Testi e testimonianze
CASTIGLIONI MARIOTTI
Atella, ae, f.,
Atella, città degli Osci in Campania, CIC.; Atellanus, a, um, agg., di Atella, atellano, CIC.; fabella
Atellana o solo Atellana, ae, f., Atellana, farsa con maschera fissa; Atellanus, i, m., attore di
Atellana, QUINT. e a.; Atellani, orum, m., abitanti di Atella, PLIN.; Atellanicus (SUET.) e Atellanius,
a, um (CIC.), relativo alle atellane.
Livio., 7, 2, 8-12
Liuius post aliquot annis, qui ab saturis ausus est primus argumento fabulam serere, idem scilicet–id quod
omnes tum erant–suorum carminum actor, dicitur, cum saepius reuocatus uocem obtudisset, uenia petita
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
239
puerum ad canendum ante tibicinem cum statuisset, canticum egisse aliquanto magis uigente motu quia nihil
uocis usus impediebat. inde ad manum cantari histrionibus coeptum diuerbiaque tantum ipsorum uoci relicta.
postquam lege hac fabularum ab risu ac soluto ioco res auocabatur et ludus in artem paulatim uerterat,
iuuentus histrionibus fabellarum actu relicto ipsa inter se more antiquo ridicula intexta uersibus iactitare
coepit; unde exodia postea appellata consertaque fabellis potissimum Atellanis sunt; quod genus ludorum ab
Oscis acceptum tenuit iuuentus nec ab histrionibus pollui passa est; eo institutum manet, ut actores
Atellanarum nec tribu moueantur et stipendia, tamquam expertes artis ludicrae, faciant. inter aliarum parua
principia rerum ludorum quoque prima origo ponenda uisa est, ut appareret quam ab sano initio res in hanc
uix opulentis regnis tolerabilem insaniam uenerit.
Livio, parecchi anni dopo, fu il primo che osò abbandonare le sature e comporre un'opera
teatrale organizzata attorno ad un soggetto fisso. Siccome, a quanto si racconta, non
diversamente da quanto facevano allora tutti, egli era anche attore delle sue opere, gli capitò
di dover concedere parecchie repliche e di perdere la voce. In quell'occasione egli chiese
perdono e introdusse un fanciullo che cantò davanti al flautista; poi seguì il canto con dei
movimenti molto più appropriati perché non aveva la preoccupazione di articolare la voce. Da
allora in poi gli istrioni presero ad accompagnare con dei gesti la parte cantata e soltanto le
parti dialogate erano lasciate alla loro voce. E dunque, quando le opere teatrali cominciarono
ad avere struttura fissa, l'azione scenica divenne completamente diversa dalla comicità e
dallo scherzo un po' irriverente perché lo spettacolo stava diventando una vera e propria
espressione d'arte. I giovani allora lasciarono la recitazione delle opere regolari agli Istrioni e
ritornarono all'uso antico di lanciarsi reciprocamente dalle battute comiche in versi; da qui
nacquero quelle farse finali che furono accostate sopratutto alle Atellane. I giovani
conservarono per sé questo genere teatrale importato dagli Osci e non permisero che esso
fosse contaminato dagli attori di professione. Per questo fu stabilito allora che gli attori di
atellane non siano espulsi dalle tribù e prestino servizio militare in quanto non si tratta di
attori di professione. Penso di aver fatto bene a ricordare, tra le cose che hanno avuto inizi
modesti, anche le origini degli spettacoli teatrali: in questo modo sarà chiaro da quale onesto
principio essi siano mossi per arrivare a questa pazzia che anche i regni più ricchi a stento
riescono oggi a tollerare.
Tr. Mazzocato
Diom., ??
Tertia species est fabularum Latinarum, quae a civitate Oscorum Atella, in qua primum coeptae, appellatae
sunt Atellanae argumentis dictisque iocularibus similes satyricis fabulis Graecis.
Trovare testimonianza che parla di Silla come autore di Atellane.
Fest., verb.sign. 217
Personata fabula quaedam Naevi inscribitur, quam putant quidam primum <actam> a personatis
histrionibus. Sed cum post multos annos comoedi et tragoedi personis uti coeperint, verisimilius est eam
fabulam propter inopiam comoedorum actam novam per Atellanos, qui proprie vocantur personati; quia ius
est is non cogi in scena ponere personam, quod ceteris histrionibus pati necesse est.
Iuv., 6, 60 segg.
Porticibusne tibi monstratur femina uoto
digna tuo? cuneis an habent spectacula totis
quod securus ames quodque inde excerpere possis?
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
240
chironomon Ledam molli saltante Bathyllo
Tuccia uesicae non imperat, Apula gannit,
[sicut in amplexu, subito et miserabile longum.]
attendit Thymele: Thymele tunc rustica discit.
ast aliae, quotiens aulaea recondita cessant,
et uacuo clusoque sonant fora sola theatro,
atque a plebeis longe Megalesia, tristes
personam thyrsumque tenent et subligar Acci.
Vrbicus exodio risum mouet Atellanae
gestibus Autonoes, hunc diligit Aelia pauper.
soluitur his magno comoedi fibula, sunt quae
Chrysogonum cantare uetent, Hispulla tragoedo
gaudet: an expectas ut Quintilianus ametur?
accipis uxorem de qua citharoedus Echion
aut Glaphyrus fiat pater Ambrosiusque choraules.
Sotto i portici ti viene forse mostrata una donna che sia degna dei tuoi voti? In tutti i comparti a
cuneo dei teatri hanno forse gli spettatori da offrirti ciò che tu possa amare senza averne
preoccupazioni, ciò che di lì ti sia possibile scegliere? quando il femmineo Batillo balla la « Leda
» rappresentata a gesti, Tuccia non riesce a comandare... alla sua vescica, Appula a lungo
(come in un amplesso improvviso) e miserevolmente mugola di piacere, tende la sua attenzione
Timele: Timele (in quei momenti come una campagnola!)... impara. E da parte loro, le altre
donne, quando i sipari ormai riposti se ne stanno a riposo e, vuoto e chiuso il teatro, solo i Fori
risuonano di voci, quando dai Giochi Plebei lontani nel tempo sono i Megalesici, con volto
aggrottato continuano a tenere in mano maschera, tirso e... mutande di Accio! Urbico, in una
farsa, muove le risate con i gesti di una « Autonoe »... di Atella: è lui che Elia ama, dato che
dispone di pochi soldi; invece per il piacere di altre donne, è pagando gran prezzo che si riesce a
sciogliere la fibbia dell'attore di commedie! ce ne sono di quelle che mettono Crisogono in
condizioni... di non poter cantare; Ispulla, invece, si gode un attore tragico: ti aspetti forse che sia
Quintiliano ad essere amato? tu prendi una moglie, dalla quale è poi Echione citaredo oppure
Glafiro a diventare padre, e così Ambrosio, flautista che accompagna il coro!
Trad. e note di G. Viansino, Mondadori 1990.
60-113. Le donne si invaghiscono di uomini dello spettacolo (soprattutto gladiatori, che osano - da eroine
epiche - seguire anche in luoghi lontani); al v. 70 un esempio di « feticismo » femminile.
60-70: per i porticati, cfr. 4,6 (come i teatri ed il Circo, luoghi per incontri d'amore: cfr. Ovidio, a. a. 1,88-92 e
175); per spectacula, cfr. 2,34; per i mimi, cfr. 3,93 e 99 (per chiromon, cfr. 5,121); amori di Giove,
trasformato in cigno, e di Leda (Batillo: mimo d'età augustea, favorito di Mecenate. Per i nomi che si
trasmettono, cfr. vv. 77 e 70; e 13,125: medici); molli: effeminata delicatezza di movimenti; per gli spettacoli
che eccitano, cfr. 11,170 (per vesica, cfr. 1,39 e 11,170; per i mugolii dell'orgasmo, cfr. 9,78. - Schiavi,
valletti, mulattieri e gladiatori sono i soli ad eccitare le donne di alta classe: Petronio 126); Timele (cfr. 1,36;
8,197. - Per la ripetizione, cfr. v. 15; 3,53; 7,213; 8,159 e 243) conosce l'arte di fingere l'orgasmo, eppure ha
tutto da imparare; rusticus = pudore (cfr. Ovidio, a. a. 1,605); per aulaea, cfr. 10,39; per le Feste Megalensi,
cfr. 1,193 (in aprile) e le Feste Plebee (istituite per solennizzare la riconciliazione dopo la secessione
sull'Aventino) in novembre (417): nel frattempo, unico « spettacolo » erano gli avvocati nel Foro; per tristes,
cfr. 9,1; per il tirso, cfr. 7,60 (usato per la rappresentazione di
azioni « satiresche » riguardanti Bacco e simbolo sessuale: si trattava di « vesti sceniche », comperate come
« ricordini » per le « reliquie » dell'amato, cfr. vv. 383-4). 71-9: per 1'exodium, cfr. 3,175 (a Roma si
rappresentavano ancora quelle che proponevano parodie del mito); Utbico è nome ricorrente nel mimo;
Autonoe, figlia di Cadmo tebano, fu sorella (anche lei invasata da Dioniso) di Agave (cfr. 7,87), che fece a
pezzi il figlio Penteo (il racconto tragico era rappresentato a gesti, nella forma propria dell'Atellana. - Per
l'accostamento « inatteso » Atellanae... Autonoes, cfr. 5,59: « Ganimede getulico »); per conservare la voce,
gli attori limitavano la loro attività sessuale (una specie di cintura di castità - cfr. v. 379; Marziale 7,82; 11,75;
14,215 - applicata su fori fatti nella pelle - cfr. Celso 7,25,3 - li difendeva dalle voglie femminili ed accresceva
il prezzo delle loro prestazioni); gli attori della « popolare » Atellana si accontentavano di poco per
concedere le loro grazie; per Crisogono citaredo, cfr. 7,176; per Ispulla, cfr. 12,11; per « attore tragico », cfr.
v. 396; per Quintiliano, cfr. v. 280; 7,186 (l'uomo di cultura contrapposto al mondo dello spettacolo. - Altri
pensa ad una sarcastica allusione alla « moralità » del maestro, che aveva sposato chi poteva essergli
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
241
figlia); per exspecto, cfr. v. 239; 14,25; per il citaredo, cfr. 10,210 (Glafiro, famoso in età augustea, e poi un
altro in età domizianea: cfr. Marziale 4,5,8. - Per l'eredità dei nomi, cfr. v. 63); per la moglie che ha figli da
gente dello spettacolo, cfr. Marziale 6,39,19 (e per i figli illegittimi, cfr. v. 600); palchi (cfr. 3,174) presi in
affitto (cfr. 7,45) venivano piantati lungo le strette strade (cfr. 3,236) per assistere alle processioni celebranti
festivi tà di nobili; per il v. 79, cfr. vv. 51-2 (per grandfs, cfr. 12,91).
80-9: il ritmo dei w. 80-1 indica
prima la solennità domestica della casata, poi la sua caduta; per le scaglie di tartaruga, cfr. 11,94; per
Lentulo, cfr. 7,95; 8,187 (possedeva quattrocento milioni di sesterzi, come il liberto Narciso: cfr. 14,329); per
il mirmillone, cfr. 8,200; senator: non è detto sia Veientone (cfr. v. 113; 4,113), che può valere come nome
emblematico di vecchio odioso e ripugnante; Eppia accompagna una « Scuola » di gladiatori in « tournée »
in Egitto; per il Faro, cfr. 12,76 (Lago, ammiraglio di Alessandro, relegò a funzioni religiose l'antica capitale,
Menfis, d'Egitto - che gli era toccato in sorte, dopo Alessandro - abbellendo con opere pubbliche la nuova
capitale Alessandria); per famosus, cfr. 15,46 ed anche 1,26 (Canopo è autorizzata a condannare
l'immoralità delle donne romane); per prodigia, cfr. 4,97; sororis: cfr. v. 111 (è un fatto di cronaca vera);
patriae: i doveri sociali che le competevano; per improba, cfr. 3,282 (è l'esatto contrario della « montanara »
dei vv. 5-9); per il v. 87, cfr. 3,223; 11,53 (per Paride, cfr. 7,87); per le « piume », cfr. 1,159; per segmentatis,
cfr. 2,124,
91-
Petr. Sat. 53,12
Mirabatur haec solus Trimalchio dicebatque ingratum artificium esse. ceterum duo esse in rebus humanis
quae libentissime spectaret, petauristarios et cornic<i-n>es; reliqua [animalia] acroamata tricas meras esse.
'nam et comoedos' inquit 'emeram, sed malui illos Atell<ani>am facere, et choraulen meum iussi Latine
cantare.'
Petr., sat. 68,5
Nullus sonus umquam acidior percussit aures meas; nam praeter errantis barbariae aut adiectum aut deminutum clamorem miscebat Atellanicos versus, ut tunc primum me etiam Vergilius offenderit.
Porph., ad Hor.ep., 2,1,145
Fescennina. Per hunc, inquit, morem ueterum agricolarum etiam Fescennina inuenta sunt, in quibus exprimebantur iocosa conuicia. Dicta autem Fescennina ab oppido Fescennino, unde primum processerunt et
A<t>ellanica nominata sunt.
Suet., Cal.
Atellan[i]ae poetam ob ambigui ioci uersiculum media amphitheatri harena igni cremauit.
Val. Mass. 2,4,4
Nunc causam instituendorum ludorum ab origine sua repetam. C. Sulpico Petico C. Licinio Stolone
consulibus intoleranda uis ortae pestilentiae ciuitatem nostram a bellicis operibus reuocatam domestici atque
intestini mali cura adflixerat, iamque plus in exquisito et nouo cultu religionis quam in ullo humano consilio
positum opis uidebatur. itaque placandi caelestis numinis gratia conpositis carminibus uacuas aures praebuit
ad id tempus circensi spectaculo contenta, quod primus Romulus raptis uirginibus Sabinis Consualium
nomine celebrauit. uerum, ut est mos hominum paruula initia pertinaci studio prosequendi, uenerabilibus
erga deos uerbis iuuentus rudi atque inconposito motu corporum iocabunda gestus adiecit, eaque res ludium
ex Etruria arcessendi causam dedit. cuius decora pernicitas uetusto ex more Curetum Lydorumque, a quibus
Tusci originem traxerunt, nouitate grata Romanorum oculos permulsit, et quia ludius apud eos hister
appellabatur, scaenico nomen histrionis inditum est. paulatim deinde ludicra ars ad saturarum modos
perrepsit, a quibus primus omnium poeta Liuius ad fabularum argumenta spectantium animos transtulit,
isque sui operis actor, cum saepius a populo reuocatus uocem obtudisset, adhibito pueri ac tibicinis
concentu gesticulationem tacitus peregit. atellani autem ab Oscis acciti sunt. quod genus delectationis Italica
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
242
seueritate temperatum ideoque uacuum nota est: nam neque tribu mouetur <actor> nec a militaribus
stipendiis repellitur.
Bibliografia
ICCU Soggetto
Titolo: Atellanae fabulae / edidit Paulus Frassinetti
Pubblicazione: Romae : in aedibus Athenaei, 1967 , Collezione: Poetarum latinorum reliquiae
ICCU Niente per autore
"Fabulae Atellanae - Encarta"
Atellana Rappresentazione farsesca popolare in voga nell’antica Roma. Assimilabile, per certi versi, a quella
che sarà nella tradizione italiana la commedia dell’arte, la fabula atellana è caratterizzata
dall’improvvisazione dei soggetti e dalla fissità dei personaggi, tra i quali ricorrenti erano le “maschere” di
Bucco, lo stupido, di Dossenus, il gobbo, di Pappus, il vecchio da raggirare.
Il suo nome è legato ad Atella, città della Campania, il che testimonia che la probabile origine di questo
genere è da ricercare presso le popolazioni dell’Italia preromana, soprattutto osche. L’atellana, agli albori
della letteratura latina, era molto probabilmente priva di ogni redazione scritta. Questo non impedì che la sua
diffusione – al pari dei fescennini, altro genere prettamente orale – influenzasse profondamente le produzioni
letterarie, prima fra tutte il teatro di Plauto. Vi furono in seguito tentativi di codificarla in vero e proprio genere
letterario, e ciò avvenne specialmente in età sillana per opera di Lucio Pomponio e Novio, delle cui opere
non abbiamo però che scarsissime testimonianze.
"Fabulae Atellanae - Treccani"
Atellane. Le Fabulae Atellanae, così dette dai latini per la loro provenienza da Atella in Campania, dove si
rappresentavano in ricorrenze religiose, erano composizioni farsesche comuni alla letteratura popolare degli
Osci. Ce ne parla tra i primi Tito Livio (VII). Originariamente in lingua osca, vennero poi composte anche in
latino e recitate come exodia al termine degli spettacoli istrionici.
E' incerta l'epoca in cui le a. vennero introdotte in Roma: certamente dopo le guerre sannitiche,
durante le quali furono conosciute, e prima del 240 a.C., quando per merito di Livio Andronico ebbero inizio
regolari rappresentazioni drammatiche.
La farsa, ordinariamente di carattere comico-osceno, riproduceva la vita comune della plebe e dei
contadini e veniva improvvisata intorno a un intreccio prestabilito (trica). I personaggi caratteristici, cui in
seguito se ne aggiunsero altri secondo le regioni, erano Maccus, il ghiottone, Pappus, il vecchio rimbambito,
Buccus, lo spaccone, e Dossennus, il gobbo astuto. Tra i poeti d'a. si ricordano L. Pomponio, Novio e lo
stesso L. Cornelio Silla, sotto la cui dittatura l'a. abbandonò il genere d'improvvisazione per assurgere a
forma autentica d'arte.
Riposati
c) Atellana. Assai vicina agli spiriti liberi dei Fescenntni e della Satura romana, ma contenuta e disciplinata
nell'impostazione drammatica entro certi schemi determinati, e perciò piú aflìne alla commedia d'arte, è la
fabula Atellana. Gli antichi scrittori (Livio, Valerio Massimo, Diomede, ecc.) concordano quanto al nome, che
pongono in relazione con Atella, piccola città osca tra Capua e Napoli (oggi Sant'Arpino d'Atella), donde la
fabula ebbe origine. In realtà era quella una terra feconda di briosa comicità, punto d'incontro di diverse
correnti ètniche e culturali, greche, italiche ed etrusche, sin dal secolo VII a. C. II suo nome era legato a
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
243
quelle frequenti rappresentazioni di farse indígene, che tanto piacquero al popolo, da uscire ben presto dai
limiti locali e raggiungere Roma circa il 300 a. C., ad opera dei Rvmani stessi o dei Campani(l).
Ciò permette di distinguere anche nella storia dell'Atellana due momenti evolutivi: quello dell'origine, I'osco,
nel quale essa rimase sempre un genere di improvvisazione estemporanea, e quello della sua
ambientazione romana, quando venne elevata a un vero e proprio genere di commedia, ed ebbe, all'epoca
di Silla, poeti di nome, come Pomponio e Novio.
L'atellana primitiva, siccome ci è dato intendere dal giudizio degli antichi e dai frammenti rimastici di quella
letteraria, rispecchia in pieno il carattere realistico e la sàpida spassosità dello spirito italico: piccole scene
comiche, improwisate nei crocicchi delle vie e sulle piazze, fresche e vivaci di lazzi, di allusioni equivoche e
personali briose e sostenute sí da suscitare riso e buon umore negli spettato;i, mai confusione o disgusto. In
tal maniera le atellane, mentre si ricollegano, per l'intonazione, allo spinto del dramma satiresco greco (e
verranno poi usate anch'esse come exodtum), costituiscono un magnifico precedente della nostra commedia
d'arte.
Le improwisazioni venivano condotte su una specie di canovaccio prestabilito, risultante dall'intrico
buffonesco e bizzarro degli incidenti comici (tricae), ed erano facilitate dall'impiego di quat tro maschere
costanti, che caratterizzavano e denominavano gli stessi attori: Maccus, lo sciocco, lo stupido, il tonto (nel
dialetto sardo anche oggi maccu vale ' scioccone'); preannunzia il tipo ' Arlecchino ' o ' Pulcinella '; Bucco (da
connettere con bucca), il " gran mangione 1>, oppure il " fanfarone )>, il " chiacchierone sguaiato " (anticipa il
nostro ' Brighella '); Pappus (in osco Camar, in latino canus, " canuto"), il vecchio scimunito, avaro, ridicolo,
ambizioso (il nostro ' Pantalone'); Dossennus (o Dossenus), il gobbo astuto, malizioso (dossus = lorsus per
terXurn, già in Plauto): nella favola antica tale era ritenuto il gobbo; poi divenne caricatura del ' dotto', in
genere, e indicò il "dottore)), il asaccente" (il nostro ' Balanzóne '). L'uso costante di codeste maschere
doveva portare naturalmente a una certa staticità e, spesso, banalità della scena, che solo la valentía
dell'attore poteva riuscire a superare.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
244
Prime forme letterarie
Appio Claudio Cieco
Cenni biografici
Nacque intorno al 350 a.C.. Fu censore dal 312 al 307 a.C. e console nel 307 e nel 296 a.C.. Per
sua iniziativa venne costruito nel 312 il primo tratto il primo tratto della via che collegava Roma a
Capua e che da lui prese nome di via Appia, appunto, e progettò il primo grande acquedotto,
l’Aqua Claudia. Pur di origini aristocratiche, dimostrò posizioni popolari riformando come censore
le liste dei cittadini, aprendo così la via al Senato anche ai plebei.
Cicerone nel Brutus ce lo presenta come buon oratore, che riesce a distogliere il senato dalla pace
che sta per concludere con Pirro e Gaio Fabrizio; sembra che del discorso fecesse una parafrasi il
poeta Ennio, ma sia questa che la trascizione sono andate perdute.
Sempre nel Brutus eccolo “oratore pieno di zelo, molto colto ed esperto ed inoltre assai versato
nella conoscenza del diritto augurale, di tutto il diritto pubblico e delle antichità romane.”
Per Pomponio., ench., 36, = D. ??? A.C. è uno dei decemviri(? Di che?), ed è dotato di maximam
scientiam nella dottrina giuridica.
Interessi linguistici vengono provati dalla notizia che Appio avrebbe introdotto nella scrittura la
differenza fra r e s e bandito la consonante z (cf. per questo anche Accio).
In realtà all’impulso di Appio dobbiamo la volgarizzazione delle norme giuridiche del così detto Ius
Flavianum, perché il compilatore fu un suo liberto, Gneo Flavio.
Ritrattto della sua felice vecchiaia dato da Cicerone in Lael. .
.
Opere
Abbiamo frammenti, per un totale di 23 parole, in W. Morel, Fragmenta poetarum latinorum
epicorum et lyricorum praeter Ennium et Lucilium, Leipzig, Teubner, 1927.
Cicerone (Tusc., 4,4,7) parla di un Carmen Pytagoreum, in realtà intitolato Sententiae, intessuto di
sentenze morali ed apprezzato da Panezio in una lettera; in versi saturni: i principi della sapienza
romana non vi erano disgiunti da quella greca.
Resta da Pomponio notizia di un trattato giuridico De usurpationibus, già perduto ai tempi di
Pomponio stesso. L’unicità del tema sarebbe da confrontare con quella di Manilio (venalium
vendend. V. a voce) e di Servio (de dotibus v. a voce).
Bretone, Storia del diritto romano, TavCron., parla, per il 310, di una discussione tra Appio e P.
Sempronio Sofo sul valore della lex.
Testi e testimonianze
Cic., Cato, 37
Quattuor robustos filios, quinque filias, tantam domum, tantas clientelas Appius regebat et caecus et senex;
intentum enim animum tamquam arcum habebat nec languescens succumbebat senectuti; tenebat non
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
245
modo auctoritatem, sed etiam imperium in suos, metuebant servi, verebantur liberi, carum omnes habebant;
vigebat in illa domo mos patrius disciplina.
Un Appio Claudio guidava quattro figli ben validi e cinque figlie, governava una famiglia assai
grande, una numerosissima clientela; ed era cieco, oltre che vecchio: Ma tutto ciò perché teneva il
suo spirito desto come un arco teso e non cedeva languidamente all'età: Esercitava sui suoi non
autorità, ma una vera e propria signoria: la servitù lo temeva, i figli lo rispettvano, era caro a tutti:
nella sua casa erano in onore il costume e la regola di vita dei padri.
Cic., Brutus, 55
Possumus Appium Claudium suspicari disertum, quia senatum iamiam inclinatum a Pyrrhi pace revocaverit;
possumus C. Fabricium, quia sit ad Pyrrhum de captivis recuperandis missus orator; Ti. Coruncanium, quod
ex pontificum commentariis longe plurumum ingenio valuisse videatur.
E possiamo congetturare che fosse buon parlatore Appio Claudio, che distolse il senato dalla pace
che stava per concludere con Pirro e Gaio Fabrizio, perché fu mandato ambasciatore da Pirro a
trattare il riscatto dei prigionieri; e Tiberio Coruncanio perché dai libri dei pontefici risulta che
esercitò larga influenza per la forza del suo ingegno.
Traduzione di E. Malcovati, Milano, Mondadori, 1996.
Cic., Brutus, 267
Appius Claudius socer tuus, conlega et familiaris meus: hic iam et satis studiosus et valde cum doctus tum
etiam exercitatus orator et cum auguralis tum omnis publici iuris antiquitatisque nostrae bene peritus fuit.
Appio Claudio, tuo suocero e mio collega e famigliare, che fu oratore pieno di zelo, molto colto ed
esperto ed inoltre assai versato nella conoscenza del diritto augurale, di tutto il diritto pubblico e
delle antihità romane.
Traduzione G. Norcio, Torino, Utet, 1970.
Cic., Tusc., 4,3-4 (2)
Ex quo perspicuum est et cantus tum fuisse discriptos vocum sonis et carmina. quamquam id quidem etiam
duodecim tabulae declarant, condi iam tum solitum esse carmen; quod ne liceret fieri ad alterius iniuriam,
lege sanxerunt. nec vero illud non eruditorum temporum argumentum est, quod et deorum pulvinaribus et
epulis magistratuum fides praecinunt, quod proprium eius fuit, de qua loquor, disciplinae. mihi quidem etiam
Appii Caeci carmen, quod valde Panaetius laudat epistola quadam, quae est ad Q. Tuberonem,
Pythagoreum videtur. multa etiam sunt in nostris institutis ducta ab illis; quae praetereo, ne ea, quae
repperisse ipsi putamur, aliunde didicisse videamur.
E d'altronde il fatto che la poesia fosse diffusa già a quei tempi ci è testimoniato anche dalle Dodici
Tavole, che proibiscono di comporre carmi diffamatori. Un'altra prova dell'elevato livello culturale
dell'epoca è l'usanza di suonare la cetra ai sacri simposii e ai banchetti dei magistrati - usanza che
fu caratteristica appunto della scuola di cui parlo. E di intonazione pitagorica, per me, è anche
l'opera poetica di Appio Cieco, di cui Panezio parla molto bene in una lettera a Quinto Tuberone.
Traduzione di A. Di Virginio, Milano, Mondadori, 1996.
Ennio (ann., 6, 199-200) in Cic., Cato 17.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
246
quo vobis mentes, rectae quae stare solebant antehac, dementes sese flexere viai? (4).
Ceteri senes, Fabricii Curii Coruncanii, cum rem publicam consilio et auctoritate defendebant, nihil agebant?
ad Appi Claudi senectutem accedebat etiam ut caecus esset; tamen is, cum sententia senatus inclinaret ad
pacem cum Pyrrho foedusque faciendum, non dubitavit dicere illa quae versibus persecutus est Ennius:
'Quo vobis mentes, rectae quae stare solebant
antehac, dementes sese flexere viai?'
ceteraque gravissime; notum enim vobis carmen est; et tamen ipsius Appi extat oratio. atque haec ille egit
septimo decimo anno post alterum consulatum, cum inter duos consulatus anni decem interfuissent
censorque ante superiorem consulatum fuisset; ex quo intellegitur Pyrrhi bello grandem sane fuisse; et
tamen sic a patribus accepimus.
Traduzione .
Sallustio cita una delle sententiae di Appio
Sall., ad Caes. Ep. 1,1,2
Sed res docuit id verum esse, quod in carminibus Appius ait, fabrum esse suae quemque fortunae, atque in
te maxume, qui tantum alios praegressus es, ut prius defessi sint homines laudando facta tua quam tu laude
digna faciundo, ceterum ut fabricata sic virtute parta, quam magna industria haberei decet, ne incuria
deformentur aut conruant infirmata.
Ma l’esperienza ha dimostrata vera la massima di Appio, che cioè ciascuno è artefice della propria
fortuna; e questo nel caso tuo in particolare, che hai spinto tanto innanzi la tua superiorità sugli altri
che la gente si è stancata prima di esaltare le tue gesta che tu di compiere imprese lodevoli.
Liv., 10,22 sollers iuris
Fabi oratio fuit, qualis biennio ante; deinde, ut uincebatur consensu, uersa postremo ad collegam P. Decium
poscendum: id senectuti suae adminiculum fore. censura duobusque consulatibus simul gestis expertum se
nihil concordi collegio firmius ad rem publicam tuendam esse. nouo imperii socio uix iam adsuescere senilem
animum posse; cum moribus notis facilius se communicaturum consilia. subscripsit orationi eius consul cum
meritis P. Deci laudibus, tum quae ex concordia consultum bona quaeque ex discordia mala in
administratione rerum militarium euenirent memorando, quam prope ultimum discrimen suis et collegae
certaminibus nuper uentum foret admonendo: Decium Fabiumque qui uno animo, una mente uiuerent esse
praeterea uiros natos militiae, factis magnos, ad uerborum linguaeque certamina rudes. ea ingenia
consularia esse: callidos sollertesque, iuris atque eloquentiae consultos, qualis Ap. Claudius esset, urbi ac
foro praesides habendos praetoresque ad reddenda iura creandos esse. his agendis dies est consumptus.
postridie ad praescriptum consulis et consularia et praetoria comitia habita. consules creati Q. Fabius et P.
Decius, Ap. Claudius praetor, omnes absentes; et L. Uolumnio ex senatus consulto et scito plebis
prorogatum in annum imperium est.
Traduzione
Dig.1.2.2.36
Pomponius l.S. enchir.
Fuit autem in primis peritus publius papirius, qui leges regias in unum contulit. ab hoc appius claudius unus
ex decemviris, cuius maximum consilium in duodecim tabulis scribendis fuit. post hunc appius claudius
eiusdem generis maximam scientiam habuit: hic centemmanus appellatus est, appiam viam stravit et aquam
claudiam induxit et de pyrrho in urbe non recipiendo sententiam tulit: hunc etiam actiones scripsisse traditum
est primum de usurpationibus, qui liber non exstat: idem appius claudius, qui videtur ab hoc processisse, r
litteram invenit, ut pro valesiis valerii essent et pro fusiis furii.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
247
Bibliografia
Frammenti in W. Morel, Fragmenta poetarum latinorum epicorum et lyricorum praeter Ennium et
Lucilium, Leipzig, Teubner, 1927.
FPL Blansdorf 1995, pp.11-13.
Per le testimonianze sulle orazioni cf. H. Malcovati, Oratorum Romanorum Fragmenta Liberae Rei
Publicae, Torino, 19764 pp. 1-4.
Per gli aspetti legati alla storia del diritto F. D’Ippolito, Giuristi e sapienti di Roma antica, RomaBari, Laterza, 1986.
F. P. Bremer, Iurisprudentiae antehadrianeae quae supersunt, 2 voll. Leipzig 1896-1901.
Vol. 1, Lipsiae 1896, F.P. Bremer (anast. Leipzig 1985), pp.1-6.
ICCU completo
Autore: Amatucci, Aurelio Giuseppe
Titolo: Appio Claudio Cieco / Aurelio Giuseppe Amatucci
Pubblicazione: Torino : E. Loescher, 1893
PHI
"Appio Claudio Cieco - Encarta"
Claudio Cieco, Appio (IV-III secolo a.C.), uomo politico, scrittore e oratore romano. Fu censore dal 312 al
307 a.C. e console nel 307 e nel 296 a.C. Favorì costantemente i plebei e riformò le regole relative allo
status civico, introducendo nel senato anche figli di schiavi liberati. Nel 312 fece costruire il primo tratto della
via Appia, che collegava Roma a Capua. Celebre è l'orazione da lui pronunciata al senato contro le proposte
di pace dell'ambasciatore di Pirro. Ad Appio sono attribuite alcune sentenze morali, raccolte nei Carmina,
delle quali sono rimasti solo pochi frammenti.
"Appio Claudio Cieco - Treccani"
Claudio Cieco Appio. Una delle figure più rappresentative del periodo eroico della storia di Roma. Fu uomo
politico, ottimo comandante in guerra, esperto di diritto, cultore di lettere ed oratore. Nacque verso il 350 a.C.
e fu censore, console e dittatore. Durante la sua censura del 31 si iniziò la costruzione del primo acquedotto
di Roma e della grande strada che da lui prese il nome. La via Appia seguiva nel primo tratto il tracciato della
vecchia via Albana : giungeva a Capua e successivamente fu prolungata fino al Benevento e di lì a Brindisi.
Per la sua ilnportanza venne detta Regina varium. Ad Appio dobbiamo la volgarizzazione delle norme
giuridiche delJus Flavianumperché il compilatore fu un suo liberto, Gneo Flavio. Tale sanzione in un testo
delle norme del diritto costituì un'altra vittoria della parte popolare romana.
Appio fo un uomo aperto al nuovo soffio di cultura venuto dalla Magna Grecia; da Cicerone
sappiamo che scrisse un carme con tracce di dottrina pitagorica e di massime della poesia gnomica greca.
E' di Appio il famoso detto secondo cui ciascuno è artefice della propria fortuna. Interpretò lo slancio
espansionistico di Roma e con la sua virtù contribuì alle vittorie della terza guerra sannitica. Nel 280, dopo la
sconfitta dei Romani ad Eraclea, Pirro mandò ambasciatori per la pace. Appreso che si correva il pericolo
che fosse concessa, Appio si fece accompagnare in Senato e sostenne che di pace si sarebbe parlato
soltanto dopo che Pirro avesse lasciato l'Italia. Il discorso, che fu poi scritto e di cui fece una parafrasi il
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
248
poeta Ennio, è andatò perduto. C. introdusse nella scrittura la differenza fra r e s e bandì la consonante z.
Noto l'affreseo del Maccari, rappresentante Appio Claudio in Senato, che è a Palazzo Madama a Roma.
Appio Claudio il Cieco - Riposati
APPIO CLAUDIO CIECO: uomo di eccezionale valore, espressione alltentica di antica romanità e
antesignano di tempi nuovi, tempra vigorosa di cittadino e di soldato, ardito e geniale riformatore, giurista,
grammatico, poeta, oratore. La sua figura appartiene alla storia piú che alla letteratura, ma per varietà di
interessi e concretezza di ideali umani, per robustezza di ingegno e originalità di maniere sta senza dubbio,
innanzi a Livio Androníco, tra gli iniziatori delle forme letterarie latine.
Aristocratico di sangue, perché discendente dall'antichissima famiglia patrizia dei Claudi (forse sabini), da cui
ereditò fierezza di carattere e tenacia di volontà, consacrò tutta la vita al trionfo degli ideali democratici in un
fulgido esempio di virile austerità morale e di assidua, feconda operosità. Le impellenti riforme economiche e
sociali, le difficilissime condizioni politiche e militari di Roma, minacciata dai Galli, combattuta dagli Etruschi,
dai Sanniti e dai Sabini, lo trovarono sempre in prima linea nei posti di responsabilità e di comando, durante
la lunga, e spesso ricorrente, carriera politica di tribuno militare, edíle curúle, censore (312), console (307 e
296), dittatore, interrège, pretore (295). Dovunque impresse l'orma della sua personalità ardimentosa e
battagliera. Console, sconfisse con il collega Lucio Volumnio i Sanniti (307), i Sabini e gli Etruschi (296);
censore, superando il vieto pregiudizio aristocratico, riformò le liste dei cittadini, aprendo la via al Senato
anche ai plebei; realizzò, tra difficoltà di ogni sorta, I'ardito progetto del primo grande acquedotto romano,
che si chiamò con il suo nome (Aqua Claudia); costruí la regina viarum ('), la Via Appia, collegando Roma
con la Campania. E intanto incrementò e abbellí l'edilizia cittadina, innalzò templi agli dèi, riformò il culto di
Ercole (1), disciplinò quello di Giove Capitolino (2), costruì il Foro Appio. La piú bella lode di questo
straordinario uomo di stato è romanamente scolpita nella sua iscrizione funebre: " Molte terre tolse ai
Sanniti, sbaragliò l'esercito dei Sabini e degli Etruschi, impedí che si facesse pace con il re Pirro, censore
fece la via Appia e portò l'acqua a Roma, innalzò un tempio a Bellóna " (3).
Sul cittadino si innesta l'uomo di lettere. Ma della sua varia produzione letteraria, oratoria, poetica, giuridica,
grammaticale a noi purtroppo non è giunta che una vaga memoria e qualche striminzito frammento,
conservatoci per fini di esemplificazione lessicale da scrittori posteriori
Eppure anche da questo poco è possibile farsi un'idea della personalità dello scrittore, che mira soprattutto a
fini pratici e mora sstlcl.
Anzitutto con le sue Orationes. Non è dato precisare quante egli ne abbia pronunziate o scritte, affidandosi
piú all'estro e alla spontaneità delle sue doti naturali che alla cura dell'arte, da lui forse non del tutto ignorata.
Cicerone comunque ricorda Appio con sincera simpatia (De sen., 6, 16), e lo dice oratore a facondo )>
(disertum: Brut., 14, 55), a proposito della celebre orazione, che egli, vecchio e cieco, pronunziò nel 280
davanti al Senato, scongiurandolo di non cedere alle insolenti proposte di pace di Cínea, legato di Pirro; e
aggiunge che quel " gravissimo " discorso, letto ancora ai suoi tempi, riscosse persino l'ammirazione di
Ennio, che lo introdusse nei suoi Annales, da cui egli, Cicerone, trasse i due esametri seguenti:
quo vobis mentes, rectae quae stare solebant antehac, dementes sese flexere viai? (4).
Parole forti, solenni, ammonitrici, quasi ispirate, di chi, pur nelI'awersa fortuna, ha sicura coscienza della
indistruttibilità del destino di Roma.
Ma dal punto di vista letterario il nome di Appio è legato soprattutto alle sue Sententiae, una raccolta di
"massime)> morali nell'andamento del verso saturnio, se non veri saturnii esse pure, ricche dx pensosa
esperienza umana e di schietta saggezza latina sostanziata da succhi dottrinali greci. Celebre fra tutte, di
sapore proverbiale, quella che esalta la divina capacità che ha l'uomo di a crearsi la propria fortuna "fabrum
esse suae quemque fortunae".
Per questo fondo nativo di sana eticità. Ie Sententiae appiàne piacquero al filosofo stoico Panèzio (') e a
Cicerone, che vi individuò filoni di dottrina pitagorica, sí da giudicarle addirittura un carmen pythagoreum.
Forse con questa attenzione le lesse il pitagorico Sallustio, se a lui dobbiamo una delle tre sentenze '
superstiti (2).
Accanto al poeta moralista sta il grammatico, ricordato dagli antichi per alcune innovazioni ortografiche e
fonetiche nell'alfabeto latino: quali l'abolizione della lettera z e la rotacizzazione della s intervocalica (Valesii
= Vulerii; Lases = Lares). II poeta Accio, piú tardi, si porrà su questa stessa linea.
Piú interessante fu la sua opera di giurista, non solo come scrittore di un trattato De usurpationibus, d; cui
nulla ci rimane ma anche come promotore e fautore della nuova legislazione procedurale, che tendeva ad
impostare su basi piú democratiche i rapporti giuridici delle classi sociali. II lavoro di codificazione venne
condotto a termine dal suo segretario, Gneo Flavio.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
249
CONSIDERARE SE RIPORTARE NELLA SEZIONE DIRITTO PIU’ SOTTO I TRE SUCCESSIVI
Gneo Flavio
Segretario di Appio Claudio Cieco, condusse a termine un lavoro di codificazione che tendeva a
democraticizzare i rapporti giuridici tra diverse classi sociali. Il testo dello ius Flavianum fu fatto
pubblicare nel 304 a.C..
Edile curule nel 304.
Testi e testimonianze
Pompon., D. 1,2,2, 6-7
Controllo e traduzione
Postea cum Appius…et aedilis curulis
Liv., 9, 46, 1-15
Eodem anno Cn. Flauius Cn. filius scriba, patre libertino humili fortuna ortus, ceterum callidus uir et
facundus, aedilis curulis fuit. inuenio in quibusdam annalibus, cum appareret aedilibus fierique se pro tribu
aedilem uideret neque accipi nomen quia scriptum faceret, tabulam posuisse et iurasse se scriptum non
facturum; quem aliquanto ante desisse scriptum facere arguit Macer Licinius tribunatu ante gesto
triumuiratibusque, nocturno altero, altero coloniae deducendae. ceterum, id quod haud discrepat,
contumacia aduersus contemnentes humilitatem suam nobiles certauit; ciuile ius, repositum in penetralibus
pontificum, euolgauit fastosque circa forum in albo proposuit, ut quando lege agi posset sciretur; aedem
Concordiae in area Uolcani summa inuidia nobilium dedicauit; coactusque consensu populi Cornelius
Barbatus pontifex maximus uerba praeire, cum more maiorum negaret nisi consulem aut imperatorem posse
templum dedicare. itaque ex auctoritate senatus latum ad populum est ne quis templum aramue iniussu
senatus aut tribunorum plebei partis maioris dedicaret.–haud memorabilem rem per se, nisi documentum sit
aduersus superbiam nobilium plebeiae libertatis, referam. ad collegam aegrum uisendi causa Flauius cum
uenisset consensuque nobilium adulescentium, qui ibi adsidebant, adsurrectum ei non esset, curulem adferri
sellam eo iussit ac sede honoris sui anxios inuidia inimicos spectauit.–ceterum Flauium dixerat aedilem
forensis factio, Ap. Claudi censura uires nacta, qui senatum primus libertinorum filiis lectis inquinauerat et,
posteaquam eam lectionem nemo ratam habuit nec in curia adeptus erat quas petierat opes urbanas,
humilibus per omnes tribus diuisis forum et campum corrupit; tantumque Flaui comitia indignitatis habuerunt
ut plerique nobilium anulos aureos et phaleras deponerent. ex eo tempore in duas partes discessit ciuitas;
aliud integer populus, fautor et cultor bonorum, aliud forensis factio tenebat, donec Q. Fabius et P. Decius
censores facti et Fabius simul concordiae causa, simul ne humillimorum in manu comitia essent, omnem
forensem turbam excretam in quattuor tribus coniecit urbanasque eas appellauit. adeoque eam rem
acceptam gratis animis ferunt ut Maximi cognomen, quod tot uictoriis non pepererat hac ordinum
temperatione pareret. ab eodem institutum dicitur ut equites idibus Quinctilibus transueherentur.
46. In quello stesso anno uno scrivano, Gneo Flavio, che era di umile estrazione, in quanto figlio
di un liberto, ma era anche molto accorto e abile nel parlare, fu eletto edile curule. Secondo
alcuni annali, mentre era ancora un funzionario degli edili, gli capitò di constatare di essere
designato edile dalla tribù che esprimeva il suo voto per prima ma poi l'elezione non veniva
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
250
convalidata a causa del suo mestiere di scrivano; allora avrebbe buttato via la tavoletta giurando
che mai più avrebbe fatto lo scrivano.
Diverso quanto riferisce Licinio Macro: Gneo Flavio già da tempo aveva smesso l'attività di
scrivano. Era già stato tribuno della plebe e triumviro (la prima volta come triunviro notturno, la
seconda volta come triumviro incaricato della deduzione di una colonia). Comunque su una cosa
tutti sono d'accordo: molto duramente egli lottò contro il disprezzo dei nobili per la sua bassa
condizione sociale; divulgò il diritto civile che veniva tenuto celato dai pontefici nei loro penetrali
e pubblicò su tavole bianche infisse tutto attorno al Foro l'elenco dei giorni fasti in modo che
ognuno sapesse quando si poteva amministrare la giustizia. Consacrò un tempio alla dea
Concordia nella piazza di Vulcano, anche in questo caso con grande opposizione dei nobili. In
questa occasione il pontefice massimo Cornelio Barbato, fu costretto dall'unanime spinta
popolare, a suggerire la formula, anche se sosteneva che, secondo la tradizione avita, solo un
console o un magistrato investito dell'imperio, poteva consacrare un tempio. Anzi, in seguito a
ciò, su proposta senatoria fu presentata al popolo una legge che impediva a chiunque di
consacrare un tempio o un altare senza l'autorizzazione del senato o della maggioranza dei
tribuni della plebe. E qui voglio raccontare un aneddoto, di per sé trascurabile ma, in ogni caso,
indizio dell'audacia della plebe contro la prepotenza nobiliare. Un giorno Flavio si era recato a far
visita ad un suo collega ammalato; alcuni nobili adolescenti che stavano seduti lì intorno si
misero d'accordo per non alzarsi in piedi e allora egli ordinò che gli fosse portata lì la sedia
curule: così, dalla sedia che era il simbolo della sua magistratura, guardò i suoi avversari
macerarsi per la rabbia. Del resto a nominare edile Flavio era stato il partito della piazza, che
aveva acquistato spazio politico grazie alla censura di Appio Claudio, colui che aveva cominciato
a inquinare il senato ammettendovi figli di liberti e che, quando si era accorto che nessuno
riteneva valida quella elezione e che egli non aveva ottenuto in Curia quel peso politicio cui
aspirava, divise il popolino fra tutte le tribù, corrompendo in questo modo il Foro e il Campo
Marzio. In ogni caso i comizi che elessero Flavio provocarono tanto sdegno nella maggior parte
dei nobili, che questi rinunciarono agli anelli d'oro e alle falere. Da quel giorno la cittadinanza si
spaccò in due fazioni: da una parte stava la parte sana del popolo, che era fautric e degli
aristocratici e ad essi favorevole, dall'altra il partito della piazza. Questo accadeva fino al
momento in cui furono eletti censori Quinto Fabio e Publio Decio: allora Quinto Fabio sia per
realizzare un po' di concordia sia per evitare che i comizi fossero completamente nelle mani dei
popolani più miserabili, isolò tutta la plebaglia forense e la racchiuse in quattro tribù che chiamò
urbane. Quel provvedimento incontrò grande gratitudine e tale equa distribuzione delle classi gli
valse il soprannome di Massimo, che non aveva ottenuto con così numerose vittorie. A quanto si
dice, si deve a Fabio anche l'istituzione dell'abitudine di passare in rassegna i cavalieri ogni 15 di
luglio.
Trad. G. Mazzocato
Gell. 7,9,1
Quod res uidebatur memoratu digna, quam fecisse Cn. Flauium Anni filium aedilem curulem L. Piso in tertio
annali scripsit, eaque res perquam pure et uenuste narrata a Pisone, locum istum totum huc ex Pisonis
annali transposuimus.
'Cn.' inquit 'Flauius patre libertino natus scriptum faciebat, isque in eo tempore aedili curuli apparebat, quo
tempore aediles subrogantur, eumque pro tribu aedilem curulem renuntiauerunt. Aedilem, qui comitia
habebat, negat accipere, neque sibi placere, qui scriptum faceret, eum aedilem fieri. Cn. Flauius Anni filius
dicitur tabulas posuisse, scriptu sese abdicasse, isque aedilis curulis factus est.
'Idem Cn. Flauius Anni filius dicitur ad collegam uenisse uisere aegrotum. Eo in conclaue postquam introiuit,
adulescentes ibi complures nobiles sedebant. Hi contemnentes eum, assurgere ei nemo uoluit. Cn. Flauius
Anni filius aedilis id arrisit, sellam curulem iussit sibi afferri, eam in limine apposuit, ne quis illorum exire
posset utique hi omnes inuiti uiderent sese in sella curuli sedentem.'
Traduzione
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
251
Plin., nat., 33,17
Frequentior autem usus anulorum non ante Cn. Flavium Anni filium deprehenditur. hic namque publicatis
diebus fastis, quos populus a paucis principum cotidie petebat, tantam gratiam plebei adeptus est–libertino
patre alioqui genitus et ipse scriba Appi Caeci, cuius hortatu exceperat eos dies consultando adsidue sagaci
ingenio promulgaratque–, ut aedilis curulis crearetur cum Q. Anicio Praenestino, qui paucis ante annis hostis
fuisset, praeteritis C. Poetilio et Domitio, quorum patres consules fuerant. additum Flavio, ut simul et tribunus
plebei esset, quo facto tanta indignatio exarsit, ut "anulos abiectos" in antiquissimis reperiatur annalibus. fallit
plerosque quod tum et equestrem ordinem id fecisse arbitrantur; etenim ad iectum hoc quoque "sed et
phaleras positas" propterque nomen equitum adiectum est, anulosque depositos a nobilitate in annales
relatum est, non a senatu universo. hoc actum P. Sempronio L. Sulpicio cos. Flavius vovit aedem
Concordiae, si populo reconciliasset ordines, et, cum ad id pecunia publice non decerneretur, ex multaticia
faeneratoribus condemnatis aediculam aeream fecit in Graecostasi, quae tunc supra comitium erat,
inciditque in tabella aerea factam eam aedem CCIIII annis post Capitolinam dedicatam. i<d> a.
CCCCXXXXVIIII a condita urbe gestum est et primum anulorum vestigium extat; pro
Traduzione
Cic., de or. 1, 185-87
Et quoniam de impudentia dixi, castigemus etiam segnitatem hominum atque inertiam; nam si esset ista
cognitio iuris magna atque difficilis, tamen utilitatis magnitudo deberet homines ad suscipiendum discendi
laborem impellere: sed, o di immortales, non dicerem hoc, audiente Scaevola, nisi ipse dicere soleret nullius
artis sibi faciliorem cognitionem videri. Quod quidem certis de causis a plerisque aliter existimatur: primum,
quia veteres illi, qui huic scientiae praefuerunt, obtinendae atque augendae potentiae suae causa pervulgari
artem suam noluerunt; deinde, postea quam est editum, expositis a Cn. Flavio primum actionibus, nulli
fuerunt, qui illa artificiose digesta generatim componerent; nihil est enim, quod ad artem redigi possit, nisi ille
prius, qui illa tenet, quorum artem instituere vult, habet illam scientiam, ut ex eis rebus, quarum ars nondum
sit, artem efficere possit. Hoc video, dum breviter voluerim dicere, dictum a me esse paulo obscurius; sed
experiar et dicam, si potero, planius. Omnia fere, quae sunt conclusa nunc artibus, dispersa et dissipata
quondam fuerunt; ut in musicis numeri et voces et modi; in geometria lineamenta, formae, intervalla,
magnitudines; in astrologia caeli conversio, ortus, obitus motusque siderum; in grammaticis poetarum
pertractatio, historiarum cognitio, verborum interpretatio, pronuntiandi quidam sonus; in hac denique ipsa
ratione dicendi excogitare, ornare, disponere, meminisse, agere, ignota quondam omnibus et diffusa late
videbantur. Adhibita est igitur ars quaedam extrinsecus ex
Traduzione
Cic., pro Mur. 25-27
Erant in magna potentia qui consulebantur; a quibus etiam dies tamquam a Chaldaeis petebatur. Inventus
est scriba quidam, Cn. Flavius, qui cornicum oculos confixerit et singulis diebus ediscendis fastos populo
proposuerit et ab ipsis <his> cautis iuris consultis eorum sapientiam compilarit. Itaque irati illi, quod sunt veriti
ne dierum ratione pervolgata et cognita sine sua opera lege <agi> posset, verba quaedam composuerunt ut
omnibus in rebus ipsi interessent. Cum hoc fieri bellissime posset: 'Fundus Sabinus meus est.' 'Immo meus,'
deinde iudicium, noluerunt. 'Fvndvs' inquit 'qvi est in agro qvi sabinvs vocatvr.' Satis verbose; cedo quid
postea? 'evm ego ex ivre Qviritivm mevm esse aio.' Quid tum? 'inde ibi ego te ex ivre manvm consertvm
voco.' Quid huic tam loquaciter litigioso responderet ille unde petebatur non habebat. Transit idem iuris
consultus tibicinis Latini modo. 'Vnde tv me' inquit 'ex ivre manvm consertvm vocasti, inde ibi ego te revoco.'
Praetor interea ne pulchrum se ac beatum putaret atque aliquid ipse sua sponte loqueretur, ei quoque
carmen compositum est cum ceteris rebus absurdum tum vero in illo: 'Svis vtrisqve svperstitibvs
praesentibvs istam viam dico; ite viam.' Praesto aderat sapiens ille qui inire viam doceret. 'Redite viam.'
Eodem duce redibant. Haec iam tum apud illos barbatos ridicula, credo, videbantur, homines, cum recte
atque in loco constitissent, iuberi abire ut, unde abissent, eodem statim redirent. Isdem ineptiis fucata sunt
illa omnia: 'Qvando te in ivre conspicio' et haec: 'Anne tv dicas qva ex cavsa vindicaveris?' Quae dum erant
occulta, necessario ab eis qui ea tenebant petebantur; postea vero pervolgata atque in manibus iactata et
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
252
excussa, inanissima prudentiae reperta sunt, fraudis autem et stultitiae plenissima. Nam, cum permulta
praeclare legibus essent constituta, ea iure consultorum ingeniis pleraque corrupta ac depravata sunt.
Traduzione
Cic., ad Att., 6,1,8
Flens mihi meam famam commendasti; quae epistula tua est in qua mentionem <non>
facias? itaque irascatur qui volet, patiar; 'tÕ g¦r eâ met' ™moà', praesertim cum sex libris
tamquam praedibus me ipse obstrinxerim, quos tibi tam valde probari gaudeo. e quibus
unum ƒstorikÕn requiris de Cn. Flavio, Anni filio. ille vero ante decemviros non fuit,
quippe qui aedilis curulis fuerit, qui magistratus multis annis post decemviros institutus est.
quid ergo profecit, quod protulit fastos? occultatam putant quodam tempore istam tabulam,
ut dies agendi peterentur a paucis; nec vero pauci sunt auctores Cn. Flavium scribam
fastos protulisse actionesque composuisse, ne me hoc vel potius Africanum is enim
loquitur commentum putes. oÙk œlaqš se illud de gestu histrionis? tu sceleste
suspicaris, ego ¢felîs scripsi.
Bibliografia
Bettini, 1, 80.
Mariotti 1, 31
F. D’Ippolito, Giuristi e sapienti di Roma antica, Roma-Bari, Laterza, 1986, in part. 1-8 e 37-62.
F. P. Bremer, Iurisprudentiae antehadrianeae quae supersunt, 2 voll. Leipzig 1896-1901.
Vol. 1, Lipsiae 1896, F.P. Bremer (anast. Leipzig 1985), p. 6.
Tiberio Coruncanio
Console nel 280 a.C., combattè contro gli Etruschi e Pirro, dopo aver affrontato nel 282 contro
Etruschi e Galli alleati. Fu il primo pontefice massimo plebeo. Da ricordare che è del 300 a.C. la lex
Ogulnia, con la quale i plebei ebbero accesso al collegio pontificale e a quello degli auguri.
Sua in gran parte la compilazione degli Annales pontificum.
Notevole la sua attività di interpretazione della legge. Per Pomponio fu il primo a farlo
pubblicamente.
Bretone, Storia del diritto romano, TavCron, “pronuncia responsi memorabili” tra il 254 e il 243
seguendo Pomponio.
Testi e testimonianze
Cic., Brutus, 55
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
253
Possumus Appium Claudium suspicari disertum, quia senatum iamiam inclinatum a Pyrrhi pace revocaverit;
possumus C. Fabricium, quia sit ad Pyrrhum de captivis recuperandis missus orator; Ti. Coruncanium, quod
ex pontificum commentariis longe plurumum ingenio valuisse videatur.
E possiamo congetturare che fosse buon parlatore Appio Claudio, che distolse il senato dalla pace
che stava per concludere con Pirro e Gaio Fabrizio, perché fu mandato ambasciatore da Pirro a
trattare il riscatto dei prigionieri; e Tiberio Coruncanio perché dai libri dei pontefici risulta che
esercitò larga influenza per la forza del suo ingegno.
Dig.1.2.2.35
Pomponius l.S. enchir.
Iuris civilis scientiam plurimi et maximi viri professi sunt: sed qui eorum maximae dignationis apud populum
Romanum fuerunt, eorum in praesentia mentio habenda est, ut appareat, a quibus et qualibus haec iura orta
et tradita sunt. Et quidem ex omnibus, qui scientiam nancti sunt, ante Tiberium Coruncanium publice
professum neminem traditur: ceteri autem ad hunc vel in latenti ius civile retinere cogitabant solumque
consultatoribus vacare potius quam discere volentibus se praestabant.
Dig.1.2.2.38
Pomponius l.S. enchir.
Post hos fuit Tiberius Coruncanius, ut dixi, qui primus profiteri coepit: cuius tamen scriptum nullum exstat,
sed responsa complura et memorabilia eius fuerunt. deinde Sextus aelius et frater eius Publius Aelius et
Publius Atilius maximam scientiam in profitendo habuerunt, ut duo Aelii etiam consules fuerint, Atilius autem
primus a populo sapiens appellatus est. Sextum Aelium etiam Ennius laudavit et exstat illius liber qui
inscribitur " tripertita", qui liber veluti cunabula iuris continet: tripertita autem dicitur, quoniam lege duodecim
tabularum praeposita iungitur interpretatio, deinde subtexitur legis actio. eiusdem esse tres alii libri
referuntur, quos tamen quidam negant eiusdem esse: hos sectatus ad aliquid est Cato. deinde Marcus Cato
princeps Porciae familiae, cuius et libri exstant: sed plurimi filii eius, ex quibus ceteri oriuntur.
Cic., Lael. 18
Sit ita sane; sed eam sapientiam interpretantur, quam adhuc mortalis nemo est consecutus, nos autem ea,
quae sunt in usu vitaque communi, non ea, quae finguntur aut optantur, spectare debemus. Numquam ego
dicam C. Fabricium, M'. Curium, Ti. Coruncanium, quos sapientes nostri maiores iudicabant, ad istorum
normam fuisse sapientes. Quare sibi habeant sapientiae nomen et invidiosum et obscurum, concedant, ut
viri boni fuerint.
[Parla Lelio]
E sia pure; però costoro parlano di una sapienza che a nessun mortale è dato di cogliere, mentre
noi dobbiamo mirare a ciò che conta nella vita pratica, non a ciò che è nei nostri sogni o nelle
nostre fantasie. Gaio Fabrizio, Manio Curio, Tiberio Coruncanio, i nostri antichi li chiamarono
sapienti; ma non come li intendono costoro. Perciò si tengano pure quel nome di sapiente che ha
in sé l’idea di qualcosa di odioso e di nebuloso, e concedano, almeno, che quelli furono uomini
buoni.
Trad. G. Pacitti, Milano, Mondadori, 1997.
Cic., de orat., 3, 56
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
254
Hanc, inquam, cogitandi pronuntiandique rationem vimque dicendi veteres Graeci sapientiam nominabant;
hinc illi Lycurgi, hinc Pittaci, hinc Solones atque ab hac similitudine Coruncanii nostri, Fabricii, Catones,
Scipiones fuerunt, non tam fortasse docti, sed impetu mentis simili et voluntate.
Liv., 18,13
Tib. Coruncan<i>us primus ex plebe pontifex maximus creatus est.
Vell. Pat., 2, 128, 1-3
In huius uirtutum aestimatione, iam pridem iudicia ciuitatis cum iudiciis principis certant; neque nouus hic
mos senatus populique Romani est putandi, quod optimum sit, esse nobilissimum. Nam et illi, qui primi ante
bellum Punicum, abhinc annos CCC, Ti. Coruncanium, hominem nouum, cum aliis omnibus honoribus, tum
pontificatu etiam maximo ad principale extulere fastigium, et qui equestri loco natum Sp. Caruilium et mox M.
Catonem, nouum etiam Tusculo Vrbis inquilinum, Mummiumque Achaicum in consulatus, censuras et
triumphos prouexere, et qui C. Marium, ignotae originis, usque ad sextum consulatum sine dubitatione
Romani nominis habuere principem, et qui M. Tullio tantum tribuere ut paene adsentatione sua quibus uellet
principatus conciliaret, quique nihil Asinio Pollioni negauerunt quod nobilissimis summo cum sudore
consequendum foret, profecto hoc senserunt, in cuiuscumque animo uirtus inesset, ei plurimum esse
tribuendum.
Traduzione Velleio Patercolo
Già da tempo l’apprezzamento della cittadinanza per le virtù di Seiano procede di pari passo con la
stima che ne ha il principe; e non è cosa nuova per il senato ed il popolo romano considerare tanto
più nobile un uomo, quanto più eccelle per le sue qualità. Infatti coloro che trecento anni fa,
anteriormente alla prima guerra , innalzarono ai fastigi più alti Tito Tiberio Coruncanio, un uomo
nuovo, non solo con tutte le cariche politiche, ma anche con il pontificato massimo ….
Bibliografia
Niente Bettini
F. P. Bremer, Iurisprudentiae antehadrianeae quae supersunt, 2 voll. Leipzig 1896-1901.
Vol. 1, Lipsiae 1896, F.P. Bremer (anast. Leipzig 1985), p. 7.
controllo per E. Seckel - B. Kuebler, Iurisprudentiae anteiustaneae reliquiae, 2 voll. Leipzig 1908 1927.
Vol. 1, Lipsiae 19086 Ph.Ed. Huschke, riv. E. Seckel e B. Kuebler (anast. Leipzig 1988) BCTv
e O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, 2 voll, Leipzig 1889, rist. riv. O. Sierl, Graz 1960.
da riportare in ogni caso per bibliografia età successive.
Niente PHI
Riposati
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
255
TIBERIO CORUNCANIO. Altra figura della generazione e dello stampo di Appio Claudio Cieco, uomo,
anch'egli singolare, d'azione e di pensiero: console nel 280, vittorioso comandante di eserciti contro gli
Etruschi e contro Pirro, primo Pontefice Massimo di stirpe plebea, ricordato con ammirazione dagli antichi
(Cicerone, Livio, Velleio) per probità di vita, vigore d'ingegno e profondità di dottrina. Non a torto Cicerone
(Brut., 14, 55) lo colloca tra le grandi figure dell'antica romanità, quali Fabrizio, Curio Dentato, Catone,
Scipione. Ebbe il gusto della cultura del tempo. Sua in gran parte deve ritenersi la compilazione degli
Annales Pontificum. Conobbe, come pochi, la scienza del diritto e fu anche eccellente oratore (3). II vanto
suo principale sta nell'essere stato il primo interprete della legge e nell'aver reso di pubblica ragione « con
responsi a libere consultazioni » la giurisprudenza romana (4), svincolandola sempre piú dal monopolio
pontificale, sull'esempio di Appio Claudio e di Gneo Flavio. Dei suoi scritti rimangono solo due frammenti (5).
P.Sempronio Sofo
Cenni biografici
Console nel 304.
Opere
Nulla resta della sua attività di consultazione pubblica (responsa) o di eventuali nuove actiones o
formulae.
Testi e testimonianze
Dig.1.2.2.37
Pomponius l.S. enchir.
Fuit post eos maximae scientiae sempronius, quem populus romanus sofon appellavit, nec quisquam ante
hunc aut post hunc hoc nomine cognominatus est.
Dopo di loro [Papirio, Appio il decmviro, Appio Claudio il Cieco] uomo di altissima scienza fu
sempronio, dal popolo chiamato sophòs [car.Greco] e nessun altro, prima e dopo di lui, ricevette
più questo appellativo.
Bibliografia
F. D’Ippolito, Giuristi e sapienti di Roma antica, Roma-Bari, Laterza, 1986, in part. 88-92.
F. P. Bremer, Iurisprudentiae antehadrianeae quae supersunt, 2 voll. Leipzig 1896-1901.
Vol. 1, Lipsiae 1896, F.P. Bremer (anast. Leipzig 1985), p. 7.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
256
Papirio
Cenni biografici
Opere
Testi e testimonianze
Controllo Sing. Enchiridion (Pomponio) = D. 1,2,2,37
Dig.1.2.2.1
Pomponius l.S. enchir.
Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque
manu a regibus gubernabantur.
Dig.1.2.2.2
Pomponius l.S. enchir.
Postea aucta ad aliquem modum civitate ipsum romulum traditur populum in triginta partes divisisse, quas
partes curias appellavit propterea quod tunc reipublicae curam per sententias partium earum expediebat. et
ita leges quasdam et ipse curiatas ad populum tulit: tulerunt et sequentes reges. quae omnes conscriptae
exstant in libro sexti papirii, qui fuit illis temporibus, quibus superbus demarati corinthii filius, ex principalibus
viris. is liber, ut diximus, appellatur ius civile papirianum, non quia papirius de suo quicquam ibi adiecit, sed
quod leges sine ordine latas in unum composuit.
Dig.1.2.2.36
Pomponius l.S. enchir.
Fuit autem in primis peritus publius papirius, qui leges regias in unum contulit.
Bibliografia
Appio Decemviro
Cenni biografici
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
257
Opere
Testi e testimonianze
Dig.1.2.2.36
Pomponius l.S. enchir.
Fuit autem in primis peritus publius papirius, qui leges regias in unum contulit. ab hoc appius claudius unus
ex decemviris, cuius maximum consilium in duodecim tabulis scribendis fuit.
Bibliografia
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
258
Bibliografia generale
Mariotti
AL Anthologia Latina, Riese 2
CRF Comicorum Romanorum Fragmenta, Ribbeck 3
FIRA Fontes iuris Romani antesiustiniani, edd. S. Riccobono - G. Baviera - V. Arangio Ruiz, I-III,
Firenze 1940-19432.
FPL Fragmenta poetarum Latinorum, Morel e Blansdorf
GRF Grammaticae Romanae fragmenta, Funaioli e Mazzarino
HRF Historicorum Romanorum reliquiae, Peter
ORF Oratorum Romanorum fragmenta, Malcovati 4
PLM Poetae Latini minores, Baehrens-Vollmer)
TRF Tragicorum Romanorum fragmenta, Ribbeck 3.
CIL, Corpus Inscriptionum Latinarum
Carmina Latina Epigrafica, F. Buecheler.
Corpus Glossariorum Latinorum, ed. G. Goetz, I-VII, Leipzig 1888-1923
Glossaria Latina, ed. W.M. Lindasy, I-V, Paris 1926-1931.
Grammatici Latini, ed. H. Keil, I-VIII, Leipzig 1855-1880 (Supplementum ed. H. Hagen Leipzig
1870).
Corpus Medicorum Latinorum:
vol. I: Celso ed. F. Marx, Leipzig 1914
vol II/3: Sereno Sammonico; ed. F. Vollmer, Leipzig 1916
vol. III: Medicina Plinii, ed. A. Önnerfors, Berlin 1964.
vol. IV: Antonio Musa e altri; ed. E. Howald - H.E. Sigerist, Leipzig 1927.
vol. V: Marcello Emprico; ed. M. Niedermann - E. Liechtenhan, Berlin 19682.
vol. VI/1: Celio Aureliano; ed. G. Bendz, Berlin 1990.
vol. VIII/1: Antimio, ed. E. Liechtenhan, Berlin 19632.
Cambridge History of Classical Literature, ed. it. Letteratura latina di Cambridge, 2 voll., Milano
1991-92.
M. von Albrecht, tr. it. Storia della letteratura latina, 3 voll., Torino 1995-96.
C. Marchesi, Storia della letteratura latina, 2 voll., Milano-Messina 19682 .
Rostagni - Lana, Storia della letteratura latina, 3 voll., Torino 1964.
E. Paratore, Storia della letteratura latina, Firenze 1950.
BLS
Atellanae fabulae, ed. Frassinetti P., Rome, 1967, 174 p. (Poetarum Latinorum reliquiae, VI, 1):
édition revue et mise à jour, avec trad. italienne, de celle publiée par le même auteur dans le
"Corpus Paravianum".
Comoedia. Antologia della Palliata, ed. Traina A., Padova, 19662, 186 p.
Comoedia Togata. Fragmenta, ed. Daviault A., Paris, 1981, s.p. (Collection des Universités de
France).
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
259
Fabularum Atellanarum fragmenta, ed. Frassinetti P., Torino, 1955, (Corpus Paravianum).
Fabularum Praetextarum quae exstant, ed. Pedroli L., Genova, 1954, (Pubblicazioni dell'Istituto di
filologia classica, 7): con comm.
Manuwald G., Fabulae Praetextae: Spuren einer literarischen Gattung der Romer, Munich, Beck,
2001, (Zetemata, 108).
Mimorum Romanorum fragmenta, ed. Bonaria M., 2 voll., Genova, 1955-1956, 180 et 250 p.
(Pubblicazioni dell'Istituto di filologia classica, 5).
Romani Mimi, ed. Bonaria M., Rome, 1965, 307 p. (Poetarum Latinorum reliquiae, VI, 2): avec
traduction et commentaire.
Scaenicae Romanorum poesis fragmenta. I. Tragicorum Romanorum fragmenta; II. Comicorum
Romanorum praeter Plautum et Syri quae feruntur sententias fragmenta, ed. O. Ribbeck, Leipzig,
1897-18983, (Bibliotheca Teubneriana): (1871-18732) rist. Hildesheim 1962,
Sigles: TRF Ribbeck et CRF Ribbeck.
Scaenicorum Romanorum fragmenta. I. Tragicorum fragmenta, ed. Klotz A., Munich, 1953,
(Bibliotheca scriptorum Graecorum et Latinorum Monacensis).
Titinio e Atta. Fabula Togata. I frammenti. I, ed. Guardi T., Milano, 1984, Testo, traduzione e
commento.
E. Flores, Letteratura latina e ideologia del III-II sec. a.C. Disegno storico-sociologico da Appio
Claudio Cieco a Pacuvio, Napoli 1974.
E. Flores, Latinità arcaica e produzione linguistica, Napoli 1978.
G. Pasquali, Preistoria della poesia romana, ??
A. Traina - M. Bini, Supplementum Morelianum, Bologna 19902.
M. Bini, Index Morelianus sive verborum omnium poetarum Latinorum qui in Moreliana editione
continentur, Bologna 1980.
V. Tandoi, Disiecti membra poetae. Studi di poesia latina in frammenti, Foggia, 1984-88.
E.H. Warmington, Remains of Old Latin, 4 voll., Cambridge Mass. 1953-19572 (1: Ennius and
Caecilius; 2: Livius Andronicus, Naevius, Pacuvius and Accius; 3: Lucililius, The Twelve Tables; 4:
Archaic Inscriptions).
Poetarum Romanorum veterum reliquiae, ed. E. Diehl, Berlin 19574.
N. Zorzetti, La pretesta e il teatro latino arcaico, Napoli, Liguori, 1980.
F. P. Bremer, Iurisprudentiae antehadrianeae quae supersunt, 2 voll. Leipzig 1896-1901.
Vol. 1, Lipsiae 1896, F.P. Bremer (anast. Leipzig 1985) BCTv
Vol. 2/1, Lipsiae 1898, F.P. Bremer (anast. Leipzig 1985) BCTv
Vol. 2/2, Lipsiae 1901, F.P. Bremer (anast. Leipzig 1985) BCTv
controllo per E. Seckel - B. Kuebler, Iurisprudentiae anteiustaneae reliquiae, 2 voll. Leipzig 1908 1927.
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
Vol. 1, Lipsiae 19086 Ph.Ed. Huschke, riv. E. Seckel e B. Kuebler (anast. Leipzig 1988) BCTv
F. D’Alessi © 2002
260
F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico
261
Il periodo arcaico
Quadro storico
CARTAGINE - LA PRIMA GUERRA PUNICA - 265-241 a. C.
DA CARTAGINE ALLE EGADI- LA GUERRA IN SICILIA - LE BATTAGLIE
CARTAGINE - SUE IMPRESE NEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE - I MAMERTINI - BATTAGLIA SUL
LONGANO - I MAMERTINI CHIEDONO AIUTO A ROMA - ROMA E CARTAGINE; LORO RAPPORTI INTERVENTO DI ROMA - CONDIZIONI POLITICHE, ECONOMICHE, MILITARI DI ROMA E CARTAGINE ANNONE - APPIO CLAUDIO CAUDICE MUOVE VERSO LA SICILIA - ARRESTO E CROCIFISSIONE DI
ANNONE - BATTAGLIA DI MESSANA - II SECONDO ANNO DELLA GUERRA PUNICA; ALLEANZA FRA
GERONE E ROMA - IL TERZO ANNO DI GUERRA; ASSEDIO E BATTAGLIA DI AGRIGENTO - CADUTA
DI AGRIGENTO - LA FLOTTA ROMANA. - I "CORVI" - BATTAGLIA NAVALE DI MYLAE - TRIONFO DI
CAJO DUILIO. - LA GUERRA IN SICILIA. - EROISMO DI CEDICIO. - BATTAGLIA DI ECNOMO - ATTILIO
REGOLO IN AFRICA - BATTAGLIA DI TUNISI - BATTAGLIA DI ERMEO - FLOTTE ROMANE DISTRUTTE
DALLA TEMPESTA - ASDRUBALE - BATTAGLIA DI PANORMO - AMBASCERIA DI ATTILIO REGOLO FINE DI ATTILIO REGOLO - ASSEDIO DI LILIBEO - BATTAGLIA DI DREPANO - AMILCARE BARCA BATTAGLIA DELLE ISOLE EGADI - PACE CON CARTAGINE - FINE DELLA PRIMA GUERRA PUNICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------CARTAGINE
La prima guerra fra Roma e Cartagine scoppiò dopo l'unificazione della penisola italiana.
"Qart Chadascht", dai Greci chiamata "Karchedon" e dai Romani "Charthago", era una colonia fenicia
dell'Africa settentrionale. Popoli eminentemente commerciali, i Fenici, fin dai tempi remotissimi (quindici
secoli a. C.), avevano fondato città e colonie in moltissimi punti delle coste mediterranee: quelli di Sidone nel
bacino orientale, quelli di Tiro nell'occidentale.
Nel Mediterraneo occidentale, non poche, erano le colonie commerciali e fra queste primeggiavano Utica
(nell'Africa Zengitana) e Gades (nella Spagna) quando, forse nel XII secolo, fu fondata Cartagine.
Secondo la tradizione, i fondatori di Cartagine furono nobili di Tiro, ai quali il partito democratico aveva tolto
di mano il potere, guidati da DIDONE, sorella del re e moglie di SICHEO, gran sacerdote del dio Melkart, che
era stato ucciso dal cognato.
Ma, al contrario di Utica e di Gades, Cartagine non fu nei primi secoli della sua fondazione una colonia
commerciale. I fondatori prima, i loro discendenti poi, uomini d'armi anziché mercanti, esplicarono la loro
attività in guerre fortunate sul continente africano, poi ingrandirono il territorio della città tra i confini della
Numidia e il mare della "Sirtis minor" (Golfo di Gabes).
Fu solo nel sesto secolo che, giunti da Tiro numerosi emigrati, in prevalenza commercianti e industriali,
Cartagine da stato prettamente militare diventò una repubblica commerciale e sorse come antagonista dei
Greci, i quali, padroni già del bacino orientale, stavano acquistando, anche loro per mezzo delle colonie,
l'egemonia assoluta sul bacino occidentale del Mediterraneo.
Allo scopo di abbattere la supremazia greca sul mare, Cartagine si alleò con gli Etruschi, rivali dei Greci nel
Tirreno, sconfisse la flotta di Massilia (Marsiglia, colonia focese) presso la Corsica, s'impadronì di Alalia in
Corsica e ridusse in suo potere tutti gli insediamenti che i Focesi avevano fondato sulle coste della penisola
iberica.
Con la successiva conquista della Sardegna e delle isole Baleari, Cartagine conseguì l'incontrastata
egemonia sul Mediterraneo occidentale e rivolse le sue mire alla Sicilia, la quale, per esser dominata dai
Greci, rappresentava una permanente minaccia alla potenza marittima della repubblica africana.
Abbiamo qua e là, nel corso di questa storia, accennato alle vicende della lunga lotta tra Cartaginesi e Greci
dell'isola. Alleatasi con Reggio, Cartagine cinge, nel 274 (480 a. C.) di assedio Imera, ma è sconfitta
duramente dagli eserciti di GERONE di Siracusa e TERONE di Agrigento; ritenta la prova nel 344 (410 a. C.)
chiamata da Segesta, e, distrutte Selinunte ed Imera, s'impadronisce di buona parte della Sicilia; e
solamente Agatocle e Pirro più tardi riescono a scacciarla (questi ultimi fatti li abbiamo letti nel precedente
capitolo).
F. D’Alessi © 2002
F. D'ALESSI - Letter