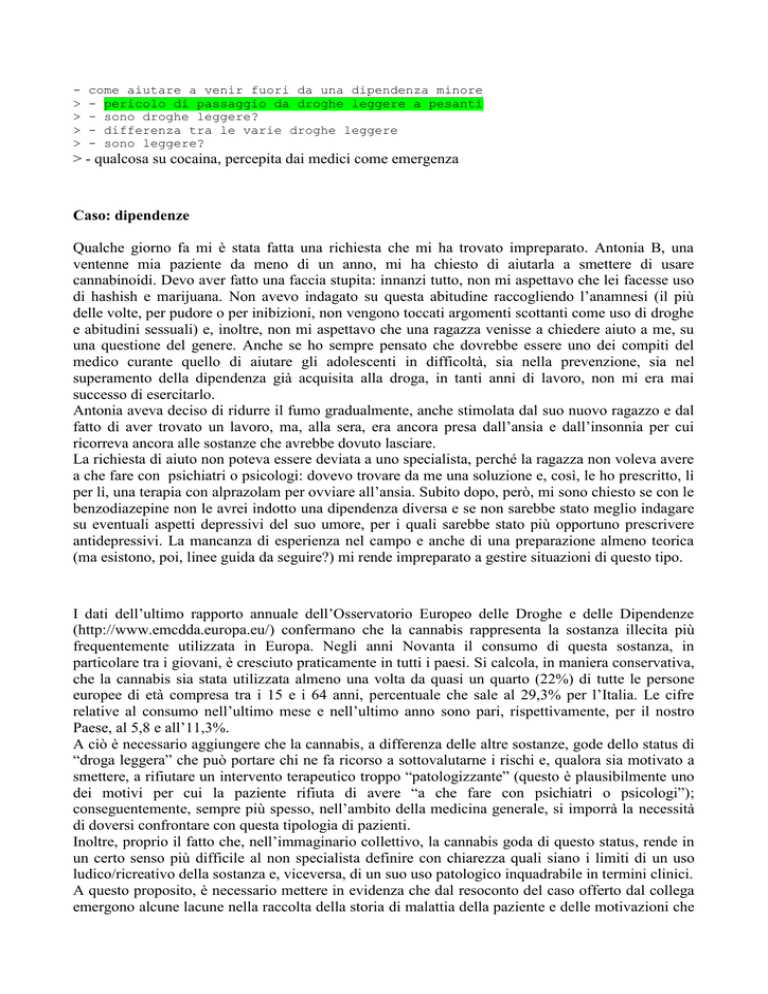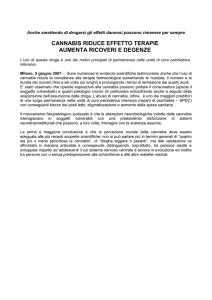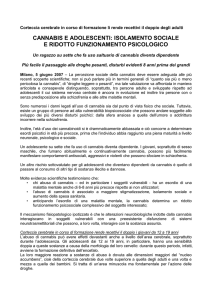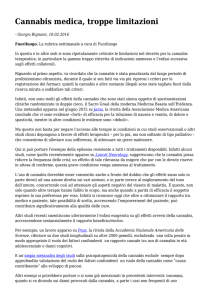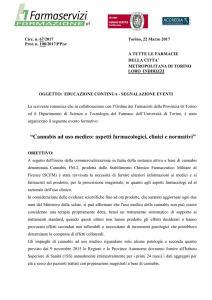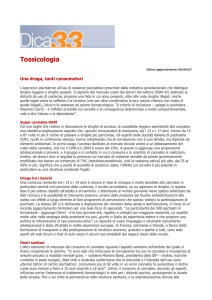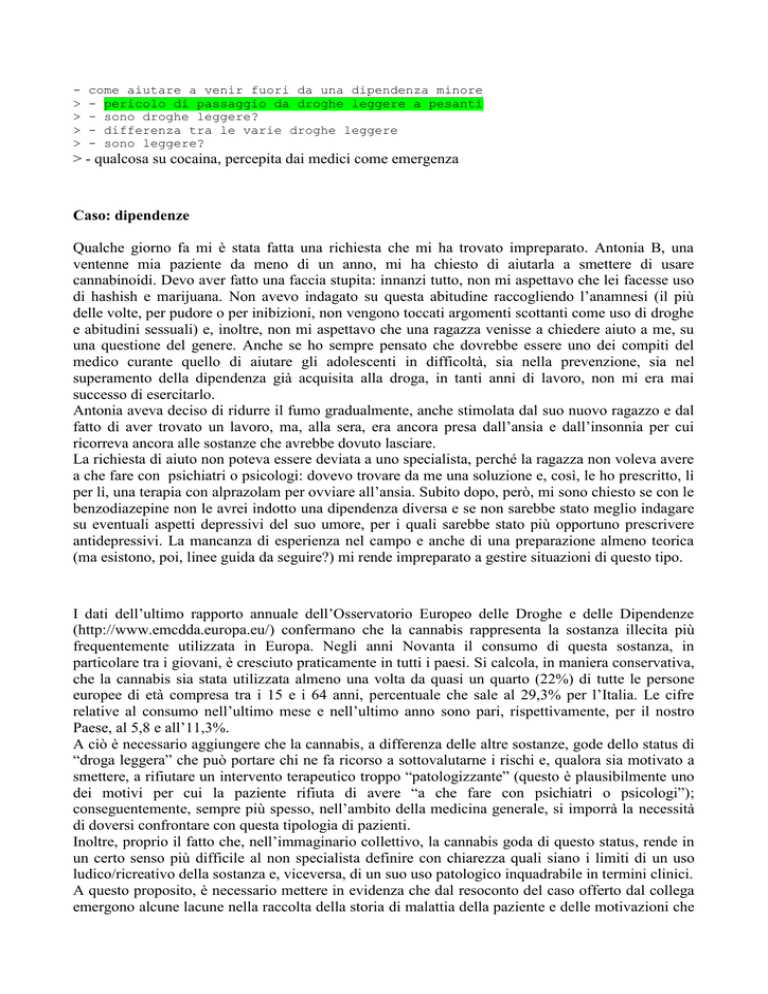
>
>
>
>
come aiutare a venir fuori da una dipendenza minore
- pericolo di passaggio da droghe leggere a pesanti
- sono droghe leggere?
- differenza tra le varie droghe leggere
- sono leggere?
> - qualcosa su cocaina, percepita dai medici come emergenza
Caso: dipendenze
Qualche giorno fa mi è stata fatta una richiesta che mi ha trovato impreparato. Antonia B, una
ventenne mia paziente da meno di un anno, mi ha chiesto di aiutarla a smettere di usare
cannabinoidi. Devo aver fatto una faccia stupita: innanzi tutto, non mi aspettavo che lei facesse uso
di hashish e marijuana. Non avevo indagato su questa abitudine raccogliendo l’anamnesi (il più
delle volte, per pudore o per inibizioni, non vengono toccati argomenti scottanti come uso di droghe
e abitudini sessuali) e, inoltre, non mi aspettavo che una ragazza venisse a chiedere aiuto a me, su
una questione del genere. Anche se ho sempre pensato che dovrebbe essere uno dei compiti del
medico curante quello di aiutare gli adolescenti in difficoltà, sia nella prevenzione, sia nel
superamento della dipendenza già acquisita alla droga, in tanti anni di lavoro, non mi era mai
successo di esercitarlo.
Antonia aveva deciso di ridurre il fumo gradualmente, anche stimolata dal suo nuovo ragazzo e dal
fatto di aver trovato un lavoro, ma, alla sera, era ancora presa dall’ansia e dall’insonnia per cui
ricorreva ancora alle sostanze che avrebbe dovuto lasciare.
La richiesta di aiuto non poteva essere deviata a uno specialista, perché la ragazza non voleva avere
a che fare con psichiatri o psicologi: dovevo trovare da me una soluzione e, così, le ho prescritto, lì
per lì, una terapia con alprazolam per ovviare all’ansia. Subito dopo, però, mi sono chiesto se con le
benzodiazepine non le avrei indotto una dipendenza diversa e se non sarebbe stato meglio indagare
su eventuali aspetti depressivi del suo umore, per i quali sarebbe stato più opportuno prescrivere
antidepressivi. La mancanza di esperienza nel campo e anche di una preparazione almeno teorica
(ma esistono, poi, linee guida da seguire?) mi rende impreparato a gestire situazioni di questo tipo.
I dati dell’ultimo rapporto annuale dell’Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Dipendenze
(http://www.emcdda.europa.eu/) confermano che la cannabis rappresenta la sostanza illecita più
frequentemente utilizzata in Europa. Negli anni Novanta il consumo di questa sostanza, in
particolare tra i giovani, è cresciuto praticamente in tutti i paesi. Si calcola, in maniera conservativa,
che la cannabis sia stata utilizzata almeno una volta da quasi un quarto (22%) di tutte le persone
europee di età compresa tra i 15 e i 64 anni, percentuale che sale al 29,3% per l’Italia. Le cifre
relative al consumo nell’ultimo mese e nell’ultimo anno sono pari, rispettivamente, per il nostro
Paese, al 5,8 e all’11,3%.
A ciò è necessario aggiungere che la cannabis, a differenza delle altre sostanze, gode dello status di
“droga leggera” che può portare chi ne fa ricorso a sottovalutarne i rischi e, qualora sia motivato a
smettere, a rifiutare un intervento terapeutico troppo “patologizzante” (questo è plausibilmente uno
dei motivi per cui la paziente rifiuta di avere “a che fare con psichiatri o psicologi”);
conseguentemente, sempre più spesso, nell’ambito della medicina generale, si imporrà la necessità
di doversi confrontare con questa tipologia di pazienti.
Inoltre, proprio il fatto che, nell’immaginario collettivo, la cannabis goda di questo status, rende in
un certo senso più difficile al non specialista definire con chiarezza quali siano i limiti di un uso
ludico/ricreativo della sostanza e, viceversa, di un suo uso patologico inquadrabile in termini clinici.
A questo proposito, è necessario mettere in evidenza che dal resoconto del caso offerto dal collega
emergono alcune lacune nella raccolta della storia di malattia della paziente e delle motivazioni che
la spingono, proprio ora, ad abbandonare il ricorso alla sostanza. A questo proposito si consiglia di
essere espliciti proprio sui temi scottanti, in particolar modo con adolescenti e giovani, proprio per
la diffusione di condotte di abuso e di promiscuità sessuale; è inoltre importante valutare anche le
relazioni familiari: ci sono buoni rapporti, i genitori sanno o sospettano, cosa farebbero se venissero
a saperlo… è frequente che una reticenza su argomenti ‘spinosi’ sia anche legata a questi fattori e
dunque la raccolta di informazioni ne sarebbe inevitabilmente danneggiata.
Tornando al nostro caso, non abbiamo informazioni su quale sia il dosaggio abituale utilizzato dalla
paziente o, almeno, sulla frequenza delle assunzioni nell’arco di una giornata “tipo” (ammesso che,
alla sostanza, la paziente faccia ricorso tutti i giorni). Il cosiddetto uso ricreativo della sostanza si
connota infatti come un uso infrequente – di solito meno di una volta alla settimana – e in occasioni
in cui la sostanza è disponibile, di solito fra amici. I fumatori abituali fumano da tre a cinque volte
alla settimana, di solito in circostanze specifiche. Fumare marijuana diviene un problema di salute
pubblica, quando questa pratica è giornaliera (da 1 a 20 sigarette al giorno) (Trattato italiano di
psichiatria).
L’attenzione dovrebbe essere inoltre rivolta a valutare se il dosaggio sia aumentato
progressivamente nel tempo in quanto questo fenomeno è indice di assuefazione agli effetti della
sostanza e depone a favore dell’ipotesi che possa essersi instaurata una dipendenza fisico-psichica
dalla stessa (tolleranza).
Anche le abitudini di consumo possono fornire informazioni utili: ad esempio, può essere
importante valutare se la paziente ricorra alla sostanza da sola o ne faccia un uso ricreativo, in
compagnia di altri, nel week-end, eccetera. Tali aspetti dovrebbero essere eventualmente indagati in
una prospettiva diacronica tenendo presente che dall’esordio (a questo proposito è anche importante
valutare quando il consumo di cannabis abbia avuto inizio...) possono esserci evoluzioni
significative delle modalità di consumo. Ad esempio da un uso condiviso nel gruppo dei pari in
adolescenza, si passa in seguito a un uso sempre più frequente e solitario.
La paziente riferisce inoltre di aver già compiuto degli sforzi, rivelatisi inutili, di ridurre
gradualmente il consumo di cannabis. Non sappiamo tuttavia se sia mai riuscita in passato a
interrompere del tutto l’uso della sostanza e, in questo caso, per quanto tempo sia riuscita a starne
lontana. Informazioni come questa possono rivelarsi molto utili per valutare, in termini prognostici,
le risorse e le probabilità di riuscita della paziente nel nuovo tentativo di abbandonare il ricorso alla
cannabis. Abbiamo tuttavia alcune indicazioni circa i sintomi psicologici e fisiologici che
accompagnano l’interruzione della sostanza o la riduzione del suo uso. La paziente riferisce infatti
sintomi d’ansia e problemi di sonno; questi sintomi meritano molta attenzione e si impone
un’indagine accurata circa la loro relazione temporale con la condotta di abuso di cannabis.
Se, infatti, una lieve sindrome astinenziale caratterizzata da umore irritabile o ansioso, tremori,
sudorazione, nausea, anoressia e insonnia è stata documentata negli abusatori abituali di cannabis, è
altrettanto possibile che l’interruzione dell’assunzione possa aver riportato in superficie un quadro
clinico psichiatrico che, proprio l’uso della sostanza, contribuiva a manteneva silente. E’ noto infatti
che il ricorso alle sostanze di abuso può avere la funzione di “automedicare” sintomi di disagio
psichico (ad esempio l’esperienza di stati affettivi negativi) difficilmente tollerabili per il paziente.
Ricerche trasversali condotte su ampi campioni epidemiologici statunitensi (Stinton et al., 2006),
hanno rilevato tassi di comorbilità tutt’altro che trascurabili tra abuso/dipendenza da cannabis e
disturbi dell’umore (in particolare, disturbo bipolare), disturbi d’ansia (in particolare, disturbo da
attacchi di panico e disturbo d’ansia generalizzato) e disturbi di personalità (in particolare il
dipendente e l’antisociale).
Indagare accuratamente le motivazioni che hanno portato all’uso della sostanza e ottenere una
buona anamnesi psicopatologica permettono quindi una comprensione del problema che si dimostra
più efficace di una semplice condanna all’uso della sostanza; inoltre, essa permette di affrontare
adeguatamente le motivazioni sottostanti impostando un intervento terapeutico efficace e ad hoc.
Non risulta infine trascurabile un ultimo aspetto: quali sono cioè le motivazioni alla base della
scelta di smettere? Avrebbe potuto essere interessante sapere, ad esempio, quale sia la relazione tra
la scelta di smettere di assumere la sostanza e l’aver trovato un nuovo lavoro. La paziente si è cioè
resa conto di non essere più “lucida” o di avere dei deficit cognitivi che le impedirebbero di
funzionare al meglio? E quale ruolo ha in questa scelta la relazione con il fidanzato? Tale relazione
può considerarsi una risorsa ai fini dell’intervento terapeutico? Questo tipo di aspetti sono essenziali
in quanto non solo possono fungere da “leve” motivazionali, ma danno l’idea di una possibile
compromissione del funzionamento generale (a livello lavorativo, sociale, relazionale) che si
ricollega alla sostanza (ad esempio, il precedente datore di lavoro ha messo in evidenza alcune sue
lacune o il fidanzato si è lamentato del suo eccessivo interesse e coinvolgimento nel ricorso alla
cannabis) e che, ancora una volta, permette di distinguere un uso ricreativo “non problematico”
della sostanza da un quadro clinico e meritevole di attenzione.
Tabella 1.
Elementi che possono far pensare ad un uso problematico
- ricorso quotidiano alla sostanza
- compromissione del funzionamento generale
- tentativi falliti di ridurre o interrompere l’uso
- tolleranza
Cannabis e disturbi psichiatrici
Esistono ormai evidenze scientifiche probanti a supporto dell’ipotesi che l’uso di sostanze illecite
come la cannabis possa causare sintomi psicotici; di fatto, spesso sono proprio le proprietà
psicoticomimetiche della sostanza a renderla ricercata da parte di coloro che la consumano.
E’ altrettanto assodato che alcune persone sono più vulnerabili a tali effetti della cannabis; alcuni
soggetti cioè, che presentano una “vulnerabilità alla psicosi” (mediata ad esempio da una
predisposizione genetica alla schizofrenia), avranno maggiore probabilità di sviluppare sintomi
psicotici anche gravi quando esposti alla sostanza stessa.
Diversa (e decisamente più delicata e controversa in letteratura) è la questione relativa alla
possibilità che l’uso di sostanze come la cannabis possa effettivamente comportare l’insorgenza di
patologie psichiatriche gravi quali la schizofrenia.
La metodologia sperimentale più adatta per rispondere a questo interrogativo è ricorrere a studi
longitudinali che seguono nel tempo una coorte di soggetti comparando il rischio per schizofrenia
tra coloro che hanno fatto ricorso alla cannabis e coloro che non hanno mai consumato la sostanza.
Studi simili sono stati condotti in diversi paesi europei (Svezia, Olanda) ed extra-europei (Israele,
Nuova Zelanda, Stati Uniti).
Una recente review sull’argomento pubblicata sulla prestigiosa rivista The Lancet (Moore et al.,
2007), che ha incluso proprio gli studi citati, ha messo in evidenza un incremento significativo del
rischio di sviluppare disturbi psicotici negli individui che avessero mai fatto ricorso alla cannabis
(adjusted odds ratio=1,41); i risultati mostrano inoltre l’esistenza di un fenomeno “dose-effetto”
tale per cui, ad una maggiore frequenza di utilizzo della cannabis, si associa un incremento nel
rischio di sviluppare disturbi psicotici (OR=2,09). Relativamente al rischio per disturbi dell’umore,
ideazione suicidaria e disturbi d’ansia, i risultati appaiono meno consistenti.
Questo studio dimostra che il ricorso alla cannabis incrementa il rischio di psicosi anche
controllando per possibili effetti di confondimento e gli effetti transitori della sostanza; gli autori
concludono che “ci sono ormai evidenze sufficienti per mettere in guardia i giovani sul fatto che
l’uso della cannabis possa incrementare il rischio di disturbi psicotici nel corso della vita”.
Tuttavia, non è legittimo sostenere che il consumo di cannabis “causi” la schizofrenia; esso infatti
non è di per sé un fattore sufficiente allo sviluppo di disturbi psicotici e la maggior parte delle
persone che, nel corso della loro vita, ricorrono alla cannabis non svilupperà mai gravi disturbi
mentali. Uno dei principali argomenti a supporto di questa tesi è, infatti, che se la cannabis fosse
realmente in grado di causare la schizofrenia, si sarebbe dovuto verificare un aumento della
diagnosi di tale disturbo, parallelo a quello avvenuto per l'abuso di sostanze nelle ultime decadi,
che, invece, non è avvenuto.
E’ ragionevole pensare al consumo di cannabis come un fattore di rischio che, agendo in sinergia
con altri fattori (quali ad esempio una vulnerabilità genetica ed eventi ambientali avversi nelle
prime fasi dello sviluppo), possa comportare, in alcuni soggetti particolarmente predisposti, la
manifestazione piena del disturbo.
Un’ulteriore precisazione riguarda i soggetti affetti da un grave disturbo mentale che ricorrono alla
cannabis o ad altre sostanze psicoattive anche allo scopo di “automedicare” i sintomi del disturbo
stesso (si pensi, ad esempio, al possibile effetto calmante della marijuana in soggetti affetti da
disturbi d’ansia).
In tal caso, il ricorso alla sostanza può comportare un significativo peggioramento del quadro
clinico oppure incrementare il rischio di una recidiva. La cannabis si è dimostrata, inoltre, in grado
di modificare, in qualche maniera, la sintomatologia specifica della schizofrenia; è stata, infatti,
associata a un peggioramento della sintomatologia positiva, soprattutto per quanto riguarda le aree
sintomatologiche di deliri, allucinazioni e disturbi formali positivi del pensiero. Più controversa è
invece la sua relazione con la sintomatologia negativa, poiché, malgrado non sia difficile credere
che i sintomi negativi possano essere peggiorati da essa, essendo stata anche relazionata a stati di
aumentata letargia e di sindrome amotivazionale, alcuni Autori hanno osservato che la cannabis era,
di contro, associata a un loro miglioramento significativo.
Cannabis e altre sostanze di abuso
Appare interessante che il collega si sia posto il dubbio di poter “indurre” una nuova dipendenza
attraverso la prescrizione di benzodiazepine senza però “per pudore o inibizioni” indagare la
presenza di altre condotte di abuso o dipendenza eventualmente già presenti. Per quanto, a
differenza di quanto avviene per le altre sostanze psicoattive, nella maggior parte dei casi i
consumatori di cannabis facciano ricorso a questa sostanza in maniera esclusiva, dati statunitensi
suggeriscono che abuso/dipendenza da alcol sono presenti in quasi il 55% dei soggetti che abusano
di cannabis (Stinton et al., 2006); ribadiamo che il ricorso alle sostanze di abuso, lecite e illecite,
necessita di un’indagine con domande esplicite, senza imbarazzi e pudori in quanto, questo tipo di
comportamenti, se non esplicitamente indagati, possono non essere riferiti spontaneamente anche
per il possibile senso di vergogna che ad essi molto spesso si associa.
Relativamente alla possibilità che un consumo di cannabis possa costituire il viatico all’assunzione
di altre sostanze psicoattive (quali eroina, cocaina ecc.), è necessario prima di tutto precisare che, a
differenza di quanto avviene per le altre sostanze psicoattive, il consumatore di cannabis, nella
maggior parte dei casi, ricorre a questa sostanza in via esclusiva. Ciò nonostante, il passaggio
dall’impiego di cannabinoidi all’assunzione di altre sostanze risulta piuttosto frequente, e le ragioni
di questo fenomeno possono essere ricondotte sia ad aspetti di ordine clinico, sia a evidenze
farmacologiche.
Infatti, il paziente consumatore di cannabis può ricorrere all’eroina o alla cocaina semplicemente
allo scopo di automedicare in modo più intensivo i propri disturbi psicologici e comportamentali, in
altri per “trattare” lo stato disforico e i disturbi indotti da un uso prolungato e massiccio della
cannabis stessa; i dati più recenti indicano inoltre una vera e propria interazione farmacologica tra il
sistema oppioide e il sistema dei cannabinoidi.
Oltre ai dati sulla comorbilità già mostrati in precedenza, altre evidenze suggeriscono la possibilità
che l’uso di cannabis possa condurre al ricorso (con conseguente comparsa di quadri di abuso e
dipendenza) ad altre sostanze psicoattive; studi condotti su coppie di gemelli discordanti per l’uso di
cannabis in adolescenza hanno mostrato, ad esempio, che il ricorso alla marijuana, in particolare
prima dei 18 anni di età, si associa a un rischio da 2 a 5 volte superiore di sviluppare dipendenza da
alcol e uso/abuso/dipendenza da altre sostanze psicoattive (Lynskey et al., 2003)
Linee guida per l’intervento
Individuare i soggetti a rischio e intervenire precocemente sono considerate due importanti
componenti di tutti i programmi di lotta al consumo di sostanze.
Non esistono elementi scientifici validi su cui possano essere improntati interventi terapeutici
specifici rivolti consumatori di cannabis e gli studi in questo settore sono limitati, fondati per lo più
su esperienze americane e australiane.
A livello europeo, gli approcci terapeutici più diffusi ai problemi causati dal consumo di cannabis
sono interventi di breve durata in regime ambulatoriale, interventi di counseling, programmi attuati
nelle scuole e attività a scopo preventivo.
In generale, si tratta di interventi brevi e mirati, attraverso una combinazione di colloqui
motivazionali o di impostazione cognitivo-comportamentale.
Sebbene non esista un ampio consenso né una ricca letteratura su quali siano le buone pratiche
terapeutiche in quest’area, alcune evidenze suggeriscono che questo tipo di impostazione possa
essere utile.
In Italia non esistono strutture terapeutiche specializzate per i consumatori problematici di cannabis,
pertanto molti di questi soggetti possono essere inviati a programmi generici di cura delle
tossicodipendenze (SERT, NOA) o a servizi di aiuto ai giovani.
Esistono alcune perplessità rispetto alla possibilità di curare i giovani consumatori di cannabis
nell’ambito di servizi generici per la lotta alle tossicodipendenze, perché in questo caso i pazienti
(soprattutto se adolescenti) possono correre il rischio di venire in contatto con consumatori
problematici di altre sostanze psicoattive di maggiore età.
Nell’ambito delle competenze del medico di medicina generale, il medico dovrebbe, dopo un
adeguato inquadramento del problema, in presenza di soggetti adolescenti o in soggetti già noti per
disturbi psichici o che lamentano, in concomitanza al ricorso alla sostanza, sintomi psichiatrici,
proporre sempre l’invio ad uno specialista.
L’impostazione di una terapia farmacologica appare infatti piuttosto rischiosa alla luce della
possibilità di indurre dipendenza da altre sostanze (quali ad esempio le benzodiazepine). Il ricorso a
questi farmaci dovrebbe quindi essere adeguatamente monitorato (ad esempio controllando la
frequenza di richiesta di nuove prescrizioni) e dovrebbero inoltre essere preferite molecole a lunga
emivita il cui potenziale, in termini di sviluppo di dipendenza, è ridotto.
Nei casi più gravi (in cui, ad esempio, l’assunzione di cannabis si inserisce nel contesto di un
quadro di poliabuso) è opportuno valutare anche la necessità di un percorso di disintossicazione in
regime di ricovero presso una struttura specializzata.
La letteratura statunitense consiglia anche la necessità di proporre al paziente l’adesione al
programma dei Dodici Passi presso associazioni quali Alcolisti anonimi (http://www.alcolistianonimi.it) o Narcotici anonimi (http://www.na-italia.it), che ormai godono di una lunga e
consolidata tradizione anche nel nostro Paese e sono diffuse su tutto il territorio nazionale.
In tutti gli altri casi, come quello proposto dal collega, in cui il quadro clinico non è apparentemente
complicato ed è presente una motivazione di fondo da parte del paziente a interrompere la condotta
problematica, è plausibile attuare un intervento di tipo motivazionale.
A tale proposito, il modello degli “stadi del cambiamento” (per un approfondimento si veda Millner
e Rollnick, 1994) risulta particolarmente utile in quanto permette di offrire aiuto al paziente nell’
abbandonare il comportamento problematico e si configura come un approccio “flessibile” testato
con successo anche rispetto ad altri comportamenti dannosi per la salute; esso può trovare quindi
applicazione per altre abitudini nocive quali il fumo, un regime alimentare non equilibrato, e può
inoltre essere utilizzato per promuovere comportamenti sani quali un esercizio fisico regolare e
condotte sessuali non a rischio.
Secondo tale approccio, il processo di cambiamento avviene in cinque fasi consecutive e distinte:
- precontemplazione: la persona non sa o non riconosce di avere un problema;
-
contemplazione: la persona sa di avere un problema ma è ancora ambivalente rispetto alla
possibilità di cambiare;
- programmazione: la persona riconosce di avere un problema, ha deciso che vuole provare a
cambiare e sta programmando cosa fare;
- azione: la persona ha cominciato ad adottare una serie di comportamenti che riducono o
eliminano il comportamento problematico;
- mantenimento: la persona si sforza di proseguire e mantenere nel tempo i cambiamenti
adottati rispetto al comportamento problematico;
- ricaduta: la persona ricade, in modo continuativo, nel comportamento disfunzionale di cui
voleva liberarsi.
Oltre a permettere di stabilire in quale stadio del cambiamento si trovi il soggetto, il modello
fornisce anche dei criteri utili per stabilire quando il passaggio da una fase all’altra può avvenire.
Indispensabile, a questo proposito è il ricorso alla bilancia decisionale dei vantaggi e degli
svantaggi del cambiamento. Il paziente può cioè essere invitato a elencare gli aspetti positivi e gli
aspetti negativi legati al consumo della sostanza.
I guadagni possono includere i vantaggi strumentali e l’approvazione da parte di sé stessi e degli
altri mentre gli svantaggi includono i costi del cambiamento e la possibile disapprovazione da parte
degli altri. Il passaggio da una fase a quella successiva avviene quando i vantaggi superano gli
svantaggi. In generale, chi si trova in una fase di precontemplazione identifica più svantaggi che
vantaggi mentre l’opposto si osserva nella fase di mantenimento.
In questo modo, identificare la posizione che il paziente occupa nel modello permette all’operatore
di individuare la strategia più efficace per aiutarlo (Fig. 1).
Paziente
Strategie dell’operatore
Nel caso specifico
L’individuo non ha alcuna
intenzione di modificare il
proprio comportamento in
quanto non lo riconosce come
problematico.
L’individuo
inizia
a
considerare la possibilità di
un cambiamento senza ancora
aver intrapreso un’azione in
tal senso.
L’individuo si prepara a
cambiare con l’intenzione di
agire concretamente nell’arco
del mese successivo.
Fornire informazioni che
accrescano la consapevolezza
del problema.
Focalizzare l’attenzione sui
possibili rischi per la salute o
sul possibile scadimento del
funzionamento cognitivo.
Rinforzare le ragioni alla base
della scelta di cambiare.
L’inizio di una nuova attività
lavorativa
impone
il
cambiamento.
Suggerire strategie efficaci,
dare consigli concreti;
Fare ricorso al supporto del
fidanzato; evitare tutte le
situazioni e le compagnie che
ricordano
l’uso
della
sostanza; trovare alternative
sane
al
comportamento
problematico.
Azione
L’individuo passa ai fatti,
modificando
il
proprio
comportamento o l’ambiente
circostante in modo da
risolvere il problema.
Mantenimento
L’individuo si sforza di
mantenere a lungo termine il
cambiamento raggiunto.
Ricaduta
L’individuo
ricade
nel
comportamento problematico.
Aiutare a monitorare il
cambiamento,
verificare
l’efficacia delle strategie
scelte e superare le eventuali
difficoltà
che
possono
verificarsi.
Rinforzare le convinzioni di
autoefficacia, promuovere il
supporto dei familiari e della
rete sociale.
Ridurre la demoralizzazione,
riavviare il processo di
cambiamento.
Fase del
cambiamento
Precontemplazione
Contemplazione
Preparazione
Il coinvolgimento del paziente è un elemento cruciale in quanto, in assenza di un’adeguata alleanza
terapeutica e obiettivi condivisi, è impossibile iniziare qualsiasi trattamento efficace. Un assessment
iniziale completo promuove questo processo mentre le tecniche dell’intervista motivazionale
incoraggia e dà supporto al paziente nel liberarsi del comportamento problematico, aiutandolo a
esplorare e risolvere le sue ambivalenze.