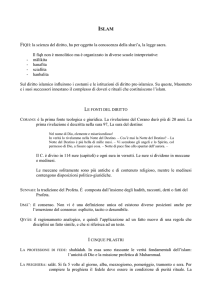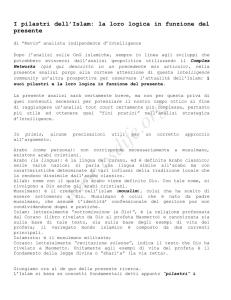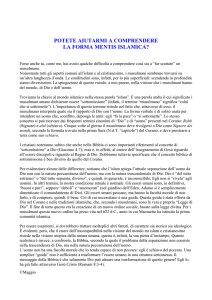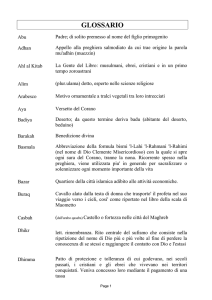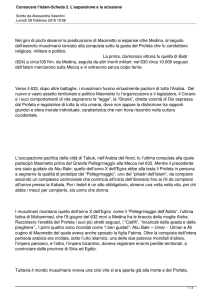“Guidaci per la retta via”
Il culto islamico come sottomissione alla volontà di Dio
INTRODUZIONE
Nella nostra riflessione cercheremo di approfondire il culto islamico sia dal punto di
vista descrittivo, inserendolo nelle coordinate della prassi rituale islamica
tradizionale, e sia sotto il profilo più strettamente spirituale, tentando di cogliere
l’atteggiamento psicologico del fedele musulmano. L’idea di fondo da cui muove
tutto il nostro percorso di approfondimento è, tuttavia, estremamente semplice: il
credente desidera, attraverso il culto, uniformarsi al volere di Dio, quel volere che
Dio ha manifestato nel Corano.
PRIMA PARTE
IL PROBLEMA DELLA VISIONE DI DIO (Ru’ya)
Dio è nel Corano il “conoscitore del visibile e dell’invisibile”. E l’invisibile (alghayb) è propriamente la sua dimensione. Il termine arabo deriva da una radice (gh-yb) che denota principalmente l’idea di “assenza”, sicché il termine intende un po’
suggerire che Dio è in una dimensione assente ai nostri sensi, non percepibile con
facoltà umane. Il termine, poi, è passato ad indicare il “Mistero di Dio”, il suo essere
ovunque pur nell’assenza. Questa assenza, diversamente da quanto afferma la
dottrina escatologica cristiana che prevede nell’altra vita una visio beatifica, rischia di
protrarsi anche nell’aldilà giacché – stando al più stretto dettato coranico – non è la
visio Dei il premio promesso ai beati. Al-ghayb andrebbe quindi forse meglio tradotto
con “l’impercepibile”, nel senso di “non afferrabile dai sensi umani”, non
inquadrabile in umane categorie.
Eppure il Corano suggerisce una sorta di onnipresenza – pur nella sua invisibilità –
del volto di Dio (wajh Allāh):
“A Dio appartiene l’oriente e l’occidente, e ovunque vi volgiate ivi è il volto di Dio, ché Dio è
ampio, sapiente” (Cor 2, 115)
Dio insomma è dappertutto. Facile era interpretare versetti come questi in senso
panteistico; dire, come fanno certi sufi trascinati a volte dall’empito mistico: ma
allora “Tutto è Lui!”; oppure: ogni volto del creato è un “volto di Dio”. Però altri
versetti, e proprio in connessione con il nostro tema, sembrano negare questa
possibilità:
“E tutto quel che vaga sulla terra perisce/ e solo resta il volto del Signore, pieno di potenza e di
gloria” (Cor. 55, 26-27)
“E non invocare insieme con Dio un altro dio: non v’è altro Dio che Lui, e tutte le cose periscono
salvo il suo volto”. (28, 88).
La concezione che ne esce – ricorda giustamente Saccone - non è certo di tipo
panteistico: Dio è dappertutto, ma ha comunque un suo volto ben distinto da ogni
altra cosa, per cui vedere il mondo non significa vedere Dio. Alla domanda: dov’è il
volto di Dio? La teologia islamica risponde che il volto di Dio è ubiquo, è
onnipresente, ma non immanente ad alcunché. L’idea immanentistica è
profondamente estranea al Corano, come alla stragrande parte della riflessione
teologica. Dio è piuttosto il testimone per eccellenza dell’universo e della sua storia,
ma con essi non si identifica. Egli viene sin nelle prime fibre di ogni anima e di ogni
atomo; è colui – si legge in un suggestivo passo coranico – che “ha posto i suoi segni
negli orizzonti e nelle anime” (Cor. 46, 53), ma non è in essi.
Dio, dunque, come ci ricorda L. Gardet, è Creatore (Khāliqa) di ogni cosa mediante il
comando (amr) espresso con la parola Kun (sii), Giudice, Remuneratore; è Dio Unico
(wahid) che non si comunica e non si incarna, ma si manifesta nel Corano e nei segni
dell’universo ayat Allāh; è dio onnipotente e misericordioso (al.rahman). Ma di Dio
non ci si può fare alcuna immagine artistica; non lo si può rappresentare. L’unico
modo traslato di rappresentarlo è attraverso la scrittura dei 99 nomi di Dio (cfr.
scheda in allegato): il pio musulmano avrà una riproduzione dei 99 nomi esposta in
casa e gira spesso con una coroncina (tasbih) di 99 grani in mano che gli permette di
recitare quando e ovunque voglia tutti i nomi conosciuti. I nomi rappresentano le
attività di Dio: il Benevolo, l’Autosufficiente, il Ricco, il Clemente, il Primo e
l’Ultimo, il Santo, il Soccorritore, il Nascosto e il Palese, il Giusto, il Santo, il
Perdonatore, il Vendicatore. A Dio – dice il Corano a più riprese – “appartengono i
nomi più belli”. Il centesimo nome secondo la tradizione lo conosce solo Dio stesso,
ovvero è impronunciabile, di cui nulla è dato sapere, neppure lo scheletro
consonantico come avviene col nome del Dio del Primo testamento. Tuttavia, per
evitare ogni scivolamento che potesse compromettere l’Unicità di Dio, i dottori
affermarono molto presto che gli attributi di Dio sono distinti dalla sua essenza
divina, ma ad esse risultano inerenti (qa’im), ovvero da essa non separabili. Solo un
attributo, il Verbo o Parola eterna di Dio, avrà nell’Islam un destino tutto speciale:
essa discende nel mondo e nella storia, si “incorpora” nelle sure del Corano come noi
lo conosciamo, ritenuto unanimemente “parola eterna ed incerata” di Dio. In questa
“incorporazione” della parola divina nel libro per eccellenza di ogni musulmano non
a torto si è visto una sorta di pendant islamico del mistero cristiano dell’Incarnazione
del Verbo. Il confronto termina qui, non essendo il Corano in sé fatto oggetto di una
adorazione, così come avviene con il Verbo in ambito cristiano. E tuttavia nel culto
emerge tutta la specialissima considerazione per questo attributo di Allāh. Il pio
musulmano si accosta al Verbo coranico con tutta una serie di atti e accorgimenti atti
a garantire la sua purezza rituale: scelta di un posto pulito, preliminari
scrupolosissime abluzioni, espressione in equivoca dell’intenzione di pregare.
Stando a quanto si è venuto dicendo, si può affermare che la via maestra attraverso la
quale il pio musulmano entra in rapporto con Dio è l’osservanza della parolarivelazione: è mettendo in pratica ciò che Dio ha affermato che l’uomo procede, con
fede salda, sulla via retta.
SECONDA PARTE
FEDE – SOTTOMISSIONE – BENE: il paradigma del credere islamico
Prima di iniziare la trattazione diffusa di questi aspetti, è tuttavia fondamentale
operare una chiarificazione di tipo terminologico. Il Corano, infatti, distingue tra due
termini, come ha ben sottolineato l’islamologo Roger Arnaldez (1993): la fede (īmān)
e la sottomissione a Dio (islām).
A questi due termini, poi, deve necessariamente esserne aggiunto un terzo, come
sottolinea Rizzardi: ihsān, “bene”, che completa il quadro di riferimento
terminologico essenziale.
Per comprendere appieno il significato dei tre termini in questione, occorre rifarsi ad
un hadith del Profeta, il secondo dei quaranta hadit Qudsi 1 :
“Omar (DCL) 2 riferisce:
Un giorno, mentre eravamo seduti accanto al Messaggero di Dio (SLPBD) 3 , ecco apparirci un
uomo dagli abiti candidi e dai capelli di un nero intenso; su di lui non traspariva traccia di
viaggio, ma nessuno di noi lo conosceva. Si sedette di fronte al Profeta (SLPBD), mise le
ginocchia contro le sue e poggiando le palme delle mani sulle sue cosce gli disse: O
Muhammad, dimmi cos’è l’Islam. Il Messaggero di Allāh (SLPBD) disse: “L’Islam è che tu
testimoni che non c’è altro Dio che Allāh e che Muhammad è il Messaggero di Dio; che tu
compia la preghiera rituale; versi la Zakat, digiuni nel mese di Ramadan e faccia il
pellegrinaggio alla Casa, se ne hai la possibilità”. Tu dici il vero! Disse l’uomo. Ci sorprese
che fosse lui ad interrogare il Profeta e lo approvasse. Gli chiese allora: Dimmi che cos’è
l’Iman. Egli rispose: “E’ che tu creda il Dio, nei Suoi angeli, nei Suoi libri, nei Suoi
Messaggeri e nell’Ultimo giorno, e che tu creda nel decreto divino, sia nel bene che nel male”.
Tu dici il vero! Replicò l’uomo che riprese dicendo: Dimmi che cos’è l’Ihsān. Egli rispose: E’
che tu adori Dio come se lo vedessi; perché se tu non lo vedi, certamente Egli ti vede”.
Questa trilogia (Islām-Īmān-Ihsān) assume il compito di fissare e circoscrivere le
coordinate fondamentali della spiritualità. Una versione approssimativa dei tre
termini, che vanno puntualizzati nei loro contenuti, potrebbe essere: credere in Dio
(īmān), salvarsi nel sottomettersi alla legge (islām), fare il bene (ihsān). Non si tratta
di tre atti, ma di tre attitudini interiori come base degli atti da compiere; sono le tre
dimensioni che costituiscono la “forma islamica” della spiritualità, ciò che la
caratterizza e la distingue dalle altre. Īmān è l’attitudine iniziale dell’Islām e l’Islām è
compimento, pienezza dell’Īmān. In altri termini credere in Dio (Imān) consiste
essenzialmente nel credere al fatto che Dio ha rivelato la sua Parola (Corano) e la sua
legge (shari’ah). Il binomio indissolubile Īmān-Islām significa l’adesione e la
sottomissione alla legge, Legge data e rivelata da Dio: la fede è la decisione
1
La tradizione islamica suggerisce la distinzione tra hadit qudsi e hadit di dubbia derivazione. Il criterio per la
qualificazione originaria dell’Hadit è la verifica della catena dei trasmettitori (matn) L’hadit è tanto più santo (qudsi)
quanto è più probabile il suo legame con il Profeta. Il testo dell’hadit qudsi è disponibile in lingua arabo-italiana. ANNAWAWI, Quaranta Hadīth, Centro editoriale studi islamici 8Cesi), Roma 1982. Altre raccolte di Hadith: ANNAWAWI, Il giardino dei devoti, Società italiana dei testi islamici, Trieste 1990; AL-BUKHARI, Detti e fatti del
profeta dell’Islam, a cura di V. Vacca, S. Noja, M. Vallaro, Utet, Torino 1982.
2
Abbreviazione dell’eulologia araba: “Dio si compiaccia di lui”.
3
Abbreviazione dell’eulologia araba: “Su lui la pace e la benedizione di Dio”.
esistenziale di lasciarsi guidare dalla Legge di Dio e l’obbedienza alla Legge è
anzitutto un atto di fede. La dimensione verticale della Legge, come Legge di Dio,
non dà origine solo ad un uomo “legale”, posto nell’ordine creaturale, ma ad un uomo
“spirituale”, in quanto il credente, il mu’min, vede in ogni comando l’autorità, la
volontà, l’onnipotenza e la “presenza” di Dio. Il culto islamico, quindi, è la risposta
alla vocazione del credente di essere e di fare quello che Dio vuole e manifesta
attraverso la Legge. Da questo punto di vista si può comprendere il termine antitetico
a Imān, kufr, che significa infedeltà o mancanza di fede, ma che non indica l’ateismo
di chi nega Dio, quanto piuttosto l’ateismo di chi si rifiuta di stare sotto la Legge. La
vera infedeltà è quella di sottrarsi alla Legge di Dio. Il termine Ihsān, poi, completa le
fede-īmān e la sottomissione-islām, venendo ad indicare, ad un livello più
superficiale, la buona condotta, il bene operato senza interessi personali, il bene
frutto della generosità e non ordinato direttamente della Legge, e poi, con sfumature
desunte dalla mistica sufi, la ricerca del Sommo bene, ossia di Dio, la familiarità con
Dio, la memoria costante di Dio, il vivere con gli occhi rivolti a Dio.
L’uomo che vive improntando la sua esistenza all’īmān- islām –ihsān, tuttavia, non è
santo, per come la santità è intesa nel Cristianesimo. Nell’Islām, infatti, tale santità
appartiene solo a Dio e Dio non la partecipa ad alcun essere. L’uomo è e rimane nella
dimensione della sua naturalità e della perfezione consentita da tale condizione. Il
concetto corrispondente a santità nell’Islām potrebbe essere “realizzazione
spirituale”, da concepirsi come raggiungimento della statura dell’uomo religioso
sottomesso alla Legge. Per questo motivo, recitando la Prima Sura del Corano, il
credente chiede ad Allāh che lo renda capace di seguire “la via retta”, che è la via
stabilita dalla Legge rivelata, seguendo la quale si rientra nell’ordine stabilito dal Dio
Creatore. La realizzazione attraverso la Legge non accresce la statura umana
dell’uomo, non la eleva, non la spiritualizza: non è meritevole, perché non è frutto del
libero arbitrio dell’uomo, quanto piuttosto frutto dell’opera creatrice di Dio che
sostiene l’uomo nelle sue scelte; viceversa, anche l’incapacità di obbedire alla Legge
è legata al volere di Dio, o meglio al suo disinteresse (Khidlan), che non è altro che la
creazione da parte di Dio nell’uomo del potere di disobbedire che conduce gli empi
all’empietà. Fare il bene, dunque, coincide con l’adeguarsi a ciò che è permesso
(hallāl), mentre fare il male significa compiere ciò che è vietato (harām). Secondo la
tradizione sannita maggioritaria il fondamento stesso della distinzione tra bene e male
è la stessa Legge rivelata. Dunque, alcuni atti sono buoni e altri cattivi perché Dio
ha deciso che sia così. In termini pratici, questo significa che l’essenza del bene
per l’uomo è l’obbedienza, la sottomissione alla Legge di Dio, mentre l’essenza
del male è la disobbedienza alla Legge di Dio. La religione (dīn) è dunque
strettamente collegata al mondo (dunyā), nel senso che la vera realizzazione spirituale
per il buon musulmano si ha quando la sfera del religioso e la sfera del secolare si
intersecano, perché il secolare e il religioso sono due facce della stessa medaglia. Il
culto, dunque, non è mai un affare privato, spiritualizzato, ma investe la vita nella sua
pienezza e nella sua radicalità: un musulmano è tale sempre e in ogni momento deve
attenersi alla Legge che gli indica la retta via.
TERZA PARTE
IL CAMMINO DELLA SOTTOMISSIONE: I CINQUE PILASTRI
I cinque pilastri (arkān) dell’islām, le cinque pratiche religiose, sono dedotti dal
Corano e dall’insegnamento del profeta: fanno parte, quindi dei diritti di Dio (huquq
Allāh) e non sono sindacabili, ma fondativi dell’essere musulmano. Tra i credenti
islamici si potrà trovare qualcuno che non li pratica in maniera continuativa, per
differenti ragioni, non per ultima quella di essere emigrante in terra straniera, ma sarà
estremamente difficile incontrare qualcuno che non li condivida, o li ritenga superati.
Nell’Islām non c’è spazio per una riforma liturgica, perché la liturgia nasce dalla
volontà di Allāh e il credente vi si deve sottomettere senza limiti. Una tradizione
attribuita al Profeta afferma che questi avrebbe detto:
“L’islām è che tu testimoni che non c’è altro Dio che Iddio e che Muhammad è il Messaggero di
Dio; che tu compia la preghiera rituale, versi l’elemosina, digiuni nel mese di Ramadan e faccia il
pellegrinaggio alla Casa, se ne hai la possibilità”
Gli arkān sono il segno della sottomissione non solo a Dio ma anche al Profeta:
“Allāh Onnipotente ha stabilito dei doveri, non li trascurate; ha fissato dei limiti, non li
oltrepassate; ha proibito alcune cose, non le trasgredite; ha mantenuto il silenzio su certe cose per
misericordia verso di voi e non per dimenticanza, non cercate di conoscerle”. (Hadit)
Dunque gli arkān sono il segno e la causa della sottomissione. Gli arkān inoltre
rappresentano la misura giusta della spiritualità, la via media, che non asseconda le
tendenze eccessivamente ascetiche per tener conto della possibilità media dell’uomo
secolare. Infine è bene richiamare la finalità comunitaria della realizzazione
spirituale: un unico atteggiamento di fronte ad un’unica normativa crea il “vivere
insieme” della Comunità. L’islām concepito come religione di comunità, non di
individui, richiede questa fraternità, che si manifesta nell’uguaglianza anche
nell’esperienza della vita spirituale. I pilastri sono dunque il “fondamento” dell’islām,
anche se non nel senso di “vertice” o di “essenza”. Un hadit ci conduce a fare questa
chiarificazione:
“Poi disse (è Muhammad che parla): “Vuoi che ti parli dell’essenza della religione, del suo pilastro
e del suo vertice?” Io risposi: Sì, o Messaggero di Allāh. Ed egli disse: “L’essenza della religione è
la sottomissione, il suo pilastro è la preghiera e il suo vertice è il Jihād”.
Gli arkān sono dunque ordinati al jihād, vertice della dīn (religione) e sono in
funzione della sottomissione, essenza della dīn. Essi non rappresentano un assoluto,
ma una modalità di espressione della sottomissione all’interno del “combattimento”,
ossia dello sforzo, per restare sulla via di Dio e per far trionfare universalmente la sua
Signoria. Questa considerazione ci porta a riconoscere la superficialità del giudizio
che definisce l’Islām come “legalismo” proprio in riferimento ai suoi cinque
fondamenti. La sottomissione è un orizzonte più largo dell’obbedienza e il
“combattimento” è una modalità più dinamica dell’osservanza.
1.LA PROFESSIONE DI FEDE (SHAHāDAH)
“Non vi è altro Dio che Iddio e Muhammad è l’inviato di Dio”
“La ilaha illa Allāh wa Muhammad rasul Allāh”.
Sul primo pilastro ci siamo già soffermati negli approfondimenti degli anni scorsi, a
cui rimando. Tuttavia, mi preme sottolineare che essa lega il muslim simultaneamente
a Dio e al Profeta, due riferimenti indissociabili nella vita musulmana. In realtà, si
tratta del riferimento a Dio e alla Sua Parola, di cui Maometto è il recitatore; in
questo senso la shahādah non rappresenta una professione duale, ma unica. L’accento
posto sul carattere teocentrico, però, non annulla il potere evocativo della professione
di fede nei confronti del Profeta; egli viene inteso, ricordato e affettivamente
nominato.
La shahādah, proprio mediante la sua recitazione ripetitiva, stabilisce, conferma,
radica il musulmano nel monoteismo professato. La potenza creatrice della parola e la
sua forza incisiva nel cuore dell’uomo, convinzione comune nella cultura semitica, dà
originalità alla recitazione ripetitiva; la Parola di Dio rimanda a Colui che l’ha
proferita, perché la Parola è chi l’ha proferita.
2. LA PREGHIERA RITUALE: SALAT
Come sottolinea giustamente Saccone, l’etica della sottomissione alla volontà divina
rappresenta il cuore dell’islām e trova la sua espressione più immediata e insieme più
alta nell’attività tipica del pio muslim: la preghiera. Nel Corano non si parla delle
cinque preghiere; è un Hadit, che riflette una prassi posteriore alla morte di
Maometto ma comunque molto antica, a prescriverne cinque. Per la verità esse sono
considerate un’unica preghiera a Dio divisa in cinque momenti: all’alba, a
mezzogiorno, a metà del pomeriggio, al tramonto e alla sera. Il dovere è assolto solo
se si prega in tutti e cinque i momenti prescritti e seguendo un preciso rituale. Questa
preghiera canonica – che è precetto per tutti i musulmani – va distinta dalle preghiere
facoltative (du’ā) e da altre preghiere speciali, supererogatorie, che si fanno in
comune come ad esempio la preghiera per ottenere il dono della pioggia dopo periodi
di siccità (istisqā), quella per i morti (salāt al-jināza); o come le preghiere individuali
tipo quella della istihāra che il pio credente esegue prima di accingersi a una nuova
opera, a un viaggio, a una impresa cui tiene particolarmente.
E’ fondamentale, tuttavia, comprendere il senso di fondo della salāt: la preghiera,
infatti, offre al pio musulmano la possibilità di inquadrare o scandire la sua giornata
attraverso un regolare contatto con Dio, ossia di ricordare che tutto il tempo
quotidiano è in linea di principio consacrato a Dio. Non è certo un caso che, secondo
un curioso hadit, Maometto inizialmente ebbe da Allāh la consegna di far pregare i
suoi 50 volte al giorno, lasciando perplesso il giovane profeta… Discendendo verso
un cielo più basso – si racconta nel medesimo hadit – Maometto incontra un
“collega” più anziano ed esperto, il biblico Mosè, che informato della cosa lo invita
perentoriamente a ritornare alla presenza di Dio per pregarlo di ridurre le preghiere
giornaliere a 40, quindi, dopo ulteriori interventi di Mosé, a 30, 20 e così via sino a
che Allāh finisce col pretenderne solo 5 (un curioso precedente biblico di questa
“contrattazione” tra Dio e un profeta, Abramo nella fattispecie, si ha in Genesi 18,
22-33). Sull’eziologia della salāt, c’è da aggiungere che non pochi studiosi hanno
voluto vedere un parallelo tra i tempi della preghiera islamica e la scansione delle
preghiere giornaliere nel monachesimo siriano, certamente ben noto ai carovanieri
arabi che si spingevano fino ai porti del Mediterraneo. L’islamologo e domenico
Jacques Jomier, poi, ha sottolineato che perfino certe posture caratteristiche, come
inchini e prosternazioni, avevano un preciso parallelo nei modi di pregare dei monaci
cristiani orientali e tuttora si trovano nel monachesimo della chiesa etiopica.
Passando alla descrizione del rituale, occorre rilevare che le condizioni preliminari
della salāt sono tre:
- lo stato di purezza (tāhir);
- la pronuncia dell’intenzione (niyyah)
- l’orientamento alla Mecca (qiblah).
1. La richiesta dello stato di purezza viene dal Corano stesso:
“O voi che credete! Quando vi accingete alla preghiera rituale, lavatevi il volto e le mani
fino al gomito e con la mano bagnata stropicciatevi la testa e i piedi fino alle caviglie. Se
siete in stato di impurità legale, purificatevi” (Cor, 5,6)
Vi è un’impunità minore (Hadat), per la quale bisogna ricorrere alle abluzioni
(wudū’) semplici (nelle modalità illustrate nella scheda in appendice), che si
consegue in tutta una serie di casi, minuziosamente descritti nei manuali dei
dottori: dopo essersi addormentati; dopo aver evacuato o toccato animali
impuri (cane, maiale,…) o sostanze impure (escrementi, sangue, …); dopo aver
toccato anche involontariamente una persone di sesso opposto (secondo alcune
scuole anche una persona di fede diversa). Ma vi è anche un’impurità maggiore
(janāba), legata solitamente all’atto sessuale, che esige una purificazione
completa (ghusl) mediante bagno. Per le abluzioni semplici, presso ogni
moschea si trova la “sala dell’acqua” (mīdāt), mentre, per il bagno, anche nei
più remoti villaggi non manca mai un hammām, un bagno pubblico, ove già
prima dell’alba i pii musulmani si recano per purificarsi in vista della
preghiera.
La richiesta dello stato di purezza si giustifica all’interno della dialettica puroimpuro, sacro-profano e ha il significato di togliere ogni impedimento
somatico-morale che vieta l’accesso al sacro. Il significato religioso di questa
ritualità va ricercato nella concezione della distanza ontologica tra Dio e
l’uomo, tra il sacro divino e la profanità umana; la ritualità della purificazione
non la elimina perché essa rimane, ma la riconosce e la confessa e, da parte
sua, l’uomo si dichiara disponibile a sottomettersi alla sua condizione
creaturale.
2. L’INTENZIONE (niyyah)
La niyyah è raccomandata da un hadit:
“Il Principe dei Credenti (Califfo) Abu Hafs Omar Ibn al Khattab (Dio si compiaccia di
lui) ha detto: “Ho sentito dire al Messaggero di Allāh (Su di lui sia la pace e la
benedizione di Dio): “Le azioni valgono secondo le intenzioni (Innamā al a’malu bi nniyyāti) ed ogni uomo avrà secondo il suo intento. Chi emigra (da La Mecca a Medina)
per Allāh, sappia che la sua emigrazione vale come fatta per Allāh e il suo Messaggero;
mentre chi emigra per avere dei benefici materiali o per sposare una donna, sappia che la
sua emigrazione vale per lo scopo per cui è emigrato”.
Possiamo riconoscere alla niyyah un triplice aspetto: un aspetto oggettivo, che
comporta la volontà di mettersi nello stato di sottomissione mentre si
compiono determinati atti; essa è la consapevole collocazione nel sistema
religioso islamico. C’è poi un aspetto soggettivo che consiste nel creare le
condizioni interne, spirituali, che predispongono all’atto richiesto. Potremmo
parlare di concentrazione interiore, ritenuta necessaria e richiesta come
indispensabile, perché essa è ciò che dà la forma religiosa all’operato. C’è infine
un aspetto soggettivo-purificativo che consiste nell’eliminazione delle
intenzionalità individuali umane mondane al fine di compiere l’azione per
piacere a Dio e per seguire l’esempio del Profeta.
3. L’ORIENTAMENTO (qiblah)
L’orientamento geografico-spirituale nella preghiera fa parte di tradizioni
antichissime, basti ricordare la tradizione biblica (Gen. 2, 8; Es. 26, 22-27). I
significati della qiblah possono essere ricondotti a due: anzitutto un significato
teologico, che consiste nel rendere concreta la presenza di un solo Dio,
rivolgendosi al simbolo (Ka’ba) dell’unico Dio; inoltre, un significato religioso,
che consiste nel fatto che questa convergenza di orientamento fa unità nella stessa
comunità dei fedeli, la ummah: gli stessi gesti, le stesse preghiere indirizzati
univocamente verso la Ka’ba.
La STRUTTURA DELLA PREGHIERA della salāt è determinata e rigidamente
codificata in formule, gesti e posture (vedi scheda). Di solito l’orante, ritto in
piedi, invoca preliminarmente la protezione di Dio dalle tentazioni di Satana con
la seguente formula coranica: “Mi rifugio nel Signore degli uomini, re degli
uomini, Dio degli uomini, contro il male del sussurratore furtivo!” (Cor., 114,1);
esprime poi l’intenzione (niyya) dicendo semplicemente: “Ora intendo compiere la
preghiera (dell’alba, della sera, ecc.). Quindi, portando le mani a fianco del capo,
distese e con il palmo in avanti, entra in stato di sacertà pronunciando la formula
“Dio è grande” (Allāh Akbar). Portate le mani sul petto col polso della sinistra
stretto nella destra, può a quel punto aggiungere altre formule coraniche, come ad
esempio: “Volgo la faccia verso Colui che ha creato i cieli e la terra, in purezza di
fede, e nessun compagno a lui voglio dare” (Cor., 6, 79), con cui l’orante ribadisce
la sua retta intenzione e la sua fede nell’unicità di Dio. La preghiera vera e propria
prevede in apertura la recita della prima sura coranica o fatiha (l’aprente):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nel nome di Dio, Clemente misericordioso!
Sia lode a Dio, Signore del Creato,
– il Clemente, il Misericordioso
il padrone del dì del Giudizio! –
Te noi adoriamo, Te invochiamo in aiuto:
Guidaci per la retta via,
la via di coloro sui quali hai effuso la Tua grazia, la via di coloro coi quali non sei adirato, la
via di quelli che non vagolano nell’errore!
Segue la recitazione di altri brevi passi coranici, la cui scelta varia a seconda del
momento della giornata. Quindi l’orante esegue un profondo inchino (ruku)
poggiando le mani sulle ginocchia e ripete per tre volte Allāh akbar (Dio è
grande); ritorna poi in posizione eretta e dice: “Dio ascolta sempre quelli che lo
lodano. O nostro Signore, a te soltanto spettano le lodi ed esse ricolmano i cieli, la
terra e tutto quel che tu vuoi!”. A quel punto si ha la prostrazione completa (sujūd)
con l’orante che in ginocchio piega la testa in avanti sino a poggiare la fronte a
terra da dove pronuncia ancora la formula Allāh Akbar e per tre volte la formula di
lode subhan Allāh (sia lode a Dio!). Quindi assume la posizione in cui è seduto sui
calcagni (julus) e richiede il perdono dei peccati con formule del tipo: “O mio Dio,
abbi misericordia di me! Orsù nutrimi, guidami, proteggimi e perdonami le
colpe!”. Segue un secondo sujūd e l’orante ritorna in posizione julus.
Un ciclo completo di posture e formule del tipo su descritto costituisce una unità
di preghiera, o rak’a. Ogni singola preghiera comprende diverse rak’a a seconda
del momento della giornata: due all’alba, quattro per quelle del mezzogiorno, del
pomeriggio e della sera; tre per quella del tramonto.
La posizione finale, in ginocchio, richiede tre invocazioni: il tashahwud, cioè la
confessione della shahadah la benedizione del Profeta, con la formula Sallā ilāh
‘alāyhi wa salam; la taslimah, cioè l’augurio della sālam volgendosi con il capo a
destra e a sinistra.
Come risulta chiaro da questa sommaria descrizione, molte posizione della
preghiera prevedono prosternazioni parziali o complete, il cui senso è quello di
esprimere in forma semplice ed efficace l’atteggiamento di umiltà creaturale e
sottomissione incondizionata che il credente deve avere davanti a Dio.
La preghiera festiva nel “giorno della riunione” (yawm al-jumu’ah) è un ordine
coranico: “O voi che credete! Quando sentite l’invito alla preghiera nel giorno
dell’adunanza, accorrete al ricordo nel nome di Dio e lasciate ogni affare! E’ la
cosa migliore per voi: se lo sapeste!” (Cor., 62,9). Vi sono tenuti tutti i musulmani
maschi maggiorenni, liberi, e si esige un numero di quaranta perché possa
compiersi. La caratteristica del culto del Venerdì è la predica (Khutbah) recitata in
piedi sul minbar da un incaricato che tiene in mano un bastone, o una spada o un
arco. La predica è costituita dalla lettura e dal commento di passi coranici, da
spunti pratici anche di carattere storico-politico e da preghiere di tutti i fedeli. Le
festività ufficiali, quelle regolamentate dai libri di diritto, sono soltanto due: la
“piccola festa” (al-‘īd al saghīr), che cade nel primo giorno del mese di Shawwāl,
alla fine del mese di ramadān. Questa festa proprio perché cade alla fine del mese
del digiuno è chiamata anche īd al fitr, ossia “festa della rottura”. L’altra invece è
la “grande festa” (al-‘īd al Kabīr), che cade nel decimo giorno del mese di Du l
Hijjah; giorno nel quale si celebra il sacrificio, legato alle cerimonie di
pellegrinaggio.
3. L’ ELEMOSINA: ZAKAT
La zakāt è una tassa religiosa, stabilita dalla shari’ah (legge) in base a riferimenti
coranici , obbligatoria, al cui pagamento sono tenuti tutti quei credenti che hanno la
possibilità di farlo. E’ una sorta di decima, che ha la funzione di purificare chi la
pratica mediante un sano distacco dai beni terreni, il cui autentico proprietario resta
soltanto Dio. Nella Sunna sono riportate tutte le disposizione precise che indicano
chi deve versare tale tassa (coloro che hanno sufficienti entrate per farlo), cosa deve
corrispondere (prodotti dei campi, frutta, bestiame, oro e argento, mercanzie), a chi
deve essere versata (alla tesoreria pubblica “bayt al-mal”) e come devono essere
impiegati i beni raccolti. Da quanto è stato detto è chiaro che l’elemosina ha sia un
fine strettamente religioso, ovvero permette al credente di prendere coscienza che
tutto ciò che ha è un segno della bontà di Allāh, unico proprietario del creato, sia un
fine solidaristico, ovvero aiuta il singolo fedele e la comunità locale a farsi carico
delle esigenze del territorio e dei membri di quella stessa comunità che si trovano in
ristrettezze. In questo senso, dunque, la zakāt è uno degli aspetti che evidenzia
maggiormente lo stretto rapporto religioso tra dīn e dunyā, cioè le implicazioni sociali
del religioso. Riconoscere la zakāt tra gli arkān significa elevare a dovere religioso e
di ordine cosmico un atto di giustizia sociale, e quindi impegnare l’autorità di Dio e
del Profeta in merito a doveri di natura umana. Pertanto la zakāt non va confusa con
sadaqah, che indica la beneficenza libera e volontaria, anche se la finalità spirituale
che determina i due atti è la stessa. Come dice il Corano: “Ciò che date in elemonisa
cercando il volto di Dio vi sarà raddoppiato” (Cor. 30, 39).
Secondo la tradizione islamica, al dovere della zakāt si riferisce il Corano quando
afferma: “Non così quelli che credono, che sono costanti nella preghiera e nelle cui
ricchezze c’è una parte riservata al mendicante e all’indigente”. (Cor. 70, 22-25; un
passo analogo lo si può trovare in Cor., 9, 60). Tuttavia, è bene sottolineare con il
Corano che ciò che conta non è il dare qualcosa, ma aprire l’animo all’indigente: “Se
poi ti allontani dai bisognosi senza poterli aiutare in attesa di un atto di misericordia
del tuo Signore, di’ loro almeno una parola gentile” (Cor. 17, 28).
Negli hadit, poi, si sottolinea la funzione pedagogica dell’elemonisa: “Quanto
all’elemosina fatta al ladro, potrebbe essere per lui una ragione per smettere di
rubare; quanto quello che hai dato alla prostituta, può essere per lei una ragione per
smettere di prostituirsi; e, infine, quello che hai dato al ricco, può essere per lui un
motivo di esempio, così che anch’egli dispensi parte di ciò che Iddio gli ha dato”.
Se vogliamo organizzare per la nostra comprensione l’insieme di queste osservazioni
riguardanti la zakāt e anche la sadaqah, possiamo dire che queste pratiche anzitutto
sono ordinate a far vivere il senso del primato di Dio sull’uomo e su tutta la realtà
creata.
L’aspetto religioso della pratica è primario, perché Dio è l’Uno e l’Unico, cui tutto è
sottomesso. Una seconda intenzionalità riposta nella pratica dell’elemosina è il
ripristino dell’ordine naturale-cosmico: la destinazione “naturale” dei beni, ossia la
destinazione comune e sociale. Una terza intenzionalità è quella pedagogicosociale: evitare l’accumulo della ricchezza nelle mani di pochi; si tratta del divieto di
ogni forma di capitalismo in nome della funzione sociale dei beni. Infine,
l’intenzionalità umanistica, l’aiuto alla persona bisognosa, la condivisione della
sofferenza del povero. C’è un aspetto che merita di essere sottolineato in questa
prospettiva: ciò che si dà è ciò che si deve dare, non ciò che si vuole dare: è il
rifiuto di ogni forma di paternalismo della beneficenza, in quanto non deve emergere
la bontà umana, ma il senso della giustizia. Non esiste, invece, un’intenzionalità
ascetica e rinunciataria. Questo è uno degli aspetti che segna la differenza tra la
charitas cristiana e la donazione islamica: la prima si pone in un contesto di
perfezione individuale, di moralizzazione personale, la seconda, invece, in un
contesto di ordine naturale. L’altro aspetto che segna una differenza è la
significazione simbolica della carità cristiana, secondo la quale un gesto di bene fatto
all’uomo è come se fosse fatto a Cristo.
4. IL DIGIUNO NEL MESE DI RAMADAN: SAWM.
Il digiuno obbligatorio nell’Islām consiste nella completa astensione da cibo e
bevande dall’affacciarsi dell’alba sino al tramonto durante il mese sacro di Ramadān.
E’ prevista anche l’astensione da ogni attività sessuale e da ogni atto illecito indicato
dalla shari’ah (legge). Durante il digiuno, inoltre, ogni musulmano deve tenere la
mente e la bocca lontano da cattivi pensieri e parole maligne, ed essere
particolarmente premuroso verso i bisognosi. Bisogna evitare, quindi, di litigare, di
rimproverare, di mentire e di calunniare e compiere opere buone: le giornate così
trascorse valgono doppie agli occhi di Dio.
Il mese di ramadān cadeva probabilmente in estate (il suo nome significa “torrido”),
ma con l’Islām le cose sono cambiate. I musulmani infatti seguono un calendario
lunare basato sulla sequenza di dodici mesi, alternativamente di 29 o 30 giorni.
Essendo l’anno lunare di undici giorni più corto di quello solare ed essendo stato
abolito da Muhammad un mese intercalare a cui precedentemente si ricorreva, non
c’è più corrispondenza fissa tra le stagioni e i mesi: questi ultimi così di anno in anno
arretrano rispetto alle prime e si trovano a cadere nello stesso periodo ogni 33-34
anni. Il mese di ramadan rimanda al momento in cui il Corano discese per la prima
volta nell’anima del Profeta, nella cosiddetta “notte del destino”: è quindi un mese
particolarmente benedetto in cui molto tempo è destinato alla preghiera e alla
recitazione del Corano.
Leggere Cor. 2, 183-187
Il mese di ramadān è fondamentale dal punto di vista della memoria storica
dell’Islām in quanto in esso vi sono le ricorrenze più importanti del mondo
musulmano: il 6 del mese ricorda la nascita del martire Husayn ibn Ali, il 10 la morte
di Cadigia, prima moglie di Maometto, il 17 la battaglia di Badr nella quale Dio ha
concesso la vittoria ai Musulmani (624), 1l 19 la presa della Mecca da parte di
Muhammad (630), il 21 la morte di Ali, cugino e genero del Profeta (660) e, infine,
questo è il culmine, la notte tra il 26 e il 27 è la notte benedetta della discesa del
Corano (Cor. 44, 3-4), la Notte del Destino (Laylat al Qadr) così commemorato nella
sura 97 del Corano:
“In verità, il Corano l’abbiamo rivelato nella Notte del Destino. E come potrei sapere
che cos’è la notte del destino? La notte del destino vale più di mille mesi. Scendono in
essa gli angeli e lo Spirito, col permesso del loro Signore, a fissare ogni cosa. Notte di
pace, fino allo spuntare dell’aurora!” (Cor. 97)
Questa ricorrenza annuale intende riaffermare tre valori nell’esperienza religiosaculturale del musulmano:
anzitutto, l’attitudine religiosa, in quanto il digiuno nel mese di Ramadān è
l’osservanza di un ordine divino, è un atto di sottomissione alla sua volontà.
In secondo luogo, il Ramadān tende a consolidare la coscienza di appartenere alla
ummah non solo in senso sentimentale, ma anche effettivo, in quanto durante il mese
vi è la ripresa intensiva dei doveri: dovere della preghiera, della lettura cranica, della
catechesi musulmana, della beneficenza e della fraternità.
In terzo luogo, il ramadan educa praticamente a vivere l’aspetto sociale della vita;
l’ebbrezza del vivere insieme a livello familiare e sociale è una sua caratteristica
inconfondibile. Al digiuno e al raccoglimento si destina la porzione più larga del
tempo, ma una parte è anche destinata alla festa notturna. Le potenzialità psicofisiche dell’uomo vengono sospese dal digiuno, ma non vengono soppresse. In fondo,
in questa esperienza promiscua di digiuno-piacere viene ripresa la dinamica
strutturale dell’essere musulmani, il legame cioè tra dīn e dunyā.
Il mese termina con la più grande solennità religiosa musulmana, īd’al-fītr (festa
della rottura del digiuno), la cui celebrazione dura per parecchi giorni, in genere tre,
in molti paesi, in cui sono d’obbligo solenni preghiere alla moschea e, insieme,
grandi feste popolari. Tra le pratiche di queste festività che seguono la festa della
rottura del digiuno, vi è l’usanza a visitare i cimiteri, il primo venerdì, con
atteggiamenti non luttuosi, ma gioiosi e soprattutto come momento di carità dei
poveri numerosi in quei luoghi.
Sono tenuti al digiuno tutti i credenti e le credenti che abbiano raggiunto la pubertà e
non appartengono alle categorie espressamente esonerate: malati e viaggiatori (che
dovranno recuperare i giorni in cui non hanno osservato il digiuno), donne gravide e
lattanti, i vecchi e i malati cronici, che sostituiscono il digiuno con una offerta di
viveri per i poveri.
Le violazioni che interrompono il digiuno sono distinte in quattro gruppi:
- quando si mangia o beve intenzionalmente o si fuma tabacco;
- quando si vomita intenzionalmente, anche su prescrizione medica;
- quando si hanno rapporti sessuali;
- quando si hanno emissioni di seme per cause diverse.
Durante le notti del ramadān gli obblighi sono sospesi e il credente deve leggere il
Corano, diviso in trenta parti.
Come ci ricorda Rizzardi il precetto del sawm ha finalità strettamente religiose:
“Esso rappresenta una modalità di “ricordo di Dio”: il distogliere il corpo e la mente delle cose
significa rivolgerli a Dio; il “ricordo di sé” spegne il “ricordo di Dio”. Questo aspetto pedagogicoreligioso è fondamentale nella pratica del digiuno. Non va sottovalutato per questo il suo valore
antropologico: la funzione di ristabilire l’equilibrio tra spirito e corpo; questo equilibrio è il risultato
di una dinamica purificativa trattandosi di due potenzialità essenzialmente positive. Nessun
disordine morale può intaccare la positività della realtà umana e nessuna rottura tra spirito e corpo
riguarda il livello ontologico. E’ la logica del “ristabilire l’ordine”, di correggere una dinamica. Vi è
poi la finalità morale del digiuno, che consiste nell’esprimere la solidarietà con i credenti più
poveri. Lo spirito che comanda questo dovere è il medesimo che suggerisce la zakat, cioè
collaborare per ridurre lo scarto di disuguaglianza tra i membri della ummah; la privazione assume
questa finalità positiva che fa sentire il musulmano imitatore della misericordia di Dio verso tutti gli
uomini. Il digiuno, infine, anche questa è una componente educativa, coltiva la virtù dell’uomo
arabo, la pazienza (sabr), lo spirito di sopportazione di origine beduina, da intendere moderatamente
come spirito di sopravvivenza, virilità, volitività, coraggio umano”.
5. IL PELLEGRINAGGIO: HAJJ
Compiere, almeno una volta nella vita, il pellegrinaggio alla città santa La Mecca è
l’aspirazione più sincera di ogni credente musulmano. Tale pratica è in evidente
continuità con i riti di pellegrinaggio dell’epoca preislamica, anche se la rivelazione
coranica e la predicazione del Profeta ne operano una profonda ristrutturazione
semantica. In effetti, mentre gli antichi riti avevano una motivazione solo a metà
religiosa (si andava a La Mecca anche perché la città diventava un pretesto di
incontro per esigenze vari di gruppi altrimenti nomadi e che avrebbero fatto fatica a
relazionarsi fra loro e a soccorrersi nelle vicendevoli necessità), il pellegrinaggio
musulmano diventa importante per le nuove connotazioni simboliche che assume. Il
viaggio è la metafora che più di ogni altra descrive la realtà intima dell’uomo nel suo
procedere dalla nascita alla morte, nel suo passare dalla morte alla nuova vita celeste.
Anche la devozione alla pietra nera viene reinterpretata dalla nuova ottica religiosa; il
secondo califfo Umar avrebbe esclamato: “So che tu sei una pietra e non sei né di
utilità, né di danno; e se non avessi visto l’inviato di Dio che ti baciava, non ti
bacerei”. Queste parole peraltro convivono con tradizioni profetiche di segno
opposto, che definiscono quel sacro meteorite “un Bianco Giacinto tra i Giacinti del
Paradiso, reso poi nero da Dio per le malefatte dei peccatori”. Non dobbiamo
comunque dimenticare l’aspetto litolatrico (culto delle pietre e dei luoghi elevati)
della religione preislamica che si è trasferito quasi naturalmente da una prospettiva
religiosa all’altra. Il culto della pietra nera si perde infatti all’interno di una grandiosa
opera di riappropriazione che l’Islām fece del tempio santo della Mecca, ponendo le
sue origini nell’epoca primordiale, al fine di ricollegarlo alla genuina tradizione
monoteistica e di purificarlo dalla contaminazione del paganesimo. La tradizione
vuole che il luogo in cui esso sorge sia stato scelto da Dio prima della creazione del
mondo e che esso sia a immagine di un tempio costruito nel cielo per ordine di Dio
stesso da parte degli angeli: come questi girano in adorazione attorno al tempio
celeste così gli uomini sono chiamati a farlo attorno a quello terreno. Si afferma che
già al tempo di Adamo una tenda fu fatta scendere dal cielo perché il primo uomo,
cacciato dal Paradiso ma ormai perdonato da Dio, compisse attorno ad essa il rito
della circumambulazione (tawaf). Perduta durante il diluvio essa fu sostituita
dall’edificio cubico (Ka’ba) edificato, così dice il Corano, per ordine di Dio da
Abramo insieme al figlio Ismaele:
“Purificate la mia casa per coloro che attorno vi correranno venerabondi, vi pregheranno devoti, vi
si inchineranno e si prostreranno reverenti”. 2,125.
Il pellegrinaggio Hajj si deve compiere in uno specifico periodo dell’anno e da un
gran numero di pellegrini insieme, come sottolinea giustamente A Bausani:
da: ALESSANDRO BAUSANI, L’Islam, Garzanti, Milano 1980, pp.59-62.
Gli elementi costitutivi dello Hajj sono essenzialmente tre:
PRIMO ELEMENTO: bagno completo; taglio dei capelli; abolizione di abiti con
cuciture (sostituiti da pezze di stoffa bianca, una delle quali ricopre la parte inferiore
del corpo, l’altra la superiore, lasciando scoperta la spalla destra: questo è valido per
il maschio). Poi si passa alla formulazione della niyyah, dell’intenzione sacra,
pronunciando la seguente preghiera:
O mio Dio!
Ecco, io ho ferma volontà di compiere il pellegrinaggio.
Me lo devi rendere facile, lo devi da me accettare.
Eccomi (Labbaīka)
O Dio, eccomi.
Tu non hai associati alla tua divinità.
Eccomi,
lode, azione di grazie ti sono dovute,
e così pure ti è dovuto il regno.
Tu non hai associati (alla tua divinità).
Dopo questo primo atto, il musulmano entra in stato di harām, ossia di
sacralizzazione separante dal resto del mondo. In harām è proibito al maschio
coprirsi il capo, radersi i capelli e barba o depilarsi, tagliarsi le unghie, profumarsi,
andare a caccia, tagliare erbe del territorio sacro della Mecca (a meno che siano
secche o siano giunchi), avere rapporti sessuali, usar galanteria con le donne. Per le
donne, poi, ci sono usi e proibizioni speciali: deve essere vestita normalmente, anche
se in bianco, e può indossare abiti cuciti; può coprire la testa e la faccia, purché il
tessuto del velo non aderisca al volto; può portare calze e guanti. Per le proibizioni di
profumi e di rapporti sessuali valgono le restrizioni imposte ai maschi. La donna non
potrà gridare il suo Labbaīka (eccomi!) ad alta voce, ma lo dovrà dire
sommessamente.
SECONDO ELEMENTO:
il musulmano giunge alla città della Mecca e si reca subito alla Ka’ba, edificio cubico
situato al centro del cortile principale della moschea, Nel lato est è conficcata la
pietra nera. L’interno della ka’ba è vuoto, mentre l’esterno è ricoperto da un velo
nero con scritte sacre che si rinnova ogni anno. Attorno alla ka’ba il pellegrino
compie la circumambulazione (tawaf), pronunciando ogni volta formule
differenziate. Poi corre sette volte fra due alture (ora livellate dal piano edilizio della
Mecca) situate ad est del tempio, Safa e Marwa, con passo accelerato. (il rito ricorda
l’episodio di Agar ed Ismaele: Agar fu abbandonata da Abramo proprio in queste
zone e, secondo la tradizione, Agar salì prima sulla collina di Safa e poi su quella di
Marwa, facendo la spola sette volte fra i colli, alla ricerca di una sorgente d’acqua per
dissettare il figlioletto Ismaele assetato, mentre la sorgente è ai piedi del bimbo.).
Rimane alla Mecca fino all’ottavo giorno del mese di pellegrinaggio.
Compiuti questi riti, il pellegrino parte per Mina, a sette km ad est della Mecca. Il
nono giorno parte per Arafat, modesta pianura a 21 km dalla Mecca, attorniata da una
parte di colline ad emiciclo, al centro delle quali si trova la “montagna della
misericordia” (jabat-r-rahmati). Si tiene in piedi sulla montagna anche solo per pochi
minuti. E’ il punto culminante del pellegrinaggio e il suo momento essenziale. Chi
non avesse fatto questa stazione avrebbe annullato il suo pellegrinaggio.
TERZO ELEMENTO
Il decimo giorno è festa grande (‘īd al kabīr). Il fedele immola agnelli o capretti in
ricordo di Abramo e del sacrificio di Ismaele (Isacco, nelle scritture ebraico-cristiane)
interrotto dall’angelo e sostituito con quello di un capretto. Si tiene ritto in piedi nella
località della Muzdalifā, anche solo per qualche minuto, poi scaglia sette pietre sulla
jamrah (stele) di Al Aqabah. Poi scanna un agnello a Mina, dov’era tornato nel
frattempo, divide il pasto con i poveri, si rasa la testa o almeno accorcia le chiome,
rientra alla Mecca e ripete la circumambulazione alla ka’ba.
CONCLUSIONE
Dopo, gli diviene lecito tutto ciò che gli era stato proibito. L’undicesimo giorno
scaglierà ancora sette pietre su altre tre steli e ripeterà il gesto nel dodicesimo giorno.
In tal modo termina il pellegrinaggio. Rientrerà a casa e avrà il titolo onorifico di
hajji (colui che è stato pellegrino). Prima di rientrare a casa, gli è consentito di
visitare a Medina il sepolcro di Muhammad e quelli dei suoi successori, Abu Bakr e
Umar.
Partecipare al pellegrinaggio è un’esperienza che vivifica e rinnova il credente di una
intensità tale da provocare in lui una sorta di nuova conversione, islamizzazione. Per
comprendere l’intensità religiosa che accompagna il fedele giustamente il Branca
riporta le parole che un grande scrittore egiziano, premio Nobel per la letteratura nel
1988, Nagib Mahfuz, pone sulle labbra di un musulmano in partenza per il
pellegrinaggio:
“Potessi restare fino alla fine dei miei giorni in quei luoghi santi, nella terra calpestata dal Profeta,
respirare l’aria che ha sentiti il battito delle ali degli angeli e vedere le dimore dove è risuonata la
rivelazione celeste che innalzava gli abitanti della terra fino al cielo. Laggiù si pensa solo
all’eternità e il cuore vibra d’amore per Dio, là si trova rimedio e guarigione. Fratello, muoio dal
desiderio di vedere la Mecca, di contemplare i suoi cieli, di udire intorno a me il sussurro dei secoli,
di camminare per le sue strade, raccogliermi nei suoi santuari, spegnere la mia sete alla fonte di
Zamzan, percorrere la strada aperta dal Profeta nell’egira, come si fa ininterrottamente da
milletrecento anni, ritemprare il cuore visitando la sua tomba e pregando nel nobile giardino”.
Ma qual è il significato di questa multiforme ritualità?
Innanzi tutto, il pellegrinaggio è l’accettazione di un comando divino, al quale ci si
sottomette nel momento in cui si pronuncia la niyyah. Il termine labbaīka (eccomi)
esprime un atto di presenza al fine di soddisfare l’ordine divino. Il desiderio e la
volontà di essere dentro l’ordine divino costituiscono l’atteggiamento interiore
primario del pellegrino, così come per gli altri arkān.
In secondo luogo, il pellegrinaggio rappresenta la riconferma della propria identità
religiosa espressa mediante l’incessante professione di fede in Dio Uno e Unico. E’
emblematico a questo proposito il bel memoriale dell’antropologo di origini
In terzo luogo, il pellegrinaggio è la riaffermazione della propria identità islamica e
dell’appartenenza alla ummah al nabī, ossia alla comunità del Profeta.
Accanto a questi aspetti più sociologici, ve ne sono altri che si inseriscono
maggiormente nella dinamica morale-spirituale dell’uomo musulmano e cioè
l’aspettativa redentivi, salutare che si esprime nell’attesa di “perdono” (tawbah) da
parte di Dio e nella decisione di restare sul “cammino di Dio” (Shari’ah)
Oltre che in occasione del vero e proprio pellegrinaggio, il musulmano si può recare
alla Mecca per devozione a titolo personale: la visita (umra) o “piccolo
pellegrinaggio” differisce dal “grande pellegrinaggio” come l’adempimento di un
obbligo religioso differisce dalla celebrazione di una festività sacra; infatti, mentre la
visita si può compiere in qualsiasi momento e individualmente, è specifico del
pellegrinaggio essere celebrato una sola volta l’anno e da un gran numero di fedeli
insieme.
CONCLUSIONE
Il senso del peccato e il bisogno del perdono manifestato in questo e in altri testi del
pellegrinaggio, rappresentano il punto focale dell’esperienza religiosa islamica, in
quanto punto di partenza e di arrivo del cammino spirituale. Si può dire,
relativizzando il senso dei termini, che in questo sta la dinamica salvifica del
musulmano. La Shari’ah educa alla coscienza critica circa il bene e il male e gli
arkān sono in funzione dello stato di pace con Dio e con se stessi; la misericordia di
Dio è la causa salvifica; la richiesta del perdono è la fiducia nella misericordia di Dio,
ciò per cui si merita la misericordia.
La distanza ontologica tra Dio e l’uomo non viene ridotta dalla vicinanza dell’uomo a
Dio espressa mediante la sua perfezione morale acquisita tramite la sottomissione alla
shari’ah. Come la prossimità di Dio all’uomo mediante la rivelazione della shari’ah
non riduce la distanza ontologica così la qualificazione morale dell’uomo non elimina
tale distanza. Nell’Islām il processo di qualificazione morale colloca l’uomo nel suo
ordine creaturale. Si può ancora osservare che la giustificazione ultima dell’atto
morale, nell’islām, è l’ordine divino; si tratta di una giustificazione immediatamente
divina.
Nell’Islam, dunque, come rileva giustamente Giuseppe Scattolin, Dio è, dal punto di
visto ontologico, il Creatore (Khāliq) e l’essere umano la creatura (Khalq-khalīqa);
mentre, dal punto di vista delle relazioni personali, Dio è il Signore assoluto (rabb) e
l’essere umano il suo servo adoratore (‘abd). Dio, quindi, comunica mediante la
rivelazione e l’ispirazione (wahy – tanzīl) e l’essere umano risponde nella preghiera e
nell’invocazione. Dio, verso l’uomo, può mostrare misericordia (rahma); grazia
(Ni’ma), ira (ghadab) e punizione (‘iqāb); mentre l’uomo può rispondere con la fede
(imān); il ringraziamento (shukr); l’incredulità (Kufr) o la paura (taqwā), ma
soprattutto la sottomissione (islām). Se sceglie di testimoniare la sottomissione nel
culto, l’uomo chiede a Dio che gli venga mostrata la via e si affida interamente al
Signore, come il servo, divenendo abd-allāh, servo del Signore. Il servo-uomo è a
completa disposizione del suo Signore, ma è anche sotto la sua cura e la sua
protezione. Di conseguenza, tutta la vita umana, in tutte le attività è nella visione
coranica un servizio-culto (‘ibāda) reso al Signore.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
R. ARNANDEZ, Il fedele musulmano, in J. RIES (a cura di), Il credente nelle
religioni ebraica, musulmana e cristiana, Jaka Book – Massimo, Milano 1993, pp.
285-340
G. RIZZARDI, Islām. Spiritualità e mistica, Cardini, Fiesole 1994
C. SACCONE, I percorsi dell’Islam. Dall’esilio di Ismaele alla rivolta dei nostri
giorni, Messaggero, Padova 2003
G. SCATTOLIN, Dio e l’uomo nell’Islam, Emi, Bologna 2004
G. VERCELLIN, Istituzioni del mondo musulmano, Torino 1996
“Guidaci sulla retta via” Cor, I, 6
IL CULTO ISLAMICO COME SOTTOMISSIONE ALLA VOLONTA’ DI DIO
Schema dell’intervento
Introduzione: il culto come superamento dell’immagine
- Il problema della visione di Dio (Ru’ya): il motivo del divieto di farsi
immagini (aniconismo)
- L’uomo come servo (‘abd) e immagine (sūra) di Dio
- La teologia dei 99 nomi: il nome come immagine di Dio
Prima parte: i significati del culto
- Il paradigma del credere islamico: īmān, islām, ihsān (fede, sottomissione,
bene); il culto come segno della fede nel Dio Unico;
- La via della sottomissione come mediazione a Dio attraverso il culto;
- La dialettica tra dīn e dunyā (religione e mondo) nel culto: il rifiuto
dell’ascetismo.
Seconda parte: descrizione ed interpretazione delle principali pratiche cultuali
- Il cammino della sottomissione: i cinque arkān (pilastri)
- La shahāda (professione di fede);
- La salāt (preghiera rituale): significato spirituale e sociale della preghiera;
analisi delle condizioni preliminari (harām, stato di purezza; niyyah, pronuncia
dell’intenzione; qibla, orientamento alla Mecca); la prassi della preghiera;
dialettica tra puro e impuro;
- La zakāt (elemosina): differenze tra l’elemosina rituale e la sadaqah,
beneficenza libera; aspetti religiosi, sociologici e pedagogici dell’elemosina
- Il sawm (digiuno): senso del digiuno e motivi storico-religiosi; dialettica tra
lecito e illecito; ‘īd al-fītr, festa della “rottura del digiuno”
- Lo hajj (pellegrinaggio alla Mecca): prassi rituale e significati storico-religiosi.
Conclusione: il senso ultimo della sottomissione