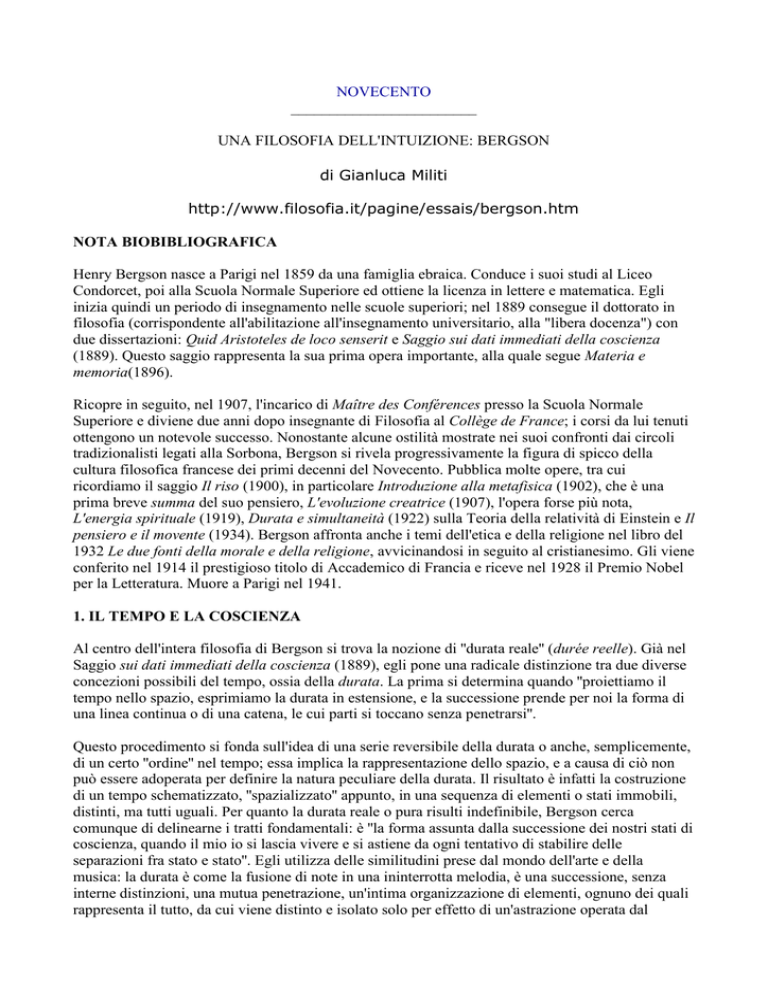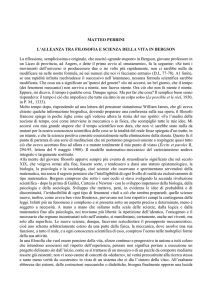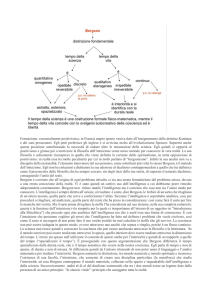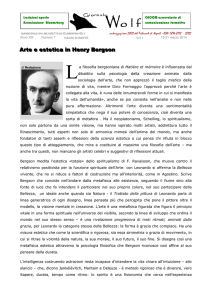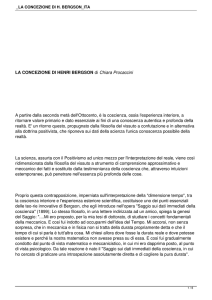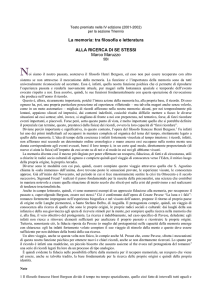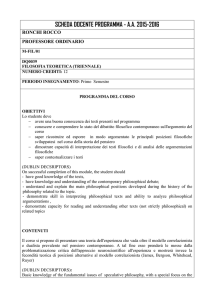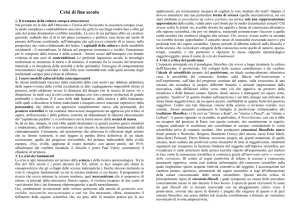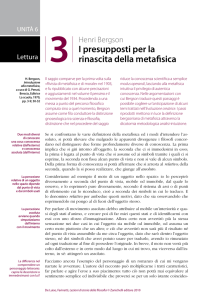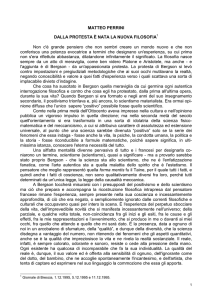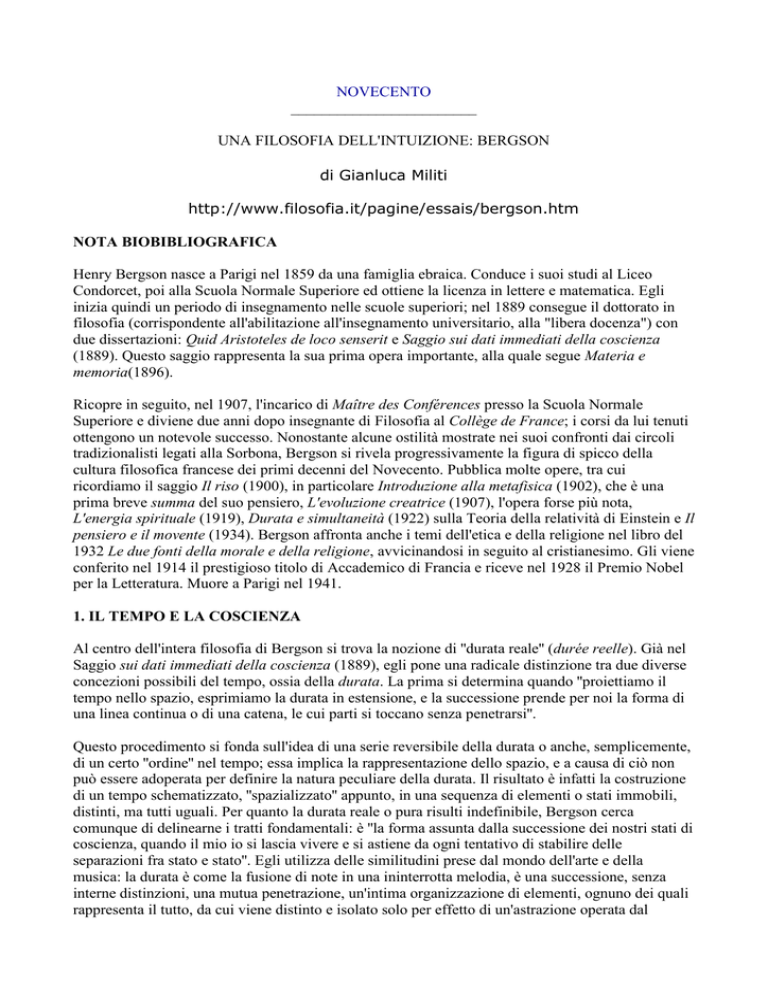
NOVECENTO
________________________
UNA FILOSOFIA DELL'INTUIZIONE: BERGSON
di Gianluca Militi
http://www.filosofia.it/pagine/essais/bergson.htm
NOTA BIOBIBLIOGRAFICA
Henry Bergson nasce a Parigi nel 1859 da una famiglia ebraica. Conduce i suoi studi al Liceo
Condorcet, poi alla Scuola Normale Superiore ed ottiene la licenza in lettere e matematica. Egli
inizia quindi un periodo di insegnamento nelle scuole superiori; nel 1889 consegue il dottorato in
filosofia (corrispondente all'abilitazione all'insegnamento universitario, alla "libera docenza") con
due dissertazioni: Quid Aristoteles de loco senserit e Saggio sui dati immediati della coscienza
(1889). Questo saggio rappresenta la sua prima opera importante, alla quale segue Materia e
memoria(1896).
Ricopre in seguito, nel 1907, l'incarico di Maître des Conférences presso la Scuola Normale
Superiore e diviene due anni dopo insegnante di Filosofia al Collège de France; i corsi da lui tenuti
ottengono un notevole successo. Nonostante alcune ostilità mostrate nei suoi confronti dai circoli
tradizionalisti legati alla Sorbona, Bergson si rivela progressivamente la figura di spicco della
cultura filosofica francese dei primi decenni del Novecento. Pubblica molte opere, tra cui
ricordiamo il saggio Il riso (1900), in particolare Introduzione alla metafisica (1902), che è una
prima breve summa del suo pensiero, L'evoluzione creatrice (1907), l'opera forse più nota,
L'energia spirituale (1919), Durata e simultaneità (1922) sulla Teoria della relatività di Einstein e Il
pensiero e il movente (1934). Bergson affronta anche i temi dell'etica e della religione nel libro del
1932 Le due fonti della morale e della religione, avvicinandosi in seguito al cristianesimo. Gli viene
conferito nel 1914 il prestigioso titolo di Accademico di Francia e riceve nel 1928 il Premio Nobel
per la Letteratura. Muore a Parigi nel 1941.
1. IL TEMPO E LA COSCIENZA
Al centro dell'intera filosofia di Bergson si trova la nozione di ''durata reale'' (durée reelle). Già nel
Saggio sui dati immediati della coscienza (1889), egli pone una radicale distinzione tra due diverse
concezioni possibili del tempo, ossia della durata. La prima si determina quando ''proiettiamo il
tempo nello spazio, esprimiamo la durata in estensione, e la successione prende per noi la forma di
una linea continua o di una catena, le cui parti si toccano senza penetrarsi''.
Questo procedimento si fonda sull'idea di una serie reversibile della durata o anche, semplicemente,
di un certo ''ordine'' nel tempo; essa implica la rappresentazione dello spazio, e a causa di ciò non
può essere adoperata per definire la natura peculiare della durata. Il risultato è infatti la costruzione
di un tempo schematizzato, ''spazializzato'' appunto, in una sequenza di elementi o stati immobili,
distinti, ma tutti uguali. Per quanto la durata reale o pura risulti indefinibile, Bergson cerca
comunque di delinearne i tratti fondamentali: è ''la forma assunta dalla successione dei nostri stati di
coscienza, quando il mio io si lascia vivere e si astiene da ogni tentativo di stabilire delle
separazioni fra stato e stato''. Egli utilizza delle similitudini prese dal mondo dell'arte e della
musica: la durata è come la fusione di note in una ininterrotta melodia, è una successione, senza
interne distinzioni, una mutua penetrazione, un'intima organizzazione di elementi, ognuno dei quali
rappresenta il tutto, da cui viene distinto e isolato solo per effetto di un'astrazione operata dal
pensiero.
La pura durata ''potrebbe essere benissimo nient'altro che una successione di cambiamenti
qualitativi che si fondono, che si compenetrano, senza contorni precisi, senza nessuna tendenza a
esteriorizzarsi gli uni nei confronti degli altri, senza nessuna parentela col numero: sarebbe
l'eterogeneità pura'', che si differenzia dalla omogeneità intrinseca alla strutturazione dello spazio. Il
senso del divenire coincide con la durata, escludendo la giustapposizione di stati ed istanti diversi e
separati, poiché è un flusso continuo, nel quale, in termini strettamente temporali, il passato si
proietta sul presente e si compenetra ad esso. Ogni stato, considerato in sé, è un perenne divenire e
ciò costituisce un limite insormontabile per la comprensione spaziale-simbolica. La durata reale, di
conseguenza, in quanto divenire implica sempre l'insorgere di qualcosa di ''nuovo'' e di
''imprevedibile'' e si rivela essere una ''creazione continua'' o autocreazione. La concezione della
durata, a partire da queste formulazioni, si impone come il vero Leitmotiv del pensiero bergsoniano
e deve perciò essere còlta nei diversi ambiti - ontologico, gnoseologico eccetera - in cui si
manifesta.
Il tempo espresso come durata, come puro divenire, è ''assoluto'' per la coscienza che lo vive: la
coscienza ''dura''. Bergson afferma che c'è almeno una realtà che tutti possiamo cogliere
nell'interiorità ed è proprio il ''nostro io che dura'', il nostro io nel suo fluire temporale. Quelli che
appaiono come degli stati della coscienza stessa, gli stati psichici, in realtà, in quanto distinti,
simbolizzati come elementi spaziali e giustapposti l'uno all'altro, non rappresentano la vera vita
coscienziale, ma solo l'io superficiale, schematizzato, esteriorizzato: in profondità invece si può
avvertire una fluida continuità. Bergson, sulla linea dello spiritualismo, sostiene in termini
''cartesiani'' che ''l'esistenza di cui siamo più decisamente sicuri, quella che conosciamo con maggior
chiarezza, è la nostra senza dubbio. Potremmo giudicare infatti esteriore e superficiale la nozione
che possediamo degli oggetti esterni; ma per quel che riguarda noi stessi, percepiamo intimamente e
profondamente'' (Evoluzione creatrice). Egli spiega come ogni stato di coscienza si arricchisca
continuamente della durata che raccoglie e nota, acutamente, che non c'è differenza tra il cambiare
di stato e il permanere nello stesso stato. Questi ''stati'' non costituiscono nemmeno in senso
rigoroso una molteplicità, se non una volta vissuti e fatti oggetto di rappresentazione, poiché nella
coscienza avviene una ''transizione continua'' o compenetrazione assoluta di tutti gli elementi.
Bergson propone molte metafore, che però, come egli stesso dichiara, sono in quanto tali inadeguate
a fornire un'immagine del processo o divenire vitale della coscienza; tra queste troviamo quella
dello srotolarsi di un gomitolo che è, al contempo, l'arrotolarsi del filo in un altro gomitolo. La
coscienza è ''il progredire del passato che rode l'avvenire e ingrossa a mano a mano che avanza'', ed
è perciò un continuo crescere su sé stessa. ''Coscienza vuol dire memoria'', conservazione del
passato nel presente ma anche anticipazione dell'avvenire: questa è l'altra tesi fondamentale di
Bergson. Di conseguenza, una coscienza non può vivere due stati identici, poiché dovrebbe
incessantemente finire e rinascere, ma ciò rappresenterebbe la negazione della memoria e quindi la
pura ''incoscienza''.
Se la coscienza è memoria, la memoria, cui Bergson dedica interessanti analisi - in particolare in
Materia e memoria (1896), che mette a fuoco in generale il rapporto tra spirito e materia - non deve
essere intesa in senso materialistico. Si devono distinguere due forme di memoria, quella dei
''meccanismi motori'' e quella dei ''ricordi indipendenti''. La prima è la memoria dello spirito, la
memoria ''per eccellenza'', la seconda è invece legata ad un ''esercizio abituale del corpo'', ad una
automatica ripetizione di azioni e si può perciò definire memoria del corpo o memoria-abitudine. La
prima forma di memoria registra, come ''immagini-ricordo'', tutti gli avvenimenti della nostra vita a
mano a mano che si svolgono; coglie ogni dettaglio, lascia ad ogni fatto e a ogni ''gesto'' il suo posto
nel tempo trascorso. Questa memoria non ha fini di utilità e di azione pratica, immagazzina il
passato solo per effetto di una necessità naturale e rende possibile il riconoscimento intellettivo di
una percezione già provata, di un'immagine trascorsa. Bergson ne esemplifica il funzionamento
riferendosi al sogno; nella dimensione onirica, in cui ''mi disinteresso della situazione presente'' nonostante il presente o l'''attualmente vissuto'' rimanga il segno fondamentale della coscienza -,
emergono ricordi legati a eventi e dati remoti dell'esistenza: il passato rimane quindi depositato nel
fondo della coscienza e può in ogni momento riaffiorare. ''Ma ogni percezione si prolunga in
un'azione nascente; e via via che le immagini, una volta percepite, si fissano e si dispongono in
questa memoria, i movimenti che le prolungavano modificano l'organismo, creano nel corpo nuove
disposizioni ad agire''.
Si crea in tal modo un'esperienza d'altro genere che si deposita nel corpo, e cioè una serie di
meccanismi già impostati di cui si prende coscienza nel momento in cui essi entrano in funzione.
Questa coscienza di un intero passato di ''sforzi'' raccolto nel presente indica una memoria molto
differente dalla prima, dal momento che, concentrata nel presente, è sempre tesa verso l'azione e
quindi verso il futuro. Essa trattiene solo i movimenti coordinati mediante l'intelligenza, in questo
modo si consolida lo sforzo accumulato; gli sforzi passati non vengono richiamati come immaginiricordo, ma nell'ordine rigoroso con cui concorrono a realizzare i movimenti attuali. Come afferma
Bergson, tale memoria ''non rappresenta il nostro passato, ma lo gioca'', lo attiva prolungando
l'effetto delle immagini fino al momento presente. È basata sulla peculiare funzione del cervello,
che consiste nel far riemergere da un fondo ''dimenticato'' quei ricordi che in proiezione futura
possono essere utili all'azione. Il cervello è allora ciò mediante cui si traduce in movimento e si
materializza la vita dello spirito. Questa, per ricordare la nota metafora bergsoniana, trascende,
come una sinfonia i movimenti della bacchetta del direttore, i meccanismi cerebrali. Tra il piano
dell'azione e quello del rivolgimento al passato, del sogno, si determina comunque un'infinita
intersezione di piani intermedi e una continua e reciproca interazione.
2. INTUIZIONE E INTELLIGENZA: METAFISICA E SCIENZA
Quella bergsoniana si può definire, dal punto di vista della conoscenza, una ''filosofia
dell'intuizione''. L'intuizione, come si legge in Introduzione alla metafisica, è quell'atto metafisico,
quella ''simpatia'', mediante cui ci si inserisce nell'interiorità di un oggetto e si attua una
''coincidenza'' con ciò che c'è in esso di unico e di inesprimibile, dunque con qualcosa di ''assoluto''.
L'intuizione si distingue dall'intelligenza - strumento proprio della scienza -, che è invece analisi. In
base al procedimento analitico si operano ''rigide'' distinzioni e si riconduce l'oggetto a elementi già
noti, ossia comuni a più oggetti: questa è una conoscenza del relativo che si serve di simboli e
schemi astratti (in tal senso opera in maniera simile all'intelletto astratto definito da Hegel).
L'analisi è l'espressione di una cosa ''in funzione di qualcosa che essa non è''; è una traduzione, una
spiegazione simbolica. In generale, l'intelligenza pensa la realtà mobile e fluida attraverso la
mediazione dell'immobile. L'intuizione è invece l'organo della metafisica, di una metafisica
autentica che secondo Bergson non consiste, come nel pensiero filosofico tradizionale, nel
passaggio dal divenire ad una struttura o entità immutabile, ma, al contrario, dal superamento
dell'immutabile nel divenire, nella durata.
La vita interiore è insieme varietà di qualità, continuità di progresso e unità di direzione; non può
essere tradotta in un'immagine - che però ha almeno il vantaggio della concretezza - né, a maggior
ragione, in un concetto o in un'idea astratta propri della conoscenza intellettiva o scientifica. Questa
è per sua natura inadatta a cogliere la realtà della durata, la sua essenza profonda, che può essere
penetrata solo attraverso l'intuizione metafisica. L'insufficienza dei concetti si mostra, ad esempio,
nel fatto che la durata viene definita come molteplicità in quanto costituita da un insieme di stati di
coscienza, i quali però non sono distinguibili poiché trascorrono e si prolungano l'uno nell'altro. In
questo senso si potrebbe parlare di un'''unità'' sui generis, ''che si muove, e cangia, e varia di colore'',
diversa dall'unità concettuale, immobile e vuota. Neanche la combinazione dei concetti di ''unità'' e
''molteplicità'' è in grado di rendere la natura della durata, la quale è originariamente un ''vissuto'', la
sostanza della vita della coscienza. L'intelligenza, che per Bergson è una facoltà che serve alla vita
pratica, domina esclusivamente la dimensione della materialità, spazialità, omogeneità e divisibilità,
attraversi cui il pensiero cerca di ricostruire in modo aporetico la durata, componendo una serie di
''immobilità''.
In questa prospettiva, egli critica il metodo della psicologia ''scientifica'', la quale risolve
analiticamente l'io in una serie di sensazioni, sentimenti e rappresentazioni; l'io viene così sostituito
da un insieme di fatti psicologici. Non si pone più così una distinzione tra razionalismo ed
empirismo poiché entrambi, procedendo per analisi, hanno come risultato la frammentazione della
coscienza, della ''personalità'', in stati immobili. Questi sono solo ''elementi di una traduzione'' e non
''parti dell'originale''. L'unica differenza è che l'empirismo cerca all'infinito l'unità dell'io nella
dispersa molteplicità degli stati psicologici, mentre il razionalismo, mediante astrazione, concepisce
l'unità come forma priva di materia, assolutamente vuota e indeterminata: questa è la fisionomia del
''concetto''. Se la conoscenza in generale assume una connotazione pratica e pragmatica, in quanto
serve all'azione, ''per prendere una decisione, per trarre un vantaggio, per soddisfare un interesse'', la
filosofia per Bergson deve, al contrario, ricercare una rappresentazione, o meglio un'intuizione
unica e semplice, che sia conoscenza ''disinteressata'' dell'oggetto, incentrata sulla cosa e non sul
concetto. Se l'analisi opera sull'immobile, l'intuizione ''ci inserisce nella mobilità, che è quanto dire
nella durata''. Bergson - questa è una tesi importante - afferma che dall'intuizione si può passare
all'analisi, ad una costruzione concettuale, ma che non vale il procedimento inverso.
Sui limiti dell'analisi è degno di nota quanto egli scrisse - siamo agli albori del cinema, nel 1907 - a
proposito della natura cinematografica del meccanismo conoscitivo. Nel caso del movimento nello
spazio, l'''artificio del cinematografo'' riproduce in fondo l'artificio della percezione, dell'intelligenza
e anche del linguaggio, poiché consiste nel proiettare un filmato con un apparecchio che svolge una
pellicola, e la pellicola è costituita da una serie di istantanee, di fotogrammi di un evento (ad
esempio, la parata di un reggimento). Questo tentativo di ricostruire il movimento a partire da
elementi fissi, immobili, per sua natura dà luogo a una ''contraddizione'' e perciò non è adeguato a
cogliere l'essenza del movimento: il movimento non può derivare dall'immobilità. Il ''metodo
cinematografico'', al di là della dimensione pratica, conduce, in ultima analisi, all'assurdo.
Sulla struttura logica di questo metodo si basa - è un punto interessante - anche l'argomentazione
mediante cui Zenone, con il noto esempio della freccia, nega l'esistenza del movimento: in un dato
istante la freccia in volo è ferma, perché altrimenti il suo movimento si realizzerebbe in due diversi
istanti; è impossibile però che un istante sia composto da più istanti. Bergson cerca comunque di
confutare la rigorosa logica di Zenone, che è rimasta per molti versi alla base del pensiero
filosofico, asserendo che essa non si rende conto che la durata - quindi l'intervallo, la traiettoria - ''si
crea tutto d'un tratto''. La conclusione è che, se è possibile suddividere a piacere la traiettoria ''una
volta creata'' non si può però mai suddividere l'atto della sua creazione, che è sempre in sé enérgeia,
atto progressivo e non ''cosa''.
3. L'EVOLUZIONE CREATRICE
Il percorso filosofico di Bergson è partito da un'indagine sui dati immediati della coscienza, dalla
quale è emerso, come tesi fondamentale, che è la ''durata'' reale a costituire l'essenza della coscienza
stessa. Egli ha conseguentemente impostato la sua filosofia sull'intuizione della durata, come è
testimoniato anche dalla teoria intorno alle due forme di conoscenza. Oltre la riflessione sul
rapporto spirito (coscienza)-corpo, Bergson ha dovuto perciò affrontare, in particolare in
L'evoluzione creatrice (1907), in chiave ''cosmologica'', l'esistenza della durata, la dimensione del
divenire nel mondo esterno.
Per un essere cosciente l'esistenza equivale al mutamento, il mutamento alla maturazione e questa al
crearsi da sé stesso indefinitamente. Anche il mondo inorganico-materiale, però, è coinvolto, al di là
dell'apparenza, nella durata, nel divenire: si può affermare allora che ''l'universo dura''. La
percezione è ciò che isola un oggetto e fornisce così le linee-guida per l'azione, ma è l'insieme
universale, la totalità delle interazioni tra i corpi la vera realtà del mondo. Il vivente, l'organismo,
non può coincidere con l'oggetto della percezione perché è qualcosa, durando, che si evolve e
condensa in sé il tempo.
Bergson conduce una penetrante critica che coinvolge sia il meccanicismo che il finalismo, in
quanto basati entrambi su schemi intellettualistici. Il meccanicismo implica una metafisica in cui la
totalità della realtà è posta tutta insieme, come fosse eterna, e quindi la durata, il tempo, che
permangono solo come espressione dei limiti conoscitivi del soggetto, sono, in ultima analisi,
negati. Il finalismo ha lo stesso principio del meccanicismo ma in forma rovesciata, poiché ''alla
spinta del passato'', per cui un dato è determinato come risultato di una serie di cause, sostituisce
''l'attrazione del futuro'', ossia prefigura un modello preesistente, un'Idea, una Forma che la serie
stessa dovrà necessariamente realizzare. La vita - come l'azione che è sua espressione - o in
generale la realtà, è invece per Bergson creazione incessante che apporta l'''imprevedibile'' e il
''nuovo''. La realtà deve essere compresa in termini di evoluzione. Ma il grande obiettivo della
speculazione bergsoniana non è individuare il risultato ultimo e perfetto dell'evoluzione, ma
piuttosto cogliere il suo unitario principio. Egli recupera il senso positivo nella dottrina del
finalismo: il mondo è un'armonia, ma un'armonia tendenziale, non attuale, in quanto ammette al
tempo stesso disarmonie, regressi e accidentalità, e quindi include la contingenza. Diversamente dal
finalismo ''radicale'', la concezione bergsoniana prevede una ''visione del passato alla luce del
presente''.
La tesi centrale, che si pone anche come principio di dimostrazione, è che ''la vita, sin dalla sua
origine, è la continuazione di un solo e medesimo slancio che si è diviso in linee di evoluzione
divergenti'': lo slancio vitale (élan vital). A partire da un'origine comune, le specie tendono ad
accentuare la loro divergenza nel corso dello sviluppo, ma proprio in base allo slancio vitale
originario mantengono, in alcuni aspetti particolari, un'identica natura. La vita, che è una creazione
che prosegue indefinitamente, procede per ''dissociazione'' e ''sdoppiamento''; si può dire che essa
effettui uno scopo, che è intrinseco, immanente, anche in linee dell'evoluzione tra loro indipendenti.
Bergson propone l'esempio dell'occhio: in esso la struttura complessa contrasta con la semplicità di
funzionamento: questo dato non può essere spiegato mediante un meccanismo o attraverso il
finalismo, né dalla concezione meccanicistica dell'evoluzione di Lamarck e di Darwin. L'unità e la
semplicità vitale dell'organo è reale, mentre la sua struttura complessa appare tale attraverso gli
schemi intellettualistici dell'analisi scientifica. La natura infatti forma l'occhio in modo analogo al
semplice e indivisibile atto con cui solleviamo una mano.
Bergson segue le tappe del percorso evolutivo, così come si configura nel mondo vegetale e in
quello animale. L'evoluzione degli Artropodi raggiunge un punto culminante diverso da quello
raggiunto dai Vertebrati, rappresentato dall'uomo. Le due diverse linee di sviluppo sono segnate,
rispettivamente, dal prevalere dell'istinto e dell'intelligenza; nell'uomo comunque si ritrovano
entrambe queste ''tendenze''. L'istinto è la facoltà di utilizzare a fini naturali strumenti organici,
mentre l'intelligenza è la facoltà di fabbricare oggetti artificiali; sul piano della conoscenza innata, il
primo si rivolge alle ''cose'', alla materia, mentre la seconda ai ''rapporti'', alla forma. Oltre c'è
l'intuizione della realtà del divenire, della vita, che fa cogliere la ''genesi ideale della materia''.
L'evoluzione segnata dallo slancio vitale talvolta si arresta, contrastata dalla legge del minimo
sforzo e dell'autoconservazione, e ricade su sé stessa. La materia consiste in questa ricaduta,
nell'''interruzione'' della tensione vitale, nell'insorgere della infinita divisione degli enti
(individuazione). La materia è anch'essa non una cosa, ma una tendenza o forza contraria, un
movimento inverso rispetto al processo della vita e della natura. Per Bergson essa non è la
negazione del processo di evoluzione, della ''realtà positiva'', ma la sua inversione, il suo opposto.
La materia e la spazialità-estensione - àmbito dell'ordine geometrico, dell'automatismo - non hanno
perciò origine da un principio diverso dallo slancio vitale, che è alla base della creazione continua,
ordine del vitale, della volontà: rappresentano la soppressione di quest'ordine, che è insieme
sostituzione, presenza di un ordine diverso.
L'aporia del discorso bergsoniano deriva dal fatto che, al tempo stesso, la materia e l'estensione, di
cui si deve spiegare la genesi, rimangono in sé un elemento di ''negatività interna'' alla positività
dell'evoluzione creatrice. È l'uomo soltanto, come coscienza, libertà e apertura all'azione (diversa
dall'automatismo dell'animale), che può sostenere lo slancio vitale e quindi la creazione, il divenire.
All'origine della vita, dice Bergson, c'è una coscienza o ''supercoscienza'', che è un ''esigenza di
creazione''. L'uomo, con le manifestazioni più elevate della sua attività e natura - la società, l'arte, la
morale, la religione -, supera i limiti imposti dalla materialità e rappresenta, in ultima istanza, la
linea fondamentale, che mai si arresta, di una complessa ed universale evoluzione.
Un luogo decisamente interessante del pensiero bergsoniano è l'analisi dell'idea del ''nulla'' (néant o
Rien), presente nel capitolo IV di L'evoluzione creatrice, (precedentemente apparsa nella ''Revue
philosophique'', 1906); questa idea è considerata ''l'invisibile motore del pensiero filosofico''. Il
''nulla'' assoluto è concepito da Bergson essenzialmente come ''annullamento'' totale, concetto che si
rivela però autocontraddittorio o ''distruttivo di sé stesso''. La sua argomentazione si sviluppa in
questi termini: se anche l'universo, il tutto, venisse soppresso o si inabissasse ''nel silenzio e nella
notte'', ci sarebbe sempre ''ciò che'' sopprime. Bergson mira a dimostrare in generale che la
soppressione di qualcosa implica, al tempo stesso, il subentrare di qualcos'altro. Anche pensare
l'abolizione di una cosa non è possibile che mediante la rappresentazione, implicita o esplicita, della
presenza di un'altra cosa. In ultima analisi, la soppressione di un oggetto esterno o interno (stato di
coscienza) è sempre una sostituzione, un ''rimpiazzamento''.
Bergson assume, per confutarla, l'ipotesi che sia possibile una progressiva, oggetto dopo oggetto,
abolizione del tutto. Ma ciò, come dimostrato, è sempre una progressiva sostituzione e perciò
l'emergere di un diverso oggetto: ne deriva l'impossibilità dell'abolizione del tutto. L'annullamento
delle cose si presenta come una ''cosa'' e quindi risulta inevitabilmente contraddittorio. L'idea stessa
dell'''inesistenza'', il giudizio che nega l'esistenza, suppone l'esistenza dell'oggetto che si assume non
esista; l'inesistenza allora non è altro se non la posizione dell'esistenza ''con in più la
rappresentazione dell'esclusione dalla realtà''. Nella prospettiva bergsoniana, il nulla è sempre
relativo e coincide con la posizione del ''diverso'': è lo stesso esito dell'argomentazione platonica nel
Sofista. Nell'universo quindi non esiste il vuoto (vide). Con questa analisi, segnata da notevole
spessore teoretico, ma anche da interne aporie, Bergson ha cercato di sostenere la sua concezione
dell'universo come continua evoluzione e creazione.
HENRI BERGSON
A cura di
http://www.geocities.com/diego_fusaro_2000/filos.htmlhttp://www.geocities.com/diego_fus
aro_2000/filos.html
IL RISO
INDICE
IL COMICO SECONDO BERGSON
IL COMICO SECONDO BERGSON
1. Le fonti. Le riflessioni di Bergson sulla natura della comicità sono racchiuse in un breve
libro, intitolato Il riso. Saggio sul significato del comico (1900), destinato ad un successo
travolgente: ebbe infatti più di sessanta edizioni in poco più di quarant'anni, grazie anche
alla leggerezza dello stile che rende tanto più piacevolmente leggibile un'opera che è
peraltro assai più impegnativa e ricca di quanto non sembri.
Quest'opera si situa in una fase importante dell'evoluzione del pensiero bergsoniano: si
colloca infatti negli anni in cui da interessi prevalentemente psicologico-filosofici Bergson
muove verso una filosofia della vita orientata metafisicamente. Il saggio sul riso accomuna
dunque, come vedremo, queste due tendenze della speculazione di Bergson e
rappresenta quindi una possibile introduzione al suo pensiero.
1. Un'idea antica: il riso ha una funzione sociale. Nelle pagine di questo suo libro, Bergson
muove innanzitutto da una constatazione di natura generale: se il riso è un gesto che
appartiene a pieno titolo al comportamento umano, allora deve essere lecito domandarsi
qual è il fine che lo anima. Ora, per comprendere il fine cui mira un comportamento si deve
in primo luogo far luce sulle occasioni in cui accade. E per Bergson vi sono almeno tre
punti che debbono essere a questo proposito sottolineati:
1. "Non vi è nulla di comico al di fuori di ciò che è propriamente umano" (ivi, p.4).
Questa affermazione può lasciarci di primo acchito perplessi: si può ridere infatti
anche di un cappello o di un burattino di legno. E tuttavia, se non ci si ferma a
questa constatazione in sé ovvia, si deve riconoscere che in questi casi il rimando a
ciò che è umano gioca un ruolo prevalente e comunque ineliminabile: di un
cappello ridiamo perché vi vediamo espresso un qualche capriccio estetico
dell'uomo, così come nella marionetta l'immaginazione scorge i gesti impacciati di
un uomo sgraziato. Alla massima antica secondo la quale l'uomo È l'animale che
ride si deve affiancarne dunque una moderna: l'uomo È un animale che fa ridere.
2. Il riso scaturisce solo di fronte a ciò che appartiene direttamente o indirettamente
all'ambito propriamente umano; perché possa tuttavia scaturire è necessario che
chi ride non si lasci coinvolgere emotivamente dalla scena che lo diverte. Per ridere
di una piccola disgrazia altrui dobbiamo far tacere per un attimo la pietà e la
simpatia, e porci come semplici spettatori o - per esprimerci come Bergson - come
intelligenze pure: "il comico esige dunque, per produrre tutto il suo effetto, qualcosa
come un'anestesia momentanea del cuore" (ivi, pp. 5-6).
3. Il riso - abbiamo osservato - chiede una sorta di sospensione del legame di
simpatia che ci lega a colui di cui ridiamo. E tuttavia tutti sappiamo che il riso È
un'esperienza corale: ridiamo meglio quando siamo insieme ad altri, ed il riso È
spesso il cemento che tiene unito un gruppo di persone. "Il riso, - commenta
Bergson - [...] cela sempre un pensiero nascosto di intesa, direi quasi di complicità,
con altre persone che ridono, reali o immaginarie che siano" (ivi, p.6).
Non è difficile scorgere la nota che accomuna queste tre osservazioni generali: il riso
sembra essere strettamente connesso con la vita sociale dell'uomo, con il suo essere un
animale sociale. Possiamo allora - seguendo Bergson - far convergere i tre punti su cui
abbiamo dianzi richiamato l'attenzione in un'unica tesi, che getta appunto la sua luce sul
quando del riso: "Il "comico" nasce quando uomini riuniti in un gruppo dirigono l'attenzione
su uno di loro, facendo tacere la loro sensibilità, ed esercitando solo la loro intelligenza"
(ivi, p.7). E se le cose stanno così, se il riso come comportamento umano sorge nella vita
associata, allora si può supporre che esso risponda a determinate esigenze della vita
sociale.
3. Il riso ed il diavolo a molla. Per far luce sul motivo che ci spinge a ridere non basta
indicare quando ridiamo: occorre riflettere anche su ciò di cui ridiamo. Orientarsi in questa
seconda parte delle analisi vuol dire innanzitutto lasciarsi guidare dagli esempi, e tra
questi uno gode di una posizione privilegiata proprio per la sua estrema semplicità: il gioco
del diavolo a molla. "Noi tutti abbiamo giocato [...] col diavolo che esce dalla sua scatola.
Lo si schiaccia ed ecco si raddrizza; lo si ricaccia più in basso ed esso rimbalza più in alto,
lo si scaccia sotto il coperchio ed esso fa saltare tutto" (p. 46) scrive Bergson, e propone
subito dopo un'osservazione che ci spiega perché un simile gioco possa far ridere un
bambino: "E' il conflitto di due ostinazioni, di cui l'una puramente meccanica finisce
ordinariamente per cedere all'altra, che se ne prende gioco" (ivi, p. 47). Del diavolo ci fa
ridere la cieca ostinazione, il suo "saltar su" come una molla: È dunque il comportamento
rigidamente meccanico di ciò che pure nel gioco vale come un essere dotato di
un'autonoma volontà a far ridere il bambino.
Un comportamento rigidamente meccanico applicato a ciò che è (o immaginiamo che sia)
vivente: su questa tesi dobbiamo riflettere perché per Bergson circoscrive in modo
sufficientemente preciso l'ambito del comico.
Molti esempi di comicità possono esserle immediatamente ricondotti: una marionetta ci fa
ridere perché i suoi gesti sono rigidi e meccanici, ed è per questa stessa ragione che ci
sembra ridicolo chi - giunto in fondo alle scale - tenta di scendere anche da un ultimo
inesistente gradino, con un gesto goffo che non è motivato da un fine reale, ma solo dal
meccanismo acquisito della discesa. Altri invece ci costringono a disporci nella prospettiva
propria dell'immaginazione che con le definizioni non procede con la stessa metodica
precisione dell'intelletto: così, non dobbiamo stupirci se il topos della meccanicità si
estende per l'immaginazione fino a coprire campi che non sembrano in senso stretto
spettarle. Per l'immaginazione una macchina È innanzitutto ripetitiva: di qui la comicità che
sorge dalla ripetizione dei gesti, delle azioni, dei pensieri. "Due volti simili, ciascuno dei
quali preso isolatamente non fa ridere, presi insieme fanno ridere per la loro somiglianza" diceva Pascal, e tutti sappiamo come un tic fisico o intellettuale (una frase, sempre la
stessa, ripetuta troppo di sovente) sia causa di ilarità. Ma un meccanismo non è solo
ripetizione: è anche - a dispetto del movimento - staticità. Una macchina è inchiodata alla
sua funzione: così, chi voglia fare una caricatura, saprà farci ridere solo a patto di ritrarre
nel volto una piega espressiva solidificata in un tratto stabile della fisionomia,
un'espressione cui la macchina dei lineamenti non sa più sottrarsi. Nell'immagine della
macchina si cela infine anche l'idea dell'ostinazione cieca, del movimento che non sa più
aderire al presente, ma segue una regola tanto fissa quanto sorda alle esigenze del
momento. Basta dunque che questa immagine si sovrapponga alla vita umana perché il
riso si faccia avanti. Una simile sovrapposizione si ha per esempio
quando l'anima ci si mostrerà contrariata dai bisogni del corpo - da un lato la
personalità morale con la sua energia intelligentemente variata, dall'altra il corpo
stupidamente monotono interrompente sempre ogni cosa con la sua esigenza di
macchina. Quanto più queste esigenze del corpo saranno meschine ed
uniformemente ripetute, tanto più l'effetto sarà vivo (ivi, p. 33).
Non è dunque un caso - commenta Bergson - se i personaggi tragici debbono tenersi
lontani da gesti che tradiscano le esigenze della corporeità, mentre il commediografo potrà
senz'altro ottenere il riso del pubblico rappresentando i suoi personaggi comici in preda a
un malanno o ad un fastidioso singhiozzo che interrompe ogni loro discorso.
Proprio come la vita dello spirito può essere ostacolata nel suo realizzarsi dalle esigenze
della macchina corporea, così la forma della vita sociale può soffocarne il senso. La lettera
- le regole e le convenzioni sociali - si sovrappone alla sostanza - la vita in comune, e dalla
contemplazione di questo travestimento della vita sorge la comicità: il deputato che
interpellando il ministro su di un assassinio famoso rammenta che il colpevole, dopo aver
ucciso la vittima, È sceso dal treno in senso contrario alla sua direzione, violando così il
regolamento, è - per Bergson - comico perché in lui l'adesione alla regola ha soffocato la
comprensione della vita.
Potremo soffermarci ancora sulle strade che l'immaginazione comica percorre, e non
sarebbe difficile mostrare come a partire dalle poche cose che abbiamo detto possano
comprendersi le ragioni che ci spingono a ridere dei travestimenti o - e su questo punto
dovremo in seguito ritornare - dei vizi di natura morale. Per ora ci basta invece il risultato
cui siamo pervenuti: ciò di cui ridiamo è - per Bergson - tutto ciò in cui l'immaginazione
scorge una sorta di meccanicizzazione della vita.
4. Il riso come castigo sociale. La comicità morale e la funzione sociale della commedia.
Le considerazioni che abbiamo sin qui svolto ci permettono di formulare ora, senza
ulteriori indugi, una risposta alla domanda da cui avevamo preso le mosse, - la domanda
sul fine che il riso persegue. Il riso - avevamo osservato - deve avere una funzione sociale,
e sorge - aggiungiamo ora - dalla constatazione di una sorta di contraddizione: ciò che
dovrebbe comportarsi in modo libero e vivo sembra assoggettare i suoi gesti a leggi
meccaniche, alla cieca ostinazione del meccanismo. Al riso spetta dunque il compito di
sanare questa contraddizione, richiamando quella parte della società (reale o
immaginaria) che è colpevole di un comportamento rigido e ostinato ad un atteggiamento
più elastico, ad uno stile di vita più duttile e desto. Il riso è quindi un castigo sociale:.
È comico - scrive Bergson - qualunque individuo che segua automaticamente il suo
cammino senza darsi pensiero di prendere contatto con gli altri. Il riso è là per
correggere la sua distrazione e per svegliarlo dal suo sogno. [...]. Tutte le piccole
società che si formano sulla grande sono portate, per un vago istinto, ad inventare
una moda per correggere e per addolcire la rigidità delle abitudini contratte altrove,
e che sono da modificare. La Società propriamente detta non procede
diversamente: bisogna che ciascuno dei suoi membri stia attento a ciò che gli È
intorno, si modelli su quello che lo circonda, eviti infine di rinchiudersi nel suo
carattere come in una torre di avorio. Perciò essa fa dominare su ciascuno, se non
la minaccia di una correzione, per lo meno la prospettiva di un'umiliazione che per
quanto leggera non è meno temibile. Tale si presenta la funzione del riso. Sempre
un po' umiliante per chi ne è l'oggetto, il riso è veramente una specie di castigo
sociale (ivi, pp. 88-9).
Di questa funzione sociale del riso, la commedia È per Bergson un'espressione
esemplare. Tra tutte le forme di comicità una in particolare sembra stringere un rapporto
strettissimo con la sfera sociale: È la comicità morale. Le passioni spesso si prendono
gioco di noi e subordinano tutte le nostre azioni ad un unico meccanismo. E' questo ciò
che accade ai personaggi comici di molte commedie: lo spettatore È chiamato a ridere di
un uomo, i cui gesti sembrano quelli di una marionetta, mossa da un burattinaio - la
gelosia, l'avarizia, la pavidità, ecc. - che ci è ben noto e di cui sappiamo prevedere i
movimenti. Di qui la forma di tante commedie che hanno per protagonisti non già
individualità ben determinate, ma personaggi tipici, marionette dietro alle quali traspare la
passione che li domina. Ma di qui anche il fine che si prefiggono: correggere, ridendo, i
costumi. Alle forme propriamente artistiche, caratterizzate dall'assoluta assenza di finalità
pratiche si deve contrapporre dunque la commedia, che è - per Bergson - una forma
artistica spuria, proprio perché affonda le sue radici nella vita e perché alla vita ritorna
come ad un valore da salvaguardare e cui sottomettere i propri sforzi.
Vi è tuttavia una seconda ragione che spinge Bergson a dedicare tanto spazio alle
considerazioni sulla commedia, ed è propriamente il carattere per così dire teatrale della
comicità. Possiamo ridere soltanto quando la rigidità di un carattere o di un
comportamento si fa gesto e si mostra apertamente agli occhi dell'immaginazione: non ci
basta sapere che la paura della morte ha trasformato Argan in un burattino; per ridere
dobbiamo vedere i gesti in cui la riduzione dell'uomo a cosa si fa spettacolo. Ma lo
spettacolo comico implica uno spettatore che sappia per un attimo guardare alla vita come
ad una rappresentazione teatrale:
Da ciò il carattere equivoco del comico. Esso non appartiene né completamente
all'arte, né completamente alla vita. Da un lato i personaggi della vita reale non ci
farebbero mai ridere se noi non fossimo capaci di assistere alle loro vicende come
ad uno spettacolo visto dall'alto di una loggia; essi sono comici ai nostri occhi solo
perché ci danno la commedia. Ma d'altra parte, anche a teatro, il piacere di ridere
non è puro, cioè esclusivamente estetico, assolutamente disinteressato. Vi si
associa sempre un pensiero occulto che la società ha per noi quando non
l'abbiamo noi stessi; vi è sempre l'intenzione non confessata di umiliare e con ciò, è
vero, di correggere, almeno esteriormente" (ivi, p. 89).
Il riso sorge così come un gesto che per strappare la vita dalla sua negazione implica una
momentanea sospensione della vita stessa: È dunque una contemplazione della vita volta
a sanare i pericoli che la mettono in forse.
5. Il riso e la metafisica bergsoniana. Nonostante la sua indubbia coerenza e la sua
capacità di far luce su di un aspetto importante del comico, il saggio di Bergson sembra
lasciare aperto più di un problema. Ciò che in particolare colpisce il lettore è forse il
trovarsi di fronte ad un saggio che con tanto vigore sottolinea la funzione sociale del riso,
senza tuttavia sfociare in un'indagine di natura sociologica che - tra le altre cose - ci mostri
quali sono i processi di apprendimento del riso. Perché almeno questo è chiaro: se il riso è
un gesto sociale che appartiene alla forma di vita propria dell'uomo, allora deve esistere
qualcosa come un addestramento al riso, - un addestramento che insegni al bambino
quali sono i vizi e i difetti di cui ridere e quando È opportuno riderne.
In realtà, basta dare uno sguardo alle brevi considerazioni che Bergson raccoglie intorno a
questi problemi per rendersi conto che le sue analisi si muovono in un'altra direzione. Se
con Bergson indichiamo quali siano i "difetti" censurati dal riso siamo innanzitutto ricondotti
a ciò che ci rende non tanto immorali, quanto poco adatti alla società, ma dobbiamo poi in secondo luogo - rammentare che troviamo comiche anche le fisionomie buffe nelle quali
l'immaginazione può scorgere un irrigidimento della vita espressiva, ma in cui sarebbe
insensato scorgere un problema per la società. Se il riso È un castigo sociale, allora si
deve aggiungere che talvolta sembra castigare anche là dove non ce n'è alcun bisogno.
Non solo: di un vizio morale come l'avarizia o la gelosia, noi non sempre ridiamo, poiché osserva in primo luogo Bergson - il riso chiede che il vizio da castigare non ci coinvolga
troppo da vicino e ci permetta di mantenere la posizione dello spettatore.
In secondo luogo, tuttavia, Bergson attira la nostra attenzione sul fatto che uno stesso
vizio - l'avarizia, per esempio - pu• talvolta suscitare il riso, talvolta il nostro disprezzo. Ora,
la diversità della reazione non dipende solo dalla gravità della colpa, ma soprattutto dal
modo in cui questa si palesa. E ancora una volta il cammino da seguire ci È indicato
dall'esperienza letteraria. Gli eroi tragici ci rivelano il loro carattere nelle azioni, e con
azioni Bergson intende i comportamenti volontari della soggettività. Il personaggio comico
invece si rivela nei gesti, e cioè in quei movimenti e in quei discorsi nei quali uno stato
d'animo si manifesta senza scopo e senza alcuna premeditazione. Nell'azione la persona
intera è in gioco, nel gesto una parte isolata della persona si esprime all'insaputa o (per lo
meno) in disparte dell'intera personalità (ivi, p. 94). Il gesto - potremmo allora esprimerci
così - è una sorta di irruzione improvvisa dell'inconscio nella vita desta, ed è proprio
questo carattere di involontarietà e di immediatezza che ci fa apparire comico anche un
vizio che detestiamo.
Ma se il comico si esprime nel gesto, anche il riso è a sua volta un gesto sociale (ivi, p. 14)
di cui si deve sottolineare l'immediatezza: non bisogna dunque stupirsi se
non ha tempo di osservare sempre dove tocca [... e se] talvolta castiga certi difetti
come la malattia castiga certi eccessi, colpendo gli innocenti, risparmiando i
colpevoli, mirando verso un risultato generale, senza preoccuparsi del singolo" (ivi,
p. 126).
Così, accanto alla tesi secondo la quale il riso sorge come prodotto di un'antica abitudine
sociale, Bergson viene sempre più chiaramente sostenendo che "il riso è semplicemente
l'effetto di un meccanismo datoci dalla natura" (ivi, p. 126). Ed in questa prospettiva, il
problema di un addestramento al riso non si pone, poiché il riso ci appare come una
manifestazione diretta della natura, come una difesa immediata della vita che È la vita
stessa a donarci, armandoci di una sorta di istintiva reazione alla comicità. Se dunque
Bergson non si impegna sul terreno delle considerazioni sociologiche è proprio perché
intende rispondere alla domanda sulle origini del riso sul terreno di una autentica
metafisica della vita, che del resto si fa percepire in vari passaggi del saggio bergsoniano.
La nostra immaginazione - scrive Bergson ha una sua filosofia ben salda; in tutte le forme umane essa scorge lo sforzo di
un'anima che foggia la materia, anima infinitamente agile, eternamente mobile
sottratta al peso perché non è la terra che l'attira... Con la sua leggerezza alata
quest'anima comunica qualcosa al corpo che anima: l'immaterialità che passa così
nella materia è ciò che si chiama grazia. Ma la materia resiste e si ostina. Essa
attira, e vorrebbe convertire la propria inerzia e fare degenerare in automatismo
l'attività sempre sveglia di questo principio superiore [...]. Laddove la materia riesce
a far crassa esteriormente la vita dell'anima, irrigidendone il movimento ed
ostacolandone la grazia, ottiene dal corpo un effetto comico (ivi, pp. 19-20).
Non è difficile scorgere in queste pagine (o in quelle in cui si deducono le leggi della
comicità dalla diretta negazione della nozione metafisica di vita) il germe di quella filosofia
che troverà poi nell'Evoluzione creatrice la sua configurazione definitiva. La lotta tra
l'urgere dinamico e multiforme della vita e la resistenza cieca e sorda che la materia le
impone trova già qui, nella disamina sul comico, la sua prefigurazione. Così, non ci si deve
stupire se l'abitudine al riso È tanto antica da affondare le sue radici in un meccanismo
della natura (ivi, p. 126): il riso è sì un castigo sociale, ma le sue origini non appartengono
alla società, ma alla vita stessa e debbono essere quindi viste sullo sfondo della lotta tra lo
slancio vitale e l'inerzia della materia.
E se ci si pone in questa prospettiva, le considerazioni bergsoniane vengono a collocarsi
nell'orizzonte problematico di una filosofia della vita, - un orizzonte cui già alludevano le
pagine di Schopenhauer.