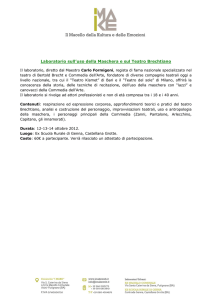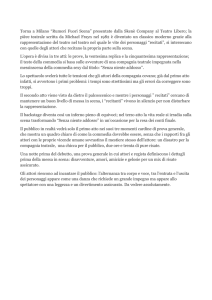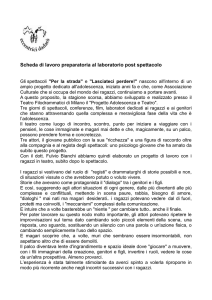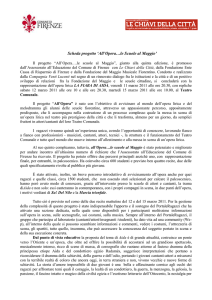Oltre la scena, dentro la storia
Saggio comparativo sulle antiche produzioni
teatrali in Occidente e in Oriente
(a cura di Lucia Mattera)
I maestri ci aprono le porte,
tocca a noi varcarle…
(antico proverbio cinese)
SPAZIO
ALLA
SCENA
Com'è noto, il teatro, in quanto organismo architettonico, trae origine, in Grecia, dalle primitive
sistemazioni dei luoghi all'aperto in cui si svolgevano danze e cori rituali connessi al culto dionisiaco:
l'altare era di solito collocato in uno spazio ridotto, pianeggiante e circolare, mentre i cittadini che
partecipavano ai riti si raggruppavano lungo il declivio concavo del terreno.
Sembra che in origine gli spettatori sedessero direttamente sull'erba del pendio naturale, intorno allo
stadio, e che i posti a sedere sull'erba siano stati sostituiti man mano da strutture lignee, una volta
circondata tutta l'area con uno steccato in modo che, nelle zone specialmente in cui non vi era tra gli
abitanti uguaglianza di diritti, una parte di essi veniva esclusa dagli spettacoli previsti.
Più tardi venne introdotto nel mondo greco il sistema minoico 1 della scalinata di pietra, restando
immutato il resto della struttura.
Con la nascita della tragedia e della commedia, concepite anch'esse come manifestazioni dell' “ethos”
comune e, quindi, di significato mediatamente rituale, fu consuetudine far svolgere entro il recinto
dell'altare, già definito “orchestra”, le prime pubbliche e gratuite rappresentazioni sceniche.
Quanto alla forma del teatro greco, è abbastanza plausibile l’ipotesi di un’influenza almeno parziale di
quella dei teatri di corte minoici, tradizionalmente quadrangolari: i primi arcaici teatri della reggia di
Phaistos e Knossos, infatti, come quelli dell'Ellade anteriori al V sec. a.C., avevano l’orchestra in forma
quadrata e la cavea grosso modo trapezoidale (teatro di Leneo ad Atene del 450 a.C.).
Un primo tentativo di teatro a forma semicircolare si attuò durante il periodo di Gerone I e Dionisio III a
Siracusa (per esempio il teatro costruito nel 470 a.C. da Damacopo detto Myrilla), mentre solo con il IV
sec. a.C. si ebbero delle cavee interamente in pietra, come quelle di Epidauro (370-360 a.C.) e di
Megalopoli (360-330 a.C.).
Nei primi tempi, la rappresentazione scenica si svolgeva sul medesimo piano dell'orchestra2, attorno
all'altare (thymele)3 e a stretto contatto con l'azione del coro, davanti ad un semplice fondale mobile (skenè)
di tela, posto dietro l'orchestra, dalla parte opposta all' “auditorium” (o “cavea”)4.
1
Per quanto concerne il teatro minoico o cretese, si veda anche al cap. “Non solo classico” del presente lavoro, al par.
2.
2
Chiamata così dal verbo όρχέομαι (= danzo), poteva presentarsi in forma trapezoidale, semicircolare o circolare del
diametro di ca. m. 20; era situata di solito in una zona piana, affiancata a un pendio, delimitata all'intorno da un
canale ricoperto di lastre, ampio poco meno di m. 1, detto “euripo”, che convogliava le acque defluenti dalla collina.
3
Posto al centro, di forma circolare e con la statua di Dioniso, serviva sia per offerte sia come punto di riferimento per
i movimenti del coro.
4
Il pendio, con i sedili sistemati a gradinata, costituiva la cavea, costruita nel sec. IV al posto dei sedili di legno,
generalmente a semicerchio abbondante intorno all'orchestra; era divisa in tredici cunei da dodici scalette verticali,
mentre i “corridoi" separavano orizzontalmente i settori secondo il prestigio di chi l’occupava. I primitivi sedili in
legno furono successivamente sostituiti con sessantasette seggi in pietra od in marmo pentelico, con schienali e
braccioli di varia forma e dignità per i personaggi più autorevoli (quello centrale era assegnato al sacerdote di
Dioniso).
A questa primitiva scena di tela se ne sostituì presto una stabile, costituita da un elemento rettangolare
ligneo, che aveva la duplice funzione di fondale e, nella sua parte retrostante, di magazzino per gli attori.
La scena rappresentava ordinariamente la facciata di un palazzo, con tre porte, e sosteneva le antenne per
la manovra degli scenari dipinti. Questi, man mano che non servivano più erano calati in apposita fossa,
che correva lungo tutto il fronte della scena. Come nel teatro di Dioniso ad Atene, dinanzi alla scena era
pure una vasta pedana di legno un poco sopraelevata rispetto al piano dell'orchestra e notevolmente
profonda, il cosiddetto “logeion”, da cui recitavano gli attori, servendosene come cassa armonica.
All'orchestra e alla scena si accedeva attraverso due ingressi laterali (parodoi)5, ricavati nello spazio
intercorrente fra la cavea e l'orchestra: sotto il piano dell'orchestra erano praticate gallerie, accessibili
dalla fossa scenica e in comunicazione con l'altare, ergentesi al centro e con gli angoli dell'orchestra
muniti di uscite (kàthodoi), donde apparivano le ombre dei morti evocati dal sottoterra (dette perciò anche
“klimakes karonoi”)6. Infine sul tetto dell'edificio scenico, accessibile dall'interno, era ricavata una
piattaforma destinata alle epifanie delle divinità (theologeion), che di lassù prendevano parte diretta alle
5
L'accesso al teatro avveniva o dall’alto (come spesso oggi) o attraverso le parodoi, spesso lievemente inclinate,
arricchite da statue e dediche votive, utili agli attori e agli spettatori, chiuse da porte solo in età più tarda. Da quella
di destra, per convenzione, entravano i personaggi provenienti dalla città, dall’altra di sinistra quelli che giungevano
dalla campagna.
6 E’ il caso della apparizione del re Dario nei “Persiani” di Eschilo (vv. 739-842).
vicende degli uomini. Gli ambienti raffigurati nella scena erano dipinti 7 e manovrati in modo che
all'occorrenza, spiccati dai sostegni e lasciati cadere nella fossa, provocassero il cambiamento della scena:
dovendosi procedere a più di un mutamento, si montavano sulle antenne, prima della rappresentazione,
le scene occorrenti, in modo che prima fosse quella di immediato impiego e ultima, o più interna, quella
riservata all'ultima scena8. Essendo, inoltre, il teatro greco privo di qualsiasi riparo, cioè aperto da
“fondali” o da “cieli” nel senso moderno della parola, divenivano elementi scenografici
il reale
paesaggio circostante, cielo compreso. Il succedersi di luci e colori, il gioco alterno delle nuvole e sole, il
levarsi del vento, i rumori dall'esterno accentuavano, difatti, la naturalità dell'evento scenico,
definendone al contempo la sua irripetibile singolarità. Non c’era dunque bisogno di grandi sforzi
immaginativi per ottenere un’ illusione scenica completa, che non fosse compromessa al più che dalla
stessa struttura teatrale.
Nella cavea, o “auditorium”, la gradinata (koilon) era divisa solitamente in tre distinti e separati ordini di
posti mediante settori circolari (kerkides) riservati, a partire da quello più prossimo all'orchestra, ai
7
8
La tradizione attribuisce al pittore Agatarco l'ufficio di scenografo ai tempi di Eschilo e di Sofocle .
La scena, tangente all'orchestra, era originariamente una costruzione improvvisata con tendaggi e pali, ma in età classica
assunse una linea architettonica stabile come sfondo all'azione, alla quale spesso si adeguava; si ebbero infatti riproduzioni
della facciata di un palazzo reale o di un tempio, rocce, grandi sepolcri e altari; talvolta su tavole dipinte issate lungo le
antenne, quando servivano, altrimenti calate dentro la fossa scenica per mezzo di corde) o prismi girevoli erano raffigurati
paesaggi di città o di campagna; pedane, gru, fosse e rotaie di scorrimento venivano impiegate per gli artifici scenici
necessari. Due strutture laterali, dette “parasceni”, finivano con maggior compiutezza l'edificio di fondo, in cui si aprivano
le porte, tre normalmente, a indicare vicine o lontane provenienze. Dietro erano i luoghi riservati agli attori, ai costumi e agli
attrezzi. Non raro, tuttavia, l’espediente di narrare la scena, per bocca di un messo, anziché rappresentarla, laddove la
scenografia sarebbe risultata complessa e il numero di attori eccessivo (ad es., scene di guerra nei “Persiani” di Eschilo).
magistrati e ai sacerdoti, ai militari ed al popolo. Queste gradinate poi erano intervallate da una rete di
scale radiali e di corridoi orizzontali anulari (diazomata), che assolvevano il compito di coordinare i vari
percorsi della cavea per un continuo disimpegno dei singoli settori.
Il pubblico era ammesso dietro pagamento di un modico biglietto (due oboli), il cui costo per i cittadini
poveri era sostenuto dallo stato. Tale provvedimento, in realtà, non era tanto espressione di una prassi
demagogica dello stato democratico ma nasceva piuttosto dal ruolo e dalla considerazione del teatro
classico ateniese come pubblica occasione di formazione, cui ogni cittadino aveva l’obbligo e il diritto di
partecipare.
Durante l'età ellenistica, si mise mano alla costruzione di numerosi teatri nuovi e alla trasformazione di
molti preesistenti9. Siffatte trasformazioni, in genere graduali, riguardarono l'orchestra, la cavea e,
specialmente, l’edificio della scena, in conseguenza di fattori quali l’esaurirsi della tragedia, l'affermarsi
della Commedia Nuova, la diminuita importanza, nella finzione scenica, delle parti affidate al coro.
L’ orchestra, pertanto, va perdendo sempre più della sua importanza a favore dell'edificio della scena,
dove gli attori, su un apposito palco (logeion), svolgono la loro azione. Gli attori tragici ( a differenza di
quelli della commedia che agivano in prossimità degli spettatori) recitavano su una pedana profonda
anche tre metri, sostenuta da colonne o murature, ornate di statue, semicolonne e grandi vasi di bronzo
per diffondere e potenziare il suono.
Quanto alla evoluzione della scena, dapprima si introduce un proskenion10 mobile di legno in teatri di
vecchio tipo, quindi (dal 250 a.C.), in teatri di nuova costruzione, il proscenio in legno è stabile e con un
basso colonnato, fino a passare dal 200 a.C a un vero e proprio proscenio in muratura. In certi casi, però,
per esigenze del terreno, si manterrà l'uso della scena mobile di legno, i cui elementi, dopo le
rappresentazioni, si conserveranno in apposite skenothekai .
Una volta trasferito sul logeion lo spazio della recitazione, l'edificio della scena acquista la funzione di
sfondo della finzione scenica con la erezione di un secondo piano (episkenion), dapprima ligneo e poi in
muratura.
I tipi principali di scena che meritano qui di essere ricordati sono: il tipo cosiddetto “a paraskenia”, o
“occidentale”, in cui si conservano i corpi laterali aggettanti dell'edificio della scena del teatro più antico,
fra i quali è inserito il logeion; il tipo “a rampe”, o “continentale”, con il logeion accessibile dall'orchestra
per mezzo di due rampe inclinate, collocate alle estremità, lungo la linea dell'edificio della scena
(Epidauro); il tipo “orientale” con scena a parete diritta, proscenio senza chiusure laterali, esteso talvolta
sui lati o tutt'intorno all'edificio della scena; il tipo con proscenio con vero e proprio colonnato
dell'avanzato ellenismo. L’edificio scenico, ormai a più piani, poteva infine svilupparsi in un portico
9
Fra i principali di nuova costruzione, quello di Delfi; fra i più importanti di quelli rimaneggiati, i teatri di Atene ed
Epidauro.
10
Il proscenio si presentava come una fronte rettilinea di pilastri, colonne o semicolonne appoggiate a pilastri (per lo
più di ordine dorico). Riservati alcuni degli intercolumni (uno o tre) come vani di comunicazione fra l'orchestra e
l'edificio della scena, gli altri potevano essere riempiti con pannelli di legno dipinti ( pinakes). La fronte
dell'episcenio presentava un numero variabile di grandi aperture, da tre a cinque, e sette chiuse spesso da scenari
dipinti mobili (thyromata).
monumentale ed ospitare, tra nicchie ed esedre, dei veri e propri giardini11. Gli esemplari più antichi
sono identificabili nelle strutture di Eleusi e di Torico, databili al VII sec. a.C., mentre si può assumere
come forma compiuta e paradigmatica dell'evoluzione architettonica per l'età classica il teatro di Dioniso
Eleutherios in Atene, alle pendici meridionali dell’acropoli entro il thèmenos del dio.
(tratto da Wikipedia, alla voce “Teatro greco”)
_________________________________________________________________
Nel mondo latino
I Romani cominciarono a costruire edifici teatrali in muratura soltanto dopo il 30 a.C. Nel periodo
precedente i luoghi degli eventi teatrali erano costruzioni di legno provvisorie spesso erette all'interno
del circo o di fronte ai templi di Apollo e della “Magna Mater”.
Vitruvio testimonia come all'inizio le scenografie del teatro romano non fossero molto elaborate, e che gli
attori, proprio come nell'antica Grecia, affidassero alla loro arte il compito dell'evocazione dei luoghi e
delle circostanze12. In seguito, negli anfiteatri, si cominciarono a costruire vere e proprie macchine
teatrali, adibite agli effetti speciali.
11
Così, ad es., nel teatro romano di Sabratha e forse in quello di Leptis Magna.
12
Cfr, Vitr., De Architectura, V, 6 e VII, 6 ss.
Il teatro romano di Mérida, costruito tra il 16 e il 15 a.C. grazie agli auspici del console Marco Vipsanio Agrippa
I Romani cominciarono a costruire edifici teatrali in muratura soltanto dopo il 30 a.C. Nel periodo
precedente i luoghi degli eventi teatrali erano costruzioni di legno provvisorie spesso erette all'interno
del circo o di fronte ai templi di Apollo e della “Magna Mater”. Vitruvio testimonia come all'inizio le
scenografie del teatro romano non fossero molto elaborate, e che gli attori, proprio come nell'antica
Grecia, affidassero alla loro arte il compito dell'evocazione dei luoghi e delle circostanze13. In seguito,
negli anfiteatri, si cominciarono a costruire vere e proprie macchine teatrali, adibite agli effetti speciali.
Elementi scenografici sempre presenti erano:
il proscenium, la porzione di palcoscenico in legno più vicina al pubblico, raffigurante in genere
un via o una piazza, corrispondente all'attuale proscenio.
la scenae frons, un fondale dipinto.
i periaktoi, di derivazione greca, prismi triangolari rotabili con i lati dipinti con una scena tragica
su un lato, comica su un altro e satiresca sul terzo.
l'auleum, un telo simile al nostro attuale sipario (sconosciuto ai greci) che permetteva veloci cambi
di scena o veniva calato alla fine dello spettacolo. In alcuni teatri, invece di cadere dall'alto,
veniva sollevato.
La cavea fronteggiava il palcoscenico (pulpitum), che per la prima volta assumeva una profondità cospicua,
rendendo possibile l'utilizzo di un sipario, con suggestivi effetti prospettici, e una netta separazione
dalla platea. Il teatro romano dell'età imperiale, invece, era costruito in piano e non su un declivio
naturale come quello greco, con una forma chiusa, che rendeva possibile la copertura con un velarium.
Oggetti collocati sulla scena fungevano a volte da marcatori temporali, come accadeva anche nel teatro greco: una
lucerna indicava, ad esempio, la notte.
13
Si andava così delineando, con queste nuove tipologie, la struttura universalmente adottata dell’ edificio
teatrale moderno.
Eredità classiche
La diffusione del teatro classico, già assicurata, a partire dal II sec. a. C., dai cosiddetti “artisti itineranti di
Dioniso”, si estese ben presto dall’ambiente latino a tutta l’area del Mediterraneo, grazie anche agli stretti
rapporti che ebbe Roma con città greche della Sicilia e dell’Italia meridionale14.
Eretta come la “nuova Roma”, Costantinopoli non poteva naturalmente sottrarsi a tale influsso, parallelo
a sua volta, almeno nelle prime fasi, a quello del teatro etrusco. Costantinopoli possedeva, difatti, diversi
teatri, costruiti secondo i modelli ellenistici e greco-romani, così come altri centri dell’Impero bizantino
ugualmente importanti, almeno fino al 1453, sotto il profilo sociale e culturale. Commedie di Menandro,
ad esempio, venivano rappresentate ad Antiochia ancora nel V secolo d. C., accanto ad attività teatrali
che abbracciavano i generi più vari, dal pantomimo, ai mimi, dalle tragedie alle commedie, danze e
rappresentazioni di ogni tipo15. Ancora, a Costantinopoli era stato costruito un teatro simile al Circo
Massimo di Roma, il cosiddetto “Ippodromo”, dove venivano effettuate, tra fazioni di tifosi e alla
presenza di un pubblico tra i 40.000 e 80.000 spettatori, corse di carri e lotte di prigionieri o gladiatori.
14
A dimostrazione di tali rapporti, la visita a Roma nel 237 a. C. “ ad ludos spectandos” del tiranno di Siracusa Ierone
II. Ancora, nel 413, i prigionieri ateniesi in Sicilia furono lasciati liberi in seguito a un’apprezzata declamazione di
versi euripidei. Lo stesso Dionigi di Siracusa componeva tragedie, mentre, qualche secolo più tardi, Alessandro
Magno e i suoi successori curarono a Delfi, in occasione dei Giochi Pitici, agoni che prevedevano la rappresentazione
di tragedie e commedie. E’ inoltre presumibile che lo stesso Alessandro abbia fatto costruire teatri alla maniera
ellenica nelle “colonie” di Arachosia e Battriana, per quanto non si siano rinvenute testimonianze concrete, a
eccezione dei resti di un teatro ad Ai Khanum.
15
Analogamente in Armenia, conquistata nel IV secolo da Alessandro Magno e, successivamente, legata al Regno di
Seleuco. Tra i re successivi, Tigrane II (95-54 a.C.), in particolare, insieme alla moglie Cleopatra, figlia di Mitridate,
dimostrò una forte sensibilità alla cultura greca, fondando teatri e favorendo l’allestimento di tragedie greche.
Con il Concilio di Costantinopoli del 692 e la conseguente messa al bando degli spettacoli teatrali, fatta
eccezione per cerimonie religiose, il teatro di tipo classico decadde irreversibilmente, lasciando il posto,
accanto a rozzi drammi popolari spesso improvvisati, al teatro d'ombre di matrice turco-orientale16.
Teatro romano ad Aspendos, in Turchia
Teatro romano a Leptis Magna, in Libia
Maschere elleniche a Myra, in Turchia
16L’origine
del “teatro delle ombre”, nonostante la fortuna del genere in ambiente medio-orientale, è legata a una
leggenda cinese riguardante un imperatore della dinastia Han. Disperato per la prematura scomparsa della sua
concubina prediletta, venne soccorso da un monaco taoista, che gli promise di riportare in vita la giovane. Fece
muovere l’immaginaria fanciulla dietro una tenda illuminata da una candela, mentre l’imperatore si rallegrava di
poter rivedere almeno l’ombra dell’amata.
Nel citato volume del “Natyasastra” sono descritte le tre forme di sale utilizzate per le rappresentazioni
teatrali: quadrata, rettangolare, triangolare. Ognuna delle tre tipologie si differenziava, a sua volta, in
base a tre misure: grande, media, piccola.
La platea era divisa da quattro colonne principali di diverso colore: bianco, rosso, giallo, e azzurro, che
simboleggiavano i quattro punti cardinali e rappresentavano, al contempo, le quattro caste della società
indiana: i bramini, i guerrieri, gli artigiani e i servi.
Nell’Impero del Sol Levante
Cina
All’insegna di una essenziale stilizzazione, tale da porre in risalto l’interpretazione dell’attore, la scena
teatrale cinese si componeva di un semplice palco sopraelevato rispetto alla platea, aperto su tre lati e
privo di sipario. Un grande tendone sul fondo, come accadeva col prisma del teatro greco, si prestava a
diverse interpretazioni e, a destra e a sinistra, similmente alle parodoi, si aprivano due porte con tende:
una serviva per l’entrata e l’altra per l’uscita degli attori.
Sempre sul fondo, al centro o a lato, sedevano i suonatori, non più di cinque o sei, in un posto che veniva
detto “dei nove dragoni” (jiulongbi).
Un tavolo e due sedie, ricoperti da un drappo rosso di seta, rappresentavano in toto l’intera scenografia,
eppure bastavano a creare lo sfondo dei numerosi drammi esistenti. Tutto dipendeva dal contesto o dall’
uso che ne facevano gli attori. Ad esempio, due sedie avvicinate significavano un letto, una sedia singola
simboleggiava una montagna da scalare.
Non si rinunciava inoltre alle più comuni simbologie: una bandiera con dipinta la ruota di un carro
significava salire e andare in carrozza o su un carro; se invece l’immagine era di un pesce, voleva dire
andare per mare; un frustino appoggiato spiegava, infine, che il cavaliere, sceso a terra, legava a un
albero il cavallo.
Le rappresentazioni avevano inizio a partire da mezzogiorno e si dividevano in tre turni: “il turno
iniziale”, “il turno di mezzo” e, infine, “il grande turno” che si concludeva all’inizio della serata e nel
quale si esibivano gli attori più importanti.
Quanto alle sedi delle rappresentazioni, un ruolo di primo piano era tenuto dalle case da tè, ciascuna
delle quali all’interno aveva un suo palco per gli spettacoli, per i quali non si pagava il biglietto ma la
consumazione.
Altre rappresentazioni, non intese ad ampio raggio come eventi sociali, avvenivano invece nei ristoranti,
nelle sedi delle associazioni commerciali, presso le gilde regionali, nelle famiglie importanti, in occasione
di matrimoni, funerali, festività particolari o rituali.
Alle innovazioni del repertorio e degli aspetti artistici si accompagnarono mutamenti nella sfera
organizzativo-amministrativa, con notevoli differenze tra nord e sud.
Dalla conduzione di tipo familiare si cercò di passare a una fase organizzativa più avanzata, che
comprendeva il proprietario e il responsabile del teatro per la parte economica, un responsabile del
retroscena addetto all’organizzazione coadiuvato da un assistente civile e un altro esperto in arti marziali,
un responsabile del palcoscenico che seguiva lo svolgimento dello spettacolo, un responsabile per i
costumi e gli accessori, un responsabile per le prenotazioni, e così via.
Si creò in tal modo una vasta rete che comprendeva anche dei controllori che, non solo seguivano ogni
momento della vita dell’attore, la morale, l’adempimento delle cerimonie in favore degli dei del teatro,
ma vagliavano i testi e le rappresentazioni affinché non superassero certi limiti (licenziosità, erotismo).
Fu proprio in questo periodo che venne istituita la prima legislazione teatrale che stabiliva i diritti e i
doveri degli attori, che comunque rimanevano all’ultimo gradino della scala sociale, una
regolamentazione che controllava e censurava anche la loro condotta sia sessuale che ideologica.
Va comunque precisato che le forme dei teatri variavano da provincia a provincia per via del clima e
dell'ambiente. A sud, ad esempio, proliferavano i teatri sull'acqua, itineranti su barche o costruiti su
palafitte e facilmente trasportabili. Se ne offre, nelle immagini sottostanti, una plausibile ricostruzione:
Giappone
A prescindere dalle prime forme teatrali, ovvero il “kagura”, il “gigaku” e il “bugaku”, concepite come
occasioni cultuali comunitarie con processioni e danze mascherate, il teatro No17 , sviluppatosi insieme
17
Affermatosi a partire dal 1300, il teatro “No” fu concepito originariamente come forma d’arte e di intrattenimento
dalla casta samuraica (il termine significa difatti “abilità”), per poi assestarsi in forme definite (oltre che in testi
col “kyogen” dal più complesso “sarugaku”, non si avvaleva di edifici chiusi né di rudimentali strutture
mobili. Le rappresentazioni coreutiche e canore si alternavano con i dialoghi del Kyogen in spazi aperti,
nonché in prossimità di corsi d’acqua, come attestano tuttora il pino che fa da sfondo e i pilastri per
l’orientamento dell’attore. E’ intorno al pino18, difatti, elemento sacrale in quanto simbolo del “ma”, che
si concentrano gli scarni elementi scenografici, ridotti spesso a uno scheletro di una barca o di una
carrozza, ad evocare l’oggetto insieme a gesti e lenti movimenti. Frequente, se non fissa, la presenza del
ventaglio, nelle mani degli attori, metafora di oggetti o di astratte situazioni. Una graduale e secolare
evoluzione avrebbe fissato uno schema architettonico più organico ed articolato, dove non mancano,
come si vedrà, affinità con il teatro cinese e con strutture classiche occidentali.
Palco di un teatro Nō
1: Kagami-no-ma (Stanza degli specchi)
2: Hashigakari (Ponte)
3: Palcoscenico
4-7: Quattro colonne chiamate rispettivamente Metsuke-Bashira, Shite-Bashira, Fue-Bashira e WakiBashira.
8: Jiutai-za, dove siedono i Jiutai , ovvero i componenti del coro
9: Spazio per l’orchestra. Dalla sinistra verso destra: Kue-za (suonatore di flauto traverso chiamato Nokan), Kotsuzumi-za (un piccolo tamburo), Ohtsuzumi-za (un tamburo di medie dimensioni) e
occasionalmente Taiko-za (un largo tamburo).
10: kohken-za (suggeritore)
11: Kyogen-za (Kyogen-shi, un attore comico, appare in alcune opere)
12 : Kizahashi (scalini)
scritti), immutate nel corso dei secoli, con uguale livello di ricettività. A distinguerlo dal più leggero e talora
parodistico “Kyogen”, la presenza di attori professionisti nelle vesti di dei o imperatori, con ruoli subalterni per
personaggi di rango inferiore. Per ulteriori approfondimenti, si legga il saggio on line “ L’anima del teatro No“ di
Angela Picciafuochi.
18 Ci sono molte spiegazioni possibili per la scelta di questo albero, ma una tra le più comuni è che simboleggia il
mezzo con cui le divinità scendevano sulla terra, secondo il rituale shintoista. Si noti come il pino compaia in origine
anche nelle cerimonie dedicate a Dioniso come simbolo di una natura sempre rinascente. Una pigna, peraltro,
incoronava il suo tirso.
13: Shirazu (sabbia bianca)
14-16: Pini
17: Gakuya (Backstage)
18: Makuguchi, entrata principale al palcoscenico.
19: Kirido-guchi, entrata per le cantanti del coro (Jiutai) e gli assistenti di scena (Kohken).
20: Kagami-ita, disegno di un rigoglioso pino verde, nello stile della scuola Kano
Kagamino-ma e Hashigakari sono circondate da una tenda chiamata Agemaku, dipinta con tre o cinque
colori.
La scena, come accennato, è ridotta all’essenziale. La rappresentazione ha luogo su un palco fatto di
Hinoki
(cipresso giapponese). Il palcoscenico è completamente vuoto, a parte il citato “kagami-ita”,
realizzato su un pannello di legno, posto sul fondo del palco.
In contrasto con il palco completamente disadorno, i costumi sono estremamente ricchi: molti attori, in
particolari quelli Shite, sono vestiti con abiti di broccato di seta. Sorprendenti, ancor più che nell’opera
cinese, le affinità sia pure casuali con il teatro greco e occidentale: gli attori, per salire alla ribalta,
percorrono una passerella posta a sinistra del palcoscenico19 (detta Hashigakari o anche, nel Kabuki,
Hanamichi, cioè “ponte dei fiori”;
lo stesso butai, cioè lo spazio scenico, era inteso e costruito come un
mondo di intersezione tra l’umano e il divino: il tetto che lo ricopre lo definisce spazio sacro, i pilastri
che lo sostengono sono i tramiti tra le due dimensioni; l’honbutai, la parte centrale dello spazio scenico, è
collegato alla “camera dello specchio” da un corridoio, oltre il quale, nell'immaginario comune, si trova il
paradiso della Terra Pura buddista; infine, il ponte sul palcoscenico delinea il passaggio possibile tra il
nostro mondo, rappresentato dal palco, e l'altro mondo, riflesso nella “camera dello specchio”.
TIBET
Come accadeva nel teatro greco, la rappresentazione di un lhamo o “ache lhamo”20, nella cultura tibetana, è
un evento che coinvolge, per più giorni, l’intera comunità, allo scopo, in primo luogo, di “consacrare lo
spazio”, ovvero trasformare un insignificante cortile o una radura nel luogo, sia pure provvisorio, in cui
riconoscersi, unirsi e ancora ricongiungersi benevolmente alle forze che regnano nelle diverse regioni del
19
Inevitabile il confronto con le parodoi, per cui si veda anche al precedente paragrafo riguardante il teatro greco.
Le radici del genere, in cui la recitazione si combina con la musica, la danza ed altre forme di intrattenimento, si
rintracciano nel periodo delle dinastie reali del Tibet (VI – IX secolo d.C.), ma il processo che portò alla definizione
della forma attuale è attribuito a Thangtong Gyalpo, maestro illuminato del XIV secolo, per cui si veda alla nota
successiva.
20
cosmo. Semicoperta e ridotta all’essenziale, l’intera struttura, come il teatro greco, si divide in spazio
scenico e area orchestrale. Attorno ad una “orchestra” semicircolare, sotto una grande tenda a volta,
possono prendere posto circa duemila persone: su alcune panche siedono, come previsto in norme anche
altrove i vigore- autorità e figure di rilievo; il resto del pubblico si sistema su tappeti portati di solito da
casa. Dipinti e accentuati movimenti di danza valgono a suggerire situazioni, sopperendo così alle scarne
scenografie: stoffe dipinte con i pesci e le onde indicano, ad esempio, barche in movimento, Al centro,
addossato a un palo ornato che simboleggia l’axis mundi, un altare che, nella convenzione scenica, può
diventare anche un trono. Ivi, nella seconda parte della rappresentazione, prima che si dia il via alla
recitazione della storia e al suo commento musicale, attori, capeggiati da un maestro spirituale, pongono
una piccola statua di Thangtong Gyalpo21, il leggendario fondatore del teatro tibetano.
21
Maestro spirituale e convinto divulgatore del messaggio buddhista, Gyalpo promosse, peraltro, la costruzione di
ponti che collegassero villaggi remoti. Si racconta che, avendo bisogno di fondi per costruire il ponte sul fiume
Kyichu, insegnò a sette sorelle che vi stavano lavorando a cantare e a danzare, mentre lui suonava tamburo e cimbali.
Gli spettatori, colpiti dalla bellezza delle ragazze, esclamarono: <<Le danzatrici sono proprio delle Lhamo (ovvero
delle dee)>>. Da qui il nome “Ache lhamo”, che significa letteralmente “dea sorella” o “sorella celestiale”, o
semplicemente “Lhamo”, con il quale è conosciuta questa peculiare forma teatrale.
Non solo
classici
Scene e scenari di diverse civiltà
1. Da iscrizioni risalenti al 2600 a.C. circa è documentata l'esistenza in Egitto di cerimonie pubbliche in
cui erano previste rappresentazioni sotto forma di processioni e feste, nelle quali venivano utilizzate
varie arti performative, come la danza, la musica, unitamente alla narrazione di racconti mitologici.
Diversi documenti testimoniano il carattere teatrale delle feste egizie. Sui papiri rinvenuti nel
“Ramesseo” di Luxor sono descritti i preparativi per la festa per il trentesimo anno di regno del faraone
Sesostris, e vengono precisati i dialoghi, le azioni, le posizioni degli attori in scena, oltre a dettagli
riguardo alle scenografie, alla musica e alla presenza di danzatori e comparse. Nelle iscrizioni
autobiografiche sulla stele di Ikhernofret (1820 a.C. circa), il tesoriere e organizzatore di feste del faraone
Sesostris III racconta di aver lui stesso impersonato «l'amato figlio di Osiride» in una scena di
combattimento tra divinità. Rientrano, infine, tra le rappresentazioni teatrali o ad esse affini la solenne
processione in onore di Iside, celebrata una volta all’anno sul fiume Nilo (dalle lacrime divine, si diceva,
si alimentava l’ “acqua della vita”). La dea appariva in una barca, travestita da orsa, richiamo all’omonima
costellazione. A seguire un corteo di sacerdoti, anch’essi mascherati, a simboleggiare le quattro stagioni
(precisamente, lo sparviero indicava l’inverno, il leone l’estate, il lupo l’autunno e il toro la primavera).
Chiudevano la sacra teoria popolani variamente mascherati, accompagnando con canti e danze il
suggestivo corteo22.
2. Nell’isola che fu sede della civiltà minoica i sacri recinti, ove sembra si svolgessero cerimonie religiose
con danze e cori, possono essere riconosciuti tra i luoghi che in età più remota furono adibiti a
rappresentazioni teatrali. Omero23, infatti, riferendosi a Dedalo, parla di un <<coro (inteso qui come
spiazzo) costruito per Arianna dalla bella chioma…dove adolescenti e vaghe vergini danzavano, tenendosi per
mano…Numerosa folla le circondava, prendendone diletto e un aedo divino segnava il ritmo al suono della lira>>.
22
Si legga, al riguardo, la descrizione che ci dà Apuleio in Met,. XI, 3 ss., quando la dea Iside, prima in sogno e
poi nella realtà, si presenta al protagonista mutato, suo malgrado, in asino.
23
Cfr. Hom., Il. XVII. K. Kerenyi, nel suo saggio “Labyrinth-Studien” (1950) (ed. it. Nel labirinto, a cura di Corrado
Bologna, Boringhieri, Torino 1983), riscontrava un’analogia con la danza “Maro”, in Polinesia, ballata da nove
uomini in spirali intrecciate a nove volute per nove giorni e nove notti; secondo la leggenda (la storia della fanciulla
Hainuwele), al centro delle danze sta “Mulua Satene” (una “Kore”) che simboleggia una porta d’accesso; gli uomini
che non riescono a varcare la porta vengono trasformati in animali, coloro che la superano affronteranno un faticoso
viaggio iniziatici. Per approfondimenti, si legga il saggio on line “Labirinto”, al sito www.mariateresalupo.it.
Si era dunque agli albori di una più composita tradizione che avrebbe man mano raggiunto, dopo
Micene, il cuore della Grecia.
3. A prescindere da forme teatrali, di indubbia influenza nella genesi del teatro latino, le origini di
quest’ultimo, secondo Ovidio24, si ricollegherebbero al noto episodio del ratto delle Sabine, avvenuto per
l’appunto in un teatro nel corso di una rappresentazione. Si trattava, in realtà, di un edificio rudimentale,
senza marmi né tende, comprendente solo un palco e gradini ricoperti di erba e terra. Eppure non
mancavano autori ed attori improvvisati che offrivano a un pubblico senza troppe pretese spettacoli
estemporanei di musiche, danze e performances varie. Col rafforzarsi del dominio romano, si istituì un
legame più stretto con credenze religiose ed occasioni cultuali. Già dall'epoca di Romolo erano infatti
invalsi giochi pubblici in onore del dio Conso (“Consualia”) e corse di cavalli (“Equirria”), celebrati due
volte all'anno nel Campo Marzio. Fu il re Tarquinio Prisco, probabilmente, a promuoverne una
evoluzione, riorganizzandoli in quelli che sarebbero stati i “ludi romani” o “magni”25, celebrati attorno
alla metà di settembre. Nell’edizione del 364 a.C., fu introdotta per la prima volta nel programma della
festa una forma di teatro originale, costituita da una successione di scenette farsesche, contrasti, parodie,
canti e danze buffonesche. Tratto comune, una maliziosa e spensierata licentia, quella che avrebbe
caratterizzato, nei secoli a venire, il teatro romano e, in particolare, la “vis comica” plautina. Occorrerà
invece attendere, il 240 a. C., perché si porti sulla scena, con Livio Andronico, un dramma greco tradotto
in latino. In quell’ anno, difatti, non riuscendo i romani a debellare una pestilenza, decisero di inserire,
3. Cfr. Ov, Ars
am., I, 101-112.
Accanto a quelli “romani”, vanno ricordati i “ Ludi Plebeii”, consacrati ancora a Giove e celebrati in novembre, a
ricordo della riconciliazione tra patrizi e plebei; i “ Ludi Apollinares”, celebrati a luglio in onore di Apollo, e infine i
“Ludi Megalenses”, dedicati in aprile alla dea Cibele, il cui culto fu introdotto a Roma nel 204 a.C..
25
per placare l'ira divina, anche ludi scenici, per i quali fecero venire dall' Etruria artisti e danzatori. Era il
preludio di una produzione in buona parte perduta, affidata alla recitazione e , più tardi, alla lettura.
4. Poco mancava ai libri di Giobbe, di Ruth, di Esther o al Cantico dei Cantici per diventare, grazie a
strutture dialogiche e a un incalzante ritmo narrativo, dei veri e propri drammi rappresentabili. Eppure il
teatro non incontrò all’origine il favore degli Ebrei, scettici di fronte ad una attività che non sembrava
conciliarsi con i rigidi precetti religiosi né tanto meno con l’ antico genio semitico. In realtà, non
mancavano, a Gerusalemme come in Cesarea, sotto gli Erodi, teatri di stile greco e romano, ma la legge
talmudica ne vietava o sconsigliava la frequenza, impedendone altresì la costruzione. Si temeva, infatti,
che il popolo si distraesse con spettacoli giudicati immorali o che venisse a contatto dei Gentili, peccatori
e “impuri”. A Roma, d’altronde, come a Gerusalemme e ad Alessandria, l’Ebreo era frequente zimbello
dei mimi, bersaglio, da parte anche di storici, di critiche e caricature26. Ciononostante, alcuni Ebrei
Alessandrini s’accostarono, nei primi secoli del Cristianesimo, al teatro o per lo meno alla composizione
drammatica, come si rileva dalla “Preparazione evangelica” di Eusebio, da Eustazio, da Epifanio e da
Clemente Alessandrino. I tre frammenti a noi pervenuti appartenevano a tre sacre rappresentazioni
giudaiche in greco. La prima, del Giudeo Ezechiele, riguardante il passaggio degli Ebrei dall'Egitto in
Palestina, annovera tra i vari personaggi Mosè, Sefora, Dio e l'Angelo; la seconda verte, invece, sull' unità
e immaterialità di Dio, mentre la terza, ispirata al Libro della Genesi ha come tema nonché protagonista il
Serpente del Paradiso.
Nel trattato “Sulle virtù di Caligola e sull’ambasceria ” Filone ebreo ci fa intendere come fossero trattati gli Ebrei
nei teatri.
26
Nei secoli seguenti la tradizione drammatica non venne meno, influenzando peraltro- al di là dei diversi
contesti e credenze- anche i misteri persiani. Bisognerà però attendere almeno il diciassettesimo secolo
per trovare delle opere letterarie, destinate alla scena o alla semplice lettura, a prescindere dai drammi di
israeliti in lingua spagnola o rivolti a un pubblico tedesco27. In questi ultimi, come anche in altri apparsi
in Russia, la ripresa drammatizzata di episodi biblici, come l’esodo di Abramo, fungeva da modello e
motivo di speranza per i tanti ebrei profughi dispersi in Europa ma che ancora conservavano vivo il
legame con la Palestina. Sulla stessa linea il dramma neo-ebraico dal titolo “I prigionieri della speranza”,
composto in Amsterdam nell'anno 1667. Suddiviso in tre atti, si impernia sulle vicende di un Re, di un
Angelo, di Satana, di una Donna e di figurazioni allegoriche quali il Discernimento, la Previdenza, l’'
Istinto, il Piacere e la Verità. Il dramma, contrassegnato da un convinto sostrato morale, è preceduto da
varie poesie, con le quali ben 21 poeti, in versi ebraici, spagnoli e latini, mostrano la loro ammirazione e
riconoscenza per il lavoro e festeggiano il primo poeta drammatico neo-ebraico ; spicca, tra le lodi, il
seguente distico: <<Tandem hebraea gravi procedit musa coturno, prima quae feliciter pede pandit iter>>.
PERSIA
5. Allo studioso Chodzko si deve una descrizione particolareggiata del teatro persiano, comprensivo di
generi diversi, dove il pathos intenso e spesso esasperato si esprime in forme ben lontane da un classico
equilibrio “catartico”, con effetti incisivi e accattivanti per un pubblico fanatico e fin troppo entusiasta.
Ecco, ad esempio, quasi osservata dall’alto del palco, la rappresentazione di un faziè28, dopo una breve
Tali sarebbero “L’Anello di Salomone” del Blischenthal; il “Tito. La distruzione di Gerusalemme” di Giulio
Kossarski; “Il Cantico dei Cantici” del Mandelstamm che scrisse pure in russo “La Famiglia Ebrea ”.
28
Il termine sta a indicare un dramma di soggetto sacro o storico alquanto idealizzato. Tra i protagonisti compaiono
infatti Maometto o anche profeti o “imam” di pari carisma, venerati soprattutto da sciiti come vere divinità. Si noti, al
riguardo, il mancato sviluppo del teatro arabo anche in relazione a tematiche di facile presa tra i fedeli islamici. Solo
a partire dalla metà dell’ ‘800, per influenza delle colonie europee dell'Algeria e della Siria, alcuni Arabi tentarono d'
imitare il teatro europeo; fu un certo Daninos, ad esempio, forse d' origine greca, ad introdurre, nel 1848, un dramma
regolare arabo presso gli Arabi d'Algeri.
Cfr. De Gubernatis, “Storia del teatro…”, cit., par.137.
27
introduzione sulla struttura degli spazi teatrali e sulla loro organizzazione :« Poiché gli spettacoli si danno
sempre a cielo scoperto, a riparo del sole e della pioggia si distendono tele immense sul luogo ove si deve recitare. Le
loggie e le finestre delle case che danno sullo spianato ricoperto dalle tende sono riservate alla nobiltà.. Gli
spettatori, ciascuno secondo la sua qualità, ottengono un posto più o meno privilegiato, poiché in Oriente 1' etichetta
è sempre strettamente mantenuta29. Le donne vanno a sedersi, in un compartimento per lo più distinto, su
panchettine che ogni donna reca con sé. Il resto della platea è occupato da gente seduta alla maniera persiana, cioè
accoccolata sopra le ginocchia, come cammelli in riposo. Questi gruppi di spettatori sedati, offrono alla vista una
varietà pittoresca. Si vedono tra gli altri acquaioli, i quali, coi loro sacchi di cuoio, pieni del prezioso liquido, e
sospesi ad armacollo, tenendo in mano uno scodellino, offrono a bere, in memoria della sete che tormentava, nel
mezzo dell'arido deserto, la famiglia dell' imam […] anni. Nulla di più grazioso a vedere che que' piccoli acquajoli,
dai piedi ignudi: li chiamano “Nazareni”, cioè votati, devoti. Vestiti con lusso, con le ciglia e le sopracciglia dipinte
in nero, le chiome inanellate cadenti sulle spalle, recanti in capo un berrettino di lana finissima, ornati
splendidamente di perle, essi offrono da bere al pubblico. Dopo di loro vengono gli affittatori di pipe, i mercanti di
frutta, i venditori di ghiottonerie, con piselli, semini di popone e di pera, miglio, preparati all’ orientale, cioè,
dapprima macinati nella salamoia e poi arrostiti. Se ne consuma una grande quantità. Il passatempo riesce tanto più
piacevole in quanto si attribuisce al miglio una virtù sommamente tragica; si crede che esso aiuti a piangere. Si
veggono infine passar come meteore sinistre i servi incaricati di mantener l' ordine30, armati di poderosi bastoni,
vigili, che per un nonnulla si disputano o vengono a' pugni. Quanto al palcoscenico, esso si riduce ad una porzione
di suolo più o meno vasta, ripulita, innaffiata nel mezzo della platea. Nel centro, si vede il “takìit”, specie di tavolato
con piccoli zoccoli, coperto di un tappeto; su questo tavolato si innalza per lo più un seggiolone, alcuna volta una
cattedra.[…] Lo spettacolo incomincia con l'ingresso di un declamatore, con l’incarico di recitare il prologo,
accompagnato da una mezza dozzina di “pishkan, o coristi. Egli rimane per alcuni minuti meditabondo, guarda
verso il cielo, sospira, si mostra con gli occhi lacrimosi, e dice singhiozzando : <<O fratelli miei, o sorelle mie ! Date
i vostri cuori, affliggetevi e piangete a calde lacrime. Non dimenticate che la meditazione sopra le sventure della
famiglia del Profeta ci apre una via che conduce alla porta del paradiso>>. Tenendo l'oriuolo in mano, contai
settantaquattro minuti, ne' quali il declamatore non faceva altro se non variare i suoi lamenti sullo stesso tema, e
con parole simili a quelle che ho riferite. Perciò i pishkhan cantavano in coro le strofe, ed egli il ritornello[…].
Partito il declamatore, i servi portarono via la poltrona e la tavola, spazzarono e innaffiarono lo spianato; e gli attori
arrivarono poco dopo. Nell’ intermezzo, gli spettatori, con quella facilità di passare da un eccesso all' altro che
distingue i Persiani, fumavano, prendevano rinfreschi o
discorrevano tranquillamente, come se nulla fosse
accaduto .Parecchi spettatori , non paghi di battersi il petto fortemente coi pugni, si fanno col pugnale ferite
profonde alla fronte31[…]. Spesso si fanno venire parecchi declamatori, che vengono ad occupare la poltrona gli
uni dopo gli altri. Allora, nonostante la gravità del soggetto, accadono i più comici incidenti. Quelli che non
riescono a far piangere gli uditori, si sdegnano e li colmano d'ingiurie. Altri, meno irritabili, ricorrono a modi più
soavi; essi supplicano il pubblico « di fingere di piangere, se ha la disgrazia d'essere talmente indurito nel peccato da
non poter piangere con sincerità. I più cortesi finiscono con un complimento in verso od in prosa, diretto
Si noti l’affinità con il diritto, presso gli antichi Greci, di “paredria”.
La scena ricorda quella di , nel prologo de , vv. (<< >>).
31
Il De Gubernatis, a riguardo, fa un raffronto con gli effetti prodotti talora dalle tragedie greche, laddove a essere
rappresentate o anche solo narrate erano scene particolarmente violente e coinvolgenti. Tra gli esempi, donne che
abortivano, vedendo le Erinni mostruose che avvinghiavano il matricida Oreste.
29
30
all'imprenditore che paga la rappresentazione. Essi, come gli istrioni della farsa, appartengono alla classe più
povera della società, quantunque tenuti in uguale o maggior conto. Recitano senza suggeritore; quando non hanno
mandato bene a memoria la loro parte, escono sulla scena, coi loro quaderni in mano, ch'essi consultano senza
alcuno scrupolo, quando la memoria viene loro a far difetto. Il direttore scenico tiene una verga in mano, e, ritto
sulla scena, dirige i movimenti degli attori. Non vi sono né quinte, né scenari, né telone. Quando un attore ha finito
di dire la sua parte, si siede in terra, ed attende, per rialzarsi, che torni il suo momento di partire >>.
6. Parte integrante della scenografia teatrale indonesiana, il cosiddetto “gunungan”, una sorta di stendardo
a forma di pentagono, fisso sulla scena o esibito nel corso di cortei. Quanto alle immagini su di esso
rappresentate, occorre distinguere tra quelli giavanesi e i più semplici ma altrettanto colorati dell’isola di
Bali. Nei primi, la parte inferiore è occupata dalla raffigurazione di un portone, fiancheggiato da motivi
di ali. A sinistra e a destra troviamo le guardie del tempio, ovvero giganti (“buta”), armati di una mazza
per stornare l’influenza dei demoni del male.
Plausibile l’ipotesi, secondo cui si tratterebbe di una “Porta celeste”, ingresso al giardino magico dove
sorgeva l’albero sacro, presente spesso sullo sfondo in forme stilizzate. Intrecciati ai suoi rami o disposti
frontalmente in posizione laterale, animali fantasiosi o reali , come tigri, pavoni, uccelli e i mitici serpenti
“raga”. Assai simili i “gunungan” balinesi, dove però manca la porta centrale.
L’altra metà del mondo:
Il teatro nell’America precoloniale
Le antiche popolazioni dei Toltechi e, più tardi, degli Inca e degli Aztechi, che in epoca medievale
Medioevo occuparono una vasta area dell’America centromeridionale (dal Messico al Perù), provenivano
probabilmente dall’Asia orientale, dove era invalsa, con danze accompagnate da strumenti musicali, una
fiorente tradizione teatrale.
I teatri, come ricostruibile da resti archeologici e descrizioni, sia pure tarde, di visitatori, consistevano, per
lo più, in una terrazza scoperta in una parte del mercato o nel cortile di un tempio o di un palazzo,
abbastanza elevata perché il pubblico potesse scorgere gli attori. La scena, come si può al più evincere da
rappresentazioni di età postcoloniale32 legate tuttora a schemi tradizionali, era di solito costituita da un
boschetto artificiale ornato di fiori, uccelli dorati e d'argento, ma poteva estendersi talvolta alla piazza
della comunità. Attestato, altresì, l’uso di maschere numerose33, sebbene utilizzate in ruoli affini da una
medesima persona, come si è visto in analoghe produzioni.
L’evoluzione raggiunta, grazie anche al positivo riscontro sul piano sociale, si coglie nel dramma più
noto, il “Rabinal Achì”, dedicato, come ovvio, all’eroe nazionale dell’età precolombiana. Rappresentato
Nei drammi postcoloniali compare, dove è evidente il rimpianto di una civiltà affidata a pochi resti e a vivi ricordi,
compare, tra gli elementi scenografici, un grande sole nero, a indicare la profanazione del Perú.
33 Oltre a personaggi rappresentativi di storie e leggende incas, compaiono, nei drammi moderni, anche gli antichi
dominatori spagnoli, mascherati in qualche caso, da orsi, condor o giaguari. L'azione è accompagnata da intermezzi
canori e musicali, affidati al coro delle “ñustas”, che in alcune occasioni elogiano la bellezza dell’ eroe Inca o ne
lamentano la morte, in altre cantano un inno in cui si offre sangue alle divinità del Sole e della Luna, ad evocare riti
ancestrali per la fertilità.
32
per circa tre secoli dopo la Conquista dagli indigeni Maya-Quichés del Guatemala, fu trascritto per la
prima volta nel 1850 e tradotto in francese, dodici anni più tardi, dall’abate Brasseur de Bourgbourg.
Protagonista dell’opera, da intendersi come una sorta di balletto intervallato da musiche corali e e parti
recitate, l’ “eroe di Rabinal” (questo il significato del titolo), figlio del capo tribù “CinquePioggia”, che
vince e fa prigioniero il capo dei Quichés. Portatolo al padre, quest’ultimo lo fa sacrificare, dopo avergli
concesso gli omaggi rituali riservati agli eroi. Proprio quest’ultima scena, secondo il De Gubernatis,
sembrerebbe confermare, nell’adozione di un registro cerimonioso e formale, la derivazione da formule
cinesi di congedo o
presentazione, che prevedono il rispetto di qualsiasi avversario, come regola, del resto, di ogni codice
“feudale”.
Caratteristiche simili, a livello strutturale e letterario, si colgono altresì nell’antica tradizione teatrale
messicana.
Sulla struttura del teatro principale, sito nel mercato del quartiere di Tlatitolco, una preziosa quanto
attendibile descrizione ci viene dalla relazione di Cortez, cui si aggiunge, riportata dal De
Gubernatis, la testimonianza oculare di Acosta. Secondo Cortez, si trattava di un’ opera muraria; la scena
aveva un’ tezza di tredici piedi ed una larghezza di trenta passi.
Nei giorni di spettacolo, come attesta l’Acosta, si ricopriva con un padiglione di fogliame, analogo a
quelli che si usano nelle processioni campestri, e si ornava il proscenio di grandi alberi alla veneziana,
con bandiere sventolanti, che rappresentavano gli animali favolosi, insegna della città.
Una viva partecipazione popolare accompagnava, ad esempio, le manifestazioni pubbliche che si
svolgevano a Sholula in onore di “Quetzalcohuatl”, l’uccello piumato venerato come una divinità:
« Nel cortile del tempio di questo dio, vi era un piecolo teatro di trenta piedi quadrati, costruito ed imbiancato con
molta cura; provvedevano a conservarlo pulitissimo, e, in occasione dello spettacolo, l’ornavano con verdi
ramoscelli, archi di piume e ghirlande, di fiori, collocando, nel mezzo, uccelli, conigli e
molti oggetti curiosi. Dopo aver mangiato, la folla vi accorreva. Gli
attori si presentavano al pubblico,
contraffacendo, in scene grottesche, i sordi, i malati, i ciechi, gli zoppi che si recavano al tempio per implorare dagli
Dei il ritorno della loro salute. I sordi, interrogati, rispondevano imitando il suono della tosse cavallina; altri, a
seconda della loro malattia, in modo da esilarare gli spettatori. Dopo queste prime scene buffonesche, venivano
innanzi altri attori, travestiti stupendamente in varie forme d' animali, gli uni in scarabei, in rospi, in lucertole, gli
altri in quadrupedi o anfibi, manifestando, in vari dialoghi, la natura degli animali che venivano a rappresentare.
Alunni del tempio, con ali di farfalla o d'uccello a più colori, uscivano quindi, arrampicandosi sugli alberi, ove i
preti gettavano loro, motteggiando, delle palline di terra>>.
Quanto infine al teatro inca, nell’area compresa tra gli attuali Colombia, Ecuador e Perù, le analogie nella
scelta di temi ancorati a simili valori sottesi, si colgono nell’anonimo poema dal titolo “Ollantay”34,
destinato a una lunga fortuna letteraria. Perno della trama, la storia d’amore contrastata fra il giovane e
valoroso generale degli eserciti Inca, ovvero Ollantay, e Qoyllur, la figlia del re inca Pachacutec, di
superiore rango sociale. Allorché la principessa rimane incinta, viene fatta imprigionare dal padre nella
“Casa delle Vergini del Sole”. La loro bambina verrà allevata in un convento. Ollantay fugge lontano fino a
scontrarsi, tempo dopo, col medesimo sovrano. Alla morte di quest’ultimo, tradito e imprigionato, viene
infine perdonato dal nuovo imperatore, Túpac Yupanqui, suo amico, oltre che cognato. Sarà appunto
quest’ultimo a ricomporre la coppia, e con loro la piccola Yma Sumac (alla lettera= “Quanto bella”),
inaugurando per il popolo un’era di pace e di felicità.
34
Secondo ipotesi accreditate, l’autore andrebbe forse identificato con Antonio Valdes
VOLTI NASCOSTI,
MONDI SVELATI
Forme e simbologie di maschere e costumi nelle antiche produzioni teatrali
La maschera e il doppio
1. Sul noto vaso François di Firenze sono raffigurate diverse divinità, che sfilano di profilo in una
processione. Ma c’è una figura -non una sagoma, ma un semplice volto- che sembra fissare frontalmente
le pupille dell’osservatore, un volto bloccato in una posa innaturale e ambigua, statica ma al tempo stesso
in tensione. Quello del vaso François non è del resto un caso isolato: si è appurato ormai che solo al volto
di Dioniso o alle sue maschere è riservato, nell’iconografia vascolare greca, il privilegio della frontalità.
Dioniso, dunque, non è un dio ‘obliquo’, come Apollo: il suo messaggio è diretto al fedele in modo
esplicito, senza compromessi o ambiguità oracolari, e il fedele lo deve accogliere come un’esperienza
totalizzante, rinunciando all’apparenza, rendendosi “altro” da sé. Ma per comprendere le molteplici
valenze e simbologie afferenti al culto dionisiaco, occorre prendere in considerazione la pittura vascolare
del VI e del V secolo a.C., dove compaiono donne che celebrano il rito intorno al simulacro del dio,
ovvero un tronco o un semplice palo di legno, cui è appesa una maschera con barba, riccioli o trecce.
Siffatta iconografia, documento per molti del passaggio dal culto aniconico del dio a quello
antropomorfico, ci dimostra la stretta connessione originaria tra Dioniso e la maschera, metafora allusiva
di una dialettica tra essere e apparenza, su cui si fonda il “thauma” (prodigio), che nasce (e che talvolta
può far nascere ) dal delirio e dalla “mania”. Ancora, Pausania35 racconta di una enigmatica maschera di
Cfr. Paus., X, 11. Per ulteriori approfondimenti sulla figura e sul culto di Dioniso, cfr. AA.VV., “Storia delle
credenze e delle idee religiose”, vol. I: “Dall’età della pietra ai Misteri Eleusini”, Sansoni, 1979, 388-403.
35
legno trovata da alcuni pescatori di Lesbo in fondo al mare, che subito fu considerata epifania di Dioniso.
Le maschere di Dioniso, infatti, erano venerate non già come dei semplici simboli ma come
manifestazioni (e dunque presenze) del dio, che pur restava assente nella sua ambigua “estraneità”.
Quanto al legno, elemento che ricorre di frequente nel repertorio iconografico e nella attinente mitologia,
non va dimenticato il suo legame con la vite, di cui fu scopritore, nonché con l’edera, che della vite
sembra riprodurre la forma e il colore. Tra gli epiteti del dio figura, inoltre, quello di “orthòs” (= diritto),
forse riferito al fatto che in origine il dio era adorato all’origine nella forma di palo o anche di “phallòs”,
simbolo di fecondità portato “eretto” nelle processioni, benché l’epiclesi potrebbe anche riferirsi al
tenersi “diritti” in piedi, evitando con l’acqua gli effetti dell’ebbrezza. Il dio era inoltre detto “Endendros”
e “Dendrìtes”, ossia “spirito dell’albero” e infine, come “Euànthes” (= “dalla feconda fioritura”), era
invocato dai seguaci del thìasos in processioni rurali. Dioniso è dunque dio e uomo, pianta e animale,
sintesi dialettica del Tutto, nella costante ricerca di una precisa identità. Ne è prova il mito orfico, in cui il
dio bambino, con la faccia imbiancata di gesso –come una sorta di maschera- si guarda allo specchio e non
si riconosce, e, come lui, l’adepto, in un affresco della “Villa dei Misteri”, che scorge nella coppa in cui si
specchia l’enigmatica espressione del dio. <<”Principio” e “fine” di questo cammino di misteriosa
trasformazione>>, la maschera, dunque, è il solo strumento di annullamento dei contrari << e lo sguardo inquietante
delle sue orbite vuote apre l’adepto a prospettive oscure e luminose, comunque sovrumane.>>36.
GRECIA
2. Strettamente connesso al culto dionisiaco, il teatro ellenico non poteva non serbare tracce, cultuali e
iconografiche, di un dio “straniero” ma fortemente presente. La maschera, pertanto, il cui uso è attestato
nell’arte con implicazioni religiose molto prima del dramma, era la caratteristica più importante
dell’attore greco. Fatta di lino, sughero o legno e munita di una parrucca, pur con una fisionomia fissa
(viso dipinto di bianco per le donne, di grigio per gli uomini ), era fondamentale per attori che dovevano
sostenere anche dieci ruoli diversi e quindi accessoriata (in relazione al colore, alla forma, alla natura dei
capelli, alla varietà dei copricapi), in modo tale da poter ottenere da pochi tipi una serie di personaggi
dissimili. Tratto comune l’apertura più o meno accentuata della bocca non solo a fini espressivi ma anche
con funzioni di megafono (la scena poteva, infatti, distare dagli ultimi spettatori anche 90 metri). Di
quelle del quinto secolo ci sono pervenute scarse informazioni, grazie soprattutto a raffigurazioni
vascolari, ma scavi effettuati a Lipari hanno portato alla luce terrecotte raffiguranti personaggi teatrali
36
Cfr. il saggio “Dioniso e il mondo dionisiaco”, sul sito volta.valdelsa.net/thiasos/baccanti/saggi.htm.
che consentono di contare ben 44 tipi da collocare nell’arco di tempo che va dalla prima metà del secolo
IV alla metà del secolo II a.C.. Se in origine -come attesta il lessico di Suda alla voce “Thespis”- maschere
in lino o tela, con fori per gli occhi e la bocca, sostituirono il semplice trucco con biacca e porcellana, nel
periodo d’oro della tragedia (IV sec. a.C.), la maschera diventa più imponente e presenta una bocca
decisamente sproporzionata al resto del volto. Affissi ad essa, talora, crini, stoppie, capelli, retaggio forse
di antichi riti primitivi, funzionali di certo a una più icastica espressività 37. Quanto agli altri costumi
(forse introdotti da Eschilo), fondamentale era il “chitone”, una tunica a maniche lunghe abbellita da
ornamenti e legata da una cintura sotto il petto (chitone ionico) o più corta ed aperta sui fianchi (chitone
dorico); sul chitone, munito a volte di uno strascico o σύρμα, veniva indossato o un “imation” (lungo
mantello raccolto sulla spalla destra) o una “clamide”, un mantello corto portato sulla spalla sinistra. In
alcune pitture vascolari compaiono personaggi con indumenti simili a pantaloni, per influsso
evidentemente di usanze e costumi orientali, così come si accenna, in alcune tragedie, ad accessori
particolari, anch’essi funzionali a una caratterizzazione culturale: lo straniero di alto grado, come il re
Dario nei Persiani, indossa la tiara; i Troiani, e gli orientali in genere, possono portare il berretto frigio. Il
colore stesso dei costumi si prestava ad analoghe funzioni: il nero, ad esempio, indicava lutto o sventura,
il rosso porpora la dignità regale, gli abiti femminili erano verdi o azzurri, bianchi quelli delle
sacerdotesse. M i personaggi erano distinguibili anche da particolari che rimandavano alle loro età o
occupazione (ad esempio, la βακτηρία, cioè il bastone, era attributo dei vecchi; la spada dei guerrieri; una
ghirlanda designava i messaggeri). Ad incrementare la già notevole statura dell’attore, imbottito e munito
di un όγχος, ovvero di una parrucca per motivi scenici (cioè per essere distinto anche dagli spettatori posti
sulle ultime gradinate), era diffuso l’uso del “coturno”38, un tipo di calzatura che, nata con suola bassa, ma
resa più spessa in epoca tarda, aumentava di ben
venti centimetri la solennità del personaggio
37
Sorprendenti analogia, anche se in epoche e in contesti culturali differenti, si rilevano in una descrizione di
metà ‘800 dell’abate Brasseur de Bourbourg, invitato ad assistere al dramma guatelmateco “Rabinal Aci”:
<<Vestito di rocchetto e di stola, entrai nel tempio. Era pieno di gente. Gli attori erano tutti coperti dei loro nuovi
costumi, con la testa cinta dei loro diademi di piume disposte a ventaglio. Ciò che dava loro un aspetto veramente
originale era la maschera in legno di cui tutti gli attori avevano coperto il volto; tali maschere erano benissimo
scolpite e dipinte, interamente d’accordo con la parte di ciascun personaggio, con due fori agli occhi ed un foro alla
bocca; un ricordo perfetto del teatro dei Greci e dei Romani (ed io aggiungo qui dei Cinesi e Giapponesi), dove vi
erano sempre due o tre attori per una sola parte per potersi, occorrendo, sostituire l'uno all'altro, poiché la
lunghezza del dramma e la maschera di legno che loro copre il viso li affaticano, specialmente in un paese caldo,
oltre misura>>. Seguono, quindi, punteggiate da brevi notazioni, la trama dell’opera e il commento alle modalità
recitative. A concludere, un’informazione sulle maschere, numerose, come in Oriente, ma tali da dover ricoprire più
ruoli affini. Da qui, dunque, l’abitudine degli attori di annunciarsi in terza o in prima persona, come accadeva in
Cina (vedi al cap. del presente saggio), con un analogo e un po’ rigido formulario di cortesia. Cfr. De Gubernatis,
op. cit., par. 215.
38 Non c'è oggi concordanza tra gli studiosi circa l’introduzione già con Eschilo scena di coturni provvisti di un
cospicuo rialzo. Le fonti iconografiche su vaso, al contrario, descrivono calzari con una suola non particolarmente
elevata, che coprono le gambe sino al polpaccio, fermati da lacci di pelle morbida, talora con la punta ricurva ; nella
biografia di Sofocle si accenna a calzari bianchi che indossano gli attori ed i coreuti. Non si può escludere che in
alcuni casi gli attori recitassero a piedi nudi (dato certo nel caso delle Oceanine nel “Prometeo incatenato”). Più
plausibile l’ipotesi che dopo la metà del secolo IV a. C., all’epoca di Licurgo , il teatro greco sia stato profondamente
modificato e tra le altre innovazioni siano comparsi i coturni con una suola e tacchi alti fino a 10 (anche 20) dei nostri
centimetri e che siano stati preferiti per le parti femminili o effeminate, secondo un’usanza d’ispirazione orientale.
Cfr. “Il costume nel teatro greco, la sua evoluzione nel teatro latino”, consultabile on line, pp. 8 s..
interpretato. Dati ulteriori su costumi e convenzioni varie in materia di abbigliamento ci vengono dall’
“Onomasticon” di Giulio Polluce39 ( II sec. d.C.), dai nomi specifici di abiti e accessori ( tra questi, la
“simmetria”, una tunica femminile
orlata di porpora lunga fino ai piedi, alla “aptis”, un manicotto
purpureo a indicare il personaggio del cacciatore, dalla raffinata “exomis”, rifinita a volte anche con oro,
alle più modeste “batrachis” o “encoboma” di colore bianco.40 Difficile, infine, imaginare come venisse
raffigurato cieco o accecato, come nel caso dell’ “Edipo a Colono” o nell' “Ecuba”: ad indicare la
situazione, erano forse bende sugli occhi o mani grondanti sangue. Ad accrescere il pathos, evidenziando
al contempo la compartecipazione del coro, lacrime, capelli corti o del tutto rasati.
Quanto ai costumi in uso nella commedia, erede diretta, a detta di Aristotele 41, di “canti fallici” eseguiti
in processioni, è difficile stabilire se il coro e gli attori si uniformassero alla caratterizzazione di “itifalli”
o “fallofori”42 o se, a partire da quelle tradizioni, vi sia stata nei secoli progressiva evoluzione. Se
Aristotele, al riguardo, ci dà scarse indicazioni -contrapponendo l’origine falloforica della commedia
39
Giulio Polluce elenca altresì ben 28 tipi differenti di maschere, suddivisibili in quattro categorie: uomini anziani,
giovani di sesso maschile, schiavi e donne, dall' anziana nutrice alla giovane infelice eroina, giacché alle maschere
era demandato il compito di raffigurare non solo il ruolo ma anche il carattere del personaggio.
40 Cfr. “Il costume nel teatro greco…cit., pp. 2 ss..
Cfr. Arist., “Poetica”, IV 1449 a: <<La tragedia, essendo nata all’inizio dall’improvvisazione –come anche la
commedia, la prima da coloro che intonavano il ditirambo, la seconda da quelli che cantavano i canti fallici, in uso
ancora presso molte delle città- a poco a poco si accrebbe, poiché si svilupparono gli elementi che divenivano
evidenti in essa […]. In primo luogo, Eschilo portò il numero degli attori da uno solo a due, diminuì l’importanza
del coro e rese protagonista il dialogo. Sofocle portò gli attori a tre e aggiunse la scenografia. Più tardi, acquisì la
sua solennità, dopo essere passata da miti brevi e da un linguaggio giocoso e aver abbandonato l’elemento satiresco,
ed anche il metro da tetrametro trocaico divenne giambico>>.
41
42
Un esempio di falloforia è negli “Acarnesi” (vv 241-279), dove il protagonista Diceopoli, dopo aver concluso una
pace con gli Spartani, festeggia l’evento con una processione a cui partecipano la figlia, che funge da canefora, il
servo, col simbolo fallico di cuoio, e lo stesso Diceopoli, che intona il canto, mentre la moglie osserva dall’alto di un
tetto. Un’importante testimonianza ci viene anche da un frammento di Semo di Delo (200 a. C. circa), riportato da
Ateneo (II sec. d.C.) nei “Deipnosofisti”. In esso si legge di attori detti appunto “itifalli” o “fallofori”, incoronai e
mascherati da ubriachi, che sfilavano in processioni fino all’orchestra, per poi intonare un canto in onore di Dioniso e
abbandonarsi ad ogni genere di beffe verso gli spettatori. Secondo gli studiosi, tali performances avrebbero lasciato
palesi tracce dapprima nella “parabasi” della Commedia antica e poi nei “carmina fescennina”. Il termine
“fascinum” indicava infatti il “malocchio” e, per metonimia, il membro maschile, ritenuto il più mezzo per stornare
la sterilità, particolarmente temuta in una società agricola.
all’etimologia sostenuta dai Peloponnesiaci43 e alle loro rivendicazioni-, notizie più precise ci vengono da
un passo di Semo di Delo nei “Deipnosofisti” di Ateneo44, in riferimento probabilmente ai fallofori di
Sicione. Incoronati di rami e ghirlande di fiori, sfilavano nell’orchestra, già sede di queste cerimonie,
preceduti da un giovane che portava il fallo col volto tinto di nerofumo. A loro simili gli “itifalli”,
accompagnati da maschere di ubriachi, e i cosiddetti “autokabdaloi”, ovvero “improvvisatori”, esperti
forse di azioni mimiche con tratti caricaturali. Analoghe tradizioni, presenti del resto, in diverse civiltà,
erano ancora i cortei di mendicanti, che beffeggiavano, a fini apotropaici, rivali, ricchi cittadini o casuali
passanti, nonché le “τρυγωδίαι” di contadini, coperti nel volto da “τρύξ”, ovvero “mosto” o “feccia”45.
Pare, inoltre, che in queste processioni si portassero in giro animali, forse a scopo sacrificale, particolare
che giustifica, a prescindere da valenze simboliche,
l’introduzione, nella fase ormai matura della
commedia, di cori animaleschi, come le “Vespe”, le “Rane”, gli “Uccelli”. Dal fallo in legno o in cuoio,
portato in bella vista tra le mani di chi apriva il corteo, si sarebbe passati, a quanto pare, a grottesche
imbottiture del ventre, delle parti posteriori e degli organi genitali, come è possibile evincere da pitture
vascolari, come ad esempio il cratere corinzio del Louvre. La raffigurazione, su quest’ultimo, di due ladri
di vino puniti in ceppi, con fallo e deretano spropositati, distinti da flautisti e danzatori, lascia credere
che si tratti di attori che, al pari del coro, incarnavano, come demoni ebbri, la forza, quasi sacrale, della
natura e della fecondità46.
ROMA E IL MONDO LATINO
3. Sull’utilizzo di maschere o tutt’al più di acconciature che definissero, degli attori, ruoli e caratteri
precisi, la questione è ancora dibattuta47. Pare certo che essa venisse usata regolarmente nel I sec. a.C. ma
Secondo questa diversa teoria, sostenuta da Erodoto, Historiae, V 67, Clistene, tiranno di Sicione nel VI secolo a.C.,
proibì il culto dell’eroe Adrasto, cui erano dedicati cori tragici, restituendo questi ultimi a Dioniso e consacrando a
Melanippo, nemico di Adrasto, il resto della cerimonia. Fu forse l’alternarsi tra il coro tragico dedicato all’eroe e le
battute pronunciate, al riguardo, dagli astanti a dar vita a un dialogo drammatico, come quello ipotizzato da
Aristotele a proposito del ditirambo.
43
44
45
Il particolare, oltre a creare un legame tra le forme primitive di commedia e il culto di Dioniso inventore del vino,
ha dato adito a una sovrapposizione semantica tra τρυγωδία e τραγωδία, a tutt’oggi smentita.
46 Non è certo, in realtà, se gli attori e il coro avessero il “somation”, ovvero questo rigonfiamento, come tratto
costante o solo in particolari occasioni, come ad es., in danze scomposte di ballerini pancioni. Neppure si può
escludere una maggiore varietà nei costumi, almeno per quel che riguarda i coreuti, anche perché la presenza del
fallo non si accorderebbe con la loro natura spesso animalesca.
47 Si osservi che il termine “maschera” non appartiene al lessico greco ma deriva dal germanico “masca”, ovvero
“strega” o “fantasma”, in riferimento forse all’illusorietà e assenza di consistenza reale del personaggio che la
indossa. Viceversa, il termine “persona”, con cui in ambiente latino si indicava la maschera dell’attore, si ricollega
all’etrusco “fersu”, a designare il personaggio e il suo ruolo sulla scena e, più tardi, nella vita e nella società (cfr.
per l’età arcaica non esistono testimonianze sicure. Difficile ipotizzarne le tipologie, per quanto concerne
le rappresentazioni tragiche, non avendo di queste ultime, al di là di frammenti e citazioni indirette, testi
e informazioni esaurienti. A fornircene un’idea, testimonianze figurative coeve o di poco posteriori,
come ad esempio l’affresco pompeiano, conservato al Museo Nazionale Archeologico di Napoli, in cui un
attore osserva, pensoso, la maschera tragica attinente a suo ruolo; maschera che nei tratti somatici,
espressivi e accentuati, rivela l’influsso del teatro ellenistico, accanto ad apporti e suggestioni di diverse
civiltà. Non mancavano, del resto, particolari che accentuassero, nelle singole tragedie, effetti tragici
spesso esasperati48, facilitando, al tempo stesso, l’identificazione di personaggi non sempre mutuati dai
repertori tradizionali.
Tratto distintivo rispetto al teatro greco, l’uso, riservato ai protagonisti, della “toga praetexta” orlata di
porpora nelle tragedie di ambientazione romana49, oltre ai valori talora differenti che si attribuivano ai
medesimi colori50. .
Quanto al genere comico, riferimenti nei testi plautini e terenziani ad espressioni del viso farebbero
pensare piuttosto che il volto degli attori, pur coperto da trucco, restasse comunque scoperto. A
caratterizzare il personaggio o i personaggi che il singolo attore interpretava bastava probabilmente la
gestualità che, associata ad una particolare tipologia linguistica51, consentiva allo spettatore
una
immediata comprensione. A caratterizzare alcuni personaggi non mancavano però costumi e accessori
fissi: il soldato, ad esempio, portava la spada e la clamide, il messaggero il tabarro e il cappello, il villano
la pelliccia, il parassita il mantello, il popolano il farsetto. Un’altra distinzione riguardava i costumi dei
mimi: il “mimus albus,” ad esempio, aveva vestiti candidi, il “mimus centuculus” (quasi un Arlecchino)
indossava costumi di vari colori. Al personaggio di Ulisse, sia nelle rappresentazioni tragiche che nelle
parodie, si attribuiva come segno distintivo un berretto a forma conica, il cosiddetto “pilleus”, così come a
figure di origine rurale il fazzoletto quadrato, detto “ricinum”, posto sul capo.
Cic., Ep .ad Atticum, VII,11 e IX,11). Accostabile a “persona” il termine greco πρώσοπον, che significa alla lettera
“davanti al volto”.
48 Un esempio, l’ingresso delle Furie armate di fiaccole accese, a imitazione delle Erinni delle “Coefore” eschilee,
nell’ “Alcmeone” di Ennio (fr. 18 Traglia).
49 Come è noto, i Romani distinguevano, per quanto attiene al genere tragico, tra “cothurnata” e “praetexta”, a
seconda che l’ambientazione e i rispettivi costumi (a partire appunto dal coturno) fossero greci o romani, e tra
“palliata”, ovvero la commedia ispirata al mondo ellenico, in contrapposizione alla citata “togata”, commedia in
vesti romane. Nella pratica spettacolare la divisione non sarebbe stata, tuttavia, così evidente, essendo frequenti le
contaminazioni tra un genere e l'altro anche nei testi più antichi, tanto più che il termine “fabula”, dal verbo “fari”,
ovvero “parlare”, designava e indica tuttora sia la tragedia che la commedia. Alle suddette tipologie di commedia si
sarebbero più tardi sostituite la “tabernaria”, avente come sfondo la taverna popolare, e spettacoli di mimo di breve
durata, ispirati a una più crassa e spesso licenziosa comicità.
Tra gli esempi, stando alla testimonianza di Elio Donato, il giallo che in Aristofane è il colore della seduzione, in
Terenzio diviene il colore della cupidigia, appropriato dunque al personaggio della mezzana avida di denaro.
50
51
Pare, secondo alcuni critici, che l’attore Roscio abbia per primo introdotto, nella commedia, l’uso della maschera,
perché, essendo guercio, avrebbe potuto soltanto rappresentare il carattere del parassita scroccone ed adulatore. Non
si esclude, tuttavia, un uso più antico di tale accessorio, motivato da ragioni più ampiamente condivise.
Testimonianze varie, soprattutto vascolari, lasciano infatti supporre che quanti partecipassero a ludi o forme teatrali
primitive portassero maschere alquanto rudimentali, oltre al viso dipinto di rosso.
Di più facile identificazione, e da più fonti attestate, le maschere dell’Atellana52, dai tratti fissi e spesso
deformati. Ad esempio, a Bucco e a Macco, si attribuivano una bocca e sproporzionata e deforme giacché
prototipi di ingordi e ciarlatani; il falso e presuntuoso Dosseno era visto come un gobbo che agisce, quasi,
di nascosto; capelli e barba tra il grigio e il bianco contornavano il volto dai lineamenti marcati del
vecchio ridicolo raffigurante Pappo; scioccamente saltellante sulla scena, Kikirrus si distingueva, infine,
dagli altri personaggi, per il becco adunco e la “voce” di gallo53.
La decadenza dei generi tradizionali e l’affermarsi di forme popolari, dove anche le donne potevano
recitare, portò alla distinzione tra la “fabula ricinata”, con attrici-ballerine che indossavano il citato
“ricinum” e la “fabula planipedaria”, con attori a piedi scalzi e senza più maschere.
Era la fine del teatro classico, tra la crisi irreversibile di generi inattuali e la ricerca, in nuce, di nuove
forme e più realistiche modalità.
Tipiche maschere dell’Atellana, probabilmente Pappo e Dosseno
Farsa popolaresca di origine osca, proveniente dalla città campana di Atella, fu importata a Roma nel 391 a.C. come
una sorta di “comica finale”. Affidata in origine all’improvvisazione, sarebbe quindi evoluta, unitamente a generi
affini (dalla “farsa fliacica” -dal greco φλύαξ, collegabile al verbo φλέω (= trabocco), in riferimento, probabilmente,
all’ebbrezza del vino-, attestata da raffigurazioni vascolari taratine, ai “fescennini” di origine etrusca) in produzioni
scritte e più mature rappresentazioni. L’aggiunta della recitazione, sia pure improvvisata, in quel miscuglio di arti
sceniche denominato “satura” ( da “satur”, ovvero “pieno”, riferito metaforicamente alla “ lanx”, vassoio ripieno di
primizie, o al “farcimen”, ricco impasto alimentare –evidente il legame, peraltro, tra “farcia” e “farsa”-, o ancora a
una legge che comprendeva diversi provvedimenti) rappresentò un importante passo avanti nella genesi e nella
evoluzione di una già varia produzione teatrale, percepita ormai come romana.
52
Secondo V. Gleijeses, “Le maschere e il teatro nel tempo”, Napoli, 1981, p. 9, Macco ha le stesse caratteristiche
fisiche e caratteriali del moderno Pulcinella, a cominciare dalla protuberanza sul volto, che può essere un naso
adunco o un becco. Pulcinella, del resto, è l'unica maschera della commedia dell'arte che proviene dal Sud Italia, più
precisamente dalla Campania, al di là della fama internazionale del personaggio a cui si ispireranno, tra gli altri,
l’inglese Mr. Punch, il russo Petruska, l'austriaco Kasperle e il ceco Kašpárek (cfr. H. Paerl, “Pulcinella la misteriosa
maschera della cultura europea”, Apeiron. 2002, p. 193). Secondo altri, invece, antecedente è Kikirrus, vista anche
l’affinità del nome e del modo di porgersi.
53
Capua, Museo Campano, Maschera Atellana,
Parigi, Museo del Louvre, Macco (?)
Attore di una farsa fliacica, pittura vascolare conservata al Louvre
Scena di Atellana in un frammento di vaso (Arezzo, Museo Archeologico Nazionale “G. C. Mecenate”)
Affresco di epoca romana raffigurante due attori calzanti maschere, conservato al Museo Archeologico Regionale di
Palermo
GIAPPONE
4. Vi è una storiella che da sempre circola tra gli attori del teatro no: “Un giovane praticante segue una
vecchia signora per la strada. Quando la donna si volta e gli chiede il perché di quel comportamento, il
ragazzo le spiega che dovrà assumere il ruolo di una vecchia in un dramma no e vuole perciò studiare i
suoi atteggiamenti. Allora la vecchia, proprio come certi misteriosi personaggi di sapienza soprannaturale
che compaiono in questo tipo di teatro, lo ammonisce che, per diventare un grande attore, non dovrà
osservarla per
assumerne la voce e le tipiche
posture, ma dovrà riuscire a rappresentarla con gli
strumenti che troverà nel suo cuore”. L’invito alla spontaneità e alla personalizzazione del ruolo
interpretato non esclude, tuttavia, l’utilizzo di maschere di notevole espressività, scolpite, peraltro, in
modo tale che, in rapporto a orientamento e incidenza della luce, si producano diverse variazioni.
Inoltre, poiché i buchi all'altezza degli occhi sono di ridottissime dimensioni, per aumentare
ulteriormente l'espressività, gli attori sono costretti ad avvalersi di punti fissi e percorsi prestabiliti per
una maggiore libertà espressiva.
A indossare la maschera era di solito solo lo “Shite”, l'attore principale, ma, in alcuni casi, potevano
indossarla anche gli “Tsure”, specie se si trattava di personaggi femminili. Buona parte delle maschere
raffigurano precise tipologie femminili, accanto a vecchi, ragazzi, nonché divinità, animali o personaggi
surreali54.
Di particolare rilievo i ritratti dei cosiddetti “oni”55, demoni di solito descritti come giganti dagli artigli
taglienti, con lunghi capelli, bianchi e scomposti, e corna che spuntano alle due estremità. La loro pelle
può essere di colori diversi, ma quelli più comuni sono rosso, blu, nero, rosa e verde.
Ad accentuare il loro aspetto feroce, tipici attributi quali la pelle di tigre e la mazza ferrata (kanabō).
54
Gli attori senza maschera, tra cui in genere coprimario waki, hanno sempre un ruolo di uomini adulti di venti,
trenta o quarant’anni.
55 Sull’origine di queste figure, diverse sono le interpretazioni. Va in primo luogo precisato che nelle prime leggende
gli oni, come per esempio la ragazza del pozzo, erano creature benevole, capaci di tenere alla larga spiriti maligni e di
punire i malfattori. Durante l'era Heian, il Buddhismo giapponese, che aveva già importato una parte della
demonologia indiana (rappresentata da figure come i “kuhanda”, “gaki” e altri), incorporò queste credenze,
chiamando queste creature aka-oni (“oni rosso”) e ao-oni (“oni blu”) e facendone i guardiani dell'inferno o
torturatori delle anime dannate. Alcune di queste creature erano inoltre riconosciute come incarnazioni di spiriti
shinto. Con il passare del tempo, si accentuò la connotazione negativa degli oni, sì da considerarli portatori o agenti
delle calamità. Da qui l’associazione con nemici o stranieri, sprezzati come barbari e feroci, specie quelli, di origine
cinese, stanziati nel nord-est (non a caso, la pianta a L di templi ed edifici giapponesi avrebbe la funzione di
stornarne gli influssi malefici). Secondo un'altra tradizione di origine taoista si ritiene che alcuni oni possano fare
delazioni alle divinità sui peccati dell'uomo, donde la nota rappresentazione delle tre scimmie che «non vedono, non
sentono e non parlano». È’ stato infine ipotizzato che gli oni non siano altro che una trasposizione degli “Ainu”,
antica popolazione europoide del Nord del Giappone, stanziata tuttora nell'isola settentrionale di Hokkaidō, da
sempre giudicati esseri animaleschi per via dei peculiari tratti fisici (la lunga barba bianca e la capigliatura grigia e
fluente), emarginati ovviamente da ogni contesto della società.
L’intensa espressività di una maschera può altresì affidarsi ad accese gradazioni di colore e a tratti
accentuati di sofferta passionalità. Si guardi, ad esempio, la maschera della donna gelosa, il cui volto è
deformato da un’ira feroce, fino ad assumere demoniache connotazioni:
Come nel mondo greco, la maschera, inoltre, ha una funzione mediatrice, vale a dire può incarnare entità
superiori, ponendosi come punto di incontro tra il mito e la storia, l’uomo e la divinità.
Nei drammi più antichi le maschere erano anzi considerate delle vere e proprie divinità, cosicché ogni
spettacolo era preceduto da preghiere ad esse rivolte. E ancora, alle maschere si attribuiva la funzione di
richiamare i morti sulla terra: indossando la maschera del defunto, l'attore, dunque, ne incarnava lo
spirito.
Una medesima varietà di tipologie si riscontra laddove ad attori reali si sostituiscono raffinate marionette,
non troppo distanti, in fondo, dai modelli reali, se si considera di questi ultimi la ieratica solennità di
movimenti e posture e una certa stilizzazione nei costumi.
Rispetto al corpo umano, la grandezza delle marionette è di metà o due terzi. Il corpo è in generale
coperto da un kimono, per cui non c’è bisogno, molto spesso, di sospendere al busto, per gli arti, altri
tronchi di legno.
Le teste, con un’impugnatura con dei fili per muovere occhi, bocca e sopracciglia, sono classificabili in
ben 70 categorie, come la donna anziana e quella non sposata, il giovane soldato che si distingue per
forza e fisicità. E come varia il loro aspetto così le loro voci, nella recitazione di un unico narratore: da un
tono basso per gli uomini (più alto se si tratta di guerrieri o imperatori) a un tono in falsetto per i
bambini e per le donne.
Teste dei burattini, lunghe 15-20 cm, usate rispettivamente per il ruolo di uomo attraente e per quello di cortigiana.
CINA
5. All’insegna di una varietà tipologica che potesse al tempo stesso prestarsi alla rappresentazione dei
diversi personaggi delle corti imperiali, l’Opera di Pechino si caratterizzò fin dalle origini per l’adozione
di accessori policromi con diversi decori e di abiti dai colori fissi, ciascuno per ogni ruolo.
Il vestito dell’imperatore, ad esempio, era sempre di colore giallo, a prescindere dall’epoca e dal singolo
personaggio; abiti o accessori di colore nero designavano sincerità e buona fede, il verde, al contrario, era
il colore della perfidia; un fiore rosso usato come spilla indicava che quell’uomo era sposato; il ricamo di
un pipistrello era simbolo di longevità, quello di una tigre emblema di forza virile. .
Analogo discorso per cappelli, copricapi, barbe, scarpe, ventagli e soprattutto per il trucco che ogni attore,
anche per più ore, applicava da sé56 : un personaggio malato, ad esempio, aveva come segno distintivo
tra le sopracciglia una sottile linea rossa verso l'alto; i personaggi aggressivi e frustrati un’immagine di
freccia che sbiadiva sulla fronte; i pagliacci una sorta di maschera dipinta dalle tinte bianche e rosse. Le
ciglia stesse, nere e ben marcate, erano più sottili per le figure femminili; i capelli raccolti distinguevano,
tra queste, le fanciulle non sposate. Quanto ai copricapi, studiosi e ufficiali indossavano cappelli neri con
ali nere su entrambi i lati; i generali elmi con le piume della coda dei fagiani (un elmo tolto indicava, tra
l’altro, che il personaggio era esausto, frustrato o pronto ad arrendersi, così come lo scuotere la coda dei
cavalli); i soldati semplici cappelli normali; regine e principesse elmi ingioiellati.
Solo occasionalmente, infatti, si indossavano maschere, giacché ad esse si preferivano “visi dipinti”, detti
hualian).
56
A favorire ulteriormente la comprensione della storia in relazione ai personaggi, i movimenti
convenzionali dei piedi e degli occhi e delle mani”57.
Acquerelli dell'Istituto di Scenografia di Shanghai
Si legga, al riguardo, il par. 6 del capitolo dedicato alla danza, dove si accenna a simili usanze nel mondo indiano,
di esplicita valenza simbolica e sacrale.
57
Gioielli femminili
Quanto infine alle calzature, gli uomini erano soliti indossare stivali neri con suole bianche alte, che
potevano rallentare se non ostacolare l’andatura, sì da conferire una maggiore solennità.
L’imitazione delle donne portò inoltre alcuni attori, i citati danera, a camminare su speciali zoccoli o
“piedi” di legno (qiaoxie) con l’estremità in verticale, quasi sulla punta: in tale posizione i piedi venivano
fasciati e infilati in minuscole scarpine.
TIBET
6.1 Ispirato, come detto, a principi e credenze buddiste, di cui è riflesso un limitato ed omogeneo
repertorio di testi, l’ ache-lhamo è eseguito – e si direbbe vissuto- da attori e interpreti di danze e di
sezioni musicali, che personificano emblematiche figure di sovrani, guide illuminate, fedeli o oppositori
di benefiche potenze o di spiriti del Male. Tra le figure principali, che sfilano di solito sul palco nelle
scene iniziali, i cosiddetti “ngonpa”, ovvero pescatori o cacciatori, impersonati in genere da acrobati nelle
vesti anche di “buffoni”. Seguono quindi i “daini” e i “gyalu”, capivillaggio o capiclan solitamente in
numero di due, per il cui ruolo sociale superiore sono prescelti attori più anziani con vesti dorate o
comunque decorose.
Per identificare un personaggio sono talvolta indossate maschere a vivaci colori, in cui il rosso
simboleggia la regalità, il giallo la natura divina di potenze soprannaturali o dei loro rappresentanti in
terra, ovvero “lama” e maestri spirituali. Degna di menzione la caratteristica “Maschera Blu”, in origine
di colore bianco, calata sul volto di un interprete per rispetto del pubblico, all'inizio dell’esecuzione, ma
posta sul capo durante la danza per favorire i movimenti complementari all’azione. Cantori, oltre che
interpreti di parti recitate, gli attori assumono altresì funzioni sacerdotali, celebrando con canti corali le
loro guide spirituali ma anche le bellezze del creato. A concludere l’esibizione, l’interazione finale tra gli
attori, che ringraziano il pubblico personalmente, e gli spettatori o i rappresentanti delle istituzioni, che
omaggiano gli artisti con le “khata”, sciarpe bianche con valore beneaugurale.
6.2 In uso nelle rappresentazioni teatrali come in altre manifestazioni prettamente cultuali, le maschere
tibetane, non prive di affinità con quelle mongole, indiane e coreane, presentano come tratti comuni,
accanto a un’espressione solitamente feroce, una corona di serpenti o teschi intagliata sulla fronte e un
“terzo occhio”, a suggerire una natura surreale e superiore.
Oltre a rappresentare, difatti,
figure di
Buddha e Santi monaci delle varie generazioni, le maschere raffigurano per lo più spiriti delle due grandi
categorie “Yisiba” e “Jideba”, ossia ultraterreni e terreni. Ne è esempio, ritratto nella figura, il dio dei
morti Yama, accostabile al greco ade o all’egizio Horus, visto anche come “Spirito difensore della legge”.
Da notare, sul petto, la ruota del “Dharma”, simbolo cosmico in oro -sostituito altrove da uno specchio in
argento-, per invitare gli spettatori ad un’introspezione interiore, e, tra le mani, una mazza magica a
forma di scheletro di bambino e un “rapala”, ovvero una ciotola ricavata da un cranio.
Africa
7. Meritano infine un cenno, tanto da coglierne palesi affinità, le maschere in uso in Africa, dove, pure in
assenza di un vero e proprio teatro, non mancano – come nel continente oceanico- tuttora radicate
occasioni cultuali. Funzione primaria delle maschere -costruite con svariati materiali, dalla pelle alle
piume, dalla paglia alle ossa e alle conchiglie- la mimesi di defunti (solitamente antenati), di dei o
animali assurti a protettori della comunità58.
Maschera utilizzata nelle cerimonie magiche del popolo Fang, Gabon, XIX secolo
Precise simbologie si associano alle più frequenti raffigurazioni: linee spezzate rimandano al percorso
segnato degli antenati, difficile e tortuoso ma che conduce al successo; pattern a scacchiera alludono alla
contrapposizione dialettica fra i poli opposti della realtà (ad esempio, maschile-femminile, giorno-notte e
così di seguito); una linea spezzata rappresenta, tra i due solstizi, il percorso del sole. Credenze
58
Da precisare che non tutti i membri della società sono autorizzati a indossare maschere ma solo chi detiene un
ruolo di prestigio come i re e i capi. A questi ultimi sono, in particolare riservate le maschere di re defunti e di
divinità, da cui possano attingere la necessaria autorità.
fisiognomiche sembrano
qui
acquisire un
particolare valore:
occhi
socchiusi
rappresentano
l'autocontrollo, la pace interiore e la pazienza; occhi e bocca di dimensioni ridotte l'umiltà; la fronte
sporgente
esperienza e saggezza; maschere con mento e bocca molto grandi, al contrario, possono
rappresentare autorità e forza (per esempio in Gabon). E ancora, attributi di animali (soprattutto antilopi,
facoceri, coccodrilli) si rivestono di particolare significato: le corna, specie di antilope, sono simbolo
augurale di un prospero raccolto, le orecchie rimandano ai canti delle donne per alleviare lavori faticosi .
Canoni di bellezza femminile talora difformi ispirano, altrove, decorative stilizzazioni: i Panu del Gabon,
ad esempio, enfatizzano le ciglia arcuate, gli occhi a mandorla, il mento sottile, e rappresentano nelle
maschere anche i gioielli ornamentali, disposti in due linee curve ai lati del naso; i Baga della Guinea
rappresentano, in maschere femminili che indossano gli uomini, seni cadenti e cicatrici ornamentali , e se
compaiono anche lacrime o labbra screpolate vuol dire che la donna raffigurata appartiene ormai al
mondo dell’aldilà.
Maschera dell'etnia Mitsogo, Gabon
Un’ultima curiosità riguarda, infine, le maschere ricavate da un tronco cavo in Liberia e Sierra Leone,
indossate come elmi o scafandri, o che coprono non il volto ma il torso, come ad esempio nelle cerimonie
dei Makonde in Tanzania.