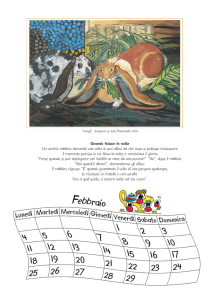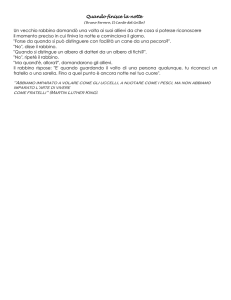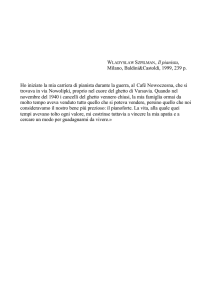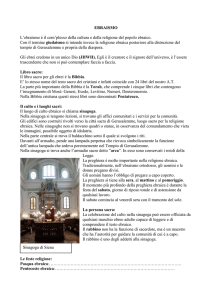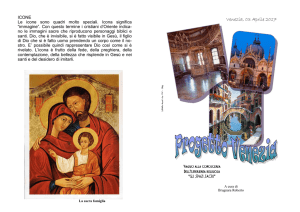1.
A nove anni sapevo già leggere e scrivere in italiano, un po’
meno in lingua ebraica ma poco o nulla sapevo del mondo. Le
preghiere le imparavo a memoria, che sin da allora era prodigiosa, in una lingua che non era quella parlata tutti i giorni e
che avevo appreso pochissimo dalle lezioni del rabbino in preparazione del mio bar-mitzvah, dunque il loro significato mi
arrivava per approssimazione, per concetti astratti; suoni come
mantra che però creavano un cammino verso Javhé. Non un
colloquio con Lui, ma una strada verso di Lui. Non c’era un
ritorno, il piccione non tornava indietro con un messaggio,
nessuna parola da Javhé che invece si serviva delle parole del
rabbino, concise ed oscure. Quel giorno correvo. Correvo per
le stradine fangose di Cèneda. Correvo scalzo, le braghe sdrucite, la camicia lisa smessa da mio padre che mi andava larga
e svolazzava al vento con i riccioli neri dei miei lunghi capelli
inanellati. Niente parrucca, a quell’età! Ma neanche più tardi, in giovinezza maturità e vecchiaia, non mi è mai piaciuta.
Corre il ragazzo ebreo e tiene con la mano ben ferma sulla
nuca la kippah perché non voli via con tutto ciò che ancora gli
resta dell’ebraismo, nella zucca e nella coscienza.
Era l’agosto del 1763. Cèneda era una gentile e vaga città
della Marca Trevigiana con una modesta Sinagoga e molto più
grandi e numerose Chiese, fra le quali un’antica Cattedrale.
Non c’era stata ancora la Rivoluzione Francese – qui da me
persino la Storia, quella con la maiuscola, è, alla pari delle sto9
rie, tutta presente e tutta insieme, qualunque cosa significhi,
che pacchia: un’occhiata e via: tutta la Storia nella testa, nella
memoria. Anche quella che per voi è futura: ma non credeteci
più di tanto, perché io sono sempre stato un gran bugiardo,
troppo ricco di immaginazione e di amore di sé, sempre voglioso di stupire il mio pubblico e ingannare il destino.
Correva il ragazzino, correva a gambe levate perché il padre Jrmeyahu lo inseguiva ansimante, ed urlava «Fermati!
Immanuel! Ti prego! Ci stanno aspettando!» – affiancato dagli
altri due figlioletti, Baruch e Anania, tutto sudato nel suo
corpetto di cuoio, egli che faceva di mestiere il cuoiaio, che
allora includeva anche quello del commerciante di pelli oltre
che dell’artigiano e se l’era conciato e tagliato e cucito con le
sue mani, insieme alle braghe di pelle di capra, aderenti alle
gambe corte e scheletriche, incapaci di competere con quelle
del figlio, lunghe e magre ma muscolose, adusate alle fughe,
ricoperte di lise brache d’una maglia di cotone tessuta in casa.
Correva Immanuel Conegliano per le strette calli e gli ombrosi
portici del ghetto. Correva a perdifiato ma all’angolo tra due
stradine ecco che una mano sbucata dall’arco pietroso d’una
porta lo afferra e lo trae dentro uno stanzone semibuio, la
Sinagoga. Il rabbino trattiene Immanuel ben stretto finché il
ragazzo smette di ansimare.
«Calmati – gli sussurra – qui sei al sicuro.»
Lo precede verso l’aròn, lo ferma al cospetto del tamid appeso davanti e gli intima:
«Prega.»
«Tu sei veramente il mio Re e il mio Signore, che ci doni
ogni salvezza. Tu hai salvato e dato vigore a Giacobbe...»
Cominciò Immanuel, in ebraico, oscillando con il corpo
avanti e indietro, le mani giunte sul ventre. E siccome le parole ebraiche le ripeteva a memoria ma non le capiva del tutto,
il rabbino per sicurezza, mentre ne correggeva la pronuncia,
10
gliele traduceva nel dialetto veneto, perché alla sua funzione
pedagogica non rinunciava mai. Ma nelle pause l’indignazione
lo sopraffaceva:
«Non è neanche un anno che hai avuto il tuo bar-mitzvah!
E ora vogliono farti diventare cristiano? Prega!»
«È nostro dovere lodare il Signore del tutto, acclamare la
grandezza dell’Uno che produce tutta la creazione, perché
Javhé non ci ha fatto come le altre nazioni, né come le altre
stirpi della terra. Javhé non ci ha posto nella stessa situazione
degli altri popoli, e il nostro destino è diverso da quello di tutti
gli altri.»
Immanuel era un ragazzino sveglio, intelligente, anche se
ignorante come una capra, perciò argomentava dentro di sé
che se il suo destino era diverso da quello di tutti gli altri forse il rabbino, se non Javhé, avrebbe potuto ancorarcelo ben
bene e salvarlo dalla prospettiva di cambiar religione. Avrebbe
dovuto lasciare lo studio dell’ebraico, la sua lingua madre, approfondito nei mesi precedenti al bar-mitzvah, e dedicarsi con
maggior impegno allo studio del latino, cominciato un paio
d’anni prima con una sorta di precettore ingaggiato dal padre, un figlio di contadini, forse ancora più ignorante del suo
allievo. Costui pretendeva di ficcargli la sintassi di Cicerone
nella zucca con le legnate; studio interrotto da Jrmeyahu con
altrettante legnate inferte al pedagogo e ripreso recentemente
con Don Pietro Bortoluzzi, un buon prete che lo istruiva per
prepararlo al Battesimo. Ma suo padre s’era intestardito a quel
passo, con tutta la famiglia, egli stesso, Jrmeyahu e i tre figli,
Immanuel, Baruch e Anania, per lasciare finalmente il ghetto,
oltre il cerchio del muro che lo chiudeva alla città. E soprattutto per un altro motivo, incoffessabile.
Jrmeyahu irrompe nella Sinagoga, trascinando con sé i pargoletti.
11
Mi càpita di passare dalla prima persona alla terza, come
dall’imperfetto, dal passato prossimo e da quello remoto al presente. Mi sfuggono le nozioni temporali e spaziali ed anche la
nozione di io e di lui. Parlo con l’io e parlo con l’egli indifferentemente. La narrazione segue le ellissi della memoria, in un
labirinto; vedo direttamente le scene della mia vita come in un
teatro; qualche volta dal palcoscenico, ed uso la prima persona, altre dalla platea, e passo alla terza. Ciascuna scena è una
tessera dell’intero mosaico e nello stesso tempo contiene l’immagine dell’insieme: ogni istante della vita è tutta la vita. Sono
io che racconto ciò che vedo ed è lui, anche, che racconta ciò
che ricorda. Me stesso, io, egli. E voi che leggete. Uno sforzo di
immaginazione e potrete vedere ciò che leggete, ciò che avviene
sul palcoscenico. Del resto, non sono stato, non sono, un uomo
di teatro? Le trame della mia vita avrei potuto scriverle io stesso,
e chissà che non l’abbia fatto! Le trame delle mie commedie
avrebbe potuto scriverle la mia vita, e certamente lo ha fatto.
Jrmeyahu irrompe nella Sinagoga. Senza una parola e con
modi assai spicci il cuoiaio afferra Immanuel e, aiutato dai due
fratellini, lo trascina via sotto la sguardo esterrefatto e furente
del rabbino, il cui volto, muto, esprime un’emozione tale da
levargli il respiro.
«No padre no, non voglio, non voglio...» – si difende
Immanuel ma Jrmeyahu gli toglie dalla nuca la kippah e mettendosela in tasca dice, con voce non sai se più autoritaria o
supplichevole:
«Obbedisci, è per il bene della famiglia.»
«No, è perché vuoi sposare quella goiah!»
Jrmeyahu gli dà uno scappellotto:
«Non goiah, non in ebraico! Scordatelo l’ebraico! Cristiana,
Cristiana, senti come suona meglio in italiano? Vuoi dirlo in
latino? Cristiana puella! Orsola è cristiana e se riesco a sposarla avrò una moglie e voi avrete una mamma!»
12
Ma Immanuel è un ragazzino caparbio. Sibila: «Tu avrai
una moglie, e basta!»
Eppure erano ormai parecchi mesi che Immanuel frequentava le lezioni di cristianesimo, in latino, del cancelliere vescovile della diocesi di Cèneda, Don Pietro Bortoluzzi. E con
profitto, se ricordo bene. Ricordo confermato del resto dalla
mia padronanza di quella lingua, che allora non era morta per
niente, che tuttora conservo, anche se ve ne risparmio l’uso. So
che nel vostro adesso nessuno lo parla più, il latino, nemmeno
i preti e tuttavia quella lingua divina non muore, non è morta, non morirà. Oh Dio, almeno credo. E mi appassionava, il
latino, lo studiavo con piacere, con golosità addirittura e mi
sembrava che fosse adatto alle parole del Cristo Gesù, anche se
Egli usava l’aramaico, sembra. Qui le lingue si confondono e si
fondono l’una con l’altra. Per narrare in italiano devo estrarre
questa lingua da tutte le altre. Non mi costa sforzo alcuno
perché per natura apprendo e domino facilmente le lingue.
Questa inclinazione mi facilitò i viaggi e le permanenze in nazioni diverse d’Europa e d’America; luoghi spesso frequentati
per pochi anni o addirittura pochi mesi e dove tuttavia riuscivo ad apprendere l’idioma dei loro abitanti, in pochi giorni, quel tanto che mi serviva per comunicare l’essenziale, e in
breve tutto il resto. In Europa, ma anche nelle Americhe, mi
servì di base la lingua latina, che le persone colte – quelle che
io per il mio mestiere e la mia condizione di abate frequentavo
– parlavano correttamente.
Dunque Immanuel studia il latino da un po’ di mesi e con
esso il catechismo cattolico, la vita di Gesù, i Vangeli, le preghiere, le regole. E tuttavia resta ancorato all’ebraismo della
sua prima infanzia, a quell’ebraismo semplice e quotidiano
trasmessogli da sua madre Sara Pincherle; insegnatogli dalla
madre dalla nascita all’età di cinque anni, quando lo lasciò
per volare in Paradiso – dico ora; ma allora non c’era ancora
il Paradiso nella mia visione di ragazzino ebreo; c’era tuttavia
13
un’altra vita, descritta meno compiutamente ma c’era. Più tardi
mi affascinerà Dante Alighieri, la cui Comedia ho ancora tutta
a memoria. Ora però Immanuel ben Jrmeyahu, ragazzo ebreo,
deve scegliere e neppure troppo liberamente. Dovevo considerare provvisorio quel tratto di vita, quei primi quattordici
anni. Mi si insinuò nella mente per la prima volta il concetto di
provvisorietà; capii, sia pure ancora confusamente, che nessuna
condizione umana può considerarsi stabile, definitiva. Ora so
che nemmeno la morte. Ma questa è un’altra questione, che
affronteremo più tardi. Dirò solo questo: solo un paranoico
nichilista considera definitiva la morte e ben gli stia.
14
2.
Mio padre mi trascinò sino a casa, nel ghetto. Non immaginatevi un luogo cupo, sporco e poverissimo. Pessima letteratura denigratoria antisemita. Il ghetto era un quartiere allegro. Gli Ebrei sono animali gioiosi, ballano e cantano ad ogni
occasione e cercano di non abbandonarsi mai allo sconforto,
neppure di fronte alla morte. La quale cercano di tenere in
ombra e della quale parlano pochissimo e alla quale dedicano
cerimonie brevi e sottotono. Non c’è popolo che ami la vita
e detesti la morte come quello ebraico. Questa antichissima
nazione, la sola convinta di essere stata chiamata sul palcoscenico della storia per realizzare i piani di Dio, è formata da
individui che amano la vita più di qualsiasi essere umano. Non
nel senso triviale della joie de vivre, ma come solenne celebrazione della vita. Sono convinti di essere eterni, mentre gli altri
popoli tremano di fronte alla prospettiva della loro prossima
estinzione. Non è la loro stessa vita individuale che gli Ebrei
considerano così deliziosa ma piuttosto l’idea di una vita, fondata su un Patto con Dio, che procede ininterrotta attraverso
le generazioni. La vita brulicava nel ghetto, specie a Cèneda,
dove l’imperio intelligente e magnanimo del Vescovo Lorenzo
Da Ponte aveva affrancato gli Ebrei da quella che era altrove
una condizione sottomessa, come conveniva a chi era accusato
di deicidio. Tuttavia il ghetto era circoscritto da un alto muro,
che lo separava, tranne che per alcuni varchi, dal resto della
città. E questo, se poteva essere considerato dai più ottimisti
un vantaggio – maggior sicurezza e protezione, maggior tutela
15
dell’identità ebraica – era certo in qualche misura oppressivo,
mortificante. La gente del ghetto era dunque di buon carattere, dedita al lavoro artigianale, ai piccoli traffici, alla gestione
dei prestiti, alla buona cucina, all’arte medica, alla cultura delle lettere e della tradizione. E, persino, alla cura del proprio
corpo, alla pulizia.
Nella tinozza piena d’acqua calda Immanuel, nudo come un
cerbiatto, lo avevano immerso sino al collo e lo stavano strigliando come un puledro ma a differenza di quello il ragazzo
non si ribellava, sembrava goderne. Aveva tempo per riflettere.
Intanto, ribellarsi era inutile quanto faticoso. La mani gentili
della goiah di suo padre lo strofinavano a dovere e su di lui
pendevano le ciocche dei suoi capelli biondi che la cuffia non
riusciva a trattenere del tutto. Bianche e affusolate e tuttavia
forti le sue dita penetravano tra i miei capelli e massaggiavano
la mia cute. Mio padre aveva già preso in casa la sedicenne
Orsola, sua promessa sposa. La governante della fanciulla, un
donnone cinquantenne sempre presente, garantiva che la verginità di Orsola sarebbe stata salvaguardata sino alle nozze. Le
stava sempre accanto e anche adesso la aiutava a lavarmi ben
bene.
La vestizione avvenne subito dopo. Per la prima volta mi
infilarono sulla nuda pelle un paio di mutande, una specie di
brache di cotone leggero, molto aderenti e lunghe al ginocchio, che dovevo portare sotto i calzoni nuovi. Questi, di seta,
a sottili bande argento-azzurre, erano chiusi da lacci sotto il
ginocchio.
«Te li manda il Vescovo e questa è la tua riconoscenza!» –
borbottava mio padre, anche se non ce n’era più motivo perché io accettavo che mi vestissero di quegli abiti lussuosi con
la stessa emozione che mi avevano dato poco prima i lavacri
delle mani di Orsola sulla mia pelle nuda. Calze lunghe di filo,
gialle; camicia di batista dal collo alto; camisiola di taffetas
neroazzurro ricamato con sete policrome sin lungo le mostre,
16
lungo l’orlo inferiore e sulle patte delle tasche, velada come i
calzoni ma ricamata nelle profilature con motivi di rami fioriti; e poi un jabot giallo come le calze, che Orsola mi allacciò al
collo con grazia. E commentò:
«Sembri un cavaliere!»
E si azzardò a farmi una carezza sulle spalle, come per far
aderire meglio la marsina.
Io me ne stavo zitto – della beffa delle calze gialle inflitta al povero Malfolio nulla ancora sapevo, né tanto meno di
Shakespeare – non volevo cedere troppo facilmente e troppo
in fretta. Mi guardavo addosso, senza tuttavia riuscire a farmi
un’immagine completa di me così agghindato. Allora Orsola
mi prese per mano e mi condusse nella sua camera: davanti
allo specchio incorniciato che troneggiava sulla toletta mi fermai allibito. Mi raggiunse mio padre e mi mise sulla testa il
tricorno.
Il ragazzo è bello, alto e snello, l’aria sveglia.
Mi specchiavo, immobile. Mi guardavo e con la mano rassettai le pieghe del vestito. Un gesto automatico.
17