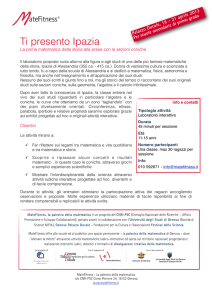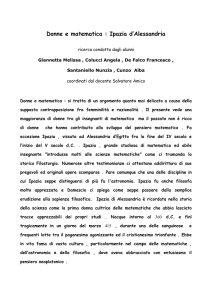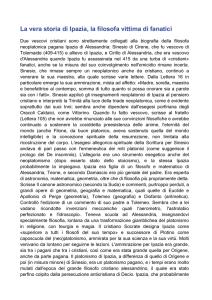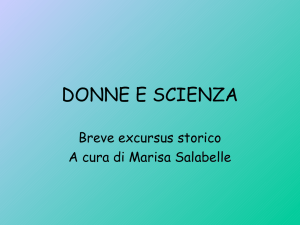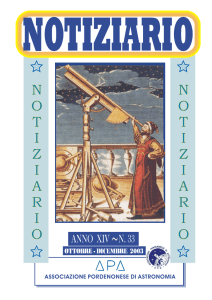Ipazia di
Alessandria:
la donna e il cielo
di Claudia Baracchi
Entrai a Ipazia un mattino, un giardino di magnolie si specchiava su lagune azzurre, io andavo tra le siepi sicuro di scoprire belle e giovani dame fare il bagno: ma in fondo all’acqua
i granchi mordevano gli occhi delle suicide con la pietra legata al collo e i capelli verdi
d’alghe.
(Italo Calvino, Le città invisibili)
Questa primavera si è tornato a parlare molto di Ipazia di Alessandria, in
occasione dell’attesa (e contrastata) uscita del film di Alejandro Amenábar,
Agorà. Come il film è arrivato nelle sale italiane, l’attenzione si è prontamente spostata altrove. Ma vorrei prendere questa circostanza a pretesto
per una breve riflessione.
A Milano per la presentazione, Amenábar ha detto di aver ricevuto l’impulso
iniziale per questo lavoro nel corso di un viaggio in barca: l’esperienza della
nuda esposizione al cielo stellato aveva lasciato un’eco profonda in lui. Aveva
così cominciato a maturare l’idea di un film sull’astronomia e a fare ricerche
su studiosi di varie epoche: Keplero, Galileo, Newton…. La scoperta di un
solo nome femminile, quello di Ipazia di Alessandria, lo stimolò a “rappresentare la scienza attraverso una donna”: attraverso una vita di donna, di
questa donna che fu astronoma, matematica e filosofa neoplatonica nella
tarda antichità.
In che modo, dunque, l’esperienza di una donna inflette e intepreta la scienza? Come visse, Ipazia, la ricerca che diciamo scientifica? Come operò
nella scienza, da donna di scienza, e da filosofa?
*
Se della vita e dell’insegnamento di Ipazia sappiamo poco, la sua morte è
sovrastante. Fu vittima di un estremo ostracismo perpetrato dai cristiani nel
marzo del 415. Socrate Scolastico, suo contemporaneo, scrive nella Historia Ecclesiastica che “la ero fuori dalla sua carrozza e la portarono nella chiesa chiamata Caesareum, dove la spogliarono completamente e poi
l’assassinarono con dei cocci. Dopo avere fatto il suo corpo a pezzi, portarono i lembi strappati in un luogo chiamato Cinaron, e là li bruciarono….
Questo accadde nel mese di marzo durante la quaresima, nel quarto anno
dell’episcopato di Cirillo, sotto il decimo consolato di Onorio ed il sesto di
Teodosio.” Damascio aggiunge che “le cavarono gli occhi, mentre ancora
respirava un poco.”
Dal secolo dei Lumi, e secondo molteplici varianti, Ipazia è divenuta simbolo della lotta del libero pensierocontro l’oscurantismo dell’istituzione religiosa. Malgrado sia stato notato, per esempio da Mariateresa Fumagalli su
L’Unità (13 aprile 2010), che “le cose erano un po’ più complicate di quel
che appare nell’immagine convenzionale di Ipazia martire predestinata,”
tale semplificazione, nellasua apparente e seducente ovvietà, ha dominato
anche le recenti discussioni.
Colpisce in particolare l’insistenza su Ipazia come scienziata e paladina della ragione. La dimensione propriamente filosofica del suo lavoro e della sua
formazione viene oscurata a favore di un’esaltazione del razionalismo scientifico di cui Ipazia sarebbe stata tra i primi rappresentanti. Ipazia offre pertanto occasione per la riduzione della ragione a scienza e l’obliterazione della
filosofia nel suo più ampio respiro (penso alle sue dimensioni aporetiche, alle
cure etico-politiche, al pathos della ricerca, alle aspirazioni contemplative).
Come se la scienza fosse massima espressione e sintesi ultima delle potenzialità del pensiero, e non una delle sue modalità. Come se, dall’antichità ad
oggi, assistessimo al lineare e progressivo sviluppo della scienza, implicitamente intesa come categoria trans-storica, vale a dire sempre già moderna.
Come se potessimo astrarre la scienza moderna dal suo orizzonte genetico e
proiettarla come costante atemporale.
Così, già nel 1999, l’esemplare Piergiorgio Odifreddi scriveva: “Ipazia viene
ricordata come la prima matematica della storia: l’analogo di Saffo per la
poesia, o Aspasia per la filosofia. Anzi, fu la sola matematica per più di un
millennio: per trovarne altre, da Maria Agnesi a Sophie Germain, bisognerà
attendere il Settecento” (“Santa Ipazia, matematica e martire,” in Tuttolibri
de La Stampa, 21 agosto).Salvo poi precisare, in un recente dibattito (Repubblica TV, 12 aprile 2010) e per dovere di “matematico e razionalista,”
che questa “proto-martire della ragione” non fu “una grande matematica,
una grande scienziata,” e che si è “costruito” su di lei “un mito.” La risposta
di Stefano Puglisi (Cronache laiche, 14 aprile 2010) a tale valutazione risulta
sia comprensibile che sorprendente: lamenta l’infondatezza del drastico ridimensionamento dell’alessandrina da parte di Odifreddi (“Ipazia di Alessandria uccisa due volte”), mentre di quest’ultimo tacitamente sottoscrive
i presupposti teorici. Vale a dire: non mette in discussione per un istante la
caratterizzazione di Ipazia come scienziata e razionalista, e anzi ribadisce
che ella fu tra coloro che “si sono battuti per gli stessi valori ed ideali nei
quali un laicista come Odifreddi si dovrebbe riconoscere appieno.”
Sulla stessa falsariga Adriano Petta (Alias, 10 aprile 2010), riferendosi
all’ascesa della cristianità al potere politico tra IV e V secolo, e alle efferatezze che l’accompagnarono, richiama al compito di raccontare “senza alcuna
pietà la storia di coloro che hanno depredato l’umanità di almeno 1200 anni
di progresso.” E d’altronde, già nella prefazione al libro di Petta e Colavito
(Ipazia. Vita e sogni di una scienziata del IV secolo, 2009), Margherita Hack
si era conformemente pronunciata: “Ipazia rappresenta il simbolo dell’amore
per la verità, per la ragione, per la scienza, che aveva fatta grande la civiltà
ellenica. Con il suo sacrificio comincia quel lungo periodo oscuro in cui il
fondamentalismo religioso tenta di soffocare la ragione.” Di “lotta per la ragione” scrive egualmente Alberto Crespi su L’Unità(23 aprile), ma l’elenco
potrebbe continuare, ribadendo l’opposizione schematica (invero caricaturale) tra chiesa e scienza, fede e ragione, forze regressive e progressive—o
perfino spiritualità e materialismo.
Tanto che Vito Mancuso (per la verità attenendosi all’analisi del film di
Amenábar), sente di dover replicare difensivamente: per tutelare “le religioni” dai facili attacchi, ricorda che non sono esse sole ad essere portatrici
di violenza e intolleranza: “Ipazia, filosofa e matematica, ad Alessandria nel
415; Florenskij, teologo e matematico, a Leningrado nel 1937: la prima uccisa
dall’intolleranza dogmatica della religione, il secondo ucciso dall’intolleranza
dogmatica dell’antireligione” (La Repubblica, 24 aprile 2010).
Non mi pronuncio qui sull’efficacia di tale “difesa.” Ma certo il martirologio
comparato di Mancuso mette in luce la povertà e illusorietà delle opposizioni in generale. Rivela che gli opposti sono parimenti forme di fondamentalismo; che il fondamentalismo è dogmatismo, e questo non è prerogativa
esclusiva delle religioni; che ogni fondamentalismo segue la stessa logica
e produce così i propri santi e martiri. Il fatto stesso di parlare di martiri e
vittime sacrificali tradisce il rimando, cosciente o latente che sia, alla testimonianza di verità dogmatiche. E poco importa se i dogmata siano rivelati
piuttosto che ateisticamente dimostrati, cioè frutto della fede in una scienza
una, oggettiva e progressiva, non meno escatologica nel suo slancio e teologica nei presupposti (onto-teologia, diagnosticava Heidegger).
Posso qui solo notare, in margine, che anche l’intervento di Nicla Vassallo
(L’Unità, 25 aprile 2010) riposa sullo stesso assunto: sulla fede ingenua (non
esaminata, spesso incosciente) in una razionalità illuminativa, autofondata,
unica, emancipata da vincoli di natura storica quanto corporea. Vassallo si
appella all’androginia della ragione (“l’onesta razionalità androgina della filosofascienziata” Ipazia), al fine di proteggere la parità intellettuale femminile
e di “mettere a tacere con onestà intellettuale ogni teoria della differenza
sessuale e ogni nocivo dualismo cui la differenza si presta.” Come dire: la
razionalità è una, e le sue operazioni sono assolutamente separate dal corpo,
dalla vita e dall’esperienza in cui accadono. E così si afferma l’eguaglianza
tra donne e uomini nel modo più violentemente sbrigativo: confondendo
l’eguaglianza nei diritti e nella dignità con l’identità, l’indifferenziazione.
Così per ovviare al pericolo di vedere la differenza sessuale distorta e la
duplicità ridotta a dualismo, si ricorre alla drastica misura dell’eliminazione
della differenza. Come dire, la differenza è vulnerabile, sempre esposta a interpretazioni svilenti e strumentali: liberiamocene, semplifichiamo. (Come
se, tra l’altro, fosse possibile.)
E si fonda così, nell’androginia in-differente e difensiva della ragione,
quell’altro dualismo che da secoli ci domina, operando una frattura profonda
in noi: quello tra mente e corpo. Va sottolineato: la soppressione della differenza è sempre anche l’annuncio di una soppressione, non necessariamente
solo simbolica, del corpo.
Non sto qui a soffermarmi sull’attacco di Vassallo alle “filosofe della differenza sessuale,” presentate come concordi “con la Chiesa cattolica.” Ci porterebbe lontano. Mi limito a rilevare ciò che è evidente: quando Vassallo si
appella all’androginia, sicuramente non ha in mente la conjunctioalchemica,
indice di una raggiunta completezza psichica, di uno sposalizio dei sessi ed
equilibrio delle forze in cui si annunciava una perfezione umana alle soglie
dell’angelico. No, androginia per l’autrice significa indifferenza e irrilevanza
dei corpi e delle storie nell’esercizio del pensare: il mito della neutralità. Significa l’astrazione della ragione una e unica, che assicura che, indipendentemente da differenti vicende individuali, storiche, filogenetiche, antropologiche e morfologiche, uomini e donne pensano ugualmente, pensano uguale, pensano lo stesso. È per questo, credo, che l’autrice celebra Ipazia come
“una donna ‘contro natura,’” cioè, una donna che, malgrado la natura (corpo
di donna), fu intellettualmente non differente da un uomo. O addirittura fu
intellettualmente uomo. (Poiché è vano il tentativo: l’androginia non può
essere neutralità, se “lo stesso” che uomini e donne penserebbero “ugualmente” si identifica di fatto con ciò che è emerso nel corso e discorso di una
storia che neutra non è, né androgina, ma essenzialmente di uomini.)
Non dico sia semplice; il percorso è disseminato di rischi e imboscate, si può
sempre ricadere in facili semplificazioni, o perfino prestarsi al surrettizio
riemergere di gerarchie e discriminazioni: ma pensare la differenza, anche
quella sessuale, che pure ci si impone perentoria, mi pare compito ineludibile. Ineludibile e degno, anche politicamente. Poiché di quale ausilio può
essere ignorare ideologicamente la differenza, le differenze, monodicamente insistendo su ciò che ci accomuna? Non è altrettanto urgente riconoscere
ciò che ci separa, lavorare sulla nostra capacità di riconoscere l’irriducibilità
dell’altro, l’impossibilità di chiudere il cerchio, l’ineluttabilità dell’apertura
e della molteplicità, e imparare a sostenere la complessità, in noi e intorno a
noi? Forse la possibilità della comunità passa crucialmente attraverso questo
esercizio.
*
Ma torniamo a Ipazia. Ipazia era una santa del laicismo? Una fondamentalista del razionalismo, caduta nella lotta emancipativa contro la buia minaccia
del cristianesimo? O, ancora, una scienziata contro natura che, come avrebbero fatto poi gli scienziati moderni (uomini e cartesiani), si opponeva alla
natura per farne il proprio oggetto e carpirne il segreto?
E la scienza stessa—la scienza è una? Anaffettiva, astratta, emancipata dal
corpo e dal suo tempo? E se, invece, molteplici fossero le vie conoscitive,
irriducibilmente declinate secondo contesto e sensibilità?
Mariateresa Fumagalli nota che varie furono le convergenze tra neoplato-
nis�������������������������������������������������������������������������
mo e cristianesimo, al punto che quest’ultimo è stato più volte interpretato come una sorta di platonismo (“per il popolo,” diceva Nietzsche). Non
si può quindi ridurre la relazione tra cristianesimo e filosofia neoplatonica
ad antagonismo, e tanto meno all’opposizione tra teismo ed ateismo. Nella
meditazione platonica, e ancora tramite Plotino, la dimensione scientificodimostrativa e quella propriamente teologica sono inscindibili, sebbene discernibili. Il lavoro della ragione si articola nel rigore che gli è proprio, ma non
basta a se stesso; il suo movimento ha luogo in un orizzonte che lo eccede e
resta misterioso, come eccessivamente misteriosi (nel senso di indimostrabili) restano i princìpi primi ed ultimi. La prospettiva di una razionalità atea ed
autonoma è frutto squisitamente recente, e pertanto anacronistico in questo
contesto. E il senso del divino, articolato sia tramite la riflessione sul bene
sia nella contemplazione del cosmo-natura, acquista unità solo trascendendo
un paganesimo figurativo e antropomorfo, e rasentando l’intraducibilità in
sistema, l’ineffabilità, il silenzio. Così si configura la dimensione sorgiva della
filosofia.
È pertanto difficile, o perfino inappropriato, insensato, cercare una collocazione di Ipazia sui fronti opposti di fede e ragione. Anche lei, dice Gabriella Caramore (Adista, 1 maggio 2010) fu profeta, ma lo fu nel modo
della filosofia: “Ipazia non ha divinità da ascoltare. Parla a nome di se stessa.
Nessun dio le appare immune dagli attributi di idolo che l’essere umano gli
conferisce. E tuttavia anche Ipazia è in ascolto di una voce che le impone di
dire la verità, di fare verità, e di esprimersi in piena e totale libertà.” Dunque
fu profeta, parlò “con franchezza, in amore di verità” (la parrhesiaricordata
da Socrate Scolastico), ma non fu fanatica della ragione perché dubitava, e
instancabilmente sperimentava, cercava. Questo il film di Amenábar mostra
bene. E si deduce anche dal coinvolgimento pratico che caratterizzò il suo
neoplatonismo. In esso convergevano studi geometrico-matematici e tensione etico-politica, e ciò lo distinse dal neoplatonismo di matrice retoricoumanistica, più astratto e argomentativo (si pensi per esempio ad Isidoro,
maestro di Damascio). Più in generale, il precario equilibrio tra geometria e
vita distinse il neoplatonismo alessandrino tanto da quello magico-teurgico
(Giamblico) che da quello anti-cristiano e militante di Atene.
Ipazia fu dunque profeta. Al contempo, ancora nelle parole di Caramore,
ella fu “figura del dubbio, della perplessità, della ricerca,” ma in un’epoca
in cui dubitare era sommamente pericoloso, perché occorrevano “opzioni
certe,” scelte di campo: occorreva sapere “con chi e contro chi combattere.”
In questo senso, Ipazia non fu martire. Così come non lo fu Socrate. I loro
percorsi indicano una ricerca in cui il logos non assurge a nuovo dio, un
amore della verità che non prende la forma dell’acquisizione e del possesso
certo: un amore esposto, indifeso, appeso ad un filo che è facile spezzare. A
maggior ragione se ad amare così è una donna.
Dicono che Ipazia insegnasse il platonismo delle origini: Platone, Plotino,
Porfirio. Ma Suida (le fonti sono Esichio e Damascio) riporta che commentava anche Aristotele, e che offriva i suoi insegnamenti in pubblico. E
mentre è vero che scarsa è la documentazione pervenutaci sulla natura del
suo insegnamento, è lecito pensare che le opere di Sinesio, suo allievo e
corrispondente per tutta la vita, ci trasmettano un riflesso del pensiero della
maestra “veneratissima.” È su questa base che Gemma Beretta (Ipazia di
Alessandria, 1993) sottolinea, nella filosofia di Ipazia, l’essenziale unità di
studi fisico-matematici e interrogazione del divino. Secondo Beretta, Ipazia “non si mosse alla ricerca dell’essere e del divino attraverso un discorso
retorico-dimostrativo che costruisce il vero facendo a meno dei fenomeni e
dell’esperienza.” Proprio come in Platone, lo sguardo si rivolge al cielo non
per trascendere la condizione terrena, ma per trovare di essa lo specchio immenso; non per investigare i fenomeni celesti in uno studio fine a se stesso,
ma per gioire della bellezza degli ornamenti di luce; per cogliere nelle scansioni armoniose delle sfere non solo la divinità, ma la radice del giusto (com)
portamento in questa vita, su questa terra.
Come in Platone, il cielo è matematica visibile, musica inudibile, divinità che
appare e forma del nostro vivere. E come in Aristotele la contemplazione
che è detta sophia si eleva al di là della materia quotidiana senza per questo
trascendere il sensibile: il cielo, corpo manifesto del divino, è ancora fenomeno—fenomeno di massimo splendore e unico accesso al dio. (Nell’Egitto
tolemaico, Serapide è la divinità che si ammanta del cielo.) Nel testo giovanile De dono astrolabii, scrive Sinesio: “’astronomia è di per se stessa una scienza di alta dignità, ma può forse servire da ascesa a qualcosa di più alto, da
tramite opportuno, a mio avviso, verso l’ineffabile teologia, giacché il beato
corpo del cielo ha sotto di sé la materia e il suo moto sembra essere ai sommi
filosofi un’imitazione dell’intelletto. Essa procede alle sue dimostrazioni in
maniera indiscutibile e si serve della geometria e dell’aritmetica, che non
sarebbe disdicevole chiamare diritto canone di verità.” Invero, come ribadito due volte nelle epistole, “la geometria è cosa sacra.”
La scienza fisica, la matematica, la teologia e l’indicazione etica si intrecciano indissolubilmente in questa ricerca filosofica. E fino nelle scienze uranie,
apparentemente remote dalle umane cure, si coglie la valenza politica, si
trasmette la filosofia come “stile di vita, una costante, religiosa e disciplinata
ricerca della verità” (così Bregman, Synesius of Cyrene: Philosopher Bishop,
1982). Quindi Ipazia, astronoma e matematica, fu maestra (“veneratissima”)
di vita; secondo questa esperienza la scienza fu modo di vita; l’astronomia/astrologia fu ad un tempo contemplazione estetica ed etica, indagine condotta
con strumenti matematici , e occasione di un contatto con il divino che segna
i limiti del dicibile, diventando gesto.
Per questo, notiamolo solo di passaggio, non è di grande aiuto parlare, come
fanno tanti (non da ultima Silvia Ronchey), di un certo “irrazionalismo” del
neoplatonismo. Cioè non è d’aiuto passare, sempre secondo la logica degli
opposti, da un’enfasi razionalistica alla sottolineatura delle dimensioni non
riconducibili alla ricerca scientifica stricto sensu. Né si prova illuminante (è,
anzi, ingannevole) il costrutto di una dicotomia tra le scienze fisico-matematiche e propriamente razionali, da un lato, e dall’altro le derive mistiche delle
dottrine esoteriche—delle quali le scienze essoteriche sarebbero state semplicemente la dissimulazione istituzionale, di facciata. Nella figura di Ipazia
non ci troviamo di fronte alla dualità male integrata di matematica/scienziata
in pubblico e sacerdotessa di riti occulti in segreto. Ci troviamo bensì di
fronte a un senso diverso della filosofia, e quindi della ricerca scientifica che
in seno ad essa si sviluppa.
Ancor meno ci pare cogente supporre che, proprio per il loro “irrazionalismo,” certe comunità pitagoriche e platoniche attraessero a vario titolo
donne al loro interno. Sarebbe più sobrio attribuire la presenza femminile
in questi contesti al nudo fatto che le scuole di matrice pitagorica e platonica
contemplavano programmaticamente l’insegnamento alle donne. Questo è
originariamente inscritto nella struttura profonda dei testi di Platone, oltre
che nelle esplicite dichiarazioni. Basti pensare, per esempio, alla traiettoria complessiva di Repubblicae Timeo—in bilico tra il discorso quasi (sebbene mai compiutamente) iconoclastico sul bene, grande padre invisibile di
tutto il visibile, e l’immagine della grande madre al limite del dicibile: assisa
al centro del cosmo, Necessità enigmaticamente ne regge il divenire dalle
sfere celesti fino alle vicende terrestri, tramite le divinità (sue figlie) che tessono i destini.
Non si tratta dunque di razionalismo e irrazionalismo, ma di un pensiero più
antico di questa opposizione, nel senso che la precede ed eccede. Si tratta di
un pensiero che comporta un esercizio della ragione né mitigato né menomato, ma compreso in un mistero inesausto, intraducibile in dottrina. In
un tale equilibrio tra il bene e la necessità, tra indicibile e inimmaginabile,
armonia strana e difficile, duplicità dei princìpi e irriducibilità a uno—in tale
improbabile equilibrio si svolge un pensiero che è anche un vivere, un sentire, per il quale servirebbero categorie nuove e riletture radicali della storia.
In questa luce il misticismo non è deriva, ma esperienza squisitamente filosofica dei limiti del logos.
*
Un epigramma attribuito a Pallada di Alessandria si chiude celebrando Ipazia come “astro incontaminato.” È però nel terzo verso che, più rigorosamente, riconosce il legame di lei con il cielo, ma a partire dalla terra: Ipazia
è colei che volge “al cielo” tramite le proprie “azioni” (pragmata); che collega terra e cielo, il cielo e questo corpo vulnerabile. Ipazia fu mortale e fu
donna, e come donna si eclissò.
Non fu soltanto uccisa: il suo corpo fu oggetto di una volontà di azzeramento. Per annientare la sua straordinaria sapienza, la sua capacità di guardare lontano e intessere legami, di sentire l’intimità con la volta celeste ed
ancorarsi ad essa, fu accecata. Per cancellare ogni traccia del corpo che
si rapportava all’infinito, fu dilaniata. E ancora, non fu soltanto uccisa: fu
“uccisa due volte”—prima da credenti galvanizzati dalle circostanze epocali
mutate a loro favore, e poi dalla scienza moderna, dalla storiografia non
meno credente che l’ha voluta martire di ancora un altro dio (il dio logosa
cui si richiama anche Freud, prorio nella sua polemica anti-religiosa). Comune a entrambi gli dèi: il corpo visto con sospetto, repulsione, ansia di controllo: castigato o vivisezionato, represso o esorcizzato, dimenticato o ridotto
a macchina, ad oggetto; specialmente il corpo inquietante di donna, così
prossimo all’animale. È forse da qui, da questa complicità tra gli opposti,
che si potrebbe ripartire per pensare (sentire) il corpo—problema grave ed
urgente, in questi tempi disorientati.
1. E nell’eclissi della donna già in atto da tempo al tempo di Ipazia, e che
in seguito si approfondì ancor più, tra resti di statue di dee decapitate e
teste sfregiate, ci chiediamo come salvare qualcosa dei suoi frammenti,
le ceneri rarefatte di donna fatta a pezzi. Ci chiediamo che cosa fu obliterato in quello smembramento, in quali altri modi la scienza si sarebbe
potuta sviluppare, secondo quali ragioni, quali altre potenzialità della
ragione, quale tenerezza nel pensiero. Immaginiamo, se mai fu, la possibilità di una scienza a venire che non si risolva in calcolo, quantificazione, previsione, e soprattutto che non si contrapponga allo slancio
verso l’indicibile e non tema il silenzio; la possibilità di una fede legata
al sentire, alla sensibilità; di un esercizio della ragione che non sia farneticazione razionalistica, che non si fondi sulla separazione e sopraffazione del corpo—di uomo, di donna, uguale e differente.Il rapporto
di reciproco riconoscimento è il luogo storico del dono. La Trinità è il
luogo metastorico del dono.
2. L’analisi del luogo storico del dono è fenomenologicamente eseguibile.
L’analisi del suo luogo metastorico è una faccenda teologica. Si possono
tuttavia costruire delle significative analogie.
3. Derrida presenta una riduzione trascendentalistica del donare (donare
il tempo). Marion presenta una riduzione fenomenologica del dono.
Entrambe le riduzioni abbisognano di un prolungamento metafisico :
tendenzialmente rifiutato da Derrida, tendenzialmente proposto da
Marion.
4. Il prolungamento metafisico nasce dalla analisi del donarsi. Chi si dona
si sdoppia. Non si può essere nello stesso senso e sotto lo stesso rispetto dono e donante, come non si può essere nel contempo movente e
mosso.
5. La polemica di Marion contro la causalità è equivoca. La causalità è
vista in modo efficiente e per giunta come causalità fisica (cioè poi meccanicistica).
6. La polemica contro la “rappresentazione”, di ascendenza heideggeriana, riduce la presenza alla sua forma “neutra”, scambiando l’apparire
con una certa forma d’apparire: quella che si relaziona all’oggetto al
modo del dominio.
7. L’apparire in quanto tale precede i modi di apparire, cioè le molte forme di relazione intenzionale e le possibilita. L’apparire non è oltre le
molte forme di apparire, ma esiste nelle forme d’apparire, una delle
quali è insieme una e insieme fondamento delle molte : il puro e semplice apparire.