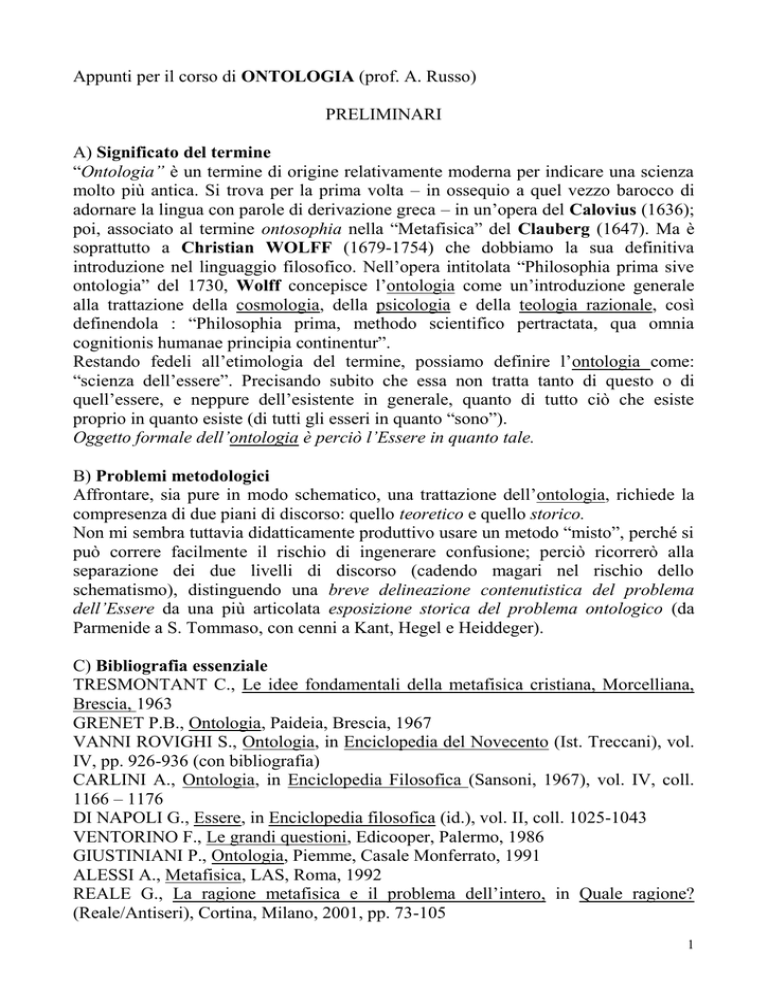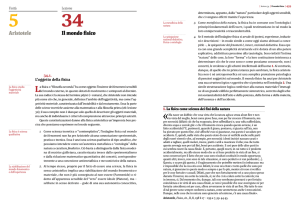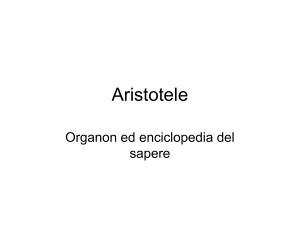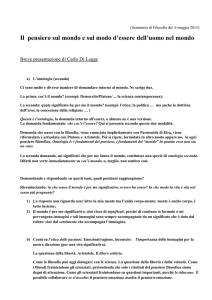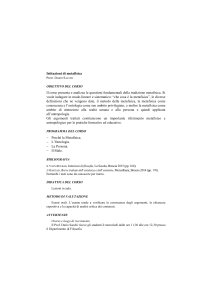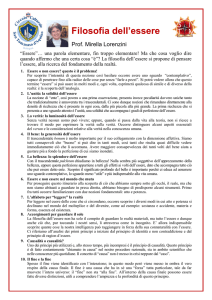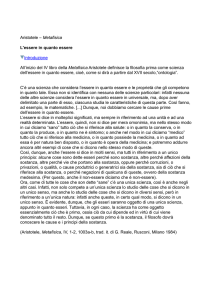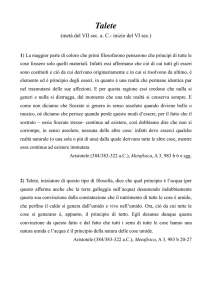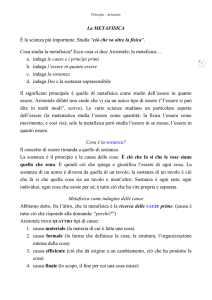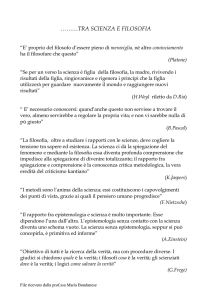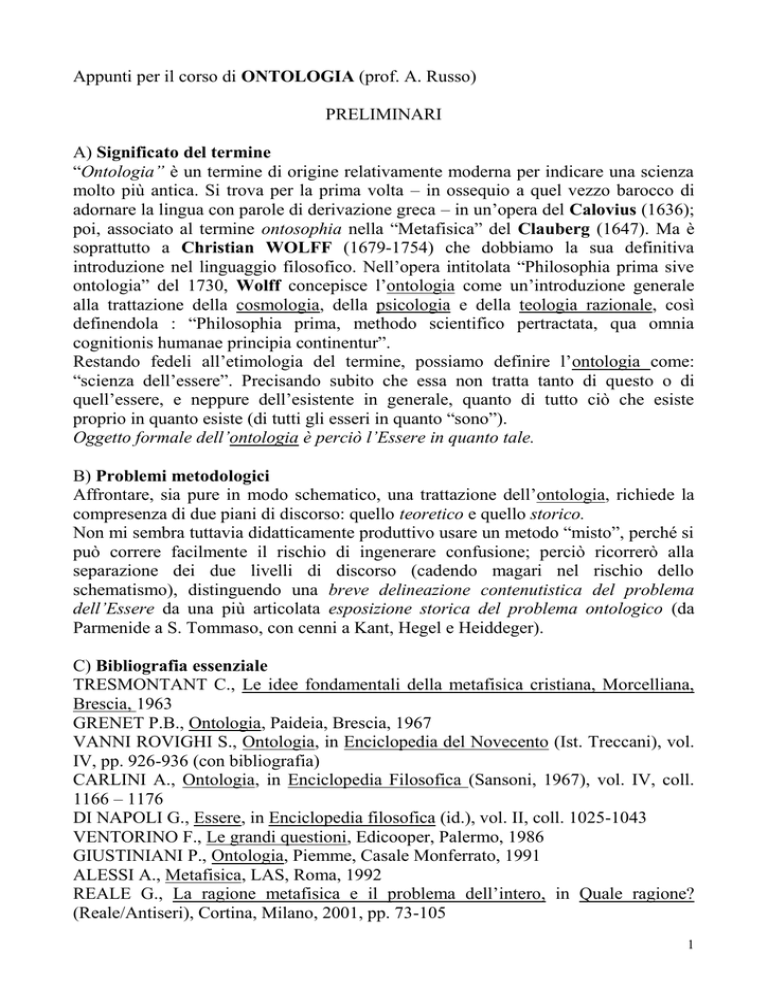
Appunti per il corso di ONTOLOGIA (prof. A. Russo)
PRELIMINARI
A) Significato del termine
“Ontologia” è un termine di origine relativamente moderna per indicare una scienza
molto più antica. Si trova per la prima volta – in ossequio a quel vezzo barocco di
adornare la lingua con parole di derivazione greca – in un’opera del Calovius (1636);
poi, associato al termine ontosophia nella “Metafisica” del Clauberg (1647). Ma è
soprattutto a Christian WOLFF (1679-1754) che dobbiamo la sua definitiva
introduzione nel linguaggio filosofico. Nell’opera intitolata “Philosophia prima sive
ontologia” del 1730, Wolff concepisce l’ontologia come un’introduzione generale
alla trattazione della cosmologia, della psicologia e della teologia razionale, così
definendola : “Philosophia prima, methodo scientifico pertractata, qua omnia
cognitionis humanae principia continentur”.
Restando fedeli all’etimologia del termine, possiamo definire l’ontologia come:
“scienza dell’essere”. Precisando subito che essa non tratta tanto di questo o di
quell’essere, e neppure dell’esistente in generale, quanto di tutto ciò che esiste
proprio in quanto esiste (di tutti gli esseri in quanto “sono”).
Oggetto formale dell’ontologia è perciò l’Essere in quanto tale.
B) Problemi metodologici
Affrontare, sia pure in modo schematico, una trattazione dell’ontologia, richiede la
compresenza di due piani di discorso: quello teoretico e quello storico.
Non mi sembra tuttavia didatticamente produttivo usare un metodo “misto”, perché si
può correre facilmente il rischio di ingenerare confusione; perciò ricorrerò alla
separazione dei due livelli di discorso (cadendo magari nel rischio dello
schematismo), distinguendo una breve delineazione contenutistica del problema
dell’Essere da una più articolata esposizione storica del problema ontologico (da
Parmenide a S. Tommaso, con cenni a Kant, Hegel e Heiddeger).
C) Bibliografia essenziale
TRESMONTANT C., Le idee fondamentali della metafisica cristiana, Morcelliana,
Brescia, 1963
GRENET P.B., Ontologia, Paideia, Brescia, 1967
VANNI ROVIGHI S., Ontologia, in Enciclopedia del Novecento (Ist. Treccani), vol.
IV, pp. 926-936 (con bibliografia)
CARLINI A., Ontologia, in Enciclopedia Filosofica (Sansoni, 1967), vol. IV, coll.
1166 – 1176
DI NAPOLI G., Essere, in Enciclopedia filosofica (id.), vol. II, coll. 1025-1043
VENTORINO F., Le grandi questioni, Edicooper, Palermo, 1986
GIUSTINIANI P., Ontologia, Piemme, Casale Monferrato, 1991
ALESSI A., Metafisica, LAS, Roma, 1992
REALE G., La ragione metafisica e il problema dell’intero, in Quale ragione?
(Reale/Antiseri), Cortina, Milano, 2001, pp. 73-105
1
PARTE PRIMA
L’Essere come oggetto formale dell’ontologia
L’ontologia in quanto scienza o dottrina dell’ESSERE coincide con la philosophia
prima di Aristotele, quella che fu poi chiamata METAFISICA.
In realtà l’ ontologia è solo la prima parte della Metafisica, e cioè “la dottrina
dell’ente come tale e di tutto ciò che gli appartiene essenzialmente ed
immediatamente”. La metafisica aristotelica, come è noto, sfocia infatti in una
teologia naturale, cioè in una indagine su “Dio e la sostanza soprasensibile”, in una
dottrina dell’Essere supremo ed increato.
Per Aristotele (e così pure per gli Scolastici) Ontologia e Teologia costituiscono
un’unica scienza: il problema di Dio non è altro che il problema della perfezione di
quell’essere che la nostra ragione è in grado di cogliere autonomamente con la
propria riflessione.
Si potrebbe anche dire che la teologia non fa altro che esplicitare e tematizzare il
problema di Dio come sostanza assoluta soprasensibile che è implicitamente
contenuto nelle idee di essere, di ente e di sostanza guadagnate con la riflessione
ontologica.
Va sottolineato però quanto è avvenuto nella riflessione filosofica a partire dalla
seconda metà del Seicento: la solidale connessione tra ontologia e teologia è venuta
via via allentandosi (e proprio in quel WOLFF che, per primo, ha trasformato
l’ontologia in una scienza autonoma va rintracciata l’originaria responsabilità di tale
distacco), indebolendo in modo irreparabile la profonda unità di tutta la conoscenza
metafisica. Su questa incrinatura è venuto ad innestarsi il criticismo kantiano, che ha
finito per rifiutarle entrambe: l’ontologia, dichiarando inconoscibile l’Essere e
ponendo come termine di riferimento ultimo la Coscienza, e la teologia, mostrando
l’infondatezza razionale di qualunque prova dell’esistenza di Dio e chiudendosi in
una posizione agnostica. Con il kantismo, la strada verso ogni possibile
giustificazione razionale della metafisica appare definitivamente sbarrata.
Ma su tutto ciò si tornerà in sede di discorso storico.
La nozione di essere
Nel bagaglio di idee, nozioni ed esperienze che costituiscono il nostro “vissuto” di
coscienza, l’ idea di essere ha un posto specialissimo. Prendiamo spunto da questo
pensiero di GRENET (op. cit. pp. 179-180):
“Né parola definitiva su tutto (per es. Parmenide), né balbettio senza valore (per es.
Positivismo), essa (cioè: l’idea di essere) ci appare come l’ ATTO FONDAMENTALE
CON IL QUALE IL NOSTRO SPIRITO SI METTE IN PRESENZA DI TUTTO IL
REALE, DATO O NO”.
Esplicitiamo le importanti affermazioni implicate in questa definizione.
2
Intanto la “nozione di essere” non è una scienza assoluta e
onnicomprensiva, ma neppure una parola senza significato che mette capo a
qualcosa di indefinibile: essa è il frutto di un atto globale che risulta dal
mettersi in gioco di tutta la nostra personalità (quindi non solo l’intelletto)
nella sfida di comprensione della realtà, nel tentativo di dar ragione ultima a
quello “stupore” e a quell’ “attrattiva” che si prova nei confronti della
constatazione che noi esistiamo e che tutto ciò che ci attornia “esiste”.
IL NOSTRO SPIRITO. La conoscenza presuppone un soggetto, che ne sia
il portatore capace ed unico. E’ l’intuizione profonda di uno dei più antichi
pensatori della nostra tradizione filosofica d’Occidente, Eraclito di Efeso
(VI sec. a.C.), lo scopritore del logos (che è insieme ragione, parola e
discorso). Ecco una sua bellissima sentenza: “I confini dell’anima non li
potrai mai trovare per quanto tu percorra le sue vie; così profondo è il suo
logos”.Questa intuizione può essere sviluppata – ed in effetti così è
avvenuto nella
millenaria vicenda filosofica dell’umanità – sul piano
psicologico (problema dell’anima ), su quello gnoseologico (l’intelligenza
che conosce il reale), su quello etico (la coscienza), su quello religioso (la
salvezza individuale)… A noi interessa qui la portata ontologica di questa
intuizione. Identificato da taluni (Idealismo) con la realtà totale, negato
recisamente da altri (Materialismo), ridotto a pura funzione psichica
(Psicologismo), o ancora assimilato ad una “somma di stati di coscienza” o
ad un principio di attività vitale (Intuizionismo), lo SPIRITO ci appare
invece come quell’essenza sostanziale del nostro IO che, nella sua unità e
semplicità, permane al di sotto del flusso vitale, del divenire temporale e del
susseguirsi degli stati d’animo e delle esperienze che facciamo. Non è uno
“stato”, un’ “attività”, una “funzione sintetica”; bensì un’entità
permanente e sussistente, nella quale l’Essere si manifesta, si rivela, si
esprime, si dà.
SI METTE IN PRESENZA. E’ nella luce dello spirito, nell’orizzonte
dell’ente, che l’Essere ci appare, la Realtà si presenta a noi. Anche questa è
un’intuizione antichissima: per Parmenide l’Essere e la sua “inconcussa
verità” si automanifestano all’intelligenza umana in maniera totale,
esauriente, evidente, indubitabile. L’ aletheia (etimologicamente: ciò che
non è nascosto) è autosvelamento dell’Essere al Pensiero dell’ente.
L’autopresentazione dell’Essere all’ente è invece mediata e riflessa,
condizionata in buona parte dai sensi, dall’esperienza della molteplicità
sensibile, dalla congenita difficoltà di ridurre ad unità il variegato mondo
dell’esistenza. La nozione dell’essere non è perciò una NOZIONE PURA,
nettamente separata dal contatto diretto con il mondo degli esseri reali e
dalla funzione della sensibilità. Il “mettersi in presenza della realtà da parte
del nostro spirito” non è un’operazione immediata ed intuitiva, facile e
diretta (critica dell’ontologismo, che crede ciò possibile per l’uomo); bensì
un cammino tormentato e difficile. Ciò non toglie, naturalmente, il carattere
3
fondamentale e decisivo di tale operazione. (E’interessante, a tale proposito,
la controversia tra Hegel e Schelling sulla possibilità di una conoscenza
immediata ed intuitiva dell’Assoluto, perché mette a fuoco proprio la natura
di questo atteggiamento conoscitivo primario e fondamentale).
DI TUTTO IL REALE. L’apertura di uno spirito che cerca la verità è di
360°. Abbiamo detto che si tratta di un atteggiamento che si acquisisce con
fatica e con sforzo – e non di un’intuizione immediata ed esaustiva ; ma è
un atteggiamento che punta alla totalità. L’idea di essere che il nostro
spirito arriva a cogliere è proprio l’idea che l’Essere è una totalità
indivisibile, che si pone oltre e al di là delle sue connotazioni e delle sue
infinite sfaccettature. La conoscenza ontologica fondamentale non ha nulla
a che fare con una qualsiasi conoscenza particolare della realtà: essa si
appoggia sull’idea dell’Essere come un tutto
DATO O NO. Questa apertura a 360° del nostro spirito nell’atto ontologico
fondamentale non riguarda solo il modo sensibile, ma ogni possibile aspetto
del reale, e quindi ogni possibile conoscenza. La nostra intelligenza non è
fatta solo per scoprire e conoscere l’universo sensibile, ma per trascenderlo
e travalicarlo. Essa cerca la Perfezione, l’Assoluto, l’Infinito, il Tutto,
perciò non può appiattirsi sull’imperfetto, il finito, il particolare.
PARTE SECONDA
Il cammino storico dell’ontologia nel pensiero occidentale
E’ una profonda e suggestiva intuizione di Platone (Teeteto, 155 d), poi ripresa e
sviluppata da Aristotele (Metafisica, A, 2), l’idea che la filosofia sia nata dalla
“meraviglia”, dallo stupore dell’uomo di fronte sia alla molteplice varietà degli esseri
sia al loro ordine (il mondo, la natura, come kosmos anziché come kaos).
Rileggiamo insieme questi due passi, tanto celebri e tanto conosciuti, ma sempre
pieni di straordinarie vibrazioni.
Dal TEETETO di Platone:
“TEET. In verità, Socrate, io sono straordinariamente meravigliato di quel che siano
queste “apparenze”; e talora, se mi ci fisso a guardarle, realmente ho le vertigini.
SOCR. Amico mio… è proprio del filosofo questo che tu provi, di esser pieno di
meraviglia; né altro cominciamento ha il filosofare che questo; e chi disse che Iride
fu generata da Taumanto non sbagliò, mi sembra, nella genealogia”.
(N.B. Iride (simbolo della filosofia) è nella mitologia greca la messaggera degli dei
fra gli uomini ed ESIODO nella sua Teogonia la vuole figlia di Taumante, figlio di
Teti e “prodigio del mare”: in greco thauma significa appunto “prodigio,
meraviglia”).
4
Dalla METAFISICA di Aristotele:
“Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine (kài nun kài tò
pròton), a causa della meraviglia (dià tò thaumàzein): mentre da principio restavano
meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco a
poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori, come i problemi riguardanti i
fenomeni della luna e quelli del sole e degli astri e poi i problemi riguardanti
l’origine dell’ intero universo”.
Questi due passi testimoniano benissimo il radicamento profondo dell’atteggiamento
di ricerca filosofica nella coscienza spontanea dell’uomo e anche, se vogliamo,
l’origine “popolare” e non “colta” della filosofia, la sua stretta solidarietà con il senso
comune.
La filosofia (nonostante il suo successivo sviluppo spesso assuma l’aspetto di una
vera e propria controtestimonianza) non è, come qualcuno maliziosamente crede, il
prodotto di un’operazione colta e verticistica, fatta allo scopo di condurre l’uomo
lontano dalla realtà e dal comune sentire (magari per inconfessabili ragioni di potere
o di dominio). Essa scaturisce dall’approfondimento di domande sorgive, presenti
nella coscienza spontanea di ogni uomo, e rappresenta il tentativo umano più alto e
più nobile di rispondervi, elevando lo spirito dal pedestre asservimento al “concreto”
alle vette pure dell’ “astratto”.
(N.B. Nella capacità di “astrazione” della mente umana dobbiamo vedere il carattere
più nobilmente distintivo della nostra specie rispetto ad ogni altra condizione
animale. Excursus sulle caratteristiche della capacità astrattiva dell’intelligenza
umana).
La “meraviglia” – che per il Socrate del Teeteto platonico rappresenta il proprium
della filosofia - è la stessa meraviglia del bambino o del primitivo di fronte allo
“spettacolo del mondo”; ma il filosofo altro non fa se non trasformare questo
spontaneo ed ingenuo stupore in un rigoroso e strutturato metodo di indagine. La
meraviglia cessa così di essere un fatto episodico, una suggestione temporanea
confinata nella parte emozionale del nostro io, per diventare un habitus permanente,
una struttura stabile della nostra ricerca intellettuale. Comincia così quel cammino,
assai ben descritto in poche righe da Aristotele, che porta l’uomo-filosofo dal
particolare all’universale, dirigendolo verso la comprensione della totalità e verso
l’astrazione pura.
A) Dagli “esseri”concreti all’Essere degli “esseri”
Il primo “movimento filosofico” della mente è orientato verso la natura, percepita sì
– come è proprio della conoscenza sensibile – nella sua varietà, molteplicità e
mutevolezza; ma nello stesso tempo intesa anche come un “tutto unico”, un universus
(ad unum versus).Insomma come un kosmos (ordine/bellezza) e non come un kaos
(disordine/male).
5
Nasce la domanda: “Che cos’è la natura? (tì estì fysis). Ma inizialmente l’interesse è
tutto centrato sul tì : si va alla ricerca dell’ archè, il principio costitutivo
fondamentale della realtà, che ne sia insieme anche la causa, il cominciamento primo.
Le prime risposte non esorbitano dall’orizzonte naturalistico: ad esempio l’archè è
individuata in uno degli elementi primordiali (Talete, Anassimene, Eraclito) o in tutti
e quattro (Empedocle) oppure in un’infinità di principi sostanziali (i “numeri” di
Pitagora o i “semi” di Anassagora). Naturalmente non mancano spiragli od
anticipazioni verso nuovi approfondimenti: per esempio l’ apeiron (indefinito, senza
confini) di Anassimandro, il panta rei (divenire) di Eraclito, il nous (mente) di
Anassagora.. Ma si rimane sempre nell’ ambito di spiegazioni di ordine cosmologico.
E’ soltanto con PARMENIDE (VI-V sec.) che la domanda originaria (tì estì fysis)
subisce una radicale trasformazione. Egli infatti concentra tutto il suo interesse sull’
estì della fysis, anziché sul tì . Si dice comunemente che Parmenide sia lo scopritore
dell’Essere. In realtà sarebbe molto più esatto affermare che Parmenide abbia
scoperto le condizioni di intelligibilità dell’Essere, o anche che abbia individuato per
primo l’Essere come oggetto formale del pensiero.
Per Parmenide c’è una sostanziale coincidenza tra “pensiero” ed “essere”:
- “Per la parola ed il pensiero bisogna che l’essere sia: solo esso infatti è
possibile che sia, e il nulla non è”.
- “La stessa cosa è pensare e il pensiero che è, che senza l’essere in cui è
espresso non troverai il pensiero: niente altro infatti è o sarà al di fuori
dell’essere, poiché di fatto la Moira lo vincola ad essere un tutto immobile;
perciò non sono che puri nomi quelli che i mortali hanno posto, convinti che
fossero veri: divenire e perire, essere e non essere, e cambiare di luogo e
mutare lo splendente colore”..
L’evidente dato che i sensi ci forniscono – il molteplice divenire della natura – appare
a Parmenide (per effetto dello spostamento di interesse sull’estì) nient’altro che
ingannevole apparenza. Abbandonata perciò l’ingenua e passiva aderenza
“naturalistica” ai dati del reale, Parmenide si avventura sulla difficile via della pura
razionalità (il sentiero del Giorno), pervenendo ad una duplice scoperta:
1. L’univoca e assoluta esistenza dell’ESSERE;
2. La contraddittorietà dell’esistenza del NULLA.
Come abbiamo prima precisato, la dizione “scoperta dell’Essere” va intesa nel senso
di scoperta delle condizioni di pensabilità dell’Essere (o: scoperta dell’Essere come
oggetto formale del pensiero). Quali sono queste condizioni? La prima è la
coincidenza tra pensiero ed essere: per il pensiero è necessario che l’ Essere sia. La
seconda, strettamente intrecciata e conseguente, è l’impensabilità dell’esistenza del
Nulla: “il non-essere non puoi né conoscerlo (è infatti impossibile), né esprimerlo,
perciò è necessario che non sia”.
Siamo qui nel cuore profondo del modo di pensare dell’Occidente: la scoperta dei
capisaldi logici della nostra attività mentale (i principi di identità e di non
contraddizione), che sono anche il fondamento insostituibile della visione metafisica
della realtà.
6
Parmenide è perciò il vero fondatore dell’ontologia, che è appunto la scienza che
pensa l’Essere. Sulla scia di questa “scoperta” – ancora balbettante nella sua
formulazione, ma pur tuttavia imprescindibile avvio di un nuovo cammino – si verrà
ad innestare l’intero processo di sviluppo logico, metafisico, gnoseologico e
linguistico della filosofia dell’ Occidente.
Ma: se è vero che in Parmenide assistiamo al primo e più importante tentativo
filosofico di passare dalla cosmologia all’ontologia, è altrettanto vero che in questa
appena abbozzata visione ontologica del reale permangono gravi residui naturalistici.
Infatti: l’essere parmenideo è connotato come un “tutto pieno”, come una massa
monolitica senza buchi, impenetrabile (piena e rotonda, ingenerata, immobile),
perennemente identica a se stessa, compiuta ed unica. L’univocità dell’essere
parmenideo conduce pertanto alla dissoluzione della molteplicità, all’impossibilità
del movimento, alla riduzione di tutti i fenomeni a pura apparenza.
Come è stato giustamente osservato (Giovanni REALE), Parmenide “salva l’Essere,
ma non i fenomeni”.
Infatti questa prima scoperta “astratta” della nozione di essere – proprio nella misura
in cui non è ancora completamente “astratta”, ma troppo legata al concreto, troppo
ancora naturalistica – finisce con l’entrare in un insanabile conflitto con la visione del
“senso comune”, saldamente ancorata alla realtà dei fenomeni, generando sconcerto e
rischiando il paradosso (cfr. appunto i celebri “paradossi” con i quali il discepolo
Zenone difese le tesi del maestro contro i detrattori).
Nello stesso tempo, però, questa magistrale teoria, essendo solidamente congiunta
alla scoperta dei primi due fondamentali principi della logica, costituisce una verità
profonda ed irrinunciabile, ponendosi come ineliminabile punto di riferimento per la
successiva speculazione.
Come sempre avviene nel corso della ricerca umana, sono tuttavia proprio le
“aporie”, cioè le difficoltà, gli errori o le incompletezze di una teoria, che
determinano il passaggio ad acquisizioni successive, più complete e mature.
Assistiamo a questo passaggio, come in una straordinaria esemplificazione, nella
ripresa platonica dell’intuizione parmenidea.
Platone non può sottrarsi alla suggestione del “venerando e terribile” predecessore
(venerando, per l’autorità imprescindibile della sua dottrina, ma terribile, per le
sconcertanti conseguenze cui perviene) ed affronta coraggiosamente tutti i nodi posti
dall’ Eleatismo: il rapporto tra Essere e Nulla, tra Uno e Molteplice, tra piano della
sensibilità e piano dell’intelligenza. I Dialoghi in cui Platone affronta questa tematica
(il Parmenide appunto ed il Sofista) sono tra i più complessi e di difficile
interpretazione dell’intero Corpus, per cui mi guardo bene dall’addentrarmi nella loro
problematica, limitandomi a sottolineare due evidenze conclusive:
1. L’ammissione del non-essere come semplice alterità. Il mondo delle Idee, che
per Platone rappresenta il mondo nella sua perfetta intelligibilità, è un mondo
pluralistico. Le Idee sono, è vero, finalizzate in modo gerarchico verso un
principio incondizionato e assoluto che Platone chiama BENE (n.b. Qui
bisognerebbe far cenno alla cosiddetta “dottrina non scritta” di Platone, che
aveva appunto come oggetto esclusivo la trattazione del Bene e veniva svolta
7
in modo riservato soltanto con i più fidati discepoli), ma – essendo l’una
diversa e distinta dall’altra – sono appunto molteplici. Ciascuna Idea, quindi,
non essendo le altre, possiede in qualche modo l’attributo del non-essere.
2. La nozione di partecipazione (metessi/koinonia). Platone introduce
nell’Essere un doppio movimento: a) il dinamismo mediante il quale le Idee
sono in comunicazione fra di loro e, tutte insieme, con il Bene; b) il movimento
mediante il quale il mondo sensibile partecipa del mondo intelligibile.
Sarà soltanto con Aristotele che l’analisi dell’Essere si spingerà a profondità
definitive per la ricerca del mondo antico.
Aristotele comprende che la nozione di Essere non è né semplice né univoca. Con
Platone si era già fatto un notevole passo in avanti rispetto a Parmenide, concependo
il non-essere anche come “diversità” e non solo come un’entità assoluta, ma sia
l’esistenza del mondo sensibile sia l’intelligibilità completa del divenire erano
rimaste problematiche e comunque non pienamente giustificate da un punto di vista
strettamente razionale (cfr. il ricorso platonico al mito, soprattutto il mito della biga
alata e quello del Demiurgo).
Per Aristotele l’Essere ha una molteplicità di significati. C’è essere ed essere: l’essere
in quanto è, l’essere per cui si è, l’essere che si può essere (quest’uomo/ la grandezza
di quest’uomo/ l’architetto che quest’uomo grande può essere).
Allo stesso modo è per il Non-essere: vi è il non-essere puro e semplice (l’Assoluto
Nulla, che non c’ è); il non-essere relativo (il cane non è un uomo, ma è qualcosa); il
non-essere potenziale (il neonato non è ancora un adulto, ma può diventarlo).
In Aristotele rimane irrinunciabile l’acquisizione parmenidea del principio di non
contraddizione come legge fondamentale della conoscenza razionale, ma si dissolve
totalmente l’univocità dell’ontologia parmenidea che concludeva nella inconcepibilità
del divenire. Per Aristotele, il divenire è completamente intellegibile e giustificabile:
esso è un movimento dell’essere all’interno dell’Essere, non un passaggio –
impossibile – dall’Essere al Nulla e viceversa.
Tra tutti i possibili significati dell’essere spicca, nell’ontologia aristotelica, la coppia
Potenza (dynamis) – Atto (energheia/entelecheia): potenza è l’essere in quanto
“può” essere (il seme rispetto alla pianta/l’uomo ad occhi chiusi rispetto all’azione
del vedere); atto è l’essere nel suo stato di realizzazione finale, l’essere che “è”
realmente (la pianta che abbiamo di fronte/l’uomo che guarda).
Il divenire (kynesis)è il passaggio dalla potenza all’atto. Esso non è contraddittorio
per la nostra intelligenza, perché non è un passaggio dal puro non-essere (che non è,
perciò non diviene) all’essere; bensì il passaggio da un relativo non-essere (cioè
l’essere-in- potenza) ad un essere determinato (l’essere nell’atto di essere ciò che
appunto è).
Siamo arrivati qui ad un’intuizione fondamentale – che possiamo ritenere definitiva –
circa quel problema che abbiamo definito come una ricerca dell’Essere degli esseri a
partire dal dato concreto dell’esistenza della realtà (gli esseri), caratterizzata
dall’esperienza fin troppo ovvia e banale del mutamento delle cose e della vita stessa.
Da questo dato così evidente (e che perciò non può essere così facilmente eluso e
8
messo tra parentesi, come sembra aver fatto Parmenide) il nostro spirito risale, con un
vertiginoso colpo di astrazione, al fondamento permanente ed immutabile del tutto
(appunto: l’Essere).
In fondo questo è il problema fondamentale della filosofia: il rapporto tra l’ Uno ed il
Molteplice. Come i molti (risultanza inconfutabile della nostra esperienza sensibile
del reale) sono in fondo uno (esigenza insopprimibile della nostra mente che vuole
attingere al “che cosa” della realtà)? Come può essere mantenuta l’assoluta identità
dell’Unico Essere senza sacrificare l’effettiva esistenza dei molti: o viceversa?
Abbiamo anche visto come in Aristotele questo problema “uno-molti”sia strettamente
connesso al tema del “divenire”. Non si tratta infatti solo di domandarsi come l’unico
essere possa fondare i molti senza perdere la propria identità, senza sparire od
annullarsi in essi; ma anche di chiedersi come questo unico essere possa far ciò senza
necessariamente dover essere definito come “immobile, immutabile, monolitico”
ecc…
B) Il problema ontologico in Aristotele
Aristotele ha individuato, nella sua ricerca, quattro fondamentali gruppi di significato
per il termine Essere:
1.
2.
3.
4.
L’essere categoriale
L’essere come potenza ed atto
L’essere come accidente
L’essere come verità
a)L’essere categoriale
Il problema di classificare i differenti generi di essere ha sempre preoccupato
Aristotele – come del resto aveva preoccupato i suoi predecessori (cfr. per esempio
le 10 coppie di contrari di Pitagora o i 5 generi del “Sofista” di Platone). Pertanto
egli si è preoccupato di redigere, sulla base della lingua greca e della comune
esperienza delle cose, una tavola delle principali proprietà che l’uomo accusa
(kategorein: il termine è preso dal linguaggio giuridico del tempo) in tutto ciò che
vede e di cui parla.
Nascono così i dieci predicati o attributi o generi dell’essere, noti appunto come
CATEGORIE: sostanza (ousia) – qualità ( poiòv) – quantità (posòn) – relazione
(pròs tì) – azione (poiein) – passione (paschein) – luogo (pou) – tempo (potè) –
avere (echein) – giacere (keisthai).
(N.B. Se si volesse leggere una simpatica e “leggera” esemplificazione di queste 10
categorie si veda: De Crescenzo L., Storia della filosofia greca da Socrate in poi,
Milano, Mondatori, 1986, pp. 125-26).
9
La prima categoria – sostanza (ousia) – ha una priorità su tutte le altre ed è
fondamentale.
Sostanza è “ciò che è in quanto è”. Come più tardi dirà il filosofo Spinoza, sostanza
è “quod in se est et per se concipitur”. E’ fondamentale, perché tutti gli altri
predicamenti si riferiscono sempre alla sostanza come tale. Dirà San Tommaso:
“Substantia est fundamentum et basis omnium aliorum entium”.
Afferma Grenet (cit. in bibliografia, p. 156): “La sostanza è l’essere al quale spetta
di esistere in sé e non in un altro; l’accidente (ontologico) è l’essere al quale spetta
di esistere in un altro come nel proprio soggetto”.
Si potrebbe allora dire che tutte le altre categorie sono “accidentali”, naturalmente in
senso ontologico, e non in quello di “casualità fortuita” (cfr. n° 3 della tavola dei
significati dell’Essere secondo Aristotele) di cui parleremo più oltre.
L’Essere quindi, nel suo senso più forte, è ousia. Si capisce bene allora perché
Aristotele definisca la Metafisica anche come “teoria della sostanza”.
Quali sono i nodi principali di questa teoria della sostanza in Aristotele?
Essenzialmente due:
a) Che cosa è la “sostanza in generale”?
b) Ci sono sostanze soprasensibili, oltre a quelle sensibili che la comune
esperienza ci fa incontrare e conoscere?
Vediamo come Aristotele risponde alla prima questione. Scrive G. Reale nella sua
Storia della filosofia antica, vol. II:
“Che cos’è la sostanza in generale? 1) I Naturalisti indicano negli “elementi
naturali” il principio sostanziale; 2) i Platonici lo indicarono nella “forma”; 3) al
senso comune, invece, sembrerebbe essere sostanza l’individuo e la cosa concreta,
fatti ad un tempo di forma e materia. Chi ha ragione? Secondo Aristotele, hanno
ragione ad un tempo tutti e nessuno, nel senso che queste risposte, prese
singolarmente, sono parziali, ossia unilaterali; nel loro insieme ridanno invece la
verità”.
Perciò Aristotele articola il discorso sull’essere come sostanza su tre piani, distinti
ma anche profondamente connessi fra di loro:
MATERIA (hyle): è il “sostrato” di tutte le realtà sensibili, nel senso che
l’assenza di materia ne vanificherebbe l’esistenza. Scrive Aristotele nella
Fisica che la materia è “il sostrato primo di ogni cosa, dal quale, come
elemento essenziale intimamente costitutivo, deriva qualcosa non solo per
accidente”. Naturalmente qui non si parla della materia concreta di cui sono
fatti i corpi che noi vediamo e tocchiamo (per Aristotele questa è la “materia
seconda”, che è oggetto delle scienze naturali e non della metafisica), bensì
della “materia prima”, oggetto solo del pensiero, non identificabile con alcuna
sostanza corporea determinata, fondamento ontologico comune a tutti i corpi,
ma non essa stessa corpo od oggetto sensibile. In questo senso, la materia
prima è pura spazialità, potenzialità indeterminata, incapace di diventare
qualche cosa senza l’intervento determinante di una forma. E’ quindi esatto
definire la “materia prima” come “sostanza”, ma non in senso univoco ed
assoluto.
10
FORMA (morphè): è il principio determinativo che attualizza la materia e si
pone come il “che cos’è” (quod quid est degli Scolastici) di ciascuna cosa.
Anche se Aristotele usa spesso il termine eìdos (proprio di Platone), la sua
forma non è trascendente, ma si pone come costitutivo intrinseco dell’essere,
diventando addirittura la principale “causa” dell’esistenza di un quid. La
forma aristotelica è una forma sostanziale, fondamento essenziale interno di
ciascun ente reale, principio proprio dell’essere specifico di ciascuna realtà e
causa prima di quel dinamismo che spinge verso l’autorealizzazione ogni
esistenza potenziale. La forma è dunque per Aristotele l’essere nel suo senso
più pieno, la sostanza nel suo significato più proprio, l’essenza vera di ogni
realtà.
COMPOSTO DI MATERIA E DI FORMA (synolos): tutto ciò che esiste
appare “composto” (questa sarà la traduzione scolastica del termine “sinolo”,
che letteralmente significa “tutt’uno”) di materia e di forma. E’ la risultanza
della sostanziale coesistenza e coincidenza di principio materiale e principio
formale. La sinolicità è dunque il vero modo di essere della sostanza, la
sostanza in modo pieno e assoluto.
Ma allora – se il senso vero della parola sostanza è la “sinolicità” – esisterebbero solo
sostanze composte di materia e di forma, di atto e potenza: insomma soltanto
sostanze sensibili. Esistono sostanze di altro tipo? Per esempio soprasensibili (del
tipo, per intenderci, delle idee platoniche)?
Vediamo come Aristotele risponde alla seconda questione.
Aristotele arriva a sostenere l’esistenza di sostanze soprasensibili partendo dal
movimento (kynesis) e postulando come causa prima di questo un principio assoluto
eternamente immobile ed immutabile. Su questa via la sua metafisica sfocia in una
vera e propria “teologia naturale” (è il significato ultimo della sua ricerca, che finisce
con il ricomprendere al suo interno le altre tre definizioni che egli dà della sua opera:
indagine sulle cause/indagine sull’essere/indagine sulla sostanza: eziologia,
ontologia, ousiologia). Ma seguiamo brevemente il suo ragionamento.
La fisica ci mostra in modo inoppugnabile che quidquid movetur ab alio movetur; ma
è altrettanto inoppugnabile che un’infinita catena causale senza un cominciamento
primo è impensabile secondo la logica aristotelica, perché ci introduce in un orizzonte
indeterminato, inconoscibile in quanto non riconducibile al principio conoscitivo
dello “scire per causas” (Aristotele non accetta la visione mistica e panteistica dell’
eterna catena degli esseri).
Deve esistere perciò un “primum movens”, un motore che sia non a sua volta effetto
di un movimento prodotto da un’altra realtà, ma causa prima, eterna ed immutabile di
ogni movimento. Inoltre, tale primo motore, in quanto immobile, deve essere
assolutamente privo di qualsivoglia potenzialità (perché la potenzialità implica un
intervento formale per potersi attualizzare, quindi un movimento): insomma, un
ATTO PURO.
Ora: poiché la potenza si identifica con la materia e l’atto con la forma, ne consegue
che l’ atto puro è pura forma. L’atto puro è dunque una sostanza soprasensibile,
11
immateriale, che può essere oggetto solamente di conoscenza intellettuale e non di
esperienza sensibile.
E’ così dimostrata – attraverso la via naturale del ragionamento che parte dall’analisi
del movimento, delle sue leggi e delle sue cause – l’esistenza (anzi: la necessità
dell’esistenza) della sostanza soprasensibile.
Su questa solida premessa Aristotele continua rigorosamente a dipanare la sua catena
di deduzioni, venendo a riconoscere a questa sostanza soprasensibile i seguenti
attributi:
La perfezione : la vita e la natura di questo atto puro, privo di ogni potenzialità
e totalmente realizzato, sono perfette. L’ entelechia prima è intrinsecamente
compiuta, da sempre realizzata, immodificabile : appunto perfetta, e quindi
divina.
La noeticità : l’Atto puro, Dio, è “pensiero di pensiero” (nous noesetos).
L’intelligenza perfetta non può avere altro oggetto se non la propria stessa
perfezione. Se pensasse ad “altro da sé” non sarebbe perfetta. Dio non può
interessarsi o preoccuparsi di ciò che è “meno” di Sé stesso.
L’ unità : è chiaro, in Aristotele, che Dio è una totalità semplice ed assoluta,
indivisibile e senza parti. Rimane invece tutt’altro che chiarito il tema
dell’unicità, perché non essendo il suo Atto Puro un “creatore” nel senso
biblico del termine (per Aristotele la creatività divina sarebbe una
diminuzione, un difetto, in contrasto con il concetto di perfezione assoluta)
rimane come sospeso, non spiegato, irrisolto, il nodo dei rapporti tra Dio e le
altre sostanze intelligenti ed eterne (le 55 intelligenze motrici che presiedono al
movimento delle sfere celesti; l’anima, nel caso che si sciolgano in modo
positivo le ambiguità circa l’immortalità dell’anima contenute nella
Psicologia), come con la materia sensibile ed il mondo dei sinoli.
Il finalismo : Dio, con la sua compiuta perfezione, attrae a sé tutto, ma non in
maniera attiva ed intenzionale. Si parla di finalismo passivo, perché il Dio
aristotelico può essere solo oggetto di amore, non soggetto che ama (l’amore,
come già aveva detto Platone, implica una mancanza, un desiderio di
perfettibilità, quindi si tratta di un sentimento incongruo per una divinità come
quella aristotelica, perfetta ed assorta nella propria autocontemplazione).
b) L’essere come potenzialità ed attualità
Riprendiamo qui le osservazioni già fatte, a proposito del divenire, sulla distinzione
aristotelica tra atto e potenza, collegandole a quelle altre, sempre già svolte nel
paragrafo precedente, su materia e forma. E’ evidente la stretta aderenza di queste
coppie di termini e di concetti:
La Materia è Potenza, nel senso che la sua caratteristica fondamentale è
la “recettività”, il poter diventare, grazie all’intervento della forma,
“questo” o “quello”.
La Forma è Atto, nel senso che solo la forma dà una determinata
attuazione all’essere potenziale, conferendogli quel quid (essenza) che lo
12
fa essere ciò che in effetti è. La forma è il logos della cosa (ratio rei).
Come diranno gli Scolastici: id quo res est id quod est, non aliud. O
ancora: id secundum quod alicui competit esse.
L’atto rappresenta la perfezione della sostanza: questa è tale solo nell’atto di essere
(actus essendi). L’atto ha perciò una priorità assoluta sulla potenza, anche se quest’
ultima – intesa come materia – è il presupposto dell’atto. Ma la materia è conoscibile
come tale ( in senso proprio, non nel senso puramente astratto di “materia prima”)
solo in relazione all’atto che la informa ed, informandola, le conferisce l’esistenza
attuale. Si deve perciò dire che l’atto (entelechia) precede ontologicamente la
potenza (dynamis), mentre quest’ ultima precede cronologicamente l’atto.
Classici esempi come quello dell’ uovo e della gallina, o del seme e della pianta,
possono validamente dimostrare questo assunto.
Ai concetti di potenza ed atto si connette anche l’altro concetto aristotelico di
privazione (stéresis). Essa significa la mancanza – che può essere temporanea o
definitiva (quindi: non esistenza di) – di condizioni o proprietà che fanno parte dell’
essere-in-potenza e ne vengono ad impedire la perfezione o la realizzazione (es. la
cecità).
La privazione non è dunque puro non-essere (negazione dell’essere), ma semplice
limitazione o impedimento dell’ actus essendi. In termini morali essa viene a
coincidere con il male (che, per esempio, S. Agostino definisce come defectus boni).
In Aristotele non c’ è tuttavia alcuna connotazione morale, per cui la “privazione” è
anche la condizione che consente la modificazione della materia, quindi la possibilità
dinamica per un ente di raggiungere la propria realizzazione.
c) L’essere come “puro accidente”
Questo concetto non ha alcuna rilevanza ontologica e non va confuso con i nove
ordini “accidentali” della sostanza (le altre nove categorie). Aristotele ne parla come
di un semplice accadimento fortuito e casuale, che non entra mai nella definizione
sostanziale di un termine. L’accidente ( tò sunbebekòs) è non sempre né per lo più
(mentre la scienza si occupa solo di ciò che è sempre o per lo più). L’accidente si
riferisce perciò ad una condizione del tutto provvisoria e fortuita del sinolo (per
esempio il fatto che ora io possa essere accaldato o pallido). La rilevanza di tale
definizione non può interessare il piano ontologico dell’essere, ma caso mai quello
storico, empirico o fenomenologico.
d) L’essere come “verità”
Questo modo dell’essere è studiato dalla logica. La “verità/falsità” di un ente risulta
solo da una “corrispondenza/non corrispondenza” dell’oggetto reale con le
proposizioni logiche fondamentali (adaequatio rei et intellectus, diranno poi gli
Scolastici). C’è una situazione di verità quando la nostra mente pensa le cose
(l’essere) come sono in realtà; c’è una situazione di falsità (almeno potenziale)
quando il nostro pensare è privo di ogni corrispondenza con il reale. E’ chiara quindi
la precedenza dell’ ontologia sulla logica: è l’ontologia che descrive la struttura
13
profonda della realtà, l’essere delle cose nella loro permanente consistenza; la logica
mette questa realtà ontologicamente percepita in relazione con i criteri e le regole di
verità/falsità stabilite dalla nostra ragione.
C) Il problema dell’essere in san Tommaso
L’affronto del problema dell’essere in san Tommaso (1221-1274) richiederebbe una
rigorosa premessa di carattere storico-culturale per chiarire quale sia stato il
sostanziale mutamento delle condizioni in cui si esercita il pensiero (in generale, ma
in particolare quello filosofico) verificatosi con l’irruzione del Cristianesimo
nell’occidente greco-romano e con la progressiva, crescente ed infine vittoriosa
sostituzione della cultura cristiana alla cultura pagana.
Una messa a punto così rigorosa non possiamo ovviamente farla in questa sede,
anche perché ciò significherebbe fare – sia pure a grandi linee – la storia della
penetrazione del Cristianesimo nel tessuto profondo della società occidentale, del
formarsi della nuova società medievale e delle sue istituzioni storico-culturali e – da
un punto di vista strettamente filosofico – la storia della Patristica greca e latina e
della Scolastica.
Ci limitiamo pertanto ad accennare – a mo’ di premessa generale allo studio
dell’ontologia tomista – a tre importanti questioni. Due sono di carattere storicoculturale (la nascita dell’ Università e la riscoperta dell’ opera aristotelica), la terza di
ordine filosofico (il rapporto fede-ragione nella filosofia cristiana medievale).
Il carattere “pubblico, aperto e laico” dell’Università medievale.
L’Università, prestigiosa ed insostituibile istituzione scolastica superiore
dell’Occidente, nasce alla fine del XII secolo (lo Statuto della prima università,
quella di Bologna, risale al 1158, ma la sua origine è più antica: 1088). Prima
di allora – fatta eccezione per la famosa schola palatina di Carlo Magno
dell’VIII secolo, esperienza per altro assai circoscritta nello spazio e nel tempo
– erano esistite solo scuole monastiche (annesse ai monasteri per formare i
novizi alla lectio divina), episcopali (annesse alle cattedrali per formare il
personale addetto ai servizi amministrativi) e in qualche caso molto limitato
anche parrocchiali. Con l’Università assistiamo alla nascita di un’ istituzione
pubblica (sia nel senso che di essa si fanno carico i pubblici poteri, laici e/o
ecclesiastici, sia nel senso che la frequenza non è riservata ai soli ecclesiastici e
che essa è dotata di un preciso iter formativo, di un piano sistematico di studi e
di un collegio di docenti qualificato e in grado di fornire – cosa assolutamente
nuova e straordinaria – un titolo di studio legale, non solo ufficialmente
riconosciuto ma anche prestigioso ed assai apprezzato); aperta (naturalmente in
relazione ai tempi, i docenti godono di un’ampia autonomia di ricerca e di
didattica, continuamente e gelosamente difesa contro le pretese e l’ingerenza
dei poteri costituiti); e infine laica (nel senso che, pur se il corpo docente è
prevalentemente formato da religiosi, il suo compito non è quello di formare
degli ecclesiastici, bensì di avviare a professioni “civili”). E’ facile dedurre da
14
queste premesse storico-culturali il carattere “scientifico e sistematico” che
assumerà la filosofia scolastica (appunto: la filosofia insegnata nelle
università).
La riscoperta e la diffusione dell’opera aristotelica. Attraverso la
mediazione della cultura araba, la conoscenza delle opere di Aristotele (e della
Metafisica in particolare) si diffonde nelle università. E’ un’ autentica
“rivoluzione”. Le opere di Aristotele introducono sia nuovi strumenti formali
(il metodo della logica preposizionale) sia nuovi contenuti di ordine
ontologico, antropologico, etico e cosmologico. La filosofia cristiana, sin qui
abituata a mutuare i contenuti dalla Rivelazione e tutt’al più da alcune opere
platoniche e neoplatoniche, si trova improvvisamente di fronte ad un organico
sistema filosofico, ad un’armonica e coerente spiegazione razionale dell’uomo
e dell’universo del tutto indipendente dalla verità rivelata del Cristianesimo. E’
un vero e proprio choc : o si rigetta in blocco questo imponente sistema di
“verità” (e ciò appare francamente inammissibile per degli onesti ed
appassionati ricercatori del vero quali sono i filosofi scolastici) oppure si cerca
di “cristianizzarlo”, nel senso buono del termine: cioè si va alla ricerca delle
concordanze, ripensando poi tutto il sistema aristotelico all’interno del
patrimonio di verità costituito dalla Rivelazione cristiana. Sarà questa la via
scelta dal grande Alberto Magno (1206-1280) e dal suo illustre discepolo San
Tommaso d’Aquino (1221-1274).
Ragione e fede. Il rapporto ratio/fides (o anche: scienza/rivelazione; filosofia/
teologia) è il problema fondamentale di tutta la filosofia cristiana medievale (e
non solo medievale: si veda l’enciclica Fides et ratio del 1998 nel suo
complesso, ma per esempio in IV, 42: “la fede chiede che il suo oggetto venga
compreso con l’aiuto della ragione; la ragione, al culmine della sua ricerca,
ammette come necessario ciò che la fede presenta”). Impostato dalla Patristica
(a partire da san Giustino), inquadrato con grande equilibrio da Sant’Agostino
(suo è il famoso credo ut intelligam/intelligo ut credam) e da Sant’Anselmo di
Aosta (fides quarens intellectum), il problema acquista una nuova e
drammatica attualità al tempo della diffusione dell’aristotelismo. C’è
autonomia della ratio? A chi spetta la priorità nell’atto conoscitivo? Ragione e
fede si escludono a vicenda (razionalismo / fideismo) oppure sono
complementari? Quale il ruolo dell’una e dell’altra? Fino a dove può giungere
la ricerca razionale senza l’apporto della verità rivelata? Quale è insomma
l’ambito della filosofia?...
1) Ragione e fede in San Tommaso
La soluzione tomista del problema del rapporto “ratio/fides” sta tutta nel concetto di
filosofia come preambulum fidei e come ancilla theologiae.
San Tommaso è assolutamente convinto dell’autonomia e della specificità della
ricerca razionale ( e la recente riscoperta del pensiero di Aristotele ne costituiva
15
un’ulteriore formidabile conferma). La ragione – e quindi la filosofia – ha un proprio
metodo, una propria specifica configurazione che le consente di inoltrarsi verso la
conoscenza, anche delle cose “ultime”, senza dover ricorrere ad apporti esterni o
chiedere umilianti “pass”. Ancora una volta il sistema aristotelico ne è la prova
convincente: Aristotele ha saputo indagare correttamente non soltanto sull’uomo e sul
mondo, ma anche su Dio e sulle cose soprasensibili. Su Dio, pur in assenza di una
rivelazione e facendo esclusivamente appello alla ragione, ha raggiunto conclusioni
assolutamente rispettabili, rigorose, totalmente condivisibili dal punto di vista logico
e non incompatibili col punto di vista della fede.
La filosofia, insomma, si appoggia esclusivamente sull’evidenza razionale, sulla
forza dei suoi principi e sul rigore delle proprie argomentazioni: a null’altro si devono
le sue conclusioni. Ma ciò che è sorprendente è che tali conclusioni non entrino in
conflitto con la verità rivelata. Commenta il Papa a questo proposito : “La luce della
ragione e quella della fede provengono entrambe da Dio, egli (cioè: Tommaso, ndr)
argomentava: perciò non possono contraddirsi tra di loro” (Fides et ratio,IV, 43).
Fatta salva questa autonomia e questa specificità della ratio, va comunque aggiunto
che la filosofia non ci può dare una verità assoluta e definitiva. Non soltanto perché
essa non esaurisce tutto ciò che l’uomo può conoscere e dire, ma soprattutto perché
l’oggetto ultimo vive nella dimensione del mistero. La filosofia ci “introduce” alla
verità totale, ma non è capace di farcela attingere.
Da qui deriva la definizione di preambulum fidei (lett. “anticamera della fede”): la
ragione ci conduce in prossimità del vero, nelle immediate vicinanze del mistero
divino, ma non ha il potere di svelarcelo in tutto il suo splendore.
N.B. Il termine preambulum non ha qui il significato prevalentemente negativo con
cui oggi solitamente lo si contrassegna (per esempio di un “cappello” inutile e
superfluo ad un discorso, che può essere tranquillamente eliminato senza pregiudizio
per la comprensione del testo; in questo senso si dice, per esempio, bando ai
preamboli, quando si vuole entrare direttamente nel vivo di un discorso). Esso
significa invece, in senso letterale, “ingresso/anticamera”. Se si pensa alla casa
romana, nella quale un solo ingresso dà accesso a tutti gli ambienti interni, ogni
significato di inutile superfluità si dissolve per lasciare invece spazio ad un senso
forte di introduzione necessaria, obbligatoria, vincolante per poter entrare nella “casa
della verità”.
Così pure il termine ancilla dell’espressione “ancilla Theologiae” (anch’essa usata
come metafora del rapporto filosofia/teologia) non va inteso nel senso dispregiativo
che oggi noi attribuiamo ad esso: se la filosofia fosse soltanto “schiava” della
teologia, allora si configurerebbe un inaccettabile ruolo subalterno della ricerca
razionale, ridotta a poco più di una sterile esercitazione in vista della produzione del
vero sapere, che è quello teologico. Come l’ancilla rende la domina tale (cioè: grande
e superiore), così la teologia è il luogo dell’inveramento, del completamento, del
definitivo realizzarsi ed esprimersi della tensione conoscitiva della ratio. La “domina”
senza “ancilla” non sarebbe più tale: così la teologia, senza l’indispensabile aiuto
della filosofia, non sarebbe altro che vano sproloquio.
16
Per San Tommaso, come del resto per ogni pensatore medievale, il fine di ogni atto
conoscitivo è la conoscenza di Dio, perciò filosofia e teologia, fede e scienza non
possono avere due oggetti diversi di conoscenza, ma uno solo: distinti sono caso mai i
campi ed i metodi, ma c’è comunque un rapporto organico, ordinato e gerarchico fra
le due modalità. Non è dunque possibile fare teologia senza una corretta impostazione
filosofica, ma una filosofia che non si traguardi e non si completi nella ricerca
teologica tradisce la sua natura e si preclude il raggiungimento della sua finalità
ultima, che è la ricerca della verità.
Come afferma il Papa all’inizio della sua enciclica: ” La fede e la ragione sono come
le due ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della
verità”.
Viene in mente a questo punto quello stupendo passo del Fedone di Platone, in
cui il grande filosofo greco riconosce l’insuperabile limite di una ricerca
puramente razionale ed accenna, con desiderio e nostalgia, ad una possibile
rivelazione che sciolga ogni dubbio: “Perché, insomma, trattandosi di tali
argomenti, non c’è che una cosa sola da fare di queste tre: o apprendere da
altri dove sia la soluzione; o trovarla da sé; oppure, se questo non è possibile,
accogliere quello dei ragionamenti umani che sia se non altro il migliore ed il
meno confutabile e, lasciandosi trasportare da questo come da una zattera,
attraversare così, a proprio rischio, il mare della vita: salvo che uno non sia in
grado di fare il tragitto più sicuramente e meno pericolosamente su più solida
barca, affidandosi ad una divina rivelazione” (cap. XXXV).
2) La nozione di essere in san Tommaso
Alla radice dell’ontologia tomista sta la distinzione ed il chiarimento concettuale e
terminologico di ESSENZA, ENTE, ESISTENZA. Con questo fondamentale
chiarimento san Tommaso, fin dalla sua prima opera giovanile – il De ente et essentia
che risale al periodo del suo insegnamento parigino (1252-1259) – pone le solide basi
del suo futuro edificio metafisico e teologico.
ESISTENZA: questa è semplicemente e nient’ altro che la comune realtà di
cui tutti abbiamo esperienza. Di essa non può darsi una definizione
concettuale, ma solo una descrizione, con l’ausilio dei dati che il nostro
apparato sensoriale ci fornisce di volta in volta. L’esistenza è un aliquid che
esiste extra mentem, extra causas, extra nihilum. Essa è la risposta positiva alla
domanda: “c’è qualcosa” ? (an sit); ma non ancora alla domanda: “che cos’è”?
(quid sit).
ENTE: è ciò che esiste nella forma determinata di un quid, è un “qualche
cosa”. L’esistenza dell’Ente può essere di due tipi: a) logica (cioè solo mentale,
concettuale, in mente); b) reale (realmente esistente, extra mentem).
L’ente logico è tutto ciò che può essere pensato, ma non necessariamente
esiste al di fuori della nostra mente. Esso è frutto della nostra capacità di
astrazione, ma non necessariamente esiste nel modo stesso in cui è pensato (per
esempio: la cecità è un ente logico, ma di esistente ci sono soltanto i ciechi).
17
L’ente reale invece è tutto ciò che esiste fuori della nostra mente e di cui noi
perciò predichiamo l’esistenza.
ESSENZA: è l’ ousia in senso aristotelico (il quod quid erat esse degli
Scolastici), l’insieme delle note fondamentali, delle caratteristiche sostanziali
per cui un ente si distingue da ogni altro. Essa è la risposta positiva alla
domanda: “che cos’è”? (quid sit).
Fondamento dell’ontologia tomista è la distinzione reale tra essenza ed
esistenza. In tutte le creature finite, gli enti reali (entia quae sunt), distinguiamo l’
essenza (quid sit, cioè l’ousia: pura potenza, attitudine ad esistere, ma non
necessità di esistenza), dall’ esistenza (actus essendi, cioè il vero e proprio atto di
essere, che chiamiamo semplicemente l’ “esserci “ di fatto). L’essere è perciò un
atto, che rende concreta e reale, veramente esistente, un’ essenza che di per sé è
puro “poter essere”. La metafisica tomista è pertanto, in senso forte, una
metafisica dell’essere, e non una metafisica delle essenze. Anche il Papa, nella
enciclica più volte citata, sottolinea questo aspetto: “La sua è veramente la
filosofia dell’essere e non del semplice apparire” (IV, 44).
Distinzione però non significa separazione. Essere ed essenza non sono pensabili
separatamente, ma stanno in relazione organica e dinamica come la potenza e
l’atto della metafisica aristotelica. L’ontologia tomista è perciò una dottrina del
concreto e non una filosofia dell’astratto.
2) La perfezione come “actus essendi”
Scrive Battista MONDIN, nella sua interessante opera su san Tommaso (Il sistema
filosofico di Tommaso d’Aquino, Milano, Massimo, 1985): “L’aspetto più
interessante ed originale della concezione tomistica della verità riguarda l’attenzione
che vi viene riservata all’essere. E questo è in perfetta sintonia con la sua filosofia
che è eminentemente filosofia dell’essere. L’essere è infatti per Tommaso la
perfezione suprema, fondamentale, massima, quella che permea tutte le cose
conferendo loro consistenza e realtà; per cui ogni cosa è tale in forza della sua
partecipazione all’essere ed una cosa è tanto più perfetta quanto maggiore è il suo
grado di partecipazione all’essere” (op. cit., pp. 47-48).
San Tommaso collega quindi la nozione di perfezione con quella di actus essendi. La
potenza è imperfezione, solo l’atto è perfetto. Ciascun ente realizza la propria
perfezione anzitutto esistendo: perciò l’ente reale è infinitamente più perfetto
dell’ente logico perché è “in atto”, cioè esiste. L’essere è inter omnia
perfectissimum. C’è naturalmente una gerarchia di perfezione, legata al grado di
attualità/potenzialità presente in ciascun ente.
Siamo ancora, se si vuole, all’interno del ragionamento aristotelico che, attraverso la
concatenazione di potenza ed atto, aveva guadagnato il concetto di “entelechia
prima”, di Atto Puro. Ma San Tommaso non si limita a relegare l’idea di perfezione
in questa astratta nozione di atto puro. Scrive ancora Mondin, strenuo difensore della
originalità del pensiero tomista, che San Tommaso non è “un semplice ripetitore e
neppure solo un continuatore di Aristotele, bensì l’iniziatore di un nuovo sistema
18
filosofico, fondato su una base assolutamente nuova, sconosciuta allo stesso
Aristotele, la base costituita dalla perfezione dell’essere, perfezione assoluta, radicale,
nucleo e fondamento di ogni altra perfezione” (p. 21). E ancora: “Tommaso è un
pensatore originale, che ha fatto la grande e originale scoperta che, a livello
ontologico, la perfezione massima è la perfezione dell’essere e che qualsiasi altra
perfezione è dotata di realtà soltanto nella misura in cui è partecipe della perfezione
dell’essere” (p. 21).
Su questa base – la perfezione dell’essere in quanto tale – san Tommaso (riprendo
liberamente dal testo di Mondin a pag. 62) innalza il suo possente edificio metafisico,
le cui strutture portanti sono i concetti di “essenza ed esistenza”, che in tutte le cose
osservabili sono nettamente distinti l’uno dall’altro. Essenza ed esistenza convergono
però necessariamente verso un punto d’incontro, nel quale si identificano. Questo
punto d’incontro, “pinnacolo dell’edificio”, per il credente Tommaso è l’essere stesso
(Esse ipsum”), cioè Dio. Continua Mondin: “In Lui risiede la pienezza della
perfezione dell’essere e con essa la pienezza di ogni altra perfezione. Da Lui discende
ogni sostanza, ogni virtù e ogni azione. Dio, causa prima e totale di ogni ente,
comunica ai suoi effetti realtà, verità, bontà, bellezza, valore; conferisce sostanza,
causalità e attività; li fa simili a se stesso e infonde nel loro intimo un’ansia di far
ritorno alla sorgente da cui sono usciti” (p. 62).
Citiamo qualche espressione di Tommaso:
“Esiste un essere massimale, e lo chiamiamo Dio”
“Nel modo più vero e prima di tutto chiamiamo ente Colui il cui essere non è
ricevuto, ma sussiste di per sé”
“Di tutti i nomi che si attribuiscono a Dio il primo è COLUI CHE E’, perché
comprendendo tutto in se stesso possiede l’essere medesimo, come una specie
di oceano infinito e senza limite”.
Insomma: laddove Aristotele direbbe che tutto ciò che è e che noi chiamiamo ente
esiste ed è intelligibile per il suo rapporto con la propria ousia, la sostanza; san
Tommaso invece afferma che tutto ciò che è esiste per il suo rapporto di dipendenza
dall’ Esse ipsum, Dio.
Ecco un altro fondamentale tocco di originalità: il rapporto ente-Essere non è più un
semplice rapporto di inerenza (come quello dell’accidente alla sostanza cui si
riferisce), bensì un rapporto di dipendenza causale, per il quale ogni ente (potenziale)
riceve l’essere reale da un Creatore che glielo conferisce.
Diciamo perciò: Dio dà l’essere, l’ente lo riceve; DIO E’ L’ ESSERE, L’ ENTE
HA L’ESSERE. In Dio essenza ed esistenza coincidono, nell’ente mai. L’esistenza
dell’ente è caratterizzata dalla non-necessità (Contingenza), quella di Dio dalla
necessità (Sussistenza).
Ma facendo questi discorsi abbiamo messo in pratica (senza nominarlo e definirlo) il
nucleo metodologico più importante della metafisica tomista: il principio dell’
ANALOGIA.
3) La dottrina dell’ Analogia
19
Prendendo a prestito una parola greca – appunto ANALOGIA, che significa
“somiglianza di rapporti” – San Tommaso formula la sua originale dottrina
dell’intellegibilità dell’Essere.
Dunque: se l’ente ha l’essere, mentre Dio è l’Essere stesso, non si può parlare di
identità tra Dio e le creature, tra l’essere di Dio e l’essere delle cose del mondo. Il
significato del termine essere non può quindi esser univoco. Dice Tommaso:
“Impossibile est aliquid univoce praedicari de creatura et de Deo”.
N.B. : osserviamo per inciso come quest’affermazione si collochi agli antipodi di
quella parmenidea, per cui l’essere è UNICO, in perfetta identità con tutto ciò che
esiste.
Ma, tornando a Tommaso, se è vero che non c’è perfetta identità tra l’essere di Dio e
quello delle creature, è altrettanto vero che non si può parlare di equivocità del
termine, cioè di significati completamente diversi per i due termini. Infatti, come
insegna la Rivelazione, le creature (appunto in quanto “create”, cioè fatte esistere dal
Nulla) portano in sé l’impronta del Creatore (cfr. l’idea dell’uomo fatto a “immagine
e somiglianza” di Dio).
Ma allora come si configura questo rapporto, che non è né univoco, né equivoco?
Appunto come un rapporto di Analogia, cioè un rapporto di somiglianza e
dissomiglianza insieme, di corretta proporzionalità tra termini che, pur essendo tra di
loro diversi, hanno in comune appunto l’essere. Ciò che si predica delle creature può
quindi essere predicato anche di Dio, e viceversa, purchè si facciano, come si dice nel
linguaggio popolare le “debite proporzioni”.
Qui filosofia e teologia, fides e ratio, vengono ad incrociarsi ed insieme possono
contribuire alla ricerca della verità su Dio, l’uomo e il mondo. Quello che attraverso
la ragione naturale (e quindi la filosofia e tutte le altre scienze) veniamo man mano a
scoprire circa l’uomo e la realtà possiamo, in un certo senso ed in maniera analogica,
predicarlo anche per Dio; e viceversa, quello che attraverso la fede (e quindi
l’intelligenza della fede esercitata dalla teologia) conosciamo di Dio Padre e
Creatore, Essere Supremo e divino, possiamo utilizzarlo ai fini di una più
approfondita conoscenza della vera natura e del significato dell’uomo e del mondo.
4) La nozione di partecipazione
Abbiamo già visto come la nozione di “partecipazione” fosse un caposaldo della
dottrina platonica delle idee: le idee comunicano tra di loro e, tutte insieme, con la
suprema idea di Bene; inoltre il mondo sensibile partecipa del mondo ideale, in
quanto le cose, la natura, sono “copie” delle idee. E’ probabilmente attraverso la
mediazione del Neoplatonismo e dell’ Agostinismo che la nozione di partecipazione
perviene a san Tommaso, il quale la fonde con i motivi aristotelici dandole un nuovo
ed originale rilievo.
Si tratta, ancora una volta, di rispondere al problema fondamentale della metafisica: il
rapporto UNO-MOLTI. Ma san Tommaso, a differenza dei suoi predecessori greci,
dispone di un formidabile concetto metafisico fornitogli dalla Rivelazione: l’idea di
creazione.
20
Per san Tommaso, tutto ciò che esiste è fondato, radicato in Dio, Essere
Autosussistente, Assoluto ed Infinito, che reca in sé, unitariamente e
simultaneamente, tutto ciò che appare diversificato e distinto nel grande panorama
del creato. E’l’intuizione resa vertigine poetica dal genio di Dante:
Nel suo profondo vidi che s’interna / legato con amore in un volume / ciò che
per l’universo si squaderna / sustanzia ed accidente, e lor costume / tutti con
flati insieme per tal modo / che ciò ch’io dico è un semplice lume.
( PARADISO, XXXIII, 85-90)
Nella visione cristiana gli enti finiti non si rapportano al loro fondamento assoluto nè
secondo le modalità del panteismo, comune a molte dottrine filosofiche e religiose (i
molti sono semplici “modi” di esistenza dell’ Uno, sue particolari ma sostanzialmente
indistinte determinazioni), né secondo quelle dell’emanazionismo, dottrina propria
della filosofia neoplatonica (i molti fuoriescono dall’Uno eternamente, in un flusso
continuo senza finalità e senza rapporti di dipendenza, come acqua che sgorga da una
sorgente o luce da una fonte luminosa), bensì secondo il rapporto Creatore/creatura.
Tale rapporto può configurarsi come il rapporto potenza/atto: la creatura riceve
l’esistenza (materiale e spirituale) dallo stesso Essere (che è Causa incausata e primo
motore), e rimane in stretto rapporto con lo stesso, partecipando delle sue
caratteristiche in modo proporzionale al suo grado di perfezione.
In sintesi: solo Dio, Atto puro ed infinito, Ente che è l’Essere, è autosussitente.
Attraverso un’iniziativa libera e gratuita, che rimane per noi misteriosa ed
inattingibile, Dio pone contemporaneamente in ogni ente la potenza di essere
(materia) e l’attualità che gli compete (forma), determinandone l’esistenza e la
fuoriuscita dal nulla. Ogni ente poi non rimane “tagliato fuori”, estraneo ed
indipendente dalla vita di Dio, ma permane innestato in essa con un rapporto di
autentica comunione (figliolanza/fraternità).
5) I TRASCENDENTALI: uno, vero, bene
Partecipare all’essere significa anche partecipare – s’intende sempre in forma
analogica, proporzionale – dei connotati fondamentali, delle determinazioni profonde
dell’Essere stesso. Nel linguaggio aristotelico-scolastico queste connotazioni si
chiamano: i trascendentali. Il termine sta ad indicare qualche cosa che accompagna
inseparabilmente una certa essenza, “trascendendo” ogni particolarità. Secondo la
maggior parte degli autori i trascendentali in san Tommaso sono 3 (unità / verità /
bontà), ma altri vi aggiungono anche la realtà e la bellezza.
UNITA’ (omne ens est unum). L’unità è la prima e più importante proprietà
essenziale dell’essere. Dire che l’essere è uno, significa dire che non è diviso
(unità reale) e non è contraddittorio (unità logica), ma è intrinsecamente se
stesso. L’unità dipende dal grado di essere che si possiede, nel senso che
quanto maggiore è il grado di essere che si possiede, tanto maggiore è l’unità.
Naturalmente è vero anche il contrario: ma la filosofia tomista rimane una
filosofia dell’Essere, in cui l’unità è una proprietà essenziale, ma non il
21
fondamento ultimo (nel Neoplatonismo, invece, il divino è l’Uno, mentre
l’essere è un grado ipostatico dell’Uno) che è l’esse ipsum. L’unità di Dio è
assoluta, semplice, totale, in quanto piena coincidenza di essenza ed esistenza;
mentre l’unità dell’ente è sempre un’unità composta (essenza+esistenza). Va
precisato che questa unità trascendentale ha un significato esclusivamente
metafisico e non numerico (aspetto quantitativo che si riferisce esclusivamente
agli enti corporei): perciò il Dio dei cristiani può essere tranquillamente e non
contraddittoriamente “Uno e Trino”.
VERITA’ (omne ens est verum). Ogni ente in quanto tale è intellegibile, e può
essere oggetto della nostra conoscenza razionale, in quanto possiede,
proporzionalmente al proprio essere , un certo grado di oggettiva verità. L’esse
ipsum è la Verità assoluta e totale, perciò costituisce l’oggetto più adeguato
della nostra capacità conoscitiva, che cerca appunto la verità di ogni cosa. Se il
vero è una proprietà dell’essere, la ricerca della verità non può essere una
questione solo logica (come in Aristotele), ma diventa ontologica. Ciò vuol
dire che il problema della verità non riguarda soltanto il rapporto tra il nostro
intelletto e la realtà (adaequatio intellectus nostri ad rem), ma anche il modo in
cui quest’ultima si riferisce oggettivamente all’essere divino (adaequatio rei
ad intellectum Dei). Scrive GRENET : “Poiché il pensiero ha come oggetto
formale l’essere, ed ogni essere è, in quanto essere, oggetto di pensiero, il
VERO è detto dalla mente solo in base al suo rapporto con l’essere, e
dell’essere solo in quanto la mente ha rapporto con l’essere” (op.cit., p. 246).
Insomma: anche la verità (come già l’unità ontologica) dipende dal grado di
essere che ciascun ente possiede. Dio, che è Sommo Essere, è perciò somma
verità, sia in senso ontologico che logico. Tutti gli altri enti sono più o meno
razionali e più o meno intrinsecamente veri (corrispondenti al modello divino)
a seconda del grado di partecipazione all’essere.
BONTA’ (omne ens est bonum). Scrive Tommaso : “ Dio ama tutti gli esseri
esistenti, perché tutto ciò che esiste in quanto esiste è buono ; infatti l’essere di
ciascuna cosa è un bene, come è un bene del resto ogni sua perfezione. Ora la
volontà di Dio è causa di tutte le cose e per conseguenza ogni ente ha tanto di
essere e di bene nella misura che è oggetto della volontà di Dio. Dunque ad
ogni essere esistente Dio vuole bene. Perciò, siccome amare vuol dire volere
ad uno del bene, è evidente che Dio ama tutte le cose esistenti. Dio, però, non
ama come noi. La nostra volontà infatti non causa il bene che si trova nelle
cose; al contrario è mossa da esso come dal proprio oggetto; e quindi il nostro
amore con il quale noi vogliamo del bene a qualcuno, non è causa della bontà
di costui, chè anzi la di lui bontà, vera o supposta, provoca l’amore che ci
spinge a volere che gli sia mantenuto il bene che possiede e acquisti quello che
non ha, e ci adoperiamo a tale scopo. L’ amore di Dio invece infonde e crea la
bontà delle cose” (S. theolog., I, 20, 2).
Il bene è l’essere visto nella sua proporzionalità al desiderio, cioè alla tendenza
alla propria perfezione che è insita in ogni ente. Bene ed essere coincidono:
22
infatti se la perfezione per un ente è il suo “actus essendi”, la sua entelechia,
sarà proprio questo actus essendi, in quanto télos dell’ente, il suo bene. Ogni
cosa è buona, insomma, in quanto è; ed è tanto più o tanto meno buona in
proporzione al suo grado di essere. Ma – in più rispetto alla semplice idea di
essere – l’idea di bene esprime e sottolinea il tema del “desiderio”, della
“appetibilità”, della tensione di ogni creatura verso la propria perfezione.
Dio è Sommo Bene, Assoluta Bontà. Solo Dio è “essenzialmente” buono; e
solo Dio è causa prima, efficiente e finale di ogni bontà. Tutte le creature,
esistendo, partecipano di questa divina bontà: tutto ciò che esiste, dunque, in se
stesso e nell’insieme, è buono, perché possiede, in proporzione al proprio
essere, un certo grado di perfezione e di bene, in analogia con la bontà somma
di Dio. La metafisica tomista è una metafisica OTTIMISTICA. E non solo
perché tutte le cose partecipano della divina bontà per il solo fatto che esistono;
ma anche perché il desiderio di perfezione che è insito in ogni creatura non è
un appello vano ed inutile, una tensione velleitaria ed illusoria: Dio, somma
perfezione, comunica la propria bontà e si pone come il bene supremo e finale
per ogni ente.
La ragionevole speranza di perfezione da parte dell’uomo s’incontra – nel
mistero della partecipazione alla vita divina – con la bontà liberamente e
gratuitamente effusa da Dio. Il Dio cristiano, a differenza di quello aristotelico,
è un Dio che ama, che ha creato tutto per amore, che crea le cose amando e,
amandole, le fa esistere ed essere buone.
L’uomo si affeziona agli altri enti e li desidera in quanto buoni, ma, amandoli,
trascende se stesso e tutte le cose, collocandosi all’interno stesso del mistero
dell’ amore divino. San Tommaso afferma, nel suo De veritate : “Tutti gli
esseri conoscenti conoscono implicitamente Dio in ogni cosa conosciuta”. Noi
potremmo aggiungere anche che, amando in modo giusto ed onesto tutte le
cose, si ama implicitamente Dio.
6) La questione del “bello”
Abbiamo detto che alcuni autori includono tra i trascendentali di Tommaso anche la
bellezza. In realtà Tommaso non ne parla, ma la scelta degli interpreti di cui sopra
non è del tutto arbitraria. Basta intendersi! Tommaso infatti non elenca il bello tra gli
altri trascendentali per la semplice ragione che per lui (come del resto per tutta la
cultura medievale) il bello si identifica con il bene: la bellezza è un elemento
intrinseco della perfezione, un costitutivo della forma.
La perfezione dell’ actus essendi include sostanzialmente la bellezza, ma questa
risulta e risplende solo nell’atto conoscitivo. La forma di un essere, in quanto
realizzata nella sua perfezione attuale , è il bene di un ente; in quanto riconosciuta ed
apprezzata dal soggetto conoscente è il bello di un ente. Dice Tommaso: “Il bello
riguarda la facoltà conoscitiva: belle sono infatti quelle cose che viste destano
piacere (pulchra sunt quae visa placent)”.
Il bello è dunque come il manifestarsi della interiore unità della forma di un ente
(livello ontologico) nella esteriorità sensibile (livello fenomenologico). Questa
23
manifestazione, secondo Tommaso, esige tre condizioni: “Per la bellezza si
richiedono tre doti. In primo luogo integrità e perfezione: poiché le cose incomplete,
proprio in quanto tali, sono deformi. Quindi si richiede debita proporzione o
armonia tra le parti. Finalmente chiarezza e splendore: difatti diciamo belle le cose
dai colori nitidi e splendenti” (S. theolog., I, 39, 8, c).
Integrità e perfezione – debita proporzione fra le parti – chiarezza e splendore:
queste sono le caratteristiche dell’esperienza estetica secondo Tommaso. Si tratta,
come si vede, di un ideale estetico ancora legato alla visione classica del bello: la
bellezza è una proprietà oggettiva dell’essere, che scaturisce sì nell’esperienza
sensibile e nel giudizio particolare del soggetto conoscente, ma non ha la sua radice
nel bisogno soggettivo del singolo. Secondo la celebre definizione del maestro di
Tommaso, Alberto Magno, la bellezza è: Splendor Formae. Il bello è ontologico, è
proprietà fondamentale dell’essere, è un trascendentale che si accompagna
inseparabilmente all’ actus essendi, secondo le gradazioni e le sfumature proprie della
gerarchia dell’essere.
N.B. Facciamo qui un piccolo accenno all’estetica kantiana per avere almeno un’idea
sommaria del procedimento che ha portato l’estetica moderna a rifiutare ogni
fondamento ontologico per radicarsi esclusivamente nella coscienza soggettiva.
Per Kant il bello non è una proprietà ontologica del reale, ma un “giudizio” che
scaturisce dal rapporto tra il soggetto e l’oggetto. In particolare, il giudizio estetico
(che è un giudizio riflettente e non un giudizio determinante; quindi privo di ogni
valore conoscitivo) avrebbe l’effetto di produrre una sorta di armonia tra natura e
libertà (termini tra loro antitetici), tra la conoscenza e la volontà, al solo fine di un
piacere soggettivo, di una delectatio. L’estetica kantiana non ha una finalità etica, ma
si propone esclusivamente di garantire al soggetto un godimento spirituale ed
un’interiore elevazione. E’ una sorta di gioco elegante, nobile e raffinato, che non ha
tuttavia tra i suoi fini quello di introdurci più a fondo nella realtà e di farci conoscere
la verità ultima delle cose (e quindi l’Esse ipsum che le fonda).
7) Le principali obiezioni dei contemporanei ai trascendentali
Raccogliamo in rapidissima sintesi il contenuto delle principali obiezioni che il
pensiero moderno e contemporaneo ha indirizzato alla dottrina ontologica dei
trascendentali dell’essere.
La negazione dell’unità ontologica. L’essere non è Uno – non solo
logicamente, come vuole per esempio la dialettica hegeliana degli opposti, ma
anche storicamente, come afferma per esempio la dialettica marxiana – ma è
frammentato in una pluralità di esseri, che sono “differenti” ed irriducibili tra
di loro. Così è per esempio per l’ esistenzialismo, per il quale esistono soltanto
i molti soggetti, i diversi “io”, ciascuno a sé stante, incomunicabili fra di loro;
oppure esistono come delle “zone” assolutamente eterogenee di essere (cfr.
Sartre, che oppone irriducibilmente un in-sè materiale ad un per-sè
coscienziale, rinunciando definitivamente ad ogni sintesi del tipo di quella
hegeliana). Fa eccezione Heiddeger, per il quale c’è una sorta di riapparizione
24
dell’essere come orizzonte comune di tutti gli enti, ma il senso di questa
riapparizione è subito limitato dal concetto di differenza ontologica, con cui si
stabilisce “il non tra ente ed essere” e si sancisce l’impossibilità per ogni ente
di attingere l’essere.
La negazione della verità ontologica. Si parte dagli estremi dell’assurdismo
(Sartre/Camus) e dello scetticismo (Rensi) per arrivare alla verità intesa solo
come proposizione scientifica verificabile (positivismo/neopositivismo) o
come utilità personale e/o sociale (pragmatismo/utilitarismo).
La negazione del bene ontologico. Si identifica il bene con l’utile
(utilitarismo), con ciò che è “conveniente” in una determinata situazione
(relativismo/situazionismo). Comunque si afferma che il bene non è proprio
dell’essere ma della capacità valutativa della coscienza. Nel migliore dei casi
rimane un ideale, una tensione continua ed un’aspirazione irrealizzabile della
volontà dell’io o del collettivo sociale.
La negazione del bello ontologico. Già nella breve esemplificazione
sull’estetica kantiana abbiamo visto la riduzione del bello ontologico ad attività
armonizzatrice della coscienza soggettiva. Il bello non è più una proprietà
oggettiva dell’essere, ma una condizione soggettiva. Se anche si sfugge alla
arbitrarietà più bieca (bello è ciò che piace), si rimane comunque nell’ambito di
una criteriologia che ha sede nella coscienza e non nell’essere. L’estetica
crociana ha il doppio merito di restituire all’estetica un valore conoscitivo e di
tentarne una fondazione oggettiva, pur in una piena autonomia dalle altre
attività spirituali: ma si pone contro ogni radicamento ontologico dell’idea di
bello e ne esclude ogni valenza di tipo etico.
CONCLUSIONI
I limiti propri del corso mi costringono a mettere qui la parola fine. Mi limito perciò a
segnalare molto succintamente almeno tre tornanti fondamentali che un’eventuale
ricerca di approfondimento del tema trattato dovrebbe assolutamente prendere in
considerazione.
La crisi della metafisica in Kant. Kant sancisce l’impossibilità di una
conoscenza scientifico-razionale dell’essere e afferma la conseguente riduzione
della metafisica ad aspirazione interiore del soggetto. La trascendentalità non è
una proprietà dell’essere, ma una struttura formale del soggetto conoscente.
Hegel: il confinamento dell’ontologia nella logica. L’idea di essere è l’idea
più elementare e più povera di determinazioni che la nostra mente possa
concepire. L’ontologia è dunque il principio della logica, ma in quest’ultima
l’ontologia subito si dissolve, perché l’essere pensato nella sua completa
astrattezza, privo di ogni determinazione particolare, è identico al nulla, e
perciò svanisce subito, lasciando tutto lo spazio al divenire, che è sintesi di
essere e non essere. Il concetto assoluto non è la Realtà, ma la Ragione: quella
che noi chiamiamo comunemente realtà non è altro che un momento transeunte
del cammino di autorealizzazione della ragione come Spirito Assoluto.
25
L’esistenzialismo fenomenologico. L’essere è presente alla coscienza come suo
oggetto intenzionale (Husserl), oppure si rivela nel Dasein, l’esser-ci
(Heiddeger), o ancora appare in entrambi (Hartmann): ma resta comunque al di
là sia del pensiero, sia dell’ente. Heiddeger introduce il concetto di differenza
ontologica per sostenere che l’essere non è definibile con le categorie proprie
del pensiero razionale, perché manca degli elementi che costituiscono la
possibilità stessa della definizione (genere prossimo/differenza specifica),
ponendosi come puro trascendimento; non è neppure riconducibile ad “ente”
(neppure al più alto della possibile scala di enti) perché non gli si possono
attribuire i “predicati ontici” che permettono l’individuazione dell’ente.
Perchè si rifiuta la metafisica? Le principali ragioni del rifiuto.
Nel bel libro di Adriano Alessi, Metafisica (LAS, Roma, 1992) si trova una
eccellente esposizione sintetica delle principali obiezioni nei confronti della validità
della metafisica (pg.15 e segg.).
- Anzitutto se ne contesta la validità teoretica. Paradigmatica, per la sua radicalità, è
la posizione di Nietzsche, che accusa la metafisica di essere nient’altro che una
“menzogna” (come per altro la religione e la morale). Si tratta di nient’altro che di un
“lunghissimo errore”, imperniato sul dualismo essere-divenire, verità-menzogna,
mondo vero-mondo delle apparenze e sull’astratta e dogmatica asserzione che un solo
elemento di questa polarità (il vero, il bene, il fondamento, la cosa in sé) è vero,
valido e reale. In verità “l’essere è una vuota finzione. Il mondo “apparente” è l’unico
mondo; il “vero mondo” è solo un’aggiunta mendace” (Crepuscolo degli idoli. Cfr.
anche, nella stessa opera, l’aforisma intitolato: Come il “mondo vero” finì per
diventare favola).
- Altre posizioni contestano la portata esistenziale del pensiero metafisico, accusato
di disumanità e di violenza. Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti, ad esempio, i
sostenitori del cosiddetto “pensiero debole”, criticano la metafisica come “ideologia
legata all’insicurezza e al dominio che da essa deriva” , ricordando che “il pensiero
della verità non è il pensiero che “fonda”, come pensa la metafisica, anche nella sua
versione kantiana; bensì quello che, esibendo la caducità e la mortalità proprio come
ciò che fa l’essere, opera uno sfondamento”. E continuano affermando che “oggi non
è più tempo di principi superiori, di fini ultimi, di verità definitive”; che “l’idea di
sistema e anche solo quella di “definizione” diventano impraticabili, non
convenienti”, concludendo che “non è possibile librarsi in volo e liberamente spaziare
come un uccello nell’aria: forse l’unica alternativa è imparare a strisciare imitando il
serpente, poiché solo aderendo alla terra avremo una possibilità di sollevarci sopra di
essa” (cfr. Il pensiero debole, a cura di G.Vattimo e P.A. Rovatti, Feltrinelli, Milano,
1983).
26
- C’è infine una critica che proviene da ambienti fideistici che mette in discussione la
valenza religiosa del pensiero metafisico. Sulla scia di Lutero, ad esempio, il teologo
Karl Barth sostiene che ogni ricerca che pretenda di fondare razionalmente i
preambula fidei è palesemente empia, in quanto pretende di far dipendere la scelta di
fede da qualcosa di diverso dalla semplice accoglienza della parola di Dio.
Ma – in modo ancora più articolato – è possibile raggruppare le obiezioni alla
metafisica secondo questo quadruplice schema.
A) Obiezioni che nascono dal carattere illusorio o problematico del conoscere.
A questo gruppo appartengono sia le antiche posizioni della sofistica e dello
scetticismo, che ritengono impossibile pervenire ad una qualunque forma di certezza
o di verità razionale, sia le più aggiornate posizioni del relativismo e del
problematicismo. Il primo proclama l’impossibilità di pervenire a verità assolute,
universalmente valide, in quanto ogni conoscenza sarebbe inesorabilmente legata a
condizionamenti di ordine culturale, spaziale e temporale ed ogni affermazione
teoretica è solo espressione di una cultura determinata e storicamente definita.
Insomma: ciò che ieri appariva assolutamente certo, oggi risulta inevitabilmente
insufficiente ed aleatorio; ciò che alcuni ammettono come assoluta verità è negato da
altri come illusorio od ipotetico. Quanto al problematicismo, esso afferma che il
contenuto del sapere e della ricerca non è un vero, ma un problema. Il pensiero non
può pertanto rimanere vincolato all’oggettività del reale, ma deve esprimersi come
infinita libertà, scevro da ogni predeterminazione o preconcetto, costruendo semmai
una sistematica aperta e progressiva del sapere ( Banfi). La filosofia non sarebbe
altro che una continua ed insoddisfatta “aspirazione alla filosofia” (Spirito).
B) Obiezioni in nome del valore e della natura dell’esperienza.
L’esperienza umana è, per sua natura, limitata, particolare, confinata
irrimediabilmente al campo della realtà sensibile. I nostri sensi sono invalicabili: non
possiamo perciò avere alcuna conoscenza di ciò che starebbe oltre o al di sopra di
essi. Questo è il nocciolo della tesi empirista, che ha i suoi campioni in Bacone,
Hobbes, Locke, Hume, Stuart Mill. Il positivismo, iniziato da August Comte e
continuato da Spencer in Inghilterra, da Ardigò in Italia e da Haeckel in Germania,
ribadisce questi principi e riconosce validità ai soli dati verificabili (appunto ciò che è
“posto”, positivum). L’unica forma di conoscenza valida è perciò la scienza, che si
attiene solo ai fatti, ne studia le cause e ne prevede gli sviluppi.La metafisica è
assurda ed insostenibile, sapere fittizio ed illusorio.
Anche per il neopositivismo (Carnap, Russell, Neurath, Schlick, Ayer) solo la
scienza ha valore conoscitivo, mentre la metafisica è semplicemente “insensata”, in
quanto costituita da proposizioni non verificabili. “Né Iddio né alcun diavolo
potranno mai darci una metafisica” (Carnap). “La metafisica è poesia in concetti”
(Hans Reichenbach). “La maggior parte delle questioni filosofiche sono prive di
senso” (Wittgenstein).
C) Obiezioni fatte in nome del primato del soggetto
27
Da Cartesio in poi si accentua la consapevolezza che non si dà conoscenza
dell’oggetto se non nella misura e secondo le condizioni stabilite dal soggetto. Come
si può pretendere di conoscere la realtà in se stessa, il suo nucleo ultimo ed
essenziale, se tutto ci è dato solo attraverso la mediazione imprescindibile del
soggetto?
Il fenomenismo kantiano nega la validità conoscitiva della metafisica (declassandola
a semplice aspirazione, sia pure irrinunciabile, della coscienza, a puro ideale della
ragione) perché si può conoscere solo attraverso una interazione di “forme a priori”
dell’intelletto e di “dati di fatto” della esperienza sensibile. La realtà in sé rimane
inattingibile : si può solo pensarla esistente (noumeno), ma non conoscerla
scientificamente alla stregua dei fenomeni.
Con l’assolutizzazione idealistica del soggetto la realtà diventa un momento
dialettico del processo storico di autocostruzione dell’Io (il “non-io” di Fichte, la
“preistoria della coscienza” di Schelling, la “natura” di Hegel : in una parola
l’objectum che si oppone al subjectum, l’antitesi che si oppone alla tesi). La
metafisica è, per Hegel, un “vecchio modo di vedere”, una “mera veduta
intellettualistica degli oggetti della ragione”, divenuta infine un puro “dogmatismo”
per la sua pretesa che “mediante la riflessione si conosca la verità e si acquisti la
coscienza di ciò che gli oggetti veramente sono” e che “di due affermazioni opposte
l’una dovesse essere vera e l’altra falsa” (cfr. Enciclopedia delle scienze filosofiche in
compendio, 1817, §§ 26-36).
Per l’esistenzialismo, l’interesse si sposta dall’essere al singolo. Solo quest’ultimo
conta, solo ciò che lo riguarda è conoscibile, solo ciò che a lui risulta esiste. La
metafisica è soltanto astrattezza e generalità, mentre il singolo è concreto e
particolare. Kierkegaard inoltre accusa la metafisica di essere la principale
responsabile della “confusione” che domina i tempi moderni, confusione che consiste
“nell’aver abolito l’abisso immenso della differenza qualitativa fra Dio e l’uomo”
(cfr. Diario, n° 1293). Le categorie della metafisica sono astratte; non solo, ma anche
sostanzialmente irreligiose. Mentre “il Singolo è la categoria attraverso la quale
devono passare – dal punto di vista religioso – il tempo, la storia, l’umanità… Con
questa categoria sta e cade la causa del Cristianesimo, dopo che lo sviluppo del
mondo ha raggiunto il grado attuale di riflessione” (ib. N° 1348).
Per J.P. Sartre poi, poiché “l’esistenza precede l’essenza” (cfr. L’esistenzialismo è un
umanismo, 1946) vengono a cadere e a dissolversi tutte quelle forme di conoscenza e
di comprensione del reale che pretendono di attingere all’universale e al necessario.
Nello stesso Heiddegger, in cui si manifesta una forte volontà di riattingere l’essere,
in realtà tutto si concentra sull’esserci (Dasein), sulle sue caratteristiche
imprescindibili di finitezza e storicità, per cui risulta impossibile parlare in senso
proprio di metafisica. Si rimane nel campo dell’antropologia filosofica.
D) Obiezioni che partono dal primato della prassi.
La cultura occidentale è stata da sempre contrassegnata dal dominio della teoria sulla
prassi. Per molti pensatori s’impone perciò l’istanza di un capovolgimento. Capofila
di questa “rivoluzione culturale” è Karl Marx, di cui ricordiamo un famoso detto: “I
filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il mondo, ma si tratta di
28
trasformarlo” (Tesi su Feuerbach, n° 11, 1845). E ne L’ideologia tedesca (1846)
scrive: “La produzione delle idee, delle rappresentazioni, della coscienza, è in primo
luogo direttamente intrecciata all’attività materiale e alle relazioni materiali degli
uomini…Sono gli uomini i produttori delle loro rappresentazioni, idee, ecc., ma gli
uomini reali, operanti, così come sono condizionati da un determinato sviluppo delle
loro forze produttive.. Di conseguenza la morale, la religione, la metafisica e ogni
altra forma ideologica, e le forme di coscienza che ad esse corrispondono, non
conservano oltre la parvenza dell’autonomia. Esse non hanno storia, non hanno
sviluppo, ma gli uomini che sviluppano la loro produzione materiale e le loro
relazioni materiali trasformano, insieme con questa loro realtà, anche il loro pensiero
e i prodotti del loro pensiero. Non è la coscienza che determina la vita, ma la vita che
determina la coscienza” (I, A). Il criterio della prassi come criterio di verità è
chiaramente affermato nella seconda delle Tesi su Feuerbach: “Il problema se il
pensiero umano abbia una verità oggettiva non è un problema teorico, ma pratico.
Nella prassi l’uomo deve dimostrare la verità, cioè la realtà e la potenza, la
concretezza del suo pensiero”. Questo è un caposaldo fondamentale di tutta la
filosofia marxista. Basti, a conferma di ciò, questa breve citazione da Lenin: “Il punto
di vista della vita, della pratica, deve essere il punto di vista primo e fondamentale
della teoria della conoscenza” (Materialismo ed empiriocriticismo, 1908).
Anche per il pragmatismo americano (Peirce, James, Dewey) il criterio della verità
consiste esclusivamente nella sua utilità in relazione alle esigenze vitali degli
individui. Il conoscere non è altro che un momento propedeutico alla “pratica
manipolativa”, il cui criterio di legittimità è l’utilità, l’efficacia. Come scrive Peirce,
“la verità di una concezione poggia esclusivamente sulle sue relazioni con la condotta
della vita” (Che cos’è il pragmatismo). La metafisica come ricerca disinteressata di
una sapienza prima ed ultima, finalizzata al solo bisogno di conoscere la verità e
priva di conseguenze pratiche immediate (non di solo pane vive l’uomo), non è una
forma di conoscenza legittima e sostenibile.
Anche in una certa parte della riflessione teologica (la etichettiamo sbrigativamente
con l’espressione teologia della liberazione) la prassi viene prima della teoria. La
filosofia, la metafisica, la stessa teologia non darebbero altro che “universi
fantomatici di occultamento della realtà” (H. Assmann). Non esiste alcuna verità
oggettiva, ontologica, che preceda la prassi: la verità della verità è la prassi. Scrive
padre E. Schillebeeckx: “La Chiesa per secoli si è occupata principalmente di
formulare delle verità, mentre non faceva quasi nulla perché si costruisse un mondo
migliore. In altre parole, si limitò all’ortodossia e si ridusse a lasciare l’ ortoprassi
nelle mani di chi era fuori della Chiesa e dei non credenti” (I cattolici olandesi,
1970). Quindi anche nella Chiesa, nella teologia, il primato spetta all’ortoprassi.
L’aiuto che può venire dalla riflessione metafisica è insignificante – se non
addirittura fuorviante . “Il terreno del non empirico è sdrucciolevole” (Paul Van
Buren), perciò meglio puntare tutto sulla presenza dei cristiani nella società, sui
processi di liberazione dalle varie dipendenze, sull’agire sociale e politico del popolo
di Dio.
29