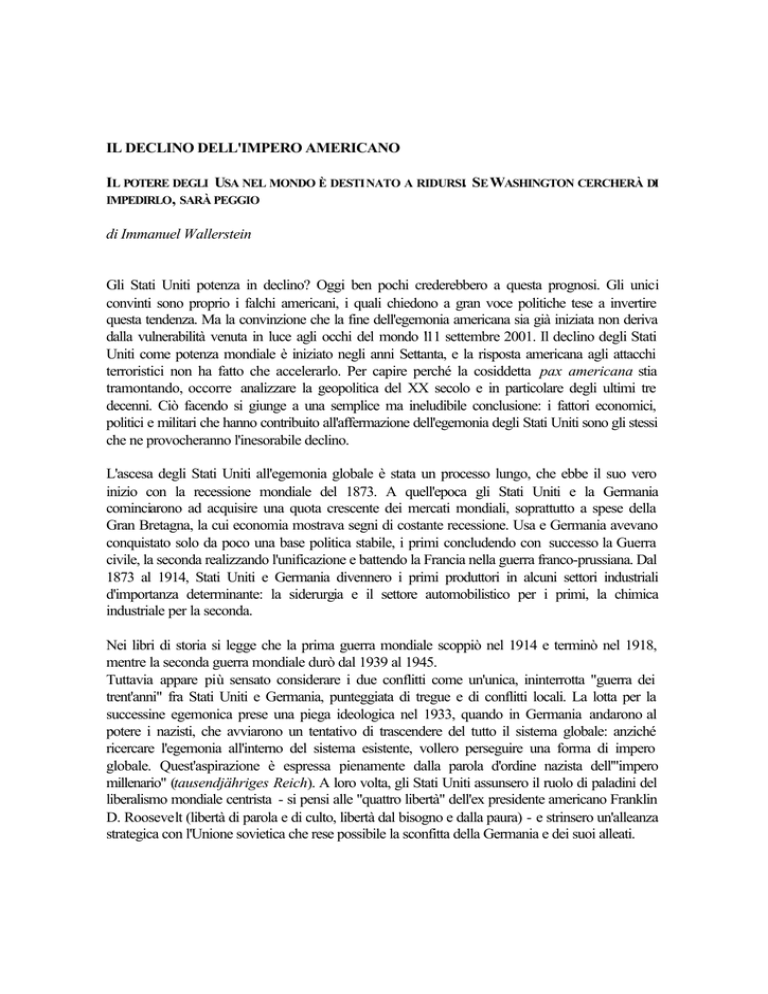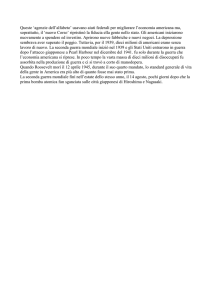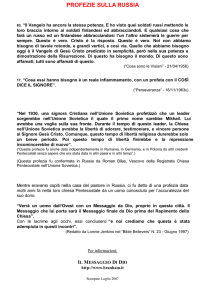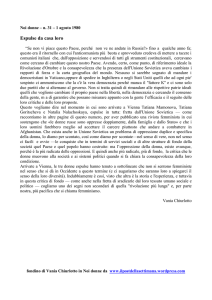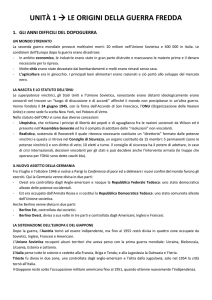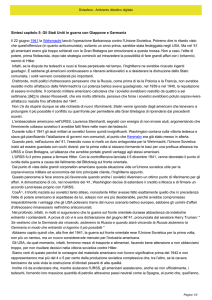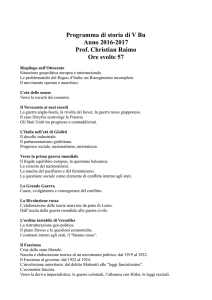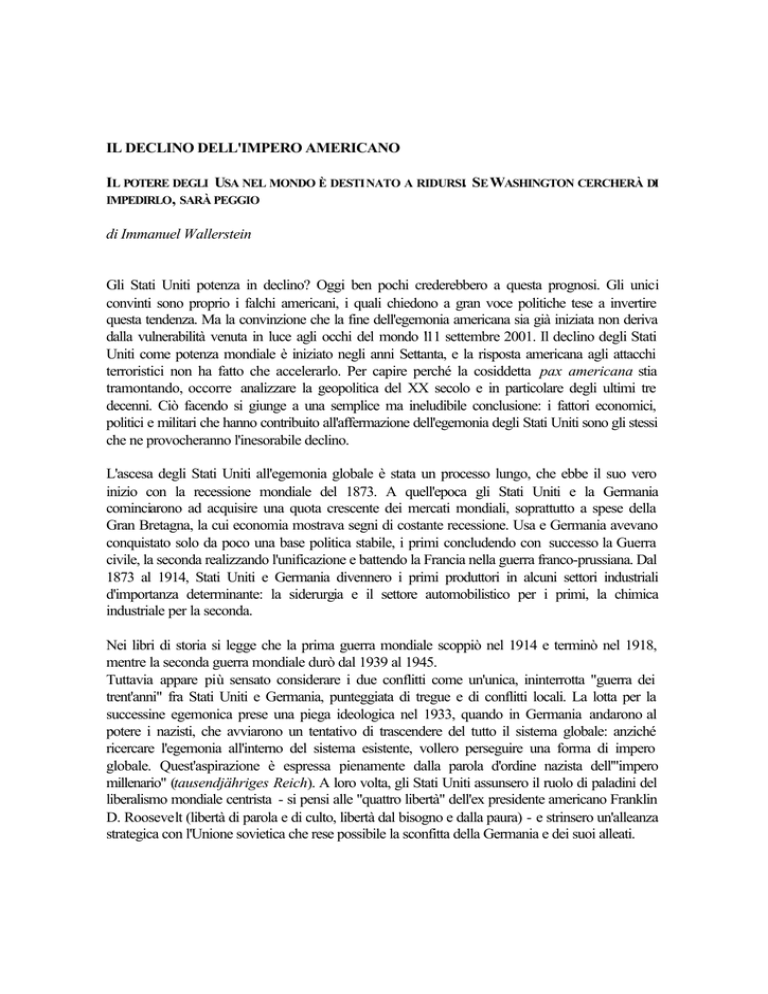
IL DECLINO DELL'IMPERO AMERICANO
IL POTERE DEGLI USA NEL MONDO È DESTINATO A RIDURSI. SE WASHINGTON CERCHERÀ DI
IMPEDIRLO, SARÀ PEGGIO
di Immanuel Wallerstein
Gli Stati Uniti potenza in declino? Oggi ben pochi crederebbero a questa prognosi. Gli unici
convinti sono proprio i falchi americani, i quali chiedono a gran voce politiche tese a invertire
questa tendenza. Ma la convinzione che la fine dell'egemonia americana sia già iniziata non deriva
dalla vulnerabilità venuta in luce agli occhi del mondo l'11 settembre 2001. Il declino degli Stati
Uniti come potenza mondiale è iniziato negli anni Settanta, e la risposta americana agli attacchi
terroristici non ha fatto che accelerarlo. Per capire perché la cosiddetta pax americana stia
tramontando, occorre analizzare la geopolitica del XX secolo e in particolare degli ultimi tre
decenni. Ciò facendo si giunge a una semplice ma ineludibile conclusione: i fattori economici,
politici e militari che hanno contribuito all'affermazione dell'egemonia degli Stati Uniti sono gli stessi
che ne provocheranno l'inesorabile declino.
L'ascesa degli Stati Uniti all'egemonia globale è stata un processo lungo, che ebbe il suo vero
inizio con la recessione mondiale del 1873. A quell'epoca gli Stati Uniti e la Germania
cominciarono ad acquisire una quota crescente dei mercati mondiali, soprattutto a spese della
Gran Bretagna, la cui economia mostrava segni di costante recessione. Usa e Germania avevano
conquistato solo da poco una base politica stabile, i primi concludendo con successo la Guerra
civile, la seconda realizzando l'unificazione e battendo la Francia nella guerra franco-prussiana. Dal
1873 al 1914, Stati Uniti e Germania divennero i primi produttori in alcuni settori industriali
d'importanza determinante: la siderurgia e il settore automobilistico per i primi, la chimica
industriale per la seconda.
Nei libri di storia si legge che la prima guerra mondiale scoppiò nel 1914 e terminò nel 1918,
mentre la seconda guerra mondiale durò dal 1939 al 1945.
Tuttavia appare più sensato considerare i due conflitti come un'unica, ininterrotta "guerra dei
trent'anni" fra Stati Uniti e Germania, punteggiata di tregue e di conflitti locali. La lotta per la
successine egemonica prese una piega ideologica nel 1933, quando in Germania andarono al
potere i nazisti, che avviarono un tentativo di trascendere del tutto il sistema globale: anziché
ricercare l'egemonia all'interno del sistema esistente, vollero perseguire una forma di impero
globale. Quest'aspirazione è espressa pienamente dalla parola d'ordine nazista dell'"impero
millenario" (tausendjähriges Reich). A loro volta, gli Stati Uniti assunsero il ruolo di paladini del
liberalismo mondiale centrista - si pensi alle "quattro libertà" dell'ex presidente americano Franklin
D. Roosevelt (libertà di parola e di culto, libertà dal bisogno e dalla paura) - e strinsero un'alleanza
strategica con l'Unione sovietica che rese possibile la sconfitta della Germania e dei suoi alleati.
La seconda guerra mondiale provocò colossali devastazioni delle infrastrutture e delle popolazioni
di tutta l'Eurasia - dall'Oceano Atlantico al Pacifico - che non risparmiò quasi nessun paese.
L'unica grande potenza industriale del mondo a emergerne incolume, anzi rafforzata sul piano
economico, furono gli Stati Uniti, che passarono rapidamente a consolidare le posizioni raggiunte.
Tuttavia l'aspirante egemone si trovò di fronte ad alcuni ostacoli pratici di natura politica. Durante
la guerra, le potenze alleate avevano concordato di istituire l'Organizzazione delle Nazioni Unite,
composta prevalentemente da paesi che avevano fatto parte della coalizione contro le potenze
dell'Asse. La caratteristica determinante dell'Onu era il Consiglio di Sicurezza, l'unica struttura che
potesse autorizzare l'uso della forza. Ma in pratica, il Consiglio finì con l'essere privo di vero
mordente, dal momento che la Carta delle Nazioni Unite conferiva il diritto di veto a cinque
potenze, compresi gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. In questo senso, non fu la fondazione delle
Nazioni Unite, nell'aprile del 1945, a determinare il quadro politico della seconda metà del XX
secolo, quanto piuttosto il vertice fra il presidente americano Roosevelt, il premier britannico
Churchill e il leader sovietico Stalin, svoltosi due mesi prima a Yalta.
Degli accordi conclusi a Yalta, quelli formali furono meno importanti di quelli informali e taciti, la
cui lettura è possibile soltanto osservando il comportamento tenuto dagli Stati Uniti e dall'Unione
Sovietica negli anni seguenti. L'8 maggio del 1945, quando la guerra finì in Europa, truppe
sovietiche e occidentali (cioè americane, britanniche e francesi) venero stazionate in determinate
località, ma essenzialmente lungo una linea che attraversava il centro del continente e che venne
chiamata "linea dell'Oder-Neisse". A parte qualche aggiustamento secondario, quelle truppe
rimasero lì. Retrospettivamente si può dire che a Yalta le due parti concordarono che potevano
restare lì e che nessuna delle due avrebbe usato la forza per estromettere l'altra. Quel tacito
accordo si applicava anche all'Asia, come dimostra l'occupazione americana del Giappone e la
divisione della Corea. Pertanto, sotto il profilo politico, Yalta fu un accordo sullo status quo in
base al quale l'Unione Sovietica controllava circa un terzo del mondo e gli Stati Uniti il resto.
Ma Washington si trovò di fronte anche minacce militari più serie. L'Unione Sovietica disponeva
delle forze di terra più numerose del mondo, mentre il governo americano subiva pressioni interne
a ridurre le dimensioni delle forze armate, in particolare ponendo fine al sistema della leva militare.
Gli Stati Uniti decisero pertanto di affermare la propria potenza militare non per mezzo delle forze
di terra, ma attraverso il monopolio degli armamenti nucleari (oltre che per mezzo di un'aviazione
in grado di dispiegarli). Ma ben presto quel monopolio venne meno: nel 1949 anche l'Unione
Sovietica mise a punto armi nucleari. Da allora, gli Stati Uniti si sono ridotti a tentare d'impedire
l'acquisizione di armamenti nucleari (oltre che chimici e biologici) da parte di sempre nuovi paesi,
tentativo che oggi, nel XXI secolo, non sembra perfettamente riuscito.
Fino al 1991 gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica sono coesistiti in quell'"equilibrio del terrore" che
chiamiamo Guerra Fredda, una condizione messo a dura prova soltanto tre volte: con il blocco di
Berlino del 1948-49, con la guerra di Corea nel 1950-53 e con la crisi missilistica di Cuba del
1962. In ciascuno dei tre casi, l'esito è stato il ripristino dello status quo. Per giunta, si noti che
ogni volta che l'Unione Sovietica si è trovata davanti a una crisi politica fra i suoi regimi-satellite (la
Germania dell'est nel 1953, l'Ungheria nel 1956, la Cecoslovacchia nel 1968 e la Polonia nel
1981), gli Stati Uniti hanno reagito facendo poco più che uno sfoggio di propaganda, e di solito
hanno lasciato che l'Unione Sovietica procedesse come meglio riteneva.
Naturalmente, però, quella passività non si estendeva anche al piano economico. Gli Stati Uniti
hanno approfittato dell'atmosfera della Guerra fredda per avviare massicce iniziative di
ricostruzione economica, prima nell'Europa occidentale e poi in Giappone (oltre che nella Corea
del sud e a Taiwan). La logica era chiara: a che serviva disporre di una superiorità produttiva tanto
schiacciante, se poi il resto del mondo non riusciva a esprimere una domanda efficace? Per giunta,
la ricostruzione economica ha contribuito a creare relazioni clientelari con i paesi beneficiari degli
aiuti americani: il dovere della riconoscenza ha alimentato in quei paesi la disponibilità a stringere
alleanze militari e, cosa ancor più importante, ad accettare la sottomissione politica.
Non va sottovalutata, infine, la componente ideologica e culturale dell'egemonia statunitense. Il
periodo dell'immediato dopoguerra ha segnato forse il culmine storico della popolarità
dell'ideologia comunista. Noi oggi dimentichiamo facilmente quanti voti prendevano i partiti
comunisti nelle libere elezioni che si tenevano in paesi come il Belgio, la Francia, l'Italia, la
Cecoslovacchia e la Finlandia, per non parlare dei consensi che i partiti comunisti raccoglievano in
Asia (in Vietnam, in India e in Giappone) e in tutta l'America Latina. E questo senza parlare di
paesi come la Cina, la Grecia e l'Iran, dove le libere elezioni non esistevano, o subivano forti
limitazioni, ma dove i partiti comunisti godevano di vasta popolarità. In risposta, gli Stati Uniti
hanno messo in piedi un'offensiva ideologica anticomunista di portata massiccia.
Retrospettivamente l'iniziativa si può definire largamente riuscita: Washington ha brandito il proprio
ruolo di leader del "mondo libero" in modo almeno altrettanto efficace quanto quello in cui
l'Unione Sovietica ha fatto pesare il suo ruolo di capofila dello schieramento "progressista" e
"antimperialista".
È stato proprio il successo degli Stati Uniti come potenza egemone nel dopoguerra a creare le
condizioni del declino di questa egemonia. Quattro simboli riassumono questo processo: la guerra
del Vietnam, le rivolte del 1968, la caduta del muro di Berlino nel 1989 e gli attacchi terroristici
del settembre 2001. Ciascuno di questi simboli ha le sue radici nel precedente, e l'intera sequenza
culmina nella situazione in cui gli Stati Uniti si trovano attualmente: l'essere una superpotenza
solitaria che manca di vero potere, un leader mondiale che nessuno segue e pochi rispettano, una
nazione pericolosamente alla deriva in mezzo a un caos globale che non riesce a controllare.
Che cosa è stata la guerra del Vietnam? In primo luogo e sopra ogni altra cosa, è stata il tentativo
del popolo vietnamita di porre fine al dominio coloniale e darsi uno Stato suo. I vietnamiti hanno
combattuto contro i francesi, i giapponesi e gli americani, e alla fine hanno vinto: un bel successo,
effettivamente. Ma sotto il profilo geopolitico la guerra ha rappresentato il rifiuto dello status quo
di Yalta da parte di popolazioni che allora erano etichettate come Terzo Mondo. Il Vietnam è
diventato un simbolo tanto potente perché Washington è stata così sconsiderata da investire tutta
la sua potenza militare nella lotta, eppure gli Usa hanno perso. È vero, gli Stati Uniti non hanno
dispiegato armi nucleari (decisione a lungo criticata da certi gruppi miopi della destra); ma usarle
avrebbe significato mandare in pezzi gli accordi di Yalta e forse avrebbe provocato un olocausto
nucleare, esito questo che gli Usa semplicemente non potevano rischiare.
Ma il Vietnam non è stato soltanto una sconfitta militare o una ferita inferta al prestigio degli Stati
Uniti. Quella guerra ha inferto un duro colpo alla loro capacità di restare la potenza economica
dominante del mondo. Il conflitto ha avuto un prezzo estremamente alto e ha praticamente
consumato tutte le riserve auree degli Stati Uniti, assai cospicue dal 1945 in poi. Per giunta gli
Stati Uniti hanno sostenuto questi costi mentre l'Europa occidentale e il Giappone conoscevano
una forte espansione economica. Sono state queste circostanze che hanno posto fine alla
preminenza americana nell'economia-mondo. Dalla fine degli anni Sessanta, i membri della triade
sono stati quasi su un piede di parità economica: in certi periodi uno stava meglio degli altri due,
ma nessuno ha mai distaccato gli altri due in modo netto.
Quando nel mondo sono scoppiate le rivolte del 1968, il sostegno al popolo vietnamita è
diventato una delle componenti principali della retorica adottata: gli slogan "uno, due molti
Vietnam" e "Ho, Ho, Ho Chi Minh" sono stati intonati in mille piazze, anche negli Stati Uniti. Ma i
sessantottini non si limitavano a condannare l'egemonia americana: condannavano anche la
collusione dell'Unione Sovietica con gli Stati Uniti, condannavano Yalta e usavano o adattavano il
linguaggio della rivoluzione culturale cinese, i cui esponenti dividevano il mondo in due
schieramenti: le due superpotenze da una parte, il resto del mondo dall'altra.
La denuncia della collusione sovietica ha condotto logicamente alla denuncia delle forze nazionali
che con essa avevano stretto un'alleanza, il che nella maggioranza dei casi significava i partiti
comunisti tradizionali. Ma i rivoluzionari del 1968 inveivano anche contro altre componenti della
Vecchia Sinistra—i movimenti di liberazione nazionale del Terzo Mondo, i movimenti
socialdemocratici nell'Europa occidentale e i democratici del New Deal negli Stati Uniti—
accusando anche loro di collusione con quello che i rivoluzionari definivano genericamente
l'"imperialismo americano".
L'attacco alla collusione sovietica con Washington, sommato all'attacco contro la Vecchia Sinistra,
ha ulteriormente indebolito la legittimità degli accordi di Yalta, in base ai quali gli Usa avevano
modellato l'ordine mondiale. Per giunta ha minato la posizione del liberalismo centrista come unica
ideologia globale legittima. Se le conseguenze politiche dirette delle rivoluzioni mondiali del 1968
sono state minime, le loro ripercussioni geopolitiche e intellettuali sono state enormi e irrevocabili.
Il liberalismo centrista è precipitato dal trono che occupava fin dalle rivoluzioni europee del 1848
e che gli aveva consentito di cooptare tanto i conservatori quanto i radicali. Queste ideologie sono
tornate alla ribalta e ancora una volta hanno rappresentato una vera gamma di scelte. I
conservatori diventavano di nuovo conservatori, i radicali radicali. I liberali centristi non sono
scomparsi ma sono stati ridimensionati. E strada facendo la posizione ideologica ufficiale degli
Stati Uniti—antifascisti, anticomunisti, anticolonialisti—è apparsa inconsistente e poco convincente
a una parte sempre più numerosa della popolazione mondiale.
Per la potenza statunitense, l'insorgere della stagnazione economica internazionale negli anni
Settanta ha avuto due conseguenze importanti. In primo luogo, la stagnazione ha dato luogo al
crollo dello "sviluppismo" (nato come desarrollismo nell'America latina), cioè dell'idea che ogni
paese potesse recuperare la propria arretratezza economica a condizione che lo Stato assumesse
iniziative adatte: questo era il principale assunto ideologico dei movimenti della Vecchia Sinistra
allora al potere. Uno dopo l'altro, questi regimi si sono trovati ad affrontare disordini interni, calo
del tenore di vita, crescente dipendenza debitoria dalle istituzioni finanziarie internazionali ed
erosione della propria credibilità. Quello che negli anni Sessanta era apparso come il tentativo
riuscito, da parte degli Stati Uniti, di navigare la decolonizzazione del Terzo Mondo—contenendo
al massimo le crisi e aumentando al massimo il trasferimento senza intoppi del potere a regimi
"sviluppisti" ma quasi mai rivoluzionari—ha lasciato il posto alla disintegrazione dell'ordine, a un
malcontento strisciante e a tentazioni radicali incontrollate. Quando gli Stati Uniti hanno cercato
d'intervenire, hanno fallito. Nel 1983 l'allora presidente Reagan ha inviato truppe americane in
Libano per riportare l'ordine. In realtà, quelle truppe sono state cacciate. Lui ha compensato
invadendo Grenada, un paese privo di forze armate. Dal canto suo, il presidente George Bush
padre ha invaso Panama, altro paese senza forze armate. Ma dopo l'intervento in Somalia per
ristabilire l'ordine, gli Stati Uniti sono stati costretti ad andarsene in modo alquanto ignominioso.
Dal momento che i governi americani potevano fare ben poco per invertire la tendenza al declino
dell'egemonia americana, hanno semplicemente scelto di ignorarla: e questa è stata la politica
prevalente dal ritiro dal Vietnam all'11 settembre 2001.
Frattanto, i veri conservatori hanno cominciato ad assumere il controllo di alcuni Stati decisivi e di
alcune istituzioni interstatali determinanti. L'offensiva neo-liberale degli anni Ottanta è stata segnata
dai regimi Thatcher e Reagan e dall'emergere del Fondo monetario internazionale (Fmi) fra i
protagonisti della scena mondiale. Mentre un tempo (per oltre un secolo) le forze conservatrici
avevano cercato di presentarsi come i liberali più saggi, adesso i liberali centristi erano costretti a
presentarsi come dei conservatori più efficaci. I programmi dei conservatori erano chiari. Sul
piano interno, i conservatori hanno tentato di attuare politiche tese a ridurre il costo della
manodopera, ridurre i vincoli imposti alle industrie dagli ambientalisti, tagliare i trasferimenti
previdenziali dello Stato. Poiché i successi effettivi sono stati modesti, i conservatori sono passati
energicamente all'azione sul fronte internazionale. Le riunioni del World Economic Forum di
Davos sono diventate un punto d'incontro per le élite e i mass media.Il Fondo monetario
internazionale è diventato un club di ministri delle Finanze e governatori delle banche centrali. E gli
Stati Uniti hanno spinto per la creazione dellaWto, l'Organizzazione per il commercio mondiale,
per far passare a forza i liberi flussi commerciali attraverso le frontiere del mondo.
Intanto, mentre gli Stati Uniti guardavano da un'altra parte, l'Unione Sovietica si disgregava. È
vero, Ronald Reagan aveva ribattezzato l'Unione Sovietica "l'Impero del male" e aveva usato
l'enfasi retorica di invocare la distruzione del Muro di Berlino, ma gli Stati Uniti non facevano sul
serio e di certo non sono stati responsabili del crollo dell'Unione Sovietica. In verità, l'Unione
Sovietica e l'Est europeo, la regione del suo impero, si sono disgregati a causa della delusione
popolare nei confronti della Vecchia Sinistra combinata con i tentativi del leader sovietico Mikhail
Gorbaciov di salvare il suo regime liquidando Yalta e introducendo la liberalizzazione interna
(perestrojka più glasnost'). Ora, Gorbaciov è riuscito a liquidare Yalta, ma non a salvare
l'Unione Sovietica (anche se, va detto, ci è andato vicino).
Gli Stati Uniti sono rimasti stupefatti e perplessi da quel crollo improvviso, senza sapere come
gestirne le conseguenze. In effetti il crollo del comunismo ha significato il crollo del liberalismo, ha
cioè rimosso l'unica giustificazione ideologica che sorreggeva l'egemonia degli Stati Uniti—
giustificazione tacitamente appoggiata da quello che agli occhi di tutti era l'avversario ideologico
del liberalismo. Questa perdita di legittimità ha portato direttamente all'invasione del Kuwait da
parte dell'Iraq, mossa che il leader iracheno Saddam Hussein non avrebbe mai azzardato se
l'assetto di Yalta fosse stato ancora in piedi. Retrospettivamente, gli sforzi americani nella Guerra
del Golfo sono riusciti a ottenere una tregua su una linea di partenza che era fondamentalmente la
stessa. Ma può una potenza egemone accontentarsi di un pareggio in una guerra con una potenza
regionale di mezza tacca? Saddam ha dimostrato che era possibile attaccare briga con gli Stati
Uniti e farla franca. Ancor più della sconfitta in Vietnam, quel che ha fatto rodere il fegato alla
destra americana, in particolare ai cosiddetti falchi, è stata la sfrontata sfida di Saddam: e ciò
spiega perché essi nutrano oggi il fervente desiderio di invadere l'Iraq distruggendone il regime.
Fra la Guerra del Golfo e l'11 settembre 2001, le due principali zone di conflitto nel mondo sono
state i Balcani e il Medio Oriente. In entrambe le regioni gli Stati Uniti hanno svolto un ruolo
diplomatico di primo piano. Guardiamoci indietro e chiediamoci quanto sarebbero stati diversi i
risultati, se gli Stati Uniti avessero assunto una posizione completamente isolazionista. Nei Balcani,
uno Stato multinazionale riuscito sul piano economico—la Jugoslavia—si è disgregato
essenzialmente nelle sue componenti. Nell'arco di dieci anni la maggior parte degli Stati che ne
sono scaturiti si è dedicata a un processo di etnicizzazione, passando attraverso violenze alquanto
brutali, diffuse violazioni dei diritti umani e guerre vere e proprie. Un intervento esterno in cui
figuravano al primo posto gli Stati Uniti ha prodotto una tregua e ha posto fine alle violenze più
smaccate, ma questo intervento non ha assolutamente fermato l'etnicizzazione, che adesso si è
consolidata e in un certo verso legittimata. Quei conflitti sarebbero andati a finire in un modo
diverso senza il coinvolgimento degli Stati Uniti? Le violenze avrebbero potuto proseguire ancora,
ma probabilmente i risultati fondamentali non sarebbero stati poi troppo diversi. Ancor più fosco il
quadro del Medio Oriente, dove, se non altro, il coinvolgimento degli Stati Uniti è stato più
profondo e i loro fallimenti più spettacolari. In Medio Oriente come nei Balcani, gli Stati Uniti non
sono riusciti a esercitare efficacemente il loro peso di potenza egemone, non perché non ne
avessero la volontà, né perché non ci abbiano provato, ma per mancanza di vero potere.
Poi c'è stato l'11 settembre: lo choc e la reazione. Sotto il fuoco incrociato dei membri del
Congresso, la Central Intelligence Agency (Cia) sostiene adesso di aver messo in guardia
l'amministrazione Bush circa possibili minacce. Ma nonostante la Cia si sia concentrata su alQaeda e malgrado la sua expertise in materia di intelligence, essa non ha saputo prevedere (e
quindi impedire) gli attacchi terroristici. O comunque così ha sostenuto il suo direttore, George
Tenet. Questa deposizione non può certo confortare il governo né il popolo degli Stati Uniti.
Qualsiasi altra cosa decidano gli storici, gli attacchi dell'11 settembre 2001 hanno posto una
grande minaccia alla potenza americana. Non sono stati perpetrati da rappresentanti di una grande
potenza militare, ma da membri di una forza non statale, dotati di un alto grado di decisione, di un
certo quantitativo di fondi, di una banda di seguaci convinti e di una forte base in un unico Stato
debole. In breve, sul piano militare non erano niente. Eppure sono riusciti a mettere a segno un
audace attacco sul suolo americano.
Quando è andato al potere, George W. Bush ha aspramente criticato il modo in cui
l'amministrazione Clinton aveva gestito gli affari mondiali. Quel che il neo-presidente e i suoi
consiglieri non hanno ammesso—pur essendone indubbiamente consapevoli—è che la strada
battuta da Clinton era la stessa percorsa da tutti i presidenti americani da Gerald Ford in poi,
compresi Ronald Reagan e George Bush padre. Ed è la stessa che ha battuto l'attuale
amministrazione prima dell'11 settembre: basta guardare in che modo Bush ha gestito la vicenda
dell'aereo americano abbattuto al largo della Cina nell'aprile 2001 per capire che la sua parola
d'ordine era "prudenza".
Poi però, a seguito degli attacchi terroristici, Bush ha cambiato linea e ha dichiarato guerra al
terrorismo, assicurando al popolo americano che "l'esito è certo" e informando il mondo che "chi
non è con noi è contro di noi". I falchi, rimasti a lungo frustrati anche dalle amministrazioni più
conservatrici, sono finalmente giunti a dominare la politica di Washington. La loro posizione è
chiarissima: gli Stati Uniti dispongono di una potenza militare schiacciante e anche se innumerevoli
leader stranieri ritengono che non sia saggio per Washington agitare la minaccia militare, se gli
Stati Uniti dovessero decidere di imporre la loro volontà al resto del mondo quegli stessi leader
non possono fare e non faranno un bel nulla. Secondo i falchi, gli Usa fanno bene a comportarsi
come una potenza imperiale per due motivi:uno è che possono farla franca, l'altro è che rischiano
citare la loro forza.
Attualmente le posizioni dei falchi si esprimono in tre modi diversi: l'aggressione militare in
Afghanistan, il sostegno de facto al tentativo israeliano di liquidare l'Autorità Palestinese, e
l'invasione dell'Iraq, che a quanto si dice è già passata allo stadio dei preparativi militari. Forse, a
meno di un anno dagli attacchi terroristici del settembre 2001, è troppo presto per valutare quali
risultati sortiranno queste strategie. Finora esse hanno condotto al rovesciamento dei Taliban in
Afghanistan (senza però smantellare completamente al-Qaeda, né catturarne i massimi dirigenti); a
enormi devastazioni in Palestina (senza però rendere il leader palestinese Yasser Arafat
"irrilevante", come l'aveva definito il premier israeliano Ariel Sharon); e all'energica opposizione
degli alleati europei e mediorientali degli Stati Uniti ai loro piani per l'invasione dell'Iraq.
La lettura che danno i falchi degli eventi recenti pone l'accento sul fatto che l'opposizione alle
azioni degli Stati Uniti, benché seria, per lo più è rimasta verbale. Né l'Europa occidentale, né la
Russia, né la Cina, né l'Arabia Saudita si sono mostrate disposte a rompere seriamente i rapporti
con gli Usa. In altre parole, i falchi sono convinti che Washington l'abbia fatta franca, e danno per
scontato che la stessa cosa succederà quando le forze statunitensi passeranno a invadere l'Iraq, e
successivamente quando Washington eserciterà il suo potere anche in altre parti del mondo, che si
tratti dell'Iran, della Corea del nord, della Colombia o magari, chissà, dell'Indonesia.
Il paradosso è che la lettura dei falchi è diventata, in larga misura, quella della sinistra
internazionale, la quale protesta a gran voce contro le politiche americane forse perché teme che
gli Usa abbiano buone probabilità di successo. Ma l'interpretazione dei falchi è errata e non farà
altro che contribuire al declino degli Stati Uniti, trasformando un tramonto graduale in una caduta
assai più precipitosa. Specificamente, le scelte dei falchi sono destinate alla sconfitta per motivi
militari, economici e ideologici.
È fuori di dubbio che la carta più forte degli Stati Uniti sono e restano le forze militari: anzi, sono
l'unica che abbiano da giocare. Attualmente gli Stati Uniti dispongono dell'apparato militare più
formidabile del mondo. E se dobbiamo credere a chi dice che possiedono tecnologie nuove e
imbattibili, allora il margine di superiorità delle forze americane rispetto al resto del mondo è oggi
notevolmente maggiore rispetto ad appena dieci anni fa. Ma ciò significa forse che gli Usa
possono invadere l'Iraq, conquistarlo rapidamente e insediarvi un regime amico e stabile? La cosa
ci sembra improbabile. Non bisogna dimenticare che, delle tre guerre serie che i militari americani
hanno combattuto dopo il 1945 (Corea, Vietnam e Guerra del Golfo), una si è conclusa con una
sconfitta e due con un pareggio. Non ci sembrano esattamente precedenti gloriosi.
L'esercito di Saddam Hussein non è quello dei Taliban e il controllo interno che egli esercita
tramite i militari è di gran lunga più coerente. Un'invasione americana comporterebbe
necessariamente lo spiegamento di una forza di terra seria, che dovrebbe farsi strada combattendo
fino a Baghdad e con ogni probabilità subirebbe perdite significative. Per giunta, questa forza
avrebbe bisogno di basi d'appoggio, e l'Arabia Saudita ha già detto chiaramente che non intende
servire a questo scopo. L'aiuto verrà forse dal Kuwait o dalla Turchia? Forse, se Washington
gioca tutte le sue carte. Nel frattempo ci si può aspettare che Saddam dispieghi tutte le armi a sua
disposizione, e il governo americano suda freddo proprio chiedendosi quanto possano essere
distruttive queste armi. Gli Stati Uniti possono benissimo mettere alle strette i vari regimi della
regione, ma agli occhi dell'opinione pubblica le loro mosse rispecchiano la profonda avversione
antiaraba degli americani. Con queste premesse un conflitto del genere si può vincere? Lo Stato
maggiore britannico, sembra, ha fatto sapere al primo ministro Tony Blair che non ne è affatto
convinto.
E poi c'è sempre la questione dei "secondi fronti". Dopo la Guerra del Golfo le forze armate
americane hanno cercato di prepararsi in vista della possibilità di due guerre regionali in
contemporanea. Dopo un po' di tempo il Pentagono, senza far chiasso, ha abbandonato l'idea
giudicandola impraticabile e costosa. Ma chi può star certo che questo o quel potenziale nemico
non colpisca proprio nel momento in cui le forze armate americane appaiono impantanate in Iraq?
Si pensi poi alla questione della tolleranza del popolo americano alle vittorie mancate. Gli
americani oscillano fra un fervore patriottico che incensa tutti i "presidenti di guerra" e una
profonda tentazione isolazionistica. Dal 1945 a questa parte il patriottismo si è scontrato contro un
muro, ogni volta che il numero delle vittime ha superato un certo limite. Perché mai oggi la
reazione dovrebb'essere diversa? E se anche i falchi—che sono quasi tutti civili—pensano di poter
ignorare l'opinione pubblica, lo stesso non si può certo dire dei generali dell'esercito americano,
rimasti scottati dal Vietnam.
Veniamo ora al fronte economico. Negli anni Ottanta, innumerevoli analisti americani si sono fatti
venire le crisi isteriche per il miracolo economico del Giappone. Poi, negli anni Novanta, si sono
calmati, di fronte alle ben pubblicizzate difficoltà finanziarie di Tokyo. Tuttavia, dopo aver
esagerato la rapidità dell'espansione del Giappone, le autorità degli Stati Uniti adesso fanno mostra
di un facile ottimismo, fiduciose come sono che il Giappone abbia perso svariate incollature di
vantaggio. Di questi tempi Washington sembra più incline a far la lezione ai politici giapponesi
Questo trionfalismo è tutt'altro che giustificato. Riprendiamo una notizia pubblicata dal "New York
Times" il 20 aprile di quest'anno: "Un laboratorio giapponese ha costruito il computer più veloce
del mondo. La macchina è talmente potente da eguagliare la potenza di elaborazione dei 20
i d'America sommati insieme, e supera di gran lunga il detentore del
precedente primato, un computer costruito dall'I.B.M. Questo traguardo... dimostra che la
competizione tecnologica che molti informativi americani erano convinti di vincere facilmente è
tutt'altro che finita". L'autore prosegue la sua analisi e osserva che i due paesi hanno "priorità
scientifiche e tecnologiche contrastanti". Il computer giapponese è costruito per analizzare i
cambiamenti climatici, mentre quelli americani sono concepiti per simulare armi. Questo contrasto
ben illustra quella che è la più antica caratteristica delle potenze egemoniche. La potenza
dominante si concentra (a sue spese) sull'assetto militare, il candidato alla successione si concentra
su quello economico. Ed è quest'ultimo che si è sempre rivelato quello di gran lunga vincente. Lo è
stato per gli Stati Uniti, perché non dovrebbe esserlo anche per il Giappone, magari dopo aver
stretto un'alleanza con la Cina?
Infine vi è l'aspetto ideologico. Attualmente l'economia americana appare relativamente debole, e
ancor più se si considerano le spese militari esorbitanti che le strategie dei falchi comportano. Per
giunta, Washington resta politicamente isolata: praticamente nessun altro paese, tranne Israele,
pensa che la posizione dei falchi sia sensata o meriti un incoraggiamento. Gli altri paesi hanno
paura o non sono disposti a contrastare direttamente gli Usa, ma basta la loro riluttanza a
danneggiare Washington.
Eppure, la risposta di Washington è poco più che un'arrogante pressione per metterli alle strette.
Ora, l'arroganza ha i suoi lati negativi: giocarsi tutte le carte in una volta significa lasciarsi meno
carte per la prossima volta, e l'acquiescenza recalcitrante alimenta i risentimenti. Nel corso degli
ultimi duecent'anni gli Stati Uniti si sono conquistati un notevole credito ideologico. Ma
ultimamente gli stanno dando fondo ancor più rapidamente di quanto fecero con le loro riserve
auree negli anni Sessanta.
Nei prossimi dieci anni, gli Usa hanno di fronte due opzioni. O seguono la strada indicata dai
falchi, con conseguenze negative per tutti, ma soprattutto per l'America stessa. Oppure si rendono
conto che le conseguenze negative sono troppo pericolose. Ultimamente, sul "Guardian", Simon
Tisdall sosteneva che anche ignorando l'opinione pubblica internazionale, "gli Stati Uniti non sono
in grado di combattere da soli una guerra vittoriosa in Iraq senza esporsi a danni immensi, non da
ultimo ai loro interessi economici e ai loro rifornimenti energetici. Bush si è ridotto a fare la voce
grossa e ad apparire del tutto inane". E se gli Stati Uniti decidono comunque di invadere l'Iraq, e
poi si vedono costretti alla ritirata, appariranno ancora più inefficaci.
In conclusione, le opzioni a disposizione di Bush sono estremamente limitate e vi sono pochi dubbi
che nei prossimi dieci anni il declino degli Stati Uniti in quanto forza decisiva sullo scenario
mondiale proseguirà. Il vero interrogativo da porsi non è se l'egemonia degli Usa stia tramontando,
ma se essi siano in grado di escogitare un modo di tramontare con grazia, arrecando il minimo
danno possibile al mondo e a se stessi.
Immanuel Wallerstein è senior research scholar all'Università di Yale
Traduzione di Marina Astrologo