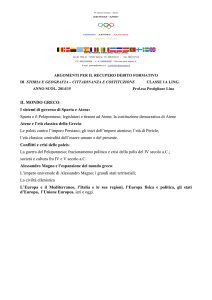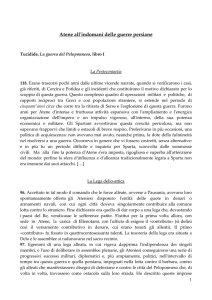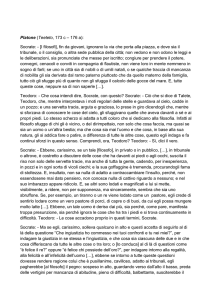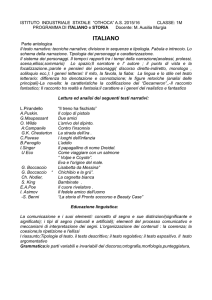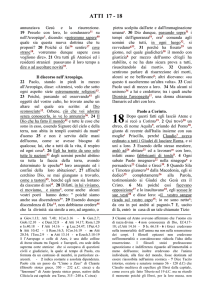TRA IDENTITÀ E INTEGRAZIONE: ASPETTI DELLA POSIZIONE
DELLO STRANIERO NEL MONDO GRECO
Sommario: 1. Greci, xenoi, bárbaroi – 2. Sentimento di identità e rifiuto dell’integrazione: il mito
dell’autoctonia – 3. La posizione delicata dell’apolide.
1. GRECI, XENOI, BÁRBAROI
1
La compresenza, nel mondo greco, di una forte omogeneità culturale e di un’estrema
frammentazione politica incide in modo significativo sulla percezione dello straniero. Nel rivendicare la
propria identità in rapporto allo “straniero”, l’uomo greco distingue infatti fra lo straniero di stirpe greca
(xenos), che è tale in quanto appartiene ad una comunità politica diversa dalla propria, e il barbaro. I
livelli di estraneità sono, nei due casi, assai diversi.
Nel caso dello xenos, l’estraneità investe esclusivamente l’aspetto politico: il Greco cittadino di
un altro stato, città (polis) o stato federale (ethnos), appartiene infatti alla medesima comunità di sangue, di
lingua, di culti, di costumi che definisce, in Erodoto VIII, 144, la Grecità (Hellenikón) come unità etnicoculturale. La coscienza dell’appartenenza ad una civiltà unitaria, che è ben espressa dal passo erodoteo,
convive con la coscienza delle differenze culturali tra ethne (per esempio, fra Dori e Ioni) e con il forte
senso di appartenenza alle singole entità politiche, ognuna caratterizzata da una sua specifica identità
culturale espressa nella comune esperienza religiosa (i culti) e politica (le leggi); essa tende poi ad
accrescersi, nel corso del IV secolo, con lo sviluppo del panellenismo, ma senza indebolire il senso di
appartenenza alla polis.
Il barbaro, invece, diversamente dallo xenos, è “straniero due volte”, sia sul piano etnicoculturale, sia su quello politico: mentre non condivide con i Greci nessuno degli elementi identificati da
Erodoto nella definizione della Grecità, vive pure un’esperienza dello stato radicalmente opposta a
quella dei Greci. Egli si contrappone “in maniera simmetrica e completa alla duplice identità dell’uomo
greco”2 e ne rappresenta l’immagine negativa.
I barbari sono dunque radicalmente “altri”, e inferiori, in quanto, come mostra l’origine del
termine bárbaros, parlano una lingua incomprensibile, percepita come un balbettio inarticolato, e in
quanto sono caratterizzati da una ferocia di costumi che va a detrimento della loro piena umanità. Ma
soprattutto, essi hanno con lo stato un rapporto di servitù, che li caratterizza come douloi di fronte al
dispotismo del monarca, mentre i Greci si pongono di fronte allo stato come cittadini, liberi ed
autonomi, protetti dalla sovranità della legge (cfr. il discorso di Demarato a Serse in Erodoto VII, 101105).
Il processo di maturazione della percezione di sé da parte dell’uomo greco, con la sua
caratterizzazione eminentemente politica e la sua forte contrapposizione con il barbaro3, si colloca nel
contesto delle guerre persiane, come evidenzia la letteratura contemporanea. Eschilo, nei Persiani del
472, celebra la vittoria greca esaltando la superiorità non tanto di natura, quanto di civiltà politica dei
Greci sui barbari: i Greci vengono definiti come coloro che “di nessun mortale sono chiamati servi né
sudditi” (v. 242); Grecia e Persia sono rappresentate come due donne, “sorelle della stessa stirpe”, ma
Ho già trattato i temi discussi in queste pagine nei seguenti interventi: Lo straniero nel mondo greco: xenoi, apolidi, barbari, in
Stranieri, profughi e migranti nell’antichità, Nuova Secondaria 18, 3, novembre 2000, 30-38; I meteci di Lisia, Nuova Secondaria 18,
3, novembre 2000, 34-36; Rivendicazione di identità e rifiuto dell’integrazione nella Grecia antica (Ateniesi, Arcadi, Plateesi, Messeni), in
Identità e integrazione. Passato e presente delle minoranze nell’Europa meridionale (Atti del Seminario, Milano 29 aprile e 3 maggio
2004), in corso di stampa; Autoctonia, rifiuto della mescolanza, civilizzazione: da Isocrate a Megastene, in Incontri tra culture nell’Oriente
ellenistico e romano (Atti del Convegno, Ravenna 11-12 marzo 2005), in corso di stampa.
2 M. Moggi, Greci e barbari: uomini e no, in Civiltà classica e mondo dei barbari. Due modelli a confronto, Trento 1991, pp. 31-46, p. 34;
I D., Straniero due volte: il barbaro e il mondo greco, in Lo straniero ovvero l’identità culturale a confronto, Roma-Bari 1992, pp. 51-76; I D.,
Lo straniero (xenos e barbaros) nella letteratura greca di epoca arcaica e classica, Ricerche storico-bibliche VIII, 1-2 (1996), pp. 103-116.
3 Che ha indotto J.M. Hall, Ethnic Identity in Greek Antiquity, Cambridge - New York 1997, pp. 47 ss., a parlare di
“oppositional identity”, rispetto alla “aggregative identity” dell’arcaismo.
1
1
l’una docile al giogo, l’altra intollerante di ogni costrizione, che rifiuta di lasciarsi imporre le redini (v.
176 ss.). In tutta la tragedia attica i barbari sono presentati come incapaci di concepire il potere politico
se non come assoluto e dispotico: come tali essi sono destinati ad essere dominati dai Greci,
radicalmente diversi da loro4. L’esasperata autocoscienza che induce il Greco a contrapporsi al barbaro
ha dunque come contenuto l’antinomia fra polites e doulos, fra cittadino libero e suddito.
Nel IV secolo affiora invece l’idea di una vera e propria superiorità etnica, e non solo politica,
del Greco sul barbaro. Isocrate (Antidosi, 293-294; cfr. Panegirico, 184; Panatenaico, 163) considera i
barbari inferiori per virtù (areté) e per educazione (paideia); Aristotele (Politica, 1285 a 20) arriva a definire
i barbari, che si lasciano governare dispoticamente, come schiavi per natura. “Grecità” diviene così
uguale a cultura e civiltà, mentre l’Oriente persiano incarna la barbarie, non più soltanto in senso
politico, ma anche come stile di vita collegato con le qualità naturali della razza: l’autocoscienza greca
assume un carattere non più soltanto etico-politico, ma più ampiamente "culturale", fino ad assumere
risvolti etnici non chiaramente presenti in origine5.
Il mondo greco ci propone dunque una duplice definizione dello straniero: una definizione
culturale, che identifica il barbaro, e una definizione politica, che identifica lo xenos6. La percezione dello
xenos non risente, ovviamente, dell’estraneità etnico-culturale relativa ai ba rbari, ma anch’egli, quando
non sia garantito da specifici rapporti di tipo personale o familiare che lo trasformano in ospite o
protetto da convenzioni stipulate a livello di comunità, è un individuo formalmente privo di diritti e,
quanto meno potenzialmente, anche un polemios, un nemico, esposto al diritto di rappresaglia (il diritto
di impadronirsi della persona o dei beni di qualcuno, che il cittadino di uno stato poteva esercitare nei
confronti del cittadino di uno stato estero, quando non potesse far valere i suoi diritti davanti agli organi
di tale stato). E’ questo il riflesso del frazionamento politico del mondo greco, in cui ogni comunità
statale si pone in posizione antagonistica e competitiva rispetto alle altre: ma del problema si prese
coscienza, cercando, fin dall’età arcaica, di porvi rimedio con istituti particolari. Essi riguardano
prevalentemente il mondo degli xenoi, e sembrano dunque presupporre, almeno idealmente, una
omogeneità politico-culturale (non sono pensati, cioè, per essere applicati, in via normale, ai rapporti
con i barbari).
Tra queste forme, la più antica era la xenía, presente nel mondo greco fin dall’arcaismo: essa era
una forma di ospitalità fondata sulla reciprocità, che prevedeva la mutua assistenza (espressa attraverso
l’ospitalità concreta, cioè l’offerta di vitto e alloggio, e attraverso la rappresentanza di fronte alla
comunità cittadina ospitante) e veniva sancita con lo scambio di sýmbola, piccoli oggetti spesso spezzati
in due parti, che servivano come strumento di riconoscimento e come prova dei legami di ospitalità
anteriormente stabiliti.
La prossenia costituisce l’adattamento alle esigenze pubbliche dell’antica pratica privata della
xenía. Il prosseno era un cittadino che, risiedendo nella sua città d’origine, rappresentava la comunità
straniera che gli aveva conferito il titolo di prosseno; veniva nominato dalla comunità interessata non
fra i propri cittadini, ma fra i cittadini della comunità in cui si desiderava assicurare protezione ai propri
cittadini quando vi giungevano come xenoi. Suo compito era essenzialmente quello di assicurare la
protezione materiale dello straniero e la cura dei suoi interessi; in cambio, il prosseno veniva
considerato straniero privilegiato nello stato che gli aveva conferito il titolo, e talora gli veniva
addirittura concessa la cittadinanza7.
L’asylía o inviolabilità si sviluppò invece in ambito sacrale. In origine essa caratterizzava lo hieròn
ásylon, il luogo sacro da cui persone e cose non potevano essere allontanate con la violenza e entro il
quale esse erano protette da una garanzia giuridica che le rendeva immuni dal diritto di rappresaglia.
Con l’evoluzione del diritto, si sviluppò una differenza tra la sacralità del santuario, ove chiunque aveva
il diritto di porsi come supplice (hikesía), e l’asylía vera e propria, che non era legata solo al diritto
sacrale, ma era giuridicamente garantita anche dalla legge positiva e presupponeva una concessione.
Cfr. Eschilo, Supplici, pp. 370 ss.; Euripide, Ecuba, pp. 1199 ss.; Elena, p. 276; Ifigenia in Aulide, p. 1400.
Cfr. W. Nippel, La costruzione dell’“altro”, in I Greci. Storia cultura arte società, I: Noi e i Greci, Torino 1996, pp. 165-196.
6 Cfr., oltre ai contributi di Moggi citati alle note 3 e 4, M.-F. Baslez, L’étranger dans la Grèce antique, Paris 1984, p. 22.
7 Su xenía e prossenia cfr. M. Scott, Philos, philotes and xenia, in Acta classica 25 (1982), pp. 1-19; M.B. Walbank, Athenian
Proxenies of the Fifth Century B.C., Toronto-Sarasota 1978; B. Bravo, “Sulan”. Représailles et justice privée dans les cités grecques,
“Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa” III, 10, 1980, pp. 675-987.
4
5
2
L’asylía, nel senso di immunità dal diritto di rappresaglia, poteva essere concessa ai singoli in virtù di
particolari benemerenze oppure ad intere città in seguito a trattati; in quest’ultimo caso essa era
concepita anche come riconoscimento dell’inviolabilità di un’area sacra o di un intero territorio,
all’interno dei quali veniva garantita protezione, in quanto l’area dichiarata ásylos era sottratta alla
giurisdizione secolare. Le dichiarazioni di asylía si diffusero in età ellenistica grazie all’iniziativa dei
grandi santuari, come Delfi, di sovrani e di città: nonostante il loro carattere prevalentemente onorifico,
esse contribuirono notevolmente, grazie alla protezione che offrivano, a favorire la libera circolazione
internazionale8.
Si è detto che i sýmbola erano, in origine, i doni che gli ospiti si scambiavano come pegno di
ospitalità. Il termine passò poi a designare le convenzioni giudiziarie, di carattere reciproco, tra due stati,
destinate a proteggere i rispettivi cittadini nei casi di contenzioso riguardanti prevalentemente l’ambito
commerciale. Il termine symbolaí, invece (che designava in origine i rapporti di tipo creditizio in ambito
di diritto privato), venne ad identificare prima gli accordi tra Atene e le città appartenenti alla lega delioattica (trattati che garantivano l’immunità della persona e dei beni di cittadini ateniesi e regolavano le
procedure esperibili per agire in giudizio sui rispettivi territori, e di cui abbiamo alcune testimonianze
epigrafiche), poi accordi giudiziari tra stati greci di portata più generale, non limitati all’area dei rapporti
creditizi9.
Lo straniero di passaggio nella polis poteva poi godere di alcune concessioni. Nel diritto attico
sono attestati il diritto di svolgere traffici commerciali nell’agorá, il diritto di usare pascoli in territorio
ateniese, il diritto di possedere immobili (énktesis ghes kai oikías), il diritto di sposare una donna attica
(epigamía). Concessioni come l’epigamía e l’énktesis, che incoraggiavano la stabilizzazione, erano di
carattere eccezionale, perché la polis era assai riluttante a concedere forme di equiparazione allo
straniero, anche in un contesto democratico come quello dell’Atene periclea.
Un notevole progresso nella mitigazione della posizione dello straniero fu l’istituto della
metoikía, a noi noto soprattutto in ambito ateniese, ma certamente esistente anche in altre città greche. I
meteci, o stranieri residenti, avevano uno status intermedio tra cittadini e xenoi: erano stranieri, di stirpe
greca, che si stabilivano in Atene, per motivi commerciali, per un periodo superiore a un mese.
Avevano l’obbligo di porsi sotto la protezione di un cittadino, che assumeva la funzione di patrono
(prostates): suo compito era appoggiare la richiesta di iscrizione nelle liste dei meteci e garantire il
pagamento della tassa (di 12 dracme all’anno) cui erano sottoposti gli stranieri residenti. I meteci erano
iscritti in speciali registri anagrafici e prestavano servizio militare (flotta, truppe ausiliarie), ma erano
esclusi da ogni forma di partecipazione politica. Per quanto riguarda la capacità processuale, potevano
ottenere la tutela dei loro diritti intentando le apposite azioni davanti al magistrato competente,
l’arconte polemarco (che in età classica era competente per ciò che riguardava i rapporti con gli
stranieri). Si ritiene in genere che avessero la possibilità di agire in giudizio solo quando erano in gioco i
loro interessi particolari: potevano cioè esperire solo azioni private, non pubbliche (riservate ai
cittadini), e comunque, secondo una testimonianza di Aristotele (Politica 1275 a 5 ss.), attraverso il
prostates. Sembra però che quest’ultimo non avesse una funzione di rappresentanza, ma semplicemente
di garanzia in sede di citazione o di istruttoria, anche in relazione al deposito delle spese legali.
La posizione del meteco nell’ambito della comunità della polis è assai discussa. In genere sono
state sottolineate le forme di esclusione del meteco rispetto al cittadino: l’impossibilità di esercitare i
diritti politici, le restrizioni in termini di godimento dei diritti civili (matrimonio, proprietà), la mancata
equiparazione giuridica e fiscale. Tuttavia, è stato posto l’accento anche sulle modalità di parziale
integrazione (a livello militare, fiscale, giudiziario) e sulla necessità di ridimensionare il ruolo del prostates.
Sull’asylía, cfr. K.J. Rigsby, Asylia. Territorial Inviolability in the Hellenistic World, Berkeley-Los Angeles 1996; M. Dreher (ed.),
Das antike Asyl. Kultische GrunD.L.agen, rechtliche Ausgestaltung und politische Funktion (Akten des Kolloquiums Villa Vigoni,
Loveno di Menaggio, 13.-16. März 2002), Köln 2003.
9 Sulle convenzioni fra stati cfr. P. Gauthier, Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques, Nancy 1972; S. Cataldi,
Symbolai e relazioni tra le città greche nel V secolo a.C., Pisa 1983.
8
3
La posizione del meteco rispetto alla comunità ateniese sembra insomma essersi avviata verso una
maggiore integrazione nel corso del IV secolo, soprattutto nel campo giudiziario10.
2.
SENTIMENTO
DELL’AUTOCTONIA
DI
IDENTITÀ
E
RIFIUTO
DELL’INTEGRAZIONE:
IL
MITO
Non tutti gli stati greci avevano lo stesso atteggiamento di fronte al rapporto con lo xenos. Atene
non temeva il rapporto con gli stranieri ed era disponibile ad accoglierli nel suo territorio e a farveli
risiedere stabilmente come meteci: essa aveva anzi fama di aprire le sue porte agli esuli fin dall’epoca
soloniana (Plutarco, Vita di Solone, XXIV, 2) e alimentava tale fama come una delle caratteristiche
positive del proprio stile di vita (Tucidide II, 39, 1). Sparta, invece, teneva sotto attento controllo gli
stranieri di passaggio e praticava regolari xenelasíai, “espulsioni di stranieri” (Tucidide I, 144, 2): si
temeva infatti che il contatto con gli stranieri e, in particolare, l’importazione di denaro monetato
alterassero il delicato sistema socio-economico spartano (cfr. Senofonte, Costituzione degli Spartani XIV,
4). Ma, al di là di queste differenze legate ad un diverso stile di vita, tutto il mondo greco è accomunato
da un sostanziale rifiuto dell’integrazione, non solo verso il barbaro, ma anche verso lo xenos.
Diversamente che nel mondo romano, dove la coscienza di essere fin dalle origini un popolo misto
favorì la disponibilità all’integrazione del “diverso” sul piano etnico, sociale e culturale, in Grecia l’ideale
è costituito dalla “non mescolanza”11: lo evidenzia bene il mito dell’autoctonia (la rivendicazione di
essere “nati dalla terra” e di non essere immigrati nella propria sede di stanziamento dall’esterno),
utilizzato come forma di rivendicazione di identità etnico-culturale.
Un primo esempio ci è offerto dal contesto ateniese, che ripropone il mito dell’autoctonia
attraverso diverse fonti. Tucidide si premura di precisare che l’Attica “fin dai tempi più remoti era stata
abitata sempre dalle stesse persone” (I, 2, 4), mentre i Dori erano giunti nel Peloponneso ottant’anni
dopo la guerra di Troia, sotto la guida degli Eraclidi (I, 12, 3). La contrapposizione tra gli Ateniesi,
autoctoni e di origine pura, e i popoli giunti da fuori e di carattere “misto” (migades) è espressa con
particolare forza da Isocrate (Panegirico, 24). Il tema mitico vale a rivendicare aspetti apparentemente
contraddittori del sistema di vita ateniese. Da una parte, esso ha un significato democratico e sottolinea
l’uguaglianza fra i cittadini di Atene, tutti parte di una popolazione etnicamente e culturalmente unitaria,
priva di stratificazioni sociali legate all’arrivo di nuove popolazioni sovrappostesi a quelle già insediate
nel territorio (come era invece avvenuto, nel Peloponneso, con l’arrivo dei Dori)12. Lo mette bene in
evidenza un passo del celebre Epitafio di Pericle (Tucidide II, 36, 1) che collega autoctonia e libertà;
analoga sottolineatura delle conseguenze che discendono dall’essere gli Ateniesi autoctoni, in termini di
libertà e di democrazia, emerge da un passo dell’Epitafio di Lisia (II, 17-18). D’altro lato, il mito
dell’autoctonia ha in ambito ateniese un risvolto assai meno nobile: poiché si basa su una forte
rivendicazione di identità anche etnica, esso vale infatti a giustificare la “serrata” della cittadinanza,
voluta dalla legge di Pericle del 451/50, che limitava l’accesso al corpo dei cittadini di pieno diritto ai
figli di padre e di madre ateniese, con l’intento di riservare ad un gruppo relativamente limitato i
privilegi derivanti dal possesso dello status di cittadino: privilegi che nella democrazia ateniese erano
tanto significativi da frenare ogni disponibilità ad estenderli oltre la cerchia dei cittadini “puri” (katharoí).
Del resto, non manca l’utilizzazione del tema dell’autoctonia in chiave imperialistica: l’immagine
dell’Attica come madrepatria dell’intera stirpe ionica, che armonizza mito dell’autoctonia e tema della
Cfr. D. Whitehead, The Ideology of the Athenian Metic, Cambridge 1977; C. Bearzot, Apragmosyne, identità del meteco e
valori democratici in Lisia, in Identità e valori: fattori di aggregazione e fattori di crisi nell’esperienza politica antica (Atti del
Convegno, Bergamo-Brescia 16-18 dicembre 1998), Roma 2001, pp. 63-80.
11 Cfr. M. Sordi, Integrazione, mescolanza, rifiuto nell’Europa antica, in Integrazione, mescolanza, rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in
Europa dall’Antichità all’Umanesimo (Atti del Convegno Cividale del Friuli, 21-23 settembre 2000), Roma 2001, pp. 17-26;
E AD., Her. VIII, 144, 3 – Sall. Cat. VI, 2: unità e alterità etnica nel modello greco e nel modello romano, in L’alterità nella dinamica delle
culture antiche e medievali: interferenze linguistiche e storiche nel processo della formazione dell’Europa (Atti del Convegno Milano, 5-6
marzo 2001), Milano 2002, pp. 71-81.
12 Cfr. V. Rosivach , Autochtony and the Athenians, CQ 37 (1987), pp. 294-306; M. Sordi, Propaganda e confronto politico, in Alle
radici della democrazia: dalla polis al dibattito costituzionale contemporaneo, Roma 1998, pp. 57-67, 60 ss..
10
4
parentela ionica, ebbe un ruolo importante nel sostenere le pretese egemoniche degli Ateniesi rispetto
agli alleati ionici della lega delio-attica.
Un altro esempio è offerto dal caso dell’Arcadia, che ripropone il tema dell’autoctonia in un
contesto geopolitico molto diverso, quello del Peloponneso, la cui storia era stata caratterizzata
dall’arrivo successivo di diverse popolazioni e dalla ricerca di non sempre facili compromessi di
convivenza con i popoli già presenti sul territorio. Gli Spartani, non a caso, giustificavano la loro
egemonia sul Peloponneso con il mito del “ritorno degli Eraclidi”, testimoniato anche da Tucidide I, 12,
3: l’arrivo dei Dori nella penisola non sarebbe stata una vera e propria invasione di popoli estranei
all’area peloponnesiaca, ma il ritorno alla loro terra d’origine degli antichi abitanti. In questo contesto di
tensioni e rivalità fra popolazioni etnicamente non omogenee, gli Arcadi, all’epoca dell’egemonia
tebana, si appellano alla tradizione che li voleva unica popolazione autoctona del Peloponneso13 per
rivendicare il diritto all’egemonia su di esso, sia contro gli Spartani, invasori provenienti dall’esterno, sia
contro i Tebani, possibili “nuovi Spartani”, a loro volta estranei al Peloponneso. Il tema viene proposto
in un discorso dell’arcade Licomede di Mantinea, che risale all’anno 364 e che ci è conservato da
Senofonte (Elleniche VII, 1, 23-24). Il richiamo all’autoctonia ha, come si è già ricordato, anche precise
implicazioni democratiche, che si ripropongono qui nella contrapposizione tra gli Arcadi, stato federale
a orientamento democratico, e la Sparta oligarchica paladina delle autonomie cittadine. Ma l’aspetto a
mio parere più significativo sta nel collegamento tra il mito dell’autoctonia e la crescita di una
autocoscienza che porta gli Arcadi a rivendicare l’egemonia sul Peloponneso. Licomede presenta infatti
gli Arcadi come gli unici abitanti autoctoni del Peloponneso, dunque i più antichi e i soli a poter vantare
diritti sul territorio; inoltre, come la popolazione “più numerosa e più forte della Grecia”, come la più
coraggiosa e capace di fornire un insostituibile contributo militare. La convinta rivendicazione
dell’origine autoctona e della forza militare e demografica degli Arcadi va di pari passo con l’invito ad
assumersi le relative responsabilità storiche come egemoni di un Peloponneso libero da influenze
esterne, finalmente nelle mani non di usurpatori venuti da fuori, ma di un popolo dotato di una forte
identità etnica strettamente legata alla dimensione locale14.
Il mito dell’autoctonia riveste dunque per i Greci un ruolo fondamentale nella rivendicazione
della propria identità etnico-culturale ed è usato, di volta in volta, per porre l’accento su aspetti diversi,
dall’uguaglianza “democratica” tra le componenti della cittadinanza alla difesa dei propri privilegi, dalla
giustificazione di pretese egemoniche su elementi culturalmente affini alla rivendicazione nazionalistica
dei propri diritti ancestrali su un territorio contro usurpatori di diversa origine. In tutti i casi, appare
forte la tendenza a sottolineare la propria identità politica e culturale nei confronti di altre realtà
elleniche, verso le quali viene percepita e sottolineata, a diversi livelli, un’estraneità che fa da
presupposto al rifiuto di ogni autentica prospettiva di integrazione.
3. LA POSIZIONE DELICATA DELL’APOLIDE
Esclusione tendenziale dello straniero e forte sottolineatura dell’identità rendono
particolarmente difficile la posizione, in Grecia, dell’apolide. Tale è la condizione degli esuli (phygades), la
cui posizione giuridica è, nel mondo greco, anche più delicata di quella degli xenoi. Gli apolidi sono
infatti uomini rimasti privi della cittadinanza: ed essendo il Greco essenzialmente un polites, l’assenza di
cittadinanza rende l’esule degno di disprezzo. Si diventava esuli in seguito a provvedimenti di bando,
dovuti a motivi di carattere politico (le lotte di fazione che caratterizzarono la storia della Grecia classica
furono potenti fattori di crescita del fenomeno dell’esilio) oppure all’applicazione di una pena; era però
relativamente frequente che vi si ricorresse volontariamente, per sfuggire (anche preventivamente) a
Presente già in Erodoto (VIII, 73: “Sette popoli abitano il Peloponneso. Di essi due sono autoctoni e risiedono nella
regione che abitavano anche nei tempi antichi, gli Arcadi e i Cinuri”) e in Tucidide (I, 2, 3: “Le terre migliori subivano
continui mutamenti di abitatori, come quella che ora è chiamata Tessaglia e la Beozia e la maggior parte del Peloponneso ad
eccezione dell’Arcadia”).
14 Cfr., per ulteriore approfondimento sul discorso di Licomede, C. Bearzot, Federalismo e autonomia nelle Elleniche di Senofonte,
Milano 2004, *.
13
5
questi provvedimenti o per cercare altrove condizioni di vita più favorevoli. Nel corso del IV secolo il
numero degli esuli crebbe enormemente nel mondo greco: gli apolidi, in condizioni di grave precarietà
sul piano economico e sociale, andarono ad accrescere le masse itineranti di avventurieri, mercenari,
mercanti (Isocrate fa spesso riferimento a loro definendoli con il nome di planómenoi, “erranti”: cfr.
Plataico, 46 ss.; Archidamo, 68; Filippo, 96). In una Grecia povera di risorse, queste masse di apolidi privi
di residenza fissa e di mezzi di sostentamento (l’aporía tou biou di cui parla Isocrate, Panegirico, 174,
sottolineandone le conseguenze negative in termini di instabilità sociale) alimentarono anche il
brigantaggio15.
L’esule poteva porre rimedio alla sua condizione (che spesso comportava anche la rottura dei
rapporti familiari e la confisca dei beni) chiedendo ospitalità ad un’altra comunità politica. L’esule si
affidava, in questo caso, al principio religioso della sacralità dell’ospite, posto sotto la protezione di
Zeus Xenios, e poteva rendere più impegnativa per l’interlocutore la sua richiesta ponendosi nella
condizione di supplice (hiketes): tuttavia, le autorità politiche potevano esitare nel concedere protezione,
per motivi di opportunità politica (evitare conflitti con la comunità d’origine dell’esule) o anche per il
possibile contrasto tra norma religiosa e legge positiva (l’esule poteva trovarsi nella sua condizione
anche in base a fondati motivi giuridici). La sicurezza dell’esule dipendeva insomma dalla disponibilità
di comunità che non avevano obblighi nei suoi confronti, il che lo esponeva a diversi rischi: egli poteva
essere dichiarato nemico dallo stato ospite, e dunque perseguito, catturato e ucciso (si pensi al caso di
Temistocle, inseguito per tutta la Grecia da emissari spartani e ateniesi, o ai “cacciatori di esuli”
sguinzagliati dai Macedoni contro i democratici ateniesi nel 322), oppure essere oggetto di una richiesta
di estradizione (come quella rivolta da Sparta alle città greche a proposito dei democratici esuli all’epoca
dei Trenta Tiranni). Il tema dei rischi che l’esule correva nel momento in cui si rivolgeva ad una
comunità per chiedere ospitalità è fortemente presente nella tragedia attica, a riprova dell’importanza
del problema nella società, nella cultura e nell’etica greca (per esempio nelle Supplici di Eschilo,
nell’Edipo a Colono di Sofocle, negli Eraclidi di Euripide). Già abbiamo ricordato la tradizionale
disponibilità degli Ateniesi nei confronti degli esuli: possiamo aggiungere che l’epigrafia ha restituito
diversi decreti ateniesi in favore di esuli, i quali prevedono, oltre a vari onori e concessioni, forme di
affidamento alle autorità (la boulé, gli strateghi), affinché essi non subiscano adikía e godano di tutela
giuridica.
La massima aspirazione degli esuli era costituita, in ogni caso, non dall’integrazione in un
diverso contesto politico e sociale, ma dal ritorno alla propria comunità di origine. Lo mostra bene il
caso degli abitanti di Platea, una comunità di esuli che, in condizioni assai sfavorevoli, riuscì a
mantenere una salda identità cittadina e coltivò sempre il sogno del ritorno, mostrandosi disinteressata
all’integrazione in un contesto diverso. Platea, città beotica gravitante fin dal VI secolo su Atene, cui era
legata da una stabile amicizia, venne distrutta nel 427 dai Tebani, sostenuti dagli Spartani; gli uomini
furono uccisi, donne e bambini resi schiavi (Tucidide III, 68). Circa 2000 Plateesi (tra cui circa 550
adulti maschi) trovarono rifugio in Atene, dove ricevettero, con un raro caso di naturalizzazione di
gruppo, la cittadinanza ateniese16.
L’inserimento nel corpo civico ateniese consentì ai Plateesi di sfuggire alla precaria condizione
di apolidi, in attesa di tempi migliori. Durante la permanenza in Atene, sappiamo che la comunità dei
Plateesi cercò di mantenere la sua coesione attraverso lo stretto contatto con i connazionali e il
mantenimento delle proprie abitudini e tradizioni. Un passo dell’orazione lisiana Contro Pancleone, rivolta
contro un tale che si diceva Plateese ed era sospettato di volere, con ciò, usurpare i diritti concessi dagli
Ateniesi agli sfortunati abitanti di Platea, ci informa del fatto che i Plateesi residenti in Atene si
riunivano fra loro una volta al mese al mercato del formaggio fresco (Lisia XXIII, 5-6). La
testimonianza illustra bene la volontà dei Plateesi di mantenere la propria identità e la coesione della
comunità, costituendo una sorta di enclave nell’ambito del corpo civico ateniese, in attesa del ritorno alla
propria città di origine. La difficoltà di integrazione dei Plateesi in ambito ateniese, nonostante la
Cfr. C. Bearzot, Xenoi e profughi nell’Europa di Isocrate, in Integrazione, mescolanza, rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa
dall’Antichità all’Umanesimo (Atti del Convegno, Cividale del Friuli 21-23 settembre 2000), Roma 2001, pp. 47-63.
16 Cfr. L. Prandi, Platea. Momenti e problemi della storia di una polis, Padova 1988, pp. 93 ss.; per una accurata disamina delle fonti
sulla concessione cfr. M.J. Osborne, Naturalization in Athens, I, Brussel 1981, 28 (D1); II, Brussel 1982, pp. 11 ss..
15
6
tradizionale amicizia con Atene e la generosa accoglienza ricevuta, è testimoniata dal mantenimento
dell’etnico Plataieus (che emerge, oltre che dalla testimonianza lisiana, dalle iscrizioni sepolcrali)17 e dallo
svolgimento del servizio militare in unità separate (Tucidide IV, 67, 1-2). Una conferma viene dal fatto
che gli Ateniesi, già nel 421, cercarono di trovare una nuova sede ai Plateesi, inviandoli col loro
consenso a Scione, distrutta e spopolata (Tucidide V, 32, 1; Isocrate, Panegirico, 109; Diodoro XII, 76,
4). Nel 404 però, dopo la sconfitta di Atene nella guerra del Peloponneso, i Plateesi furono espulsi da
Scione per volontà di Lisandro (Plutarco, Vita di Lisandro, XIV, 4) e dovettero rientrare in Atene, dove
come testimonia Lisia, si trovavano agli inizi del IV secolo.
Ma la vicenda non finisce qui. Platea fu ricostruita in seguito alla pace comune del 386 (Pausania
IX, 1, 4), dalla quale probabilmente i Plateesi si attendevano una garanzia di autonomia dalle pretese
tebane. In un clima politico che vedeva Atene e Tebe alleate contro Sparta, l’appoggio di quest’ultima
diveniva fondamentale per Platea, che accolse una guarnigione spartana e con Sparta collaborò negli
anni successivi. Nell’estate del 373 Platea, riluttante ad aderire alla Lega beotica sottomettendosi al
controllo di Tebe, fu nuovamente attaccata e distrutta dai Tebani; l’intervento fece precipitare i rapporti
fra Atene e Tebe, che erano state fino a quel momento unite contro Sparta (Senofonte, Elleniche, VI, 3,
1)18. Si apriva così, per i Plateesi, una nuova stagione di incertezza. Nonostante l’impegno profuso da
Isocrate, che pubblicò fra 373 e 371 il Plataico per sostenere i Plateesi che chiedevano la ricostruzione
della loro città e dipinse a tinte fosche il triste destino dei Plateesi privati della patria (§ 46 ss.), questa
volta l’impegno ateniese nei confronti degli esuli fu meno deciso di quello del 427. Del resto, forse gli
stessi Plateesi non si attendevano, né desideravano, un nuovo assorbimento nel corpo civico ateniese:
dal Plataico isocrateo risulta in realtà che essi si limitarono a richiedere la ricostruzione della loro città,
lamentando la perdita del koinòs bios e, con esso, del rapporto solidale con la comunità (§ 46-49). Il
passo mostra come i Plateesi temessero soprattutto la perdita di identità collegata con la fine di quel
koinòs bios che si sperimentava nell’ambito della polis e che costituiva uno degli aspetti fondamentali
dell’identità greca, tant’è vero che essi avevano cercato in ogni modo di mantenerne alcuni aspetti
durante il soggiorno ateniese del secolo precedente: in questa prospettiva, una nuova concessione di
cittadinanza da parte ateniese non avrebbe certo risolto i loro problemi. Non è la piena integrazione nel
corpo civico dell’amica Atene che i Plateesi si attendevano, bensì un concreto aiuto a tornare a Platea e
a ricostituire l’integrità della comunità cittadina originaria: il che poté avvenire solo dopo il 338, quando
Platea fu ricostruita per iniziativa di Filippo II di Macedonia.
Nella situazione di estrema precarietà dei Plateesi, costretti a lunghi periodi di esilio che
comportarono la resezione dei rapporti con il territorio e lo sfaldamento della comunità e li costrinsero
a sopravvivere come minoranza numerica più o meno ben tollerata in ambiente estraneo, colpisce la
capacità di mantenere comunque una forte identità etnica, politica e culturale, in grado di consentire la
rifioritura della comunità, una volta realizzate condizioni più favorevoli. E colpisce soprattutto il
disinteresse per l’integrazione in Atene, che pure li aveva accolti con generosità, concedendo loro una
eccezionale naturalizzazione di gruppo e sottraendoli al loro stato di apolidi.
La percezione dello straniero nella mentalità dei Greci e la posizione giuridica di cui egli godeva
nel mondo delle città greche autorizzano a parlare di una sua “definizione funzionale”19: egli, cioè,
riceve una serie di concessioni che ne migliorano la condizione e ne favoriscono, se non l’integrazione,
almeno la sicura convivenza con i cittadini della comunità che più o meno stabilmente li ospita, nella
misura in cui essi offrono a tale comunità prestazioni che essa riconosce utili. Il rapporto che si viene a
determinare è dunque di natura contrattuale: la polis, nel suo carattere di comunità fondata sul
riconoscimento di culti e di leggi comuni e sulla partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari
comuni, in linea di principio esclude lo straniero; ma ne può apprezzare l’attività in campo economico,
contributivo, militare, evergetico. In questo caso, la città elabora i diversi istituti che abbiamo esaminato
Plataieús /Plataiké, con diverse grafie: cfr. IG II-III 2 10086-10102.
Sulla vicenda e le relative fonti cfr. Prandi, Platea, pp. 121 ss.; C. Bearzot, La città che scompare. Corinto, Tespie e Platea tra
autonomia cittadina e politeiai alternative, in In limine. Ricerche su marginalità e periferia nel mondo antico, Milano 2004, pp. 269-286.
19 Baslez, L’étranger dans la Grèce antique, 204.
17
18
7
e, pur non integrando lo straniero, gli offre la possibilità di non essere considerato un nemico e di
entrare in una qualche relazione con la comunità cittadina.
Ma il rapporto fra identità e integrazione nel mondo greco è complesso. Il cittadino, con il suo
forte senso di identità, anche nei confronti degli altri Greci, che così bene si esprime nel mito
dell’autoctonia, è riluttante a integrare lo xenos; ma è anche vero che neppure lo xenos vuole veramente
integrarsi, e gli apolidi, come mostra il caso dei Plateesi, mostrano un sostanziale disinteresse per ogni
soluzione (dall’integrazione alla ricerca di nuove sedi) che non comporti la ricostruzione della comunità
originaria. Il forte senso identitario caratteristico dell’uomo greco tende ad escludere ogni forma di
integrazione, non solo, come è logico, nel caso in cui si debba concederla, ma anche nel caso in cui se
ne sia beneficiari.
Il tramonto, in seguito all’affermazione dei grandi regni ellenistici, dell’esperienza politica della
polis (le cui tradizionali strutture sopravvivono, ma ormai prive, una volta venute meno l’autonomia e la
libertà, del loro più autentico significato partecipativo) favorì una percezione diversa, e caratterizzata da
maggiore apertura e disponibilità, verso lo straniero. La grande crescita della popolazione e la
commistione che essa portò con sé creò un tessuto sociale assai composito, in cui la diversità, anche
etnica, fu percepita in forma meno drammatica. All’interno delle città, la differenza tra meteci e xenoi,
così forte nella polis classica, si affievolì; lo sviluppo della vita associativa, in ambito militare,
commerciale e religioso-cultuale, favorì l’integrazione degli elementi stranieri, anche di etnia non greca.
La città ellenistica, concepita come centro di cultura piuttosto che come forma di stato, può essere
considerata, diversamente da quella classica, una più efficace struttura di integrazione.
Cinzia Bearzot
Università cattolica di Milano
8