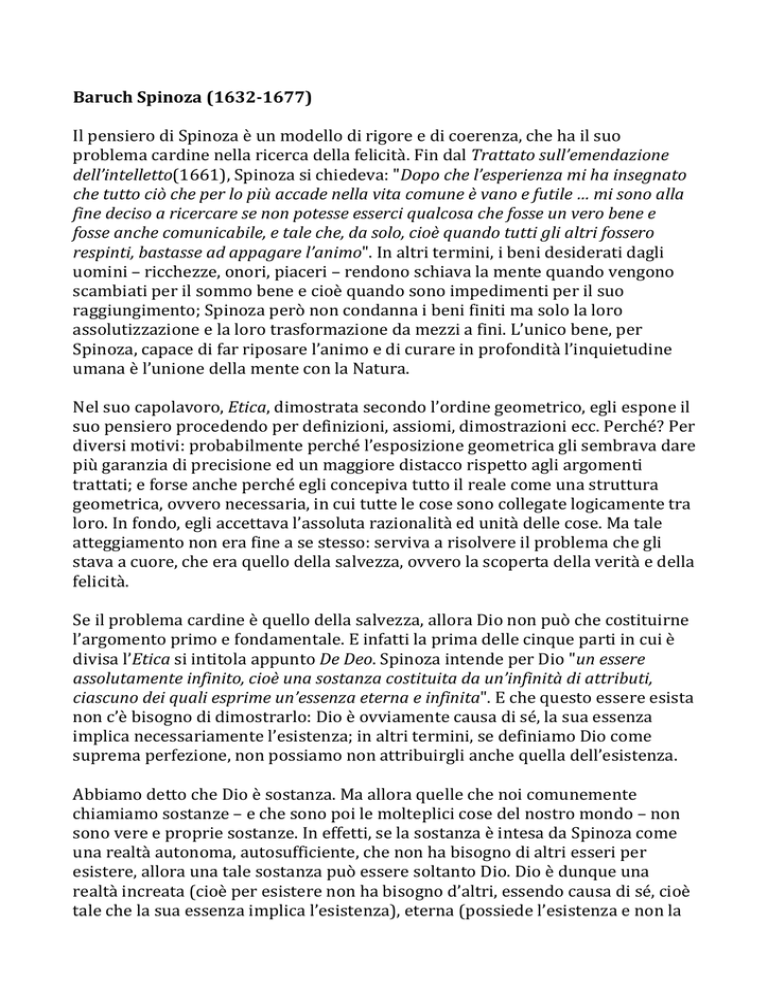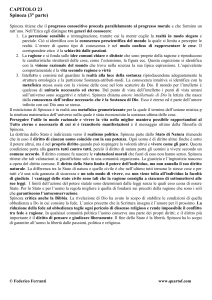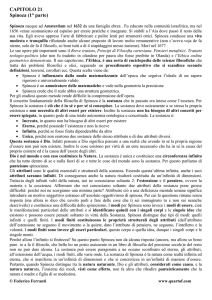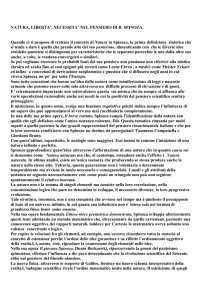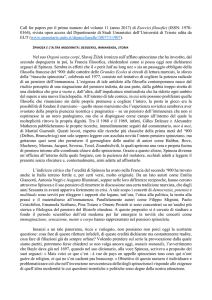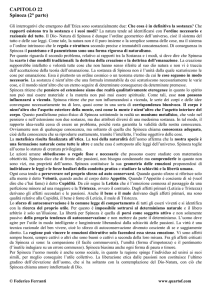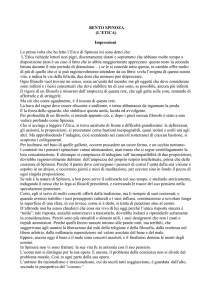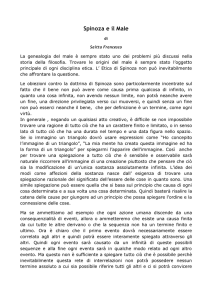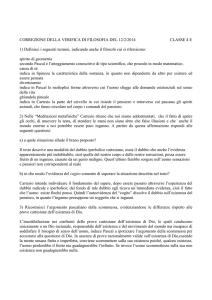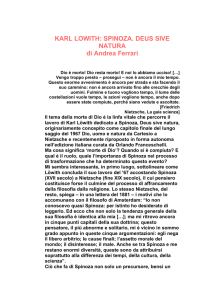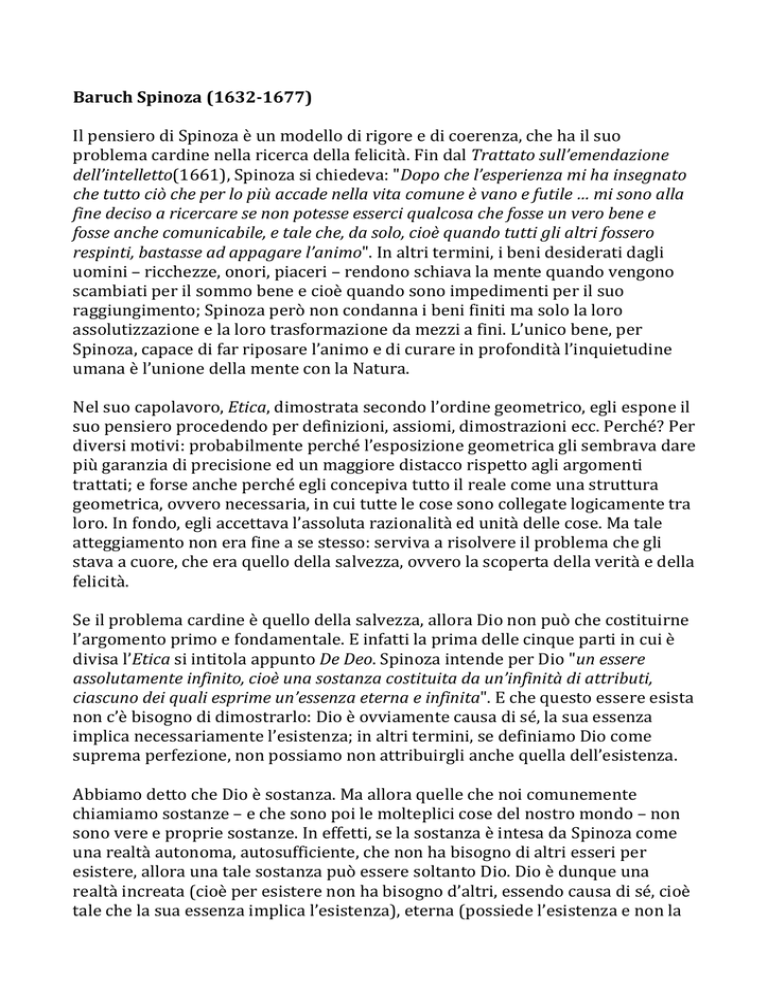
Baruch Spinoza (1632-1677)
Il pensiero di Spinoza è un modello di rigore e di coerenza, che ha il suo
problema cardine nella ricerca della felicità. Fin dal Trattato sull’emendazione
dell’intelletto(1661), Spinoza si chiedeva: "Dopo che l’esperienza mi ha insegnato
che tutto ciò che per lo più accade nella vita comune è vano e futile … mi sono alla
fine deciso a ricercare se non potesse esserci qualcosa che fosse un vero bene e
fosse anche comunicabile, e tale che, da solo, cioè quando tutti gli altri fossero
respinti, bastasse ad appagare l’animo". In altri termini, i beni desiderati dagli
uomini – ricchezze, onori, piaceri – rendono schiava la mente quando vengono
scambiati per il sommo bene e cioè quando sono impedimenti per il suo
raggiungimento; Spinoza però non condanna i beni finiti ma solo la loro
assolutizzazione e la loro trasformazione da mezzi a fini. L’unico bene, per
Spinoza, capace di far riposare l’animo e di curare in profondità l’inquietudine
umana è l’unione della mente con la Natura.
Nel suo capolavoro, Etica, dimostrata secondo l’ordine geometrico, egli espone il
suo pensiero procedendo per definizioni, assiomi, dimostrazioni ecc. Perché? Per
diversi motivi: probabilmente perché l’esposizione geometrica gli sembrava dare
più garanzia di precisione ed un maggiore distacco rispetto agli argomenti
trattati; e forse anche perché egli concepiva tutto il reale come una struttura
geometrica, ovvero necessaria, in cui tutte le cose sono collegate logicamente tra
loro. In fondo, egli accettava l’assoluta razionalità ed unità delle cose. Ma tale
atteggiamento non era fine a se stesso: serviva a risolvere il problema che gli
stava a cuore, che era quello della salvezza, ovvero la scoperta della verità e della
felicità.
Se il problema cardine è quello della salvezza, allora Dio non può che costituirne
l’argomento primo e fondamentale. E infatti la prima delle cinque parti in cui è
divisa l’Etica si intitola appunto De Deo. Spinoza intende per Dio "un essere
assolutamente infinito, cioè una sostanza costituita da un’infinità di attributi,
ciascuno dei quali esprime un’essenza eterna e infinita". E che questo essere esista
non c’è bisogno di dimostrarlo: Dio è ovviamente causa di sé, la sua essenza
implica necessariamente l’esistenza; in altri termini, se definiamo Dio come
suprema perfezione, non possiamo non attribuirgli anche quella dell’esistenza.
Abbiamo detto che Dio è sostanza. Ma allora quelle che noi comunemente
chiamiamo sostanze – e che sono poi le molteplici cose del nostro mondo – non
sono vere e proprie sostanze. In effetti, se la sostanza è intesa da Spinoza come
una realtà autonoma, autosufficiente, che non ha bisogno di altri esseri per
esistere, allora una tale sostanza può essere soltanto Dio. Dio è dunque una
realtà increata (cioè per esistere non ha bisogno d’altri, essendo causa di sé, cioè
tale che la sua essenza implica l’esistenza), eterna (possiede l’esistenza e non la
riceve da altri), infinita (se no dipenderebbe da qualcos’altro mentre la sua
essenza non può avere limiti), unica (non possono essercene due uguali,
entrambe infinite, eterne ecc.).
Attenzione adesso: questo Dio di Spinoza non è però il Dio della tradizione
religiosa. La sostanza così concepita viene chiamata da lui Deus sive Natura (Dio
ovvero la Natura): infatti, se la sostanza è unica, tutte le cose saranno o la
sostanza stessa o manifestazioni di essa. In altri termini, Dio e il mondo non sono
due enti separati, bensì uno stesso ente, giacché Dio non è fuori del mondo ma
costituisce con esso un’unica realtà chiamata da Spinoza Natura. Il che equivale a
dire che Dio è visto come "causa immanente, e non transeunte, di tutte le cose"
(cfr. Lettera 73°). Dio e la Natura e le cose sono i modi della stessa sostanza
divina.
Spinoza distingue in Dio gli attributi e i modi. Gli attributi sono le qualità
essenziali e strutturali della Sostanza e sono infiniti (Perché sono infiniti?
Perché, come il nulla non ha attributi perché è appunto il nulla, così, ciò che è
qualcosa, proprio perché è qualcosa, ha degli attributi; di conseguenza, più un
essere è qualcosa, più un essere è complesso, più ha molti attributi; Dio, che è
l’essere più perfetto, deve dunque avere infiniti e perfetti attributi). Spinoza
definisce Dio e gli attributi, considerati come causa, la Natura naturans. L’uomo,
di tutti gli attributi divini, ne può conoscere però soltanto due: l’estensione e il
pensiero, ovvero la materia esteriore delle cose e la coscienza.
I modi sono invece le manifestazioni degli attributi, ovvero i singoli corpi e le
singole idee, che non hanno vera e propria sostanzialità, in quanto esistono solo
in virtù della Sostanza e dei suoi attributi. Essi sono, ad esempio, il movimento,
l’intelletto, la volontà, quel determinato corpo, le varie cose ecc. L’insieme dei
modi, visti come effetto, è chiamato da Spinoza Natura naturata.
Si noti ancora una volta: la natura non è intesa da Spinoza come la tradizione
popolare e filosofica ci hanno abituati. Essa non è più, in Spinoza, una potenza
dinamica e procreante, non è qualcosa che genera le cose bensì è un ordine da
cui seguono i vari modi; essa è l’ordine necessario e razionale del tutto, è l’ordine
geometrico dell’universo, cioè il sistema o la struttura globale del tutto e delle
sue leggi. In altri termini, la Natura o Dio è per Spinoza il complesso delle leggi
universali dell’essere, l’ordine strutturale delle relazioni tra le cose.
Dio ovvero la Natura ovvero la Sostanza non crea le cose. Le cose singole non
scaturiscono né per creazione né per emanazione; esse derivano piuttosto
necessariamente come dalla definizione di una figura deriva necessariamente
che ad es. la somma degli angoli interni è uguale a due retti. Insomma, le cose
scaturiscono in modo necessario dalla Sostanza, come le conseguenze di
particolari premesse.
Allora nell’universo di Spinoza non vi può essere nulla di contingente, poiché in
esso tutto ciò che è anche solo possibile si realizza necessariamente. Nella
Sostanza stessa, coincidono libertà e necessità, nel senso che essa è libera perché
agisce senza nessun condizionamento esterno ad essa (non c’è nulla di esterno
alla Sostanza), ma è anche necessitata perché agisce necessariamente, in virtù
delle leggi immanenti del suo essere. Non vi sono neppure, in un simile universo,
le cause finali: è solo un pregiudizio dell’intelletto umano – dice Spinoza –
credere nelle cose come dei mezzi per conseguire dei fini; da ciò nasce poi il
pregiudizio che la divinità produca e governi le cose per gli uomini, per legare gli
uomini a sé e per essere da essi onorata. Ma se Dio agisse per un fine, vorrebbe
qualcosa di cui egli difetterebbe, e dunque Dio non sarebbe più perfetto. In
realtà, per Spinoza, i valori, cioè il bene, il male, l’ordine, il disordine, il bello, il
brutto ecc. non hanno un valore oggettivo ma esprimono solo il modo in cui le
cose stesse colpiscono gli uomini. Del resto neppure l’uomo è libero. Gli uomini
pensano di essere liberi perché sono consci dei loro voleri e dei loro desideri,
mentre in realtà ignorano le cause che li hanno portati a desiderare qualcosa.
L’uomo è spinto ad agire sempre in vista dell’utile, comunque venga inteso, ed
appunto in questo senso non ci possiamo ritenere liberi ma determinati.
Tuttavia – dice Spinoza – vi è un’alternativa, tra l’agire per l’utile in modo
istintivo ed emozionale (e quindi essere schiavi delle passioni, lasciandoci
travolgere e guidare solo da esse), e l’agire per l’utile in modo intelligente (e
quindi senza lasciarci travolgere dalle passioni). In questo senso l’uomo può
essere libero, se sceglie di porsi come soggetto attivo e non puramente passivo
nei confronti della propria tendenza all’autoconservazione.
Si badi: il saggio non pretende di avere un dominio assoluto sulle passioni, che
Spinoza ritiene impossibile. La libertà del saggio consiste, più concretamente, in
una sempre più adeguata comprensione di esse, visto che di esse non ci
possiamo totalmente liberare. La virtù è allora per Spinoza "agire secondo le
leggi della propria natura"; è uno sforzo di autoconservazione divenuto
cosciente e saggiamente diretto; è una tecnica razionale del vivere bene, in un
calcolo intelligente circa ciò che si deve o no fare in vista della migliore
sopravvivenza possibile. L’uomo morale è allora l’uomo sociale, in quanto la
ragione spinge l’uomo ad unirsi ai suoi simili, per meglio conseguire un utile che,
in tal modo, diventa un utile collettivo. In questo senso, dice Spinoza, "nulla è più
utile all’uomo che l’uomo stesso" (cfr. Etica, 4,18, scolio). Compito della filosofia
sarà allora quello di liberare l’uomo dalle illusioni e dall’ignoranza, in modo che
possa giungere alla salvezza. Nella quinta e ultima parte dell’Etica (intitolata "La
potenza dell’intelletto ossia la libertà umana"). vi è un vero e proprio inno alla
libertà, all’amore e alla beatitudine, come compimento di quell’itinerario di
salvezza da cui la speculazione spinoziana aveva preso le mosse. Il filosofo del
determinismo assoluto, senza rinnegare le sue premesse, è diventato il filosofo
che auspica la perfetta libertà.
Non siamo però ancora arrivati alla fine. L’esito finale della elevazione spirituale
dell’uomo sarà dato da ciò che Spinoza chiama l’amore intellettuale di Dio. Per
comprendere che cosa intende Spinoza con questa espressione, dobbiamo
cominciare a dire che ai sensi il mondo appare molteplice, contingente,
temporale, imperfetto; all’intelletto, invece, esso appare come un tutto unitario,
necessario, eterno, dove il bene e il male, la perfezione e l’imperfezione sono
soltanto punti di vista relativi e antropomorfici. La falsità – che è l’errore
fondamentale a cui l’immaginazione può condurre l’uomo – è non vedere le cose
nella loro autentica fisionomia, cioè nella necessità, unità, eternità. Certo, anche
l’errore, il male, l’illusione, in quanto sono qualcosa, dipendono necessariamente
ed eternamente da Dio, ma altrettanto ne dipende la verità del loro
oltrepassamento e del loro smascheramento. A questo riguardo, però, si badi:
non si tratta per Spinoza né di deridere né di detestare gli affetti e le azioni degli
uomini ma di comprenderle, come dicevamo già prima (non ridere, neque
detestari sed intelligere). Per Spinoza non ha senso un’etica in senso classico,
prescrittiva, in cui sono date delle norme: l’etica spinoziana descrive, non
prescrive. Detto questo, la via della sapienza è intesa come la conoscenza
adeguata del Tutto e delle parti che lo compongono. Il processo conoscitivo, una
volta abbandonata la fallacia della immaginazione, coincide col processo di
liberazione, che non è fuga dal mondo ma riconoscimento del suo reale
significato: "Quanto più noi conosciamo le cose singole, tanto più conosciamo
Dio". Il vertice della conoscenza è raggiungere il punto di vista di Dio stesso. Qui
ha origine l’amore intellettuale di Dio, che è "una parte dell’amore infinito col
quale Dio ama se stesso". Non solo : "l’amore di Dio verso gli uomini e l’amore
intellettuale della mente verso Dio sono una sola e medesima cosa". La felicità
nasce appunto dalla conoscenza di quell’ordine necessario che è la stessa
sostanza di Dio. In altri termini, la conoscenza di ogni singola cosa come
elemento o manifestazione necessaria di quell’ordine è appunto contemplazione
di Dio e amore intellettuale di lui. Ecco la beatitudine per Spinoza: perseguire
l’utile in maniera razionale e vivere la vita nel miglior modo possibile.
Ci si può certo chiedere: ma è possibile arrivare a quel punto? Spinoza non fa
mistero sulle difficoltà dell’impresa: "Tutte le cose sublimi sono tanto difficili
quanto rare". Tuttavia si può e si deve provare. Proprio per questo si può sempre
sperare che ogni uomo, anche se adesso è schiavo della passione e
dell’ignoranza, possa aprirsi alla via della salvezza. Dio – dice Spinoza – non
pretese dagli uomini altra conoscenza al di fuori di quella della sua divina
giustizia e della carità: conoscenza che non è necessaria alla scienza ma soltanto
all’obbedienza. La virtù, che per il saggio consegue alla conoscenza, per il volgo è
oggetto di obbedienza, che esso accoglie non in base all’evidenza intrinseca del
comando ma sulla fiducia nella testimonianza stessa.
Questo ci porta alla concezione spinoziana dello Stato. Egli parte dalla
considerazione del cosiddetto stato di natura. Per esso, ogni uomo è di diritto
altrui finché è sotto il potere altrui, ed è nel proprio diritto quando può
respingere ogni violenza, quando può vendicare il danno che gli è stato fatto e
quando può vivere come gli pare. Ora, quanti più individui si associano, tanto più
cresce la loro potenza e quindi il loro diritto, così la loro associazione determina
un diritto più forte, che appartiene a ciò che chiamiamo "governo". Il sorgere di
un diritto comune fa sorgere le valutazioni morali che, al di fuori di esso non
hanno senso. Il diritto dello Stato limita il potere dell’individuo ma non annulla
del tutto il suo diritto naturale. La differenza tra lo stato di natura e lo stato civile
è che in quest’ultimo tutti temono le stesse cose e per tutti c’è una sola garanzia
di sicurezza ed un solo modo di vivere (ciò non toglie all’individuo la facoltà di
giudizio). I vantaggi dello stato civile sono comunque tali che la ragione consiglia
a tutti di sottomettersi alle sue leggi. Vi è comunque un limite all’azione dello
Stato: esso è sottomesso alle leggi, nel senso che è obbligato a non distruggere se
stesso. Poiché il fine dello Stato è la pace e la sicurezza della vita, la legge
fondamentale che limita l’azione dello Stato deriva da quella sua intrinseca
finalità, senza la quale viene meno allo scopo per cui è sorto, cioè alla sua stessa
natura. In qualsiasi comunità politica, l’uomo conserva una parte dei propri
diritti; e il diritto più geloso è la facoltà di pensare e di giudicare liberamente. Il
fine dello Stato – dice Spinoza – è quello di garantire che la mente e il corpo degli
uomini adempiano con sicurezza la loro funzione, che essi si servano della libera
ragione e non si combattano con odio, ira o inganno, né si affrontino con animo
iniquo (cfr. Trattato teologico-politico, 20). In quanto alla religione, se la fede è
vista da Spinoza come essenzialmente obbedienza e se l’unico precetto della
Scrittura a cui si può ricondurre tutto è l’amore per il prossimo, allora la
religione è riconducibile a pochi capisaldi che esprimono appunto le condizioni
necessarie e sufficienti dell’obbedienza. Così è tolto ogni pericolo di dissenso
religioso ed è reso impossibile ogni conflitto tra fede e ragione, teologia e
filosofia.
CENNI BIOGRAFICI (1632-1677)
La vita di Spinoza fu, sotto ogni aspetto, esemplare. Fu l’esistenza di un uomo
modesto e lieto, raccolto nella meditazione, schivo di onori, sprezzante della
ricchezza, del tutto alieno da risentimenti e rancori, ma non scevro da quel fondo
di passionalità che è il contrassegno stesso della partecipazione alla vita, anche
se il pensiero e l’esistenza di Spinoza hanno quale meta il dominio razionale
delle passioni. Vi è in lui una profonda coerenza tra l’uomo reale e quel modello
umano che aveva tracciato nell’Etica. Il suo modello di uomo è quello di un
essere che si lascia guidare soprattutto dalla ragione. E ragione significa
intelligere: il comprendere spinoziano è il tentativo di purificare le passioni per
rendere la mente più limpida dal punto di vista del Tutto. Spinoza scelse per sé
un modo assai semplice e frugale di esistenza perché, pur avendo quelle qualità
che aveva in sommo pregio – come la fermezza morale, la forza d’animo e la
gaiezza senza eccessi – non desiderava avere soverchi fastidi e intendeva
dedicarsi senza distrazioni al proprio lavoro intellettuale e a quella meditazione
della vita in cui faceva consistere la vera filosofia. Era ben consapevole di vivere
in una società fanatica e intollerante, ma rimase sempre sereno, deciso a
salvaguardare la propria tranquillità interiore, non volendo perdere la cordialità
e la cortesia nei confronti di chiunque, ricchi o no, gente semplice o esimi dotti.
Spinoza proveniva da una famiglia benestante e stimata di commercianti
appartenenti alla florida e colta comunità ebraica portoghese, rifugiatasi in
Olanda per sfuggire le persecuzioni. La sua cultura fu vasta e profonda (otto
lingue tra antiche e moderne, conosceva bene la Bibbia, il Talmud, la filosofia
ebraica e araba oltre a quella a lui contemporanea, e tutto il pensiero scientifico,
teologico e politico della sua epoca) ed ebbe relazioni di alto livello con molti
uomini illustri del suo tempo (Leibniz, Enrico Oldenburg, Simone de Vries ecc.),
ma non disdegnava in alcun modo gli uomini di buonumore, amanti della vita e
attenti al proprio utile.
Educato nella comunità ebraica, visto il talento e la cultura di Spinoza nel quale
avevano riposto le più grandi speranze, quando il giovane Spinoza manifestò le
sue idee "eterodosse", fecero di tutto per fargli cambiare idee: giunsero ad
offrirgli una pensione annua pur di evitare lo scandalo di una apostasia. Alla fine
però venne scomunicato e bandito dalla comunità il 27/7/1656. Da allora vivrà
tutto dedito ai suoi studi e provvederà al proprio mantenimento vendendo lenti
da lui stesso molate con grande perizia. Si stabilirà prima a Rijinsburg, poi a
Voorburg e quindi all’Aja, dove morirà il 21/2/1677.
Spinoza rappresentò l’uomo della tolleranza e della ricerca instancabile,
l’avversario di ogni dogmatismo, di ogni chiusura intellettuale e morale, di ogni
ortodossia teologica, ecclesiastica o politica che ostacoli o vieti la libertà di
pensare e quella, non meno importante, di esprimere le proprie idee e di
insegnare.