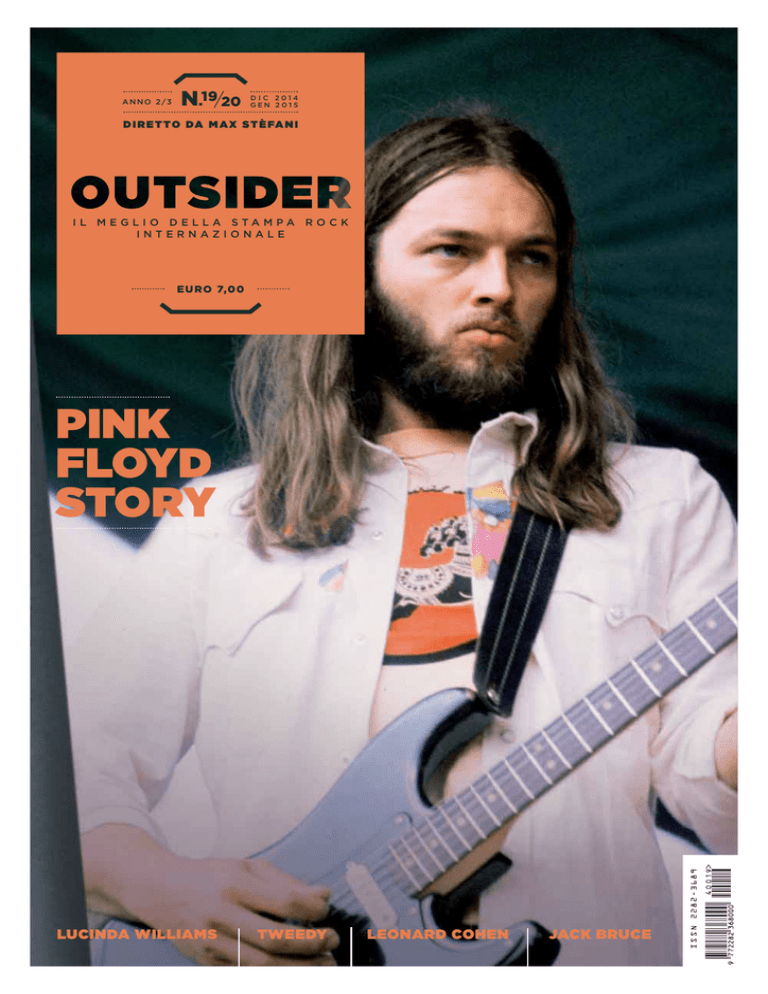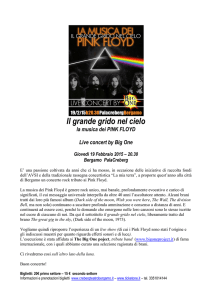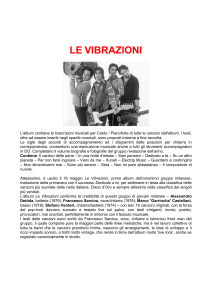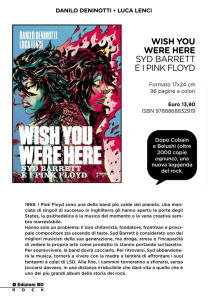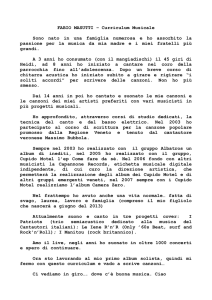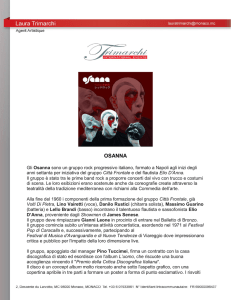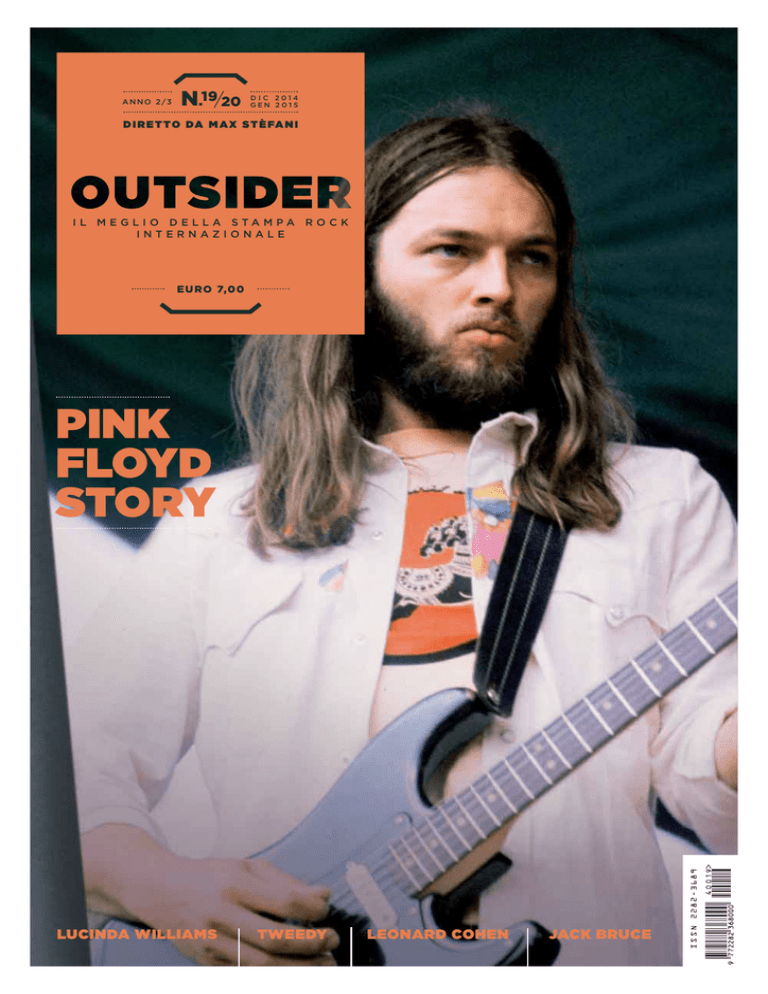
ANNO 2/3
N.19/20
DIC 2014
GEN 2015
D I R E T TO DA M A X S T È FA N I
I L M E G L I O D E L L A STA M PA R O C K
INTERNAZIONALE
EU RO 7,00
PINK
FLOYD
STORY
LUCINDA WILLIAMS
TWEEDY
LEONARD COHEN
JACK BRUCE
BRUCE SPRINGSTEEN
creatività&grafica | link, milano | [email protected]
THE ALBUM COLLECTION VOL. 1, 1973-1984
I primi 7 ALBUM da studio di SPRINGSTEEN
rimasterizzati,
disponibili in CD e LP per Columbia Records/Legacy Recordings,
con riproduzioni degli ARTWORK ORIGINALI,
FOTO, MEMORABILIA E RARITÀ.
VERSIONE CD
VERSIONE LP
www.brucespringsteen.net
b
i
t
www.sonymusic.it
https://www.facebook.com/SonyMusicLegacyItaly
https://twitter.com/LegacyItaly
IN TUTTI I NEGOZI DA NOVEMBRE
ROLLING STONES
FROM THE VAULT/
HAMPTON COLISEUM
LIVE
IN 1981
____________
DVD / SD BLU-RAY / DVD + 2 CD /
DVD + 3LP
“From The Vault” è la nuova serie di concerti dal
vivo estratti dall’archivio dei Rolling Stones che
vengono per la prima volta pubblicati ufficialmente. “Hampton Coliseum - Live In 1981” è il primo
titolo di questa fantastica serie, che inizia dal quel
magico tour americano del 1981 per la release
dell’album “Tattoo You”, in grado di fruttare ben
50 milioni di dollari in biglietti venduti. Saltiamo
con Mick Jagger sulle note di “Tumbling Dice,”
“Miss You,” “Brown Sugar,” “Jumping Jack Flash,”
“(I Can’t Get No) Satisfaction” e molte altre.
ROLLING STONES
L.A.
FORUM - LIVE IN 75
____________
DVD / DVD + 2 CD / DVD + 3LP
“L.A. Forum - Live In 1975”è il secondo titolo della
serie FROM THE VAULT direttamente dagli archivi
dei Rolling Stones; questa volta il tour di riferimento
è quello del 75, denominato “Tour Of The Americas
’75”, il primo con il nuovo chitarrista Ronnie Wood.
Dopo un paio di concerti di “riscaldamento” in
Louisiana il tour salpò alla volta di 44 date dal 3
giugno all’8 agosto 1975. Cinque furono le notti al
FORUM di Los Angeles dal 9 al 13 luglio, questa è
quella del 12 luglio, con tanto di audio restaurato e
nuovamente mixato da Bob Clearmountain.
Un documento imperdibile!
GENESIS
SUM
OF THE PARTS
____________
GENESIS
THREE
SIDES LIVE
____________
DVD / BLU-RAY
DVD / BLU-RAY
I Genesis si raccontano in un documentario che
ripercorre la loro incredibile carriera. ‘Sum of
the Parts’, contiene i contributi dei membri del
passato e del presente: Tony Banks, Phil Collins,
Peter Gabriel, Steve Hackett, Mike Rutherford
e Anthony Phillips. Prodotto da Eagle Rock
Film Productions e diretto da John Edginton il
docu-film racconta quella che è una straordinaria
avventura musicale, capace di esplorare il gruppo
dall’interno e di mettere in rilievo alti e bassi della
loro intera avventura. ‘Sum of the Parts’ contiene
anche il documentario ‘Together and Apart’
prodotto e trasmesso solo dalla BBC.
“Three Sides Live” è un documento filmato che risale al Novembre del 1981 durante il tour di “Abacab” in Nord America, originariamente pubblicato in
VHS per l’uscita sul mercato dell’omonimo album
dal vivo.
Fu reso disponibile come DVD solo nel box limitato
di “The Movie Box 1981-2007”. Prodotto in origine
in 16mm, il filmato è stato interamente restaurato
ed è finalmente disponibile come standard DVD e
Blu-ray per la prima volta in assoluto.
ERIC CLAPTON
PLANES, TRAINS AND
ERIC
____________
DEEP PURPLE
WITH ORCHESTRA
LIVE
IN VERONA
____________
DVD / BLU-RAY
DVD / BLU-RAY
La fedele testimonianza del tour di Eric Clapton
con la sua band in estremo oriente nel 2014 con
performance complete estratte dal tour oltre a
interviste con lo stesso Clapton e i membri della
band , durante prove, soundcheck, viaggi in treno
e in aereo; mostrandoci sotto ogni punto di vista
che significa andare “On the road” con Eric Clapton.
Concerto ripreso nella a dir poco spettacolare cornice della storica Arena di Verona. Questo concerto dell’estate del 2011 vede i Deep Purple esibirsi
nei loro classici più famosi con il supporto di una
intera orchestra .
Disponibile anche in alta definizione (Blu-ray) per la
gioia dello sterminato seguito dei DEEP PURPLE.
DOORS
FEAST
OF FRIENDS
____________
MONTY PYTHON
LIVE (MOSTLY)
ONE
DOWN FIVE TO GO
____________
DVD / BLU-RAY
Feast Of Friends è stato filmato nel 1968, come
primo ed unico film prodotto dai Doors sui Doors.
Ci offre una visione cinematografica che vede la
band on the road nel corso del tour dell’estate di
quell’anno.
Sebbene non del tutto completato il film fornisce
un approccio in pieno stile cinema veritè tipico degli anni 60 con spezzoni di concerti e riprese dirette
del gruppo nel loro habitat naturale.
DVD / BLU-RAY / DE LUXE
La reunion sul palco dei Monty Python per la prima volta dopo 30 anni è stato uno degli eventi del
2014. Ripreso dal vivo la sera finale del 20 luglio
dopo ben 10 performance alla O2 Arena di Londra
di fronte ad un pubblico di oltre 200.000 persone.
Tra i bonus troviamo i dietro le quinte dell’annuncio
della reunion del novembre 2013, della produzione
e del backstage alla 02 Arena delle serate del luglio
2014. Il tutto disponibile in alta definizione DVD,
Blu-Ray e in versione De Luxe con audio esclusivi
dello show in 2 CD e un libretto fotografico di 64
pagine.
www.edel.it
A DIVISION OF EAGLE ROCK ENTERTAINMENT LIMITED
eagle vision www.eagle-rock.com
4
OUTSIDER
OVERTURE
OVERTURE
di Max Stèfani
Torniamo al nostro progetto iniziale, che era quello di fare un giornale di alta qualità solo
per abbonamento. La discesa negli inferi delle edicole non era prevista né tantomeno voluta.
Di conseguenza questo numero di dicembre/gennaio esce normalmente nelle edicole italiane, ed è doppio, per dare a tutti voi che ci leggete il tempo per abbonarsi, per trovare 60 euro,
5 euro al mese, 16 centesimi al giorno, che possano allungare la vita di questo giornale fino
a che non saremo tutti vecchi e appagati di rock.
Da febbraio saremo solo in abbonamento.
So che per molti sarà un boccone amaro da digerire, perchè
anni e anni d’inefficienza della Posta ci hanno insegnato
a non fidarci, perché siamo abituati fin da quando cominciamo a leggere a rivolgerci all’edicola sotto casa, perché
comunque non crediamo nel prossimo.
Siano l’editore, la Posta, il postino, i vicini di casa, che sicuramente ci rubano la posta, il politico, il collega di lavoro etc.
Ma il mercato è cambiato e dobbiamo bene o male avvicinarci ai paesi più avanti di noi, dove le edicole non esistono
e i giornali vengono spediti solo per posta. Valga per l’Inghilterra o gli Stati Uniti.
Troppo dispendioso il percorso che porta questo giornale
sotto casa vostra. Alla fine per vendere le attuali 4000 copie
(comunque più dei vari ‘Mucchio’, ‘Blow Up’, ‘Rumore’) bisogna stamparne 15.000. E fa male buttare al macero
11mila copie! È uno spreco dannoso alla natura (quanti al-
beri inutilmente tagliati?) e alle nostre casse. Anche perché
dei 7 euro che costa la rivista ce ne arrivano a malapena
poco più di 3.
È un suicidio.
E non è neanche possibile ridurre la tiratura perchè se si
diminuisce porta con sé anche il calo delle vendite. Nessun
giornale regge 60mila edicole.
Inoltre, ciò ci consente anche di tornare alla stampa in ‘piana’ dei primi numeri, che offriva una risultato migliore.
‘OUTSIDER’ è un giornale di qualità nei testi. Nelle fotografie. Nell’impaginazione. E tutto questo merita anche
una qualità di stampa e di carta che ne faccia risaltare le
doti.
Resta comunque inteso che anche qualora non si raggiunga un numero di abbonati tale per garantire la sopravvivenza, verrà stampato nelle copie necessarie per tutto
il 2015, onde non lasciare nessuno a piedi.
OUTSIDER
Detto questo, passiamo alla
vivo che riporta il rock vemusica.
nato di country al massimo
Pare proprio che il disco dei
del suo splendore, con una
Pink Floyd abbia riportato
sequenza di canzoni che racin Italia la gente nei negozi
chiudono l’intero percorso
di dischi. Contenti per una
della cantautrice americana,
boccata di ossigeno necessadimostrando che quando l’iria. Solo per questo l’evento
spirazione si miscela a cuore,
andrebbe comunque festegesperienza, sentimento e tecgiato. Si parla anche di un
nica la mente vola.
loro passaggio a San Remo…
Lucinda che ha inizio 2014
Ma, come dice Michele Borgià ci aveva deliziato con
soi in facebook, c’è sempre
la ristampa dell’omonimo
un leggero velo di tristezza:
e seminale album del 1988,
“È proprio uno strano monche non solo annunciò l’ardo questo in cui per settimarivo di una voce di grande
ne sono stati riempiti media
significato per le arti e la
e social network di commenletteratura americana, ma
ti e notizie inerenti alla sua
segnò anche la nascita di un
pubblicazione come se si fosnuovo genere: l’alt country.
se trattato del miracolo della
L’incipit dell’articolo dice
liquefazione del sangue di
‘Troppo country per essere
San Gennaro (sostanzialrock - Troppo rock per essere
mente una bufala), mentre
country’. Può darsi, ma per
la pubblicazione dell’intefortuna il mercato italiano
grale dei Basement Tapes,
non è per lei fondamentache stanno al rock e alla mule. Ne può fare volentieri a
Sgomitando tra due life-style a Linate
sica popolare del ‘900 come
meno. Non noi però.
gli affreschi della cappella
Si prosegue con Tweddy,
degli Scrovegni stanno alla pittura del ‘300 e del primo riperché il suo nuovo disco con il nipote è l’ennesima chicca
nascimento, non se li sia filati praticamente nessuno”.
dell’ex leader dei Wilco.
Noi prendiamo l’occasione al volo per dedicare ai 5 uomini
A aprire la ‘wild song’ del mese, ovvero Hallelujah, fate
inglesi (la copertina a Gilmour non ha particolari signifivoi se nell’originale di Leonard Cohen o nella più famosa
cati, è solo un buon scatto) lo spazio necessario per rinverdelle cover, quella di Jeff Buckley.
dire una bella e lunga storia.
A chiudere un breve excursus sulle migliori uscite discoPoi a voi giudicare la qualità del disco che ha diviso come
grafiche di questo 2014. O scaricate o preparate il portafopochi.
glio…
Potrei suggerirvi di non trascendere visto che non esistono
E poi la solita messe di recensioni di dischi nuovi (ricorverità assolute nella musica? ...ognuno sente e si emoziona
datevi che noi aspettiamo sempre uno-due mesi rispetto
per chi ama.
ai nostri colleghi) come Neil Young, Brian Setzer, Damien
Comunque, per giudicare la qualità della critica rock locaRice, Mark Lanegan, Lucero, Jerry Lee Lewis etc, ristamle... per la metà i Pink Floyd muoiono con Barrett. Per l’altra
pe, vedi David Wiffen, Lowell George, George Harrison,
metà si fermano a Ummagumma, un disco che tutti gli auPaul McCartney, Ry Cooder, Big Star, Steve Ray Vaughan
tori definiscono, con un delicato giro di parole, una cacata.
etc., chicche della parte finale “Mixed Up”, cioè Marshall
Io e Trombetti ci siamo rotti la testa a cercare e tradurre il
Tucker Band, Quicksilver, Dave e Phil Alvin nel loro tour
meglio, onde fornire uno spaccato del ‘mondo Pink Floyd’
italiano da noi sponsorizzato, Bad Company, Sonnie Leril più completo possibile.
che etc.
Anche per questo mese è tutto. Ci vediamo fine gennaio,
Lucinda Williams meritava lo spazio che volentieri
ma state collegati sul nostro sito www.outsiderock.com o
gli concediamo. E a dirla tutta anche la copertina, anche
su facebook.
se purtroppo per lei, il tempo passa e non è più la fresca
cowgirl di fine anni ottanta. È un po’ stagionata ma con lei
Buon Natale e capo d’anno.
succede come con il vino di qualità.
Con affetto i vostri Jake e Elwood, Max Stèfani e GiancarDown Where The Spirit The Bone è un doppio album dal
lo Trombetti.
5
6
OUTSIDER
TITOLO ARTICOLO
SOMMARIO/POSTA
SOMMARIO N.19/20
DIC 2014/GEN 2015
4 EDITORIALE
6 SOMMARIO
+ POSTA
86 RECENSIONI
8
QUESTO MESE TOCCA A LISA
LE BLANC, WEEZER, NEIL
YOUNG, DANIEL LANOIS,
DAMIEN RICE, MARK LANEGAN LUCERO, SHOVELS AND
ROPE… INSOMMA NIENTE
MALE.
WILD SONG
QUESTA È LA NOSTRA ‘WILD
SONG’ DEL MESE. HALLELUJAH DI LEONARD COHEN MA
ANCHE DI JEFF BUCKLEY.
QUALE PREFERITE?
14
62
PINK FLOYD
48
L’OCCASIONE
DELL’USCITA DI THE ENDLESS RIVER, AL DI LÀ DI
COME LO GIUDICHIATE,
CI DÀ L’OPPORTUNITÀ DI
TORNARE PER LA SECONDA VOLTA NELLA STORIA
DI QUESTO GIORNALE
SULLA BAND INGLESE.
E CI SIAMO ALLARGATI
COME AL SOLITO.
JEFF TWEEDY
LUI È QUELLO DEGLI
UNCLE TUPELO E SOPRATTUTTO DEI WILCO.
INSOMMA UN NOME
TUTELARE DI QUELL’AREA DI ROCK AMERICANO VICINO ALLE SUE
RADICI. IL SUO NUOVO
DISCO CON IL NIPOTE
È ANCORA UNA VOLTA
INTRIGANTE.
POSTA
76
LUCINDA
WILLIAMS L’IDEA
ERA VERAMENTE DI METTERLA IN COPERTINA
MA L’OCCHIO ESPERTO
DELL’UOMO DEL MONTE
HA DETTO DI NO. CIÒ
NON TOGLIE CHE LA
SIGNORA AMERICANA
È UNA DELLE NOSTRE
FAVORITE DA QUASI 25
ANNI. E QUINDI LUNGA
INTERVISTA E BELLISSIME FOTO D’ANNATA.
OSCAR 2014
L’ANNO SCORSO ABBIAMO EVITATO QUESTA INUTILE SEQUENZA DI TITOLI
MA VISTO CHE CI AVETE
BACCHETTATO ECCO UN
40 DISCHI PER CUI È VALSA LA PENA SPENDERE
I NOSTRI PREZIOSI EURI.
E IN FIN DEI CONTI CI
SIAMO ANCHE DIVERTITI
A BUTTARLA GIÙ.
98 RISTAMPE
INEVITABILE SCRIVERE
DELL’ENNESIME REISSUE DEI
LED ZEPPELIN. POI DAVID
WIFFEN, JONI MITCHELL,
RY COODER, HARRISONE
MCCARTNERY, LOWELL
GEROGE, OASIS…
110 MIXED UP
FLEETWOOD MAC, PHIL
E DAVE ALVIN, UNPAIO
DI ADDITT COME JACK
BRUCE E ROAS, QUICKSILVER, MARSHALL TUCKEER,
CLAPTON, ROLLING STONES,
BAD COMPANY, HOUSE OF
CARDS…
129 WHO WE ARE
CHI SONO I DUE TIMONIERI
DI OUTSIDER MAX STEFANI
(JAKE “JOLIET” BLUES) E
GIANCARLO TROMBETTI
(ELWOOD BLUES)?
COSA È PREVISTO PER FEBBRAIO? FORSE TELEVISION,
ZZ TOP O GENE CLARK.
MAGARI MELLENCAMP. O CI
FACCIAMO DEL MALE CON
JACKSON BROWNE? BASTA
ASPETTARE PER SAPERLO.
[email protected]
Ciao Max ti ho già scritto quasi un anno fa per i complimenti e per il piacere di ritrovarti ancora sul campo, pronto per nuove sfide. Spiace sentire che potrebbe esserci la
possibilità di avere la rivista solo per abbonamento. Personalmente una rivista così bella non vorrei mai vederla
distrutta per infilarla nella buca delle lettere stretta e piccola. Già mi è spiaciuto vedere il cambio di carta che c’è stato
e vederla trattare male mi farebbe stare peggio. Pensa che
se la rivista mantenesse l’attuale impostazione editoriale e le stessa grafica sarei anche disposto a pagarla uno o
due euro in più, ma se passerete al solo abbonamento purtroppo sarò costretto a lasciarvi, con mio grande dispiacere.
God save our music.
Domenico (Torino)
Lo so, vecchio problema con il quale come editore mi scontro da 30 anni. Allargare la cassetta?
OUTSIDER
Grazie Max, ti seguo da tanti anni e sto adorando “Outsider”...
Sono un rocker bassofilo, ex venditore di dischi ventennale
(categoria estinta), a lutto per Jack Bruce ma felice di aver letto
di Berry Oakley e co. su Outsider. E complimenti sempre per la
coerenza.
Luca De Pasquale
Troppo buono Luca...grazie.. Tra un po’ anche i giornalisti/editori musicali saranno una categoria estinta.
Max! Spiacente per il ritardo. Mi ero distratto un po’.. e confesso di aver perso il filo da i tempi del “Mucchio”.
Ho scoperto Outsider al mattino presto, in edicola, lo scorso
numero (gli occhi, nonostante il torpore mattutino pre-caffè,
si sono autosbarrati su quella copertina..“Allman Brothers
Band”). La Foto, il nome, la veste essenziale ed imponente
allo stesso tempo del magazine.. Classe di altri tempi.., non vi
potevano essere dubbi. Ho aperto delicatamente la rivista.. Ed
eccomi qui.
Senza ulteriori preamboli. Mi abbono!. Cartaceo. Ovviamente.
Giusto per quella sublime sniffata mensile di rivista appena
stampata.
Mi abbono. Non intendo assolutamente saltare i Grateful
Dead!
Max, sarà pura nostalgia.., ma “Outsider” è eccezionale (nella
veste e nella sostanza). Come una bella e intelligente signora
ancora piacente…
Grazie e ciao.
Ah, dimenticavo. Avrei una domanda imbarazzante da porti.
Ma sino a che età può andar bene il Rock? Qual’è il limite per
evitare eventuali controindicazioni?
Michele Patanè
Limiti?
Salve, sono Maurizio. Ormai cinquantenne ma cresciuto con
tutti i primi numeri del ‘Mucchio Selvaggio’ e estimatore di
Max e di Giancarlo Trombetti, che conobbi più di trent’anni fa
nella sede di Radio Viareggio mi sembra si chiamasse e lui trasmetteva musica rock in piena notte.... e io sempre a seguirlo.
Ho trovato x caso in edicola Outsider e me ne sono innamorato subito, mi fa riprovare quei bei momenti di buona musica
passati e le foto delle copertine del Mucchio poi.... e ler ricordo
tutte... belle sensazioni. Ora voglio tutti i 16 numeri che ho
perso.
Grazie Max per essere tornato... e un caro saluto a Giancarlo di
cui possiedo a distanza di oltre 30 anni ancora le musicassette
di concerti registrati da lui del grande Frank Zappa...
Vi seguirò sempre
Grazie
Maurizio Lenzetti
Max is back. Finalmente ho trovato la rivista “Outsider” (numero 17….. ma ho già provveduto tramite l’edicolante a richiedere tutti i numeri pubblicati) esposta tra le altre, nella edicola
di fiducia della città in cui vivo (Isernia, per dovere di cronaca). Ho ritrovato Max tra le sue pagine. Sono diventato adulto
(musicalmente) leggendo il “Mucchio” e ascoltando la nostra
musica. Oltre i doverosi complimenti, tutti quelli che desideri,
ti chiedo caro Max di fare in modo che per ogni mese trascorso
la ritrovi lì, la mia nuova rivista, nella edicola della mia città.
Ennio Notardonato
Ciao Max. Eccomi qui a Linate, tornando a Bari dopo un viaggio
lampo a Londra per vedere i Blackberry Smoke in concerto. 2
ore di attesa per la coincidenza, entro in edicola senza grande
speranze: ma oddio, ho visto bene??? Che cos’e’ questa rivista?
Jerry Garcia in copertina? The Band? Grateful Dead? 70s British
pub-rock? Ducis in fundo una recensione dello stesso Blackberry Smoke??? Ma allora c’è speranza, esiste gente qui in Italia che
apprezza la grande musica del passato e del presente, che non
sente l’obbligo di seguire ciò che fa tendenza!
Incredibile, grande grande grande, un prodotto eccezionale, per
me supera anche i miei co-nazionali Mojo e Uncut che, per citare te stesso, hanno fatto “discesa negli inferi delle edicole” e
ora risultano scialbe e ripetitive. Grazie di cuore e un salutone
anglo-italiano! Many thanks!
Martin Baxter
Caro Max, Ho letto con interesse sull’ultimo numero di Outsider l’articolo sulle Jam Bands, ma devo farTi un appunto: mi
sarei aspettato uno specchietto che indicasse i migliori album
dal vivo di Grateful Dead, Govt Mule, Widespead Panic e Phish
da avere (o i concerti top da scaricare dal sito bt.etree.org); nel
“mare magnum” di centinaia di uscite occorre infatti una guida all’acquisto per orientare il navigante smarrito!
D’altra parte lo avevi già fatto per i Grateful Dead nel numero
393 di Mucchio Selvaggio dell’aprile 2000.
Complimenti per trasmissione (ops, la rivista) e mi auguro di
continuare a trovarla in edicola.
Baccio da Pisa
Ciao Max. Ho cercato Outsider di novembre a Roma nelle edicole centralissime di Piazza S. Silvestro, Piazza Colonna, Via
Veneto, Largo Argentina ma niente. E non è esaurito, non lo
conoscono proprio. Stessa cosa per San Lorenzo o Corso Trieste.
Solo oggi, venerdì 21 novembre, l’ho trovato, in un’edicola di
piazza Bologna, dove l’avevo cercato anche nei giorni scorsi.
Che si può fare?
Riccardo Tessari
A Roma siamo con quasi 1000 copie su 140 rivendite circa,
comprese quelle dell’Aeroporto. La copertura delle edicole servite è buona, ma tieni presente che su Roma ci sono circa 850
(?!?) edicole. Capisci xche andiamo solo x abbonamento?
Ciao, sarà che comincio ad invecchiare anche io, sarà che in un
mondo sempre più virtuale ed effimero si cerca di aggrapparsi alle poche cose materiali che ancora vengono prodotte con
qualità... sarà invece che la passione per il rock non muore mai
e alla fine ad una rivista come la vostra mi ci sono abbonato.
Grazie per l’ottimo lavoro e continuate così.
Bokal
Ciao Max, una cosa soltanto: grazie. Ho scoperto da poco (un
mese appena) la rivista, e sono impazzito. È bellissima, fichissima, oh sì, che goduria, ancora. straordinaria.
Io mi occupo di tutt’altro settore (sport), troppo spesso di bassa
qualità su giornali e riviste. Credo che la musica possa essere
trattata, proprio come lo sport, in maniera banale, superficiale,
scadente. Oppure no. Bello vedere che in giro ci sono prodotti
meravigliosi come quello che fate voi.
Complimenti.
Giorgio Burreddu
7
8
OUTSIDER
Photo: Claude Gassian
HALLELUJAH
OUTSIDER
WILD SONGS
LEONARD COHEN
HALLELUJAH
di Kim Ruehl
È una canzone scritta (con molti riferimenti ai testi biblici e all’Antico Testamento) e interpretata da Leonard Cohen nel 1984 sull’album Various Positions. Nel corso degli anni ne sono state fatte molte
reinterpretazioni, ad opera sia dello stesso Cohen, che ne modificava ripetutamente il testo (quella pubblicata nell’album Cohen
Live del 1994 manca per esempio della maggior parte dei rimandi
al testo sacro), sia di molti altri artisti. Se la prima cover fu del 1991,
incisa da John Cale (nel 2001 inclusa nella colonna sonora del film
d’animazione ‘Shrek’), la reinterpretazione di maggior successo, che
supera in notorietà anche l’originale, rimane ancora oggi quella di
Jeff Buckley, pubblicata nel 1994, nel suo unico album Grace.
I’ve heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don’t really care for music, do you?
It goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah…
9
10
OUTSIDER
HALLELUJAH
Prendetevi una pausa, lettori, ed alzate gli occhi al cielo, perché anche una
canzone di questo livello ha dovuto
sopportare interpretazioni assurde, al
limite del ridicolo. Cantata in maniera
fantastica da artisti del calibro di K.D.
Lang (nel 2006) o Jeff Buckley (nel
1994) prima di lei, è stata eseguita in
contesti tipo ‘American Idol’ o in talentshow per adolescenti tipo X-Factor che
ce la propinano nella versione di Buckley senza dare l’impressione di averne
colto minimamente il senso più profondo. Anzi, a volte ridicolizzandola.
Questa, pur splendida, è quella maggiormente conosciuta, e molti ‘alternativi’ di oggi, quelli fighi che non hanno
idea di cosa possa significare informarsi, scoprire, ricercare, approfondire,
sono convinti che Hallelujah sia stata
scritta proprio da… Jeff Buckley.
E non possiamo biasimarli del tutto,
visto che ha fatto parte anche di innumerevoli colonne sonore cinematografiche e di telefilm ed è stata inoltre
oggetto di un documentario del 2008
andato in onda su BBC Radio 2.
Quasi in contemporanea proprio nello
stesso anno la canzone fu riportata sotto i riflettori dall’interpretazione della
cantante inglese Alexandra Burke,
che ebbe la malaugurata idea di pubblicarla come singolo di debutto, subito
dopo aver ottenuto la
vittoria della quinta
edizione del talent
show inglese ‘X-Factor’.
Buckley ha preso dunque questa canzone da
un artista – Leonard
Cohen che la incise
nel 1984 per l’album
Various Positions –
che la eseguiva a mo’
di mantra rendendola quasi una forma di
meditazione, e l’ha
resa un drammatico
inno all’amore mentre
nel frattempo Cohen
ha cominciato a provato timidamente a
chiedere di grazia di
evitare di proporre altre versioni della sua
canzone.
Ma senza ottenere granchè.
Originariamente Cohen aveva scritto
circa ottanta versi per Hallelujah e l’ha
eseguita in diverse versioni.
Dylan ha detto che, nel backstage di
un concerto, Leonard Cohen gli aveva confidato di aver impiegato circa
due anni per completare la canzone e
l’autore stesso confermò poi l’episodio,
aggiungendo però di aver mentito, perché si vergognava di rivelare che in realtà aveva impiegato un tempo ancora
più lungo di quanto dichiarato.
Cohen descrisse le difficoltà nella
composizione citando un episodio in
particolare:
“Avevo riempito due blocchi degli appunti e ricordo
che ero al Royalton Hotel
a NYC seduto in mutande
sul tappeto, mentre sbattevo la testa sul pavimento
dicendomi ‘Non riesco a
finire questa canzone’”.
Il brano fu poi registrato con il produttore John Lissauer, ma ci furono molte
resistenze da parte della Sony a pubblicare il disco in quanto riteneva che
il materiale non fosse abbastanza buono. Cohen molti anni dopo aggiunse
così di considerare la popolarità ottenuta da Hallelujah attraverso i suoi
molti interpreti, come una sorta di
piccola rivincita nei confronti dell’iniziale diffidenza dimostrata dalla casa
discografica.
Peccato comunque che per i più esista
solo il testo cantato da Buckley, che
non rende a pieno la complessità della
storia raccontata da Cohen (nella quale il narratore racconta in terza persona la vicenda di Sansone e Dalila, cercando di cogliere dalla stessa il senso
delle proprie vicende personali).
Come prima cosa è interessante notare
come il pezzo ci racconti dell’esperienza di comporre canzoni.
Un ‘Re confuso’ compone un ‘hallelujah’ seguendo una progressione da
un accordo di quarta ad uno di quinta
facendolo cadere su uno di minore per
poi risalire con un accordo maggiore.
Questo è l’accompagnamento, ma il
cantato si muove un passo alla volta
su una scala maggiore. Ci parla di una
Jeff Buckley (Getty Images)
OUTSIDER
scontata frase musicale cantandola in
maniera prevedibile in modo da poter
raccontare una storia di amore altrettanto prevedibile – bastano i primi tre
versi a farci capire che c’è una donna
che lo prenderà, lo lascerà e gli spezzerà il cuore – dando vita ad una drammatica elegia.
Come era più che ovvio, si tratta di una
puttana; non c’è dubbio che sia così,
soprattutto dal momento che non si
lascia nemmeno far intravedere.
Ma non è questo il punto, anche se il
concetto è stato espresso dall’autore in
una forma poetica accattivante quanto convincente. La versione di Buckley consente a chiunque abbia anche
minime capacità vocali di eseguire il
pezzo indulgendo maggiormente alla
cifra emotiva. C’è dramma, sesso, lotta
di potere fra due amanti. Si
tratta di una storia fantastica,
dove il tema del sesso assume un ruolo fondamentale al
punto che Buckley omette di
proposito le due strofe della
versione originale che si riferiscono invece al tema della
redenzione. Lo stesso Buckley
dichiarerà in un’intervista
che “chiunque ascolti chiaramente Hallelujah scoprirà
che è una canzone che parla
di sesso, di amore, della vita
sulla terra. L’alleluia non è un
omaggio a una persona adorata, a un idolo o a Dio, ma è
l’alleluia dell’orgasmo. È un’ode alla vita e all’amore”.
Ma a parte la modifica nel testo è il
modo in cui Buckley affronta l’esecuzione della melodia che in genere
attrae altri cantanti e li spinge ad eseguirne una propria versione.
La sua registrazione comincia con un
lungo respiro, si direbbe più propriamente un sospiro. L’attenzione è tutta concentrata sul narratore. Nessun
sentimento si sviluppa nei confronti
della donna della quale si parla. È uno
sfogo bello e buono – la reazione ad
un torto subito da chi enfatizza altresì
la propria condizione di amante non
corrisposto. E l’emozione è così prorompente, il cuore così infranto, che
era indispensabile un sospiro, una
pausa prima di cominciare a raccontare. Prima di arrivare al verso più amaro
e dolente (“Tutto ciò che ho imparato
dall’amore è come difendersi da chi
ha già impugnato le proprie armi
per ferirti”) sembra manchi il respiro
quando la chitarra si affranca dal lussureggiante giardino di note continue
e tenute vive dalle pedaliere per tuffarsi in una passeggiata che nota dopo
nota riporta alla cima della tastiera
della chitarra. Ma quando
le dita stanno raggiungendo
la sommità, come volessero
sbirciare dalla cima del monte, il pensiero di spiccare un
balzo viene cancellato dalla
necessità di fare retromarcia
e l’artista rimugina sulla disapprovazione del suo stesso
comportamento.
Dopo il verso citato, Buckley
si affida alla sua chitarra
accelerando e sfruttando i
crescendo per dare spazio
al ruggito della sua voce, e
continua a svelare i segreti
dell’amore: “Non è un grido
disperato quello che tu odi di
notte – Non c’è nessuno che abbia ricevuto alcuna rivelazione – È solo un
hallelujah singhiozzato a sproposito”.
Il modo di cantare lascia trasparire un
interprete poco convinto delle parole
recitate. I versi stessi, peraltro, sono
poco convincenti quando vorrebbero
far credere che l’amore è una gigantesca e drammatica esplosione – un
evento, più che un lungo e difficoltoso
cammino -.
Ma qui dobbiamo fermarci un attimo
per cogliere per bene il significato.
‘Hallelujah’ è una parola adoperata in contesti di carattere religioso.
È composta da due parole ebraiche
e significa ‘pregare dio’.
Può essere un comando (i.e.:
‘devi pregare dio’) ma può
essere anche un’esclamazione di gioia. In quel verso in
cui Cohen parla di un ‘hallelujah’ distaccato al punto
da essere stentato, vuol fare
intendere, credo, che sia vivo
il bisogno di dare valore alla
fugacità della sensazione lussuriosa che si prova amando, piuttosto che disperarsi
per i dolori di cuore che la
condizione dell’amore può
riservare. Un tale senso di
gratitudine non è facilmente
raggiungibile, e così il poeta è
costretto a ripetere all’infinito la parola, come fosse un mantra cui alla fine
si è portati a credere.
11
12
OUTSIDER
HALLELUJAH
I versi selezionati da Buckley per la
sua versione della canzone mostrano
il protagonista, un re, e la sua amata,
dipinta come una bugiarda tentatrice
che ha solo in mente di usarlo. L’amore è un attimo fuggevole, certo non
qualcosa di duraturo, che l’amato lo
desideri oppure no. Se si pensa all’amore come ad un sentimento passeggero, è più semplice drammatizzare,
più facile rimpiangere, più immediato
desiderare ancora. L’aspetto fuggevole
di tale visione si dipana meglio attraverso il cantato, più ancora dell’aspetto interpretativo che vorrebbe inquadrare l’amore come parte di un tutto.
La drammatica apatia di Buckley si
scontra contro la realtà di Cohen.
Non è determinante il fatto che Buckley abbia tralasciato alcuni dei più
profondi versi di Cohen, è nell’intenzione che l’esecuzione di Buckley diverge da quella di Cohen.
Gli ‘hallelujah’ di Buckley si incastrano sia melodicamente che ritmicamente. Sono espressione di chi racconta, mentre nella versione di Cohen rimangono staccati dal dolore di chi soffre – e calamitano ogni attenzione su
se stessi. Nella registrazione di Cohen,
sono cantati da un coro che snocciola
le sillabe secondo il ritmo intrinseco
della parola, su tre note – verso l’alto
prima, per poi ricadere verso il basso
come le onde e la loro risacca, all’in-
finito – enfatizzando il finale ‘yah’
(‘dio’) come fosse il punto alla fine di
una frase. Cohen continua a cantare
anche fuori dal ritmo sottostante - mostrando attraverso la voce la sua incapacità di marciare a ritmo con la grazia
della preghiera. Non cerca di convincersi che si trattava di un amore su
cui continuare a contare come sembra
fare Buckley. Quella di Cohen è una
canzone di sfida; quella di Buckley
una non troppo velata ammissione di
impotenza. Questa sottile differenza è
quello che rende per me assurda la diffusione che ha avuto l’interpretazione
di Buckley, considerando che avevamo già quella di Cohen.
“Dici che ho pronunciato il nome di
dio invano – Ma se non lo conosco
Ciò che distingue questa
da ogni altra canzone
pop è che Cohen ha creato un’allegoria per poi
analizzarla dal di fuori
e condividere con tutti
una lezione imparata a
proprie spese.
nemmeno questo nome – Ed anche se
fosse così, a te poi, cosa importa? – C’è
un’esplosione di luce in ogni parola –
E non conta cosa tu abbia sentito – Il
sacro o il profano Allelujah”.
Questo verso sposta la questione di
amore dall’allegoria all’accusa. (la
versione di Buckley è tutta allegoria).
In altre parole, ciò che distingue questa da ogni altra canzone pop è che
Cohen ha creato un’allegoria per poi
analizzarla dal di fuori e condividere
con tutti una lezione imparata a proprie spese. Ciò che spesso rende una
forma d’arte tradizionale convincente, è la sua capacità di catturare l’attimo fuggente. Molte canzoni pop sono
come istantanee. Puoi interpretarle
come vuoi e lo stesso fatto che spesso
si tratta di affermazioni incomplete
mette in discussione la nostra pretesa di essere infallibili, e ci permette di
meditare insieme sul senso delle cose.
Se l’artista seguisse i propri pensieri
e li completasse con logiche quanto
personali deduzioni, finirebbe per allontanare quel pubblico che potrebbe
non avere avuto insegnamenti simili
da simili esperienze. Ma Cohen ha superato questo impasse, sviluppando
in ottanta versi una storia che racconta per filo e per segno dall’inizio sino
alla conclusione. Ci sfida a seguirlo
lungo il suo percorso. Ed è per questo
che Hallelujah ci prende più di altre
canzoni, perché inconsciamente noi,
come tutti i cantanti che continuano
a riproporla, abbiamo accettato la sfida, forse consapevolmente o forse no.
Facendoci dare una mano dalla solita
Wikipedia in lingua inglese (alla quale rimandiamo) moltissimi sono gli
artisti che hanno interpretato Hallelujah nel corso degli anni, oltre quelli
già citati. Già nel 2010 si contavano
circa 200 cover del brano registrate e
pubblicate ufficialmente. Numerosi
altri artisti hanno invece eseguito il
brano dal vivo, senza mai pubblicarne una versione. L’elevato numero di
cover, spesso realizzate per trasmissioni televisive o per le colonne sonore
di film, spinse alcuni critici e fan a
richiedere una sorta di moratoria per
fermarne l’uso, che Cohen commentò
nel 2009 dichiarando di considerare
eccessivo il numero degli interpreti
del brano. Nel gennaio 2012 Cohen
OUTSIDER
confermò di aver avuto in alcune
occasioni l’istinto di esporsi personalmente per fermare la continua
pubblicazione di cover del brano, aggiungendo però di aver poi cambiato
idea e di essere felice che il suo brano
venisse cantato da altri.
Nel 1988 un anno dopo l’uscita della
versione originale del brano, Bob Dylan ne fornì un’interpretazione dal
vivo durante un concerto al Montreal
Forum. Un’altra interessante versione del brano è quella realizzata dal
canadese Rufus Wainwright.
Il 12 febbraio 2010 viene cantata da
K.D. Lang alla cerimonia di apertura
dei XXI Giochi Olimpici invernali di
Vancouver.
Tra gli artisti più noti a livello internazionale che abbiano pubblicato una
versione di Hallelujah vogliamo citare Bono, Bon Jovi, Damien Rice,
Annie Lennox (nel 2007 cantò il
brano durante il programma televisi-
vo Taratata della TV francese), Sheryl
Crow, addirittura i nostri Elio e le
storie Tese (il 12 settembre 2001 aprirono il loro concerto al Palavobis di
Milano con una cover di questa canzone come omaggio alle vittime degli
attentati dell’1 settembre 2011 avvenuti il giorno precedente).
Nel 2007, dieci anni dopo la scomparsa di Buckley, la cover fu pubblicata
come singolo, ottenendo nel corso
degli anni seguenti un buon successo
commerciale, fino a raggiungere il disco di platino in Australia, Stati Uniti
e d’oro in Svezia e Nuova Zelanda.
In un sondaggio di ‘Rolling Stone’
americano, la versione di Hallelujah realizzata da Buckley è stata indicata dai lettori come le terza miglior
cover di tutti i tempi. Accidenti, non
ricordo quali fossero le prime due.
Forse due tra All Along The Watchtower di Dylan nella cover di Hendrix,
Black Magic Woman dei Fleetwood
13
Mac da parte di Santana, Mr. Tambourine Man sempre di Dylan da parte dei Byrds?
Oppure Respect di Otis Redding da
parte di Aretha Franklin, Stand By
Me di di Ben E. King interpretata da
John Lennon, With A Little Help
From My Friends dei Beatles cantata da Joe Cocker, Knocking on
Heavens Door dei Guns n’ Roses
sempre di Dylan, Nothing Compares
2 U classico di Prince cantato da Sinead O’Connor, I Heard It Through
The Grapevine di Marvin Gaye con
la voce di Fogerty, Twist And Shout
degli Isley Brothers fatta dai Beatles,
Gloria dei Them fatta da Patti Smith,
Downtown Train di Waits cantata da
Rod Stewart, Me and Bobby McGee
di Kris Kristofferson cantata da Janis
Joplin, Woodstock di Joni Mitchell
ripresa da CSN&Y, I Fought the Law
di Bobby Fuller di Strummer e soci.
Sto divagando. Lo so.
VINILI - CD - DVD - BOOKS
MAGAZINES - TOUR BOOKS
LP USATI
I VOSTRI CD ED
ACQUISTIAMO
TI
CONTAN
PAGAMENTI IN
RECORD RUNNERS · VIA ALBUZZI, 8 - 21100 · VARESE · TEL. 0332 234550 · www.recordrunners.it · [email protected]
www.myspace.com/recordrunners
www.facebook.com/recordrunners
Skype-name: recordrunners
14
OUTSIDER
196
1967
9677 (Get
((Getty)
Getty)
ty
y)
PINK FLOYD
OUTSIDER
IL FIUME INFINITO
PINK FLOYD
STORIE E SEGRETI
di Giancarlo Trombetti
Pink Floyd: ha un senso parlarne oggi? 38 anni sono trascorsi da The Piper at the Gates of Dawn e 31 dal vendutissimo The Dark side of The Moon.
Tenendo conto a) delle aspettative di The Endless River, il
nuovo album dei Pink Floyd targati David Gilmour, Rick
Wright e Nick Mason b) a naso in sù sotto la gigantografia
della copertina appesa in via Turati, all’incrocio con via
Moscova, a Milano c) della loro ombra che ancora si stende
su molto del rock degli ultimi anni, specie ‘post’, diremmo
proprio di sì.
Non sono ovviamente brani nuovi, nascono dalle sessioni di registrazione del 1993 per l’album The Division Bell,
quindi suonati da David Gilmour, Nick Mason e da Rick
Wright (scomparso nel settembre del 2008).
Un album essenzialmente strumentale diviso in “quattro
parti” con una canzone, Louder Than Words, il cui nuovo
testo è stato scritto da Polly Samson.
Era dunque opportuno nella filosofia di questo giornale,
che consiste comunque nel rivangare il passato della nostra musica cercando di mettere a fuoco cose all’epoca impossibili, raccontarvi da diligenti cronisti storie dei vecchi
Pink Floyd. Attraverso articoli/interviste/recensioni dell’epoca (non ultime quelle terribili di ‘Ciao 2001’).
Non è la prima volta che torniamo su di loro, il numero 2/3
di ‘Outsider’ è lì ad aspettarvi. Buona lettura.
15
16
OUTSIDER
PINK FLOYD
Esistono leggi non scritte nel mondo
musicale. Difficile abituarsi, ancora
più duro accettarle. Ma stanno lì, sotto
gli occhi di tutti, molto più facilmente
dentro le orecchie e fuori dei cervelli
non pensanti. Forse la cosa più difficile nell’ambiente musicale è convivere
con i giudizi degli Esperti; per un appassionato imparare a fidarsi e lasciarsi
guidare dalle parole e dai consigli di un
critico è come scegliere di mettersi nelle mani di un medico o di lasciar guidare l’amico ubriaco di cui non ti fidi.
In ogni caso una prova stressante e che
necessita di coraggio, oltre che di tempo, di molte, ripetute letture di molti,
troppi giornali contenenti i giudizi che
tanti decideranno, a scatola chiusa,
di far propri. Entriamo a gamba tesa
sull’argomento: parliamo dei Pink
Floyd. Dovendo seguire la critica, già
dopo il primo album, l’unico con Barrett a pieno regime, inizia o inizierebbe la parabola discendente del gruppo.
Scartate a priori produzioni minori
come le colonne sonore senza neppure
domandarsi perché queste venissero
elette da musicisti ancora da formarsi e
insediarsi nel mondo del rock, al massimo si arriva ad accettare Ummagumma. Dopo di esso, il diluvio.
Eppure la storia racconterebbe altre
vicende. Se solo si andasse ad approfondire la valanga provocata dalla
slavina dei Pink Floyd, si potrebbe anche arrivare a capire che l’importanza
della portata della loro musica sia andata ben oltre qualsiasi disquisizione
critica. Senza i Floyd non sarebbe nato
il Krautrock; d’accordo, liberissimi di
vederla come una liberazione, ma suggeriremmo di approfondire l’argomento prima di gettarlo dalla finestra.
Senza i Floyd sparirebbe la vena centrale della ‘psichedelia’ dal novanta
per cento dei gruppi di fine sessanta
in poi; di qua e di là dall’oceano. Senza
l’evoluzione della loro musica, infine,
oltre a cambiare l’approccio di molti
musicisti dediti alle sole colonne sonore cinematografiche, lo stesso movimento ‘progressivo’ avrebbe seguito
un’altra strada. In ultima analisi, molte tematiche introspettive e contenuti
strettamente personali, delicati, non
avrebbero raggiunto il grande pubblico, portandolo a riflettere. Eppure
parlare di Pink Floyd è ritenuto superfluo, arcaico, inutile. La loro musica
ridondante, barocca, auto gratificante,
eccessivamente piena di orpelli. Vero?
Mah, se ad affermarlo fossero gli aman-
ti dell’uno, due, tre, quattro e giù con
lo stesso accordo per due minuti, non
ci sarebbe niente di strano: le sole introduzioni strumentali dei Floyd durano, in genere, più di un intero disco
amato da costoro. Il guaio è che molti
altri hanno cercato, diciamo negli ultimi 45/50 anni, di togliervi dalla vista
e dalle orecchie l’enorme portata creativa della musica cui i quattro, poi tre,
poi due Pink Floyd hanno dato vita. Il
gioco ridicolo del massacro “a prescindere”, la macchina perfettamente oliata della denigrazione è ripartita con la
batteria perfettamente carica al primo
giro di chiave: al solo annuncio della
pubblicazione di The Endless River
l’ultimo, in tutti i sensi, album dei Pink
Floyd.
Nessuno ne aveva udito una sola nota
che il web e i giornaletti già lo descrivevano come un inutile appendice. Roba
che lo Shining di Dan Torrance a confronto è uno scherzo. “È la pubblicazione di scarti di venti anni fa!”, si è subito
detto. Nessuno vi ha spiegato, però, che
la maggioranza degli artisti sovra produce e recupera in seguito materiale di
anni prima, nessuno vi ha specificato
che l’intera carriera dei Floyd stessi è
basata sulla composizione e sul recu-
OUTSIDER
pero successivo di idee e linee musicali
sviluppate anni dopo, nessuno vi ha
specificato che, di fatto, Endless River
era già pronto vent’anni fa, dovendo
essere nelle intenzioni iniziali The Division Bell un disco doppio composto
di soli strumentali la seconda parte;
proprio come Endless River. Nessuno
vi ha detto infine che a selezionare e rivedere con senso logico gli strumentali
che compongono il disco fosse stato
chiamato Phil Manzanera, non un
produttore ma un musicista intelligente e lucidissimo, pignolo e pianificatore. Uno che si sarebbe rifiutato di tirar
fuori una mera collezione di banalità
strumentali se avesse dovuto piazzarci
il proprio nome in calce. Nessuno vi
ha mai fatto notare che l’intera storia
del gruppo (e non giusto un paio di
episodi) sia stata condizionata e guidata, nel bene e nel male dalla presenza
– e dalla assenza – proprio di quel Syd
Barrett che, cottosi il cervello, aveva
obbligato i restanti compagni a metterlo da parte con la morte nel cuore. Ed in
un mondo musicale in cui chiunque
passa sul cadavere del migliore degli
amici, vedere e sentire cantare il dolore
della perdita di un amico per tutta una
vita è raro. Unico. Rispettabile.
Il più grande successo commerciale dei
Floyd, quel Dark Side of the Moon che
viene ancor oggi giudicato con sufficienza per la sola presenza di un paio
di ritmi orecchiabili, come se la buona
musica dovesse essere per forza inafferrabile, era sostanzialmente dedicato al tema della follia, della perdita di
coscienza, ancor prima che un intero
disco, Wish You Were Here divenisse
l’esaltazione finale, assoluta, del tema
della scomparsa, dalla copertina, alle
foto interne, ai testi, ai titoli delle canzoni. I Pink Floyd non erano mai riusciti a superare il dolore della perdita di
Barrett, così come oggi, a otto anni dalla perdita definitiva di Rick Wright,
si ritrovano a piangere e a dedicare al
tastierista l’ultima pietra del loro, vero
e reale, muro separatore: la morte.
Endless River è l’ultima possibilità di
ascoltare Wright insieme ai due restanti Floyd, David Gilmour e Nick
Mason, di sentirli ancora insieme
come un gruppo, seppur a vent’anni da quei suoni e con la certezza che
non potremo mai più vederli esibirsi
dal vivo per presentarceli. Una storia
lunga cinquanta anni, una vita, che si
chiude definitivamente a meno di imprevedibili strette di mano con l’ego in
perenne espansione di Roger Waters,
il Giuda pronto a rinnegare qualsiasi
ex-compagno; salvo poi piangerne la
mancanza.
BOOKS
IL FIUME INFINITO
TUTTE LE CANZONI DEI PINK FLOYD
È uscito a metà novembre il nuovo “imponente” lavoro dei Lunatics, cinque appassionati di diverse parti d’Italia ed esperienza varia (dai quindici ai trent’anni di
collezionismo) che sembrano aver dedicato la loro vita ai Pink Floyd.
Questa è la seconda saga, a due anni dal precedente best seller “Pink Floyd Storie e Segreti”. La nuova opera affronta con una profonda indagine storiografica
l’intera produzione musicale del gruppo (comprensiva di inediti e progetti mai
ufficialmente registrati) lungo quasi cinquant’anni di storia. Traccia dopo traccia,
album dopo album, anno dopo anno: un mirabile resoconto di oltre trecento pagine che dalle formazioni giovanili fino al nuovo disco,dispiega l’intera vicenda
compositiva del gruppo, analizzando genesi, contenuti e retroscena di ogni canzone dal ‘65 al 2014.
Il libro si candida per diventare un’opera fondamentale della pubblicistica legata
ai Pink Floyd. Altro libro consigliato, che forse potete trovare in qualche bancarella dell’usato, sarebbe “La storia dietro ogni canzone dei Pink Floyd” di Cliff
Jones, pubblicato dalla Tarab fiorentina nel 1997.
No, dimenticatevi di quello che vi hanno detto e cercate di andare oltre tutto
quello che non vi hanno raccontato.
Smettete di fidarvi di chi vi ha spiegato
che un concerto dei Pink Floyd fosse
solo una grande esibizione circense,
quando in verità era un eccezionale
spettacolo di musica da vedere meraviglioso, con pochi confronti. Scordatevi i
fiumi di fesserie che vi hanno fatto leggere quelli che dei Floyd non hanno
mai avuto un disco in casa dopo The
Piper at the Gates of Dawn e che non
li hanno mai visti suonare dal vivo. Fidatevi delle vostre orecchie. Abbassate
le tapparelle, lasciatevi trasportare su
universi oscuri, andate oltre le parole
e superate il muro della fantasia. Gruppi come i Pink Floyd ne nascono uno
ogni cento anni. A voi la fortuna di
avervi assistito.
PINK FLOYD
LINE UP
1964 – 1965
Syd Barrett / Bob Klose / Nick Mason /
Roger Waters / Richard Wright
1665 – 1967
Syd Barrett / Nick Mason / Roger
Waters / Richard Wright
1967 – 1968
Syd Barrett / David Gilmour / Roger
Waters / Richard Wright
1968 – 1979
David Gilmour / Roger Waters /
Richard Wright /Nick Mason
1979 – 1985
David Gilmour / Roger Waters /
Nick Mason
1987 – 1990
David Gilmour / Nick Mason
1990 – 1995
David Gilmour / Richard Wright /
Nick Mason
2005
David Gilmour / Roger Waters /
Richard Wright /Nick Mason
17
18
OUTSIDER
PINK FLOYD
4 marzo 1967 (Cyrus Andrews/Getty Images)
OUTSIDER
19
ANALISI FLOYDIANA
UN DONO DI DIO
di Jim Green // Trouser Press // maggio 1980
I Pink Floyd sono particolarmente strani. E non parliamo del gruppo ma anche del modo in cui sono
stati guardati dal mondo del rock. Qualsiasi siano le motivazioni, la differenza tra il gruppo che ha
registrato See Emily Play e quello che ha dilapidato una fortuna elaborando The Wall non è semplicemente il risultato del trascorrere di tredici anni.
Il pubblico, specialmente in America, pensa ai Pink Floyd
come se fossero due gruppi differenti. Il primo – ammesso che
i ragazzi ne siano davvero a conoscenza – viene aggregato
alla fine dell’invasione di rock inglese, come gli Zombies, o
con l’inizio dell’era psichedelica, come se fossero stati un cosa
tipo i Thirteenth Floor Elevator o una cosa simile. Il secondo è classificato tra i sostenitori convinti del rock progressivo come gli Yes o le perversioni successive come gli Styx.
Adesso se ne profila un ipotetico terzo: un gruppo con una
classe a se stante.
Come si sia riusciti ad andare oltre – o almeno come il primo gruppo divenne il secondo – può essere individuato al
meglio seguendo l’evoluzione dei Pink Floyd su vinile. Erano stati in circolazione per un paio di anni come Sigma 6 e
Megadeath prima di emergere ma non come i pop-rocker
psichedelici del loro primo disco; il loro nome non era l’appellativo di qualche ipotetico uomo nero venusiano ma piuttosto la combinazione dei due nomi di due semi-sconosciuti
bluesmen americani, Pink Anderson e Floyd Council. Al
tempo in cui cambiarono nome suonavano brani blues vecchio stile sull’onda di quello che facevano Alexis Korner e
John Mayall con i Bluesbreakers e pezzi jazz (sull’onda della
Graham bond Organisation), anche se facevano già ‘strani’
trattamenti agli originali.
Il Capo Istigatore era il chitarrista Roger “Syd” Barrett entrato a far parte del gruppo nel periodo in cui cambiava nome. Il
bassista, George Waters preferiva usare il suo secondo nome,
Roger, ma chi aveva mai sentito parlare di un gruppo con due
Roger? Poi Barrett iniziò a usare il soprannome Syd Barrett
iniziò anche a comporre. E i risultati furono vendibili ma anche disegnati dalla sua strana immaginazione e dall’approccio strumentale fuori dal comune del gruppo. Si interessarono anche nei giochi di luce, dato che Barrett, un ex- studente
di scuola artistica, aveva deciso di evolvere la sua nozione
di “suono dipinto”. Quando si iniziò a parlare di loro, i Pink
Floyd erano psichedelici come suggeriva il loro nome.
Inghilterra, inizi del 1967: Hendrix rotolava nelle classifiche
dentro una Purple Haze; Carl Wayne dei Move cantava I
Can Hear The Grass Grow; i Beatles si facevano una passeg-
giata lisergicamente amplificata giù per Penny Lane fino a un
campo dove abbondavano le fragole insieme ad altre sostanze.
I Floyd, finanziati dal direttore dell’UFO club, un club molto
frequentato dal gruppo, incidevano un singolo nella speranza di adescare una casa discografica. La EMI abboccò e spinse il singolo dentro la tempesta di quel mercato con la sua
etichetta Columbia. Arnold Layne è un breve racconto acido
di un furto notturno di biancheria intima. Il basso pulsante,
l’organo indemoniato e le percussioni con l’eco costruiscono tensione e intensità emotiva finché i cori autoritari non
ammoniscono “Arnold Layne non farlo più”. Il conflitto tra
la ricerca del desiderio e il suo impedimento da parte di un
ipocrita senso di autorità è cosa che echeggerà più in là nello
sviluppo concettuale del gruppo.
Arnold Layne riuscì a spingere il suo ritmo nei primi venti
singoli inglesi. Ma il grande colpo lo fece il successivo, See
Emily Play. La prima produzione, ovviamente non sotto l’egida della EMI, era stata gestita da Joe Boyd, che avrebbe
lavorato in seguito con artisti meno bizzarri come i Fairport
Convention; il primo singolo sponsorizzato dalla casa discografica venne seguito da Norman Smith. Essenzialmente
un ingegnere, Smith mostrò di essere un produttore comprensivo con i Floyd. Incorniciò il ritratto del ritiro di una ragazza dalla realtà all’interno della sua immaginazione sfruttando la quantità di effetti sonori inconsueti per cui i Pink
Floyd stavano diventando noti: i tocchi stravaganti di chitarra di Barrett, le tastiere eccentriche di Wright e la ragnatela
del basso di Waters, con la propulsione della batteria di Nick
Mason. Fu l’inizio brillante di una lunga relazione tra Smith
e il gruppo; alla metà dell’estate il singolo (n.6) stava gomito a gomito nei primi dieci con cose tipo A Whiter Shade of
Pale dei Procol Harum. Nel frattempo i Floyd avevano già
iniziato a incidere il loro primo album agli studi di Abbey
Road della EMI. Sistemati nello studio a fianco c’era un altro
gruppo con cui Smith aveva lavorato nel suo periodo psichedelico: i Beatles stavano registrando Sgt. Pepper. Va da sé
che per quanto fosse psichedelico per i Beatles, Sgt. Pepper è
più accessibile del Piper at The Gates of Dawn dei Pink Floyd
– ma in quel periodo molto della psichedelia dei Beatles era
20
OUTSIDER
PINK FLOYD
blanda, o al massimo guardata da dietro a una tendina grazie
al produttore George Martin. I Pink Floyd ed in particolare
Syd Barrett non potevano essere inquadrati così efficacemente e Norman Smith non ci provò nemmeno. Piper trabocca di
una miscela inconvenzionale di racconti di fantasia e luoghi
comuni (The Gnome, Bike), un elegante misticismo (Chapter
24), una oscura atmosfera (Lucifer Sam), tutte arrangiate ed
eseguite in modo evocativo; l’idea del suono dipinto non era
una semplice scusa per uno spettacolo di luci.
Degne di nota particolare sono Astronomy Domine e Interstellar Overdrive, due brani lunghi e essenzialmente strumentali. Con questi brani di quasi dieci minuti i Pink Floyd
crearono un precedente che avrebbe permesso a molti gruppi
sbagliati di stiracchiare improvvisazioni registrate a lunghezze faticose. Ma i Floyd non erano pesantemente solisti, una
cosa tipo “guarda come sono fichi i miei solo”; un creativo
unicamente folle come Barrett avrebbe potuto difficilmente
considerare la sua musica in questi termini banali. Queste altro non erano che più ampie sollecitazioni di suoni come Pow R
Toc H e Take Up Thy Stethoscope and Walk, che contenevano
comunque sezioni strumentali.
Piper ebbe un grande successo
nelle classifiche degli album in
Inghilterra (n.6) come Emily l’aveva avuto nei singoli, un notevole riconoscimento dato che né
Emily o Arnold apparivano sul
33. I Floyd erano adesso stelle
riconosciute. Ma quasi due mesi
dopo che Piper era stato pubblicato, il terzo singolo dei Floyd,
Apples and Oranges/Paint Box,
divenne il loro primo fallimento
totale. Entrambe le facciate erano complicate, più graziose dei
consueti Floyd e con una punta
di influenza dei Beatles, ma con
nessuna delle due, adatta a essere un singolo.
Arrivato alle calcagna di un
rapido successo il fallimento
del singolo scoraggiò Waters,
Wright e Mason ma fu una vera
frustrazione per Barrett. La sua
spiacevole dissoluzione come
uomo nell’inverno del 1967/68
condusse all’aggiunta del chitarrista David Gilmour e, poco
dopo, anche all’estromissione di
Barrett. Anche se i tre non lo abbandonarono completamente,
assistendolo nelle sue avventure da solista.
Le due Scream Your Last Scream e Vegetable Man di Barrett
– del tutto appropriate – venne-
ro trasmesse nellla Top Gear della BBC ma mai pubblicate.
Al contrario lo venne la It Would Be So Nice di Wright con
la sua benevola celebrazione della vita. Anche questo brano
non andò da nessuna parte, facendo immaginare che nessuno volesse sentir parlare dei Pink Floyd senza Barrett. Ma il
gruppo raddoppiò gli sforzi e più in là nel corso dell’anno prepararò A Saucerful of Secrets.
Un disco salutato come un capolavoro da alcuni, e maltrattato da altri che ci videro solo un insieme di musica sbiadita e
noiosa. Data la natura di transizione del disco, molto del contenuto risultava decisamente valido allo scopo, che era decisamente ambizioso per i tempi. Gilmour ricopriva un ruolo
del tutto creativo nei nuovi Floyd e Waters prendeva il toro
per le corna, emergendo come il creativo del gruppo. Quel
che lui ed i Pink Floyd avevano scelto di fare era la musica
riservata, evocativa di Interstellar Overdrive. Navicelle spaziali veloci si muovevano lentamente comparate alla vastità
dell’universo; e anche se Mason picchiava con rispettabile
OUTSIDER
ritmica, la musica si muoveva lentamente intorno a lui. Le
tastiere di Wright erano in primo piano nelle immagini panoramiche del suono cosmico.
Si trattava di una mossa
che si allontanava dall’influenza di Barrett nonostante ci fossero un paio
di saluti: Corporal Clegg,
scritta da Waters in modo
sarcastico e barrettiano,
e la Jugband Blues dello
stesso Barrett che chiudeva
l’album con ironia gentile, quasi di buon umore.
La sua influenza nel Pink
Floyd svaniva ma la sua
ispirazione e lo spettro del
suo declino, no. Il pubblico
dei Pink Floyd era scivolato da un mercato commerciale di massa a quello
che stava diventando un
luogo progressivo e sotterraneo. Point Me At The
Sky , pubblicata nel tardo
1968, sottolineava il mutamento. Era il brano più
commerciale del gruppo
da See Emily Play e scavava in più di una passeggera
somiglianza a Lucy In The
Sky With Diamonds – anche se pur più dura e rumorosa – ma non sfondava tra
gli acquirenti dei 45 giri. La
seconda facciata, Careful
With That Axe Eugene, decisamente più in linea con
Saucerful, divenne uno
dei brani favoriti dal vivo.
Questo fu il loro ultimo
singolo in Inghilterra fino
a Money nel 1973.
In America, la Capitol
records, pur convinta di
spingere qualsiasi gruppo
venisse
dall’Inghilterra,
non aveva idea di cosa fare
con i Pink Floyd. decisero
di piazzarli nella loro sussidiaria alternativa, a bassa
priorità di promozione, la
Tower, che era il cimitero
per gruppi come Chocolate Watchband, Standells, i Them post-Van Morrison e varie colonne sonore
cinematografiche. Piper venne significativamente stravolto:
pezzi vennero rimossi, inclusa la brillante Astronomy Domi-
21
ne, e anche ripiazzati nella sequenza: Interstellar Overdrive
messa sul lato due dell’album e See Emily Play inserita come
brano iniziale. Emily era un singolo minore ma i Floyd restavano un qualcosa di oscuro, anche nel relativamente piccolo, se pur crescente,
mercato underground.
The Piper si fermò al n.131
delle charts USA, quando
qualsiasi disco inglese arrivava nei primi 50 posti.
Al tempo del terzo album,
More, i Pink Floyd erano
stati spostati dalla Columbia in Inghilterra alla nuova e progressiva Harvest.
More era un infelice risultato dell’entusiasmo di
Waters di vedere i Floyd
diplomati dalla loro fama
multimediale al mondo
delle colonne sonore. Seccati di non esser riusciti
a mettersi d’accordo con
Stanley Kubrick per la
colonna sonora di 2001,
Waters si gettò sulla possibilità di farla per More.
Forse quella delusione,
unita alle limitazioni di
lavorare per un film mediocre, spiegano i risultati
fiacchi. Cymbaline è sommessamente deliziosa; The
Nile Song una convincente proiezione di libidine e
furia e Ibiza Bar presagisce
il loro successivo stile rock.
Ma la maggior parte del
disco è privo di indirizzo
e trascurabile e incapace
di stare in piedi da solo.
I Floyd ebbero anche un
coinvolgimento abortito
con lo Zabriskie Point di
Antonioni, finendo con
il concedere tre brani per
la colonna sonora inclusa
una rivisitazione di Eugene lì chiamato Come in
Number 51 Your Time Is
Up.
Con la pubblicazione del
disco successivo, Ummagumma, la Capitol mise
in piedi una etichetta Harvest negli Stati Uniti e dato che i
sessanta diventavano i settanta, l’America organizzò un adeguato lancio dei Pink Floyd che portò la band al n. 74 delle
22
OUTSIDER
PINK FLOYD
charts. Il disco doppio era metà dal vivo e metà di studio. La
parte dal vivo mostrava il suono sofisticato del palco e documentava l’evoluzione di Eugene in un lavoro di coerenza e
potenza solo accennato nell’originale. Il disco conteneva anche una interpretazione fedele e emozionante di Astronomy
Domine mentre Set The Controls For The Heart Of The Sun e
Saucerful Of Secrets suonavano agili ma relativamente poco
spettacolari, eccezion fatta per quelli che desideravano testare
le proprietà del loro impianto hi-fi, che in quegli anni stava
esplodendo sul mercato di massa, ponendo finalmente fine a
impianti di ascolto che di stereo avevano ben poco.
Il disco di studio dava a ogni Floyd un quarto di disco. Un
capolavoro di autoindulgenza, seppur interessante a tratti;
la Narrow Way di Gilmour sarebbe stata eccellente se di soli
quattro minuti invece di dodici. Ummagumma comunque
ottenne in Inghilterra risultati insperati da tutti, vista la difficoltà del progetto, arrivando al n. 5.
Il giovane pubblico rock alla moda americano non aveva ancora sentito nulla come i
Pink Floyd, nonostante le esperienze di band
come i Grateful Dead, e la propensione tecnologica del gruppo impressionava molti;
anche i rumori elettronici di Waters riuscivano a esaltare molti stonati entusiasti dello
stereo. Negli anni successivi Ummagumma
sarebbe diventato più di una istituzione nelle
camerate dei college in tutto il Paese come le
pipe per l’hashish e gli Zap Comix di Robert
Crumb.
L’autunno del 1970 fu ravvivato dall’uscita
di Atom Heart Mother, anticipato quell’estate al Festival di Bath. L’album risultò una
pietra miliare per molti motivi. Precedentemente, all’inizio dell’anno, Waters aveva
aiutato il suo eccentrico amico Ron Geesin
a comporre e suonare la colonna sonora per
The Body; The Womb Bit, Bridge Passage
for Three Plastic Teeth e altre sono raccomandate per quelli che non ne hanno avuto abbastanza dei rumori animali di Waters
su Ummagumma. Geesin restituì la cortesia
componendo, insieme ai Floyd, la lunga suite che dà il titolo al disco; questa era la prima
volta che un estraneo riceveva credito su un
album del gruppo, e l’ultima fino a The Wall.
Il disco segnava anche un cambio nelle relazioni tra Norman Smith ed il gruppo. Smith
aveva prodotto il solo disco di studio di Ummagumma; i Floyd si erano gestiti la parte
live da soli. Su Atom Heart Mother, Smith recedeva a produttore esecutivo. I Pink Floyd
si sentivano ora sufficientemente sicuri in
studio da non aver bisogno dell’aiuto di un
estraneo.
Comunque non si accontentarono di farla
facile. Atom Heart Mother è un complicato
quadro di un gruppo, dei cori, fiati e dei caratteristici trucchi di studio. Una miscela di
rock, classica e musica sperimentale, con melodia e dissonanze e che include alcuni passaggi raffinati e vagamente intesi
per essere – qualche volta in modo ruffiano – uno sguardo al
ciclo della vita animale, o qualcosa di simile. E quel “qualcosa di simile” è il problema, dato che Atom Heart Mother
è concettualmente impenetrabile o semplicemente confuso.
Nonostante la mancanza di entusiasmo della critica, suscitò
interesse nei circuiti di musica classica, che casualmente condussero i Pink Floyd ad apparire al Festival di Musica Classica
di Montreux. I fans dei Floyd ritennero che fosse un bene; se
non avessero avuto il tempo per eseguire Atom Heart Mother, avrebbero potuto attaccarsi alla delicata ballata If di Waters, alla tronfia ma godibile Summer of ‘68 di Wright o l’eccellente e bizzarra Fat Old Sun di Gilmour, per non ricordare
quella sorta di audio-verità di Alan’s Psychedelic Breakfast.
Insieme ad Ummagumma, Atom Heart Mother rappresenta la scala di creatività del gruppo al punto massimo del suo
OUTSIDER
equilibrio; gradualmente, da qui, Waters avrebbe ampliato la
sua influenza, incominciando dal successivo Meddle.
Fu anche il loro primo n.1 in UK e anche in America scalò le
vendite fino al n.55.
C’è un anno di buco tra Atom Heart Mother e Meddle, riempito con la pubblicazione di Relics, con
sottotitolo A Bizarre
Collectionof Antiques
& Curios. La EMI olandese aveva già pubblicato un best of, più tardi ripubblicato nella
serie Masters of Rock,
che includeva Apples
and Oranges, It Would
Be So Nice e la bellissima seconda facciata del singolo di See
Emily Play: Candy and
a Currant Bun, un’irriverente parodia del R
& B tosto che traspariva nei primi periodi
del gruppo. Da parte
sua, Relics conteneva
la versione originale
di studio di Eugene ed
un tosto, blueseggiante ed inedito Biding
My Time.
Point Me At The Sky
apparve solo su un
promo radiofonico statunitense ed un altro
brano chiamato Embryo apparve su un
promozionale inglese
della Harvest, adesso
introvabile.
Meddle tramutò la già
mancanza di entusiasmo della critica in
un esplicito disprezzo.
E non è difficile comprendere il perché;
dopo Atom Heart
Mother – che, seppur
incostante, era almeno avventuroso – l’ultima proposta dei
Floyd sembrava blanda e risciacquata. In realtà soffre in paragone nei confronti di molti album dei Floyd, ma nel mezzo
di noiose ballate, miscugli di jazz, ritagli e privi di indirizzo
country blues, Fearless accumula un’emozione curiosa, contagiosa mostrando una forza risoluta e con l’intermezzo di una
folla che canta You’ll Never Walk Alone. La lunga Echoes che
riempie tutta la seconda facciata, sviluppa un’eloquenza piacevole, gentile, specialmente dopo ripetuti ascolti. Queste due
composizioni divennero tra le favorite dei Floydiofili.
23
Secondo quanto riportato dalla stampa al tempo, nella band
circolavano brutti risentimenti. Questo potrebbe spiegare
perché il progetto successivo fosse un’altra colonna sonora
per un film intitolato La Vallee, che i Pink Floyd intitolarono
Obscured By Clouds. Atipico, per i Floyd, nella sua convenzionalità l’album ha i suoi momenti positivi: The Gold It’s In The... ,
Wots...uh The Deal, Childhood’s
End e Free Four. Il suo successo (n.6
in UK e 46 in USA parlando di vendite) sta principalmente nei testi,
quasi tutti di Waters, che non sono
pastorali o cosmici ma quasi personali, a prescindere dalla trama del
film.
Il lavoro pacato ma articolato di
Gilmour alla chitarra è un altro punto
di forza. Obscured By
Clouds è di solito trascurato come esterno alla personalità
dei Floyd, ma i suoi
temi più personali, le
strutture meno intricate delle canzoni e
la gamma limitata di
tempo e ritmi fanno
tutti parte del continuo sviluppo del
gruppo. Dopo quasi
otto mesi di studio,
i Pink Floyd riemergevano all’inizio del
1973 con Dark Side
Of The Moon. Un
ragguardevole passo
in avanti, ma se osservato attentamente rivelava la sua discendenza dai lavori
precedenti, incluso
Obscured By Clouds.
Waters sembrava voler esprimere alcune
verità familiari di
fresca scoperta. I dissidi interni e le pressioni dello status di
star in qualche modo
in calo potrebbero
aver condotto ad un
medesimo genere di
stress sul genere di quello occorso a Syd Barrett; in Breathe
Waters avverte circa il prendere il gioco della vita troppo
seriamente. Brain Damage se non interamente riguardante
Barrett era definitivamente incentrato su quel tipo di soggetto : “And if the cloud bursts, thunder in your ear / You shout
24
OUTSIDER
PINK FLOYD
and no one seems to hear / And
if the band you’re in starts playing different tunes / I’ll see you
on the dark side of the moon.”.
(E se la nuvola esplode, ed hai il
tuono nelle orecchie/Urli e nessuno sembra sentirti / E se il tuo
gruppo inizia a suonare musiche differenti / Ci vedremo sul
lato oscuro della luna ).
Il disco termina con l’oscura affermazione di Waters, “tutto sotto
il sole è in sintonia, ma il sole è
eclissato dalla luna”.
Potente, logico, magistrale, potete immaginarvelo – la critica
si emozionò di nuovo per i Pink
Floyd, gettando ovunque così
tanti superlativi quanti dollari (e
sterline) da influenzare il pubblico di acquirenti.
Dark Side fu il primo album a raggiungere il
primo posto in America; ed è il disco che - insieme a Thriller di Michael Jackson (NDT)
- è rimasto più lungamente nelle classifiche
americane, oltre che sull’altro lato dell’Oceano
dove raggiunse il n. 2 delle classifiche UK. Cavalcando il successo, i Pink Floyd erano in grado di passare molto tempo, oltre due anni, a lavorare sui due dischi successivi. Si permisero
anche di cambiare etichetta negli Stati Uniti,
passando alla Columbia, dato che l’originale
aveva contestato eccessivamente il soggetto
guida di Wish You Were Here. Divenuto una
merce da vendere, Waters – adesso scrittore
ufficiale dei testi, mentre la musica restava
un prodotto dell’intero gruppo – disquisiva di
questi problemi su Welcome To
The Machine e Have a Cigar. Il
secondo in particolare contiene
delle immagini caricaturali graffianti : “Il gruppo è fantastico, lo
penso davvero. E, in ogni caso,
chi è Pink?... Siamo così felici che
possiamo a malapena contare.”.
Il brano che dà il titolo al disco potrebbe essere Waters che
parla a Barrett, all’ascoltatore, a
entrambi o a nessuno dei due;
esprime difatti anche il costo pesante di perseguire le ambizioni
di una vita. La canzone è piazzata in mezzo alla prima e la ultime cinque parti di Shine On You
Crazy Diamond, un’ode a Barrett, vittima di cotanta guerra.
Imperfetto, altamente idiosincrasico, rigonfio di più emozioni
di quante i Pink Floyd ne avessero mai
proposte, Wish You Were Here era probabilmente il disco più potente dalla nascita
del gruppo.
E all’epoca fu anche il più venduto, n.1 sia
in USA che UK.
Nel 1977 spruzzarono il loro veleno un
po’ più in là. Animals abbracciava l’intera razza umana, dopo tutto composta da
differenti generi animali. Tre lunghi brani
comprendevano Dogs, Pigs (Three Different Ones) e Sheep e ti portavano all’interno di condizioni umane tipo la schiavitù e
il degrado, criminalità di ogni genere, con
reati commessi con o senza una cravatta
e nei riguardi del fisico o dello spirito, e
al massacro dell’apatia e della passività.
Diretto e corrosivo l’efficacia di Animals
è invalidata solo dalla sua
mancanza di concisione e
dalle conclusioni dubbie,
ammesso che ve ne siano.
Dopo Animals, dall’organizzazione dei Floyd filtrarono
notizie per cui sarebbe passato un po’ di tempo prima che
il gruppo avesse nuovamente prodotto un disco. Waters
avrebbe potuto essere soddisfatto di lavorare esclusivamente sui progetti dei Pink
Floyd, dato che concettualmente il gruppo era divenuto
sostanzialmente il suo bambino; ma Gilmour e Wright
avevano necessità creative
dal soddisfare e scelsero di
pubblicare album solisti nel
1978. Mason si accontentò
di produrre il secondo disco
dei Damned in quel periodo. Gilmour, che
aveva ricoperto il ruolo del filantropo aiutando Kate Bush agli inizi, mise insieme
un disco di brani in stile Pink Floyd per mostrare il peso che il gruppo aveva su di lui... o
lui nel gruppo. Si trattava spesso di godibile
rock and roll ma ogni tanto arrancava come
musica minore dei Floyd, come qualcosa in
meno da dire. Il Wet Dream di Wright soffriva di una melanconica noia terminale vagamente percettibile; il chitarrista Snowy
White o il sax di Mel Collins troppo spesso
mettevano in ombra la tastiere di Wright in
parti strumentali anonime.
Perciò i fans dei Floyd iniziarono a guardare
con grande anticipo e interesse all’annunciato The Wall. E quel che ottennero era
il gruppo al massimo dell’ambizione, che
OUTSIDER
tracciava la vita da rock star sulle quattro facciate del vinile.
Il protagonista è asfissiato dalla madre, picchiato da un maestro sadico – che se ne va a casa per essere picchiato a sua
volta dalla moglie – e violentato dalla fabbrica delle rockstar
e dalle groupies affamate di fama, per questo erige un muro
di follia per nascondersi da tutti. Sebbene disgustato, viene
comunque corrotto da tutto ciò ed alla fine si confronta con
la concretizzazione di tutte queste influenze in un qualche
tribunale immaginario della propria coscienza. Il risultato è
equivoco: il muro finisce con l’essere abbattuto, ma cosa significa in realtà? I concetti terminano con un commento di un
artista amico che desidera aiutare il nostro anti-eroe: “Dopo
tutto, non è facile sbattere il tuo cuore contro il muro di qualche pazzo bastardo”.
Bob Ezrin co-producendo il disco insieme a Waters e Gilmour
otteneva emozioni più ampie, drammatiche. Lo stimolo è relativamente vivace e gli arrangiamenti abbastanza vari da
mantenere l’attenzione per la maggior parte del tempo, ma
Waters, che aveva composto tutto il disco eccetto quattro brani, si era ridotto a uno stile troppo leggero da un punto di vista
melodico. Pur contando su una vasta quantità di materiale da
assimilare, solo due pezzi emergono nettamente: la rocciosa
Run Like Hell e Another Brick In The Wall. Fortunatamente Waters suddivide Brick in quattro parti inserite all’interno dell’album. A parte qualche anti-autoritario sciovinismo
25
nazionalistico, The Wall è ampiamente emozionante, se non
sempre godibile; mostrando più intelligenza tematica e concettuale della maggioranza dei ‘concept album’. Fu il terzo
disco a arrivare n.1 in USA e al n.3 in UK.
Qualcuno potrebbe dire che i Pink Floyd abbiano raggiunto
tutti, specialmente alla luce della teatralità dal vivo dell’opera, di quanto avevano potuto fare in teoria nel corso della loro
storia, confermando generalmente una elevata qualità del
prodotto. Dove andranno d’ora in poi?
Waters saprà mantenere la guida al timone della creatività del
gruppo oppure qualcuno degli altri non si mostrerà in linea
con le sue intenzioni future? La risposta dovrebbe arrivare
in due o tre anni, quando uscirà il prossimo album dei Pink
Floyd.
NDR- The Final Cut arriverà 4 anni dopo, nel 1983 arrivando ancora una volta n. 1 in UK. Nel 1985 Waters abbandona
il gruppo. A Momentary Lapse of Reason esce nel 1987, The
Division Bell nel 1994 arrivando al n. 1 sia in USA che in UK.
Nei tour susseguenti questi due ultimi dischi, Waters sarà
sostituito da Guy Pratt e Tim Renwick alle chitarre, con Jon
Carin alle tastiere. Nel 1995 la formazione cessa la propria attività, sciogliendosi definitivamente nel 2006. Esattamente 20
anni dopo The Division Bell arriva il compendio di questo:
The Endless River.
SYD BARRETT
20 GIUGNO 1968 // ULTIMO CONCERTO CON I PINK FLOYD – ‘MELODY MAKER’
La stella luminosa che fu Syd Barrett ha suonato il suo ultimo concerto con i Pink Floyd lo scorso 20 gennaio 1968. Barrett era
il principale compositore, cantante, chitarrista e punto focale per i pionieri della psichedelia dalla loro formazione fino al 1967,
quando molte motivazioni hanno portato alla sua uscita dal gruppo.
I Pink Floyd erano in costante ascesa nel corso dell’anno dorato del 1967. Il gruppo ha pubblicato un paio di singoli divenuti dei
classici, Arnold Layne e See Emily Play, così come il loro incredibile album di debutto, The Piper At The Gates Of Dawn, ma il
comportamento incostante e imprevedibile tenuto da Barrett è cresciuto al punto da rendere sempre più difficile per il resto del
gruppo mantenerlo in riga. L’amico e collega, il chitarrista David Gilmour è stato fatto entrare nel gruppo nel tardo 1967 per
sopportare Barrett alla chitarra. Gilmour è divenuto l’esecutore per la maggior parte delle linee di chitarra dal vivo dato che Barrett tendeva a iniziare le canzoni nella tonalità sbagliata e spesso si fermava nel mezzo dell’esecuzione. La formazione a cinque
è durata poco dato che il gruppo era stanco di avere a che fare con Barrett in assoluto. Il 20 gennaio 1968, mentre si recavano alla
Southampton University per un concerto, il gruppo ha deciso di non avvertire Barrett di presentarsi al concerto. Secondo David
Gilmour, in una intervista del 1995 con Guitar World, “Uno di noi in auto disse...dovremmo passare a prendere Syd? ….ed un
altro rispose.. .chi se ne frega”.
In ogni caso dimenticarono di avvertire Syd che il suo aiuto al gruppo che aveva creato non era più necessario. “Inizialmente fu
davvero imbarazzante - disse Rick Wright nella biografia di Barrett ‘A Very Irregular Head’ – mi toccava dire cose tipo “Syd vado
a comprare le sigarette” e poi partivo per suonare un concerto; ovviamente lui poi capì cosa stava succedendo”.
Wright condivideva un appartamento con Barrett al tempo. In principio gli venne proposto di restare a casa a fare il medesimo
ruolo che Brian Wilson aveva con i Beach Boys e concentrarsi sullo scrivere canzoni e registrare, ma questa idea non andò molto
lontano e non è chiaro quanto fu imbarazzante e difficile tagliare gli ultimi legami. “C’erano momenti piacevoli – disse Gilmour
nella medesima biografia – con due o tre di noi che ballavamo con Syd nei camerini prima di salire sul palco”. Ma non fu fino
al 6 di aprile del 1968 che venne annunciato ufficialmente che Syd aveva lasciato il gruppo. Un amico di Barrett, il poeta Spike
Hawkins, ricorda di Syd che gli raccontava delle prime registrazioni dei Floyd e di come lui volesse “andare molto più profondamente avanti a esplorare utilizzando musica e testi come chiavi per aprire porte”. Hawkins disse a Barrett che difatti lui aveva
aperto porte per il gruppo e Barrett rispose : “Si, ma con chiavi da due soldi”.
26
OUTSIDER
PINK FLOYD
DAVID GILMOUR
di Jerome Soligny // Les Inrockptibles // 2000
Photo: Claude Gassian
OUTSIDER
27
È in occasione dell’uscita dell’album della tournee di The Wall, progetto megalomane di Waters che portò alla
sua uscita dal gruppo, che David Gilmour riceve la stampa mondiale (un giornale per paese, scelto da lui medesimo) nel suo studio galleggiante (una meraviglia in legno costruita nel 1911 in cui risiedette, tra gli altri, Charlie
Chaplin). Le dita che hanno creato Echoes si sciolgono su un manico di chitarra spagnola, poi lo strumento viene
posato su un letto di cuscini color sangue. Viene servito del tè, si schiacciano in contemporanea play e record.
Ti sei unito ai Pink Floyd dopo The
Piper At The Gates Of Dawn, il primo album. Forse sarà una domanda scontata, ma quale era il suo
rapporto con Syd Barrett?
Conosco Syd dall’età di 13-14 anni, frequentavamo la stessa scuola, la Cambridgeshire High School a Hills Road,
siamo diventati presto amici: abbiamo
imparato a suonare la chitarra insieme,
ci siamo insegnati delle cose a vicenda.
Siamo andati in vacanza insieme in
giro per l’Europa, Francia/Spagna, suonando dove capitava canzoni dei Beatles. Quando il gruppo ha iniziato a sfondare in Inghilterra, io vivevo in Francia
e suonicchiavo da quelle parti con i Jokers e non sono rientrato in Inghilterra
che nel settembre del 1967. Alcuni singoli e l’album erano già usciti.
Quindi, tu andavi a sentirli suonare dopo che sei tornato come a vedere dei vecchi amici?
Sì, per il fatto che frequentavamo gli
stessi club con il mio primo complesso, i
Jokers Wild. E conoscevo naturalmente
anche gli altri.
Il modo in cui sei stato chiamato a
unirti ai Pink Floyd non è mai stato molto chiaro: eri, almeno all’inizio, considerato come un quinto
membro o era già evidente che dovevi rimpiazzare Syd?
Quello che mi dissero subito era che
Syd non era più in grado di esibirsi dal
vivo. La sua malattia gli impediva di restare naturalmente sul palco e l’idea era
che io restassi lì per assicurare le parti di
chitarra nel caso lui non si fosse presentato. Abbiamo dovuto fare 4-5 concerti
in cinque, ma è diventato chiaro molto
in fretta che le cose non avrebbe funzionato a lungo in quel modo e siamo stati
costretti a lasciare Syd indietro.
Il tuo unico contributo ufficiale
a A Saurceful Of Secrets è il pezzo
Jugband blues, un brano che Peter Jenner e Andrew King, i vostri
manager di allora, avevano intuito potesse essere il seguito di See
Emily Play. Tuttavia, la leggenda
afferma che tu e Syd siete presenti
entrambi in alcuni pezzi.
Quel disco è stato iniziato prima che io
fossi chiamato e Juggabd Blues era già
stata registrata in un altro studio. È Syd
che suona in Remember A Day e siamo
presenti effettivamente tutti e due in
Set the Controls For The Heart Of The
Sun. Io ho poi suonato in tutto il resto.
Nel 1969 i Pink Floyd hanno pubblicato More, la colonna sonora
del film di Barber Schroeder su una
comunità hippie di Ibiza, e Ummagumma, doppio album decisamente sperimentale contenente dei
pezzi live.
Dal vivo i Pink Floyd sono sempre stati
molto sperimentali e non avevano in
definitiva niente a che fare con le canzoni pop compatte che scriveva Syd. Interstellar Oderdrive, sul, primo album,
mostra chiaramente che il gruppo era
pronto a battere altri territori.
A più di 30 anni dalla sua comparsa Ummagumma resta una bestia
sacra?
In effetti la sua popolarità mi ha sempre stupito. Non l’amo tantissimo e
secondo me moltissime cose non sono
messe a fuoco. Diciamo che sono buttate lì. All’epoca eravamo un po’ smarriti,
da lì venne l’idea di delirare ognuno
nel proprio angolo e di includere alcune parti live. Però la copertina è splendida e il titolo anche (risate), È ciò che
dà a quel disco quella profondità di cui
manca terribilmente.
Tuttavia, forse inconsapevolmente, avevate gettato le basi del suono a venire?
Forse. A Saurceful Of Secrets, sull’album omonimo, qualche passaggio di
Ummagumma e Echoes su Meddle
lasciano intravedere il seguito e Dark
Side of The Moon.
Parliamo un po’ di suono: da Atom
Heart Mother nel 1970, i Pink
Floyd sono noti per una cura particolare delle proprie registrazioni e della riproduzione sonora
dal vivo. Quando interpretaste
quell’album nella sua integralità
al festival di Bath, utilizzaste un
impianto sonoro che diffondeva la
musica in rilievo a 360°.
In realtà il gruppo utilizzava questo
sistema quadrifonico prima che mi
unissi a loro, ma venne rubato. All’inizio degli anni settanta, gli ingegneri
della EMI avevano costruito un nuovo
modello di cui ci saremmo serviti. In
associazione con la WEM, cercammo
di ricavare un suono ad alta fedeltà sul
palco, che in seguito riuscimmo d addomesticare su disco, a partire però da
Meddle.
Ho nominato l’album che ospita Echoes, un vero e proprio monumento, un ode alla chitarra
fluttante. Dall’ondata dei gruppi
progressive alle attuali musiche
elettroniche, passando per gruppi come Radiohead o Beta Band, è
chiara l’influenza dei Pink Floyd
su diverse generazioni di musicisti oggi si rivela capitale. Ne sei
cosciente?
Fa bene all’ego (risate). L’impressione
di aver potuto contribuire in un modo
o nell’altro alla musica di oggi è assai
piacevole. Ma è vero? Non lo neanche
io ma ne sono comunque fiero. Soprattutto nel momento in cui ascolto qualcosa sapendo con assoluta certezza che
non sarebbe esistito senza di noi. Hai
usato la parola ‘fluttuante’ per la mia
chitarra? Diciamo che Peter Green è
stato molto importante per la mia formazione chitarristica. Forse quella parola è più adatta a lui che a me.
Prima di passare a Dark Side Of
The Moon, occorre menzionare
Obscured By Clouds, un’altra colonna sonora uscita nel 1972. Da
28
OUTSIDER
PINK FLOYD
dove proveniva quella frenesia di
progetti cinematografici?
In realtà, quelle sono musiche per Barber, proprio come quelle di Zabrinskie
Point per Antonioni…
che avessimo iniziato realmente a padroneggiare la composizione e gli studi
all’epoca. Alla fine fummo in grado di
controllare un progetto dall’inizio ala
fine. Forse sei anni per arrivarci sono
stati troppi ma va bene uguale. Non
bisogna neanche dimenticare che avevamo suonato le canzoni di Dark Side
of The Moon già parecchie volte al momento di registrarle, la macchine era
ben oliata, avevamo corretto tagliato,
aggiunto, limato e sapevamo che la
gente avrebbe reagito favorevolmente. E, soprattutto, avevamo Alam Parsons nel ruolo di ingegnere del suono,
un gran vantaggio. Gli ingegneri della
EMI che avevano lavorato precedentemente con noi non erano altrettanto
bravi. Con Alan la corrente si è trasmessa molto in fretta, improvvisamente si
era creata una squadra.
Che lui trovò troppo tristi?
Assolutamente (risate). Comunque,
non sapendo se la band sarebbe durata nel tempo, ritenevamo che la musica da film potesse essere qualcosa
di alternativo nel caso le cose fossero
andate male. A nessuno di noi andava
di tornare a fare l’impiegato o a lavorare in banca. Vedevamo tutto quando
come una maniera civile di continuare a guadagnarci da vivere suonando,
nel caso in cui il gruppo cappottasse.
Vero che Atom Heart Mother era arrivato al numero 1 delle charts di casa
nostra, ma fu solo nel 1973 con The
Dark Side of The Moon che capimmo
che ormai avevamo svoltato. E poi era
Non trovi ironico il fatto che Morapido, piacevole, immediato. Non
ney, uno sberleffo al denaro scritto
c’era tempo per esitare: c’era una data
da Roger ma cantato da te, alla fine
limite, si compone, si
registra e via. Fatto. Era
1978 Gilmour e figlio (Chris Walter)
come andare a scuola.
Esperienza.
Fare una domanda pertinente su un
disco
importante
come Dark Side of
The Moon è davvero
un’impresa…
(un accenno di sorriso
agli angoli della bocca)
Tuttavia sarà meglio
provarci…
D’accordo, ci provo: non hai avuto
l’impressione
che
improvvisamente, i
pezzi del puzzle Pink
Floyd si mettessero a
posto? Come se aveste, infine, trovato
un equilibrio perfetto tra i brani lunghi,
alambiccati, e le canzoni pop immediate,
il tutto con un suono
he chiunque sarebbe
stato in grado di comprendere?
Effettivamente penso
ve ne abbia portato tantissimo, diventando anche una delle canzoni
più celebri del vostro repertorio?
Assolutamente. Tutto quello di cui ci
prendevamo gioco è diventato la nostra vita.
Il tema dell’alienazione, della paranoia…
Non siamo che esseri umani, dopotutto…. Disprezziamo il denaro quando
non l’abbiamo.
Nel momento in cui i Pink Floyd
divennero sempre più popolari, tu
non hai comunque abbandonato
Syd, collaborando ai suoi album
solisti. Si può considerare Wish
You Were Here come un omaggio
al vecchio leader del gruppo o no?
(pensieroso). Shine On You Crazy Diamond è dedicata a lui, non è un segreto
per nessuno….
Non era una situazione strana involarsi verso la gloria
e il denaro sapendolo
in lontananza, dietro
di voi ad errare tra i
suoi fantasmi, alle
prese con la schizofrenia, infelice o felice forse…
Felice? Syd? No, non
credo proprio. Non è
mai stata una situazione facile, soprattutto
per me, visto i trascorsi.
Ma erano già passati 5
anni dalla sua uscita
dal gruppo e ciò che era
diventata la band non
aveva più niente a che
fare con quello che era
all’inizio. Ma non sono
mai stato geloso di Syd o
di quello che ha apportato al gruppo agli inizi
per la semplice ragione
che era mio amico, che
gli volevo davvero bene
e che ero cosciente dal
suo talento e del pasticcio in cui si trovava…
Adoravo le sue canzoni,
il suo modo di affrontarle, era un essere umano
meraviglioso. Fragile.
OUTSIDER
Era un grande onore comporre una
canzone per lui.
Non vi siete mai sentiti un po’ a
secco dopo Dark Side?
A dire il vero, il successo ci ha letteralmente rubato le ambizioni. Avevamo
raggiunto tutti i nostri obiettivi, fama,
denaro, gloria, donne, potere e ci siamo
ritrovati smarriti…
Troppo di tutto e tutti insieme?
Sì, eravamo in cima al mondo…. A che
scopo continuare? Avevamo tutto. E
poi, iniziavamo a comunicare molto
male tra di noi. È stato un periodo davvero difficile ed è un miracolo che ne
sia usciti fuori.
Qualche parola su Animals. All’epoca si scrisse che si trattava essenzialmente di scarti di Wish You
Were Here e che la cosa migliore
del disco fosse la tua chitarra.
È lusinghiero ma non sono d’accordo.
È però vero che alcune canzoni come
Dogs o Sheep risalivano a registrazioni precedenti. Ma se avevamo lasciato
da parte quei brani all’epoca era perchè sapevamo che avrebbero meritato
che gli s idesse più tempo e spazio. In
effetti, Roger continuava sviluppare il
tema dell’assenza già evocato in Shine
On You Crazy Diamond. Mi sono ribellato a quell’idea, ma lui ha insistito e,
in fin dei conti, penso che abbia avuto
ragione.
Animals uscì nel 1977, in piena
ondata punk. Quando tutti vi consideravano dei dinosauri da seppellire. Tempi duri anche per i Pink
Floyd?
Siamo stati pesantemente criticati. Ci
rimproveravano di avere un suono
pomposo, le prestazioni sceniche. Tutti
volevano tornare all’immediatezza del
rock, tre accordi e via. Ma non era tutto vero. Il punk dimostrò di aver con
se molte frecce nell’arco ma era un fenomeno costruito dall’industria discografica. Insomma erano sempre i soliti
a spartirsi la torta. E non dimentichiamo che a fine anni settanta non c’erano solo i Sex Pistols e i Clash ma anche
Springsteen, Dire Straits, Tom Waits,
Little Feat, Warren Zevon, Tom Petty
tutti musicisti che andavano oltre i tre
accordi e componevano alcune delle
loro cose migliori.
Comunque il punk è la ragione per cui
Animals è più secco, quasi aggressivo.
Volevamo dimostrare che c’eravamo
ancora.
Nel 1979 sotto l’impulso di Roger
Waters, avete affrontato il vostro
progetto più ambizioso, The Wall.
Avete portato questo doppio album in tour con un folle spettacolo
e Alan Parker ha tratto un film dalla storia. Si è sempre detto che a te
The Wall non sia mai piaciuto…
Ho affettivamente detto questo una
volta. Lo sai, si dice tutto e il contrario
di tutto, a seconda dall’umore: la verità
era che ero depresso ascoltando i demo
di Roger. Certe parti erano troppo lunghe, altre un po’ inutili e ho percepito
subito che il progetto avrebbe necessitato di parecchio lavoro. Soprattutto, ci
si trovava di fronte a una storia con un
contenuto narrativo particolarmente
forte e bisognava metterlo in musica.
In quanto musicista, io procedo più
spesso al contrario. Per me la musica è
alla base di tutto e le parole si devono
adattare, non il contrario. A forza di volersi attenere troppo al testo, alcuni passaggi musicali di The Wall sono meno
riusciti di altri.
Non è un segreto per nessuno che
Roger incominciò allora vampirizzare la band, a considerare i Pink
Floyd la sua backing band.
Bisogna riconoscere che all’epoca era
più o meno il leader, quello che ci motivava. Quello che proponeva, quasi
sempre, lo facevamo. Non mettevamo
in discussione questo. Come musicista,
anche se raramente ero d’accordo con
lui, cercavo di contribuire facendo del
mio meglio, perché è quella magia che
mi affascina. I nostri scontri derivavano soprattutto dal fatto che lui dava a
mio parere troppa importanza ai testi o
meglio non privilegiava abbastanza la
musica. Questo accadeva da anni. Ma,
proponendo il progetto, sembrava avere un’idea chiara del risultato finale, e li
abbiamo fatto il suo gioco. I Pink Floyd
hanno sempre funzionato secondo un
metodo meritocratico: chi arriva con le
idee più interessanti dirige le operazioni. Occorre sapere che Nick non ha mai
29
apportato granchè a livello di scrittura,
che Rick aveva una vita così piena di
problemi all’epoca che non proponeva
niente neppure lui e, in fin dei conti,
effettivamente, abbiamo lavorato per
Roger al meglio delle nostre possibilità.
So che molti pensano che The Wall rappresenti l’inizio della fine, ma io non
la vedo in quel modo. Abbiamo litigato ma non più di quanto lo facessimo
prima, o di qualsiasi altra band. Molto
sinceramente, penso che lavorassimo
benissimo insieme.
Per The Wall siete ricorsi al produttore Bon Ezrin, all’epoca conosciuto per aver collaborato con alice
Cooper e Lou Reed.
Da qualche album Roger e io eravamo
i produttori ma sapevamo che il progetto sarebbe stato impegnativo: si trattava come minimo di un doppio album,
particolarmente difficile da pianificare
in tutti i suoi aspetti. Avevamo giudicato che un aiuto esterno poteva esserci
molto di aiuto. Occorreva qualcuno che
potesse aiutare Roger nella sua narrazione, cosa che io non averi mai potuto
fare. Bob Ezrin ci era stato consigliato
dalla moglie di Roger ed è stato geniale,
estremamente talentuoso ed efficace. Ci
ha cementati, mi ha incitato a proporre
10 BEST SONGS
ASTRONOMY DOMINE
HAVE A CIGAR
BRAIN DAMAGE
ECHOES
MONEY
ANOTHER BRICK IN THE
WALL (PART II)
SHINE ON YOU CRAZY
DIAMOND
TIME
COMFORTABLY NUMB
WISH YOU WERE HERE
30
OUTSIDER
PINK FLOYD
delle musiche, cosa che io non volevo
fare visto che si trattava di un progetto
di Roger. Ha aperto a Nick delle prospettive straordinarie, indicandogli un
altro modo di usare il suo strumento e ci
ha insegnato delle tecniche di registrazione particolarmente innovative: una
volta incise le basi, le passava sula pista
di un altro registratore che veniva utilizzato per registrare il seguito, preservando così le ritmiche per il missaggio
finale. Poi sincronizzava di nuovo l’insieme sotto il nostro sguardo stupefatto.
Ci ha aiutati a salire un gradino in più
nella nostra eterna ricerca della qualità
del suono.
La ripercussioni di The Wall, tour
e film, sono straordinarie e drammatiche: il disco contribuisce ad
amplificare la popolarità dei Pink
Floyd ma la situazione tra Roger e
il resto del gruppo si deteriora. Registrate The Final Cut, concepito in
origine per essere l’ennesima musica per un film, senza Rick. Oggi
quel disco è considerato il primo
vero album solista di Roger Waters,
che firma la totalità delle canzoni. Nel 1986, persuaso che voi non
avreste proseguito senza di lui, lascia il gruppo per incompatibilità
d’umore e di carattere. L’anno seguente pubblicate A Momentary
Lapse Of Reason e dimostrate al
mondo, a voi stessi, e a Roger, che i
Pink Floyd possono esistere senza
di lui.
Del tutto onestamente, ho sempre conservato la fede nele mie attitudini musicali. Dopo il periodo Barrett, il suono
dei Pink Floyd era la mia chitarra, le tastiere di Rick, la mia voce per gran parte
del tempo e parecchie idee di Roger. Ma
in effetti lui non ha mai scritto tutta la
musica e il suono che conosce la gente è alla fin fine soprattutto quello che
Rick e io abbiamo composto. E poi, non
vedevo perché noi non avremmo potuto continuare. In verità, il mio vero
cruccio era soprattutto a livello dei testi,
ma all’epoca avevo già registrato due
album solistici e mi sono detto che con
Bob Ezrin a spalleggiarmi, le cose potevano funzionare.
Suppongo che tu abbia sempre
tentato di separare la musica dal
business, ma non era disturbante
proseguire l’avventura sapendo
che Roger avrebbe fatto di tutto
per impedirvi di utilizzare il nome
Pink Floyd?
Sì, sicuramente, era parecchio difficile,
soprattutto nel momento in cui lavoravamo. Nei 5 o 6 mesi delle registrazioni
sul battello, gli avvocati chiamavano
dieci volte al giorno e bisognava che ci
parlassimo. Sapevamo che Roger non
avrebbe vinto la causa ma era este-
Nick Mason, con suo figlio, 12 ottobre 1972 (Michael Putland/Getty Images)
nuante. Le cose sono andate a posto
quando siamo partiti per terminare
l’album a Los Angeles: a causa dei fusi
orari, gli avvocati non potevano più
assillarci. Alla fine, l’affare non è mai
finito in tribunale ma nel corso del tour
che ha seguito l’uscita del disco ha minacciato più volte di fermarci, cosa che
non ha ovviamente mai fatto.
In fin dei conti, l’avete aggiustata
amichevolmente e avete discusso
insieme di Is There Anybody out
There?,il disco del tour di The Wall
pubblciato 20 anni dopo.
Discutere è una parola grossa. Diciamo
che i nostri manager e i nostri avvocati
si sono messi d’accordo. Ma non ci parliamo più dalla notte dei tempi.
Almeno non vi ha impedito di pubblicare quell’album.
Il rischio non c’era, lui era il primo a volere che uscisse.
The Delicate Sound Of Thunder, il
live del tour che ha seguito l’uscita
di A Momentary Lapse Of Reason,
er al’album da comodino dei cosmonauti russi nella stazione Mir.
È vero, mi ricordo. Personalmente, preferisco The Pulse, quello che abbiamo
pubblicato dopo The Division Bell, il
nostro disco in studio più recente.
Parlando di viaggio e tralasciando il caso Barrett, credi
che le deroghe abbiano giocato un ruolo predominante
nel processo creativo dei Pink
Floyd, come lo è stato per band
americane come i Grateful
Dead?
Francamente non posso negare la
loro importanza, d’altro canto legata essenzialmente all’epoca, ma
credo che la loro funzione fosse
ancora più decisiva per i nostri fan.
Le droghe non hanno influenzato direttamente il nostro modo di
comporre, ma, poiché tentavamo
di sedurre il pubblico che, lui sì, nascondeva le sue preferenze per certe sostanze, credo di poter dire che
hanno giocato sicuramente un
qualche ruolo. Siamo sempre stati
assai più professionali di quanto la
gente potesse pensare.
OUTSIDER
THE 12
PINK FLOYD
STUDIO
ALBUMS
di Robert Sandall // MOJO, Maggio 1994
31
32
OUTSIDER
PINK FLOYD
THE PIPER AT THE GATES OF DAWN
Insieme a Sgt Pepper, il disco d’esordio dei Floyd rappresentava il contributo durevole all’’Estate dell’Amore’. All’inizio
del 1967 i Pink Floyd entravano negli studi di Abbey Road
della EMI con una catasta di stravaganti canzoni su gnomi,
spaventapasseri e biciclette, pezzi psichedelici che rassomigliavano solo vagamente alle prolungate jam spaziali per le
quali erano famosi. Norman Smith, ingegnere per i Beatles,
ne era il produttore.
Nick Mason: Ci venne dato Norman Smith alla EMI, senza
discutere. Così Joe Boyd, il nostro produttore originale, venne messo da parte. Norman era maggiormente interessato a
farci suonare come un gruppo rock classico. Era una cosa un
po’ alla George Martin, un’influenza utile da sperimentare.
Passammo tre mesi per registrarlo, che era davvero molto
tempo per quei tempi. In genere i gruppi terminavano le
incisioni in una settimana, con l’aiuto di musicisti di studio
buttati dentro per coprire le parti più difficili da eseguire. Ma
dato che i Beatles se la prendevano comoda nell’incidere Sgt
Pepper nello studio a fianco, la EMI pensò che questo fosse
il modo in cui adesso si facessero i dischi. Ci portarono un
giorno a incontrarli, mentre stavano incidendo Lovely Rita.
Per noi ragazzini fu un po’ come visitare la Famiglia Reale.
Peter Jenner (vecchio manager): Norman era il perfetto
uomo di relazioni. Comprese che Syd poteva scrivere grande
canzoni pop. Se avessimo provato a fare quel che facevamo
dal vivo, non avrebbe venduto un cacchio e saremmo morti
come band ancora prima di nascere. L’unico pezzo che era
tipo quello suonato dal vivo era Interstellar Overdrive. La
suonarono due volte, una versione incisa direttamente sopra l’altra. Praticamente sovraincisero l’intero pezzo. Perché? Beh, suona fottutamente strana, no? Con quel suono
ampio e tutta quella batteria battente...
A SAUCERFUL OF SECRETS
La prima formazione dei Pink Floyd stava già sbandando
all’inizio del 1968 quando iniziarono a lavorare sul secondo
album. Nel corso delle registrazioni Syd Barrett fu messo da
parte a favore di un nuovo ragazzo, Dave Gilmour. Presagendo la fine, i manager Peter Jenner e Andrew King abbandonarono la nave.
Peter Jenner: Era stressante aspettare Syd con le canzoni
per il secondo disco. Tutti guardavano a lui ma lui non era
in grado di farlo. Jugband Blues è davvero una canzone triste, il ritratto di una crisi di nervi. L’ultima canzone che Syd
scrisse per i Floyd, Vegetable Man, era stata fatta per quelle
incisioni anche se non vide mai la luce. La compose girando
attorno a casa mia; è la descrizione di quello che indossava?!? È molto inquietante. Roger la tolse dall’album perché
era troppo cupa. Come un lampo psicologico.
Rick Wright: Scrissi il pezzo che dava titolo al disco e ricordo che Norman mi diceva: “Non puoi farla, è troppo lunga.
Dovete scrivere pezzi da tre minuti”. Eravamo belli cazzuti
a quel punto e gli risposi: “Se non vuoi produrla, vattene”.
Un bell’atteggiamento, credo. Lo stesso motivo per cui non
abbiamo mai suonato See Emily Play dal vivo.
David Gilmour: Ricordo Nick e Roger che dipingevano A
Saucerful Of Secrets come un diagramma architettonico, in
forme dinamiche piuttosto che in qualsiasi altra forma musicale con picchi e solchi. Questo è quel che era. Era musica per il gusto della bellezza o dell’emozione, sena nessuna
particolare motivazione dietro. Non c’era una linea logica.
E questo nonostante negli anni successivi continuammo a
ricevere lettere da gente che ci spiegava cosa credeva significasse. Brani composti come se fossero anche colonne sonore.
UMMAGUMMA
Disco doppio del 1969 di transizione, Ummagumma era
metà dal vivo metà brani individuali. La copertina disegnata dalla Hypgnosis era più forte della maggior parte della
musica che è in gran parte improvvisata in modo irrilevante
tornando alla vita solo nello spettrale, luminoso classico Careful With That Axe Eugene, il primo di molti pezzi dei Pink
Floyd in merito alla pazzia.
Nick Mason: Non era assolutamente l’album di un gruppo.
La parte dal vivo suona incredibilmente vecchia riascoltata oggi, nonostante che i Pink Floyd che suonavano al Mothers di Birmingham fosse considerato un piccolo evento al
tempo. Eravamo alla ricerca di nuovi modi di costruire un
album, anche se penso che questo disco dimostri che la somma di noi quattro sia sempre migliore delle singole parti. La
EMI aveva una mentalità molto ristretta in quei giorni. Era
ancora gestita da tizi in impermeabili bianchi. Mi impedirono di rivedere i miei nastri con un ingegnere di studio che
mi disse che non ero membro di alcun sindacato e di levarmi
dai coglioni che non avevano tempo da perdere.
David Gilmour: Non avevo mai scritto nulla in precedenza. Entrai in studio e iniziai a esitare, mettendo insieme un
pezzo qua ed uno là senza molto senso. Telefonai a Roger a
un certo punto per chiedergli di scrivermi qualche testo che
proprio non mi veniva niente di meno che avesse un senso.
Mi rispose semplicemente: no.
ATOM HEART MOTHER
Con le orecchie piene di idee sperimentali e d’avanguardia,
i Floyd si unirono con il compositore elettronico Ron Geesin
per creare il brano che riempie tutta la prima facciata. Il titolo del disco fu preso a caso dai titoli di testa di un quotidiano.
Da questo momento in poi il gruppo si produsse da solo.
Nick Mason: È un disco inciso con una qualità tutto sommato media ma da una idea molto interessante, lavorare con
Ron Geesin, un orchestra e il coro di Roger Aldiss. Roger ed
io eravamo molto amici di Ron. Credo di averlo incontrato
tramite Robert Wyatt. Quel che Ron ci insegnò in particolare
furono le tecniche di incisione e i trucchi fatti con poco. Imparammo come evitare gli uomini-in-impermeabile-bianco
e farci le cose a casa, come il montaggio. Ron ci spiegò come
usare due registratori per creare un eco continuo. Fu tutto
molto importante per le cose che facemmo in seguito. Oggi
OUTSIDER
lo ascolto con imbarazzo perché la traccia di base venne messa insieme da Roger e me, dall’inizio alla fine, in una sola
volta. Di conseguenza il tempo va su e giù, non è continuo.
Insomma è un casino. Era un pezzo di venti minuti e ci trovammo un po’ spiazzati nel corso del brano.
D’altra parte Alan’s Psychedelic Breakfast fu un’altra grande idea – rumori di caminetto scoppiettante, bollitori in ebollizione, che non funzionavano per niente sul disco ma che
erano un divertimento dal vivo. Non ho mai sentito Roger
dire che fosse una sua idea, cosa che mi fa pensare che l’abbiamo avuta tutti insieme.
David Gilmour: In quel tempo sentivamo che Atom Heart Mother, come Ummagumma, fosse un passo avanti in
qualche modo. Oggi credo che si trattasse di un vagare impacciato al buio. Per fortuna che al tempo quasi nessuno se
ne accorse.
MEDDLE
Questo è l’album che accelerò e affermò il marchio dello
stile più maturo dei Pink Floyd: un tessuto denso e colorato
di suoni attuali (in particolare il coro calcistico in Fearless),
composizioni elettroniche originali e rock strumentale più
convenzionale. Venne inciso agli Abbey Road e all’Air London nel 1971.
David Gilmour: Facemmo tonnellate di demo che poi mettemmo insieme e per la prima volta funzionò. Questo album
fu un evidente anticipazione per Dark Side Of The Moon, il
momento in cui per la prima volta mettemmo a fuoco l’obbiettivo.
Nick Mason: Passammo molto tempo prima di iniziare il
disco. Lavorammo a lungo anche con un progetto che passava attraverso il Sound Of Household Objects, un disco fatto
senza strumenti musicali ma con oggetti comuni, ma che
non terminammo mai. L’idea era sempre di creare un brano
continuo di musica che passasse attraverso varie emozioni e
questo fu il disco che fissò il concetto. Rick fu la persona che
se ne uscì con quella nota all’inizio.
Rick Wright: Stavo suonando il piano in studio ma fu Roger che mi disse: “Sarebbe possibile prendere quella nota da
un microfono e poi farla passare attraverso il Leslie?”. Tutto
partì da qui. È questo il modo in cui ha inizio il miglior brano
dei Pink Floyd, credo.
DARK SIDE OF THE MOON
Il futuro inizia da qui. Inciso agli Abbey Road su di un nuovo mixer a sedici tracce, montato in sequenza senza singole tracce utilizzando un concetto “tematico” per connettere
i brani, Dark Side fu l’album che proiettò i Pink Floyd da
gruppo di culto per pochi adetti a pietre miliari della cultura rock. Un rimissaggio quadrifonico fatto da Alan Parsons,
autorizzato dalla EMI e presentato al London Planetarium,
causò scompiglio, con il gruppo che si rifiutò di presenziare.
A parte questo, il disco fu un enorme successo e lo è ancora
oggi, in termini commerciali, con le sue 28 milioni di copie
33
vendute in tutto il mondo (44 milioni nel 2013 . ndt).
Nick Mason: Dark Side iniziò come una sequenza chiamata Eclipse. La gran parte venne sviluppata nel corso delle
prove per i concerti e la suonammo per intero al Rainbow di
Londra aprendoci i concerti in America nel 1972. Il concetto
crebbe intorno alle discussioni del gruppo circa le pressioni
della vita reale, come il viaggiare o il denaro, ma poi Roger la
ampliò in una meditazione sui motivi della follia. Il legame
tra tutti i suoni e le voci era ben fatto, credo, e usammo per la
prima volta verso la fine uno dei primi sintetizzatori, il DCS3.
Le registrazioni furono prolisse ma non tese, non angosciose dopo tutto. Lavoravamo davvero bene come gruppo, ma
non fu solo la musica che ne fece un successo. EMI/Capitol
aveva scartato un po’ di gruppi in America, così misero tutto il denaro recuperato su d noi per promuoverci veramente
per la prima volta. E questo cambiò tutto.
David Gilmour: La grande differenza per me con questo
album fu il fatto che lo suonammo dal vivo prima di inciderlo. Non puoi più farlo oggi, ovviamente, ti coprirebbero
di bootleg su You Tube. Però quando entrammo in studio,
tutti avevamo già confidenza con il materiale. Suonare era
facile. Una cosa naturale. E questo era una bella accoppiata.
La musica, il concetto, la copertina, tutto venne facilmente.
Per me fu la prima volta che abbiamo cantato grandi testi; gli
altri erano soddisfacenti o sbrigativi e anche semplicemente brutti. Su Dark Side Roger decise che non avrebbe voluto
nessun altro a scrivere testi.
WISH YOU WERE HERE
L’umore chiaramente elegiaco di questo album è in stridente contrasto con quello più spassionatamente meditabondo del suo predecessore. Nel 1975 a Roger mancava Syd; il
mondo della musica stava catturandolo e lo infastidiva – e
la citazione “And by the way, which one’s Pink?” che compare su Welcome To The Machine era una vera citazione da
una frase di un esecutivo dell’etichetta americana. Il disco
vede anche Gilmour che dà il suo più importante contributo da sempre, con molti eccellenti assolo ed alcune delle più
toccanti parti cantate che i Floyd abbiamo mai messo su un
disco.
David Gilmour: Dopo Dark Side eravamo davvero in difficoltà. Io volevo che il disco successivo fosse più musicale
perché sentivo che molte delle canzoni precedenti erano
state principalmente dei veicoli per le parole. Stavamo lavorando nel 1974 in questa orribile piccola sala prove in Kings
Cross senza finestre, mettendo insieme quello che divennero
i due dischi successivi. C’erano tre brani lunghi, incluso Shine On You Crazy Diamond, che volevo registrare e Roger disse “No, prendiamo Shine On e dividiamolo in due parti, poi
mettiamoci dentro altro materiale che sia in sintonia con lo
stesso tema”. Aveva ragione lui, mi sbagliavo io.
Roger Waters: Tutto il disco proveniva da quella frase di
chitarra di quattro note di Dave in Shine On. La sentimmo
e pensammo subito che era davvero un gran bell’accordo. La
linfa iniziò a scorrere e ci condusse a quello che penso sia il
nostro disco migliore, il più colorato, il più denso di emozioni.
34
OUTSIDER
PINK FLOYD
Rick Wright: Stavamo incidendo Shine On, i testi su Syd
erano stati scritti, ed io entrai nello studio di Abbey Road;
Roger era seduto al mixer e vidi questo tipo grosso pelato che
sedeva sul divano dietro a lui. Quasi cento chili. Non sapevo chi fosse. In quei giorni era quasi normale che qualche
estraneo si aggirasse dentro alle nostre stanze. Poi Roger mi
disse: “Non sai chi è questo ragazzo? È Syd”. Fu uno shock perché non lo vedevo da sei anni. Continuava a stare in piedi
e pulirsi i denti, poi metteva via lo spazzolino e si risedeva.
A un certo punto si è alzato e ha detto: “Bene, quando devo
inserire la mia parte di chitarra?“. E ovviamente non aveva
una chitarra con se. Così gli dicemmo che le parti di chitarra
erano già state tutte fatte.
Nick Mason: Questo fu un disco molto più difficile da fare.
Roger stava acquistando più spazio e noi stavamo diventando più vecchi. Avevamo figli. C’erano più difficoltà tra di noi,
gente che arrivava in studio in ritardo, una cosa che un po’
tutti odiavamo. C’era più pressione su di me per ottenere un
suono di batteria più accurato e meno elaborato. Ma credo
che sia un album che scorra veramente bene. È come un erede di Meddle nel senso dell’uso dei temi ripetuti e del ritmo.
ANIMALS
Il concetto del disco proviene da Waters, ma due dei quattro animali presenti come canzoni erano già stati sentiti altrove sotto nomi differenti: Sheep era una rielaborazione di
Raving and Drooling. Dogs era una trasformazione di You
Gotta Be Crazy. Waters e Gilmour iniziavano ad azzuffarsi
per il controllo, dividendosi i crediti della produzione ed iniziando un lungo litigio in merito alle royalties del disco che
non terminò prima di dieci anni.
Nick Mason: Fu il ritorno al concetto di gruppo, una sessione allegra come la ricordo io. Lo realizzammo nel nostro
nuovo studio che avevamo appena messo in piedi. In quel
periodo Roger era un fiume in piena con le idee, ma al tempo stesso impediva a David di creare ed era una frustrazione
volontaria, la sua.
Roger Waters: Non mi piacque molto scrivere per Animals
ma sfortunatamente non avevo altro da proporre. Credo di
aver suonato bene me ricordo di non essermi sentito particolarmente felice o creativo, in parte per colpa dei problemi con il mio matrimonio. Questo fu l’inizio del mio blocco
come compositore di testi.
David Gilmour: Su Animals io ero la prima forza musicale
trainante. Roger era il solo motivatore e compositore dei testi.
THE WALL
La perdita di due milioni di sterline in investimenti spinse
il gruppo a un esilio nel sud della Francia per via delle tasse
nel 1978; lì registrarono un doppio album con un solo concetto portante che si rivelò essere il progetto più strettamente
legato a Roger fino ad allora. Mentre si trovavano in Francia, l’amicizia all’interno della seconda formazione dei Pink
Floyd iniziò infine a dissolversi.
David Gilmour: Penso ancora oggi che parte della musica di The Wall sia incredibilmente pacchiana, ma il disco è
brillante da un punto di vista concettuale. In quel periodo
pensavo che fosse l’elenco di Roger di tutte le cose che possono far diventare una persona normale un essere umano
isolato. Mi resi conto che era una delle persone più fortunate
al mondo che riusciva a fare un catalogo di rabbia e violenze
contro gente che non gli aveva mai fatto nulla. Roger prendeva sempre più spazio nei crediti dei nostri brani. Nel libretto per questo album ad esempio, per Comfortably Numb
c’è scritto “Musica di Gilmour e Waters”, ma non è vero. Lui
scrisse i testi, io la musica. Iniziai a trovare centinaia di carognate come questa. Non dovrei sputtanarlo, ma ci si sente
ingiustamente presi per il culo. Senza contare le royalties
che passano di mano.
Nick Mason: Le registrazioni furono molto tese, principalmente perché Roger iniziava a dar di matto. Questo fu il disco in cui litigò malamente con Rick. Rick aveva uno stile
naturale, un approccio stilistico specifico al modo di suonare
il piano, ma non si adattava con facilità ai brani e non sapeva comporli su ordinazione. Che poi è il problema che si
pone quando gli altri si preoccupano di chi ha fatto cosa e
chi dovrebbe ottenerne il merito. Ci fu anche una voce secondo cui Roger e Dave mi avrebbero estromesso per continuare come duo. C’erano dei momenti in The Wall in cui
Roger e David stavano veramente spingendo per portare
avanti il disco. Rick era privo di entusiasmo ed io non ero in
grado di essere di aiuto a nessuno.
David Gilmour: Di solito Nick lavorava duro e suonava
bene su The Wall. Riuscì persino a trovare il modo di studiare per saper leggere la musica per le partiture di batteria. Ma
c’era un brano chiamato Mother che davvero non riusciva
a suonare. Così affittai Jeff Porcaro per suonarlo. E Roger si
attaccò a questa idea, nel modo in cui faceva sempre con le
mie idee, e iniziò a pensare... ”forse non sono più necessario?”.
Rick Wright: Roger portò tutto il disco su un demo; ognuno di noi pensò che fosse potenzialmente buono ma musicalmente molto debole. Davvero molto debole. Bob Ezrin,
Dave ed io stesso ci lavorammo a lungo per renderlo più
interessante. Ma Roger stava attraversando un periodo di
egomania in quel tempo e diceva che io non stessi mettendoci sufficiente interesse nonostante facesse di tutto per rendermi impossibile fare qualcosa. La crisi arrivò quando ce ne
andammo tutti in vacanza verso la fine delle registrazioni.
Una settimana prima delle vacanze ricevetti una telefonata
da Roger dall’America che diceva di prendere un aereo e andare immediatamente lì. E ci fu questa riunione in cui Roger
mi disse che voleva che me ne andassi. Dapprima rifiutai.
Così Roger si alzò in piedi e disse che se non me ne fossi andato dopo la fine del disco se ne sarebbe andato lui in quel
momento portando via i nastri con sé. Non ci sarebbe stato
alcun disco e nessun denaro per pagare i debiti enormi che
avevamo contratto. Dovetti accettare per forza. Avevo due
bambini da mantenere. Ero terrorizzato. Oggi credo che commisi un errore. Era un bluff. Ma davvero non avevo più voglia di lavorare con quell’uomo.
David Gilmour: Avevamo uno studio nel sud della Francia
dove abitava Rick. Noi altri avevamo affittato delle case a
OUTSIDER
una ventina di chilometri di distanza. Ce ne andavamo tutti a casa la sera e dicevamo a Rick... ”fai quello che ti pare,
ascoltati i brani, scrivi qualcosa, suona un assolo, metti giù
un po’ di cose. Hai tutta la sera, ogni sera, per farlo”. Per tutto il tempo che restammo lì, che furono diversi mesi, non
fece niente. Semplicemente non era più in grado di suonare
niente.
THE FINAL CUT
Questa è la cosa più prossima a un disco solista di Roger Waters e che è uscito sotto il nome di Pink Floyd. Il materiale era
stato scritto per The Wall ma rifiutato al tempo dal resto del
gruppo. Un gruppo adesso di fatto ridotto a duo con Waters
e Gilmour e con le sessioni di incisione che non erano altro
lunghe litigate tra i due che finirono con Gilmour che decise
di far rimuovere il suo nome dai crediti della produzione.
David Gilmour: Dissi a Roger: “Se queste canzoni non erano sufficientemente buone per The Wall, come potrebbero
essere buone adesso?”. Passammo il peggior periodo della
mia vita. Roger aveva voluto Rick fuori dal gruppo, Nick
non ci frequentava più e adesso stava iniziando con me. Una
esperienza spiacevole e umiliante.
A MOMENTARY LAPSE OF REASON
Dopo la partenza di Waters nel 1985 ed un periodo teso di
discussioni pubbliche circa i diritti sul nome del gruppo,
Gilmour iniziò a mettere insieme un nuovo disco dei Pink
Floyd nel 1987 utilizzando il produttore di The Wall, Bob
Ezrin, e lavorando su canzoni con una squadra di assistenti,
Phil Manzanera incluso. Come il suo predecessore, A Momentary Lapse Of Reason si dimostrò di fatto un disco solista eccezion fatta per il nome.
David Gilmour: Sia Nick che Rick erano catatonici in termini di abilità esecutiva all’inizio. Nessuno dei due ha suonato sul serio sul disco. A mio modo di vedere erano stati
distrutti da Roger. Nick ha suonato un po’ di tom-tom su un
brano ma per il resto utilizzai altri batteristi. Rick suonava
su alcune piccole parti. Ma per la maggior parte suonavo io
le tastiere facendo finta che fosse lui. Il disco l’ho fatto essenzialmente da solo, con qualcun altro e Dio sa come. Non
credo che sia il miglior disco mai fatto dai Pink Floyd, ma ho
fatto del mio meglio.
Nick Mason: Dave era sotto pressione per presentarsi con
canzoni plausibili e cercava aiuto ovunque lo trovasse. Era
divertente registrare sulla barca (lo studio galleggiante di Gilmour a Hampton-on-Thames) ma poi se ne andò in America
e affittò tutti quei musicisti da studio che potessero risolvergli
i problemi velocemente. A quel tempo parve una strada giusta da percorrere ma mi suonò decisamente allarmante.
Rick Wright: Io non facevo parte del gruppo. In quel momento non mi riconoscevano. Non avevamo suonato insieme per anni. Fui pagato con un salario come session-man
per le registrazioni. Anche se ottenni delle royalties sul disco. Non tante quante Dave e nick in ogni caso.
35
DELICATE SOUND OF THUNDER
È solo il secondo live di tutta la loro carriera ed è quello che
contiene otto musicisti in aggiunta ai tre Pink Floyd originali; questo documento del più lungo tour dei Floyd venne
registrato in vari stadi europei nell’agosto del 1988.
David Gilmour: All’inizio del ‘Momentary Lapse of Reason
tour’ Gary Wallis suonava tutte le parti di batteria perché
Nick non poteva e presi Jon Carin per suonare le tastiere perché lui poteva fare Rick Wright meglio di Rick stesso. Ma li
incoraggiai entrambi a riprendere e verso la fine dei primi
tre mesi di tour Nick e Rick suonavano alla grande. La loro
fiducia in se stessi era stata restaurata. Quel tour li ha riportati indietro ad essere musicisti a tempo pieno. O, potrei anche
dire che... fui io a farlo...
THE DIVISION BELL
L’ultimo album, quello del ritorno agli inizi, che necessitò
di un anno per essere registrato fuori e dentro il barcone di
Gilmour, un tentativo scrupoloso di ricostituire il gruppo
come qualcosa di più di un marchio che ruotava intorno a
un unico soggetto che utilizzava un repertorio famoso. Se da
un lato non si addentrava in alcun nuovo terreno musicale,
il suono è qui più coeso e con testi più delicati di ogni cosa i
Floyd avessero inciso dai giorni gloriosi nel 1970. Il tono è
più quieto e il suono della chitarra vede Gilmour in un atteggiamento più lirico piuttosto che acuto. Wright, ora un
compagno minore invece di un impiegato a pagamento, si
sente più chiaramente qui di quanto lo sia stato negli ultimi quindici anni. La ricerca di Gilmour per un paroliere era
terminata essendo molti brani scritti insieme alla sua nuova
compagna, la giornalista Polly Samson. Bob Ezrin, ancora,
era alla produzione.
Nick Mason: C’è molto del feeling di Meddle qui che in
qualunque altro disco. Questo album è partito come quello
prodotto da un gruppo, con noi tre che passavamo due settimane insieme solo facendo improvvisazioni. Abbiamo messo giù 40 abbozzi di brani in due settimane, poi le cose hanno
continuato ad andare avanti da sole. Alcune di quelle idee
iniziali potrebbero senz’altro finire su un disco satellite.
Rick Wright: Ho scritto brani per quel disco. Ci canto pure.
Credo che sia un album molto migliore del precedente. Ha
molto più sentimento di quelli che erano i vecchi Floyd. Ritengo che saremmo potuti andare oltre. Solo Nick ha suonato la batteria e il mio organo hammond è tornato sulla maggior parte dei brani.
David Gilmour: Su questo disco sia Nick che Rick suonano
tutte le loro parti. Ecco perché suona molto di più come un
vero disco dei Pink Floyd per me di qualsiasi cosa abbiamo
fatto da Wish You Were Here. È incentrato su una sorta di
tema circa la mancanza di comunicazione ma non c’è alcun
sottinteso, non intendiamo sbattere in testa a nessuno il concetto. Siamo usciti con un disco con l’intenzione di mostrare
al mondo che... siamo ancora qui, che è questo il motivo per
cui eravamo così rumorosi e casinisti. Questo è però un disco
molto più riflessivo.
36
OUTSIDER
PINK FLOYD
COSA
HANNO
SCRITTO
CIAO 2001 DOCET
ATOM HEART MOTHER
Di Enzo Caffarelli
… indipendentemente dai valori artistici che in esso si possono cogliere,
rimane una delle cose più notevoli del
gruppo e di questi ultimi tempi nella
musica pop. I Pink Floyd sono sempre
stati un vero gruppo all’avanguardia:
l’autentica musica psichedelica – è
stato detto – è quella dei Pink Floyd. Si
tratta di un’avanguardia di forme e di
contenuti, alle soglie dell’elettronica,
alle soglie della mistificazione e della non musica se vogliamo, e proprio
per questa accetta ad una schiera abbastanza elitistica, in grado di recepire
un messaggio estremamente cerebrale e mai epidermico.
Con questo disco il gruppo si è comunque rivolto a un pubblico più vasto,
se controlliamo le eccezionali vendite sul mercato. La suite divisa in sei
movimenti, era già stata eseguita al
festival di Bath, ed in un concerto ad
Hide Park. Il sound è di fattura classicheggiante; un’orchestra con fiati,
archi e cori si aggiunge al quartetto in
un contesto maestoso. In questo senso
si sono mossi con differenti risultati, i
compagni di scuderia Deep Purple.
Sul retro l’atmosfera si fa soffusa e
vellutata, a tratti intimista. Così in If,
firmata dal bassista Roger Waters, in
Summer ’68 dell’organista Richard
Wright, in Fat Old Sun del chiatarrista David Gilmour. Nella conclusiva
Alan’s Psychedelic Breakfast c’è ancora del classico, e c’è del rumore senza
senso.
CIAO 2001 DOCET 2
DARK SIDE OF THE MOON
Di Enzo Caffarelli
Preceduto da un blootleg, questo album era atteso curiosamente. Si voleva valutare il gruppo attuale, dopo le
esperienza poco convincenti di Meddle
e di Obscured by Clouds, si voleva verificare quanto Roger Waters e compagni abbiano ancora da dire.
Questo disco contiene una decina di
titoli legati fra loro a formare un’unica
suite. Costanti e palesi, nei titoli, nelle
atmosfere musicali, nella particolareggiata ricerca sonora, nelle dichiarazioni
stesse egli interessati, i riferimenti spaziali cari al quartetto.
Il risultato ancora una volta non dispiace, anzi a tratti entusiasma. Ma
la ricerca della sensazione pure va a
scaopito della musica vera e propria:
le emozioni sono soltanto momentanee, passeggere, nulla è
radicalmente profondo. L’influenza del bassista Waters, del
quale viene pubblicato anche il
‘solo’ The Body, è evidentissima
(ricordate la side B di Atom Heart Mother?). Ma anche quella
di Syd Barrett non è stata del
tutto posta nel dimenticatoio.
Un non so che di pacato, di mistico tiene le fila della musica
pinkfloydiana. Certamente il
gruppo ha avuto meriti straordinari anni or sono; ora le
imitazioni, le volgarizzazioni e
d’altro canto i progressi del pop
negli ultimi tempi, tendono a
ridimensionarli ed a confonderli nella massa.
Complessivamente i quattro
sono sempre gli stessi: li ascoltiamo in
pezzi estremamente tipici del loro repertorio, come Speak to me, breathe,
On the Run, Honey, As and Then. Da
notare l’uso del sax e l’impiego notevolissimo delle voci, anche di alcuni
ospiti, fra cui le armonie a bocca chiusa
della cantante Clare Torry nella bellissima The great gig in the Sky, Numerosi brani sono di presa immediata.
DARK SIDE OF THE MOON
di Tony Stewart // NME //
17 Marzo 1973
Sin dall’epoca della rappresentazione
di questo lavoro alla Brighton Dome
lo scorso anno quando, a causa di difficoltà tecniche l’esecuzione si bloccò a
metà strada, la struttura di Dark Side of
the Moon si è sviluppata notevolmente. Come un aircraft o una navicella
spaziale è stata soggetta a numerose
modifiche per permetterne la partenza.
Il risultato è quello che viene correttamente descritto da uno dei brani come
“il gran concerto nello spazio”.
Musicalmente questo album è simile allo stile formulato dapprima con
Atom Heart Mother e poi Meddle, sebbene sia più forte da un punto di vista
tematico su uno dei soggetti più comuni al mondo: la pazzia. “I’ve been mad
for fucking years” (Sono stato un pazzo
per molti cazzo di anni), dice una voce
mentre la batteria suonata come un
battito di cuore dà l’inizio a Speak To
Me...bum-bum, bum-bum, bum-bum...
Che di per se è già una semplificazione
perché una verifica più attenta dei testi
di Roger Waters in Breathe o Money
rivelino legami con le motivazioni della follia o della morte da lavoro eccessivo e con la separazione tra razze e classi
sociali in Us and Them.
Con la possibilità di apparire un po’
un grande fallimento, Dark Side parla
della vita e il risultato non è una bella
immagine, come suggerito in particolare da Eclipse. Probabilmente questa
è l’impresa di maggior successo artistico dei Floyd. Non solo i testi sono affermazioni di opinioni, di solito abbastanza comprensibili, ma sono valorizzate
da nastri intelligenti e effetti sonori. E
qua e là ci sono orribili risate di pazzi
che ricorrono. La musica da Speak To
OUTSIDER
Me si irradia delicatamente dentro la
melodia di Breathe con le voci che ondeggiano in una sorprendente magia
rilassante seguita dal ritmo incalzante
dell’hi-hat di Mason. Poi l’annuncio
dell’altoparlante aeroportuale e il rumore dei passi che passa da una cassa
all’altra e comprendi che sei On The
Run, In Fuga. Il ruggito di una tempesta elettronica prelude, con il ticchettio
dell’orologio, a Time. Che segue il
tempo di un metronomo con effetti
di sintetizzatore che non si sarebbero perduti nel corso di una puntata
di Dr. Who. E sebbene qualcuno
possa trovare somiglianze con i due
dischi precedenti, c’è senza dubbio
uno sviluppo di forma e struttura
nel modo in cui Time odora di accordi tosti e nel modo in cui la base è costruita sulle voci femminili di sottofondo. Oppure attraverso un ripresa
di Breathe con una graduale, riservata trasgressione di quella melodia
con le belle linee di piano di Rick
Wright che fluttuano finché non si
inserisce la chitarra. Qua la struttura
diviene più elaborata e non a causa
della semplicità della linea di basso,
assolutamente ripetitiva, ma perché
la magnifica voce di Clare Terry
evita di farle perdere attenzione, cosa
che sarebbe probabilmente successa.
I Floyd, pare, stanno ora allargando i
loro scopi, per fornire nuovi punti focali. Nello stesso modo in cui queste
signore gonfiano le voci, il sax di Dick
Perry crea una guida alternativa alla
chitarra o alle tastiere. Ma la porta delle influenze musicali è decisamente
semiaperta per farci entrare in Us And
Them e a picchi di cantato che sono più
simili ai Moody Blues che ai Floyd.
Quel brano è preceduto da una lunga
costruzione strumentale, costruita per
un ascolto notturno bevendo caffè,
con il sax che scivola attorno al piattino. Ma scommetto che nel momento
in cui avrete mangiato il vostro AfterEight avrete rovesciato gran parte della
bevanda. Mentre il gruppo scala lentamente verso Brain Damage e Eclipse,
ha ancora una volta toccato il culmine
ed in modo irritante l’ha tagliato via.
“There is no dark side to the moon really, as a matter of fact – ci informa una
voce – it’s all dark “. Bum-bum, bumbum, bum-bum....
DARK SIDE OF THE MOON
di Jacques Chabiron //
Rock and Folk
Nessun esempio ha finora smentito
l’assioma secondo cui ogni gruppo ha
il diritto di fare un passo falso durante la propria carriera. Tornando un po’
sul passato dei Pink Floyd, si constata
che il gruppo non ha fatto veri errori,
37
ma il fatto è che sono molte le sequenze di un film, quindi numerose e brevi
devono essere le illustrazioni musicali.
I Pink Floyd sono appunto il contrario
della concisione. È una musica diluita,
si estende e si espande all’infinito. Se
deve scrivere una canzone di tre minuti, il gruppo diventa un’ordinaria
formazione rock, per giunta pessima,
non conoscendo l’arte di dire tutto in
così poco tempo.
La musica dei Pink Floyd, la vera e la
migliore, eccola in questo Dark Side Of
The Moon, serie di lunghe canzoni che
si intrecciano intimamente. Musicalmente almeno, poiché i testi non hanno tra loro alcuna relazione evidente,
nonostante Eclipse, l’ultimo pezzo, sia
apparentemente un riassunto delle parole e delle idee enunciate precedentemente. (“All you see/All you touch”
proviene da Breathe, “All that you buy,
deal...” da Money, etc...). “E tutto ciò che
è sotto il sole è in armonia, ma il sole
è eclissato dalla luna”, conclude tutto.
se non registrando la colonna sonora
del film Obscured By Clouds e qualche traccia di More molto dubbiosa: e
questo per essersi troppo allontanati
dall’essenza della musica del gruppo.
Questo lavoro, effettuato su commissione, venne male ai musicisti perché
la loro musica sembrava a priori l’ideale per rafforzare le immagini del film,
Dark Side Of The Moon è ovviamente quel pezzo che i Floyd suonavano
nella prima parte dei concerti
fatti in Francia qualche mese fa.
Molto promettente dal vivo, ci
guadagna a essere ascoltato in
disco, perché le vere trovate, le
sorprese nell’arrangiamento sono
così realmente udibili. La rigorosa
progressione dell’ampiezza delle frequenze del VCS3 in On The
Run; il delicato piano di Richard
Wright (Time); il vigore, i cori
femminili in generale (e soprattutto l’exploit solitario di Clare
Torry in The Great Gig n The Sky).
Le percussioni non sono più queste troppo pesanti fanfare come
quelle di Atom Heart Mother, ma
principalmente assoli che arieggiano il pezzo e gli danno nuovo
slancio (Us and Them e Money).
La presa sonora nella sua totalità è fantastica e la produzione di questo disco
agevolmente la migliore di tutto quello che i Floyd hanno fatto fino ad ora.
Un pezzo come Money sembra anodino, a parte quando si ascolta la precisione del mixaggio delle voci, delle
chitarre wa-wa o ritmiche, dei sax e dei
vibrati: tutti questi suoni, di cui nem-
38
OUTSIDER
PINK FLOYD
meno due che si confondano o si somiglino, si rispondono a ogni tempo della
misura, che dona alla canzone un impeccabile equilibrio ritmico. La stessa
considerazione avrebbe potuto essere
fatta per Great Gig, in cui Wright suona l’organo Hammond e il piano. Tutto
ciò perfettamente piazzato e regolato
alla frazione di secondo, non impedisce però a una certa urgenza di manifestarsi qua e là, principalmente nei cori
di Gilmour (più incisivi che mai) (Any
Colour You Like). D’altra parte, i ritmi, i
colori degli episodi di questa Dark Side
Of The Moon variano abbastanza da
non rischiare di stancare. Un momento di vera follia elettro-acustica sarebbe
stato il benvenuto, ma l’opera è in se
stessa così ben composta, e riserva così
tante sorprese che non se ne sente veramente la necessità. Voci femminili
soliste, sassofono, eco alla Terry Riley
(Any Colour You Like): immenso è il
ventaglio di sonorità utilizzate. Tutte
si giustificano, mai traccia di sovraccarico, di effetti artificiali o di eccessiva
lunghezza.
La certezza ricavata da Ummagumma
era che ognuno dei musicisti avesse
delle idee interessanti, ma la musica
dei Floyd non ne beneficiava immediatamente (tranne che per quanto
riguardava i vecchi pezzi, rigenerati).
Atom Heart Mother e Meddle vennero dopo, e deluse il fatto che non concretizzassero davvero le promesse di
Ummagumma. È che non erano che
assaggi, tappe verso l’opera lunga, logicamente strutturata che è Dark Side
Of The Moon. Lunghe nello spazio
sono le misure della musica dei Pink
Floyd, lunga nel tempo è stata – e
sarà – l’evoluzione di questa musica. I
membri di questo gruppo non sono dei
tecnici, nemmeno degli strumentisti
virtuosi, ma dei compositori istintivi,
che lavorano prima di tutto la sonorità
che la tecnica della scrittura musicale.
Il loro sistema di armonizzazione (sovrapposizione di accordi o di particelle
di accordi), il loro incedere ritmico (si
tratta raramente di battere il tempo,
più spesso di accompagnare le melodie
con una ricerca sonora di percussioni – cfr. Time), tutto questo, malgrado
le apparenze, è in effetti molto meno
complesso di quello che fa un gruppo
come gli Yes, ad esempio. Ma è appunto la semplicità della loro musica ad
essere la causa del successo raggiunto
dai Floyd: perfettamente armonizzate, seducenti, eleganti, queste melodie
plananti hanno un aspetto Grande
Musica, che pare nettamente più “serio” del rock degli Stones. E affermarlo non vuole in nessun caso sminuire
i meriti dei Pink Floyd. L’importante
è che continuino e progrediscano magnificamente sulla via che si sono loro
stessi tracciati, via seguita da decine di
gruppi che, non avendo sempre un bagaglio tecnico sufficiente, hanno capito che potevano comunque esprimere
la musica che avevano dentro, e far
condividere le proprie emozioni a tutti
quelli che vogliono lasciarsi trasportare in un mondo etereo.
WISH YOU WERE HERE
di Ben Edmonds // Rolling Stone //
6 novembre 1975
Senza i Pink Floyd non avremmo
in giro moltitudini di gruppi in stile
science fiction: Hawkwind, Can,
Amon Duul e tutto il resto dei loro
amici. Sono stati i primi a esplorare le
vette dei paradisi chimici ma la loro
superiorità commerciale ed artistica, se
solo fosse mai stata in dubbio, era stata
confermata da Dark Side Of The Moon.
Quel disco che ha venduto milioni di
copie sia in Inghilterra che in America
vede il successore ottenere ben 900.000
copie in prenotazione, uno dei casi più
eclatanti nella storia della Columbia.
Circola voce che i due anni necessari
alla registrazione siano stati prolungati
dalle paranoie del gruppo. Pubblicare
qualsiasi cosa li avrebbe messi in competizione con il loro
stesso passato che non erano
certi di poter superare
Per certi versi siamo in quella situazione. Per loro stessa
ammissione, i Pink Floyd non
hanno mai ottenuto premi
per le loro abilità strumentali. Al massimo viene riconosciuta loro competenza. La
loro complessità è un’illusione creata dalla intelligente
manipolazione di elementi
così semplici, tre accordi di
base, che chiunque potrebbe
riprodurli nota per nota. Una
delle cose che hanno fatto di
Dark Side un oggetto così impressionante è stato che ha
mostrato i loro limiti come
musicisti. In passato i Pink
Floyd hanno concettualmente tenuto lontane le loro mancanze tecniche e sembrava che ognuno
avesse perfettamente calcolato come
non oltrepassare mai la linea. Ma la
maggior parte della musica su quel disco sembrava determinata a dipingere
i Floyd come un altro gruppo di rock
convenzionale, ignorando la loro autoanalisi allo scopo di poter suonare dentro un’arena in cui non erano equipaggiati per combattere. Il primo responsabile è David Gilmour, da molti indicato come il più valido tecnicamente.
Pur non essendo così bravo come lo si
vuole dipingere, possiede idee sufficienti per mantenere la connessione
con le fondamenta della massa del loro
pubblico. Gilmour oltrepassa i confini
in molti punti in Wish You Were Here,
indulgendo in lunghi assolo che lo
evidenziano come un altro chitarrista
competente che pensa con le dita invece che con la testa. Gilmour suona un
bel duetto acustico con se stesso come
introduzione al brano che dà il titolo al
disco che possiede vaghi echi di Lou-
OUTSIDER
don Wainwright nell’approccio.
È il miglior pezzo sul disco finché il
gruppo non fa il suo ingresso privo di
personalità, riportando il brano a livelli di noia. I Pink Floyd avrebbero dovuto conoscere meglio come muoversi
e imitare la tradizionale metodologia
di una rock band tradizionale cui loro
vorrebbero presentarsi come alternativa. In questo disco tendono a suonare
così direttamente per la maggior parte
del disco che gli effetti diventano così
accentuati al punto che tutto inizia a
suonare ricoperto; questo non rappresenta un complemento alla loro musica ma un contrasto e gli effetti sembrano solo trucchi. Il suono complessivo
perde la dimensione mozzafiato che
aveva fatto di Dark Side un’attrazione
per quelli che avevano considerato
i Pink Floyd nient’altro che rumori
spaziali casuali. Shine On You Crazy
Diamonds è credibile inizialmente a
causa del soggetto, Syd Barrett,
la lontana luce guida degli originali Floyd. Ma il potenziale
dell’idea è irrealizzata; i Floyd
danno una lettura così materiale di tutta quella cavolo di cosa
che potrebbero star cantando
del cognato di Roger Waters
che si compra un biglietto per il
parcheggio.
Questo atteggiamento svogliato,
tra l’altro, spinge a una rivalutazione della loro relazione di
tutte quelle orchestre spaziali
cui loro hanno inconsciamente dato vita. E la sola cosa che
quei gruppi possedevano nella
loro inettitudine cacofonica, è
una sincera passione per la loro
“arte”. E la passione è una cosa
di cui i Pink Floyd sono sprovvisti. Wish You Were Here parla
dei meccanismi dell’industria
musicale che hanno spinto Syd
Barrett alla rottura. Ma il trattamento riservato alla faccenda è così solenne che viene da domandarsi dove
stia il problema. Se l’uso del meccanismo è abbastanza vivo da trascendere
il suo solenne mormorio – anche se il
mormorio è in fondo il tuo soggetto –
sei automaticamente intrappolato. E
della mancanza di offerta di spirito di
liberazione è il punto in cui questo album lascia i Pink Floyd.
WISH YOU WERE HERE
di Jean-Marc Bailleux //
Rock and Folk
La prima volta che ho sentito Dark Side
of the Moon, l’ho trovata piuttosto insolita, ben fatta, e non priva di interesse,
ma niente di più. Poi mi ci sono voluti
sei mesi per trovarla splendida, e non
sono stato il solo, visto che è più o meno
il tempo che c’è voluto a Us & Them per
diventare una hit. Allora, sfiducia!
La metà di quelli che si regaleranno
l’album lo faranno sulla fiducia perché, entusiasti o delusi al primo approccio, hanno sempre finito per adorare l’uno dopo l’altro tutti i dischi del
gruppo, cosa che non è altro che giusta.
Una volta in più, avranno ragione.
E poi l’altra metà (forse i genitori dei
precedenti) ci arriveranno come sono
arrivati a Tubular Bells, perché i Pink
Floyd piacciono, e piacciono molto
stupidamente perché sono belli e non
disturbanti, il sottofondo perfetto delle
riunioni in salotto – perdonateli, non
sanno quello che si perdono.
E tutto questo piccolo mondo supererà
il mezzo milione. Senza rischi, senza
problemi. Tutte le argomentazioni contro i Floyd, contro questo disco, sono
distorte dall’origine: qualcuno ha mai
rimproverato Bach o Coltrane di non
39
rivoluzionare la propria musica a ogni
nuovo componimento? Facevano le
loro cose e le facevano bene, e tutti erano contentissimi ed era bello così. Certo
questi arrangiamenti, queste successioni di accordi, alcuni tratti melodici,
li avete già sentiti da qualche parte, di
sicuro! Ma riflettete bene, non era forse su un altro Pink Floyd (un Pink
Floyd, come si dice un Morgon o un
Meursault)? Non era forse in uno di
questi gruppi che, dopo averli scopiazzati li hanno sfruttati con più o meno
felicità e libertà? Si può rimproverare
gli insegnanti di aver saputo formare
degli emuli brillanti?
Dark Side of the Moon era un album
iper-prodotto, dall’ispirazione impersonale (per non dire “cosmica”, che potrebbe essere mal interpretato): all’opposto, Wish You Were Here è di una
semplicità sconcertante – niente alte
alchimie sonore, niente stratagemmi
di studio, se non molto aneddotici o
sotto forma di ammiccamento - è anche un disco dall’ispirazione molto
personalizzata, narcisistica perfino.
Lo show-businness non è implicato
se non attraverso l’esperienza che ne
hanno fatto personalmente, che ne
hanno fatto loro stessi o il “Madcap
Laughter” Syd Barrett (Crazy Diamond). I testi sono belli e investiti di
una grande emozione, tanto più grande che si dissimula sotto un’ironia
quasi disillusa. La musica è semplice e
evidente, fatta, ad eccezione di Welcome to the Machine che si distacca dagli altri pezzi, da una serie di assoli uno
più convincente dell’altro, di stili di
un’estrema diversità, ma sempre con
questa impressione, per chi ascolta, di
una meravigliosa facilità, di una chiarezza evidente, e poi questo apice che è
l’assolo di chitarra di David Gillmour
su Have a Cigar cantata-gridata-pianta
da una Roy Harper in ottima forma.
Via, questa l’avremo nei nostri juke
box! Con Have a Cigar e Welcome to
the Machine, arriva la conferma di
quel che già si sapeva, quello che ci
avevano già ampiamente dimostrato
More, Ummagnumma o Dark Side
of the Moon, cioè del fatto che i Pink
Floyd possono fare di tutto con la stessa felicità. Insomma, non abbiate nessuna paura, è proprio un Pink Floyd:
un investimento senza sorprese.
40
OUTSIDER
PINK FLOYD
PINK FLOYD E L’ITALIA
Non si può diche che la band abbia amato molto l’Italia. Ma a parte che non dipendeva da loro ma dai promoter, noi eravamo
indietro dieci anni rispetto al resto d’Europa. Così nei 3 anni 68-69-70 la band girava allegramente l’’Europa ma senza toccare i
nostri lidi. Unica eccezione i due veloci concerti romanidel 1968, i giorni, ma senza pubblico, a Pompei nel 1971 (si raccomanda la riedizione denominata Director’s Cut, pubblicata in DVD solamente nel 2003) e le due date Brescia/Roma del 1971. Poi
l’oscurità completa anche dovuta agli ‘anni di piombo’ che impedirono concerti nel nostro paese fino a fine anni settanta.
Torneranno solo nel 1988.
Ecco i 25 concerti italiani.
18 aprile 1968, Roma, Piper Club
(due set 17/22)
19 aprile 1968, Roma, Piper Club
(due set 17/22)
(esiste 1 bootleg in vinile poi rimasterizzato su CD con etichetta Black Panter,
il CD si chiama Fountains of Rome)
6 maggio 1968, Roma, Palasport
e/o Palazzetto e/o Piper (Pop Festival)
19 giugno 1971, Brescia,
Palazzo Manifest. Artistiche
20 giugno 1971, Roma, Palasport
4/5/6/7 ottobre 1971, Pompei,
Anfiteatro romano (senza pubblico)
6 luglio 1988 Torino, Stadio Comunale
8 luglio 1988 Braglia (MO), Stadio
9 luglio 1988 Braglia (MO), Stadio
11 luglio1988 Roma, Stadio Flaminio
12 luglio 1988 Roma, Stadio Flaminio
16 maggio 1989, Verona, Arena
17 maggio 1989, Verona, Arena
18 maggio 1989, Verona, Arena
20 maggio 1989, Monza, Autodromo
22 maggio 1989, Livorno, Stadio
23 maggio 1989, Livorno, Stadio
25 maggio 1989, Cava de’ Tirreni,
Stadio
26 maggio 1989, Cava de’ Tirreni,
Stadio
15 luglio 1989, Venezia, P. San Marco
13 settembre 1994, Torino, Stadio
15 settembre 1994, Udine, Stadio
17 settembre 1994, Modena,
Festa dell’Unità
20 settembre 1994, Roma, Cinecittà
21 settembre 1994, Roma, Cinecittà
* Vale la pena di soffermarsi sul ‘Pop
Festival’ di Roma del 5/6/7 maggio 1971, con la ventilata presenza di
Move, Traffic, Ten Years After, Fairport
Convention, Hendrix, Soft Machine,
Byrds, Family, Brian Auger… a cui
andarono circa 400 spettatori, di cui la
metà stranieri in vacanza, e più di 200
carabinieri, che bloccarono il concerto quando i
Move spararono durante
il loro concerto dei fuochi
d´artificio,
ovviamente
lanciando i soliti lacrimogeni all´interno della
struttura.
Il settimanale inglese
‘Melody Maker’ lo definì
“The pop-flop of ´68 ).
Su cosa accadde in realtà,
ancora se ne sa poco. Non
tutti vennero. Di sicuro suonarono Donovan,
Brian Auger con Julie Driscoll, i Move, Nice, Capt.
Beefheart, i Giganti, gli Association, Pink Floyd (che
suonarono sicuramente It
Would Be So Nice e forse
7 minuiti di Interstellar
Overdirve), Fairport Convention. I Byrds furono
OUTSIDER
dirottati al Piper (su You Tube gira un video) a causa della
scarsa quantità di biglietti venduti, qualcun altro (forse) al
Palazzetto dello Sport, vicino alla Stadio Flaminio.
Hendrix, che avrebbe dovuto aprire la manifestazione, arrivò a Roma venti giorni dopo e molti giustamente considerarono quella esibizione al Brancaccio di Via Merulana,
come la giusta e spettacolare conclusione di quel leggendario sfigatissimo primo festival rock italiano del maggio 1968.
Cattiva promozione, niente manifesti, niente articoli sui
quotidiani, che a quei tempi non sapevano neanche cosa
fosse quella musica. Apparve un articolo su “Ciao Big” (l’antesignano di ‘Ciao 2001’) che sotto una foto di Capt. Beefheart così diceva: “Tutti i complessi sfoggiavano abbigliamenti pop: i più anti
conformisti erano
senz’altro quelli di
una band francese
che suonava musica sperimentale
elettronica”.
Su You Tube girano molti video
compreso uno che
unisce Pink Floyd/
Genesis al Piper.
Digitate anche Pink
Floyd/Interstellar
Overdrive/Palazzo
dello sport…. Il 18
maggio 1968 la BBC
mandò in onda un
filmato con le riprese del Piper di circa
un minuto mentre
eseguono in playback It Would Be so
Nice, ritrasmesso da
RaiDue il 3 giugno
2004,
nell’ambito del programma
‘Eventi Pop’.
Le date italiane
del 1971 a Brescia e
Roma, furono organizzate da Franco Mamone con Francesco
Sanavio, in collaborazione con ‘2001’. Faceva parte di un mini
tour europeo. Le prime notizie parlarono
di due concerti il 19 e
20 giugno a Bologna e
Roma anche se si vociferava anche del Palaghiaccio di Milano.
Il CONI però all’ultimo non rese dispo-
41
nibile il Palazzetto dello Sport di Bologna, Milano uguale
con il Vigorelli finchè, a solo 4 giorni dall’arrivo della band,
si trovò il Palazzetto degli Industriali a Brescia. La band alloggiò all’albergo Il Gambero. Nonostante tutto vennero in
5mila. Il giorno dopo partirono per Roma, dove alloggiarono all’albergo Massimo D’azeglio. Suonarono il 20 giugno,
ma senza lo spettacolo delle luci per colpa di uno sciopero
dei dipendenti CONI o per il furto di un Tir (?!?) e tutto il
Palasport era illuminato a giorno con le lampade al neon.
Dopo il concerto Armando Gallo portò la band a rilassarsi al
Titan e pubblicò un lungo articolo su ‘2001’ del 30 giugno, di
fatto rendendo famosi i Pink Floyd. Il giorno dopo partirono
per Londra dove dovevano suonare al Glastonbury Fayre,
poi annullato. Fecero poi Giappone e Australia per tornare in Italia il 4 ottobre per il
progetto Pompei. Si racconta che quando i
tecnici si accorsero che la corrente elettrica
non era sufficiente, fu creata una prolunga
di 3 km e il cavo dovette essere sorvegliato
giorno e notte pe evitare atti vandalici o allacci abusivi, il che ridusse da 6 a 3 giorni i
giorni di registrazione disponibili.
* Il primo 45 pubblicato in Italia fu Se
Emily Play/Scarecrow nel settembre 1967.
Il primo articolo fu pubblicato da ‘Ciao
amici’ il 19 settembre intitolato ’Anche la
musica come droga’, seguito il 26 settembre da un altro su ‘Big’, a firma Armando
Gallo. Il primo 33 a stampa italiana fu
More a fine 1969, seguito da Zabriskie
Point nel marzo 1970 e a seguire nel corso del 1971, in contemporanea del tour e
del ‘lancio’ su ‘2001’, tutti gli altri. The Piper uscì il 22 aprile 1971 con una copertina diversa dal resto del mondo: mostrava
una foto dei quattro Floyd con Gilmour,
scattata nel 1969 davanti ai Kew Gardens
di Londra. Ovviamente il disco è diventato
una rarità.
42
OUTSIDER
PINK FLOYD
GILMOUR E WATERS
CORSI E RICORSI
Il 2 luglio 2005, in occasione del ‘Live 8’, la grande manifestazione musicale organizzata da Geldof per sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla povertà e sui problemi dell’Africa,
i Pink Floyd tornano ad esibirsi nella loro formazione storica, Roger Waters compreso, eseguendo cinque brani: Speak
to me, Breathe, Money, Wish You Were Here, Comfortably
Numb. Durante l’esecuzione di Wish You Were Here Waters
ricorda Syd Barrett.
Durante il tour estivo di Waters dello stesso anno, negli spettacoli in Francia, Islanda, Nick Mason si aggrega al gruppo
nella seconda parte dei concerti. Sempre Mason, in seguito, si
aggiunge a David Gilmour e a Richard Wright nella terza serata conclusiva del Tour on an Island del chitarrista alla Royal
Albert Hall il 31 maggio 2006, ricomponendo i Pink Floyd per
due canzoni: Wish You Were Here e Comfortably Numb. Si
tratta della prima apparizione del trio dopo il Live 8.
Il 7 luglio 2006 muore Syd Barrett per un tumore al pancreas.
I sui ex colleghi Pink Floyd reagiscono laconici alla notizia dichiarandosi “tristi e sconvolti”: “Syd era la luce che ci guidava
nei primi anni del gruppo e il suo lascito continua a ispirarci”. Secondo Gilmour era epilettico, secondo Wright fu l’acido
il fattore scatenante della sua follia (”Di certo l’acido ha avuto qualcosa a che fare con tutto ciò. Il punto è, non sappiamo
se è stato l’acido ad accelerare il processo che avveniva nel suo
cervello, oppure se ne sia stata la causa. Nessuno lo sa. Io sono
sicuro che le droghe un effetto lo hanno avuto”).
Waters e i Pink Floyd incrociano nuovamente le proprie
strade il 10 maggio 2007, in occasione di un concerto organizzato in memoria di Syd Barrett, morto l’anno precedente.
Nonostante l’attesa dei fan, però, i quattro non suonano insieme: Waters si esibisce nella prima parte dello show con Jon
Carin, eseguendo la sua Flickering Flame, brano che affronta
il tema di un amico morto, i tre Floyd suonano subito dopo
la vecchia Arnold Layne, senza Waters, accompagnati dallo
stesso Carin e dal bassista degli Oasis, Andy Bell.
Lunedì 15 settembre 2008 viene annunciata la morte di Richard Wright, avvenuta a 65 anni dopo una breve lotta contro
il cancro. Lo stesso giorno David Gilmour dice di Wright:
“Nessuno può sostituire Richard Wright. È stato il mio partner
musicale e amico. Nelle discussioni su chi o cosa fossero i Pink
Floyd, il contributo enorme di Rick è stato spesso trascurato.
Era gentile, modesto e riservato ma la sua voce profonda e il
suo modo di suonare erano vitali, magiche componenti del
nostro riconoscibile sound. Non ho mai suonato con nessuno
come lui. L’armonia delle nostre voci e la nostra telepatia musicale sono sbocciate nel 1971 in Echoes. A mio giudizio tutti i
più grandi momenti dei Pink Floyd sono quelli in cui lui è a
pieno regime. Dopo tutto, senza Us and Them e The Great Gig
in the Sky, entrambe composte da lui, cosa sarebbe stato The
Dark Side of the Moon? Senza il suo tocco pacato l’album Wish
You Were Here non avrebbe funzionato molto. Nei nostri
anni di mezzo, per vari motivi lui ha perso la sua strada per
qualche tempo, ma nei primi anni novanta, con The Division Bell, la sua vitalità, brillantezza e humor sono ritornati
e la reazione del pubblico alle sue apparizioni nel mio tour
del 2006 è stata tremendamente incoraggiante, ed è un segno
della sua modestia che quelle ‘standing ovation’ siano giunte
a lui come una grande sorpresa (sebbene non al resto di noi).
Come Rick, non trovo facile esprimere i miei sentimenti con
le parole, ma lo amavo e mi mancherà enormemente”.
Il 10 luglio 2010 Gilmour e Waters decidono di tornare a suonare insieme, a distanza di cinque anni dall’ultima esibizione al ‘Live 8’, in occasione di un concerto di beneficenza per
la Hoping Foundation. Gilmour, per ricambiare la partecipazione, partecipa alla data del 12 maggio 2011 del tour mondiale di The Wall a Londra suonando Comfortably Numb
insieme a Waters. Al termine del concerto, durante i saluti e
nel brano finale Outside the Wall, oltre a Roger Waters e al suo
gruppo, erano presenti sul palco anche David Gilmour e Nick
Mason. Questa è stata con ogni probabilità l’ultima apparizione in pubblico degli ultimi tre componenti rimasti in vita dei
Pink Floyd.
ABBONATI AD OUTSIDER PER IL 2015
(dal prossimo numero questo giornale esce dal circuito delle edicole)
16 CENTESIMI AL GIORNO PER REGALARTI UN ANNO DI OUTSIDER
COMODAMENTE A CASA TUA. TI SEMBRA TROPPO? O TROPPO POCO?
Per farti un’idea di quello che ti aspetta nel 2015: ZZ top, Television, Jackson Browne, Gene Clark,
David Crosby, Canned Heat, Kraut rock, Spirit, John Hartford, Bobby Womack, Richard Thompson,
Soft Machine, Bruce Springsteen, Lynyrd Skynyrd, Genesis, Randy Newman, Jonathan Richman…
OUTSIDER
FUORI DAL MUCCHIO
“Dove la musica
è ancora una
ragione di vita”
DAL PROSSIMO NUMERO OUTSIDER È SOLO PER ABBONAMENTO.
Torniamo al nostro progetto iniziale, che era quello di fare un giornale di alta qualità solo per abbonamento.
Avete tempo fino ai primi giorni di gennaio per trovare 60 euro (5 euro al mese), e ricevere comodamente a
casa la vostra copia. 16 centesimi al giorno che allungano la vita di questo giornale fino a che non saremo tutti
vecchi e appagati di rock.
Niente più ‘Outsider Point’ dunque, né edicole. Manterremo solo la distribuzione nei tre aeroporti di Linate/
Malpensa/Fiumicino.
Grazie. Max Stèfani
ABBONAMENTI
11 NUMERI
11 NUMERI
11 NUMERI
CARTACEO
PDF
CARTACEO + PDF
60 euro
25 euro
70 euro
TROVA UN NUOVO ABBONATO.
Risparmierai il 50% sul tuo.
Se già fai parte della famiglia OUTSIDER,
ti sarà prorogato di altri 6 numeri.
44
OUTSIDER
PINK FLOYD
PHIL MANZANERA
di Graham Reid
Phil Manzanera – famoso chitarrista dei Roxy Music, produttore e amico di lunga durata di David
Gilmour dei Pink Floyd – ci racconta con sincerità e con ironia dell’esser stato il co-produttore del
disco d’addio dei Pink Floyd, The Endless River. Phil ci parla anche del suo originale coinvolgimento
su invito di Gilmour, di come ha costruito un arco musicale e narrativo dalla musica disponibile e la
fine di un gruppo icona del rock.
“Ho pensato che questo fosse per gli appassionati. Non abbiamo cercato di attirare nuova gente”. Phil Manzanera
ride quando parla dei quasi due anni trascorsi a mettere
insieme il nuovo disco dei Pink Floyd, The Endless River.
Circa 30 mesi durante i quali non è successo molto tra il due
membri rimanenti dei Floyd, David Gilmour e Nick Mason. L’album giunge con la forza della stima accumulata dalla lunga carriera dei Floyd dai giorni lontani con Syd Barrett, passando attraverso Dark Side of The Moon, la guida
del bassista e compositore Roger Waters verso The Wall, e la
presa di controllo del chitarrista Gilmour a trent’anni dall’abbandono di Waters. In seguito alla morte del tastierista Rick
Wright avvenuta nel 2008, pareva
arrivato il tempo per i Pink Floyd,
per un nuovo album a vent’anni
dalla pubblicazione dell’ultimo
disco The Division Bell. Il gruppo
propone un addio elegante con The
Endless River, un disco principalmente strumentale che ti conduce in
modo sereno verso Sum il brano che
apre la “seconda parte”, con uno dei
brani più classici e apertamente “alla
Pink Floyd”. In un mondo inondato di cinguettii, post di Facebook e
fughe di notizie, The Endless River,
iniziato con il lavoro di Manzanera
nel 2012, è rimasto ben occultato finché la moglie di Gilmour e paroliere
Polly Samson, ha rotto il silenzio su Twitter lo scorso luglio.
Phil Manzanera (vero nome Philip Geoffrey Targett-Adams),
a lungo nei Roxy Music, come detto, ed amico di David Gilmour fin dai tempi delle superiori, anche se David era in effetti compagno del fratello grande di Phil, sorride pensando
a quanto tempo ci sia voluto per mettere insieme 53 minuti.
Nell’era di streaming libero e di scarico gratuito, un nuovo album dei Pink Floyd pare roba d’altri tempi.
The Endless River è concepito come composto da quattro parti, ognuna della lunghezza di una facciata di vinile ed è stato
lanciato in Londra con uno spettacolo di luci psichedeliche di
Peter Wynne-Wilson che fece il medesimo lavoro al famoso
Club UFO nei tardi anni sessanta, dove i Pink Floyd suonavano lunghe maratone di improvvisazioni e suoni sballati. Ma
un nuovo album dei Floyd è una grande scommessa, come ci
dice, pensando al peso delle attese quando fu inizialmente invitato da Gilmour ad ascoltare le registrazioni del gruppo - Gilmour, Mason e Wright – che improvvisavano nel corso delle
sessioni per The Division Bell e gli furono affidate venti ore di
nastri da comporre con una logica musicale.
Mi è stato spiegato che sei stato approcciato per scegliere i brani ed hai deciso di ascoltare ogni singolo estratto
da The Division Bell, giusto ?
Sì, David ha detto solo: “Questo è il materiale, potresti provare
ad ascoltarlo e vedere se c’è qualcosa di buono qua dentro?”.
Così quando sono andato in studio su Astoria, la barca/studio galleggiante di Gilmour dove c’erano due ingegneri del suono, Andy
Jackson e Damon Iddins mi sono
sentito dire “Non ti preoccupare, avevamo già selezionato una cosa che
avevamo chiamato The Big Spliff, circa vent’anni fa, ascoltati questa”....ed
io ho detto loro che non volevo ascoltarla per farmi condizionare e che avrei
voluto ascoltare, invece, ogni singolo
brano che era stato registrato. Mi risposero: “Stai scherzando, sono venti ore
di materiale e lo conosciamo perfettamente” così ho detto loro “Bene voi lo
conoscete, ma io non l’ho mai ascoltato!”. Così siamo partiti da lì.”.
Un saggio avrebbe detto : “Datemi The Big Spliff e vedremo di farlo funzionare”. Perché quindi ti sei messo
ad ascoltarti ogni cosa?
È una questione di fonti empiriche. Quando fai una ricerca te
ne vai indietro ai documenti originali ecco perché ho deciso di
partire dall’inizio della vicenda. Ho pensato che ci sarebbero
state cose che mi sarebbero piaciute e che non sarebbero piaciute a loro ma non volevo saltarle. Non volevo essere indirizzato, volevo ascoltare tutto... così adesso so dove hanno sotterrato gli scheletri, che è una analogia poco corretta...mi spiace...
taglia via questa espressione...ho preso il mio notebook ed ho
detto: “Perfetto iniziamo dal principio”, ed ogni volta che veniva fuori qualcosa che mi piaceva me la segnavo e pensavo:
“Che ci facciamo? Come potremmo utilizzarla?”, la mia testa
cercava di lavorare in questo modo, per farla diventare ascol-
OUTSIDER
tabile voleva dire renderla più breve, così ho iniziato a pensare
quale fosse il modo più semplice possibile per poterci riuscire
... ed ho pensato a quattro facciate dei vecchi dischi in vinile.
La musica classica possiede movimenti di circa dodici minuti
di lunghezza così ho pensato che avrei potuto avere quattro
estratti da tredici minuti, ecco perché siamo partiti dalla prima facciata, mettendo un pezzo qua e un pezzo là, saldandoli
insieme nonostante la loro reticenza a cominciare in questo
modo. Nella mia testa mi sono costruito una storia di quello
che stava avvenendo, dandogli una logica narrativa. Alla fine
di sei settimane sono andato da David e gli ho detto che era
tutto qua, lunga quattro facciate e gli ho riferito il mio racconto, quello che avevo scritto per cui avevo preparato delle immagini. Lui si era dimostrato preoccupato dal mio racconto ma
ci aveva visto delle possibilità, così mi disse di suonarlo a Nick
Mason. Lo feci ed anche lui ci vide delle potenzialità. Pensai
che fosse una bella cosa.... ma poi non accadde niente per nove
mesi. Un tipico atteggiamento rallentato dei Pink Floyd. Ho
pensato che David stesse cercando di farlo funzionare, capire
se avesse potuto diventare un disco. Aveva molte domande in
testa finché non coinvolse Polly Samson, sua moglie, che è più
di una collaboratrice, come Kathleen Brennan lo è con Tom
Waits; Polly aveva scritto testi per The Division Bell.
Lei disse di farlo sentire a Youth dato che David aveva fatto
questo disco di musica ambient, Metallic Spheres, con lui e
lui era un grande fan dei Pink Floyd. Lui lo ascoltò, gli piacque e questo finì con l’incoraggiare David. David mi disse che
gli piacevano parti del mio lavoro e parti delle idee di Youth
così coinvolse Nick e iniziò a lavorare insieme. Nel gennaio di
quest’anno – e ricordati che quando avevo iniziato era l’agosto
del 2012 – eravamo nel suo studio a Hove, vicino a Brighton
e David prese controllo della cosa. Si rese conto che avevo
elaborato un metodo di lavoro e di conseguenza avrebbe inserito estratti di cose che gli piacevano tirando via cose che
non amava. Così decise di occuparsene maggiormente, come
avrebbe dovuto. La cosa divenne un progetto dei Pink Floyd,
Nick venne e aggiunse la batteria e tutto è stato terminato solo
alcune settimane fa perché ci sono stati così tanti cambiamenti
su dove certi inserti dovevano essere fatti, se avessero dovuto
essere più brevi o più lunghi. Ma a un certo punto, è arrivato il
termine di scadenza.”.
Hai pensato in termini di quattro facciate dei vecchi
dischi; lo hai fatto perché eri consapevole che i fan dei
Floyd acquistano ancora dischi ? Loro amano dischi
come Dark Side, non molto i cd…
Certamente. Sin dall’inizio ho pensato “Cosa vorrebbe ascoltare un fan dei Pink Floyd?”. Ed io sono un appassionato dei
Floyd di tutti i differenti periodi, da quello di Syd al periodo di
Roger... mi piacciono tutti i differenti elementi, ma ho pensato “Questo andrà in mano ai fan. Non cerchiamo di catturare
nuovi appassionati”. Dato che era venuto fuori che questo sarebbe stato un modo per dire addio, dire definitivamente addio
come un tributo a Rick. Ma sembrava una crociera lenta verso
il tramonto piuttosto che uscirsene con i botti finali. Si trattava
di un saluto raffreddato, ibrido. Quasi un documentario che
voleva catturare quel momento, l’ultimo momento in cui i tre
avevano suonato insieme nel modo in cui non avevano più
45
fatto da Wish You Were Here e dal periodo precedente. Era il
modo in cui improvvisavano e cercavano ispirazione usando
le proprie tonalità e la loro gamma di suoni facendo jam per
creare qualcosa dal nulla. Cercavo di trovare una ragione a
tutto questo.... perchè ero assolutamente consapevole dell’eredità e del contesto delle cose non volendo lasciare nulla di
inappropriato, dato per scontato che non ci sarebbe stato Roger e questo non sarebbe nemmeno avvenuto in prospettiva.
Questo disco riguarda questi tre che hanno fornito il contesto
musicale per le canzoni di Roger ed anche le canzoni di David
e Polly quando erano in tour. Le loro sonorità sono state principalmente portate avanti su questo disco.
Penso ai Pink Floyd come a un gruppo strumentale con
parti cantate, ma ci sono enormi passaggi strumentali
su tutti i loro album. Ho avuto la possibilità di ascoltare il disco e mi è sembrato un elegante addio, forse per i
fan più vecchi. Tu hai tenuto i ragazzini e gli altri fuori...
(Ride) Mettiti le cuffie. Ci piace chiamarla una immersione.
Non è per tutti, è un po’ come la musica classica per certi versi; devi sederti e ascoltare lunghi estratti musicali. Non puoi
ascoltarne solo un minuto. Non è musica classica, non sto
dicendo questo, ma è il medesimo modo di percepirla. Una
esperienza differente. Specialmente per questa era in cui tutti
ascoltano brevi pezzetti su Youtube o Spotify e c’è questo atteggiamento dove ognuno si fa la propria playlist mettendo
Phil Manzanera e David Gilmour (Photo by Tomos Brangwyn/WireImage)
46
OUTSIDER
PINK FLOYD
insieme un pezzo qui ed uno là... questo è un modo di ascoltare più antico: necessita di mettersi a sedere, lasciare tutto da
parte e sognare.”
Sembra che ci sia una lunga introduzione nella prima
parte, poi i vecchi Floyd escono con la seconda parte e
quello è maggiormente l’archetipo dei Pink Floyd che
la gente conosce e ama. Roba più familiare.
Ci sono diverse possibilità. Puoi ascoltare la seconda facciata al
posto della prima; io ho suggerito molte opzioni, ma alla fine
David ha scelto quella. Avevo messo su differenti cose in punti
diversi, ma lui ha poi scelto di fare sua la sequenza: un disco
dei Pink Floyd e non una versione di Manzanera di un disco
dei Pink Floyd. Io cercavo in primo luogo di far uscire il suono
dell’organo Farfisa di Rick dal primo disco. Si chiama il Duo
Compact Farfisa che passa attraverso un Binson Echo e alla
fine l’ho trovato. È quello che dà inizio alla seconda facciata...
lui non l’aveva utilizzato dai tempi di Dark Side. Poi volevo un
po’ di quel suono di corni francesi che utilizzò molto quando
registrarono Wish You Were Here. Ne ho trovato un po’ così
ho iniziato a spingere per averli; poi ho trovato una jam che
mi ricordava molto Echoes o Live At Pompei ed ho pensato
“È grande ma non ci deve essere una parte di batteria, qua”...
poi ho trovato delle parti dove Nick Mason si stava scaldando,
ne ho fatto un loop e l’ho messo sotto come una sorta di forma
libera di percussioni... Sostanzialmente mi sono preso alcune
diaboliche libertà di mostrare a David cosa poteva essere fatto. Ho aggiunto un basso ed il resto. Beh, tutta la mia roba è
stata sostituita dalla chitarra di David, ma l’idea iniziale
era che avresti potuto prendere delle parti ed utilizzarle,
come utilizzare la moderna tecnologia ed i software come
se fossero degli strumenti. È una cosa che ha una sua storia, cose che facevamo con Eno: utilizzare il mixer ed ogni
sorta di meccanismo che fosse stato inventato per ricreare una versione avanzata ed un suono interessante. Una
cosa che oggi puoi fare molto più facilmente con i software computerizzati.
Hai nominato Eno, i suoi lavori ed i tuoi, ma David
mi sembra ancora il genere di musicista che sa come
suonare il suo strumento. Poi c’è un altro livello
dove gente come te, da un punto di vista produttivo, arriva su un altro piano di lavoro e differente
modo di pensare e cerca di modificarne l’approccio.
Quello che abbiamo fatto e tentato di fare è stato di dargli
delle opportunità dicendogli che avrebbe potuto sfruttarle
o scegliere di fare a modo suo. Gli dicevamo “Che ne pensi
di questo?”. E se a lui pareva eccessivo, diceva semplicemente di no. Così capivamo di essere arrivati al limite. Ma
questa era la mia funzione. Lui avrebbe potuto prodursi e
fare tutto da solo, ma è una cosa noiosa ed è meglio avere
altra gente intorno. È differente collaborare con altri. L’insieme è sempre migliore di ogni singolo, come loro stessi
hanno dimostrato, il risultato è differente.
Vorrei chiederti di un brano in particolare, Anisina, l’unico con un sassofono, una ballata diretta
che necessiterebbe di testi...
Ho trovato alcuni brani che suonavano come canzoni senza
testi; una è divenuta Louder Than Words ed una era Anisina.
Ho sempre detto: “Ti prego scrivile un testo”. Polly stava per
farlo per entrambe, ma una volta scritti i testi per Louder Than
Words ed il loro concetto, decise che non servivano altri testi. E
mettendola alla fine del disco, non è solo un commento al disco stesso, ma uno sguardo alla loro esperienza professionale.
Da un punto di vista concettuale era meglio avere un solo brano con testi. Di conseguenza Anisina aveva bisogno di qualcosa di aggiuntivo, per questo è stato aggiunto il sax, come una
sorta di pianto per Rick, in fondo.
Chi suona il sax?
Un mio amico che si chiama Gilad Atzmon che ha suonato su alcuni miei dischi e con Robert Wyatt. Un sassofonista israeliano, un genio. La gente si ricorderà del suo modo di
suonare su un famoso brano di Ian Dury, Hit Me With Your
Rhythm Stick.”.
Vorrei chiederti se quando pensavi a questo progetto
eri consapevole dell’eredità dei Pink Floyd, e sapevi
che questo sarebbe stato il loro ultimo disco...
David me lo disse chiaramente...
Ci sarebbe stato il peso dell’attesa ma anche un senso di
sollievo per David. Come hai vissuto questa emozione?
Ho pensato che ci sarebbe stato questo senso di sollievo. David
mi disse: “Questo è il disco di addio e lo faremo in modo sere-
OUTSIDER
no, ma se hai intenzione di tirare fuori delle canzoni, sto per
fare il mio nuovo disco da solista e lì ne avrai quante ne vuoi,
il prossimo anno”.
Il peso dell’attesa...i fans dei Pink Floyd sono vent’anni
che attendono...
È una grande scommessa e mi hanno detto che è il disco che ha
raggiunto il maggior numero di copie vendute in anticipo su
Amazon...battendo persino gli One Direction ! E i Coldplay,
tutti campioni di vendite. Non ho idea di cosa significhi, ma
sicuramente è merito del nome. Ci sono gruppi che sono usciti
negli ultimi 40 anni e che sono divenuti un marchio di garanzia, sia che si tratti dei Blur, Oasis, Pink Floyd, Roxy Music,
The Rolling Stones...hanno quel qualcosa in più al di sopra
dei singoli membri. È un questione di potenza di immagine :
il disco dei Floyd, il fan dei Floyd, un concerto dei Floyd...non
stiamo parlando solo di musica.”.
Capisco che sia un argomento delicato, ma il grande
assente è Roger Waters. Che tu sappia ha fatto qualche
commento sul disco dei Floyd?
Per quello che so nient’altro al di fuori dell’aver detto che non
è stato coinvolto. Ho letto una cosa dove ha spiegato che ha abbandonato il gruppo quasi trent’anni fa e che è contento di fare
47
le sue cose. David ha detto qualcosa qualche giorno fa: “Avevo trent’anni quando Roger se n’è andato, adesso ne ho 68”. Ci
siamo dimenticati di quanto tempo sia passato. Non sarebbe
stato corretto comunque per Roger essere coinvolto dato che
quando loro hanno registrato queste jam lui non era presente
da tempo.
Ci sono delle belle cose nel disco; On Noodle Street è un
brano ambient molto interessante.
Sì, lo è. Spero che piaccia ai fan, dato che è stato fatto apposta
per loro. Un tributo a Rick che calza a pennello e che proviene
dal luogo migliore.
Un ultimo commento: onestamente non mi piace la copertina del disco.
(ride) Non sono responsabile per la copertina. Lo sono solo
per parte della musica. Posso parlarti di alcune delle copertine dei Roxy Music che amo, se desideri...ma è tutto quello
che potrei dirti...”
Il solito, diplomatico, Phil Manzanera...
© IFA - Amsterdam, 2104
48
OUTSIDER
LUCINDA WILLIAMS
2010 (Rick Madonick/Getty Images)
OUTSIDER
SOUTHERN WOMAN
LUCINDA
WILLIAMS
TROPPO COUNTRY
PER ESSERE ROCK
TROPPO ROCK PER
ESSERE COUNTRY
di Madeleine Schwarts // The Believer // 2012
È andata in tour con icone come Bob Dylan e Tom Petty, ha inciso
con leggende come Elvis Costello e Steve Earle, è stata nominata miglior autrice d’America dalla rivista Time, e ha messo assieme
uno dei più impressionanti corpus di album su questa sponda del
rock&roll. Ma provate a dire a Lucinda Williams che è un’onore
parlare con lei e risponderà con un confuso silenzio, un altezzoso
scherno e poi un semplice, trascinato “Okaaay”.
Il nuovo album inciso dal vivo (da noi presentato lo scorso numero di Outsider) è una perla da non perdere.
Non è mai venuta ne mai verrà in Italia perchè costa 25mila euro
e quindi da noi un concerto ‘a perdere’, ma se dovesse arrivare vicino ai nostri confini… sapete che non potrete perderlo.
49
50
OUTSIDER
LUCINDA WILLIAMS
Che parlare con lei sia – in effetti – un
onore è un fatto che non può non esserle chiaro, ma Williams non dà a
vedere di saperlo. Anzi, si butta dritta
nella conversazione, speziando le sue
risposte con dei “lo sai”, (come se foste
vecchi amici e tu lo sapessi davvero),
chiudendo le sue risposte con una risatina del sud (anche la sua risata è strascicata), e di tanto in tanto chiedendoti
se puoi aspettare un attimo mentre lei
parla con suo marito, il manager Tom
Overby (“Tom sta uscendo a pranzo
con uno dei suoi amichetti dell’industria discografica... Gli ho chiesto se
potesse andarsi a cambiare la camicia,
perché ha la stessa camicia che indossava ieri”).
ghi, tristi viaggi attraverso il Sud—che
lei mette in scena con meticolosa precisione. E c’è sempre un taglio determinato nella sua pensosa, graffiante
voce, che stia cantando con rabbia o
con totale disperazione; si avverte l’energia di un torrente che passa attraverso un minuscolo forellino.
Nata in Louisiana nel 1953, è cresciuta partecipando ai laboratori di poesia e alle letture di suo padre, il poeta
Miller Williams. Ha passato qualche
decennio girando per il paese, suonando nei bar e per strada, e si è costruita un pubblico prima ancora del
suo primo successo commerciale, Car
Wheels on a Gravel Road (1998), il suo
quinto album.
I. LE FOGLIE CADONO E CADONO AL
SUOLO
Come hai scoperto in che modo
usare la tua voce?
Quando ho cominciato a suonare la
chitarra e cantare, avevo circa dodici
anni, andavo per i tredici. I miei modelli allora erano i cantanti folk. Avevano tutti queste voci ed estensioni
davvero acute e piacevoli, come Judy
Collins e Joan Baez, e in seguito,
chiaramente, Joni Mitchell e Linda
Ronstadt. Ho deciso presto che avrei
dovuto imparare a scrivere le canzoni
molto, molto bene, perché ero convinta di non poter competere con loro
come cantante. Non credevo che fosse
1992 (Jack Vartoogian/Getty)
No Depression del 1988 fu
un album seminale, che
non solo annunciò l’arrivo di una voce di grande
significato per le arti e la
letteratura americana, ma
anche la nascita di un nuovo genere: l’alt country.
Ma Lucinda Williams non appare
soltanto amichevole: è anche incredibilmente felice. Questa non è soltanto
una specie di sorpresa: è una bella sorpresa. Leggete le interviste fattele negli
anni passati, e tonnellate di queste faranno riferimento al trarre ispirazione
da relazioni orribili e tortuose separazioni: le sue canzoni di rottura regolarmente inappuntabili sono il risultato
di regolari nuove ferite emotive. La
sua ritrovata felicità, senza dubbio, ha
molto a che fare col suo recente matrimonio con Overby, anche se lei è
pronta a confermare che essere felice
non priverà le sue canzoni della sua
tradizionale grinta.
Le canzoni di Lucinda Williams sono
come un catalogo di intime sofferenze,
principalmente di tipo romantico—
poeti suicidi, amori inappagati, lun-
OUTSIDER
quello il mio punto di forza.
È stato così sinché non ho scoperto
Bobbie Gentry—è stata una delle
prime cantanti ad avere una voce
bassa, roca, con cui ero davvero in
sintonia—e quando ho poi scoperto
alcune cantanti blues come Memphis Minnie e alcune altre cantanti di blues del Delta, con le loro voci
graffianti, diverse, che ho cominciato
a trovare altri modelli
in cui identificarmi.
Ricordo che una volta
ero al ristorante con
Emmylou Harris, e
un paio di altre persone, e c’era qualcuno
che cantava un’aria
d’opera leggera, e io mi
sono girata verso e Emmylou e ho detto: “Oh,
senti che estensione!
Mi piacerebbe saperlo
fare con la mia voce!”.
E lei ha detto: “È quella la bellezza della tua
voce—hai il tuo stile
personale. Devi solo
imparare a lavorare
con i tuoi stessi limiti”.
Com’eri da bambina?
Sai, ero una bambina
che stava al chiuso. Mi
piaceva restare in casa.
Ho avuto la mia razione di campane, ruote,
alberi da scalare e cose
di quel genere, mi piacevano le robe domestiche come disegnare,
leggere e scrivere. Ho
cominciato a scrivere
brevi racconti e poesie
non appena ho imparato a leggere e scrivere. Penso che avessi sei
anni. E poi quando ne ho avuti undici,
dodici, e durante l’adolescenza, ascoltavo dischi tutto il tempo, e avevo una
chitarra. Ho cominciato a ricevere lezioni di chitarra a dodici anni. Era diventato tutto il mio mondo. Di solito
ascoltavo dischi e andavo nei negozi
di musica a cercare dei libri di testi, e
ne ho ancora una grossa collezione.
Cercavo di trovare le canzoni che erano sugli album, perché non sapevo
leggere la musica. Quindi imparavo i
testi lì e le melodie ascoltando i dischi,
sedevo col mio libro e imparavo i brani, lo sai, prima di imparare a scrivere
e tutto il resto.
Ho cominciato a cimentarmi con la
scrittura quando avevo tredici anni o
giù di lì. La prima canzone che ricordi
di aver scritto si chiamava The Wind
Blows. All’epoca non avevo colto il
doppio senso [ndt: “the wind blows”
può essere tradotto sia come “il vento
soffia” che come “il vento fa pompini”].
Era molto tipo Peter, Paul and Mary,
una specie di canzone folk. Era tipo:
Il vento soffia e soffia per il paese e la
gente in paese lo sente soffiare.
Il vento soffia e soffia per il paese e la
gente in paese lo sente soffiare...
Le foglie cadono e cadono al suolo.
Na na na na na na na na na…
51
Ricevevi ancora molti incoraggiamenti?
Beh, lo sai, venivo incoraggiata dalla
mia famiglia, specialmente da papà,
dai suoi amici e gente simile. Ero troppo giovane per suonare nei bar o ovunque. Sedevo in giro per casa. Io e i miei
amici suonavamo. Mi pare ci fosse una
gara per nuovi talenti, a scuola, e noi
siamo andati a cantare qualche canzone. Avevo una specie
di spinta e di ambizione
tutte mie, qualcosa che
continuava a spingermi
avanti.
Verso cosa ti spingeva?
Volevo riuscire a guadagnarmici da vivere.
Il mio grande sogno era
quello. Non necessariamente essere famosa o
altro. Pensavo soltanto:
“Non sarebbe fantastico
se non dovessi avere un
lavoro vero?”. Papà mi
ha incoraggiato ad andare al college e laurearmi,
perché voleva che avessi
qualcosa di serio su cui
fare affidamento, perché
lui pubblicava libri di
poesia ma insegnava anche scrittura creativa. Comunque sia, sono andata
all’Università dell’Arkansas e ho cominciato lì, poi
ho mollato, ho frequentato un altro semestre poi
ho mollato.
La mia facoltà, quando
ho cominciato non era
musica ma antropologia
culturale. Non so perché.
All’epoca non ero interessata a un’educazione
musicale formale, immagino. Tra un semestre e l’altro—era il
1971 o il 1972—sono andata a New
Orleans, e mi è stato offerto il mio primo show regolare in una piccola taverna nel quartiere francese chiamata
Andy’s—restavano aperti tutta notte.
Penso aprissero alle tre del pomeriggio e chiudessero alle tre del mattino.
In seguito è andato a fuoco. Lo facevo
solo per le mance. A quei tempi potevi cavartela piuttosto bene anche
52
OUTSIDER
LUCINDA WILLIAMS
solo con le mance. Era piuttosto facile
sostentarti come musicista, perché gli
affitti erano economici.
Comunque, mi era stato chiesto di fare
un turno due o tre volte a settimana—
mi pare fosse nel pomeriggio—dalle
quattro alle sei. Era un posto davvero piccolo, proprio su Bourbon Street,
quindi ci passava parecchia gente. Sedevi su uno sgabello, avevi un paio di
microfoni e mettevi un vaso davanti a
te. E ragazzi—ero eccitatissima. Camminavo sulla luna! Era questo quello
che volevo fare! Ho chiamato papà e
gli ho detto: “Papà, invece di tornare
a scuola, voglio restare qui e fare questo”. E lui ha detto OK. Questo è probabilmente stato uno dei primi grossi
punti di svolta, forse il punto di svolta.
II. NON SAPEVANO COSA FARSENE
DI ME
Mi domando, non sei mai stata preoccupata di non raggiungere il successo?
Ti ci è voluto un sacco di tempo per
sfondare nell’industria discografica.
Una volta che ho imboccato quella
strada, la cosa era fatta. Ero molto brava a essere al posto giusto nel momento giusto—ho seguito il mio istinto.
Sono arrivata a L.A. alla fine dell’84.
Quello è stato un altro punto critico.
Prima di allora non conoscevo niente
del mercato musicale. Non avevo un
manager, un avvocato, un agente, una
band. Suonavo con chiunque fosse disponibile, di solito solo io e un chitarrista. Quando sono arrivata a L.A., è stato
lì che ho fatto la mia prima esperienza
con l’industria discografica e le etichette e tutto quel genere
di cose. Ho cominciato a
suonare in alcuni posti,
e allora una band ha cominciato a formarmisi
attorno e qualche agente
ha cominciato ad annusare l’aria. Ma non sapevano cosa farsene di me,
perché, come ho scoperto
in seguito, ricadevo nella
spaccatura tra il country e
il rock. Non esisteva ancora l’Americana, non esisteva l’alternative country. Tutto quel tipo di roba
per il quale ora esiste un
grosso mercato e un intero genere.
2014 - Rodney Crowell, Laura Cantrell, Joe Henry, Lucinda Williams, Grant-Lee Phillips (Getty)
2004 - Raul Malo, Norah Jones, John Doe, Lucinda Williams e Steve Earle (Photo by Lee Celano/WireImage)
La gente come te lo faceva sapere?
Avevo quello che si chiamava “un contratto a
progetto”, in cui loro ti
davano una certa quantità di soldi per camparci
sei mesi, e tu avresti fatto
una demo. In questo caso
era per la Sony, o per la
CBS Records, comunque
si chiamasse, prima che
tutte le etichette cominciassero a fondersi. Il capo
dell’A&R si era interessato
a me. Ha detto: “Voglio
farti un contratto a progetto, e pagheremo per
mandarti in studio a incidere una demo. Sistemeremo tutto”. Eccomi lì in
cima al mondo, a pensare:
‘Wow, qui non devo fare
un lavoro normale per sei
OUTSIDER
mesi, tutto quello che devo fare è scrivere canzoni, e, sai, fare una demo’, e
avevo un piccolo appartamento, e ho
pensato: ‘Ragazzi, adesso ce l’ho fatta!’. Perché l’intera premessa era che
sarei andata a incidere la demo, e lui
l’avrebbe portata ai suoi colleghi, e poi
avrebbero deciso se farmi un contratto
discografico.
È stato in quel periodo che ho scritto
buona parte delle canzoni contenute
in Lucinda Williams, come Passionate Kisses, Crescent City e Changed
the Locks. Quelle stesse canzoni erano
quelle che erano state sparate in giro e
ascoltate da diversi addetti all’A&R di
varie etichette, quindi sono andata a
fare la demo, e… mi hanno rifiutata.
La ragione era, dicevano: “Alla Sony
qui a L.A., sono troppo country per essere rock, quindi le abbiamo mandate
a Nashville”, e a Nashville hanno detto: “Sono troppo rock per il country”.
Eccoti servita.
Però avevo questa demo ed era piuttosto buona; avevano partecipato alcuni
ottimi musicisti e tutto il resto. Ho cominciato a farla circolare il più posibile, e ho continuato a suonare in piccoli
bar. Ho avuto un incontro con questo
tizio della Elektra Records, e lui ha detto: “Penso che avresti bisogno di ricominciare da capo e lavorare un po’ di
più sulle tue canzoni”. E io ho detto:
“Beh, come mai?”. E lui: “Le tue canzoni non sono abbastanza formali.
Nessuna delle tue canzoni ha un bridge”. Quello di cui parlava era il modo
formalizzato di scrivere una canzone,
che è strofa, strofa, ritornello, bridge,
strofa, strofa, ritornello, o qualcosa del
genere, e ha detto: “Nessuna delle tue
canzoni ha un bridge”. Beh, molte delle mie canzoni non hanno nemmeno
il ritornello, per quel che vale!
Chiaramente, ero in qualche modo
devastata e incazzata. Ma ero incazzata abbastanza da non ascoltarlo. Se
n’è andato, e io ho subito messo su un
album di Neil Young e l’ho ascoltato.
L’ho esaminato e ho studiato alcune
delle canzoni che ha scritto. Bob Dylan, anche. L’ho esaminato e ho detto:
“Che si fotta, quel tizio! Guarda queste canzoni! Questa canzone di Neil
Young ha soltanto due strofe, non c’è
nessun bridge”. Sono rientrata e ho
semplicemente riconfermato ciò che
già sapevo, e a quello mi sono attenuta. Perché sapevo che questi tizi non
capivano un cazzo.
Hai detto in passato che la tua carriera è stata intralciata da uomini
53
che ti dicevano cosa fare.
Quando dici “uomini che ti dicevano
cosa fare”—cioè, è vero, ma quello che
devi ricordare è che l’industria musicale era ed è ancora prevalentemente
dominata dai maschi. Avrebbe potuto
essere una donna a dirmi
cosa avrei dovuto fare, e io
non avrei, sai… Mi sembra
che la gente ne parli un
sacco, e io guadagno una
specie di credito a essere la
donna forte che tiene testa a
questi tizi, o comunque sia.
Ma davvero non mi piace
darmi tutto questo credito.
Sono forte, ma penso che
all’epoca fosse più cocciutaggine che altro, e una certa paura—avevo questa terribile paura di essere troppo
prodotta. Non volevo suonare commerciale. Non volevo suonare piaciona.
C’è stato un evento che è
capitato quando ho fatto
quel secondo album con la
Folkways, Happy Woman
Blues. Ero a Houston assieme ad alcuni tizi con cui
lavoravo lì. Siamo entrati in
studio e l’abbiamo registrato
in, tipo, tre giorni. Non avevamo un batterista—giusto
un paio di chitarre e un basso. Lavoravamo con questo
tizio—il posto si chiamava
SugarHill Studios—e io
sono tornata in studio l’ultimo giorno per sentire cosa
avessimo in mano. Il tizio
che ci faceva la fonica—era
una specie di combinazione
tra un fonico e un produttore—aveva deciso di far
venire un batterista mentre
noi eravamo tutti via dallo
studio, e aveva messo la batteria sulle tracce! Senza parlarne con me o con nessun
altro! Non ci potevo assolutamente credere. Sono entrata, lui ha acceso tutto e ha
detto: “Ascolta”. E io ero tipo:
“Stronzo che cos’hai fatto?”.
E lui: “Ho pensato che ci
volesse un po’ di batteria.
Non suona bene?” E io ero
54
OUTSIDER
LUCINDA WILLIAMS
tipo: “Non è questo il punto!”. Pensava
di starmi facendo un grosso favore, capito? Ero completamente attonita. Per
non dire che mi sentivo manipolata.
Quello è stato il mio primo passo tra
le manipolatorie, dispotiche braccia
dell’industria musicale e discografica.
Penso che la cosa mi abbia messo sulla
difensiva. Non sapevo sempre spiegare cosa volessi fare in studio, ma sapevo cosa non volessi.
III. “HO INDOSSATO LE MIE SCARPE
DI CUOIO ROTTE”
Sei molto brava a scrivere di sesso—dell’apprezzare il sesso e volerlo.
Sì! Sono sempre stata cristallina, in
merito. Ne do il merito alla mia educazione. Non mi è mai capitato di
non chiedere e non volere qualcosa,
o di non essere in grado di ottenere
qualcosa, solo perché ero una donna.
Sono stata incoraggiata ad avere una
carriera—non necessariamente a sposarmi, avere dei figli e roba simile. Mi
sorprendeva quando la gente cominciava ad ascoltare le mie canzoni ed
era tipo: “Wow! Questa è davvero una
porca”. Come quella canzone, Essence,
sai? Per me era una specie di cosa na-
turale. Probabilmente è perché sono
cresciuta tra poeti e romanzieri e mio
padre scriveva poesie che parlavano di
tutto—da un gatto che dormiva su una
finestra a un incidente che aveva visto
sull’autostrada. Ho imparato a non
censurarmi: quella era una delle cose
che ho imparato nel mio apprendistato, il mio apprendistato di scrittura
creativa con papà. Non ho studiato la
scrittura creativa in modo formale, ma
ho imparato quanto possibile guardandolo, e partecipando ai suoi laboratori in casa, e ascoltandolo insegnare,
e tutto il resto. Lui mi ha insegnato a
non censurarmi. Mi ha insegnato l’economia della scrittura e dell’editing. È
un magnifico editor.
Pensate a tutti gli artisti
di ‘Americana’, donne e
uomini, che non esisterebbero senza di lei. È difficile
immaginare un mondo
senza Lucinda Williams.
Resti sorpresa quando la gente ti
dice che le tue canzoni sono sensuali o sexy? Leggevo la descrizione di uno dei tuoi concerti. Appena hai cominciato a suonare, tutti
hanno preso a pomiciare.
[Ride] Lo sento dire spesso, già. Quando eravamo a New Orleans, e questo
era durante il Jazz Fest, abbiamo fatto
un concerto alla House of Blues. Non
è stato molto dopo l’uragano Katrina,
quindi c’era una sorta di strana energia
nel pubblico. Ad ogni modo, abbiamo
suonato Essence. Abbiamo scoperto in
seguito che questa ragazza—non stava
pomiciando con qualcuno, stava sostanzialmente pomiciando con se stessa, mettiamola così. Si stava toccando.
Qualcuno tra il pubblico ha chiamato
gli sbirri, e gli sbirri sono arrivati. Doveva essere sotto l’effetto di qualche tipo
di droga. Doveva essere fatta di ecstasy.
Comunque, è stato piuttosto selvaggio.
Da che altri lavori stavi imparando, a parte quelli di tuo padre?
Amavo la narrativa breve contemporanea e Flannery O’Connor. Divoravo la
sua roba. Ero piuttosto giovane—quindici, sedici anni. La sua roba era così
descrittiva. Riuscivi a vederla—un’immagine di ciò di cui parlava. Amavo
quel tipo di scrittura, quella scrittura
OUTSIDER
molto descrittiva, realistica. Ho imparato che invece di dire soltanto “Me ne
sono appena andata da quest’ultima
città” perché non dire il nome della città? Descrivi la città. Non dire solo “Oggi
ho indossato le scarpe”: dì “Ho indossato le mie scarpe di cuoio rotte”.
emozioni e in quel momento saprò:
‘OK, potrebbe esserci bisogno di qualche aggiustatina, ma ho raggiunto il
cuore della canzone. Ce l’ho. Perché ho
raggiunto quel punto—sono andata a
fondo e ho raggiunto quel punto. Poi
ho solo bisogno di ripulirlo un po’.
Hai incontrato Flannery O’Connor
quand’eri piccola, giusto?
Lo ricordo a malapena. Avevo solo
quattro anni. Era uno dei mentori di
papà. Vivevamo ad Atlanta. Lei stava a
Milledgeville, in Georgia. Ha invitato lì
mio padre, e lui mi ha portata con sé.
Viveva in questa vecchia grande casa.
Era disciplinatissima con la sua scrittura. Scriveva dalle otto del mattino fino
alle tre del pomeriggio. Tirava le tende,
e se le tende erano tirate voleva dire
che non aveva ancora finito di scrivere
e noi abbiamo dovuto restar seduti nel
patio ad aspettare che finisse. Poi la sua
domestica è arrivata e ci ha fatti entrare. Allevava pavoni, che correvano in
giro per tutto il cortile. Papà dice che
inseguivo i pavoni.
Che posto è, quello?
Quel punto in cui mi colpisce—perciò
so che colpirà anche gli altri—dove infilo le mani a fondo nella mia psiche e
tiro fuori roba. Come quando scrivo della morte di mia madre e cose simili, sai?
Tu hai una routine del genere?
Non sono così disciplinata. Metto assieme idee e versi. La mia mente è sempre
attiva. Sto sempre ad appuntare versi, e
robe da flusso-di-coscienza. E conservo
tutto in una cartelletta. Ho un sacco di
canzoni dell’ultima sessione di stesura,
da sessioni precedenti, canzoni che ho
scritto e su cui devo tornare per lavorarci un po’ di più, e poi pezzi e pezzettini di versi e idee. Quando la musa mi
coglie, o l’umore, o qualunque cosa sia,
prendo la mia chitarra e la scarico. Mi
metto a esplorare le cose per vedere che
succederà.
IV. LA VITA NON FUNZIONA COSÌ
Come ti accorgi che una canzone è
terminata?
Aiuta avere qualcuno a cui suonarla,
qualcuno di cui ti fidi, che in questo
caso è mio marito, Tom. Ma mi sembra
di saperlo, di solito. A volte lo so perché
piango. Se per me è molto emozionante, al punto da immergermici così tanto… Per me scrivere è molto catartico,
il più delle volte. È terapeutico e catartico e tutto il resto, verrò travolta dalle
55
Una volta, tanto tempo fa, questo giovane autore mi stava chiedendo una
cosa, ha detto: “Voglio essere un autore
di canzoni. Voglio fare quello che fai
tu. Ma non so come fare. Dimmi come
fai”. E io ho detto: “Devi voler scavare
a fondo in te stesso, e andare a guardare negli occhi quei demoni e i mostri
e le cose e la roba che è successa. Vai
laggiù, e basta. Perché lì c’è una montagna di materiale”. E lui: “Non penso di
poterlo fare”. Non dimenticherò mai
quel momento. Mi ha guardata con
questo sguardo negli occhi, e ha detto:
56
OUTSIDER
LUCINDA WILLIAMS
“Non posso farlo”. E io ho solo detto:
“Bene”, sai? Quello è stato un momento molto triste. Non me ne dimenticherò mai. Sapeva di cosa stessi parlando
e sostanzialmente diceva: “Non posso
farlo. Ho troppa paura per farlo”. Non
mi era mai successo che qualcuno fosse troppo spaventato per farlo.
Non ti spaventi mai?
No, dio! Devo. È la mia forma di sopravvivenza. Devi solo andare lì dentro e confrontarti con tutta quella roba,
a meno che tu non voglia scrivere di
soli splendenti e fiorellini, e amori non
corrisposti.
Cosa ne pensi dell’idea che gli artisti debbano soffrire prima di poter
produrre qualcosa di buono?
Penso che cominciamo a soffrire dal
momento in cui usciamo dall’utero.
Penso che la gente tenda a stereotipare. Quando pensano alla sofferenza, pensano alla violenza—violenza
fisica, violenza emotiva, povertà, quel
tipo di cose. Ci sono diversi livelli di
sofferenza. Non penso che abbia a che
fare coi soldi che hai—se sei cresciuto
nel ghetto o nei quartieri alti. Per me
ha più a che fare con la percezione: la
percezione di sé e il modo in cui percepisci il mondo.
1987
La gente associa la sofferenza al
tuo lavoro, al punto che hanno cominciato a distinguere i tuoi ultimi album come gli “album felici”.
È una denominazione davvero scorretta: l’idea è che tutto d’un tratto, nel giro
di una notte, io abbia incontrato Tom
e ci siamo sposati e io ora sia felice? La
vita non funziona così. La vita va avanti e tu ancora—sono felice di aver conosciuto Tom, lo amo e, lo sai, ma sono
ancora un’artista, e ancora scrivo di varie cose. Ancora soffro e provo dolore e
tutto il resto. Ci sono un sacco di cose a
cui pensare e di cui scrivere, oltre all’amore non corrisposto. Sembra esserci
questo pregiudizio tale per cui, siccome
Non ascolto la roba che
esce da Nashville, anche
se a volte esce qualcosa di
buono. Non mi piace il
modo di produrre le canzoni , la roba nel suo insieme.
È tutto troppo furbetto.
non vado in giro con un cattivo ragazzo, siccome ora ho trovato una persona,
di cosa potrò scrivere? Che questo sia il
mio “album felice.” Ed è assolutamente
ridicolo! Mostra solo una mancanza di
consapevolezza. È così mediocre. Credici o no, ma la gente è arrivata al punto
di ipotizzare che potrei non essere più
in grado di scrivere canzoni siccome
mi sono sposata. Ho provato a spiegare ancora che ci sono altre cose di cui
scrivere, oltre a ragazzo incontra ragazza, ragazza incontra ragazzo, ragazzo
molla ragazza, ragazza è triste. Che dire
della salute mentale di mia madre, e la
sua intera vita, e la mia? Mi porto tutta
quella roba addosso come un albatros
attorno al collo. Un terapista una volta
mi ha detto: “Stai portando i suoi pesi;
devi lasciarli andare”.
La roba è questa. È questo a farmi andare avanti. Devo scrivere. Ho scritto un
paio di canzoni su mio fratello, che ha
sofferto di malattia mentale, che sono
convinta sia genetica perché anche
mia sorella è così. Un altro terapista
mi ha detto che ho il complesso del sopravvissuto, perché sono la più grande
di tre e sono sopravvissuta, e non saprò
mai bene perché, se non per il fatto che
fossi molto legata a papà, ho legato con
lui e da ciò ho tratto molta forza, come
dallo scrivere.
Come potresti scrivere di tutto questo?
Ho provato a scrivere
una canzone su mia
madre, su come è stata
cresciuta. Anche lei ha
avuto un’infanzia notevole. Suo padre era
un predicatore Metodista fondamentalista
che masticava tabacco,
e lei è cresciuta in un
tipo d’ambiente piuttosto repressivo. Questo voleva dire essere
una donna in Louisiana a quei tempi—negli
anni ’40, ’50, ’30. Aveva
quattro fratelli. Ha subito violenza emotiva, se non in qualche
modo fisica. Già, se l’è
vista brutta. Sua madre aveva una malat-
OUTSIDER
tia mentale. L’ha trasmessa a lei. Ed è
passata a mia sorella e a mio fratello.
Io in qualche modo sono riuscita a sopravvivere.
Dev’essere difficile, allora, provare a scavare nei ricordi di qualcun
altro invece che nei propri.
Volevo scavare anche nella mia infanzia. Ho molte canzoni che sono già su
di me—storie che hanno a che fare con
me e i miei uomini, i miei magnifici
perdenti, sai? Voglio scrivere di bambini. Ho cominciato qualche canzone
sui bambini, sulla violenza sui bambini. Voglio scrivere di quello.
57
V. LE GLASSATE COUNTRY-GIRLS
Credi di essere responsabile per la
creazione, all’interno della musica, per una nicchia di Americana?
Per mancanza di meglio, credo. C’era
altra gente a farlo, oltre a me, ma penso che il successo di Car Wheels abbia
molto a che fare con questo, credo. Ricordo che vivevo a Nashville mentre
costituivano questa ‘Americana Music Association’, e stavano provando a
trovare un nome da darle. Io, assieme
a molti altri cantautori che facevano
la stessa cosa, ne siamo stati responsabili. Cioè, non voglio prendermene
il merito fintanto che il mercato funziona. Penso che stessero pensant’do,
‘Dobbiamo trovare una casa per questo tipo di musica all’interno dell’industria discografica, così che non si
perda tra le pieghe’.
Qual è la tua opinione della scena country in generale? Ascolti
quello che arriva da Nashville?
Non l’ascolto per niente. Non ne sono
fan. A volte, scappa fuori qualcosa che
penso sia piuttosto buono. Ma non mi
piace la produzione, di solito non mi
piacciono le canzoni, la roba nel suo
insieme. È troppo furba. Non è buon
country. Non è country nel senso di
quello che penso il country dovrebbe
essere, come ai vecchi tempi, come
Loretta Lynn e molto dell’Outlaw
Country, come Waylon Jennings e
Johnny Cash. È più represso e commercializzato in un certo modo. Mirano a un certo pubblico, immagino.
Semplicemente non è qualcosa che
abbia voglia di metter su e ascoltare
a casa. Non ha gli spigoli abbastanza
ruvidi, almeno non la roba che ha
successo. Ho sentito roba uscita da
Nashville che è figa, ma ha problemi
a competere con le glassate, soffici,
graziose country-girls da calendario.
Da dove arriva questo problema?
Molti di questi artisti non scrivono le proprie canzoni. Hanno tutta
questa gente che scrive assieme a
loro. Hanno tutta questa gente che si
sposta a Nashville dal Connecticut e
da Long Island, si mettono al tavolo
con tre o quattro persone e scrivono
canzoni. Non hai quel senso perso-
58
OUTSIDER
LUCINDA WILLIAMS
nale, di esperienza viscerale, quando
Uno dei miei versi preferiti di una
ascolti una canzone scritta da tre o
delle tue canzoni parla di te che
quattro persone assieme. È questa la
vedi un tizio che trovi attraente, e
‘macchina da scrivere’ che ora funzionon è su una spiaggia o un posto
na a Nashville. Porta via buona parte
simile—è in un supermercato a
dell’anima. Gli artisti a cui guardo—
comprare pomodori.
Bruce Springsteen, Neil Young,
Ed è quello che non senti nel country
Elvis Costello—quelli sono artisti
moderno. Ora sarebbe su una spiaggia.
che hanno avuto
successo, sono di2013 - Lucinda Williams e Boz Scaggs (Tim Mosenfelder/Getty Images)
ventati grandi star e
hanno mantenuto la
loro integrità, sai? Un
individuo che scrive
una canzone a partire dalle proprie esperienze.
Penso che nel mondo della musica rock,
o comunque si chiami—tutto ciò che
sta fuori da Nashville—ci sia molta più
libertà di fare quello
che vuoi all’interno
dell’industria.
Nashville tende a
cadere in questa sindrome dello stampino. Tutti i dischi
cercano di avere lo
stesso sound. Tutta
la gente che arriva a
Nashville, che non
sa nulla di musica
2012 – Con Elvis Costello (Photo by L. Cohen/WireImage)
country, arriva in
città e dice: “Hey!
Scriverò una canzone country! Salterò
sul carrozzone. Ci si
possono fare i soldi,
in questo affare delle
canzoni country”. E
gli artisti che erano
un po’ diversi e un
po’ spigolosi—l’industria non li supporta.
Hanno la tendenza
a non supportare la
musica che suona
come la roba country
più vecchia. Non so
perché sia così.
Giusto, e il tuo lavoro non ricade in
quella sindrome
dello
stampino.
Qual è la cosa più carina che qualcuno abbia detto di una tua canzone?
Il mio compleanno è il 26 gennaio.
Ho ricevuto tutti questi messaggi via
mail e su Facebook e sulla mia fan
page—questi dolci, adorabili messaggi e auguri di buon compleanno.
OUTSIDER
Un paio di volte, parlando della mia
canzone Sweet Old World, ci sono
state un paio di persone che hanno
detto di aver pensato al suicidio e di
aver cambiato idea—che quella canzone aveva fatto loro cambiare idea.
Piuttosto intenso, eh? Stavo suonando Unsuffer Me, e penso che questa
donna abbia esclamato dal pubblico:
“Grazie, Lucinda! Quella canzone mi
ha salvato la vita”.
Non sorprende allora che, incastrata
tra le forze in lotta d’amore e morte,
Williams abbia deciso di scrivere una
canzone sulla morte, qualcosa che sui
precedenti album ha esitato a fare. La
sfida nello scrivere una canzone che
parli di guerra, spiega, sta nell’esplorare l’argomento senza suonare predicatoria, polemica o politica. Le canzoni
di protesta più durature sono quelle
che si focalizzano sul reale impatto
umano della guerra e non su un messaggio apertamente controverso. In
quei termini, non sono affatto orientate a protestare, ma a ritrarre: se l’artista
riesce a veicolare la realtà, l’ascoltatore non può fare a meno di reagire.
“Quel tipo di canzoni è davvero difficile da fare”, ammette. “Phil Ochs
ne era in grado, [e] chiaramente Bob
Dylan. Ma c’erano anche quelle più
delicate, come quella canzone di Pete
Seeger, Where Have all the Flowers
Gone. Voglio dire, quella è una canzone magnifica. E a suo tempo era
considerata una canzone di protesta,
e faceva: ‘Dove se ne sono andati tutti
i fiori/Da così tanto tempo’. Quindi è
qualcosa che da molto volevo esplorare. Non ci pensavo volendo che
fosse una canzone di protesta, ma
stavo certamente cercando di affermare qualcosa sugli orrori della guerra. Ma volevo prenderli e porli sotto
un aspetto più personale, familiare,
umano”.
In passato, Williams è stata descritta dalla stampa come una maniaca del controllo, una perfezionista
ossessivo-compulsiva che si fissava
così tanto sui dettagli che le ci voleva
buona parte di un decennio per fare
un album, per dire di no alle persone
che aveva reclutato perché la assistessero nella creazione di un album, o
entrambe le cose. Per esempio, l’incisione dell’album che l’ha resa famosa,
Car Wheels On a Gravel Road (1998),
è stata segnata da sessioni scartate,
amicizie rovinate e produttori rimpiazzati—tutto, a quanto pare, perché
lei voleva fare l’album in modo irragionevolmente corretto.
Se allora quel ritratto di Williams
era corretto, certamente non lo è
ora. Mentre parla del suo approccio
FILTER
DISCOGRAPHY
1979
RAMBLIN’
1988
NO DEPRESSION
1998
CAR WHEELS
ON A GREVEL
2003
ARTIST’S CHOICE: LW
2005
LIVE FILLMORE
2014
HIGHWAY
20 RECORDS
alla scrittura, diventa chiaro che sia
molto più intuitiva che meticolosa,
lasciando che sia la sua musica a fare
strada quando—e se—le fa visita.
Forse, grazie all’esperienza di ripetuti
successi, ha imparato di potersi fidare
del suo istinto; forse doveva solo imparare a rilassarsi. In ogni caso, Williams sembra un’artista in sintonia
coi propri istinti creativi, non in lotta
con essi.
59
“A volte è come scrivere un diario o
qualcosa del genere”, dice, parlando
del processo di gestazione di una canzone. “È un flusso di coscienza, quasi.
Butto lì qualche pensiero. Di solito comincia con un verso che mi viene in
mente, o qualcosa di simile. O a volte
scrivo qualcosa come un paio di versi,
qualche pensiero, come quando mi
preparo per andare a letto o magari
quando mi sono appena svegliata e
sono lì sdraiata a pensare. Mi alzo,
afferro una penna, e qualunque cosa
sia, la metto subito su carta per non dimenticare l’idea... Non resto seduta ad
applicarmi ogni singolo giorno, tutto
il giorno. Più o meno succede quando
ne ho il tempo”.
L’approccio rilassato alla scrittura e
all’incisione è dovuto, in parte, all’aver
trovato il perfetto contraltare creativo
in suo marito. Overby è un veterano
dell’industria discografica, abituato a
prestare attenzione ai piccoli dettagli
che spesso sfuggono agli stralunati
artisti. Sapendo che suo marito si prenderà cura di quei dettagli, è libera dai
suoi fardelli—e libera di focalizzarsi
sulla musica.
“Il mio approccio alla scrittura e
all’incisione e a tutto è molto organico. Tom ha lavorato per molto tempo
in una casa discografica occupandosi
di marketing, quindi è molto concettuale. Perciò siamo una buona squadra. Per dirne una, quando mettiamo
le canzoni in ordine, la sequenza, io
non voglio farlo, ma Tom è davvero bravo a metterle tutte assieme. E a
volte io faccio: ‘Quell’idea è folle!’ Per
esempio è stata una sua idea che io
facessi una cover di It’s a Long Way to
the Top [degli AC/DC]. Ho fatto: ‘Stai
scherzando? Quella canzone nemmeno mi piace!’ Non la conoscevo neanche, sai? Lui ha detto: ‘Beh, sul disco ci
serve solo un’altra canzone rock’. E io
facevo: ‘Che importa? Facciamo uscire
il disco. Non importa’. Lui si occupa di
questo. Guarda al disegno complessivo e vede se il disco sia equilibrato, tra
tutte le canzoni..
Dopo aver passato così tanti anni ai
margini dell’establishment musicale,
la Williams si trova ora nella bizzarra
60
OUTSIDER
LUCINDA WILLIAMS
posizione di fare da modello agli aspiranti artisti. La sua carriera è l’esempio
di come si facciano le cose nel modo
giusto—ironico, considerato che ha
successo malgrado l’industria musicale piuttosto che grazie a essa. Chiestole che ne pensasse dell’essere un
tale modello, non ha segreti da rivelare oltre al focalizzarsi sulla
musica: all’inferno fama e
fortuna.
grossa per qualcuno che una volta ha chiamato se stesso “Manine
di Cemento.”
Lo so. Non voglio farlo sembrare un
disco malriuscito, ma quella è stata
un’idea di Tom. [Ride.] Elvis era in città
a finire il suo album con T-Bone Burnett. L’abbiamo acciuffato. Una sera
“Ho cominciato tantissimo
tempo fa come cantautrice
solista, con solo la mia voce
e le mie canzoni, e la mia
forza era quella. In fondo
al cuore ho sempre saputo
che ‘Beh, se perdo questo
contratto discografico, il
mio mondo non cadrà a pezzi e qualcos’altro succederà.
Continuerò ad andare avanti’. Parte è solo il fattore pazienza—sai, tenere duro. E
nell’epoca in cui sono cresciuta si trattava di uscire e
suonare davanti alla gente.
È così che ci si costruisce un
seguito, e una volta che hai
quello zoccolo duro, ce l’hai
fatta. Poi serve solo che
l’industria ti acchiappi, ed
è tutto. Penso che a me sia
successo più o meno così”.
Quando le si chiede cosa ne
pensi dell’essere nella stessa
cerchia di cantautori che lei
stessa ha ammirato per così
tanti anni—cantautori come
Dylan e Petty e Young e
Springsteen— deve sforzarsi per rispondere. “In effetti mi manda fuori di testa
pensare che forse sono nella stessa cerchia”, sussurra,
come se un semplice riconoscimento della portata del
suo talento fosse una blasfemia. Poi, dopo un silenzio
ancora più imbarazzato, scoppia in
quella fantastica risatina del sud.
Una delle ospitate più interessanti del disco vede Elvis Costello
alla chitarra solista, ma non alla
voce, su parecchie canzoni. È roba
chiamare Elvis a suonare la chitarra
in qualcuna di queste tracce”. Ho detto: “Davvero? Okay”. È arrivato e si
è seduto in regia. Aveva con se tre o
quattro chitarre, e gli abbiamo suonato le canzoni una per una. Le ha ascoltate, si è seduto e ha fatto… faville.
Ero in regia a guardarlo, ascoltando la
traccia, perché avevamo fatto tutto tranne quello. Era da
perderci la testa! Incredibile.
E anche Matthew Sweet
canta in qualche brano?
Già, è venuto a fare qualche
armonizzazione. Quelle in
realtà sono solo delle specie
di sovra-incisioni. Non volevamo aggiungere troppo.
Per buona parte, tutto è stato,
per quanto abbiamo potuto,
registrato, col mio gruppo ristretto: Rami Jaffee a tutta
la roba di tastiera, Val McCallum alla chitarra, Butch
[Norton] e Dave [Sutton], la
mia abituale sezione ritmica. Greg Leisz [steel guitar]
qualche volta è venuto. Era
tutto, in realtà. Quei ragazzi,
più Matthew e Elvis.
aveva qualche ora libera, e Tom gli
ha mandato una mail chiedendogli
se potesse suonare un po’ la chitarra.
Ha risposto a Tom chiedendogli: “Sei
sicuro di averla spedita alla persona
giusta?” Anch’io ero sorpresa quando
Tom ha detto: “Hey, sai che c’è? Voglio
Negli anni hai scritto
molte canzoni a proposito di amici che si sono
autodistrutti o sono morti, e su questo disco (Blessed – ndr) ce ne sono due:
Copenhagen, sulla morte
del tuo manager, Frank
Callari, e Seeing Black,
sul suicidio di Vic Chesnutt.
Sono venute fuori molto in
fretta, davvero. Una specie
di esplosione emotiva mentre scrivevo durante la fase
di stesura. Magari avevo già
qualche verso per Copenhagen, ma per come me la
ricordo, l’ho scritta piuttosto
in fretta, e con Seeing Black è stato lo
stesso. Ho saputo del suicidio di Vic
Chestnutt mentre scrivevo. E anche
un altro mio amico si è tolto la vita,
circa sei mesi prima o giù di lì. Non
parla davvero di Vic. Il suo suicidio
ha ispirato la canzone.
Un suggestivo viaggio lungo 40 anni vissuti attraverso gli occhi e le esperienze
di musica e di vita di un gruppo di giovanissimi “PROG-ROCKERS” italiani.
- I loro ruggenti inizi in una stagione meravigliosa, i primi concerti, Rimini 1973,
il loro percorso lontano dalle grandi e luminose ribalte, ma sempre orgogliosi
protagonisti, quasi in controluce, di un affascinantissimo e multiforme movimento
musicale. Uno speciale su “Gerbrand” opera Rock.
I primi riconoscimenti internazionali, le amicizie coltivate con famosissimi
colleghi dell’universo Prog, concerti, partecipazioni illustri, anniversari, cene e
dopo-cene, indiscrezioni e bisbocce.
- Tournè, viaggi, sale di registrazione, partecipazioni e tributi e una galleria di
strumenti dell’epoca.
Un b
k con più di 200 pagine e foto inedite, immagini patinate di nostalgia seventies, manifesti e riviste d’annata, un lungo racconto
- Un
book
“romanzato” con ospiti famosi, dediche e testimonianze, i primi Fans Club.
Testo in lingua italiana con traduzioni in multilingue presto disponibili in apposita sessione sul sito www.capgroup.it
- Nr. 2 audio CD con il recupero di outtakes, bonus tracks, altenativ mix, special e limited edition, “other languages” compreso un prezioso
“best of” del loro percorso quarantennale risuonato oggi con strumenti vintage.
- Nr. 1 CD con una collezione audio dei migliori momenti live estratti dai più bei
Festival cui hanno partecipato in Europa e negli USA.
E, inoltre, la sacralità del suono di alcuni splendidi teatri e diverse re-interpretazioni
live di famosissime covers.
- E quale “Special gift” del 40° Anniversario nr. 1 CD con la riedizione integrale
rimasterizzata “Special Anniversary Edition” del loro album “seminale” ….NEI
GORGHI DEL TEMPO irreperibile da oltre 20 anni con, in aggiunta, quale Bonus
Track, uno splendido brano dall’opera rock “Gerbrand” del 1973.
Produzione:
Associazione Culturale
’70: DO NOT FORGET THEM
Via Roma 104
20013 Magenta (Mi) Italy
mail: [email protected]
BTF Srl
[email protected]
In distribuzione:
62
OUTSIDER
?????
JEFF TWEEDY
OUTSIDER
NO DEPRESSION
JEFF
TWEEDY
TRYING TO BREAK
YOUR HEART
di Dean Budnick // Relix
Uncle Tupelo e Wilco sono state due delle realtà oggettivamente più importanti dell’ultimo trentennio musicale a stelle e strisce: la prima in grado di dare vita a un’intera scena (la cosidetta ‘No Depression’); l’altra capace di
mantenere una precisa identità in cui tradizione e innovazione diventano la stessa cosa abbracciando l’ampissimo spettro di rock americano che va dalla Band
di Robbie Robertson ai Sonic Youth di Thurston Moore
passando per i Replacements e i Buffalo Tom: quello che
una volta chiamavano alt-country è solo il punto di partenza, l’arrivo è l’infinito. Elemento comune a tutto ciò,
Jeff Tweddy, che nonostante cambi di rotta, rotture prolungate, incontri/scontri, collaborazioni più disparate,
ha attraversato tutto questo senza lasciarci le penne,
pur morendo, parafrasando uno dei suoi testi più celebri
e pregnanti. Provando, sempre e comunque, a spezzarti
il cuore. In occasione dell’uscita di Sukierae, il nuovo album realizzato in collaborazione con suo figlio Spencer,
parla dei suoi metodi compositivi, nonché del potere
consolatorio della musica.
63
64
OUTSIDER
JEFF TWEEDY
“Avevo pensato di chiamare solo persone che desiderassero cambiare il
loro cognome in Tweedy per promuovere l’album in questo senso”, racconta
Jeff Tweedy, fondatore e leader degli
Wilco nonché degli Uncle Tupelo,
spiegando come lui e suo figlio Spencer abbiano individuato chi chiamare
per contribuire al loro esordio di coppia
al quale poter dare così, come titolo, il
nome di famiglia. Ma, come era logico
che fosse, le cose non hanno seguito
questa impostazione così rigida – Jess
Wolfe ed Holly Laessig del quintetto
indie di Brooklyn Lucius e Scott McCaughey, uno dei componenti dei Minus 5, hanno mantenuto i loro cognomi – anche se l’album (che abbiamo
recensito lo scorso mese su Outsider –
ndr) è di fatto il risultato di una stretta
collaborazione padre-figlio.
L’idea di lavorare insieme era partita
da alcune tracce di batteria realizzate
da Spencer per il secondo album prodotto dal padre per Mavis Staples,
One True Vine, uscito nel 2013. Con gli
altri componenti degli Wilco impegnati in progetti personali dopo l’uscita
dell’ultimo disco del gruppo nel 2011,
The Whole Love, Tweedy aveva cercato di prendere una boccata d’aria fresca
impegnandosi nella realizzazione di
un disco senza la sua band, convinto
del fatto che lavorare senza le tipiche
pressioni che caratterizzano il lavoro
di un gruppo avrebbe dato dei risultati
più che positivi.
Suonare insieme è sempre stato un ottimo modo per trascorrere il tempo per i
due Tweedy, un passatempo che prima
o poi avrebbe dato vita ad un disco. Così
come nell’album della Staples, Spencer
aveva già suonato con il padre su Ballad Of The Opening Band, un singolo
realizzato per aiutare Slim Dunlap dei
Replacements (colpito da un infarto
nel Febbraio 2012 N.d.T.), ed aveva realizzato anche un altro singolo, a nome
Raccoonists nel quale padre e figlio
avevano suonato con il più piccolo dei
figli di Tweedy, Sammy.
Dopo aver abbozzato delle demo con il
semplice aiuto del suo I-phone, Tweedy aveva arruolato Spencer, batterista
provetto, già attivo con il suo gruppo,
i Blisters, ma anche con gli Wilco dal
vivo, per dare forma a quelle canzoni. E
quando fu annunciata l’uscita dell’al-
bum, questo è stato ciò che ha detto:
“Quando ho deciso di realizzare questo
disco, avevo pensato di farlo da solo,
ma l’idea non era quella di registrarlo
chitarra e voce. La mia intenzione era
quella di comporre tutte le canzoni,
suonare tutti gli strumenti ed anche
cantare. Ma il fatto è che Spencer è stato con me sin dall’inizio del processo
creativo ed ha senz’altro contribuito
allo sviluppo artistico del disco. Il prodotto finito è un disco da solista suonato da un duo”.
Ciò che è venuto fuori da queste registrazioni è un doppio album cucinato
a fuoco lento che spesso riserva piacevoli sorprese. Si viaggia attraverso stili
differenti: per cominciare la chitarra
straziata dal rosario di note di Please
Don’t Let Me Be So Understood, che
ricorda le prime registrazioni degli Un-
cle Tupelo, poi si passa a Pigeons e New
Moon, delicate canzoni dalle atmosfere evocative costruite intorno a crudi
arrangiamenti di chitarra e voce, un
paio di canzoni piuttosto lunghe che
presentano un andamento circolare,
quali Diamond Light Pt.1e Slow Love
ed una sequenza di canzoni scritte con
anima e cuore, fino all’ultima, I’ll Never Know nella quale Tweedy racconta del tempo trascorso con la madre
a vedere i film di Judy Garland. In
altri momenti l’album sembra pescare
dalla discografia di Tweedy, strizzando
l’occhio alle varie sfaccettature degli
album degli Wilco come High As Hello
che ricalca la stessa andatura svogliata di Handshake Drugs da A Ghost Is
Born, oppure Summerteeth che viene
richiamato dall’energico pop da viaggio di Low Key, mentre lo scheletro di
OUTSIDER
un brano originariamente pensato per
Being There si rianima in I’ll Sing It. Lo
stile di Tweedy si manifesta inequivocabilmente nella produzione di chitarre molto presenti e dissonanze sonore
che attraversano il disco e sembrano
segnalare, a chi non lo avesse già colto,
che si tratta di un prodotto del Loft, lo
studio degli Wilco a Chicago. La collaborazione padre-figlio tuttavia dà vita
ad un nuovo scenario, uno stile diverso ma ben definito che si manifesta
soprattutto nelle canzoni più lunghe,
ed in special modo in Slow Love, dove
l’incedere robusto della batteria jazzeggiante di Spencer sorregge un brano saturo di riverbero, onirico quanto basta
e nel quale l’elettronica si insinua qua
e là con alcune note di piano.
Ma c’è un altro motivo per il quale
padre e figlio si sono messi insieme al
lavoro per realizzare un nuovo album.
Nel corso delle registrazioni, alla moglie di Tweedy, Sue, co-proprietaria di
uno dei locali più importanti per la musica alternativa a Chicago, il Lounge
Ax, una vera e propria istituzione, era
stato diagnosticato il linfoma nonHodgkin. La stessa Sue che nel 2004 si
era presa cura di Jeff quando questi soffriva di una patologica dipendenza da
farmaci che si innestava su una grave
forma di depressione e Tweedy si era
dovuto sottoporre ad un doppio percorso riabilitativo; ora i ruoli si sono invertiti ed è Jeff ad accompagnare la moglie
alle sedute di chemioterapia. Se è vero
che la battaglia contro questa malattia
65
non si può ancora definire vinta, Tweedy racconta che c’è ottimismo da parte
dei medici su un pieno recupero di Sue.
Il dolore, così come la capacità di recuperare sono temi portanti nel disco, ad
esempio in Diamond Light Pt.1; il verso: “Sei spaventato? Impaurito? Hai il
terrore di rimanere solo?” crea un pathos profondo, forse troppo profondo
a causa dei riferimenti autobiografici.
Ciò non vuol dire che Sukierae, titolo
ispirato dal nome Sue, sia un album
irrimediabilmente cupo e disperato,
tutt’altro: siamo di fronte ad un lavoro cesellato con l’amore e la speranza,
dove peraltro si giunge a patti con la
fine dell’esistenza. Ce lo ricordano le
parole finali di Nobody Dies Anymore
che recitano: “È strano, difficile da dire,
No Depression degli Uncle
Tupelo fu pubblicato nel
1990 e riprendeva il nome
da una storica canzone
della Carter Family. Poi
diventerà prima una fanzine, poi un vero e proprio
movimento. Adesso un
importante sito on line.
ma amo il modo in cui finiscono tutte
le canzoni”.
Dopo un’estate trascorsa in tour con
in scaletta le canzoni dell’album,
accompagnato da Spencer e da una
band composta da Jim Elkington alla
chitarra, Darin Gray al basso e Liam
Cunningham alle tastiere, e dopo
alcune date con gli Wilco effettuate
prima di dedicarsi alla composizione
delle canzoni per il nuovo album, abbiamo telefonato a Tweedy a Chicago
per parlare di Sukierae a partire dalla
sua genesi.
“Credo ci siano stati diversi motivi,
molte coincidenze che mi hanno portato a ritenere che fosse il momento
giusto per realizzare un album da solista. Uno dei motivi è il seguente: avevamo trascorso un sacco di tempo in
tour con gli Wilco negli ultimi anni,
66
OUTSIDER
JEFF TWEEDY
ed avevamo terminato con Spencer
le registrazioni di Mavis, trascorrevamo davvero dei bei momenti insieme
assemblando canzoni e pensando al
prossimo disco degli Wilco. Una cosa
peraltro molto complicata dato che
ognuno dei componenti degli Wilco
era impegnato in progetti collaterali.
Ma al posto di scoraggiarmi ho semplicemente pensato che è giusto ogni
tanto prendere una boccata d’aria, ed
allora ho preso in mano la situazione
ed ho pensato che fare un disco senza
gruppo sarebbe stata un’esperienza
molto positiva.
Che sensazioni hai provato quando hai cominciato a registrare?
Beh, come ho detto, credo di aver fatto un primo assaggio con la produzione del disco di Mavis, assemblando le
varie tracce di accompagnamento. Diciamo che questo è stato il mio primo
disco da solista – sulle prime io e Mavis
avevamo pensato di realizzare un disco
molto scarno, chitarra e voce, ma presto
ho cominciato a vederla in modo differente. Ho cominciato a pensare che le
canzoni sarebbero state più belle con
un accompagnamento, degli interventi strumentali insomma che potessero
conferire ai brani maggiore corposità.
Ho cominciato a produrre qualcosa in
questo senso e a Mavis sono piaciuti i miei demo, così come è piaciuto il
modo di suonare di Spencer. Ho capito
che si poteva continuare su questo percorso, accettando la sfida con me stesso e cominciando a suonare per il solo
piacere di farlo, prendendomi il mio
tempo, e senza badare eccessivamente
alle spese, dal momento che il processo
creativo era ben avviato ed io ci stavo
provando gusto. Diciamo che è andata
così anche per il mio disco. Anzi, non ci
siamo mai fermati dopo il disco di Mavis, abbiamo semplicemente continuato a lavorare nello stesso modo.
Hai parlato delle affinità musicali
fra te e tuo figlio Spencer e della
vostra capacità di lavorare insieme, quasi foste una sola persona.
Cosa ci puoi dire di più su questo
aspetto della vostra collaborazione?
Io e mia moglie siamo davvero fortunati, dal momento che i nostri figli,
benché adolescenti, hanno ancora
enorme piacere a trascorrere con noi
il loro tempo [ride] ed a comunicare
con noi. Se mi chiedi come sia suonare
con Spencer, posso dirti che è una cosa
piuttosto naturale. Abbiamo sempre
suonato insieme, in cantina, in altre
occasioni, dovunque. Il disco è la normale continuazione di un rapporto padre-figlio che sono musicisti e trovano
normale e spontaneo suonare insieme.
Per molti aspetti questo nuovo
album mi ricorda Being There, in
special modo per le sue caratteristiche sonorità. Avevi già in mente
un album così vario e multiforme?
Non ci penso mai in fase compositiva.
Tuttavia è quello che è successo anche
in tanti dischi degli Wilco, nei quali abbiamo sperimentato molto ed abbiamo
suonato diversi stili musicali. Potrebbe
essere ciò che succede quando si hanno
gusti diversi all’interno di una band, o
potrebbe dipendere dal fatto che forse
non ho io stesso un gusto ben definito
COMPILATION IN ARRIVO
I Wilco avevano già annunciato l’intenzione di celebrare il loro 20° anniversario con un paio di compilation: un best e un cofanetto di rarità. Entrambi sono
usciti il 17 novembre via Nonesuch.
What’s Your 20? Essential Tracks 1994-2014 è una
doppia compilation che comprende brani di tutti gli
album in studio di Wilco, più un paio del loro progetto su Woody Guthrie, che celebra ‘Mermaid Avenue’,
con Billy Bragg, mentre Alpha Mike Foxtrot: trare
Tracks 1994-2014 è un box di 4-CD/4-LP comprende
brani live (tra i quali I Must Be High, Casino Queen,
Forget The Flowers, Sunken Treasure, I Got You (At The
End Of The Century, Outta Mind/Outta Site), tagli demo
(Childlike And Evergreen, She’s A Jar…) e registrazioni rare (James Alley Blues con Roger McGuinn dal vivo, The T.B. Is Whipping
Me con Syd Straw…) spalmati su tutta la lunga carriera della band con interventi di Feist, Fleet Foxes e Andrew Bird.
Entrambe le uscite sono state prodotte da Cheryl Pawelski, che su Alpha Mike Foxtrot ha detto questo: “Come un sacco di fan,
avevo raccolto queste tracce sbandate nel corso degli ultimi due decenni mentre seguivo ogni mossa di Wilco. Comprende cose
apparse apparse sulle colonne sonore, album tributo e B-sides, e ci sono probabilmente un paio di sorprese per anche il collezionista più attento. Questa serie presenta una storia alternativa della band, diciamo con una vista laterale, e in ultima analisi,
si tratta di un ascolto super”.
Insieme con le nuove uscite, Wilco terrà quello che viene chiamato il ‘Wilco Winterlude’, suoneranno sei notti nella loro città
natale, Chicago, al Riviera Theatre, dal 5 al 12 dicembre. Ogni sera sarà caratterizzato da una scaletta diversa concentrandosi su
canzoni da diverse epoche della carriera della band.
OUTSIDER
[ride]! Mi piace semplicemente ascoltare la musica ed ho tonnellate di dischi. Non sono mai stato quel tipo di
musicista che si chiude nel suo piccolo
mondo sonoro e persegue un preciso
obiettivo estetico. Mi piacciono gli artisti che riescono a farlo. Per quanto mi
riguarda me lo chiedo in continuazione – non proprio in continuazione, ma
senz’altro più di qualche volta – eppure
non credo di poter fare in modo differente, questo è lo stile che mi soddisfa,
continuare a produrre il White Album
o, per meglio dire, la mia versione del
White Album.
C’è un suono in particolare di cui
volevo chiederti, alla fine di Diamond Light Pt.1: quasi nascosto,
sembra ottenuto letteralmente
colpendo il basso, e in breve prende il sopravvento e nasconde tutto
il resto. Mi ha ricordato Less Than
You Think da A Ghost Is Born nel
quale alcuni loops volevano trasmettere l’idea di una persistente
emicrania. C’è qualcosa di simile
anche qui?
C’è molta sperimentazione nel disco e
tanto di quello che si prova in studio
non lo trovi più nel prodotto finito. Nel
caso di cui tu parli, si tratta di un esperimento che ha prodotto un risultato
così coinvolgente e piacevole che sarebbe stato un peccato non farlo finire
sul disco. Mi piace da morire. Quello
che senti è il suono rallentato di una
drum-machine che ho usato come
‘traccia-clic’ sulla quale far suonare
Spencer. Una specie di sfida per vedere cosa sarebbe riuscito a tirare fuori
mio figlio da una base così stramba
[ride]! Abbiamo poi costruito un brano
sulle variazioni che Spencer riusciva
ad effettuare suonandoci su, questo è
tutto.
In un’intervista rilasciata al
‘Time’ parlavi di Country Disappeared e dicevi: “Ci sono immagini in questo brano che vorrei
trasmettervi senza dare troppe
spiegazioni, né specifiche opinioni […] questo è quello che è per me
– una serie di immagini.” Sembra
che le parole delle tue canzoni si
siano spesso divise fra testi diretti
e narrativi e momenti di puro im-
pressionismo verbale, al limite del
comprensibile, come nel caso di
Diamond Light, due stili che è possibile ritrovare in Suckierae. È una
valutazione condivisibile?
Sicuro. Mi piace scrivere in entrambi gli stili, ma non credo che in effetti
tutto possa essere ricondotto a due soli
stili diversi – ce ne sono senz’altro più
di due, ma alla fine sembra possibile
distinguerne soltanto due, non è così.
Veniamo a Diamond Light, posso capire che ascoltandola possa sembrare
sghemba dal punto di vista del contenuto, criptica, ma il processo creativo
dietro questo pezzo è il seguente: le
parole le ho prese in prestito dai Salmi,
mentre leggevo la Bibbia. Traducevo
ciò che leggevo in lingue differenti,
quindi traducevo di nuovo nella mia
lingua, provando a dare a questo punto un senso compiuto al tutto senza
essere risucchiato nelle paludi dell’ovvio. Ho ottenuto così un risultato meticcio. Non so, potrebbe essere il mio
sistema per accelerare i processi di evoluzione del linguaggio o qualcosa del
genere: come suoneranno queste parole fra qualche migliaio di anni? Come
saranno percepite, che significato sarà
ad esse attribuito dalle persone?
Come sei arrivato a questo approccio?
67
Diciamo che è dovuto alla mia proverbiale insoddisfazione, o alla noia [ride]!
Un modo per darmi una scossa, mettere in discussione il mio ego, esplorare alcuni luoghi reconditi della mia
mente nei quali credo meno di quanto
non creda al mio subconscio. Cerco di
raggiungere qualcosa da poter apprezzare di me che non sia espressione del
mio tipico me, del me che credo di conoscere.
Hai usato altri tipi di tecniche?
Certo, ci sono diversi tipi di approccio,
si può provare con degli esercizi di
scrittura, o giochi surrealistici attraverso i quali si può dar vita a poesie o testi
per canzoni. Ma finisco sempre per ricondurre il tutto al suo primo substrato di coerenza, altrimenti non sarei in
grado di ricordare i testi delle canzoni
una volta trascorso tanto tempo dalla composizione. Si possono prendere
ad esempio tutti i verbi adoperati da
Emily Dickinson nelle sue poesie, per
combinarli con i sostantivi presi da
The Battle Hymn Of The Republic. Se
fissi delle regole a tavolino e le segui
pedissequamente, le cose finiscono per
prendere forma ed assumere un proprio significato. Le cose acquistano magicamente senso, che noi lo vogliamo o
no, e mi sento a mio agio maggiormente ricercando tale significato, piuttosto
68
OUTSIDER
JEFF TWEEDY
che provando a realizzare personalmente qualcosa di profondo.
Fantastico, come suggeriscono gli
psico-geografi che dicono di tracciare un percorso sulla mappa di
una città nota, per poi sovrapporlo
alla mappa di una città che si desidera visitare e sperimentano questo singolare sistema di approccio
turistico.
È una corretta analogia, dal momento
che stai usando la casualità, una certa
dose di casualità per guardare con occhi diversi ciò che ti si para di fronte. È
un modo per guardare meglio le cose,
per descriverle meglio e per ascoltare
meglio. Sarebbe davvero scoraggiante
dover scrivere qualcosa che risulti perfetto sia dal punto di vista dell’ascolto
che da quello della comprensione . C’è
così tanta pressione dall’esterno, ma
io ho sempre pensato di legare la mia
creatività all’idea di gioco, così che mi
sono fatto l’idea che si può senz’altro
mantenere il controllo della propria
esistenza - al netto di tutto lo stress che
deriva dall’obbligo di seguire la corrente e farsi intrappolare dai gusti del pubblico – e questo è quello che ho fatto
nel corso della mia esistenza.
Il fatto è che Wilco è nato
come un progetto di mutazione naturale degli Uncle
Tupelo. La line-up era la stessa, fatta eccezione di Farrar.
Fu una cosa naturale. Sono
convinto che tutti i gruppi
prima o poi si trovino a dover affrontare un passaggio
così. Quando si percepisce
una punta di stanchezza
bisogna farlo.
Parliamo ora di una canzone che
presenta un testo chiaro e comprensibile come Sky Blue Sky. Conosco una persona che ha trovato
un grande conforto in questo brano, e mi chiedo se tu provi sensazioni diverse quando componi seguendo percorsi differenti.
Se il mio Io scompare mentre realizzo
qualcosa, sento di aver raggiunto l’obiettivo, ed in questo senso, entrambi
gli approcci mi danno la stessa bella
sensazione. Come ho detto, il mio testo più incomprensibile, o quello che
può sembrare un esercizio fine a se
stesso, tutte le parole scritte finiscono
per avere per me i significati più disparati. Sento un legame emozionale
molto profondo che si sviluppa anche
attraverso la melodia per quanto mi
riguarda – parole e musica diventano
un tutt’uno – tuttavia idealmente mi
piacerebbe che si potesse provare un
senso di consolazione sia di fronte a
testi chiari e limpidi che davanti a parole un po’ più criptiche e significati più
2010 Jeff Tweedy, Pat Sansone, Beck and Elton John (Larry Busacca/Getty Images for NARAS)
OUTSIDER
nascosti. Peraltro io stesso ho molto da
dire e capire, dal momento che mi sono
spesso commosso per brani strumentali, ad esempio, e questo forse perché,
al di là di quanto possa essere efficace
il messaggio, credo che il fatto stesso
di essere di fronte al prodotto intellettuale, artistico di qualcuno sia di per sé
una cosa emozionante. Non è il quadro
in sé, ma lo stesso fatto che quel quadro
ci sia, che qualcuno abbia pensato di
realizzarlo, è questo che mi emoziona.
Si potrebbe dire che c’è un legame
fra questo album ed i dischi degli
Wilco – nella canzone Low Key
quando dici “Quando sembra che
non me ne importi più niente, è
solo che sto assumendo l’atteggiamento del duro”, ho ripensato a
Please Be Patient With Me, nella
quale dici “Non importa se non mi
interessa, comunque è importante
che io ci sia”. Mi chiedo se questa
sia un’affermazione conseguente
ad un rifiuto, o il sintomo di una incapacità di comunicare emozioni…
Diciamo che potrebbe essere così, ma si
potrebbe trattare anche di qualcosa di
molto più immediato.
C’è una grande probabilità che io
abbia caricato troppo di significato delle frasi molto spontanee…
[ride] Sì e no! È anche la mia predisposizione quella di lavorare molto con
la testa - ed è questo uno dei motivi
per cui compongo versi di quel tipo.
Sia l’interpretazione letterale che l’approccio più mentale sono validi. Come
scrittore mi capita di indulgere ad un
approccio che vada oltre il significato
delle parole, ed ho capito che mi piace
molto studiare questa predisposizione
d’animo, più che il contenuto in sé. In
Low Key c’è una sola interpretazione
possibile – che mi ha dato molto da
pensare peraltro – che stigmatizza il
fatto che spesso mi è capitato di suonare davanti a platee che sembravano dimesse, troppo compassate, una
cosa che mi frustrava da morire, fino
a quando ho realizzato che si trattava
di caratteri molto affini al mio. C’è una
buona probabilità che la peggiore platea che mi possa capitare sia composta
da persone più vicine al mio sentire
che da altri, ma è davvero difficile per
69
me accettare l’idea di suonare per una
sala riempita da tanti Jeff Tweedy.
È chiaro che quest’album è nato
in un periodo molto doloroso dal
punto di vista della tua esperienza privata. C’è una relazione fra la
musica e queste sensazioni? È stato
positivo comporre, il processo creativo ti ha dato qualche sollievo?
È stato senz’altro positivo, ma non solo
per me, per tutta la nostra famiglia. È
stato un periodo difficile, e l’ansia non
si è ancora del tutto sopita, sebbene le
premesse per una guarigione completa
ci siano e questo aspetto ci sta aiutando
molto ad essere fiduciosi per il futuro.
Avevamo terminato il disco proprio
in coincidenza con l’inizio di questo
periodo così triste e per me e Spencer è
stato importante mantenersi occupati,
contribuiva a ripristinare il senso della normalità che si stava smarrendo. È
decisamente normale nella nostra famiglia che io lavori ad un nuovo disco
e questo impegna tutti i componenti,
non solo me o Spencer, anche mia moglie ed il nostro figlio più piccolo, così
tutti hanno partecipato ed hanno potuto assistere al processo compositivo
traendo un grande conforto dall’ascolto di brani che crescevano e prendevano forma a poco a poco. È stato un ottimo toccasana per allontanare paure,
tristezza e quel terribile senso di ansia,
ma spero che dal disco non traspaia
tutto questo; preferisco che trasmetta
un’emozione molto più profonda, ovvero di quanto sia salvifico accettare
di buon grado ciò che è trascendente,
che cioè non dipende dalle nostre azioni. È un disco che vuole regalare una
speranza, deve regalare una speranza
e ci siamo concentrati proprio su questo aspetto che si è rivelato poi essere
esattamente quello di cui proprio noi
avevamo bisogno. Per questo motivo
abbiamo usato il nome di mia moglie
per il titolo; lei è presente in ogni singola traccia e non c’è stato un solo momento nel quale non abbiamo pensato
a lei mentre realizzavamo il disco.
Ed in effetti il disco trasmette questa sensazione di attesa tranquilla
e fiduciosa; inoltre mi hanno molto colpito Wait For Love e Slow
Love in cui sembra possibile tro-
70
OUTSIDER
JEFF TWEEDY
vare un senso di pace, così come
Nobody Dies Anymore in cui si
raggiunge anche l’obiettivo della
stabilità.
Ti ringrazio. Diciamo che hai colto nel
segno, evidenziando il lato positivo di
questa orribile esperienza… Per fortuna abbiamo una famiglia molto unita, ed abbiamo raschiato il fondo del
barile per trovare una forza che non
mi aspettavo saremmo riusciti a tirar
fuori! Ciò che alla fine conta è quanto
ci è successo quest’anno – certo ogni famiglia ha la sua dose di sofferenze con
cui si deve confrontare, non so come si
possa fare ad uscire indenni dalla vita
che viviamo, ma ho capito anche che i
rischi aumentano a dismisura nel momento in cui ciascuno di noi comincia
a circondarsi di affetti, magari forma
una famiglia. Ho realizzato questo a seguito della nostra esperienza. Mi sono
occupato per la prima volta di mia
moglie, dal momento che in passato è
stata piuttosto lei ad assistermi ed incoraggiarmi. Aver constatato di essere in
grado di dare anch’io qualcosa è stato
per me sorprendente, anche perché
anche lei sa ora cosa io sia in grado di
dare. Non c’è nulla di semplice, non si
prova un singolo stato d’animo, la vita
è una continua girandola di emozioni
e sollecitazioni.
Hai parlato prima del tuo bisogno
di produrre qualcosa nei momenti
di maggiore sconforto, ed è bello
sentire che in effetti sei riuscito
persino a tirar fuori qualcosa di positivo.
È vero, mi hanno chiesto in molti ed
ho parlato parecchio della estrema sensibilità degli artisti e del loro destino
segnato da una profonda sofferenza.
Ma mi infastidisce questa lettura, anzi
credo esattamente l’opposto, ovvero
che gli artisti riescano a sopportare
maggiormente le sofferenze in virtù
della loro capacità di estraniarsi, metabolizzare e tirar fuori qualcosa di bello,
o di artisticamente valido: è quello che
mi succede e davvero non condivido
quanto dicono i più, ovvero che gli artisti soffrano più degli altri, o che si debba
soffrire per avviare un processo creativo. Tutto ciò per me non ha senso.
Eppure è un concetto ben radicato
nel sentire comune.
Non scherziamo, gli ospedali sono pieni di malati con patologie mentali che
non avviano alcun processo creativo,
così come c’è tanta gente felice in grado
di produrre cose meravigliose quanto dolorose. Molti sono gli esempi in
cui artisti perfettamente equilibrati in
termini di carattere abbiano prodotto
pezzi di un certo impatto emotivo ed
in generale non c’è alcun dato che possa provare scientificamente che ci sia
una qualche relazione fra arte e sofferenza. Anche se ogni volta che spunta
un qualche artista che abbia sofferto di
malattie della mente o che abbia avuto
periodi di grave dipendenza da droghe,
lo stesso viene preso come prova inconfutabile di un’affermazione che, lo
ripeto ancora una volta, ritengo assolutamente fuorviante.
Mi sembra che questo sia il periodo più lungo trascorso fra un disco
degli Wilco ed il successivo. Che
succede?
Penso che sia un bene. Da sempre i
componenti degli Wilco hanno progetti paralleli, e man mano che cresciamo
di età come di numero, anche i progetti
si moltiplicano. Tutte le volte che incontro Nels [Cline, chitarrista degli Wilco] mi racconta dei suoi ultimi cinque
dischi. Ma davvero non so rispondere
alla tua domanda, è come se stessimo
prendendo sotto gamba il lavoro degli Wilco, si davano
forse troppe cose per
scontate e c’era un
eccessivo senso di
appagamento. Sento
però che la tavolozza è stata finalmente
pulita ed è possibile aggiungere tutto
quello che solo ora
mi sembra possibile aggiungere, con
tutto il bagaglio di
nuove
esperienze
acquisite, cosa che
sarebbe stata impossibile fare se avessimo continuato a fare
sempre le stesse cose.
È uno dei punti di
forza degli Wilco:
non c’è proprio la predisposizione
ad accontentarsi, anzi c’è il desiderio di mettere da parte ciò che si è
fatto e mettere sempre nuova carne al fuoco.
Provo sempre un brivido positivo
quando cerco di andare dal punto A al
punto B, perché non so mai quale sarà
la strada che sceglierò. La cosa ideale
sarebbe perdersi nella giungla e cercare la via d’uscita. Quando suoni tutte
le tue canzoni in giro con il tuo gruppo per prolungati periodi di tempo e
poi ti ritrovi in sala di registrazione, si
può avvertire un certo distacco, viene a
mancare quella scintilla e questo a volte può spaventare perché puoi pensare
di essere alla frutta, di non avere più
nulla da dire. Un altro ottimo motivo
per fare una lunga e rigenerante pausa.
Questo lavoro da solista ha cambiato un po’ il tuo modo di vedere
gli Wilco?
Assolutamente no. Anzi mi ha ispirato, ha fatto ciò che doveva fare, mi
ha dato le stesse sensazioni che credo
provino gli altri quando lavorano ai
loro progetti personali. Inoltre mi sento più energico, più produttivo ed ansioso di esplorare nuovi territori con il
mio gruppo. È questa la mia prossima
meta.
© IFA - Amsterdam, 2014
Traduzione di Davide Lancieri
OUTSIDER
71
UNCLE TUPELO
NO DEPRESSION – REISSUE 2014
di Robin Smith
Per darvi un’idea di quanto sia importante questo disco, tenete conto
di questo: non soltanto è l’album
che prende il nome dalla canzone
dei Carter Family – un classico
country da cui gli Uncle Tupelo
hanno tratto ispirazione – ma di conseguenza è anch’esso eponimo delle
successive band di questo genere
che si sono unite nel prendere ispirazione dall’album e dalla sua eredità.
Troppo importante per il suo stesso
bene? Con discussioni che sembrano
correre avanti e indietro come è successo esattamente per il genere poco
sorprendentemente intitolato ‘no
depression’ e con la band che aveva
la tragedia scritta su tutta se stessa dopo bizzarre ricadute, è difficile non sentirsi come se lo spettacolo di Farrar e Tweedy
avesse avuto crudelmente quello che si meritava per aver apparentemente dato ai moderni fan del country il loro album
tipo “non ci avevo mai pensato!”.
A questo punto nel tempo, due terzi Son Volt e un terzo Wilco, sembra fissato nella storia che il 1990 segni l’anno che rappresenta i Tupelo in un fronte assolutamente unito. Siccome
Farrar dà la colpa, qualunque cosa accada, ai problemi comunicazione, raramente per il loro debutto hanno l’espressione
giusta per affrontare il gioco. I Tupelo potrebbero essere visti
come una band dal duplice ego non ancora rivelato totalmente, e le canzoni si adattano facilmente alla storia: Farrar
e Tweedy cambiano le parti principali del testo di quasi tutte
le altre canzoni e in modo così prosaico, come se non bastasse – bisogna arrivare fino a oltre Graveyard Shift, That Year e
Before I Break per trovare quella catena per frenare temporaneamente. Sarebbe semplicemente sbagliato dipingere Farrar
come un maniaco del controllo, modo in cui viene descritto
spesso, come quando Tweedy usa l’album come se fosse il suo
personale forum per due canzoni, mentre Farrar lo fa una volta sola. Le canzoni di Tweedy sono di un rock dolce/amaro,
Train che è la sorella più evoluta della più coraggiosa Flatness
e che schiaccia l’etica country della band con il suo sound semplicemente fantastico – chitarre, batteria e il resto. Farrar è il
suo corrispettivo in ogni aspetto con la semi-profetica So Called Friend che sfreccia ad alta velocità. Il lavoro di squadra del
gruppo a mala pena si distingue da quei tentativi individuali
di successo, ma la collaborazione civile fa miracoli: Life Worth
Livin è una delle più grandi pugnalate della band al cuore lancinato dal dolore, e quella non è per nulla un’impresa facile
quando sai scrivere una canzone bella quanto Still Be Around.
Musicalmente gira tutto intorno
alla sensazione; con una maggiore
semplicità sarebbe un cliché, ma la
sua esecuzione è perfetta e diventa
un vero ritorno a Guthrie: “It seems
we’re all looking for/a life worth
livin’” (“Sembra che stiamo tutti cercando una vita che valga la pena di
essere vissuta”).
Potrebbe essere un segno di giovinezza cocciuta il fatto che le due cover country tradizionali dell’album
spiccano alla grande in No Depression, ma è più probabile che ci mostri
la band come (per ora) dei performer
più che come dei compositori; John
Hardy e No Depression funzionano quasi come compensazione per una band che, come dichiarò il batterista Heidorn,
sentiva solo di contribuire a una lunga linea storica di scarse
registrazioni country. Invece di prendersi la loro corona come
re del country alternativo, il loro continuo impegno nei confronti delle loro radici è ciò che colpisce maggiormente: No
Depression viene reinventata a partire dal suo sound gospel
anni ‘40 e ribaltata con uno slancio affascinante, anche se la
chitarra acustica rimane la stessa per entrambi i gruppi. John
Hardy prende il sopravvento su Lead Belly e fa un lavoro simile di mantenimento del suono ma a un ritmo impercettibile
– qui i Tupelo alla fine lo perdono e diventano in tutti i sensi
una band più potente.
Mentre la sua reputazione è controversa – e per la maggior
parte ad opera della stessa band – quello a cui No Depression
in termini non esitanti dà inizio è la struttura degli Uncle Tupelo come dovrebbe essere. Dolci ballate inseguono ritmate
canzoni cow-punk adatte ai 13 anni, e quello che ne esce è un
disco di conflitto musicale – i Tupelo potrebbero anche stare
rendendo il loro omaggio alle icone del country, ma c’è anche
uno sgradevole dito medio che attraversa l’album troppo velocemente per delle scuse. Quello che ne risulta è una band
troppo grande per i suoi stessi stivali, ma troppo sincera perché
questo possa essere un problema.
La ristampa per la collana “Legacy Recordings”, comprende
due cd. Il primo contiene l’album originale rimasterizzato da
Vic Anesini con nuove note di copertina rispetto all’originale.
Il secondo contiene 17 canzoni della band originale risalenti
agli anni 1987-1988-1989, mai apparse su cd. Mi risulta che nella prima edizione la Sony abbia incluso nel packaging anche
un vinile in 7 pollici con la cover di I Wanna Be Your Dog degli Stooges e Commotion dei Creedence.
72
OUTSIDER
JEFF TWEEDY
WILCO
DO YOU STILL LOVE ROCK AND ROLL?
FIRENZE // OBIHALL – 11.10.201
di Alessandro ‘ Pumba’ Nutini
Ogni tanto, lo ammetto, anche io mi
faccio venire dei dubbi. Da solo, a notte fonda, magari dopo una serata storta, ecco, può capitarmi di pensare che
forse se il 99% di quello che sento definire “epocale”, “imperdibile”, “capolavoro” mi risulta eccitante meno del
ricordo di nonna che, arrancando, si
avvicinava ad pentola con l’evidente
intento di lessare delle patate… questo sia da attribuire unicamente a mie
manchevolezze. Forse è l’età, ho ascoltato troppa musica, via: un tempo ci
dicevano ammiccando che riguardo
al rock non dovevamo fidarci mai di
chi avesse più di trent’anni, e adesso
che abbiamo ampiamente scollinato
forse dovremmo semplicemente tace-
re ed osservare, senza battere ciglio, gli
stadi (o i palazzetti o quel che volete
voi) riempirsi di discepoli adoranti artisti che hanno scritto al massimo una
mezza manciata di pezzi buoni - se
proprio va bene un disco (qualità comunque sufficiente a surclassare il resto della truppa, dato che nel paese dei
ciechi l’orbo è re). Certo, per uno che
da sempre ha come sogno ricorrente
quello di salvare l’umanità – riguardo
il salvarla da cosa il mio inconscio non
ha ancora dato risposte precise, ma
sarà sicuramente qualcosa di futile e
stupido (cit) – è ben difficile rassegnarsi. Al tempo stesso, pare che combattere contro i mulini a vento porti spesso
all’ulcera.
L’ulcera, magicamente, scompare
quando ascolto i Wilco. Perché rinsaldano il mio ego, le mie certezze;
e quando il buon vecchio (?!?) Jeff
Tweedy ti chiede “Do You Still Love
Rock And Roll?” la consapevolezza
che stai dicendo la verità nel risponderti mentalmente in maniera più
che affermativa, si accompagna alla
voglia di urlare a tutti “basta che sia
tu a farlo, perdio!!!”.
I Wilco, magicamente, riescono ad
essere la migliore band in circolazione per chi ami l’American Music
(così non dobbiamo perder tempo a
definire generi, tra alternative folkster, post-rockers, new guinness, one
OUTSIDER
shot mentre stappo un’altra song con
percentuali blues, country-billy con
venature low-fi, e anche un po’ sticazzi). Nei Wilco puoi trovare l’eco di 60
anni di musica popolare americana,
dal cantautorato folk ai Pixies, dalla
dilatazione psichedelica alla violenza
punknoise al pop ma mai, mai sembrano diventare qualcos’altro con
non loro stessi. Sanno essere delicati
come il velluto e immediatamente
dopo violentarti i timpani, e sempre
con la stessa classe, anzi di più: con
una facilità disarmante. Sono meravigliosi musicisti, uno dei migliori
interplay che a mio avviso si possano ricordare in una rockband. Questo
interconnessione permette loro non
solo una monolitica compattezza,
ma la possibilità di mantenerla pur
avventurandosi in avventure dinamiche impossibili alla quasi totalità
dei gruppi rock contemporanei (per
i quali la dinamica generalmente è
data solo dal suonare/non suonare il
proprio strumento durante l’esecuzione di un brano).
Certo che per avventurarsi in certi
territori bisogna saper scarpinare con
destrezza. La grande bravura dei singoli musicisti che, baciati dalla sorte,
si tramuta in una grande band che
suona come un sol uomo potrebbe
ugualmente tradursi in un risultato pressochè disastroso (la storia del
rock è piena di esempi di famigerati
“supergruppi”, generalmente roba da
dio-ci-scampi); mentre i Wilco invece
non scarpinano nemmeno: volano.
Perché, a differenza della quasi totalità di ciò che ci circonda da un po’ di
anni – con qualche nobile eccezione,
naturalmente – associano alle citate qualità una fantastica capacità di
songwriting. Senza la quale, nel rock,
è un po’ come voler fare i pici senza
l’aglione (orrore!).
Se devo trovare una tendenza nel
rock contemporaneo, diciamo almeno negli ultimi due decenni (ma in
realtà ciò che penso è che non siamo
davvero usciti vivi dagli anni ’80), è
l’involuzione del songwriting a favore della ricerca di groove & sound.
Non so come si sia arrivati a questo,
ma sospetto che il virus si sia auto
innestato quando la gente ha iniziato a dire “senti che suono fantaaaaaastico ha questa batteria/chitarra/
quelchevuoitu!!!” piuttosto che “senti
come suona bene questo batterista/
chitarrista/quelchevuoitu-ista!” e, prima ancora (i bei tempi andati), “senti
che meraviglia di canzone”. Ormai
scrivere canzoni è un optional, e nessuno ci fa più caso. Tanto che banali
scopiazzature, se ben fatte, diventano
73
irrimediabilmente blockbusters. Beh,
verso la fine del concerto dopo aver
ascoltato un repertorio che nel panorama attuale ha pochi eguali (Jesus
Etc., Hummingbird, Art Of Almost,
Misunderstood, Ashes Of American
Flags, Always In Love, Heavy Metal
Drummer, I’m The Man Who Loves
You e I’m A Wheel sono semplicemente tra le più belle canzoni rock
scritte negli ultimi tre lustri), ho pensato che se domani accendessi la radio e per due ore
sentissi la stessa qualità di
songwriting che ho sentito nelle due ore di stasera,
probabilmente penserei
immediatamente di essere stato teletrasportato da
qualche altra parte (e in
qualche altro tempo). Domani invece mi sveglierò,
la radio passerà tumiportisùpoimilascicadere, leggerò di Jovanotti a New
York, poi arriveranno anche i Coldplay ed io avrò i
miei soliti scatti d’ira.
Scrivere canzoni, capacità
sempre più rara. Capacità
nella quale i Wilco, meravigliosi interpreti del
più bell’American Sound
attualmente in circolazione, sono maestri. The ‘best
band in town’, per me.
Prosit.
74
OUTSIDER
JEFF TWEEDY
YANKEE HOTEL FOXTROT
di Brent S. Sirota // 2002
Dicono che il Mito sia la parte nascosta di ogni storia. Il 23
di aprile, Yankee Hotel Foxtrot vedrà la luce, dopo aver trascorso lo scorso anno avvolto dal suo stesso mito caotico: una
gestazione ermetica in studio con l’imperscrutabile guida
del mago di Chicago Jim O’Rourke; litigi intestini; conflitto,
e risoluzione del medesimo, con il gigante dei media americani AOL Time Warner; una pubblicazione sinistramente
prevista per l’11 settembre ma misteriosamente rimandata;
le indecifrabili profezie delle radio a onde corte e, casualmente,
il benvenuto finale dell’eroe ai
primi entusiasmanti giorni di
primavera. Tutto qua: il miracolo
della nascita, l’eroe improbabile,
il...mmm... mentore benevolo, la
minaccia primordiale, il bene che
vince il male. Joseph Campbell se
la farebbe addosso se non fosse
morto.
La narrazione miracolosa della
nascita del quarto album dei Wilco, Yankee Hotel Foxtrot, è già
roba passata: bandito dalla Reprise della Warner dal giudizio mostruosamente miope dei dirigenti
dell’etichetta che hanno giudicato il disco uno da “fine carriera”,
i Wilco hanno passato il disco tramite lo streaming dal sito
Yankee Hotel a qualche milione di persone prima di firmare
con la stramba sotto-etichetta progressiva Nonesuch della
Warner. La via che conduce alla luce la Time Warner è lunga
e dura, temo. Ma le circostanze uniche della lunga gestazione di Yankee Hotel Foxtrot paiono fatte per le chiacchiere
inutili di un qualsiasi dj prima di lanciare Heavy Metal
Drummer.
Il ritardo prolungato e lo streaming hanno collaborato per
garantire che chiunque al mondo avesse già sentito Yankee Hotel Foxtrot in parte se non interamente, prima della
pubblicazione. L’ampia circolazione digitale, la controversia
aziendale, e il ronzio come di uno sciame di vespe hanno
fatto di tutte le recensioni una sorta di ripensamento nel
migliore dei casi. Ma il mito è sempre un ripensamento e in
questi giorni, il motivo su cui mi piace di più soffermarmi è
senza dubbio quello dell’Eroe Improbabile. Chi avebbe mai
previsto un disco di questa portata dai Wilco? Per quanto io
ami il gruppo, la verità è che sono stati insieme per cinque
anni prima di produrre qualsiasi cosa che potesse competere
con March 16-20 1992 o Anodyne degli Uncle Tupelo. AM
è quasi da dimenticare, mentre l’esteso Being There, anche
se talvolta ispirato, viaggia su sentieri strabattuti da Tom
Petty con Damn The Torpedoes se non dai Flying Burri-
to Brothers. Il doloroso Summerteeth del 1999 era esponenzialmente più sofisticato di qualsiasi cosa precedente,
sebbene le sue allusioni all’eroina, ombre di abusi domestici e impulsi a omicidi notturni stavano malamente a proprio agio con gli arrangiamenti pop attraenti e contagiosi.
Certamente Summerteeth era strano e maestoso, oscuro in
qualche modo, una deviazione dal genere country alternativo che Jeff Tweedy aveva contribuito a inventare. Ma da
Yankee Hotel Foxtrot Tweedy è
retroattivamente divenuto molto più di un messaggero di cose
che sarebbero venute in seguito.
Sotto pressione dal Chicago SunTimes per aver abbandonato il
country alternativo, Tweedy ha
sdegnosamente lasciato in eredità
il vecchio suono dei Wilco a Ryan
Adams.
E non puoi sempre ritornare a
casa.
Quindi Yankee Hotel Foxtrot giustifica le controversie, i ritardi e
lo scalpore? Tutti, penso, sanno
già che la risposta è sì; tutto quello che posso offrire è aggiungere
“anch’io” e ripeterlo. E dopo sei
mesi passati con una copia bootleg, la musica è sempre valida. Complessa e pericolosamente orecchiabile, sofisticata e provocatoria nei testi, rumorosa e in qualche modo anche serena, il nuovo album dei
maturi Wilco è semplicemente un capolavoro; è ugualmente meraviglioso ascoltato in cuffia, in auto, alle feste. E come
sa chiunque abbia visto la diversità del pubblico che affolla i
concerti dei Wilco, troverà appassionati tra gli hippies, i conformisti, gli scolaretti mangiatori di acido e i burocrati delle
etichette minori. Nessuno è troppo adatto a questo disco: e
lui è migliore di noi tutti. E riguardo a tutte quelle chiacchiere sulle influenze terminali di moda – Jim O’Rourke, il
rock tedesco, e il Conet Project – Yankee Hotel Foxtrot rievoca una classica radio rock nel fine settimana del 4 di luglio.
E tutto questo va oltre i confronti alternati con Byrds/Beatles/Stones che vivacizzano qualsiasi recensione mai scritta
su Wilco; Yankee Hotel Foxtrot rievoca gli Steely Dan, gli
Eagles, Wings, Derek & The Dominos e Traffic. Lo sconnesso e delicato piano che guida I Am Trying To Break Your
Heart è morbidamente corretto con rumore, fischi e percussioni alla rinfusa. Come se fosse il nipotino di A Day In The
Life. La pacata Kamera è oscuramente strimpellata con chitarre acustiche e elettriche; le cinguettanti parti elettroniche
in sottofondo non mitigano il confronto con le intelligenti
precise influenze jazz-blues rock dello splendido debutto dei
OUTSIDER
Dire Straits. L’inno alla psichedelia country di War On War
avrebbe potuto essere figlia di una jam di una bollente Bertha a un concerto dei Grateful Dead del 1973. Il violino e
l’atmosfera fumosa country di Jesus, etc richiama alla mente
i mitici settanta con il suo contenuto d’amore e l’odore delle
sigarette.
L’acuto e balbuziente assolo di chitarra che apre I’m The
Man Who Loves You potrebbe essere stato preso dall’interno
di un brano elettrico di Neil Young all’epoca di Everybody
Knows This Is Nowhere. Per tutta la sua aura, profonda e
stratificata, Yankee Hotel tende a venir fuori sincera come
le radio FM dei bei giorni andati. I Wilco godono del beneficio del dono di O’Rourke per aver tirato dritto alle viscere di
ogni stile, senza il peso di un marchio di fabbrica. E Tweedy
sembra esser divenuto un buon paroliere. Trasalisco ancora
quando lo sento cantare “ So che non parli molto ma sei un
ottimo conversatore”, su Being There. La meditabonda introspezione di Summerteeth costruita su una manciata di
testi eleganti, la scheletrica bellezza di She’s A Jar dove “lei
mi ha scongiurato di non perderla” ritorna come il doloroso
“lei mi ha scongiurato di non picchiarla” trasformando una
malinconica canzone d’amore in qualcosa di delicatamente
brutale. Ma su Yankee Hotel Foxtrot Tweedy diventa quel
75
che pensavo che fosse: un ottimista ed un romantico.
La sua dichiarazione di voler onorare “le ceneri delle bandiere americane” è meno cinica di, forse, la nostalgia dei
convinti liberali per un onesto patriottismo. “Tutte le mie
bugie sono sempre desideri” canta, “So che potrei morire se
tornassi indietro nuovo”. La dichiarazione finale su Yankee
Hotel Foxtrot è di una passione profonda : “ Ho avuto riserve
riguardo molte cose ma non su di te”. C’è un mondo più vero
da scoprire.
Su Summerteeth Tweedy ululava di “presentatori che parlano in codice” e pensavo di quel ritornello da I Can’t Stand
It dove avevo sentito per la prima volta le parole yankeehotel-foxtrot pronunciate dalla donna inglese incorporea
sulla sublime raccapricciante raccolta di trasmissioni di radio a onde corte, Il Conet Project, appunto, che è campionato sporadicamente lungo tutto il disco. E in un mondo più
profondo e ponderato, forse potremmo tracciare quella linea
per svelare lo stupore segreto del nuovo disco dei Wilco. Ma
io non credo che ci siano segreti; e non credo che ci siano codici. Dietro la grande storia di Yankee Hotel Foxtrot ci sono
tutte le retoriche e i simboli e le coincidenze di una piccola
mitologia; ma sopratutto c’è un disco rock fantastico. E perché dirvelo? Lo sapevate già.
I 4 CAVALIERI DELL’APOCALISSE
Di Max Stefani
LA STORIA DI
JEFF BECK, ERIC CLAPTON,
PETER GREEN, JIMMY PAGE
IN USCITA A MAGGIO 2015
La storia dei quattro grandi chitarristi inglesi
nel periodo 1960-1972
240 pagine, formato 30x22 cm, 182 foto, 25 euro.
Pre-ordinazione scrivendo a:
[email protected]
76
OUTSIDER
2014 BEST
2014 BEST
a cura di Max Stèfani
Per un giornale come ‘Outsider’ che fa dell’approfondimento del passato la sua merce più rara,
mettersi a costruire un elenco delle cose migliori uscite quest’anno, sembra una forzatura.
Ciò non toglie che 40 nuovi dischi targati 2014 (in effetti ci ho messo anche qualche cosina
uscita a cavallo 2013/2014) per cui vale la pena spendere quei quattro soldini in più che girano
a dicembre ci sono. Sempre di gusti personali si sta parlando, quindi prima di comprare un cd
andate su Spotify.
Lucinda Williams, Jackson Browne, Dianna Cohen (Paul Redmond/WireImage)
OUTSIDER
77
OLD MAN
JOHN MELLENCAMP – Plain Spoken
JACKSON BROWNE - Standing in the Beach
LEONARD COHEN - Popular Problems
PRINCE - Art Official Age/ Plectrumelectrum
RICHARD THOMPSON - Acoustic Classics
CHUCK E WEISS - Red Beans And Weiss
WILKO JOHNSON/ROGER DALTREY - Going Back Home
DAVID CROSBY - Croz
Il disco folk-rock dell’anno è per me quello di John Mellencamp, PLain Spoken. Un disco che scorre con brio, intriso di
folk e blues rurale, country urbano e le solite immancabili influenze dylaniane e Guthriane.
Jackson Browne arriva a sorpresa con un lavoro che dà la
birra ai tanti, troppi, babbioni del disco a tutti i costi con mezzi
semplici ed idee musicali non avanguardistiche né sperimentali (e perché poi cercare e volere le novità a forza? A noi piace
l’artista così come l’abbiamo sempre conosciuto ed ammirato),
con una manciata di dieci tra canzoni e ballate nel suo stile
senza orpelli e trucchetti vari, e va dritto al cuore facendo la
felicità di vecchi e nuovi seguaci.
Popular Problems è il secondo album in due anni di Leonard
Cohen. Come in Old Ideas (2012), i brani sembrano degli spogli inni, trattenuti da un mistero soggiacente—sembra che stia
raccontando tutto, ma senza scoprire mai le carte. Quella piatta
voce da corno antinebbia degli anni ‘70 è diventata inquietantemente senza fondo, le spoglie di una voce ora sparita.
Art Official Age è il più solidamente melodico dei due, Plectrumelectrum è il più divertente, con Prince che scatena le sue
note (e impolverate) abilità alla chitarra. Due buone aggiunte
al catalogo, le migliori di Prince dal 2004.
Non va sottovalutata la gioia nel risentire suonare con tanta
energia un musicista che, più o meno un anno fa, aveva dichiarato di avere un male incurabile e di voler concludere la
propria vita in giro per il mondo a suonare. Wilko e Daltrey
si conoscono da una vita, entrambi grandi fan di Johnny Kidd
& The Pirates, fonte d’ispirazione tanto per gli Who che per i
Doctor Feelgood. L’album rappresenta un omaggio ad un musicista che, in vita, non ha mai potuto godere del successo che
meritava e il cui nome, nel nostro paese, in molti nemmeno
conoscono. Going Back Home è un album fresco, vitale e con
un energia “old school” che commuove.
Acoustic Classics di Richard Thompson è un’ora di performance live libera dai rumori della folla, con una intimità che
cattura gli ascoltatori, dando l’impressione che l’artista si esibisca solo per loro. Da un artista eccezionale e influente cosa si
può chiedere di più?
Non avremmo scommesso un euro sul “ritorno” di Crosby.
E invece... il vecchio leone ha realizzato una delle sue opere
migliori. Quella di Knopfler non è l’unica presenza di prestigio
del disco – c’è un ineccepibile Wynton Marsalis in Holding On
To Nothing – ma va dato atto a Crosby di non aver puntato
sugli ospiti di lusso o sui vecchi amici per andare sul sicuro e
per creare attesa intorno al suo progetto. Ha sempre dalla sua
una voce inconfondibile e incredibilmente integra, un modo
di suonare la chitarra ritmica tanto semplice quanto efficace e
78
OUTSIDER
2014 BEST
TOM PETTY - Hypnotic Eye
PETER BUCK - I Am Back to Blow Your Mind Once Again
BRIAN SETZER - Rockabilly Riot! All Original
DANIEL LANOIS - Flesh and Machine
un tocco magico nelle armonie vocali.
Anche se oggi il blues può non riscuotere tanto successo tra i
giovani ascoltatori come un tempo, sicuramente sì però tra voi
lettori di Outsider, Red Beans and Weiss di Chuck E. Weiss
cattura alla perfezione i ritmi e i gemiti di questo genere, imponendo all’ascoltatore di fermarsi ad assaporare le sue melodie
piene di passione. Il disco è un viaggio sulle parole tra bettole
honky-tonk logorate dal tempo, le ferrovie della Seconda Guerra Mondiale, i territori nascosti di un gatto randagio e tanti altri vibranti panorami. L’album è la quintessenza del poetico e
appassionato blues di Chuck, abbracciando il vero spirito del
genere: una sinergia tra parole e musica. Sentite Shushie, che
pare s’ispiri a un gatto randagio salvato da Weiss. Si fonda sul
burroso sax di CC Worall Rubin e sulla trance indotta dal basso
di Will McGregor. È il particolarissimo stile poetico beatnikblues di Weiss, al suo meglio. Gli ascoltatori schioccheranno
le dita e batteranno il piede al suo torrido beat. Senza dubbio
il suo miglior album sino a oggi, un pazzesco blues-rock R&B.
MEZZA ETÀ
LUCINDA WILLIAMS - Down Where The Spirit Meets The
Bone
DAVE & PHIL ALVIN – Common Ground
JOHN HIATT - Terms of My Surrender
Un grande disco dal vivo per Lucinda Williams. Il
country resta un punto di riferimento anche per DWtSMtB, anche se il disco va molto più in là. C’è molta improvvisazione alla chitarra, inclusi gli assoli elettrici di Burning
Bridges e Foolishness che si rifanno al rock anni ‘70.
John Hiatt è un cantautore americano che su Outsider conoscete tutti e che ha fatto centro attorno al 1987 con Bring
the Family (stringendo un forte legame Ry Cooder, Nick
Lowe e Jim Keltner: assieme, il dimenticato supergruppo
Little Village) e andò avanti così per circa un decennio, con
classici cult come Slow Turning. Hiatt invecchia con grazia; non è uno di quelli che da un momento all’altro potrebbero finire in un qualche scandalo sessuale, ed è giusto.
Ha visto di peggio, ma si tiene bene.
Terms of My Surrender lo conferma: puro blues. Qui non
c’è lo Hiatt pulito. Qui c’è ruvidezza scarna. Una scelta
appropriata all’età. Hiatt ha 61 anni, e il blues è uno strumento espressivo più che adatto x lui. Canta in un registro
scuro, e lo fa bene. Un disco che gronda autenticità – disse Keith Richards che il blues non te lo insegnano i frati:
e Hiatt ha una vita vera. Non è saltato di botto sul carrozzone del blues – ha da sempre un gusto southern: a inizio
carriera apriva a John Lee Hooker, è stato spesso in tour con
Robert Cray, e Buddy Guy ha inciso una sua canzone. Il
22° album di Hiatt è una meravigliosa, e speriamo che non
molli mai il colpo. Un suono glorioso che ogni volta ripete
implacabile le pagine più belle della musica degli ultimi 50, 60
anni, partendo dalle basi solide del blues per poi gettarsi in un
viaggio mozzafiato nei decenni del rock’n’roll.
C’è chi lamenta che Tom Petty non scriva più le canzoni straordinarie che scrisse nei 70, 80 e 90 affidandosi per comodità a
schemi di routine, i classici giri del blues e del rock’n’roll basico, e può essere vero, ma non tiene conto di cosa siano diventati lui e compagni. Ovvero la più straordinaria rock’n’roll band
esistente. Hypnotic Eye riparte là dove lo straordinario Mojo
era terminato.
Ma com’è I Am Back to Blow Your Mind Once Again di Peter
Buck? Selvatico, arruffato: il secondo album solista dell’exR.E.M. porta avanti il ‘primitismo’ del disco precedente, fondendo garage, psichedelia lo-fi, puro pop e caldi momenti da
stadio perfetti per una scaletta dei R.E.M.
I fratelli Phil e Dave Alvin riuniti per un tributo a Big Bill
Broonzy. Il risultato è spettacolare. Broonzy fu uno degli autori più prolifici del suo tempo: più di 300 titoli editi, dal delta
blues, il blues elettrico di Chicago fino a vere canzoni di protesta come Just A Dream, pezzo audace per l’epoca - Bill andava alla Casa Bianca, e parlava col Presidente. Qua gli Alvin gli
danno vita e benzina.
Rockabilly Riot! All Original di Brian Setzer non cambierà
certo l mondo o chissà che, ma è puro rock and roll ragazzi!
Daniel Lanois mi avrebbe fatto godere come un’anguilla se
l’album fosse durato qualcosa più dei 36 minuti che raggiunge.
OUTSIDER
CONFERME
SONDRE LERCHE – Please
TWEDDY – Sukierae
NENEH CHERRY - Blank Project
JASON ISBELL – Southeastern
CHRIS ROBINSON BROTHERHOOD - Phosphorescent
Harvest
BARZIN - To Live Alone In That Long Summer
RICH ROBINSON - The Ceaseless Sight
JACK WHITE - Lazaretto
RAY LAMONTAGNE - Supernova
BECK – Morning Case
DAMIEN RICE – My Favourite Faded Fantasy
Please di Sondre Lerche è un sorprendente capolavoro pop.
In Sukierae Tweedy e suo nipote, portano avanti il powerpop degli ultimi lavori degli Wilco, ma le canzoni si distinguono per un più austero uso di chitarra e batteria. Un album
più simile a Sky Blue Sky, sia nell’aggressiva disinvoltura che
nelle ripetizioni che a volte si cagliano fino al tedio. Curioso e
interessante.
Blank Project, primo album solista in diciotto anni di Neneh Cherry, suona sia come l’apice attuale del suo lavoro sia
come un album volutamente smorzato. Blank Project è maturo, perché in decenni di musica Neneh ha imparato a usare
voce e testi per dire esattamente ciò che vuole come vuole.
Nessun declino, nessuna irrilevanza. Blank Project è il suo
album migliore, e dimostra che è un’artista sempre in crescita.
Jason Isbell è stato membro chiave dei Drive-By Truckers.
Adesso brilla ancora di più, perchè ha scritto svariate canzoni
(Outfit e Decoration Day in particolare) così straordinarie che
un giorno andrebbero iscritte nel corso di studi di un master
in composizione. Il tutto condito da piccoli accenni ai maestri
Townes Van Zandt, Prine e Willie Nelson.
Con la pubblicazione del loro terzo album in meno di due
anni, la Chris Robinson Brotherhood ha fatto in modo di
conquistarsi un posto nella storia del rock&roll — nello specifico uscendo dall’ombra dei Black Crowes. Brano dopo brano,
la band crea strati su strati di musica e voci di una bellezza
cosmica, costruendo intanto un’esperienza che non sembra
mai affrettata o eccessiva. L’album vive di una sorta di imprevedibile coerenza; appena credi di averne afferrato il sound, la
band cambia marcia, mantenendo però un senso di familiarità. Phosphorescent Harvest ricorda, a volte, le classiche band
rock jam. Tuttavia la band porta l’album in una direzione
completamente nuova, diretta verso un futuro che si sta costruendo da sola, come se fosse l’unica a sapere come arrivarci.
È tornato Barzin, il poeta canadese originario dell’Iran con
un disco a tratti impossibile da ascoltare, per quell’urgenza
carica di dolore nel descrivere la sofferenza come raramente si
era ascoltato nella storia della canzone d’autore. Inevitabili le
citazioni di Cohen e Dylan.
Il terzo lavoro solista di Rich Robinson vede il chitarrista
immerso in un solco familiare e assieme nuovo. Comporre per
i Black Crowes e per se stesso negli ultimi 25 anni ha forgiato
il suo stile musicale: ma, con The Ceaseless Sight, Robinson
si è assicurato un posto suo nella storia del rock&roll. Un al-
79
80
OUTSIDER
2014 BEST
bum così ricco d’influenze da poter uscire presto di strada e
perdere subito l’attenzione dell’ascoltatore. Robinson però fa
in modo che non accada, creando un suono coerente, variegato di punti toccanti, tutti orientati a costruire la stessa cosa: il
progresso. La band può scivolare con successo da una canzone meravigliosamente melodiosa come In Comes the Night
direttamente dentro alla giocosa e funky Inside; questo tipo
di fluidità è costante, dall’inizio alla fine. La sequenza dell’album crea un vero viaggio dinamico per chiunque abbia voglia di ascoltarlo.
Il periodo degli White Stripes ha reso Jack White un’icona
rock. Il suo debutto solista nel 2012 con Blunderbuss, dimostra l’abilità di White nel ricreare quel sound anni ‘50 e ‘60
che tanto ammira, in un modo che è assieme ortodosso e contemporaneo. Suona come un artista classic rock, forse l’ultimo
della sua specie. Sembra arrivare davvero dall’epoca d’oro del
classic rock; si trova bene nel presente, ma è molto più capace
nei trucchi della vecchia scuola di quanto non lo siano i suoi
contemporanei. È per questo che Lazaretto, il secondo lavoro solista, è così solido e rock. Un pezzo come Just One Drink
sembra un catalogo di standard blues, ma è l’esecuzione a
essere magistrale. White sa bene che standard non vuol dire
banale. Il blues ha avuto il suo ruolo in Blunderbuss, ma è
di certo la spina dorsale di Lazaretto. Questo è un eccezionale
album rock fatto da un tizio che è davvero la rockstar che mira
a essere.
Ray LaMontagne fa parte di quell’onda di talentuosi artisti
roots-rock che, in quest’atmosfera commerciale in cui i fans
cercano tregua dalle percussioni digitali, le voci in auto-tune
e freddi sintetizzatori. Il suo mito è Stephen Stills. Fa classic
rock — con quel groove delicato e appassionato che parte dalle strimpellate acustiche e arriva a una voce che imita un Van
Morrison sottile e arioso. Perché un artista del nuovo millennio non dovrebbe rifarsi a un’epoca d’oro della musica popolare e coglierne gli aspetti migliori? Perché non tornare a voci
dolci e belle come quella di Stills o di Morrison? Perché Bob
Dylan non dovrebbe galleggiare su una diafana nube di suono, immerso in una produzione degna del nuovo millennio?
Perché il roots-rock-folk deve sempre suonare così radicalmente vecchio? LaMontagne si fa strada in molti stili, quasi
tutti ottimi. Il risultato vi cullerà fino a domattina.
Con Morning Case Beck arriva a rimescolare le carte in tavola. È il primo album di brani originali di Beck in sei anni e
che si tratta di un’opera meditata ed elaborata a lungo. Il paragone con Sea Change è inevitabile, ma Morning Phase ci
sembra perfino superiore: è come se i ricordi della sua infanzia avessero finalmente trovato un solido approdo e si fossero
trasformati in realtà. Con Beck siamo sempre di fronte a una
creatività fuori dal comune.
Damien Rice …. Sono passati 8 anni dal suo formidabile debutto O e My Favourite è ancora un grande album. Una parte
della critica ha criticato i testi (soprattutto Pitchfork) ma Rice
non è cambiato come cantautore, certamente come persona.
Nel 2006, era un ‘32-year-old romantico’ con un forte spirito
nei confronti del mondo esterno. Nel 2014, è un recluso di 40
anni, che torna davanti al mondo con un rinnovato scopo:
trovare un modo per andare avanti. Non capirlo è da scemi.
NUOVI NOMI
STEPH CAMERON - Sad-Eyed Lonesome Lady
ANGEL OLSEN - Burn Your Fire For No Witness
NICOLE ATKINS - Slow Phaser
LAURA CANTRELL - No Way There from Here
TORRES - Honery
LAURA MARLING - Once I Was an Eagle
HURRAY FOR THE RIFF RAFF - Small Town Heroes
BLACKBERRY SMOKE - Leave A Scar: Live In North Carolina
AVI BUFFALO - At Best Cickoid
ALPACA SPORTS - Sealed With A Kiss
WILLIE WATSON - Folk Singer Vol. 1
THE MEN - Tomorrow’s Hits
SAM AMIDON - Bright Sunny South/Lily-O
THE WAR ON DRUGS - Lost In The Dream
7 dischi di seguito di donne. Tutti che per un verso o per l’altro ho amato senza nessuna remora. Sad-Eyed Lonesome
Lady è l’album di debutto della cantautrice canadese Steph
Cameron. Un album acustico molto essenziale dove a volte,
mi sembra una versione canadese di Tom Waits o di Johnny
Cash. Un disco piacevolissimo. Per molti versi, dà la sensazione di un gruppo di musicisti da disco folk, ma si avvia in punta di piedi nel territorio country, con quell’armonica nei punti
giusti, e alcuni dei brani hanno anche una spavalda andatura
blues.
La voce di Angela Olsen è incantevole; suona come il risultato di un incantesimo che ha richiesto il sangue di Leonard
Cohen, la laringe di Buffy Sainte-Marie, il mood di Feist e un
vecchio microfono degli anni ‘30. Anima le sue canzoni una
strana elettricità anarchica, sempre sul punto di esplodere.
L’energia esplosiva della band al completo le dà forza, accendendo un’intensità da sempre presente nelle sue canzoni e
spingendo le fiamme più in alto.
Sono passati quattro anni da quando abbiamo scoperto Nicole Atkins, grazie a una cover di Where Did You Sleep Last
Night stupenda, vetrina perfetta per una bellissima voce piena di passione e aggressività, impregnata di blues/rock. Ora
scrive con libertà, senza legarsi a un genere, aggiungendo
nuovi suoni che creano migliori dinamiche. Sono lontani i
giorni in cui ”prometteva bene”, ora lavora a modo suo, libera
dalle ansie che di solito sono lo strascico dei cantanti che ancora devono dare prova di sé.
Laura Cantrell fa country americano. No Way There from
Here unisce una perfetta voce americana, una brillante qualità d’incisione e un affettuoso melange di country e indie
pop. Il risultato è il più solido album country dopo il capolavoro dell’anno scorso, Same Trailer, Different Park di Kacey
Musgraves. Il disco continua a passare dall’una all’altra faccia, è un caleidoscopio di forme country. Interessante.
Torres, voce di Mackenzie Scott ventiduenne di Nashville,
veicola una disperazione urgente e cruda, con cui si entra in
sintonia a un livello quasi primordiale. Un suono famelico,
tra l’abbaiare di un cane e il gemito. Gela il sangue. È al suo
primo disco. L’ha registrato quasi tutto al primo take, quasi
con la sola chitarra elettrica. I testi trattano argomenti spi-
81
OUTSIDER
nosi – bisogni femminili, abiezione, soggiogamento, dominazione – che gestisce abilmente, come giocasse con pietre
roventi. Il suo tocco sicuro su questi temi scottanti la mette
al pari di una PJ Harvey o EMA. Come loro, se serve, dipinge a grosse pennellate. La sua abilità nel cogliere e tenere
un’atmosfera suggestiva ricorda anche Songs:Ohia o la Cat
Power degli inizi. Il disco è una valanga di emozioni, legate
a un’immediatezza che toglie il fiato.
Laura Marling ha 23 anni; prima la sua età era importante:
nessun coetaneo stava facendo album così. Con Once I Was
an Eagle si può dire che è perché nessuno ha fatto album
così, mai. È però il primo album a sembrare davvero sudato
e rifinito.
È aperto, ambizioso, lontano dai cliché ultimamente accumulati dal folk. È scuro, rabbioso, persino… sexy.
Quello che gli Hurray for the Riff Raff hanno messo assieme con Small Town Heroes è una raccolta di canzoni che
parlano da e per il cuore degli Ultimi d’America, chiamandoli a una missione e a una lotta. La loro cantante ha trovato
una casa (dopo un’infanzia nel Bronx, attraversando gli Stati
Uniti, saltando sui treni merci, adattandosi a ogni nuova città, assorbendo l’intero spettro storico del panorama musicale
americano) e una ragion d’essere alla propria voce – una voce
degna e meritoria di una popolazione ben più ampia di quella
del titolo del disco. Se qualcuno ha pensato che Alynda Lee
Segarra avesse scelto la stanzialità, giudicando da Ramblin’
Gal (dall’ultimo album di brani originali Look Out Mama)
si sbaglia. La strada compare ancora molto in questo nuovo
disco della band, ma le sue radici sono ben piantate a New
Orleans, casa adottiva di Segarra.
Amate la musica invecchiata e blended come un buon Bourbon? Forse lo charme del Sud non era così puro dai tardi 70 ,
l’epoca d’oro di Blackfoot, Marshall Tucker Band, Charlie Daniels Band e Lynyrd Skynyrd. Buttateci un po’ di classici Aerosmith, Stones, AC/DC, del vero country tipo Waylon Jennings
e Billy Joe Shaver e agitate. Con un ingrediente segreto, fatale
per noi amanti del rock sudista: un pizzico di bluegrass! Lasciate invecchiare per 14 anni in botti di rovere e otterrete una
bevanda di nome Blackberry Smoke!
Avi Buffalo con At Best Cickoid fa parte dell’onda del nuovo folk americano e britannico. Ben quattro anni dall’album
d’esordio. La sua voce sottile e giocata sulle tonalità più alte
può ricordare le prime cose di Neil Young, ma il paragone non
vale per la scrittura, visto e considerato che quella del cantautore canadese è più semplice e lineare. Anche nel più grigio
dei giorni, il sole brilla al di sopra delle nuvole: e un salutare
pizzico di romanticismo a scivolarti attorno all’anima è un
metodo garantito per farsi elevare alla luce!
Anche se Andreas Jonsson è un figlio della nostra epoca di
social network e di test online della personalità (che però onestamente non so se gli piacciano), tuttavia chiunque conosca
la sua produzione come fulcro centrale degli svedesi Alpaca Sports saprà già, senza l’aiuto di alcun test, che qui c’è un
uomo dal carattere ingenuo, il cui cuore batte con gli alti e
bassi di un amore da perdere la testa.
Woody Guthrie e Leadbelly sono due tra i nomi più famosi del
folk, cui si deve buona parte del repertorio americano. Il loro
Steph Cameron
Steph
Camero
Cam
eron
Angel Olsen
Torres
Laura Marling
82
OUTSIDER
2014 BEST
suono non era pulito come quello dei folker contemporanei,
ma più vicino a quello country di Hank Williams. Malgrado le
molte imitazioni, pochi hanno colto il sound e il sentimento di
entrambi in modo credibile. Uno di questi è Willie Watson,
ex membro dell’Old Crow Medicine Show. Questo suo nuovo
album solista, Folk Singer Vol. 1, raccoglie nove brani tradizionali e un originale che del folk coglie il sound e anche lo spirito. Sarà cuore, sarà anima, sarà quello che volete ma è innegabile che Watson abbia il dono di rendere vera qualunque cosa
canti. Non ha una bella voce, i suoi adattamenti non sono elaborati o fantasiosi: ma hanno una purezza che dà loro potenza.
Con Folk Singer Vol. 1, Watson non ha solo dato nuova vita
ai classici folk: chiarisce il loro valore culturale. È una storia
appassionata e intelligente degli U.S.A., un richiamo alle radici della musica popolare. Versioni così non le avete sentite
spesso. Watson fa da anello tra la musica presente e la passata. Porta rispetto per le origini delle canzoni, ma non teme di
marchiarle a modo suo. Un nuovo campione del folk, il migliore in circolazione.
I Men non hanno mai avuto paura di fare cose grosse, ma
quegli enormi riff di chitarra non hanno mai avuto un sound
così pulito. Tomorrow’s Hits è prodotto con esperienza; ogni
nota arriva con un bagliore al neon. L’ascolto di Pearly Gates
è simile a un giro a velocità folli sulle montagne russe accorgendosi che la struttura potrebbe cedere da un momento
all’altro; eccitante e in qualche caso terrificante.
Geniale ricreatore, ambiziosissimo rianimatore, meraviglioso folklorista, archivista stantìo — chiamatelo come vi pare.
L’approccio di Sam Amidon alla musica — decostruire e
rimontare antiquati canti sacri, ballate profane e pezzi folk,
e l’occasionale pezzo da classifica — consegna al cantautore
trentunenne più della sua dose di etichette, anche quando il
prodotto finale le rifiuta tutte. Questo fa di Amidon un membro attivo di quello che il leggendario cantante e polistrumentista american Pete Seeger chiamava “il processo folk”, il
passaggio della musica folk da una generazione all’altra. Un
altro protagonista del moderno revival folk, l’inglese Cecil
Sharp, ne ha elencato i tre principi: continuità, variazione, selezione. Tre parole che dicono tutto sia di Bright Sunny South
che di Lily-O, il suo ultimo progetto con Bill Frisell.
Lungo queste dieci canzoni contenute in Lost In The Dream,
un’immagine viene lentamente a fuoco, fino a una chiarezza
rara per i The War On Drugs. Si sente l’ambiente del New
Jersey e la sua ricca eredità musicale riverberare nella traccia
principale, Red Eyes. Springsteen ha gettato le fondamenta e
i The War On Drugs, con in più ossessioni dylanesche, vi costruiscono sopra un monumento. Una colonna sonora perfetta per guidare lungo la costa di Atlantic City.
Ps – Tutti i dischi citati sono stati recensiti durante il 2014
su queste pagine. Ad esse vi rimando per approfondimenti.
Su alcuni abbiamo anche intervistato i protagonisti. La lista
non pretende assolutamente di essere quella definitiva, ci
mancherebbe. Dando un’occhiata in ‘rete’ ho visto che le
scelte sono spesso diametralmente opposte le une alle altre.
Il che mi fa pensare che siano tutte inutili. Compreso questa. Comunque se vi posso aver dato qualche ‘dritta’ ne sarei
contento.
OUTSIDER
83
RISTAMPE
Beh, si cade nel caos totale. Ormai sono il 70% del
mercato e la scelta è quanto mai variegata. In questo caso contano molto i gusti personali. In tutto
l’anno ne abbiamo recensiti un centinaio, per noi
quasi tutti indispensabili. Per quanto mi riguarda, ho comprato, e ne ho gioito molto, i seguenti:
quelli degli Allman Brothers (tutti e due , sia il Fillmore 71 che il Beacon Theatre 1992), Rory Gallagher, David Wiffen, Lowell George, i vari Rolling
Stones ‘Value’, le Basement Tapes di Dylan, Melanie, Beth Orton Central Reservation, John Mellencamp Live at Town Hall, le Midnight Ramble
Sessions di Levon Helm, il CSNY 1974, il box di
Mike Bloomfield, X con Under The Big Black Sun,
Zappa, Soul Mining dei The The, Tim Hardin Bird
On A Wire, il Made in Japan dei Deep Purple, Lou
Adler, il Miles Davis At Fillmore Bootleg Series 3, Ronnie Lane, No Depression di Lucinda Williams, Blasters, Christy Moore, Billy
Bragg, Uncle Tupelo, Lee Hazelwood, Beatles US albums… Buona fortuna. E attenti al portafoglio.
WILD THING
“Wild Thing” è la mia biografia ma soprattutto la storia della rivista “IL
MUCCHIO SELVAGGIO” dal momento in cui l’ho fondata nel 1977 fino a inizio
2012, quando mi sono messo nelle condizioni di farmi dimettere.
Con tutti i retroscena, gli interventi di tanti collaboratori, il perchè di certe
scelte, la storia di molte firme storiche, chicche, curiosità, foto
originali, copertine storiche (Berlusconi, il Papa…).
Senza peli sulla lingua come da sempre nel mio stile. Pane al pane
e vino al vino.
Ma è anche molto di più. E’ la storia di chi ha scritto, fatto vedere
o sentire musica rock in Italia dal 1960 ad oggi. Con gli interventi
dei diretti protagonisti.
Stampa (da “Ciao 2001” a “Muzak” fino a “Popster/Rockstar”,
“Rumore”, “Blow Up”, “Rocksound” etc), radio (“Count Down”,
“Bandiera Gialla”, “Per voi Giovani”, “Stereonotte”….), siti web
(“Rockol” “Rock It”…), grandi storici concerti
(Led Zeppelin, Clash, Patti Smith, Bob Marley…), locali, negozi…
Compreso una lista dei migliori dischi dal 1960 ad oggi, e dei
migliori film dal 1977.
Max Stèfani
e
ultipm
e
co i
19
soloro!
eu
Wild Thing” è un librone di 330 pagine, a colori, illustrato con 708 foto, cartonato, dal peso di 1.600 grammi, formato gigante 30x24 cm.
È ordinabile all’indirizzo [email protected] al prezzo di 19 euro, comprese le spese di spedizione,
in copie autografate e personalizzate.
SE HAI PERSO I
NUMERI ARRETRATI
PUOI RICHIEDERLI COLLEGANDOTI AL NOSTRO SITO
www.outsiderock.com
O RICHIEDERLI A
[email protected]
N. 1 GIUGNO 2013
N. 2/3 LUGLIO/AGOSTO 2013
JOE STRUMMER – STEPHEN
STILLS – GRAM PARSONS –
WAYNE COYNE – JOHN GRANT TROGGS – VAN MORRISON/JOHN
MAYALL/ERIC BURDON – JOHN
MARTYN – UMBERTO PALAZZO
PIÙ LAURA MVULA - KNIFE –
STEVE FORBERT – GENE CLARK
– DON NIX – BEATLES…
P
PINK
FLOYD – QUEENS OF THE
STONE AGE – DAVE GROHL S
B
BEN HARPER – PRIMAL SCREA – ROLLING STONE – BOB
AM
DYLAN - PHOENIX PIÙ WHO
– ALLMAN BROTHERS – DONOVAN – HENDRIX –BLACK
SABBATH…
N. 4 SETTEMBRE 2013
N. 5 OTTOBRE 2013
FRANK ZAPPA – BLONDIE
– NATIONAL – SHUGGIE
OTIS – ROD STEWART –
ALBERT KING/FREDDIE
KING/B.B.KING - GANG PIÙ
SMASHING PUMPKINS - SEBADOH – DIAFRAMMA –
IAN MATTHEWS –DELANEY
AND BONNIE…
DIAFRAMMA/FIUMANI –
NIRVANA – BOARDS OF
CANADA – PETER GABRIEL
– STEVE MILLER BAND
- PIÙ J.J. CALE – ELVIS
COSTELLO – MAVIN STAPLES – ROBERT PALMER
– FAIRPORT CONVENTION
– TOM RUSH…
N. 6 NOVEMBRE 2013
N
N. 7 DICEMBRE 2013
D
DAVID
BOWIE –
DR.FEELGOOD – EDID
TORS – CARAVAN/
T
CANTERBURY/SOFT
MACHINE – JOHNNY
CASH – BOB DYLAN PIÙ
GEORGE THOROGOOD
– DEVO – HUMBLE PIE
– SLY – KING CRULE STRYPES…
ELL
ELLIOTT
SMITH – CHUCK
BERRY – RAY DAVIES/KINKS
BER
– VA
VAN MORRISON/MOONDANCE –COMMANDER CODY
DA
–N
NINE INCH NAILS – TEHO
TEARDO/BLIXA BARGELD
TEA
PIÙ JONATHAN WILSON –
PAUL MCCARTNEY – BLACK
PA
JOE LEWIS – NINA SIMONE
JO
– HENDRIX
H
- LOS LOBOS…
N. 8 GENNAIO 2014
PETER GREEN - SMALL FACES - ARETHA FRANKLIN
- JERRY WEXLER - FLEETWOOD MAC - CREAM
PIU’ WATERBOYS - WHO
- KING CRIMSON MICHAEL NESMITH SPRINGSTEEN JUANA MOLINA EXCITEMENTS....
N. 9 FEBBRAIO 2014
F
lo
i
le
bi
on
d
isp
so
PD
MIKE BLOOMFIELD - JERRY
JEFF WALKER – BEATLES
- JEFF BUCKLEY – TIM
BUCKLEY – JUANA MOLINA
- AEROSMITH - PIÙ LAURA
MARLING - KANYE WEST
– BECK - BILLY BRAGG
- UNCLE TUPELO - DEEP
PURPLE - NEIL YOUNG –
NICK CAVE…
F
lo
i
le
bi
on
d
isp
so
PD
N. 10 MARZO 2014
N
N. 11 APRILE 2014
N
R COODER – BO DIDDLEY
RY
– QUICKSILVER M. S.
- BLACK JOE LEWIS –
KING KRULE – CHARLES
BRADLEY – REFUSED - GUY
CLARK – TOWNES VAN
ZANT PIÙ DAVID CROSBY
– BARZIN – BLASTERS –
PRINCE – PETE SEEGER –
ALLMAN BROTHERS…
H
HENDRIX
- DYLAN - TRAFFIC COLOSSEUM - BECK – STRANGLERS PIÙ WILKO JOHNSON
– ROGER DALTREY – PETER
BUCK - HURRAY FOR THE
RIFF RAFF – NENEH CHERRY
- MARL LANEGAN - LITTLE
FEAT - JOHN MAYALL - BOB
CASALE – JOHNNY RIVERS –
ROGER MCGUINN…
N. 12 MAGGIO 2014
N. 13 GIUGNO 2014
DEEP PURPLE - JOHNNY
WINTER - T-BONE
BURNETT - JONATHAN
WILSON - TOM DOWD 1
- ELTON JOHN PIÙ THE
WAR ON DRUGS - GARY
CLARK JR. - MILES DAVIS
- RONNIE LANE - BILLY
BRAGG - BOB MOULD ELBOW…
LED ZEPPELIN – YARDBIRDS
– T BONE WALKER – HURRAY FOR THE RIFF RAFF
– ROXY MUSIC PIÙ ELS CHRIS ROBINSON - CHUCK
E. WEISS – WILLIE WATSON
- LINDA RONSTADT – NILS
LOFGREN – FRANK ZAPPA
- THE X – THE THE – CLASH
- JESSE WINCHSTER …
N. 14/15 LUGLIO/AGOSTO 2014
N
N. 16 SETTEMBRE 2014
N
E
ERIC
CLAPTON - JONI
MITCHELL - TOM DOWD 2 –
THE WAR ON DRUGS –
SPRINGSTEEN - NEAL CASAL
PIÙ SWANS – JOE HENRY JACK WHITE – RAY
LAMONTAGNE – REM CSN&Y - ELP - LULU –
EAGLES - LINDA
RONSTADT –
CONOR OBERST…
A
ALLMAN
BROTHERS –
RONETTES – PHIL SPECTOR - TOP DISCHI LIVE
T
- BILL GRAHAM - WILLIE
WATSON PIÙ NRBQ – JOHN
HIATT – TORI AMOS – TOM
PETTY - BETH ORTON
– MOGWAI – HANK WILLIAMS – NEIL YOUNG –
BOBBY WOMACK –
WARREN ZEVON…
N. 17 OTTOBRE 2014
N. 18 NOVEMBRE 2014
THE BAND – GRATEFUL
DEAD – PHISH – JACK
WHITE - PHIL AND DAVE
ALVIN – GRAHAM PARKER – PUB ROCK PIÙ
BLACKBERRY SMOKE
– ROBYN HITCHCOCK –
ROY ORBISON - DYLAN
- MELANIE - CLAPTON SPRINGSTEEN - LAMONTAGNE - ALICE COOPER
- BEN VAUGHN…
RORY GALLAGHER – RIVAL
SONS – TEDESCHI/TRUCKS
– ANIMALS – JOHN LEEE
HOOKER STEVE WYNN/
DREAM SYNDICATE PIÙ
JACKSON BROWNE - JOHN
MELLENCAMP – TOM PETTY
- SUZANNE VEGA - RUFUS
WAINWRIGHT – DEVO –
GARY CLARK JR –
GRAM PARSONS…
GLI ARRETRATI COSTANO 10 EURO CADAUNO, MA PER ACQUISTI
SUPERIORI ALLE 10 COPIE, VENGONO SOLO 5 EURO L’UNO.
LE SPESE POSTALI SONO SEMPRE INCLUSE.
86
OUTSIDER
NOVITÀ
NOVITÀ
LISA LEBLANC
HIGHWAYS, HEARTACHES
AND TIME WELL WASTED EP
di Zachary Houle
VOTO DELLA REDAZIONE:
7,5
In Quebec, Lisa LeBlanc, 24enne di New Brunswick, è piuttosto conosciuta, ed è considerata un nuovo talento. Il suo
omonimo album del 2012, in francese, nella provincia ha
raggiunto il Disco di Platino, facendole guadagnare il ‘Prix
Felix’ come miglior nuova artista al Adisq Awards. È stata Artista dell’Anno e Scoperta dell’Anno ai Gamiq Awards, è un
suo brano è stato Canzone dell’Anno. Ha vinto premi anche
in Francia e in Belgio, dov’è stata in tour (oltre che in Svizzera e nel natio Canada), ed è stata nominata ai Juno Award (il
Grammy canadese) per l’Album Francofono dell’Anno.
Ora sta tentando il successo nazionale e internazionale con
un EP in inglese, Highways, Heartaches and Time Well Wasted. E gente, è splendido! Se la gioca con Sad-Eyed Lonesome
Lady di Steph Cameron per il premio ‘Canadiana’, malgrado
questo non sia un vero LP. Ma non per questo è da scartare.
Ha talento vero, non importa in che lingua canti (Del resto il
suo inglese è impeccabile.)
L’EP include cinque brani originali e la tradizionale folk Katie Cruel, resa famosa da Karen Dalton. Ma non la si direbbe
una cover, da quanto LeBlanc la fa sua. Un banjo selvaggio,
una cassa palpitante, e l’aspra voce di LeBlanc in prima linea.
Il suo stile è stato pubblicizzato come “folk-trash”, e non è sbagliato, ma il suo stile prende anche dal bluegrass e dal punk,
specialmente per quanto riguarda velocità e potenza. Tutti i
brani sono stupefacenti, ma la titletrack è degna di nota per
il suo fischio sovrapposto a una chitarra acustica strimpellata
dolcemente, come in un pezzo western dei vecchi tempi. Gold
Diggin’ Hoedown è un agile pezzo bluegrass, almeno
all’inizio, prima che la chitarra elettrica esploda e LeBlanc e la band accelerino a tavoletta. E quando nella
canzone urla “Whoo!”, si capisce che non urla a vanvera.
Si sta proprio divertendo.
Altrove si cavalca il confine tra dolcezza e durezza. La
prima, You Look Like Trouble (But I Guess I Do Too), attacca dolce e pacata: LeBlanc narra dei suoi sentimenti
per un amante, poi di colpo il volume si alza e lei prende
a correre come un cane da caccia. “Ma per qualche strana ragione, beh, vorrei che tu fossi più che un’altra canzone da cantare”, ripete, legando il privato (una relazione) al pubblico (la sua musica). La ripetizione in questo
EP ha un grosso peso. Su The Waiting List canta, “Beh,
ti darà la sua camicia, ma non il suo cuore”, ripetendolo
come un mantra. La ricorrenza delle parole dà al brano
urgenza e peso. Ma oltre all’incontro tra il country-rock
e il folk punk, c’è soddisfazione anche per i fan dell’indie. L’ultimo brano, Race Track, ha una morbida chitarra che non stonerebbe in nessun attuale disco ‘vintage indie’. E chiaramente la band porta per un attimo il pezzo a un livello diverso,
partendo da un basso sussurro per andare verso qualcosa di
più solido.
Questo breve album trae ispirazione da un road-trip in America fatto da LeBlanc nel 2013, passando per Nashville, Memphis, New Orleans, Las Vegas, Austin e San Francisco. Considerato il passo e l’urgenza dell’EP, si capisce che è nato in strada. È qualcosa che viene voglia di mettere nell’autoradio—
meglio ancora in cassetta: non si capisce perché, ma è subito
chiaro che il sound ci guadagnerebbe—e mettersi a guidare,
senza nessuna meta in particolare. Se Jack Kerouac fosse ancora vivo, forse batterebbe ancora i tasti della sua macchina
da scrivere, ascoltandoselo.
Sostanzialmente il tempo passato ad ascoltare questo EP è
ben speso. Questo EP entra nel territorio del “Oh mio dio, devi
assolutamente, totalmente ascoltarlo”. Ascoltatelo, e la giovane età di LeBlanc vi sbigottirà. Sembra così saggia, matura,
sicura. Certo, LeBlanc sarà anche già famosa in Quebec. Ora
è l’occasione per il Canada Anglofono e per il resto del mondo di godersi un’artista che presto sarà sulle bocche di tutti.
Senza dubbio, è in lizza come Scoperta dell’Anno nel mondo
anglofono. Questa è roba assolutamente essenziale, e sarete
felici non solo di averla ascoltata, ma proprio di averne fatta
l’esperienza. È, certamente, qualcosa di valido.
OUTSIDER
NOVITÀ
WEEZER
EVERYTHING WILL BE ALRIGHT
IN THE END
di Evan Sawdey
VOTO DELLA REDAZIONE:
7,5
Strano a dirsi, ma ora Rivers Cuomo ora sa che gli Weezer
fanno cagare.
Non è sempre stato così. Qualcuno dirà sempre che i loro capolavori sono The Blue Album e Pinkerton, così come The Green
Album (2001) e il suo aspro sequel, Maladroit (2002), mentre
l’abilità Cuomo nello scrivere grandi riff pop-metal l’ha reso
co-autore dell’unico brano dei (dimenticati) Cold giunto in
classifica.
Pensateci, se vi domandate quando, di preciso, sia iniziata la
loro fine.
Everything Will Be Alright in the End esiste solo perché Rivers Cuomo sa che da dieci anni gli Weezer sono passati dal
successo di vendite e critica all’essere lo zimbello dell’industria musicale. Beverly Hills aveva il suono di Cuomo che
svendeva la propria anima, i suoi testi mostravano solo una
vacua fame-di-fama, e da lì in avanti è andata sempre peggio.
Lo conferma Raditude, del 2009: il peggior album mainstream
del decennio.
Con mosse ottuse come passare a un’etichetta hardrock come
la Epitaph (e subito pubblicare un disco in collaborazione con
artisti da Top40) o quella nauseante serie di clip su internet, gli
Weezer, tentando di fare musica la più easy possibile, hanno
in realtà ridotto la loro ‘fanbase’ ai soli fedelissimi. Ma anche
questi sono stati messi a dura prova da quest’incessante getto
di materiale incongruo: solo le demo di Cuomo e le rarità sanno richiamare alla mente i bei vecchi tempi.
Che sorpresa, allora, quando l’esplosivo testo di Back to the
Shack, primo singolo di Everything Will Be Alright in the
End‘, ha toccato le orecchie di chi già aveva buttato via tutti
i loro ultimi album: Cuomo stava oggettivamente chiedendo
scusa ai fans!
Testi così fanno di
Everything Will Be
Alright in the End uno
dei più incredibili atti
di auto-flagellazione
musicale della storia.
Tornati al produttore di Blue/Green, Ric
Ocasek, la band sta
deliberatamente facendo musica che suona
come quella dei summenzionati bei-vecchi-
tempi. Va bene che Cuomo ormai non sa più scrivere testi che
non siano auto-referenziali: ma Everything non sembra un
deliberato e stucchevole riciclo. Anzi: è pieno di ferite, dolore e
di alcuni dei riff più cazzuti dai tempi di Maladroit. Everything
Will Be Alright in the End sono gli Weezer che provano qualcosa a se stessi: se vogliono possono ancora essere gli Weezer.
Dall’imbarazzata strimpellata che apre Ain’t Got Nobody, è
chiaro che Cuomo ha raggiunto quel fascino goffo che aveva
reso immortale The Blue Album, con motivi compatti, concentrati, canticchiabili, mentre i testi vanno, alla bisogna, dall’apologetico all’umoristico. È un bel contrasto con gli istrionismi
di chitarra ‘à la Cheap Trick’ che avevano aiutato la band a
farsi un nome.
Anche quando si ributta sul classico tema di ragazza&problema,
da Lonely Girl a Cleopatra fino al duetto con Bethany Cosentino dei Best Coast su Go Away, sembra sempre al sicuro: motivi solidi ma non fantastici, testi semi-prevedibili, e un
generale senso di divertimento che non pare forzato come su
Raditude o Hurley. Mentre Da Vinci è sicuramente il momento più buffo del disco, il resto di Everything mostra un Cuomo
a disagio come non era da anni. Non si concentra più sui suoi
desideri o sul successo altrui, ma sui propri fallimenti morali e
ambizioni private.
Il trittico in chiusura, The Futurescape Trilogy, è talmente
sconnesso da non suonare compatto come Cuomo avrebbe
voluto. Ma quando il terzo movimento (Return to Ithaka) comincia a disegnare ornati arabeschi hair-metal, sembra subito
il fratello piccolo di Explode dei Van Halen, facendovi chiudere l’album con un gran sorriso in faccia. Era da un sacco che
gli Weezer non erano così genuinamente divertenti.
Insomma, il disco non è perfetto, ma
non ne ha nemmeno bisogno. Dopo l’orrendo Raditude, quasi nessuno pensava
che gli Weezer sarebbero mai più stati
presi sul serio, ma Cuomo doveva provare a sé e ai fan di essere ancora in grado
di scrivere belle canzoni, mettendosi alla
prova invece di prendersela noiosamente comoda come faceva da tempo. Forse
è il loro miglior album in anni, ma c’è di
più: pur con le sue pecche, è sicuramente
il loro miglior disco in dieci anni.
Pensateci, se vi domandate quando, di
preciso, sia iniziata la loro rinascita.
87
88
OUTSIDER
NOVITÀ
NOVITÀ
NEIL YOUNG
STORYTONE
di John Garratt
VOTO DELLA REDAZIONE:
6,5
Se vi dicessi che Storytone di Neil Young è un album dai
testi diretti e pungenti, probabilmente rispondereste qualcosa del tipo: “Sì. E le mucche fanno ‘muu’, i cani ‘bau’ e i gatti
‘miao’. Qualcosa che non so?”. Domanda ragionevole. Ma se
vi dicessi che buona parte del disco è registrata con un’orchestra? E che altre tracce hanno la sua voce sorretta da una big
band swing? E che nella versione deluxe di Storytone, potete
ascoltare tutte le canzoni re-incise con la voce di Young da
un solo strumento alla volta, come un piano, una resofonica
o un ukulele? Storytone è una specie di paradosso.
L’ultimo pugno di canzoni di Neil Young è una serie di
riflessioni personali su alcune cose che lui considera verità
universali. Pertanto il suono può essere sia massiccio che
sussurrato. E nella versione deluxe, alcune canzoni sono di
entrambi i tipi. Sulle prime, non si sa se ascoltare il messaggio
o l’arrangiamento. Posso dire che questo dilemma si risolve
passando del tempo con l’album. In che altro modo incidere
grandi passaggi orchestrali sotto a versi come “smetti ora di
trivellare”?
Gran parte di Storytone può essere visto come un riflesso
della recente vita personale di Young. Ma qui lo dico e qui
lo nego, perché non mi piace frugare tra i panni sporchi di
un artista finché non li espone in pubblico. Ci dice di essere
“diverso da chiunque”, su I’m Glad I Found You, una ballad
per un’amata che attende alla fine della vita. Ma nella seconda traccia si fa portabandiera per
Madre Terra. Who’s Gonna Stand
Up? È piena di slogan ecologisti,
che non sorprendono nessuno
visto che ha già scritto un intero
album parlando di un’auto elettrica. “Chi si alzerà e difenderà
la Terra?/Chi dirà che lei ne ha
abbastanza?”, dice il ritornello
passando in maggiore. La strofa,
in minore, come al solito non è affatto vaga – aggredendo le trivellazioni e incoraggiando la gente a
“contrastare il petrolio”.
Il brano seguente mette Young
al posto di guida–di un’auto,
chiaro. I Want to Drive My Car è
un aperto road blues che ribolle,
nella versione solista. La versione
con la rock band dà al pezzo uno scioglimento della tensione
che quasi la neutralizza. Il protagonista deve “trovare carburante”, catturando il moderno dilemma di qualcuno che ama
le auto classiche ma non sopporta il pensiero di bruciare altra
benzina. L’auto stessa arriva fino al brano successivo, Glimmer, ma con la canzone c’entra poco. Qui abbiamo a che fare
con l’assenza dell’amata. “Quando guido la mia macchina,
viaggiando senza te/Riesco ancora a vederti seduta accanto
a me”. Come solitaria ballad al pianoforte, tiene bene. Col cinematografico preambolo del pieno d’orchestra, a volte sembra fin troppo stramba.
E penso sia questo a impedire a Storytone di suonare sincero. Young canta di cose che per lui hanno importanza, come
l’amore e la natura. Gioca con gli arrangiamenti, ad esempio
con le partiture per resofonica, armonica o corno. Offre immagini della medesima canzone in dimensioni diverse. Capisco
a cosa stia mirando, ma qualcosa semplicemente non suona.
I grossi ottoni di Hello Chicago fanno solo scena, mentre la
versione col solo piano suona schiettamente solitaria. Gli untuosi, torbidi corni di Like You Used to Do sono in diretto contrasto con la versione basata su armonica e chitarra acustica.
È avventato pensare che Neil Young abbia faticato su un album in crisi d’identità come questo. Sono passati 46 anni dal
suo primo disco solista. Se mira a confonderci, penso che se
ne sia più che guadagnato il diritto. Per molti artisti anziani,
è quella la chiave della vitalità.
Ma ciò non vuol dire che Storytone sia uno dei migliori risultati di
Young. A volte suona come una
battuta mortalmente seria. Altre,
niente più che una ben prodotta
considerazione che un giorno gli
è passata per la mente. Lo stile
di Young con parole e melodie è
fuori questione. Brani come Plastic Flowers stanno in piedi da
soli. Quindi, se vi piace l’asciuttezza, trarrete il massimo possibile dalle canzoni nella loro forma
essenziale. A volte un po’ di apparenza aiuta, come con Who’s
Gonna Stand Up?. Ma il servizio
completo andrà bene solo a chi
ama strafare.
OUTSIDER
NOVITÀ
DANIEL LANOIS
FLESH AND MACHINE
di Maria Schurr
VOTO DELLA REDAZIONE:
7,5
Nella cartella stampa per il sesto e ultimo lavoro solista di
Daniel Lanois, Flesh and Machine, il noto produttore e virtuoso dell’ambient ammette di non avere familiarità con progetti attuali tanto stimati come Burial e Four Tet, artisti che
hanno flirtato un po’ col genere. A volte tali specifiche mancanze possono portare ad affascinanti risultati. Nel caso della musica futurista, l’inconsapevolezza di quali suoni stiano
esplorando gli artisti dell’ambient e dei generi circostanti può
mettere la musica di un artista poco illuminato a rischio di diventare immediatamente datata. È una fortuna che in questo
caso si parli di qualcuno esperto come Lanois, che con Flesh
and the Machine ha alzato la posta dichiarando di star cercando “qualcosa di mai sentito prima”. Anche se Lanois non
ci riesce del tutto, la sua visione viene chiarita con altri mezzi.
Flesh and Machine è la candidatura di Lanois “L’Album da
Auricolari dell’Anno”. Penso di aver già dato questo titolo a
You’re Dead! di Flying Lotus, ma Flesh and Machine è comunque una pubblicazione affascinante. Questa è ambient
con la capacità di eccitare, coinvolgere ed evocare. La prima
di queste qualità si trova ai cancelli di partenza, con The End,
la seconda traccia dell’album. Anche se la cacofonia qui sollevata è simile a quella stuzzicata da The National Anthem
dei Radiohead, i modi in cui la fa arrivare sono piuttosto diversi. I soli strumenti usati nel brano sono chitarra elettrica e
batteria, che Lanois ha campionato pezzo per pezzo, processato e poi rimesso nella traccia.
The End non sembra nulla di
ambient, sensazione che ritorna con Opera. Dopo un minuto
di delicate pulsazioni, le percussioni attaccano in un modo
balbettante che minaccia di imporre all’ascoltatore un attacco
d’ansia. Fortunatamente, delle
voci pacatamente campionate
ammorbidiscono la batteria abbastanza da evitare che il vostro
cuore vada in overdrive.
Sioux Lookout e Space Love
si classificano come due delle
tracce più stimolanti del disco:
la prima utilizza i suoi campioni
di voce in modo da ottenere un
effetto particolarmente maesto-
so. Lanois ha usato queste voci—che a volte suonano umane, a volte animali, tutte create da Lanois—nel tentativo di
“creare questo pianto natale contemporaneo” come dice lui.
Space Love procede in un modo che è quasi impressionante
per la sua sottigliezza, sembrano all’inizio un solitario grido
nel vuoto prima di fondersi in qualcosa di più solido, conservando comunque il proprio lamento.
Per quanto concerne l’evocazione, First Love, tenera e sognante, guida il gruppo. L’inclusione di un Suzuki Omnichord richiama i lavori di Brian Eno, mentore di Lanois.
Iceland è assieme domestica e aliena, mentre astutamente
scala le bizzarrie che a volte il paese del titolo può suggerire.
Flesh and the Machine ha una componente cinematografica. Lanois ha unito le forze con Robert Milazzo della Modern
School of Film per creare dei video per i brani. Il progetto
racchiude cineasti di grido—come Atom Egoyan de ‘Il Dolce
Domani’ o Mary Harron di ‘American Psycho’—e sconosciuti,
tutti all’opera per dare al lavoro di Lanois forme e colori distinti. Lanois, chiaramente, non ha problemi a creare immagini coi soli suoni, ma il progetto è un valido sforzo nel sostenere il video musicale, quasi dimenticato da che MTV ha
abbandonato la forma, la commercialità e la rumorosita dei
grandi video pop.
La vera componente visiva di Flesh and Machine sarà rappresentata dai concerti di Lanois per promuovere l’album.
Ogni sera, assieme al bassista Jim
Wilson e al batterista Brian Blade, campionerà, mixerà e processerà in tempo reale sul palco, facendo
di ogni serata del tour un’unica,
irripetibile performance. Il piano
suona stuzzicante, forse ancora più
progressive dei processi utilizzati
per Flesh and Machine. In un certo senso, questo metodo si rivolge
al presente e al futuro ancora più di
qualunque cosa sullo stesso album,
per via dell’effimericità del panorama culturale pop contemporaneo.
Le performance live di Flesh and
Machine appartengono alla notte,
ma le sensazioni stuzzicate dall’ascolto dell’album rimarranno ben
più a lungo.
89
90
OUTSIDER
NOVITÀ
NOVITÀ
DAMIEN RICE
MY FAVOURITE FADED FANTASY
di Mark Segal Kemp
VOTO DELLA REDAZIONE:
7,5
Negli otto anni passati da che Damien Rice ha pubblicato
il suo secondo album, 9, la produzione domestica di delicato
cantautorato indie ‘da Starbuck’ è emerso e poi esploso nel
mainstream teen-pop con l’arrivo di un accolito di Rice, Ed
Sheeran. Si riesce quasi a vederlo, Rice, che nasconde la testa tra le ali con cipiglio accigliato, cupamente torcendosi le
mani, pensando: “Ti prego, ti prego, liberami da questo blocco dello scrittore”.
Rice è stato graziato. E profondità e ampiezza del suo terzo LP
studio dimostra che per quanto seducenti siano le canzoni
delle sue legioni di seguaci, il suo caratteristico mix di chitarre acustiche e archi, loop, sovraincisioni e crude, dolorose
confessioni è inimitabile. Se 9 (2006) era una leggera delusione dopo il suo sublime debutto nel 2003 con O, questo nuovo,
maturo album rimette saldamente il cantante e chitarrista
sul ring.
Aperto e chiuso da due brani nebulosi e pieni d’atmosfera—
la titletrack e Long Long Way—e arricchito da canzoni più
sobrie piene di crepitante pizzicato e archi, My Favourite
Faded Fantasy è sorretto al centro dal doppio colpo di The
Greatest Bastard e I Don’t Want to Change You. La prima, su
una chitarra sfiorata con dolcezza, è puro Rice, mettendo in
dubbio una serie di affermazioni che sono a un tempo autogratificanti e autodenigratorie, con quella saggezza che arriva solo con l’età: “Ti ho fatto ridere, ti ho fatto piangere, ti
ho fatto aprire gli occhi”, canta e, dopo una pensosa pausa:
“Non è vero?”
I Don’t Want to Change You combina gli elementi fondamentali di Rice: drammatici archi e una chitarra acustica
disadorna; delicati tocchi di elettronica, tastiera, batteria e
il caldo battito di un basso; voce straziante e appassionata; i
testi bruciano della passione di un amante confuso. “Dovunque andrai, potrò sempre seguirti”, stride, come se letteralmente sanguinasse dall’interno. Il brano è probabilmente
una canzone d’amore per la sua ex partner musicale e di vita,
Lisa Hannigan, che una volta ha detto di amare ancora. “Se
vuoi solo stare sola, posso aspettarti senza aspettare”, continua. “E se vuoi che lasci perdere, sono più che disposto. Perché non voglio cambiarti... Non voglio farti cambiare idea”.
Eppure, si ha l’impressione che Rice l’idea gliela farebbe
cambiare più che volentieri.
Altri punti forti tra le otto lunghe tracce dell’album—solo
una dura meno di otto minuti, e due superano invece gli
otto—sono Colour Me In (sulla voglia di essere coinvolto) e
The Box (sul sentirsi legati). Sono entrambe tipiche canzoni
di Rice, iniziano dolcemente con la sola chitarra prima di
evolvere in un crescendo di archi e lamenti vocali. L’esotica e
sensuale It Takes a Lot to Know a Man incorpora tocchi quasi
mediorientali, mentre Trusty and True, col suo mix di semplice ballata britannica e gioiosi cori africaneggianti, dà un
senso di liberazione spirituale. Per quanto
riguarda la prima e l’ultima—Rice in queste tracce esplora un intero arcobaleno di
tradizioni musicali e culturali, tra melodie
sinuose, tentazioni classicheggianti, schietto rock e strutture spaziali, psichedeliche.
Ed Sheeran può avere preso il posto di
Rice, in assenza del cantante, offrendo un
simile senso di dramma e pathos a un pubblico più vasto e più giovane, ma non l’ha
mai rimpiazzato. Dopo tutto, è dura immaginarsi Rice che si butta nell’arena (per così
dire) di rap e grosse basi loopate.
Il suo lavoro dipende tutto dalle nuances
e dalle dinamiche, da profondità e apertura. Dopo quasi un decennio d’attesa, My
Favourite Faded Fantasy offre tutto questo
con un elenco di brucianti tracce di angoscia a lungo sopita e finalmente liberata.
OUTSIDER
NOVITÀ
BRIAN SETZER
ROCKABILLY RIOT! ALL ORIGINAL
di Matt Casarino
VOTO DELLA REDAZIONE:
7,5
Se avete scartato gli Stray Cats come una sciocchezza nostalgica, negli anni ‘80, probabilmente farete lo stesso con l’ultimo di Setzer, Rockabilly Riot! All Original. Stessa roba: musica
da car-club a palla che parla di ragazze, motori, spasso. Roba
che non passano alla radio, ora: ma nemmeno nell’82. Ma a
differenza degli altri progetti revival di 30 anni fa (Billy Joel,
Huey Lewis, etc), la band di Setzer non è mai parsa condiscendente o leziosa. Ok, era un imbarazzante retrò, e ok: i componenti si conciavano come delle comparse di ‘Grease’. Ma
sono comparsi come una forza originale con cui fare i conti,
come ‘ una tribute band degli Sha-na-na. Sembravano dire:
‘C’è il punk, il metal, la new wave, ma non scordatevi da dove
vengono’. Del resto, se la scena punk londinese li ha accolti,
perché noi non dovremmo?
Ma i Cats non erano punk. Spiccavano, perché sapevano suonare. E lo sanno ancora fare, con amore, per questo Rockabilly
Riot! All Original ha tanto successo. Se vi piace il rockabilly
fatto con stile, energia e competenza, eccovi serviti.
Ma li dovremmo prendere sul serio? Cioè: i titoli sembrano la
scaletta di Grease 2: Let’s Shake, Vinyl Records, Stiletto Cool,
Rockabilly Blues. Cristo santo! Non suona… fasullo? Beh, forse: e allora?! Date a Setzer del fasullo, se dovete: ma non pensiate nemmeno per un attimo che non abbia la musica nel
sangue.
Lo aiuta molto l’aver rinunciato a tutti gli ornamenti della
Brian Setzer Orchestra. Stavolta è tornato al talentuoso trio
composto da Mark
Winchester al basso
(contrabbasso, ovvio),
Noah Levy alla batteria (in piedi, naturalmente), e Kevin
McKendree al piano
(acustico: che credevate?). Ma è la semiacustica di Setzer a
guidare le danze: e
con quella è mostruoso come sempre.
Si comincia con Let’s
Shake, tre furiosi accordi che aprono la
scena a una deliziosa
chitarra e a un piano
martellante… ma in fondo questa descrizione va bene per
molti brani del disco. La varietà qui non conta—qui si parla di puro e folle rock&roll. Dovrebbe richiamare alla mente
Gene and Eddie, Jerry Lee Lewis, Little Richard—e sapete cosa? Ci riesce. (Se non sapete di chi stia parlando, questo
disco non fa per voi. No, contrordine—ne avete bisogno.) Sarà
anche calcolato, ma trasuda gioia ed energia. È vivo.
Tra i brani più significativi troviamo la (leggermente) lenta
What’s Her Name, la furibonda titletrack (col suo stupendo
assolo di basso), la fighissima Lemme Slide e la più tranquilla
Girl With the Blues in Her Eyes. Ma siamo onesti: sono tutti significativi, specialmente se siete dell’umore giusto. Un
disco consapevolmente fuori moda, ma dal suono onesto e
vero. Non è “psychobilly” (che termine sciocco), ma Rockabilly Riot è veloce e duro come un qualsiasi album degli Stray
Cats. Eppure sembra anche più saldo, più sicuro di sé. Non c’è
bisogno di trascendere nel “punk”—il selvatico rock di Setzer
è abbastanza trasgressivo di per sé.
Qualche scivolata? Direi I Should’a Had a V-8, che spinge la
sua scherzosa atmosfera bandistica e il ridicolo gioco di parole del titolo fino al limite dello stucchevole, e Blue Lights,
Big City, che sbuffa con un groove e un gioco armonico à la
Elvis/Orbison, ma abbassa l’energia dell’insieme. Il brano
finale, Cock-a-Doodle-Don’t, è ridicola quanto V-8, ma è troppo irresistibile da ignorare. Ma anche queste tre (le ultime tre
dell’album) sono piene di gioia e forza e una piacevole assenza d’ego. Potrà sbigottirvi, ma saltarle sarebbe
come saltare Chantilly Lace.
Mi rendo conto di non aver citato nessun testo, ma questo perché il punto qui non sono
i testi. Sono buoni, attenzione—brillanti e
divertenti e ammiccantemente sconci—ma
sulla lunga distanza contano a malapena.
Quello che conta è che questa dozzina di tracce porterà vita e gioia alla vostra collezione
musicale. Se vi faranno venire voglia di farvi
il risvolto ai jeans e arrotolarvi un pacchetto
di paglie nella manica della maglietta, tanto
meglio. Badate bene, Rockabilly Riot! All Original non cambierà il mondo o chissà che.
Ma vi farà sorridere, ballare, e vi farà anche
lanciare nell’occasionale “Vai, bello, vai!”
Chiamatela sciocchezzuola, se volete: ma secondo me è puro rock&roll, gente.
91
92
OUTSIDER
NOVITÀ
NOVITÀ
SAM AMIDON
LILY-O
di Gideon Thomas
VOTO DELLA REDAZIONE:
7,5
Cantante, chitarrista, violinista, suonatore di banjo, la storia
di famiglia di Sam Amidon è fatta di musica, canzoni, ballo
e narrazione, tutti temi che si ritrovano nel suo sesto album,
Lily-O. È stato originariamente concepito come un progetto
d’improvvisazione con il chitarrista jazz Bill Frisell. Durante il suo sviluppo, il disco è diventato un patchwork di canzoni contemporanee e tradizionali, eseguite con passione e
dedizione.
Con testi e idee raccolti da una gran varietà di fonti, Amidon
si è messo in combutta con la chitarra di Frisell (si sono conosciuti quando Amidon era un teenager, nei tardi anni ‘90),
assieme al basso di Shahzad Ismaily e alla batteria e l’elettronica di Chris Varalaro. La produzione del disco ha avuto luogo a Reykjavik, con Valgeir Sigurðsson al timone.
Quest’avventura vede Amidon e la band incidere completamente dal vivo, in un efficace tentativo di suonare in un
ambiente intimo, ‘reale’, senza né artifizi né sovrincisioni.
La voce di Amidon sta al cuore delle composizioni, a volte
poderosa, a volte vacillante, ma sempre adatta e composta.
Walkin’ Boss è un inizio aperto e brillante –- fatto di banjo
stridente e percussioni che rotolano in giro per adattarsi al
tema e all’idea del brano. La voce di Amidon attacca piuttosto cruda mentre lui si fa strada attorno alle parole – la
descrizione di una vita industriale. La squillante chitarra
elettrica riflette già l’atmosfera live dell’incisione, mentre
l’arrangiamento funziona in modo eccellente, con un taglio
rock che porta la tradizione in nuove direzioni, mentre la
musica di Amidon le dà una nuova focalizzazione.
Down the Line porta avanti l’idea del patchwork, con passaggi di chitarra e batteria stratificati a creare finestre nella
canzone, nella canzone e nel processo di registrazione. Si
fanno avanti lampi di musica e di storia, mentre la voce di
Amidon sfuma e riappare nel mix. Il risultato finale è strano,
bizzarro e del tutto seducente.
Blue Mountains è morbida e splendida mentre ti assorbe,
prima di aprirsi ed evolversi tra la voce e il violino. Una storia d’amore, espansione territoriale, viaggio e adattamento a
una nuova vita, tutto racchiuso da una descrizione localizzata. Una classica storia tradizionale, cui viene data un’ambientazione molto moderna.
Alcuni momenti sono più spensierati, per esempio Pat Do
This, Pat Do That, guidata dal banjo, che sboccia grazie
all’aggiunta di chitarra e batteria. È un innegabile piacere
ascoltare la traccia mentre cresce e accoglie altri elementi –mentre diventa più di quanto non fosse all’inizio, nel modo
in cui fa lo stesso album. La titletrack spicca –- una ripresa
nuova e decisamente diversa di una storia conosciuta nella
versione inglese come ‘the Cruel Brother’. La delicetazza e
difficoltà della storia – una storia di gelosia e assassinio – è
resa come se fosse un sogno, divenendo un oggetto di bellezza e meraviglia, forte e audace.
Groundhog Variations è forse il passaggio più
bizzarro dell’album –- completa d’ombreggiature dal sentore improvvisativo quasi jazz, ma il
cantante e la band la portano con grazia. Amidon vuole ovviamente fare quello che gli viene
meglio, può farlo, e sa sempre cosa stia facendo.
Won’t Turn Back e Your Lone Journey sono entrambe gloriose, tenere ed evocative, dei tributi
parimenti forti e smaccati. Devotion è portata
con aplomb, dando ulteriore prova del fatto
che Amidon possa mettere mano a diversi tipi
di canzone e di ambiente. È in grado di entrare
nelle canzoni, e le sue canzoni entrano dentro
di te, con amore, tenerezza ed emozione.
Amidon vive a Londra, è il marito di Beth Orton e Lily-O è bello quanto il precedente Bright
Sunny South del 2013.
Che dio ce lo conservi.
OUTSIDER
NOVITÀ
MARK LANEGAN BAND
PHANTOM RADIO
di Cole Waterman
VOTO DELLA REDAZIONE:
7,5
Pochi artisti sanno passare dal rock all’elettronica al countryfolk con classe. Ancora meno sono quelli in grado di infondere in tutti questi generi lo spirito del vecchio blues. Forse
solo Mark Lanegan sa farlo, entrando in ogni genere come se
fosse sempre casa propria. Una carriera imprevedibile, la sua,
e sempre più prolifica mentre si avvicina il suo 50° compleanno. E con Phantom Radio ha raggiunto un momento spartiacque.
Dopo una carriera solista di scuro folk-blues (da The Winding
Sheet del 1990 fino a Field Songs del 2001), Lanegan nel 2004
si è reinventato con Bubblegum. Sperimentale eppure molto
blues, riprendeva alcuni aspri elementi rock. Un’estetica che
tornava nelle pesanti influenze electro del suo seguito, Blues
Funeral (2012). Phantom Radio va ancora più a fondo, completando la trilogia.
E di questo trittico è la parte più solida, mostrando in modo
coerente i vari aspetti di Lanegan. Sembra più sicuro che mai,
ha tenuto ciò che funzionava in quei dischi e ha scartato il
resto. Per quanto validi, Bubblegum era transitorio e Blues
Funeral un po’ laborioso e ridondante, mentre Phantom Radio è perfetto. Mantiene il trip-hop e le tendenze krautrock
del precedente, aggiungendo il garage rock di Bubblegum e i
toni pacati dei suoi primi cinque lavori solisti.
Fondamentale qui è l’inimitabile voce.
Anni di vita sana gli stanno facendo
bene: la sua voce è flessibile e morbida,
ripulita delle vecchie, roche qualità.
Questa ritrovata dimensione fa della
sua voce un veicolo ancora più efficace
per i suoi testi. Non è certo il primo a
speziarli con riferimenti biblici o a usare concetti come il leviatano, Gabriele,
Satana, il peccato, l’espiazione e simili
come muse, ma questi elementi non
sembrano mai banali. Nessun altro ha
tanta profetica gravità in gola.
Il disco parte stuzzicante con Harvest
Home, una melodica chitarra potenziata da robuste percussioni digitali.
Mentre procede, subentra uno scintillante, adamantino synth. Lanegan,
intanto, suona cavernoso e omnicomprensivo, in pace con tutti i suoi peccati. Subito dopo, Judgement Time spo-
sta il paradigma: qui è sorretto da un harmonium e da una
ripetitiva chitarra acustica. Sembra il risveglio da un sogno
allucinogeno, le vellutate intonazioni scoppiano d’immagini
escatologiche: “Ho visto sanguinare i piedi dei pellegini/Ho
visto città affogare/Ho visto eserciti morire”. Induce paura e
anche accettazione, diventando ancora più inquietante.
Floor of the Ocean è egualmente ipnotica ed energizzante, di
certo la più orecchiabile. Un ritmo contagioso, gelato e bollente assieme, richiama i Joy Division col suo solido midtempo e un robusto basso a spaziare sopra le tastiere. La voce
è più acuta del solito e quasi irriconoscibile, ricca d’armonie
femminee. Non il miglior brano del disco, ma un’ottima scelta come singolo: riassume l’intero album, con i soliti temi di
colpa&redenzione, la voce alle stelle e la fusione di vari stili.
I sette brani rimasti vanno ognuno per la sua strada. Ma non
sembra una scomposta retrospettiva sulla carriera di Lanegan: scorrono invece assieme con naturalezza. Killing Season
fa pensare ai Portishead e agli Sneaker Pimps con la sua
aria noir, in contrasto col severo blues di I Am the Wolf, costruita su sincopate chitarre classiche che richiamano Leonard Cohen. La voce di Lanegan sembra un soffio di vento
sul deserto, come faceva nei suoi primi album. Più divertente
è Seventh Day, una specie di seguito spiritual di Methamphetamine Blues. Ma dove quella era
paranoica, questa è composta. Stessa
pulsazione, ma più riservata, e dannatamente seducente. Poi c’è Torn Red
Heart, sfrontata ballata country che Lanegan canta ancora sul registro acuto.
Riporta sia a Nashville che ai Velvet
Underground.
Chiude Death Trip to Tulsa, che sbuffa
come un treno a vapore. Piena di audace fatalismo e secchi suoni industrial,
è una riflessione sulla desolazione. A
metà emerge un synth cristallino, mostrando di nuovo il gusto di Lanegan
per il melange. E se non è il miglior
pezzo del disco, ci va vicino, finendo
Phantom Radio con positività.
È la quintessenza di Mark Lanegan:
un buon punto di partenza per i novizi e una fonte di gioia per i più storici
fan.
93
94
OUTSIDER
NOVITÀ
NOVITÀ
PINK FLOYD
THE ENDLESS RIVER
di Alexis Petridis
VOTO DELLA REDAZIONE:
7
Si dice che i Pink Floyd siano finiti nove anni fa, sul palco
del ‘Live 8’ ad Hyde Park, con un rigido abbraccio di gruppo cui almeno uno di loro ha dovuto essere costretto. Molto
pinkfloydiano: a parole un atto di riconciliazione finale dopo
anni di rancore, nei fatti gelido come sempre.
Eppure eccoci, dieci anni dopo, davanti a The Endless River,
un “nuovo” album che, da una parte, non è nuovo affatto – si
basa su scarti di 20 anni fa del 2° album post-Roger Waters,
The Division Bell. Dall’altra, suona più ‘Pink Floyd’ – almeno,
quelli dei 50 milioni di copie vendute di The Dark Side of the
Moon – di qualsiasi altro album degli ultimi 35 anni. Ma perché? E perché ora?
Se c’è una ragione, di certo non ha a che fare coi soldi: i Pink
Floyd sono tra i pochi a non avere questo cruccio. Ufficialmente è un omaggio postumo a Richard Wright, il tastierista morto di cancro nel 2008. Si può pensare a un ultimo sberleffo a Waters: non includerlo dimostrerebbe che il fascino
della band sta nel sound – la chitarra di Gilmour, le tastiere
di Wright – e non negli apocalittici testi dell’ex-leader.
Sia come sia, The Endless River è un modo per godersi assoli
molto, molto gilmoureschi, dagli strazianti bending agli scarti
tra melanconia ed euforia, e riconoscere accenni a tutto il passato della band. Compare un accenno dell’assolo di Another
Brick in the Wall (Part 2); e una vecchia registrazione all’organo di Wright alla Royal Albert Hall s’intitola qui Autumn ’68,
richiamando Summer ’68 di Atom Heart Mother. L’elegiaca,
splendida coppia d’apertura, Things Left Unsaid e It’s What
We Do, ricorda l’altro splendido peana per un compagno
scomparso, Wish You Were Here, del 1975. Data la complessa
storia di Wright con la band – licenziato mentre incidevano
The Wall, ma richiamato come
turnista stipendiato per il tour,
escluso dalla creazione di The
Final Cut, poi ripreso con paga
settimanale per A Momentary
Lapse of Reason – avrebbero
potuto intitolarlo ‘Sign on You
Crazy Diamond’: continua a firmare...
I dolci accordi di piano e il sax di
Anisina sono della stoffa di Us
and Them, mentre le rullate e la
tensione crescente di Sum riportano alla geniale introduzione
di Nick Mason per Time, ricca di rototom.
Solo che quella era l’introduzione... beh: a Time. Mentre Sum
apre a Skins, un assolo di batteria di 2’30’’.
Una band che ti costringe a un lungo assolo di batteria ad appena 15 dall’inizio rischia di sembrare un po’ approssimativa
e povera d’idee. L’ultima volta che i Pink Floyd hanno fatto
una cosa del genere è stato nel ‘69 con Ummagumma, album
però appunto molto incerto e disprezzato dalla band.
Di tanto in tanto The Endless River ha qualche guizzo, o giù
di lì. Ma malgrado l’accuratissimo dettaglio sonoro, e lo sforzo
compiuto da Manzanera e Gilmour, perché tutto scorra a dovere, capita che The Endless River tradisca la propria genesi
in modo un po’ troppo ovvio.
Ciò detto, è pieno di ottima musica e, appropriatamente,
molta è ispirata allo stile di Wright. Ebb and Flow, che mostra la slide guitar di Gilmour mentre soffia languida attorno a una paradisiaca struttura di piano, è particolarmente
goduriosa. In Autumn ‘68 è commovente lo scambio tra le
tastiere di Wright, di 45 anni fa, e la chitarra contemporanea
di Gilmour. Incarna il senso ultimo dell’album: malgrado l’amarezza e l’incomunicabilità, tra i componenti esiste un profondo legame sonoro che non sarà infranto nemmeno dalla
morte. In certi momenti The Endless River sembra una serie di prologhi musicali messi assieme, delle continue intro.
Ascolti Anisina e pensi: carina, davvero, ma farla diventare
davvero una canzone vi costava troppo? Di contro, quando
fanno centro lo fanno in grande: Louder Than Words è maestosa, commovente e generosa, un altro paio di pezzi così non
avrebbero guastato.
Ma ne avrebbero fatto un album più significativo, ed è proprio
per questo che non ci sono.
A volte si parla di “glossa finale alla carriera”, con falsa
cortesia, ma sembra che The
Endless River sia stato concepito esplicitamente come
glossa: non il nuovo album
di una band esistente, ma
un’eco del passato – un vero
abbraccio di gruppo. Chi non
è stato invitato, potrebbe non
essere d’accordo: ma in questi
termini, l’album raggiunge il
suo scopo.
OUTSIDER
NOVITÀ
LUCERO
LIVE FROM ATLANTA
di Sad Songs Keep The Devil Away
VOTO DELLA REDAZIONE:
7,5
Dopo 16 anni in tour, facendosi strada negli USA e in Europa,
il settimino di Memphis (ottetto, a volte, con Todd Beene dei
Glossary alla pedal steel guitar) i Lucero hanno finalmente
pubblicato un album live. Cattura il delirio da cui ogni vero
fan viene travolto grazie all’esperienza dal vivo. Live from
Atlanta è stato inciso durante una ruvida tre-giorni al Terminal West di Atlanta, nella seconda metà di novembre 2013,
raduno che mi ha fatto malissimo perdermi. Ciò che ne è
uscito è un doppio CD/quadruplo vinile che si dimostra un
buon esempio di quello che è vedere questa band dal vivo.
Non ricordo nemmeno quante volte io abbia avuto il piacere
di vedere un loro live. Li ho visti in svariati stati e location
nei miei 11 anni di furiosa dedizione, e ogni show è grandioso per diversi motivi. Ho visto live sciatti, concentrati, ubriachi, col frontman Ben Nichols disteso sul palco prima dei
bis, il concerto più punk e anche il concerto più country che
abbiano saputo mettere assieme. È questa la bellezza dei Lucero, specialmente dal vivo: non saprai mai cosa ti capiterà,
un po’ come con i concerti dei loro numi tutelari, i Replacements, negli anni ‘80. Una cosa però è certa: canterai in coro
e ti divertirai un sacco.
I Lucero (“stella splendente” in spagnolo) sono Ben Nichols
a voce e chitarra, Brian Venable alla chitarra solista, Rick
Steff alle tastiere e alla fisa, Roy Berry alla batteria, John
C. Stubblefield al basso, mentre Jim Spake e Scott Thompson formano una delle migliori sezioni di fiati al mondo.
Live from Atlanta è un’antologia del tipico rock&roll Americana dei Lucero, infuso di soul, macchiato di country, incatenato al punk. Prende canzoni da tutti e nove i loro album
in studio, anche l’inno spacca-tasti Rick’s Boogie, dall’album
solista di Rick Steff. È uno dei migliori album live che abbia
mai sentito, una perfetta presentazione della band per chi
non li conosce, e un fondamentale per i giradischi degli stagionati fedelissimi dei Lucero.
Per chi non li conosce, di solito comincia così: senti una loro
canzone, ti stuzzica, cerchi l’album, non riesci a smettere di
ascoltare il suddetto album, ti metti a comprare tutta la produzione dei Lucero che riesci a trovare, inclusi due documentari indipendenti su DVD. E la tua sete non è placata. Li
vedi dal vivo e ti contagiano definitivamente. Il resto è storia. Sei diventato un Fedelissimo, e la tua vita si regola ora
attorno al momento in cui la band sarà in un raggio di 200km
da casa tua. Chiedetelo a qualunque Fedelissimo, e di certo
ve lo confermerà. Il segreto del loro successo non sono solo
grandi canzoni e grandi live, ma l’accessibilità della band ai
fan. Hai quasi sempre modo di incontrare Ben e i ragazzi per
ringraziarli e dir loro quando la loro musica conti per te, un
modesto e genuino gruppo di galantuomini che è anche in
grado di devastarsi in scena.
Se non siete fan, fatevi un favore e
comperate una copia di Live from
Atlanta. Questo è il disco che conquisterà tutti e, prevedo, catapulterà i fan in un nuovo mondo. Il
solo packaging vale i soldi spesi,
con parecchie immagini dei fotografi Nicole Kibert e Adam Smith,
e ho avuto il piacere di intervistare
e scrivere un articolo su quest’ultimo qualche mese fa. I Lucero hanno appena annunciato il “By The
Seat Of Our Pants Tour”, durante
il quale apriranno i loro show con
un set acustico a band completa a
New York, Boston, Los Angeles e
San Francisco – una tre-giorni in
tutte e quattro le città, quest’autunno. Lunga vita al rock&roll.
95
96
OUTSIDER
NOVITÀ
NOVITÀ
SHOVELS & ROPE
SWIMMIN’ TIME
di Raymond E. Lee
VOTO DELLA REDAZIONE:
7,5
È un momento d’oro per il duo Americana degli Shovels &
Rope. In cinque anni, marito&moglie Michael Trent e Cary
Ann Hearst hanno guadagnato la fama nazionale con un
paio di tamburi scassati e due vecchie chitarre. La loro è una
vera storia di ascesa e riscatto, completa di colpo di fulmine,
anni di dolorosa separazione, una gloriosa riunione e il trionfo finale del bene sul male: e forse presto ne sapremo anche
qualcosa di più.
Prima degli Shovels & Rope, Trent è stato una specie di trovatore country. Southern Gothic nel suo senso moderno, l’LP
solista di Trent tratteggia la disperazione e l’affamata ambizione di qualcuno che arriva dal niente. Trent ha composto delle
solide murder ballads in minore fedeli al codice d’onore degli
Appalachi. Restando in questo solco avrebbe potuto far qualcosa di sé, ma una notte d’estate, negli abissi al neon di un
bruciabudella di Savannah, è inciampato sui passi di Cary
Ann Hearst.
La prima produzione di Hearst è marcata da un attacco alla
scrittura tutto stregoneria&cocaina à la Stevie Nicks. Che
sia la sua magnetica presenza scenica o la voce, sa gettare un
incantesimo sul pubblico. È quel tipo di donna che potrebbe
battere un tipaccio in una gara di bevute per poi riportarlo a
casa e metterlo a nanna. Dolce, altezzosa e potente, non sorprende che Trent se ne sia innamorato.
I due artisti hanno però portato avanti le loro carriere soliste
trovando poco successo, finché la necessità non li ha riportati assieme. Il loro primo prodotto, Shovels & Rope (2008), era
più una collaborazione che il lavoro
di una band, ma la critica l’ha adorato.
S’è capito che facessero sul serio con
la seconda uscita, O’ Be Joyful (2012).
Non era una specie di “Shovels & Rope
2”. O’ Be Joyful manteneva proprio le
promesse del titolo—una mania allegra e spensierata per contrastare la
depressione del primo album. La critica, ancorché entusiasta, contava poco:
il gruppo ora partecipava a festival
nazionali, faceva tour da headliner e
appariva nei principali programmi TV.
Eccoci ora al terzo movimento. L’ultimo album, Swimmin’ Time, per la
Dualtone, è l’apice di ciò che fa degli
Shovels & Rope il più eccitante grup-
po “Americana” degli ultimi tempi. Perché ogni love story
si fonda sulla reciprocità: e malgrado entrambi avrebbero potuto cavarsela da soli, è solo rinforzandosi l’un l’altro e puntellando le rispettive debolezze che hanno creato la potenza
che gli Shovels & Rope sono diventati. Sono i June Carter e
Johnny Cash della nostra generazione, e sarà la Storia a dimostrarlo.
Forse è perché arrivano dalla Carolina che l’immagine
dell’acqua appare così tanto in Swimmin’ Time. C’è qualcosa di immortale e immediato nell’immagine delle maree
della modernità. Siamo poveri e ricchi, liberi ma incatenati
da passioni, eccessi ed ego. Aggiungete i detriti galleggianti
dell’industria discografica e Swimmin’ Time diventa subito
un eccitante mare da navigare. Ancor di più se si pensa che
la loro musica è tutto meno che facile per il gusto moderno.
Delta blues, pizzicato, rockabilly, narrazioni sanguinose: tutto in acustico. Gli Shovels & Rope stanno di nuovo rendendo
fondamentale un sound che ha già visto tramontare i suoi
tempi d’oro. In fondo è meglio abbracciare le comodità moderne con intelligenza. Difatti Swimmin’ Time combina questi canti della Nuova Depressione alle moderne tecniche di
produzione.
Rispettando la filosofia DIY, Swimmin’ Time è stato inciso e
masterizzato in casa (letteralmente), e postprodotto da Trent.
Swimmin’ Time si allontana dai precedenti lavori nell’abbondanza di stratificazioni strumentali. Il duo non ha mai
suonato così gustoso, specie nelle piccanti Evil e Ohio, o nel
doo-wop anni ‘50 di Coping Mechanism.
Unendo passato e presente, hanno raggiunto il futuro. Swimmin’ Time mostra il meglio
della musica vecchia e nuova, il
passato idealizzato e il disgustoso, violento, insensato presente.
Testi da farti scappar l’anima dal
petto incontrano armonie che
convertiranno nuovi ascoltatori
per pura emozione. Sono troppo
poetico? Ci potete scommettere.
Non c’è molto apprezzamento
da parte di pubblico e critica che
non sia pagato, oggi. Io glielo
dico gratis.
2CELLOS
In collaborazione con Zenit Srl
2cellos.com
VEN 12/12/2014 ROMA - ATLANTICO
DOM 14/12/2014 MILANO - FABRIQUE
www.queenonline.com
MAR 10/02/2015 - ASSAGO (MI) -MEDIOLANUM FORUM
ARCHIVE
archiveofficial.com
deeppurple.com
MER 11/03/2015 BOLOGNA - ESTRAGON
GIO 12/03/2015 MILANO - ALCATRAZ
VEN 13/03/2015 CIAMPINO (RM) - ORION LIVE CLUB
VEN 30/10/2015 PADOVA - PALAFABRIS
SAB 31/10/2015 ASSAGO (MI) - MEDIOLANUM FORUM
GIO 5/11/2015 FIRENZE - NELSON MANDELA FORUM
VEN 6/11/2015 ROMA - PALALOTTOMATICA
RYAN
BINGHAM
STU
LARSEN
binghammusic.com
MAR 10/02/2015 MILANO - LA SALUMERIA DELLA MUSICA
THE
TWILIGHT SAD
MAR 7/04/2015 BOLOGNA - LOCOMOTIV
MER 8/04/2015 MILANO - BIKO
thetwilightsad.com
stularsen.com
MAR 17/03/2015 MILANO - BIKO
PUBLIC SERVICE
BROADCASTING
A MAGGIO IN ITALIA
INFO: 02.6884084 - BARLEYARTS.COM - FACEBOOK.COM/BARLEYARTSPROMOTION
publicservicebroadcasting.net
98
OUTSIDER
OLDIES BUT GOLDIES
OLDIES BUT GOLDIES
LED ZEPPELIN
IV/ HOUSE OF THE HOLY
Secondo capitolo delle ‘deluxe edition’ dei Led Zeppelin su
cui ci eravamo soffermati sul numero di giugno e… seconda
delusione. Led Zeppelin IV, è il disco definitivo della band di
Page, e Houses Of The Holy, album forse sottovalutato rappresenta i LZ nel momento più positivo della loro storia: il
mood è ottimo, il rapporto tra i musicisti è ancora buonissimo, il gruppo è all’apice delle capacità espressive e tecniche, il successo
– già grandissimo – di lì a breve si
trasformerà in una isteria collettiva
(soprattutto negli USA) catapultandoli in una dimensione tutta loro.
Purtroppo Page dunque spreca
un’altra occasione buona, dando
alle (ri)stampe due album bellissimi accompagnati da materiale extra
davvero… risibile.
Vediamoli uno x uno.
LZ IV Companion Audio Disc
1. ‘Black Dog’ (basic track with guitar overdubs)
2. ‘Rock and Roll’ (alternate mix)
3. ‘The Battle of Everymore’ (mandolin/guitar mix from Headley
Grange)
4. ‘Stairway to Heaven’ (Sunset
Sound mix)
5. ‘Misty Mountain Hop’ (alternate
mix)
6. ‘Four Sticks’ (alternate mix)
7. ‘Going to California’ (mandolin/
guitar mix)
8. ‘When the Levee Breaks’ (alternate UK mix)
Sembra quasi che questo materiale
alternativo (o parte di esso) sia stato fatto oggi e che non siano quindi
registrazioni originali dell’epoca,
come se Page volesse giustificare la nuova rimasterizzazione
del catalogo includendo un po’ di cose in più, ma senza svelare ciò che in realtà avvenne in studio in quegli anni.
Black Dog ha qualche vocalizzo in più alla fine e non ha l’assolo, sfido chiunque a trovare le differenze tra questa Rock
And Roll e quella originale; The Battle of Everymore è il semplice mix di chitarra e mandolino, Stairway to Heaven ha
qualche sfumatura diversa nel finale: il secondo riff di chitar-
ra che è presente in tutti i giri della sezione hard rock del cantato e la chitarra che cesella la chiusura. Per Misty Mountain
e Four Sticks vale quanto detto per Rock And Roll. When The
Levee Breaks ha il missaggio alternativo e, pur essendo una
minuzia, è interessante. Potente, con gli equilibri diversi.
HOUSES OF THE HOLY Companion Audio Disc
1. ‘The Song Remains the Same’ (guitar overdub reference
mix)
2. ‘The Rain Song’ (mix minus piano)
3. ‘Over The Hills and Far Away’ (guitar mix backing track)
4. ‘The Crunge’ (rough mix; keys up)
5. ‘Dancing Days’ (rough mix with vocal)
6. ‘No Quarter’ (rough mix with JPJ keyboard overdubs; no
vocal)
7. ‘The Ocean’ (working mix)
Forse è The Song Remains The Same
l’unica cosa di un certo interesse di
queste due nuove uscite, la versione
è quella senza la voce e con la chitarra solista che conduce le danze in
tutte le parti del pezzo. Forse sarebbe
stata il caso di presentarla come The
Campaign o The Overture, i nomi
che aveva il pezzo in origine nella
sua versione strumentale. The Rain
Song, The Crunge, Dancing Days e
The Ocean spostano di pochissimo
gli accenti mentre Over The Hills nel
finale sfuma mentre il riff acustico
iniziale torna (malamente) nel mix.
No Quarter è un rough mix senza
voce e assolo di chitarra, quello che
colpisce è la batteria di Bonham che
qui sembra ancor più efficace.
Insomma riassumendo. Nulla di
davvero interessante dunque nei
‘companion dis’c, e per l’ennesima
volta mi chiedo dove siano finiti
quegli 11 inediti esistenti del periodo 1971/75. Mi chiedo anche a che
pro mettere in piedi un trambusto
del genere per una semplice nuova
rimasterizzazione (pur molto buona) di dischi storici vista la pochezza
del materiale bonus. Il fatto è che se
Jimmy Page delude dei fan come il
sottoscritto e, posso assicurare, tanti altri nomi pesantissimi,
la cosa (dal suo punto di vista) è preoccupante. Il problema
è che Page sembra circondato solo da “yes men”: discografici, ingegneri del suono, giornalisti, amici, fan … nessuno riesce a dirgli le cose come stanno, sono tutti terrorizzati al solo
pensiero di fare con lui anche una piccola considerazione che
sia aderente alla realtà, perché basta quello per essere tagliati
fuori. Capisco che avere entrature con tipi come Jimmy Page
OUTSIDER
99
OLDIES BUT GOLDIES
possa essere elettrizzante, ma ogni tanto nella vita occorre
avere onestà intellettuale. In una recentissima intervista a
PAGE qualcuno gli chiede delle ‘bonus tracks’:
Going through the bonus tracks…
They’re not “bonus tracks!” The idea of the companion volumes is to get away from the idea of “bonus tracks.” And to
have something that is actually in the reflection of, or the
shadow of, the original album. You get running orders that
are very similar to the original album. So it’s nothing like
a “bonus” thing at all. As far as something like “Stairway”
goes, the whole perspective of the mix is quite different. It
has an audio “3D” quality to it, which is quite different to the
main version. There’s a version of “When the Levee Breaks,”
which was mixed in London on the companion disc, and
the harmonica is totally different from the version that was
done at Sunset Sound, on the version that everyone knows.
I’m really proud of that mix, because it’s so dense and it’s ominous and it’s cool.
Ecco, da qui si capisce che Jimmy Page ha perso
la bussola, lui stesso dice che con i companion
volumes l’idea era di allontanarsi dal concetto di
bonus tracks e di avere qualcosa che fosse il riflesso
dell’album originale. Vi sembra una mossa vincente? La quasi totalità dei LZ fan con un po’ di carattere è rimasta delusissima da questa campagna
di ristampe, la grandissima maggioranza dei ‘casual fan’ è assolutamente indifferente. Quello che
vende (ma ancora per quanto) è il brand Led Zeppelin, e dunque Page è molto fortunato, non fosse
così si dovrebbe porre qualche domanda e proporre qualcosa di sostanzioso quando ripubblica il catalogo; ma non si risolverà mai nulla, l’uomo vive
nella sua torre d’avorio circondato solo da servitù.
Peccato.
TIM TIRELLI
DAVID WIFFEN
DAVID WIFFEN
“David Wiffen! Chi era costui?” rumina tra sé, come un novello Don Abbondio, il recensore seduto sulla sua poltrona.
“David Wiffen! Questo nome mi par bene d’averlo letto o sentito...” Si, ma dove? Quando? La sua memoria è ormai ridotta a
un colabrodo, dal quale quotidianamente fuoriescono nomi,
fatti, titoli di dischi e di film, facce di persone e luoghi visitati,
in una sorta di inarrestabile fuga di massa. Un canadese forse?
O un inglese... O forse entrambe le cose. Insomma, non se lo
ricorda.
Ma prima di ripiegare miseramente su Wikipedia inglese, pro-
va a fare un ultimo sforzo, frugando nei propri ricordi come a
volte fa (sperando di trovare chissà cosa) in quei cestoni dei
centri commerciali pieni di cd a 99 centesimi. David Wiffen...
ma si! All’improvviso gli ricompare davanti una mappa del
Canada disegnata un tempo dal buon Valerio Marini per
il ‘Mucchio’ di allora, piena di indicazioni e di nomi (compreso quello di David Wiffen) all’epoca quasi tutti sconosciuti al
nostro recensore: il quale a questo punto si alza dalla poltrona
e punta dritto verso la sua privatissima stanza, quella che custodisce i dischi, i cd, i libri e i mensili raccolti nell’arco di una
vita, e destinati a chissà quale ingloriosa fine.
Eccolo lì, trovato: è il ‘Mucchio Selvaggio’ n.18, in copertina c’è
un elegante Roger McGuinn in dolcevita bianco, e fra gli articoli elencati a fianco c’è proprio quel CANADA Special che
stava cercando. Arriva a pagina 8, e alla vista della mappa la
sua memoria letteralmente si scoperchia, e tutto (o quasi) ritorna a galla. Quell’articolo, all’epoca, lo aveva letto e riletto
almeno dieci volte, affamato com’era di facce, suoni e nomi
nuovi, qualunque fosse la loro provenienza
geografica: David Essig, Willie P. Bennett, Valdy, Myles
& Lenny... e poi lui,
eccolo lì, David Wiffen, con quella faccia
uguale sputata a quella di un attore americano, uno che recitava la parte del capofamiglia alieno in un
vecchio telefilm... ma
si, come si chiamava...
Niente, un altro dei
fuggitivi.
L’anno era il 1979, e il
recensore, seguendo le dritte del ‘Mucchio’, si era già inoltrato
da tempo in territorio canadese (in quello meno battuto, s’intende: dalle parti di Neil Young o di Joni Mitchell c’erano già
stati tutti), scoprendo i nomi di Bruce Cockburn, Murray
McLauchlan, Gordon Lightfoot, Kate e Anna McGarrigle, ma in questo articolo ci si spingeva oltre, si esploravano
sentieri più impervi e nascosti, e fra i tanti artisti e dischi segnalati, quello che più lo colpì, chissà perché, fu Blackie And
The Rodeo King di Willie P.Bennett, che in qualche complicato modo riuscì a procurarsi. Stupendo.
Ricorda ancora, sulla prima facciata, una bellissima cover di
Stardust di Hoagy Carmichael, e gli vien voglia di riascoltarla.
Ma sotto la B (è tutto in ordine alfabetico, se no col cavolo) il
disco non c’è... e dunque? Forse sotto la P? Macchè. Poi si ricorda: l’ha regalato a un amico. Un tipo fidatissimo, un supremo
intenditore e collezionista, il quale, con buone probabilità, sta
leggendo queste righe proprio adesso. Il recensore ne approfitta per salutarlo. E intanto si consola pensando che forse su
Spotify... va bè, controllerà più tardi.
Ora la sua curiosità (ancora vivacissima, al contrario della
100
OUTSIDER
OLDIES BUT GOLDIES
OLDIES BUT GOLDIES
memoria) è tutta incentrata su questo disco di David Wiffen,
pubblicato nel 1971 per la Fantasy (l’etichetta dei Creedence),
ricomparso nel 2001 sul catalogo della disinvolta Akarma, e
oggi finalmente ripescato dalla Water Records. E scopre che
sì, Wiffen era nato in Inghilterra (suo padre era un ingegnere al servizio dell’esercito Britannico), ma si era trasferito in
Canada già nel 1958, al seguito della famiglia, quando aveva
solo sedici anni, e in breve tempo era riuscito ad inserirsi nel
circuito folk locale grazie soprattutto alla sua voce così atipica, baritonale e già matura, a metà strada fra quelle di Neil
Diamond e Leonard Cohen. Ma scopre anche che David era
un ragazzo inquieto, smanioso di scoprire il mondo (o quantomeno il Canada), e che presto abbandonò Toronto, dove
abitava con la famiglia, per dirigersi verso ovest (in autostop,
naturalmente) facendo tappa prima a Calgary, dove gestì un
piccolo locale dal festoso nome di Depression Folk Club, e poi
a Vancouver, dove prese parte, nel 1965, a quello che doveva essere un concerto collettivo alla Bunkhouse Coffehouse,
e che invece si trasformò in una performance solistica, per il
semplice motivo che nessuno dei musicisti invitati, a parte
lui, si presentò (forse per colpa delle strade ghiacciate, mi vien
da pensare).
Ne venne fuori un disco live che subito si trasformò in un oggetto di culto (il recensore, giusto per curiosità, prova a cercarlo su ebay, e ne trova una copia in vendita a 2850 dollari. Non
gli sembra il caso). Partì da lì la carriera di Wiffen, che lo portò
prima a militare tra le fila di vari gruppi dalla vita breve (The
Pacers, The Children, e i 3’s a Crowd, coi quali registra un album intitolato Cristopher’s Movie Matinee), e poi ad incidere
il suo primo album solista, David Wiffen per l’appunto, proprio quello che il recensore (perché, come si è detto, fu attratto
da un altro nome, perché trovarlo era impossibile, e soprattutto perché i soldi erano quelli che erano) non comprò. Ma
non è mai troppo tardi per nulla a questo mondo, e proprio
ora, nel mese di ottobre dell’anno 2014, con la stessa gioiosa
apprensione con cui si stappa un vino d’annata, si accinge ad
ascoltarlo per la prima volta.
La canzone d’apertura s’intitola One Step, e dura soltanto due
minuti e mezzo, ma basta e avanza per provocargli un moto
di commozione (il recensore, invecchiando, è diventato un
po’ sensibile): l’arpeggio di un’acustica, il suono pastorale di
un corno francese, una morbida sezione d’archi, e la voce suadente di Wiffen che recita : “Well, it just takes one step to start
a journey / No matter how far you may go...” Che meraviglia,
mica se l’aspettava un suono così. Pensava a qualcosa di più
semplice, di più ruspante, di più “canadese” insomma. Si allunga comodamente sulla poltrona e procede. E la strada si fa
piacevolmente flessuosa, ondulata, e lo conduce con dolcezza
dalla blanda psichedelia di Never Make A Dollar That Way
all’arioso country rock di I’ve Got My Ticket (con uno scintillante John McFee alla steel guitar), dalle atmosfere da saloon di What Alot Of Woman, a quelle da piano bar di Since I
Fell For You (cover di un celebre brano di Buddy Johnson),
dalla potente Drivin’ Wheel, una ballatona southern rock
che sembra uscita da un disco della Marshall Tucker Band,
a... E all’improvviso i neuroni del recensore si ricompattano
in forma di ricordo preciso: Drivin Wheel... ma certo, ecco chi
l’ha scritta! Subito gli torna in mente la muscolosa versione
dei Byrds su Farther Along, il loro disco d’addio, ma poi anche quella di Tom Rush, e dello stesso Roger McGuinn (prima del dolcevita bianco), e poi ancora dei Cowboy Junkies,
dei Jayhawks, persino di Chris Robinson... La memoria (la
sua, perlomeno) funziona così: se si riesce ad afferrarne un’estremità, poi tutto il resto le vien dietro, come in una rete da
pesca. Ma di tutte le Drivin’ Wheel che ricorda, questa gli
sembra proprio la migliore, a conferma del fatto che la versione originale di qualunque canzone rimane il più delle volte
insuperabile.
Poi arriva la beffarda Mr.Wiffen (Is Incommunicado Today),
in cui Wiffen stesso, parlando di sé in terza persona, comunica al mondo la sua volontà di non comunicare, abdicando al
proprio ruolo di autore. Geniale. E poi ancora Blues Was The
Name Of The Song, un capolavoro di arguzia e concisione, e
la malinconica Mention My Name In Passing (peccato per
quel synth, che si poteva evitare. Molto meglio la versione
per basso, pianoforte e voce aggiunta come bonus track), per
giungere a conclusione con More Often Than Not, una sorta
di confessione a proposito dell’abuso di alcol nel quale l’autore sta lentamente scivolando, che verrà ripresa da Jerry Jeff
Walker (pure lui assai incline alla bottiglia) nel suo Bein’
Free.
Il disco originale finirebbe qui, ma in questa nuove edizione
c’è spazio per due inediti (uno dei quali è la cover di Lover’s
Prayer di Randy Newman), e due alternate takes di ottima
qualità.
E il recensore, a questo punto, sorride, pervaso da quella specie di felicità retroattiva (non sa come altro definirla) che soltanto questo genere di scoperte riesce ancora a trasmettergli.
Ed ancora più felice lo rende il fatto che David Wiffen, dopo
questo disco, ne fece subito un altro (e poi più niente, nessuno
sa bene il perché), a detta di tutti anche più bello, e che lui, a
quarant’anni di distanza, ancora non l’ha sentito. Mai, nemmeno una volta. Che goduria.
P.S.: John Lithgow! Ecco come si chiamava l’attore... Un fuggitivo in meno.
CARLO ZAMPOLINI
JONI MITCHELL
LOVE HAS MANY FACES: A QUARTET,
A BALLET, WAITING TO BE DANCED
Il famoso cofanetto di cui si parla oramai da più di dieci anni
è finalmente qui. La signora l’ha scelto, disegnato, commentato e approvato con i suoi tempi e le sue modalità. Joni
Mitchell ha fatto degli ultimi 20 anni uno spazio temporale
OUTSIDER
101
OLDIES BUT GOLDIES
per opporsi, criticare, estraniarsi, distanziarsi. Ovviamente il
suo nemico n.1 è l’industria discografica, che lei stessa definì
alcuni anni fa “un cesso”. Si è tolta tutti i macigni dal cuore e
dalle scarpe commentando su tutto e su tutti con uno spietato acume e spavalderia. Ad una signora cosi con un bagaglio
come quello contenuto in questo cofanetto cosa gli puoi dire?
Di cosa può avere paura? Chi puo contraddirla? Q-tip il rapper
che per il bellissimo brano di Janet Jackson Got ‘till It’s Gone
che campionava Big Yellow Taxi ha coniato la frase “Joni
Mitchell never lies”.
E forse la sua integrità è una delle doti che più ha dimostrato
di avere in questo mezzo secolo di carriera, una carriera che
è andata sempre contro le mode, le tendenze, le direzioni, il
“marketing”. La sua è stata una ossessiva ricerca della perfezione, che soprattutto negli anni settanta l’ha portata a distanziarsi da tutti i generi, fino a crearne uno tutto suo. Joni
è Joni. La Joni che ha mescolato le carte con il rock, il pop, il
jazz. Che è arrivata perfino a creare una sua accordatura per
suonare la chitarra.
In questi 53 brani che spaziano da Both Sides Now del 1969,
fino ad Hana del 2007 (il suo ultimo album in tutti i sensi) si
sottolinea una personalità irrequieta, ribelle, castigatrice ma
al tempo stesso innovatrice. Il sound Joni Mitchell è quanto
di più complesso la musica pop ci abbia offerto. Basti pensare
all’album Hejira qui rappresentato con 3 brani, dove la sua
chitarra è accompagnata in un duetto percussivo e armonico
dal basso elettrico di Jaco Pastorius. E se l’album Court And
Spark è quello piu vicino ad un compromesso commerciale
(6 i brani contenuti qui), forse il successivo The Hissing Of
Summer Lawns che all’epoca fu stracciato dalla critica è quello che nel tempo ha acquistato status di culto a partire dalla
bellissima copertina.
Gli anni ottanta e il sodalizio con un nuovo marito, il bassista Larry Klein l’hanno riconciliata con il mercato seppure a
modo suo. Tre gli album: Wild Things Run Fast, Dog Eat Dog e
Chalk Mark In A Rainstorm. Night Ride Home invece inaugura una trilogia con Turbulent Indigo e Taming Of The Tiger
di un ritorno ad una versione acustica spigolosa e intimista.
Dopo il divorzio da Klein che pure l’aiuta nei due bellissimi
volumi orchestrali di standard e rivisitazioni del suo repertorio, la Mitchell si è rinchiusa nel privato prima ritrovando
la figlia che aveva abbandonato all’inizio della sua carriera
e poi separandosene di nuovo per incompatibilità caratteriale. A 70 anni è diventata una Greta Garbo della musica che si
concede ogni tanto a celebrazioni, mostre di quadri, balletti
ispirati dalla sua musica. Anni fa ha anche dichiarato che la
musica non ha più l’ispirazione forte che aveva un tempo, ed
è stata sostituita dalla pittura.
Questo cofanetto, dal titolo pretenzioso e forzato è qui per ribadire che una carriera cosi minuziosa e perfetta non si può
dimenticare dall’assenza fisica della sua protagonista. Le sue
canzoni anche senza di lei vivono una vita propria e testimoniano momenti di straordinario genio e lucidità inarrivabili
allora come oggi. Non a caso ‘The Guardian’ in un recente articolo si è spinto a dichiarare che la Mitchell soprattutto considerando l’apice della sua carriera (da Blue del 1971 a Hejira
del 1976) dimostra di essere un caso a parte nei letterati della
musica pop e rock (Dylan, Cohen, Lennon, Young….), ipotizzando che in quei cinque anni la sua produzione sia superiore a quelli di tutti gli altri.
MARCO CESTONI
RY COODER
SOUNDTRACKS
Nel corso della sua lunga carriera, Ry Cooder ha evitato con
successo il culto della personalità. La sua musica si eleva da
sola senza interferenze. Troppo spesso i dischi vengono venduti sulla base di quel che sta dietro – cosa accade nella vita
privata dell’artista, come o perché la musica è stata composta,
o semplicemente attraverso una grande sovra-rappresentazione del musicista.
Come ascoltatore e frenetico consumatore di musica, diventa un po’ noioso vedere pompata una storia nei giornali o in
tv per essere persuasi a comprare qualcosa sia che ti piaccia
quella musica o no. I responsabili delle pubbliche relazioni
e i guru del marketing potranno sussultare disapprovando e
protestando, mostrando classifiche e analisi a favore del marchio, del logo e dei messaggi subliminali. Eppure nessuna
percentuale di carisma mi convincerà ad investire tempo e
denaro nella musica di una rockstar se la musica fa schifo; le
circostanze della sua esistenza e di come il musicista ha scoperto le virtù del succo vegetale macrobiotico nella sua disintossicazione, sono irrilevanti. Il problema è che tutto è già stato fatto e scritto più volte, ma la critica è in cerca del modo per
interessare il lettore; la spazzatura promozionale qualche vol-
102
OUTSIDER
OLDIES BUT GOLDIES
OLDIES BUT GOLDIES
ta è una cosa necessaria per far iniziare le cose a funzionare.
Al tempo stesso, la critica sa che le uscite stampa sono il punto
di vista della casa discografica; niente di negativo, quasi sicuramente tutto al superlativo, e in questa posizione il recensore deve decidere se lui o lei non siano altro che dei dilettanti,
parafrasando quel che gli è stato passato o in alternativa accettare solo ciò che sia rilevante con un pizzico di scetticismo,
scartando il resto. La situazione si presta alla nevrosi, se il critico apprezzi ma al tempo stesso risenta dell’informazione fornita dal meccanismo corporativo. Questo è il motivo per cui
chi scrive di musica spesso se non diventa un passivo-aggressivo è soggetto a umori mutevoli; è un brutto affare, questo,
interessante solo per individui conflittuali o tormentati, che
sono nell’ambiente per la gloria e non certo per i soldi. Potete capire perché Lou Reed non fosse entusiasta della critica
musicale; l’unico che abbia mai apprezzato fu Jeremy Reed,
un poeta.
La pagina di Wikipedia di molti artisti ha
una sezione di “vita
personale”, ma per Ry
Cooder non c’è un bel
niente. E neppure sarete in grado di trovare una biografia o una
autobiografia. Cooder
ha avuto la tendenza
a restare da qualche
parte in seconda o
in prima fila nei momenti
significativi
della storia della musica; nei sessanta se
ne andava in giro con
Taj Mahal, Captain Beefheart, Lowell George e Randy
Newman e pare certo che gli fosse anche stato chiesto di entrare nei Rolling Stones anche se Richard doveva avere ben
chiaro che non era certo il tipo adatto a sostenere il loro ritmo.
Infatti, meglio Ron Wood,.
Dicono comunque che abbia insegnato a Keith Richards
ad accordare la chitarra blues a cinque corde; poi gli Stones
se ne andarono a conquistare il mondo con una cascata di riff
di chitarra.
Sebbene lavorasse alla colonna sonora di Performance nel
1970, quel decennio è stato speso principalmente sulla carriera solista per cui divenne noto come un asso della chitarra
slide, la sperimentazione e l’innovazione con la musica americana diventando quasi un modello per i movimenti alternativi country e di Americana. Gli anni ottanta sono passati
principalmente a comporre colonne sonore e i novanta su
quello che è nota come world music con A Meeting By The
River, Talking Timbuktu e Buena Vista Social Club. Gli ultimi anni vedono Cooder tornare di nuovo alla carriera solista.
Nonostante sia indicato da molti come uno dei cento migliori chitarristi, Cooder sembra avere un approccio alla vita con
una notevole mancanza di ego, e la mancanza di informazio-
ni personali di dominio pubblico suggeriscono che non sia
particolarmente interessato a diventare una celebrità.
Di conseguenza è comprensibile che la carriera di Cooder
possa confondere l’appassionato di musica moderna, essendo il narcisismo e l’ossessione di se stesso il punto di partenza
di una industria basato sull’artista individuale o sui ragazzi
del gruppo. Quando Cooder pubblica dischi solisti sono raramente incentrati su se stesso, ma basati sulla vita e le storie di
altra gente. Chavez Ravine tratta della comunità di Los Angeles, My Name is Buddy è la storia di un felino e I, Flathead
è incentrato sulla cultura delle corse di automobili. In questo
contesto passare una decade a comporre colonne sonore non
sorprende del tutto, ma dal punto di vista di un fan potrebbe
sembrare sbagliato quando avrebbe potuto cantare di se stesso. Non è necessario aggiungere che il recente libro di Cooder,
Los Angeles Stories, tratta ancora di altri. Il ragazzo è veramente modesto.
L’uscita stampa della
Rhino per Soundtracks
è minimale, attaccata
ai fatti; un box retrospettivo con sette cd
di colonne sonore. Tra
il 1985 ed il 1986, Cooder ha attraversato
un periodo prolifico in
cui ha composto oltre
la metà delle colonne sonore di questa
raccolta – Alamo Bay,
Blue City, Crossroads
e Paris,Texas. Le musiche spaziano molto
in termini di stile, anche se il gruppo di musicisti che le hanno suonate è rimasto
sostanzialmente il medesimo. Difatti, Jim Kelter, il leggendario Jim Dickinson, il chitarrista David Lindley ed il
compositore Van Dyke Parks possono essere sentiti in ogni
colonna sonora della raccolta.
Cooder era stato avvicinato dal regista Walter Hill nel 1980
per il suo western The Long Riders e come dimostra questa
raccolta fu un buon inizio per un numero considerevole di lavori insieme. La colonna sonora si dirige profondamente nel
folk, utilizzando pezzi della guerra civile come Rally ‘Round
The Flag per assicurarsi autenticità con l’utilizzo di strumenti
tradizionali come banjo, violini, un sax e tamburelli. I monologhi parlati sono interessanti ma enfatizzano che questa era
musica creata per un film. Sfortunatamente, comunque, Jack
Of Diamonds, che faceva parte del film e non compare sulla
pubblicazione originale, è ancora mancante.
Music For Alamo seguiva nel 1995, qualcosa di sostanzialmente differente, e questa volta per il regista Louis Malle.
Il film trattava di un veterano del Vietnam che tornava e la
musica è appropriata. Theme From Alamo Bay è splendidamente melodica e tutti i pezzi sono evocativi, malinconici e
d’effetto, arricchiti da una strumentazione giapponese come
OUTSIDER
103
OLDIES BUT GOLDIES
il shakuhachi. John Hiatt e Amy Madigan si impegnano
in un melodioso duetto country, Too Close; The Last Chance è
un pezzo da ballo da bar con il cantante dei Fear, Lee Ving e
David Hidalgo e Cesar Rosas dei Los Lobos ospiti sul bel
valzer Quatro Vicios.
Wim Wenders fu il successivo a sfruttare Cooder per una
colonna sonora sul suo importante Paris, Texas sui tentativi
di un uomo colpito da amnesia di rivivere relazioni familiari.
La musica è spoglia e metallica, meravigliosamente evocativa della vastità e del vuoto del paesaggio desertico del film. Il
tema centrale è basato su Dark Is The Night di Blind Willie
Johnson e la maggior parte della musica è una variazione su
quel motivo dominante. Harry Dean Stanton aggiunge un
delicato cantato spagnolo in Cancion Mixteca e ci sono alcuni
dialoghi dal film inclusi in I Knew These People che ha una
atmosfera paurosa. Wenders e Cooder sono tornati a lavorare
insieme un po’ di tempo dopo per Buena Vista Social Club.
Ci spostiamo su Blue City di Walter Hill, con Judd Nelson e
Ally Sheedy, un film genericamente considerato una delusione. La colonna sonora è adeguata al suo tempo; la musica
è impegnativa con molti effetti e sintetizzatori ma il modo di
suonare di Cooder emerge comunque. Benmont Tench e
Bobby King compaiono e Alejandro Escovedo dei True
Believers suona in Marianne che è un valido pezzo pop.
Don’t Take Your Guns To Town è una cover di una canzone di
Johnny Cash e potrebbe sembrare l’uomo in nero in persona. Il film di Hill, Crossroads, è un altro film che non ha avuto fortuna; i film su cui Cooder ha lavorato (fino a Cocktail)
non hanno avuto un grande successo commerciale. Crossroads era una odissea blues ispirata da Robert Johnson e la
musica mescola rifacimenti e materiale originale. Il modo di
suonare di Cooder è puntuale e Sonny Terry aggiunge grandi parti di armonica. Sfortunatamente nella colonna sonora
manca il punto focale del film suonato da Steve Vai e Cooder
e che può essere trovato su The Elusive Light and Sound Volume 1 di Steve Vai.
Johnny Handsome, un thriller con Mickey Rourke e Ellen
Barkin ha avuto problemi al botteghino nonostante i nomi
di grandi attori. La colonna sonora è interamente strumentale, interessante, con alcuni ritmi più lenti. Clip Joint Rhumba
e Cajun Metal sono classici brani di Cooder e il cd contiene
la musica più cinematografica della raccolta. Nel 1992 Hill e
Cooder si unirono per Trespass, un altro thriller scritto anni
prima da Robert Zemeckis e Bob Gale. La musica è jazz sperimentale, smussato dalla tromba di Jon Hassell, la chitarra
di Cooder e le batteria pulsante di Keltner. Cazzuto e dissonante non è il disco che vorreste ascoltare se aveste il mal di testa.
Deve essere un lavoro complicato comporre musica per un
film. In primo luogo c’è da assicurarsi che la musica non sia
più potente delle immagini sullo schermo e che, al tempo
stesso, abbia un certo impatto. Questa raccolta mostra il lavoro di Cooder fuori dai grandi effetti, tuttavia, senza poter
vedere i film chi potrebbe dire se tutto era funzionato bene
nei cinema? Quel che è certo è che di per se questi dischi sono
caratteristici e interessanti da ascoltare. Cooder apparentemente guardava al suo lavoro sui film come più prossimo alla
musica che amava fare che il Ry Cooder che noi conosciamo
ascoltando i suoi dischi solo; era libero di buttare giù il paesaggio acustico che aveva in testa, lontano dalle pressioni commerciali dell’industria musicale. Con rispetto allo stile, potete
ascoltare tutte queste colonne sonore e alla fine dell’esperienza non sarete più vicini a sapere nulla sull’uomo stesso eccetto quello che ama: la musica, la musica, la musica.
Infine è forse sorprendente che le sue colonne sonore per Southern Comfort, The Border e Streets of Fire manchino, ma forse c’è un’altra raccolta che uscirà. Nel frattempo Soundtracks
è una meticolosa introduzione per il Cooder cinematografico,
essenziale per fans e appassionati di film, ma non aspettatevi
alcun pettegolezzo hollywoodiano. Per quello dovete andare
altrove.
CHARLES PITTER
GEORGE HARRISON
THE APPLE YEARS
Nella gerarchia dei dischi solisti dei Beatles, il livello qualitativo di George Harrison è di poco al di sopra delle uscite
periodiche di Ringo Starr. E se venisse individuato in assoluto limitandosi al meglio, la discussione che lo riguarda inizierebbe con il suo disco del 1970, All Things Must Pass, finendo
con Cloud Nine, il disco del 1987 che ha lanciato il suo ultimo
vero hit.
I sette album che ha inciso nel mezzo tutto questo tempo,
tendono a essere eliminati dalla conversazione. Non sono
qua per cercare di offrire una revisione della prima parte dei
dischi solisti di Harrison che sono stati abbelliti da un punto
di vista acustico e impacchettati per un box, The Apple Years: 1968-1975. I sei dischi presi singolarmente e nell’insieme
sono vicende incostanti che mostrano il defunto George al
massimo della sua auto-indulgenza e coinvolgimento spirituale. Le sue qualità indulgenti sono fortemente evidenti nei
primi due dischi di questa collezione: Wonderwall Music del
1968 ed Electronic Sound dell’anno successivo. Il primo è una
colonna sonora che Harrison ha messo insieme per accompagnare il film Wonderwall, una cosa ridicola risalente alla
Swingin’ London e notabile solo le forme spesso nude dell’attrice Jane Birkin.
Eccetto alcuni momenti di pop psichedelico (il bel brano In
The First Place inciso con The Remo Four), il lavoro resiste solo come tentativo di portare il suono della musica indiana di fronte a un pubblico più vasto. Le esibizioni di sitar,
shehnai e tabla sono graziose, ma fin troppo brevi per coinvolgerti all’interno del potere ipnotico di quella musica. Ancor più decadente è il suo seguito, un album costituito di due
lunghi brani dove Harrison gioca con il suo nuovo giocattolino: un sintetizzatore Moog. Una cosa banale. Da quel mo-
104
OUTSIDER
OLDIES BUT GOLDIES
OLDIES BUT GOLDIES
mento Harrison decise di tornare a uno stile più tradizionale,
con quattro album che scavavano all’interno di tematiche
che hanno segnato quasi tutti i lavori solisti dei Beatles – il
desiderio per l’amore e la pace nel mondo – così come rivelare
i suoi sentimenti religiosi profondi ed uno sbilanciato senso
dell’umorismo.
Tutti questi interessi sono avvolti nell’irregolare, ambizioso
All Things Must Pass. Quando venne pubblicato nel 1970, si
trattò di una cosa imponente: un disco triplo confezionato in
un grande cartonato. Se eri un acquirente di dischi all’epoca
non c’era modo di evitare quel genere di cosa. E se ne portavi
uno a casa non c’era modo di evitarne anche la musica. Erano
canzoni avvolgenti, imbottite dal produttore Phil Spector
e da una grande lista di collaboratori che includevano Eric
Clapton, membri dei Badfinger, un giovane Phil Collins
e il vecchio amico e compagno Ringo Starr. È troppa, troppa musica per una sola uscita, incastonata, però con le sue
gemme – i singoli What Is Life e My Sweet Lord così come
l’estatica Wah-Wah e l’eccellente riflessione sui rimorsi di
Isn’t It A Pity. Chi vorrebbe, però, andare dopo oltre passando
a un secondo disco e poi a un terzo di jam session prolisse? All
Things avrà venduto anche più di sei dischi di platino, ma è
anche uno dei dischi usati più facili da trovare in circolazione.
Ci sono voluti tre anni a Harrison per pubblicare un altro disco solista, dato che passò un po’ di tempo per fare campagne
e raccogliere denaro per i rifugiati senza casa della guerra di
otto mesi per la liberazione del Bangladesh. Venne fuori da
quella situazione attraverso il Living In The Material World
del 1973 esprimendo la sua frustrazione per l’ineguaglianza
dei redditi, su The Day The World Gets ‘Round, segnalando la
sua profonda connessione con il Dio Hindu, Krishna con The
Lord Loves The One, combattendo la sua condizione di star e
la sua ricchezza con il brano che dà il titolo al disco e attaccando i suoi precedenti compagni di gruppo e le loro cause
sull’eredità dei Beatles, Sue Me Sue You Blues.
Living è l’album che beneficia maggiormente degli sforzi di
questa rimasterizzazione, aiutando a riportare fuori il vigore
del lavoro chitarristico e delle voci di Harrison, la freschezza
del suo lavoro di produzione e dove la sezione ritmica suona
particolarmente presente, e la sua grande abilità negli arrangiamenti e come il brano principale del disco luccichi da uno
swing blues all’esplorazione del sitar e delle tabla. Di tutti i
dischi del cofanetto Apple Years, questo è maturo per essere
riscoperto. Meno lo sono gli altri due dischi inclusi in questo
pacchetto, Dark Horse e Extra Texture. Pur non essendo completi fallimenti artistici, questi dischi vedono Harrison perdere il suo istinto compositivo. Alcuni motivi potrebbero essere
attribuiti ai problemi che attraversava la sua vita personale al
tempo in cui ognuno venne inciso. Dark Horse venne registrato mentre Harrison fronteggiava una crisi religiosa e il divorzio; Extra venne fuori nell’ambito della povera accoglienza ottenuta dal dischi precedenti e del tour che fece nel Nord
America insieme a Ravi Shankar. Entrambi i dischi hanno
comunque momenti in cui la vena di Harrison torna a galla.
La frivola Is It He su Dark è una gioiosa affermazione delle
sue preferenze spirituali che mescola molti interessi musicali
insieme a strumenti indiani, il folk inglese e gli attacchi dei
fiati R & B. Poche delle ballate su Texture vanno in profondità
come la disperata Grey Cloudy Lies e la densa The Answer’s
At The End con piano e archi. Harrison riesce persino a venire fuori con un canto natalizio, Ding Dong, Ding Dong che è
contagioso come la Wonderful Christmas Time di McCartney e globalmente aperta come la Happy Xmas(War Is Over)
di Lennon.
Gli appassionati dei Beatles che avevano già le uscite su cd
di questi dischi faranno bene a domandarsi che beneficio potrebbe venire dall’aprire nuovamente i loro portafogli. Vorrei
poter esservi utile. Non ho passato molto tempo ascoltando
le rimasterizzazioni precedenti così non potrei dirvi se ci sia o
meno alcun miglioramento. E dato che nessuno mi ha fornito
il DVD o il libretto per poterne parlare non vi sono di aiuto
nemmeno in questo caso. Quel che potrei dire è che le poche
tracce aggiuntive non necessariamente arricchiscono i dischi,
al di fuori della benefica inclusione sul disco Material World
di Bangla Desh, il singolo del
1971 che precorse i concerti
di beneficienza a New York.
Se occasionalmente siete appassionati dei Fab Four e di
tutte le loro uscite prima e
dopo, questo brano è essenziale da ascoltare per avvicinarvi ad apprezzare la crescita artistica e di essere umano
di Harrison. Prendete in un
colpo solo tutti questi dischi o sperate che vengano
pubblicati singolarmente.
In ogni caso immaginate
Harrison che vi attenderà a
braccia aperte e con sorriso
malizioso sul volto.
ROBERT HAM
OUTSIDER
105
OLDIES BUT GOLDIES
MCCARTNEY / WINGS
WINGS AT THE SPEED OF SOUND
VENUS AND MARS
L’album Venus And Mars del 1975 di Paul McCartney è stato rimasterizzato e ampliato per includere un secondo disco
di materiale aggiuntivo. Come nelle precedenti uscite della
‘Archive Collection’, la confezione di lusso a libretto include un DVD, oltre a un confezionamento più accurato e altre
note interne. Il disco originale, che contiene i singoli Listen
To What The Man Said e Venus And Mars/Rock Show, suona
molto migliorato rispetto all’originale, vecchio di decenni. Le
armonie, in particolare, risuonano di grande chiarezza; prendete la Spirits of Ancient Egypt di Denny Laine come primo esempio. Le rocchettare Letting Go e la Medicine Jar del
chitarrista Jimmy McCullogh ti danno un pugno finale che
non sentivi in precedenza.
Il secondo disco contiene quattordici canzoni in più, alcune delle quali erano
già state disponibili
ma che sono state
comunque rimasterizzate. Il singolo del
1974, Junior’s Farm,
emerge, seguito dalla
sua seconda facciata
country, Sally G, che
per la grande richiesta venne poi pubblicato come singolo
a se stante diventando un hit. I Wings
hanno pubblicato lo
strumentale jazzato
Walking In The Park
With Eloise, scritto dal padre di Paul, James McCartney, sotto lo pseudonimo di The Country Harms. Il suo lato B blueseggiante, Bridge On The River Suite, è anch’esso presente.
Lettin Go venne pubblicato come singolo con un mix differente che toglieva il riverbero presente sulla versione dell’album e quella revisione fa qui il suo debutto digitale per la prima volta. Un estratto di sette minuti di Rock Show vede McCartney e i Wings tirare il brano in maniera più rigida della
debole versione dell’album. Un demo di piano per Let’s Love,
in seguito registrato da Peggy Lee ci permette di ascoltare
McCartney cantare quella melodia delicata. Going To New
Orleans è un precursore di quello che divenne il lato B, My
Carnival, incluso anch’esso. C’è anche una intrigante, versione introspettiva e acustica di un pezzo chiamato 4th Of July.
Ovviamente la confezione finale a libretto non era disponibile per la recensione ma il DVD di 25 minuti, sì. È una proposta
decisamente leggerina: tre brani di filmati casalinghi e uno
spot pubblicitario di annata per il disco. Possiamo vedere riprese dei Wings in studio, che gironzolano per New Orleans
dove il disco venne inciso e che fanno le prove. Gli appassionati di McCartney lo apprezzeranno ma sicuramente penseranno che si sarebbe potuto fare di più. Grazie alla rimasterizzazione e al miglioramento del suono, Venus And Mars con
la parte aggiuntiva di audio valgono comunque la pena.
Wings At The Speed Of Sound è invece un disco di successi
che ha passato sette settimane in vetta alla classifica di Billboard nel 1976, l’ultima ristampa della serie Archive Collection di Paul McCartney. Il disco originale di undici brani è
sempre stato un po’ traballante in termini di qualità, con solo
sei pezzi cantati da McCartney. Le canzoni restanti erano state
distribuite tra i vari membri dei Wings, con Denny Laine
che ne cantava due. Quel che fa questa edizione di Speed Of
Sound così necessaria è la fedeltà sonora sensibilmente migliorata. Gli arrangiamenti infinitamente fantasiosi non sono
mai suonati così effervescenti. Il basso di McCartney in particolare scoppietta come mai nel classico Silly Love Songs e
continua a pulsare sul rock sentimentale di Laine, Beware
My Love. Un secondo disco include sette brani aggiuntivi,
uno dei quali, Message To Joe, è un buffo ritaglio che dura
meno di un minuto.
I due pezzi forti sono
esecuzioni alternative di Beware My
Love e Must Do Something About It.
John Bonham dei
Led Zeppelin suona la batteria nel
primo brano mentre
McCartney
canta
nel secondo; Joe English il batterista si
occupa del cantato.
Ci sono affascinanti
demo di pianoforte
per Silly Love Songs
e She’s My Baby. E altri demo per la ballata di chiusura Warm
And Beautiful e per il classico da classifica Let ‘em In.
Esiste anche una confezione con un libretto di lusso, ma il
DVD in quella versione è comunque spiacevolmente corto,
circa 22 minuti, con un contenuto di due filmati casalinghi
oltre al video promozionale di Silly Love Songs. È un peccato che alcuni pezzi inediti di concerti dal tour di Wings Over
America, che era a supporto di Speed Of Sound non siano stati
svelati. Ed anche se non è così interessante come la pubblicazione concomitante di Venus And Mars, le parti aggiuntive di
audio sono certamente benvenute.
Wings At The Speed Of Sound potrà anche essere una delle
uscite più deboli di McCartney nei settanta, ma la remasterizzazione ne fa una una aggiunta che vale la pena di essere
inclusa in ogni collezione.
THE OTHER CHAD
106
OUTSIDER
OLDIES BUT GOLDIES
OLDIES BUT GOLDIES
LOWELL GEORGE
THANKS I’LL EAT IT HERE
Sarò sincero: quando misi le mani per la prima volta su questo disco, il tanto atteso (da me, perlomeno) esordio solista del
sommo Lowell George (“The Orson Welles of rock”, come lo
definì una volta Jackson Browne), mi girarono le palle, e non
poco, prima ancora di averlo sfilato dalla busta e piazzato sul
giradischi. Il motivo è presto detto: sapevo bene (o meglio, lo
supponevo: all’epoca mica esisteva il pollaio globale di twitter e facebook) che Lowell George non stava attraversando un
periodo dei più proficui sul piano creativo, e questo a causa di
una serie di attriti e disaccordi maturati all’interno dei Little
Feat, e alla fine sfociati in una sorta di ammutinamento messo in atto dai suoi due storici luogotenenti Bill Payne e Paul
Barrere, (prova ne furono i due più recenti album della band,
The Last Record Album e Time Loves A Hero, in cui capitan George risultava quasi del tutto irreperibile); e sapevo
anche (pardòn, lo supponevo) che ciò
era strettamente legato al progressivo peggioramento delle condizioni
di salute dello stesso Lowell George,
uomo sfrenato e bulimico, notoriamente incline ad ogni tipo di eccesso
(speedball, whiskey e junk food ingerito in dosi equine lo avevano portato
a pesare la bellezza di 140 chili a poco
più di trent’anni d’età); pur sapendo, o
sospettando, tutto questo, io ero ancora fermamente convinto del fatto che
lui, l’esautorato Capitano, in realtà
stesse solo facendo melina, e avesse
tenuto da parte il materiale migliore
proprio per questo suo esordio solista
da lungo tempo rimandato (il contratto per la sua realizzazione risaliva al 1975); e tutto questo alla
faccia dei suddetti ammutinati, e di coloro che lo davano già
per finito, scoppiato, incapace di produrre alcunché; ed ero
pronto a scommettere che fosse questa, in realtà, la vera ragione della sua recente latitanza, e che tutto si sarebbe chiarito
dopo l’uscita di questo disco.
E invece no, mi sbagliavo: scorrendo i titoli delle nove canzoni
che componevano il tanto sospirato Thanks I’ll Eat It Here,
scoprii che soltanto una (Two Trains) portava la firma di Lowell George, ed oltretutto si trattava di un brano vecchio di sei
anni, ripescato da Dixie Chicken. E non bastò la presenza di
altri tre brani a doppia firma (Cheek To Cheek con Van Dyke
Parks – l’autore preferito da Brian Wilson dei Beach Boys -,
Honest Man con Fred Tackett, e 20 Million Things con un
certo Jed Levy, che scoprii in seguito essere il suo figliastro)
per alleviare la mia delusione. Forse i pessimisti avevano ra-
gione, forse Lowell George era veramente scoppiato, e questo
disco altro non era che la classica raccolta di avanzi e materiali di risulta rastrellati qua e là, giusto per obblighi di contratto.
Persino la copertina mi aveva illuso, con quel rassicurante
ritratto (firmato dal solito Neon Park) di un Lowell George fresco e sbarbato come non lo si vedeva da tempo, con l’occhio
scintillante e un refolo di vento fra i capelli, sullo sfondo di
un surreale Déjeuner Sur L’herbe fra Marlene Ditrich, Fidel
Castro e un cornutissimo Bob Dylan. Da sola valeva il prezzo
del disco. Che a quel punto, senza troppa convinzione, mi decisi a sfilare dalla busta e a piazzare sul giradischi.
E quando la puntina scese finalmente sui solchi, e risuonarono le prime note di What Do You Want The Girl To Do, uno
dei tanti capolavori usciti dal cilindro del mago Allen Toussaint, mi tornò in mente una vecchia frase che mi sentivo
ripetere spesso da bambino, quasi sempre accompagnata da
una sonora scoppola: scùlta, prima ‘d parlà. Prima di parlare,
ascolta. Eh già.
Erano bastati quei pochi secondi iniziali per farmi capire che
avevo parlato a vanvera, che Lowell George era vivo e vegeto, e che qui c’era da divertirsi, altro che materiale di risulta.
Una breve introduzione di piano elettrico, una calibratissima spinta di basso e batteria, ed ecco irrompere una cascata
di fiati e cori femminili, dalla quale
emerse, limpida e definita come forse
non l’avevo era mai sentita, la splendida voce di Lowell George. L’atmosfera era quella tipica del white soul
anni 70, calda ed avvolgente come
una coperta di lana (ma in questo
caso si trattava di puro cachemire),
e venne subito ripresa dalla successiva Honest Man, un incalzante
up-tempo sorretto ancora da fiati e
controcanti corali, che sembrò virare
addirittura dalle parti di Stevie Wonder (in un’intervista per il lancio del
disco George lo citò fra i suoi cantanti preferiti, assieme a Marvin Gaye e
Tony Bennett). Poi fu la volta di Two
Trains, ovvero di quello che temevo fosse un riciclo (altra
meritata scoppola), e che invece si rivelò essere una canzone
rivista e rimodellata al punto tale da essersi trasformata in
una bomba funky degna dei migliori Meters. E a chiudere
la facciata una cover di I Can’t Stand The Rain, perfetto esempio di quel Memphis soul ormai in procinto di trasformarsi in
disco (la scrisse, e la portò al successo, Ann Peebles qualche
anno prima), qui utilizzata da George come un vero e proprio
palcoscenico dal quale esibire tutte le proprie doti vocali e
strumentistiche (spuntò solo qui, per la prima volta, la sua inconfondibile slide). Fine della prima facciata.
Non era esattamente quello che mi aspettavo, certo, ma era
comunque qualcosa di assolutamente irresistibile. Ecco cosa
aveva in mente Lowell George: un album di musica soulfunky che rendesse omaggio alle sue vere radici musicali,
quelle che avevano forgiato il maestoso albero dei Little
OUTSIDER
107
OLDIES BUT GOLDIES
Feat, prima che questo ramificasse, come si è detto all’inizio,
in altre direzioni, a lui del tutto estranee ed incomprensibili
(al giornalista Bill Flanagan, che in un’intervista dell’epoca volle strappargli un giudizio su alcuni brani composti da
Bill Payne, George rispose senza mezzi termini: “È una cosa
imbarazzante, che mi fa andare fuori di testa. La completa
antitesi di tutto ciò che i Little Feat hanno sempre suonato”).
Insomma, era un modo per ristabilire le giuste coordinate, e
ritrovare la rotta. Mi sembrò di aver capito, a quel punto: ma
quando girai il disco sul lato B, ecco scattare la trappola: una
chitarra spagnola, una vihuela e un guitarrón diedero il via
all’inattesa Cheek To Cheek , un brano in puro stile mariachi, che senza un minimo di preavviso (e senza nemmeno la
pausa del cambio di facciata, ora che è finita su cd) catapulta
l’ascoltatore da Memphis, dove si trovava un istante prima,
direttamente a Guadalajara, città natale di Speedy Gonzales.
No, Lowell George non è scoppiato, pensai: è semplicemente
pazzo (“There was nothing regular about the guy” confermerà la vedova Elizabeth molti anni dopo). Qui c’era lo zampino dell’amico Van Dyke Parks, ovviamente, pazzo almeno
quanto lui, e da sempre incline a questo tipo di escursioni. E
poi? Ecco spuntare la canzone di una certa Rickie Lee Jones
(all’epoca quasi nessuno sapeva chi fosse: il suo disco d’esordio uscì in contemporanea a questo), una giovane e promettente cantautrice che Lowell George aveva visto esibirsi in
un piccolo locale di Topanga, non lontano da casa propria,
restandone così impressionato da chiederle in prestito una
canzone, Easy Money per l’appunto, per il proprio disco (finì
anche in quello della Jones): un boogie blues sorretto ancora da una robusta sezione fiati, che sembrò riportare l’album,
dopo il brusco deragliamento di cui sopra, sui binari della facciata precedente. Ma ovviamente non andò così. La successiva 20 Million Things segnò un nuovo cambio di direzione,
imboccando finalmente quella strada che io avevo sperato
di trovare fin dall’inizio, e cioè quella della ballata acustica,
e all’improvviso mi ritrovai ad ascoltare la più bella slow ballad (insieme a Long Distance Love) che Lowell George avesse
mai scritto: tre minuti scarsi di struggente soul blues che scioglierebbero il sangue nelle vene di un sordo, con quel testo a
dir poco toccante, specie se riletto alla luce della successiva
morte di George, avvenuta pochi mesi dopo l’uscita del disco.
E poi ancora Find A River, firmata dall’amico Fred Tackett,
altra ballata lenta ed acustica, e altro capolavoro di misura
e di arrangiamento, che accompagna il disco verso l’ultimo,
brutale cambio di rotta di Himmler’s Ring, un brano di musica da ballo anni trenta firmato da Jimmy Webb, con fiati dixie,
contromelodie di violino, coretti femminili in stile charleston
e pernacchio di tromba sul finale.
Mai si, mi dissi, al diavolo la coerenza e l’unità stilistica: Lowell George era finalmente libero. Libero di pescare ovunque
nell’infinito calderone della musica americana, che nessuno
meglio di lui aveva saputo fondere in un blocco unico, un
blocco che ormai si stava frantumando, e che andava ricostruito da capo, partendo proprio da quel “cracked mosaic”,
come lui stesso amava definirlo, che stava alla base di ogni
sua composizione, anche la più semplice. Ci misi un po’ a ca-
pirlo, ma alla fine lo capii. E la conferma me la diedero le parole pronunciate anni dopo da Martin Kibbee, uno dei suoi
più cari amici e collaboratori: “Lowell, in Thanks I’ll Eat It
Here, si sentì per la prima volta padrone del proprio destino
artistico.”
E se oggi, a trentacinque anni di distanza da quell’iniziale giramento di palle, io dovessi portare un disco, uno solo, sulla
classica isola deserta, saprei esattamente quale scegliere.
P.S. Quasi dimenticavo: in questa bella deluxe edition, curata dalla Friday Music, c’è anche il duetto finale di Hearthaches (già presente in precedenti ristampe), cantato in coppia
con Valerie Carter, e per i più incalliti la versione mono,
pubblicata all’epoca come 45 giri, di What Do You Want The
Girl To Do.
CARLO ZAMPOLINI
OASIS
(WHAT’S THE STORY)
MORNING GLORY?
Difficile da ricordare adesso, ma quando (What’s the Story)
Morning Glory? venne pubblicato nell’autunno del 1995, gli
Oasis erano degli sfigati. Certo, il loro album di debutto, Definitely Maybe era andato dritto al numero uno in classifica in
Inghilterra ed aveva venduto molti milioni di copie in tutto il
mondo. Ma nel loro primo test successivo, gli Oasis non potevano più vantarsi di essere la più grande rock band del paese.
Roll With It, il primo estratto da Morning Glory, venne pubblicato il 14 agosto 1995 – non casualmente lo stesso giorno
di Country House, lo spavaldo nuovo singolo dei rivali Blur,
ossia lo yin della scuola d’Arte londinese contro lo yang dei
tosti di Manchester. Un anno intero dei tabloid che facevano
cecchinaggio tra i due gruppi – che toccò il suo vertice e la
fine al tempo stesso quando l’architetto degli Oasis Noel Gallagher dichiarò che Damon Albarn dei Blur e Alex James
avrebbero dovuto “prendere l’AIDS e morire” - aveva trasformato le classifiche inglesi nell’equivalente di una rissa alla
fine della scuola. E in questo caso erano gli Oasis che finirono
con il leccarsi le ferite: quella settimana Country House vendette cinquantamila copie in più di Roll With It, prendendosi
il primo posto in classifica.
Si diceva che Roll With It non piaceva a nessuno e sarebbe
stato duro inserirla nei primi venti pezzi migliori del gruppo.
Certo era un brano che ti prendeva, ma il messaggio come
un’alzata di spalle, “you gotta roll with it” (devi saper incassare) sembrava atipicamente scettico provenendo da un gruppo
che aveva sostenuto in precedenza l’auto-idolatria, l’immortalità e il trombare medici professionisti benestanti sugli elicotteri. Comunque per un gruppo mai sfiorato dall’umiltà, la
108
OUTSIDER
OLDIES BUT GOLDIES
OLDIES BUT GOLDIES
decisione di uscire con il pezzo più debole di Morning Glory
fu, in retrospettiva, la mossa più cazzuta degli Oasis: volevano
prendere il primo cazzotto nella cosiddetta ‘Battaglia del Pop
Inglese’ perché sapevano che sarebbe stata solo una questione di tempo prima di sferrare il colpo da knockout. Morning
Glory? sarebbe andato avanti vendendo più del doppio del
The Great Escape dei Blur e nei due anni successivi avrebbe
fornito la colonna sonora non ufficiale all’imminente cambio
della guardia in Inghilterra. E, in modo significativo, ottenne
una popolarità tale da mostrare fin troppo vaghi i colleghi e
competitori degli Oasis: grazie al successo americano, il disco
raggiungeva la quarta posizione nelle classifiche di Billboard,
vendendo tre milioni e mezzo solo lì. Allo stesso tempo The
Great Escape languiva nei bassifondi intorno alla posizione
numero 200. A causa del monociglio comune e di un paio di
saluti al fotografi a dito teso, gli Oasis proiettavano un’immagine brillante dell’Inghilterra sufficientemente potente da
alimentare i capricci di un Paese alla moda tra gli anglofili
nord-americani che facevano viaggi nei negozi specializzati
per fare incetta di barrette di cioccolata della Dairy Milk ma
non lo vedevano così familiare da
vendere il proprio cuore. Quel genere di cose su cui Austin Powers e le
catene di pub in stile inglese sarebbero state messe in piedi.
Arrivato casualmente alla metà
degli anni novanta rappresentando il picco di quella ondata di pop
britannico che si era radicata con
il recupero di ricordi di vecchi suoni con gli Stone Roses e The La’s
cinque anni prima, Morning Glory? è l’apogeo assoluto degli Oasis.
Se Definitely Maybe evidenziava il
prodotto rozzo del gruppo, la psichedelia anni sessanta, il glam e punk
dei settanta, il ritmo di Manchester,
Morning Glory? li scioglieva e rimodellava in un suono svettante che era senza ombra di dubbio
tutto loro, con quelle onnipresenti ma mai ostentate sezioni
di archi che rivestivano in modo classico le canzoni come le
medaglie su un trofeo. E il vero trionfo di Morning Glory?
non è misurato dai brani che da quel momento sono divenuti dei classici del karaoke, perfetti per i balli alle feste di
matrimonio inglesi e da cantare sotto la doccia, ma da quelle
canzoni eccellenti che non sono mai salite in classifica come
Hey Now (forse il miglior brano degli Oasis a non essere mai
divenuto un singolo) e Cast No Shadow dedicato all’allora
quasi sconosciuto Richard Ashcroft dei Verve un gruppo
che avrebbe presto raccolto i frutti dell’incursione americana degli Oasis. Ironicamente l’appetito per tutto ciò che
era inglese fu importante anche per l’incombente successo
delle Spice Girls che avrebbero accompagnato un’ondata
di pop indirizzato ai ragazzini che avrebbe anche spinto in
basso nelle classifiche il rock pieno di chitarre verso la fine
di quella decade. E quel che colpisce di più oggi nell’ascolta-
re Morning Glory? è come, al vertice del successo, gli Oasis
sembravano già essere elettrizzati per la loro eventuale caduta. Il tono dell’album è decisamente più oscuro e riflessivo
della fuga dalla realtà della classe lavoratrice di Definitely
Maybe, sia esso il presentimento della profezia iniziale di
Hello, “nulla sarà mai più lo stesso”, dei comunicati a strisce
bianche da dopo-party del pezzo che dà il titolo al disco, o
della delusione a lume di accendino di Champagne Supernova dove gli Oasis suonano già nostalgici per l’idealismo
del disco di debutto. E mentre Noel tratta ancora di assurde
metafore (come potrebbe fare esattamente qualcuno a camminare lentamente lungo una sala più veloce di una palla di
cannone?) riesce anche a emergere come un complemento
più sobrio e personale dell’impertinente fratello Liam.
Questa edizione maggiorata a tre dischi di Morning Glory?
che supera il disco originale con 28 pezzi in aggiunta, mostra
quanto Noel fosse in un periodo fortunato nel 1995. La saggezza tradizionale suggerisce che gli Oasis abbiano pubblicato
due dischi di perfetto rock and roll prima di un estenuante,
prolungato processo di ritorno alla normalità. Che poi non è
del tutto vero, dato che la verità è che
gli Oasis hanno prodotto almeno tre
dischi di canzoni spettacolari, solo
che uno è stato sparso su una serie di
lati B di singoli. Quattordici di questi
erano stati collezionati nella raccolta
del 1998 The Masterplan, altrimenti
noto come Hatful of Hollow, metà
dei quali è raccolto dal periodo di
Morning Glory per ri-apparire qui.
E come qualsiasi fan può raccontarvi,
questi brani naufraghi simboleggiano alcuni dei momenti migliori del
gruppo: come il bis perennemente
eseguito di Acquiesce è una perfetta
manifestazione sonora della combattuta relazione tra Liam e Noel, con i
testi del primo uniti alla musica del
secondo; Rockin Chair, insieme alle ballate cantate da Noel,
Talk Tonight e The Masterplan, evidenziano una sottigliezza
ed una sensibilità raramente sentite in modo corretto in un
disco degli Oasis. E per quelli che preferiscono assaporare la
linee melodiche semplici piuttosto che l’aggressività da concerto a Wembley, il segreto dei demo acustici di Noel inclusi
qui offre amabili esempi di semplicità della furbizia del suo
modo di comporre. Tale consistenza era senza dubbio la base
del successo iniziale degli Oasis ma, con il senno di poi, ne ha
anche causato la seguente stagnazione. Come dimostra ampiamente questo cofanetto, Noel Gallagher è un maestro artigiano, abile nel costruire brani-simbolo anche con i mezzi
più semplici. Ma non è mai stato un talento. E non importa
quanto professasse il suo desiderio di diventare grande come
i Beatles, gli Oasis non hanno mai avuto nulla a che fare con
il processo creativo dei Quattro, così come della loro onnipotenza culturale. E per un po’ gli Oasis ci avevano convinto di
poter raggiungere la seconda senza preoccuparsi troppo del
OUTSIDER
109
OLDIES BUT GOLDIES
primo: bastava scrivere un ritornello da stadio e il resto sarebbe venuto da solo.
(What’s the Story) Morning Glory? spinge gli Oasis in cima
alla montagna ma li lascia con le teste piene di neve e visioni annebbiate, mentre dei revitalizzati Blur sarebbero emersi in seguito come il gruppo più in sintonia con lo spirito di
avventura dei Beatles. Nei momenti finali di Champagne
Supernova Liam lascia il punto focale della canzone - “dove
eravate quando stavamo in vetta?” - sospeso nell’aria, come
a suggerire che i bei tempi se ne erano già andati. E, come gli
Oasis avrebbero imparato, arrivare ancora più in alto non li
riporterà indietro.
STUART BERMAN
STEVIE RAY VAUGHAN
THE COMPLETE EPIC
RECORDINGS COLLECTION
Quando vedi un cofanetto di 12 dischi con le parole “registrazioni complete” nel titolo, potresti presumere che l’uscita sia
completa ed esaustiva. Ma quando hai per le mani The Complete Epic Recordings Collection non pensare troppo presto
di poter rimpiazzare la tua collezione di Stevie Ray Vaughan in un solo colpo.
A essere onesti, alla Legacy Records sono stati abbastanza
corretti quando hanno indicato che la raccolta fosse quella
ufficiale canonica di Stevie Ray Vaughan e dei Double Trouble. Ciò significa che hanno assemblato le registrazioni di
Vaughan accompagnato dalla sua bollente sezione ritmica
di Chris “Whipper” Layton e del bassista Tommy Shannon. In seguito, il trio venne rinforzato dall’organo di Reese Wynans che aggiunse una notevole profondità al suono
del gruppo.
Le loro uscite includevano gli album di studio Texas Flood
(1983), Couldn’t Stand The Weather (1984), Soul To Soul (1985)
e In Step (1989). In aggiunta il cofanetto contiene dei concerti già pubblicati e registrati a Austin (In The Beginning from
1980), Montreux (1982 e 1985), Carnegie Hall (1984) e Live Alive del 1986 che include estratti da Montreux, Austin e Dallas.
Se siete degli appassionati di Vaughan, ci sono molte probabilità che possediate già la maggior parte del materiale, se
non proprio tutto, incluse le versioni video di alcuni concerti, in particolare le leggendarie apparizioni a Montreux. Ma
a meno che non abbiate trovato un bootleg di A Legend In
The Making – Live At The El Mocambo, registrato a Toronto,
in Canada, il 20 luglio 1983 per una radio e disponibile solo
su copie promozionali, The Complete Epic Recordings Collection sarà la vostra prima opportunità di sentire quel concerto.
In aggiunta ci sono due dischi di registrazioni di archivio che
sono sostanzialmente brani di studio scartati di alcune canzoni note, improvvisazioni strumentali, tracce gettate.
Sono questi tre dischi che garantiranno ai collezionisti di
Vaughan la necessità di comprare il cofanetto nonostante
qualsiasi doppione della loro collezione. E parlando di doppioni, a causa della quantità di concerti da vivo che fanno
parte del box, ci sono considerevoli ripetizioni. Per esempio,
Love Struck Baby, il brano iniziale di Texas Flood, compare
anche su In The Beginning con Jackie Newhouse al basso. Il trio classico, Vaughan, Shannon e Layton, la suona su A
Legend In The Making, Live At Montreux, e Carnegie Hall.
L’organo di Wynans dona una nuova dimensione al pezzo su
Live Alive dove compare anche il fratello Jimmy Vaughan.
E parlando di Jimmy, era uno degli ospiti sulla seconda metà
di Live At Carnegie Hall insieme a Dr. John alle tastiere e la
sezione di fiati Roomful of Blues. Qui, brani come Pride and
Joy ottengono un trattamento che non sentirete mai altrove.
Quindi cosa c’è che non è stato inserito ? In primo luogo se
avete una copia del cofanetto di quattro dischi del 2000, SRV,
dovrete tenervelo. Quello contiene una quantità di pezzi non
dei Double Trouble incluse apparizioni di Stevie Ray su dischi di altri, brani acustici ed una versione del 1977 di Thunderbird quando Vaughan suonava con i Cobras. Lì c’è anche
una versione interessante di Pipeline attribuita a Vaughan
e i Double Trouble che per qualche motivo non compare nel
nuovo box. In aggiunta, dato che venne pubblicato per la
Epic e fu il primo postumo nel 1990, non c’è niente da Family
Style, la prima e ultima collaborazione tra Stevie Ray e Jimmy Vaughan. È vero: i Double Trouble non c’erano in questo
disco.
È altrimenti comprensibile che album come In The Session
(1999) con Vaughan e Albert King insieme sul palco non siano presenti. Queste registrazioni erano su diverse etichette. Di
conseguenza l’interesse verso la nuova confezione dipende
da quanto amiate SRV. Per un appassionato più occasionale,
una sola buona raccolta Best Of sarebbe sufficiente. Se è così,
scegliete una che contenga sia pezzi di studio che dal vivo. In
entrambi i casi nei loro primi concerti e negli ultimi, con esecuzioni più pulite, Double Trouble erano un gruppo dinamico
e potente. Se non avete bisogno di dodici dischi. SRV potrebbe
essere la scelta giusta.
Un fastidio è la confezione stessa. La Legacy ha deciso di non
identificare ogni singolo disco con una riproduzione della
copertina originale. Per esempio, se volete scegliere In Step
e non ricordate come fosse la copertina originale, dovrete
andare a cercare nel bel libretto annesso per capire quale
disco sia. Ciononostante The Complete Epic Recordings Collection non è solo una uscita buona per gli amanti del blues
del Texas, ma un modo per i novizi per provare un pezzo significativo del catalogo di Vaughan. Per me Stevie Ray era
il fiore più raffinato della rinascita del Texas blues e nessuno
è neppur andato vicino a sostituirlo. Nella Who’s Gonna
Fill Those Shoes di Buddy Guy, Guy fa un elenco di grandi
del blues che include Son House, Robert Johnson, The
Kings, Muddy waters, Howlin’ Wolf, Willie Dixon....e
anche Sonny Boy. L’ultimo nome in elenco è Stevie Ray.
E c’è un buon motivo per farlo.
WESLEY BRITTON
110
OUTSIDER
MIXED UP
LIBRI, MUSICA, CINEMA, FUMETTI, ARTE, CAZZATE, POLEMICHE, ETC. ETC.
WINWOOD-PETTY // BLACKBERRY
SMOKE // PAUL REVERE // DEVIL
MAKES THREE // AMERICANA //
ALLMAN BROS // X // ELECTRIC
FLAG // BAND // DEVO // GARY
CLARK JR // GRAM PARSONS // RADIOHEAD // DEEP PURPLE // REM //
TRUE DETECTIVE
ABBIAMO SPONSORIZZATO IL TOUR
DI PHIL E DAVE ALVIN E PARE CHE IL
GIORNALE SIA PIACIUTO.
A FEBBRAIO LA TERZA SERIE DI QUESTO
IMPERDIBILE CULT TV. VOGLIAMO UNDERWOOD AL POSTO DI NAPOLITANO!
È MORTO IL GRANDE JACK BRUCE.
TUTTI I BASSISTI ITALIANI, E NON SOLO,
SONO CRESCIUTI NEL SUO MITO.
EMILIANO RA-B
SPIGOLATURE.8
Non fidatevi mai di chi vi dice che ha iniziato a fare musica
per amore dell’Arte o per vocazione, specialmente se è un
uomo.
Tutti hanno iniziato a suonare perché volevano fare tanto
sesso.
E in ogni caso, se davvero non fosse così, è un’altra buona
ragione per non fidarsi di loro.
E pensare che, per rilanciare la musica in Italia, basterebbe
fare una semplice operazione in stile “We Are The World” e far
cantare assieme i nostri due eroici Maró, Fabrizio Corona e la
fan in sovrappeso di Fedez.
Magari con Fedez stesso nei panni di Quincy Jones.
Mi chiedo come mai nessuno ci abbia ancora pensato.
Scusate, mi sono distratto 5 minuti, ha fatto qualcosa di bello,
nel frattempo, Fedez?
Oh, comunque Fedez è un genio: tra inno cinquestelle, X Factor, polemica col PD e ora la polemica con Gasparri e Salvini,
sta ottenendo una visibilità pazzesca.
Se fosse pure in grado di fare
musica ascoltabile, adesso sarebbe il re del pop.
Altro che Michael Jackson.
Foto Diletta Parlangeli
I complimenti sono come i
pompini: ci sono alcune persone che, quando te li fanno, ti fanno sempre sentire
i denti.
Il rap, in Italia, è in netto calo.
Ancora non si percepisce, magari, guardandola “dal di fuori” (anzi, probabilmente sembra il contrario), ma i segnali già
ci sono tutti e sono inequivocabili.
Per chi ha visto ridurre alla pagliacciata attuale la musica che
era dei Public Enemy, dei RUN DMC, degli Afrika Bambaata
(ma anche degli Snoop, degli Eminem o dei The Roots), questa
non può rappresentare che un’ottima notizia.
L’Italia è quel paese fantastico dove senti parlare di problemi “a sinistra” quando uno di destra litiga in tv con un democristiano.
Nessuno mi toglie dalla testa che, se avesse avuto giusto un
paio di kg in meno sulle tette, adesso Selvaggia Lucarelli starebbe nel centro estetico dietro casa mia a dipingere i cuoricini sulle unghie delle coatte.
OUTSIDER
111
LIVE
FLEETWOOD MAC
TD GARDEN (BOSTON, MA – 10 OTTOBRE, 2014)
- di Ken Abrams Di nuovo in tour con il ritorno di Christine McVie e la spinta del nuovo disco (pessimo) di Stevie Nicks.
I Fleetwood Mac tornano a correre.
Venerdì notte Christine McVie cantava Sweet Wonderful You, guidando i Fleetwood Mac nel primo dei due spettacoli di questo mese al TD Garden. I testi iniziali di You Make Lovin’ Fun avrebbero potuto descrivere la mutua ammirazione esistente tra
appassionati e gruppo, in particolare la McVie, che era assente dal 1998. Le vibrazioni erano buone con un genuino calore umano
che scorreva mentre il gruppo ha incantato entrando nei cuori dei 19.600 fans presenti nell’arena completamente esaurita. Con
così tanti brani da scegliere, non ce ne sono poi rimasti molti esclusi in questa notte di grande musica.
Non c’è bisogno di dire che il momento focale della serata era il ritorno della Mc Vie, il cui cantato aveva guidato molti dei singoli
di successo del gruppo degli anni settanta/ottanta.
La McVie è rimasta parzialmente in ritiro dal 1998 mentre tutti quanti erano rimasti in attesa sentendo molto la sua assenza; in
particolare la sua Sister Of The Moon, Stevie Nicks.
Senza dubbio la McVie completa questa collaborazione unica formatasi poco per volta nei primi anni settanta. Una alchimia speciale che aveva portato il gruppo a creare il disco più venduto della decade, Rumours. Durante il concerto la Mc Vie ha mostrato
che la sua voce è ancora decisamente potente all’età di 71 anni, come se fosse stata congelata nel momento in cui lasciò il gruppo
sedici anni fa.
Come una buona bottiglia di vino, questa miscela di inglesi e americani è invecchiata con grazia, dopo aver fissato lo standard
per il rock classico nei settanta e dopo aver mostrato lo spettacolo della realtà all’interno dei loro dischi, esposto davanti a tutto il
mondo. La loro saga, probabilmente ha ispirato la serie originale di VH1, Behind the Music.
I Mac sono stati probabilmente il gruppo più importante a mostrare le loro sofferenze in pubblico dall’era dei Beatles. Ma i loro
drammi hanno ispirato alcuni classici senza tempo, molti dei quali eseguiti in concerto, qua a Boston.
Se pensiamo alle stelle dei Fleetwood Mac, i nomi di Stevie Nicks e Christine McVie sono in cima alla lista, e pare ironico
che il nome del gruppo derivi da quello del batterista originale, Mick Fleetwood e da quello del bassista John McVie. Ma non
pensate che mi stia sbagliando, i due formano una delle più grandi sezioni ritmiche nella storia del rock and roll. Difatti hanno
brillato in pezzi come Tusk e World Turning, due dei favoriti del pubblico.
E poi ci sono la chitarra, il canto e la presenza di Lindsey Buckingham. La sua abilità allo strumento è nota e la sua intensità su
pezzi come Big Love e Never Going Back Again, in una versione particolarmente rallentata, ha ammaliato il pubblico.
Il concerto ha proposto una quantità di brani da Rumours del 1977, uno dei dischi più venduti di tutti i tempi. Il disco era la cronistoria dei rapporti amorosi intercorsi tra i membri del gruppo, dove sentimenti di amore, di dolore e di inganni avevano favorito
la composizione dei testi. I Mac hanno suonato quasi per intero quel disco. La McVie ha rubato la scena dall’inizio alla fine planando dolcemente con
pezzi come You Make Lovin’ Fun, Little Lies, Over
My Head. Songbird, il bis
finale che ha aizzato la
folla, era particolarmente
toccante. L’alchimia è difficile da definire, ma funziona perfettamente. Non
si tratta di una formula, e
sebbene sia ben preparata, l’interazione sul palco
pare assolutamente autentica. Scavano davvero
in profondità per ricatturare quelle emozioni di
trionfo e dispiaceri che
sembravano così ruvidi
molti anni fa. È stato un
gran concerto.
112
OUTSIDER
MIXED UP
DEAD FLOWERS
- di Giancarlo “I Feel Free”
Trombetti -
JACK BRUCE
14 MAGGIO 1943/
25 OTTOBRE 2014
Anche Jack Bruce è volato via. Quando nell’Inghilterra di fine anni sessanta, qualcuno scriveva sui muri
“Clapton is God”, dopo aver ascoltato i
Cream, non aveva colto l’essenza del
gruppo. Clapton era “solo” un bravo
chitarrista. Era Bruce a essere Dio.
Quest’anno la Grande Orchestra del
Cielo ha deciso con Jack Bruce di rinfoltire decisamente gli organici. I Cream,
pur potendo contare su un Eric Clapton
al massimo della sua creatività, erano
grandi solo, o comunque principalmente, per la presenza del bassista e
cantante scozzese.
Con lui a fianco anche Ginger Baker
crebbe come un caposcuola del suo
strumento. Nato come bassista di estrazione jazz, Bruce era divenuto uno dei
grandi del blues inglese prima di dar
vita ai Cream, alla Crema estratta da
quella scuola di blues inglese – la radice da cui tutta l’evoluzione del rock
ebbe in un modo o nell’altro origine
– in cui aveva a lungo navigato collaborando con Alexis Korner, Graham
Bond e John Mayall.
Una bestemmia dire che i Cream furono grandi per la presenza di Bruce?
Onestamente pensiamo di no. Clapton,
se fosse dipeso da lui, avrebbe portato
il trio su lidi più marcatamente e scolasticamente blues e ben poco psichedelici e senza esplorare l’universo della lunghe jam; fu dunque la presenza
della voce, delle linee soliste del basso
di Jack Bruce che aveva scelto un suono potente, metallico, a se stante, certamente non secondario ma portante
nella struttura dei brani, a fare dei
Cream l’unica vera alternativa all’altro
trio dove, al contrario, la chitarra era la
vera essenza degli Experience.
Clapton avrebbe dimostrato chiaramente in seguito i suoi reali interessi,
così come Bruce lo avrebbe surclassato
da un punto di vista compositivo e dal
desiderio mai sopito di voler continuare a percorrere in primo luogo la forza
del classico trio andando a valorizzare
e scovare negli anni una serie interminabile di chitarristi con cui continuare
a esplorare. Sicuramente se i tre Cream
furono se non gli inventori i divulgatori dei tre strumenti solisti utilizzati
con un fine unico ciò fu dovuto alla
creatività e alle composizioni di Bruce.
Chiudete gli occhi e pensate ai nomi
dei pezzi più efficaci e noti del supergruppo: I Feel Free, NSU, Sleepy Time,
We’re Going Wrong, Sunshine of Your
Love, White Room, Politician... tutti
brani scritti, anche se spesso non cantati, da Bruce. E anche se la moda di
denigrare i migliori, di trattarli con sufficienza è malattia diffusa sopra ogni
cosa tra i critici illuminati, uno dei
quali è arrivato –
in una delle sue
dotte enciclopedie sul web – a definire i Cream “la
band sbagliata al
momento giusto”,
come se si trattasse di tre musicisti
occasionali, dal
peso secondario,
i tre restano una
delle forze trainanti che hanno
dato vita alla scuola di hard rock-blues
inglese che ci ha dato soddisfazioni e
gruppi immensi, trovando anche in
America interesse e spazio per dar vita
a una scuola parallela, partendo – guarda caso – proprio da quei Mountain,
nati attorno alla figura di Felix Pappalardi , produttore dei tre e desideroso di ricostruirne le fortune in America
a fianco di Leslie West.
La sua carriera solista, iniziata nel
1969, con il bel Songs For a Taylor, ci
lascia almeno una decina di album
di buon livello con brani recuperati
e amati da moltissimi colleghi – un
brano su tutti, l’evocativo, anomalo
Theme For An Imaginary Western
– e un elenco di collaboratori eccellenti. A caso: Jon Hiseman, Dick
Heckstall-Smith, Chris Spedding,
John McLaughlin, Jim Keltner,
Steve Hunter, Clem Clempson,
Billy Cobham, Vernon Reid, Paul
Barrere, Dr. John, Gary Moore, Robin Trower, Blues Saraceno, Mick
Taylor, Carla Bley... praticamente
OUTSIDER
gran parte della storia del rock inglese.
Nel 1974 Zappa lo volle per un suo
lungo
strumentale,
Apostrophe;
quando il disco uscì in Italia, privo di
note di copertina interne, nessuno sapeva dove Bruce avesse piazzato il suo
basso. Ma fu sufficiente il primo ascolto per capirlo: il suo suono era inconfondibile, unico, irriproducibile. Un
marchio, come solo i musicisti immensi possono lasciare.
CHARTS
– di Aldo Pedron –
QUICKSILVER
MESSENGER SERVICE
HAWAII 1970
Apro una porta aperta con voi se dico
che i Quicksilver Messenger Service
sono sicuramente la band acid-rock
per eccellenza. Rock-blues acido, poderoso, trascinante e tagliente, maestri
delle jam-session e dei suoni celebrali
assai sofisticati.Generalmente sono i
più trascurati nella classica triade dei
protagonisti del rock psichedelico di
San Francisco, a vantaggio dei rivali, Grateful Dead e Jefferson Airplane.
I Quicksilver Messenger Service dal
canto loro presentano sonorità e tratti
non meno affascinanti dei due gruppi
precedenti.
Happy Trails è registrato in larga
parte al Fillmore East e al
Fillmore West, è collocato
nella classifica dei primi
200 album migliori di tutti
i tempi.
Nel 1970 dopo due anni di
prigione ritorna Dino Valenti che prende per mano
la band e diventa il loro
cantante solista firmando
parecchi brani della formazione. Se ne vanno alle
Hawaii e nel breve periodo
di permanenza sull’isola,
in studio registreranno ben
due album. Il primo è Just
for love edito dalla Capitol
records nell’agosto del 1970
113
Per i postumi infausti di un trapianto
di fegato, perdiamo l’inventore di un
modo assolutamente originale e unico
di suonare la chitarra basso, l’ispiratore di soggetti come Stanley Clarke
e Jaco Pastorius, per loro stessa ammissione.
Speriamo almeno che nel Great Gig
In The Sky prossimo gli lascino arrangiare a modo suo qualche classico del
blues. Gli Dei si divertiranno.
Ps – Al funerale di Bruce erano presenti
Eric Clapton, Ginger Baker, Pete Brown,
Phil Manzanera, Vernon Reid e Gary
Brooker. Clapton ha suonato Strawberry Fields Forever, Morning Has Broken di Cat Stevens, Theme From an
Imaginary Western di Bruce e For
Jack, un motivetto buttato giù dopo la
sua morte. Le decorazioni della cerimonia includevano anche una chitarra
basso di Bruce.
che vede il ritorno di Gary Duncan,
con Nicky Hopkins al piano, John
Cipollina ben saldo alla chitarra
solista e sonorità sofisticate con una
splendida Fresh Air e riuscite sperimentazioni come in The Hat. Nel 1971
viene pubblicato What about Me, la
svolta fondamentale e definitiva della
band ma anche una certa involuzione
sonora rispetto ad Happy Trails, inoltre presto John Cipollina abbandonerà
la band per formare i Copperhead e la
stagione dei Quicksilver finisce irrimediabilmente qui.
Nel 1970 alle Hawaii mentre registrano i loro due album (chiamati anche
‘Hawaian albums’) tengono alcuni
concerti tra cui il leggendario Crater
Festival al Diamond Head di Honolulu e questo splendido concerto rimasto
per anni abbandonato. Si tratta di Hawaii 1970 ora edito dalla Gonzo Multimedia (?!?) e registrato per l’esattezza il
13 Giugno 1970 a Red Vest Oahu, Hawaii all’Honolulu Convention Center.
La registrazione è ottima, se considera-
te che sono registrazioni ‘non ufficiali’
di oltre quarant’anni fa !
Nelle prime 1.000 copie, disponibili
come edizione limitata il CD contiene
un Bonus disc. Il disco (CD) ufficiale
contiene 10 pezzi per oltre 66 minuti:
Fresh Air,Warm red wine, Subway,
Pride of man, Baby Baby, the Hat ( formidabile), Edward (capolavoro pianistico di Nicky Hopkins e le chitarre acide come non mai), The Truth, Freeway
flyer e Mojo. Se siete fortunati potete
ritrovarvi il secondo CD (Bonus Disc)
che presenta per l’appunto delle extra
tracks con registrazioni riprese dalla
prove del gruppo, registrate il 4 Giugno
del 1970 alla Opaelua Lodge in Haleiwa, Hawaii. I brani presentati per l’occasione sono 7 per oltre 60 minuti ancora: Cobra, una Guitar Jam, Won’t kill
me, Cobra in versione acustica, Good
old rock and roll di Jesse Oris Farrow
aka Chet Powers alias Dino Valenti,
un breve assolo di batteria Drums ed
infine Just for Love.
Diciamolo chiaro e forte, ci sono tre
pezzi che valgono da solo l’acquisto:
Fresh Air, limpida pimpante, suadente, splendida, The Hat oltre 7 minuti
di assoli chitarristici davvero imbattibili con tutte le peculiarità di questa
meravigliosa band, le chitarre di Gary
Duncan e John Cipollina, la voce potentissima di Dino Valenti ed il lirismo
pianistico di Nicky Hopkins oltre ad
una sezione ritmica davvero ragguardevole come Greg Elmore alla batteria e David Freiberg (passato in Italia
proprio lo scorso mese con i Jefferson
Starship) al basso, Edward (the Mad
shirt grinder) con un Nicky Hopkins
scatenato al pianoforte che duella con
le chitarre dei due californiani. Da non
perdere!
114
OUTSIDER
MIXED UP
LIVE
- di Aldo Pedròn -
DAVE ALVIN & PHIL ALVIN
GALLARATE/VICENZA
Due concerti per un migliaio di fortunati sparsi tra Gallarate
e Vicenza. Ecco il resoconto del breve tour dei fratelli Alvin
nel nostro paese. Il primo sponsorizzato da questa rivista.
Dave e Phil Alvin (finalmente di nuovo insieme) sono realmente i veri blues brothers, i fratelli di sangue della musica
blues. Entrambi, ama con voi sfondo una porta aperta, costituivano la spina dorsale dei Blasters, seminale e micidiale
formazione rock-blues e rockabilly dal 1979 al 1986 quando
Dave Alvin ha lasciato il gruppo (con all’attivo 7 splendidi
album).
Dave è un grande chitarrista mentre il fratello maggiore, Phil
Alvin, chitarra acustica e armonica è dotato di una voce possente, singolare e magica. Insieme sono una vera bomba. Gli
artisti preferiti dei due californiani sono artisti di colore, bluesmen e rocker del calibro di T-Bone Walker, Big Joe Turner,
Lee Allen (che poi suonerà anche nei Blasters) e Big Bill Broonzy.
In queste due date italiane hanno presentato un repertorio che prendeva spunto dal
loro recente album Common ground, contenente 12 brani del bluesman Bill Bill Broonzy, da sempre uno dei loro eroi. Common
ground è un tributo a colui che già negli
anni ’30 cominciò a gettare le fondamenta
di quello che sarà il blues elettrico e dunque,
il rockabilly ed il rock and roll stesso! Common ground ha un altro pregio: ha messo
d’accordo i due fratelli terribili che non andavano per niente d’accordo sino a due anni
fa, quando Phil in tournée con i Blasters a
Valencia in Spagna (estate 2012) è praticamente morto, colpito dal Mersa virus e soltanto poi resuscitato da una dottoressa spagnola, tale Dr. Mariella Anaya Sifuentes (Phil Alvin la
chiama Marie Marie) che gli praticato una tracheotomia e lo
ha salvato per puro miracolo. Phil e Dave Alvin sono allora
ritornati assieme, amici e fratelli come non mai, trovandosi
finalmente d’accordo nella musica di Big Bill Bronzy.
Un disco travolgente anche quando le melodie sono lente, in
cui alcuni apici sono rappresentati da All by Myself, presentata in apertura in apertura di concerto, un motivo ludico ed
aggressivo. A seguire Key to the round, I feel so good, You’ve
changed, Stuff they call money, tutte riprese dall’album
Common ground poi nominano i Blasters e subito vengono
accolti da un boato. Ecco Border Radio, una scatenata Marie
Marie e So long baby, goodbye. Phil è ancora un un cantante prodigioso e la cover di Please, please, please di James
Brown è uno dei punti più alti delle due serate. Ha ricevuto
un minuto di applausi che ha quasi ermato il brano successivo e costretto Phil atentare un sorriso, mentre alzava le mani
in segno di apprezzamento. Dave Alvin dal canto suo fa sempre un passo indietro nell’ombra, ogni volta che Phil prende
il centro, permettendo a suo fratello maggiore la possibilità
di “essere la star dello show” (come el rstoha sempre dovuto
essere) ma si ritaglia anche un proprio spazio raccontando alcuni aneddoti di ciascuna canzone e regalandoci degli assolo
di chitarra struggenti con Johnny Ace is Dead e Dry River.
Non manca la bellissima Fourth of July (sempre composta
OUTSIDER
da Dave Alvin per il suo album solista See How we are del
1987, scritta per l’amico John Doe degli X, autentica rootsmusic) ed ennesima gemma del loro brillante repertorio.
Guardando il loro linguaggio del corpo era evidente di come
Phil non fosse così duttile come il fratello, quasi bloccandosi
quando scherzosamente il fratello gli ha messo un braccio
intorno alle spalle.
Vado a un sacco di concerti e devo dire che non ho assistito
a molti concerti emozionanti e memorabili come questo. In
una certa misura, la musica è quasi passata in secondo piano perchè tutti stavamo attenti all’interazione tra i fratelli.
La luce di gioia sul volto di Dave mentre guardava suo fratello maggiore cantare, ha resro il concerto ancora più emozionante.
Con i due fratelli facevano parte della formazione Lisa
115
Pankrats, una batterista di Austin che ha suonato con Billy
Joe Shaver, Marshall Crenshaw, Bill Kirchen, la Carper Family e Johnny Bush per citarne soltanto alcuni.
Il marito di Lisa Pankrats è il bassista Brad Fordham, noto
nell’ambito della musica rock e country, per citare un solo
nome, Jerry Jeff Walker. Suonando entrambi nella band con
Dave Alvin e Phil Alvin costituiscono una sezione ritmica
davvero micidiale. L’altro chitarrista è Chris Miller, originario di Portland, Oregon.
Un migliaio di persone per due grandi concerti coinvolgenti,
fantastici, davvero eccellenti. Potevano essere di più Peccato.
Divertente girare cazzeggiando con Dave per Gallarare con
una copia di Outsider in mano. Ma non eravamo i soli, visto
che sono state distribuite gratis circa 300 copie del giornale
con in copertina i Dead.
BOOTLEG
- di Andrea Hawkes -
BOOTLEGERS, ROLL YOUR TAPE... !
Ricordate la famosa frase di Springsteen? Dopo dieci giorni, un lasso di tempo incredibilmente lungo per i velocissimi ‘bootleggers nostrani’, era possibile godere del concerto della cosiddetta “Halloween Night” tenutosi dai fratelli Dave e Phil Alvin in quel
di Gallarate (Varese). Ovviamente acquistabile alla luce del sole nel solito negozio ben fornito di Gallarate ad euro 20,00 circa.
Niente di questi soldi va a finire ai musicisti. Il tutto non fa una piega, ovviamente.
C’era una volta un “agente” Polygram che aveva in carico tutti i negozi ed i centri commerciali a Nord di Milano fino alla sponda
piemontese del Lago Maggiore. Un giorno la Polygram lo buttò fuori, non si è mai saputo perchè.
Il “Tipo” non si diede per vinto e dopo poco divenne “agente” per la Edel e per la stessa area. Si vede che al “tipo” (da adesso
chiamiamolo FB) non bastava lo stipendio e si mise a frequentare qualche Fiera del disco come Vinilmania a Milano ed altre
ancora... dove esponeva prodotti Edel a metà del prezzo di vendita che normalmente si potevano vedere nei negozi e nella grande
distribuzione.
Un bel giorno ebbe problemi anche con la Edel ...
Non si diede per vinto e incrementò il lavoro delle Fiere del disco attrezzandosi in casa per produrre in proprio cd e dvd da proporre in occasione dei molteplici appuntamenti fieristici.
Iniziò a scaricare legalmente cose tipo gli ‘instant live’ dei Black Crowes, Allman Brothers Band, Gov’t Mule, Warren Haynes etc.
Lavorava tutto il giorno e spesso anche la notte per fare copie in cd di quei download di qualità ovviamente ottima. Ne faceva
pochi alla volta ed i primi risultati erano scadenti. Dopo qualche tempo c’è stato il salto di qualità con l’acquisto di nuove tecnologia e con la “scansione a tappeto” del web alla ricerca di registrazioni meritevoli. È aumentato il catalogo titoli, è migliorata
la grafica delle copertine e i dischetti sono serigrafati. Il momento buono per arrivare anche nei negozi, ed ecco che nella storia
entra a far parte Ragù....
Il personaggio però è inciampato anche in qualche rogna. Qualche tempo fa è stato “pizzicato” da Siae e GdF proprio a Vinilmania ma perchè vendeva il dvd dell’ultimo concerto di Vasco Rossi a S. Siro. Pare che di tutto il resto della mercanzia non fregasse
invece nulla ai suddetti Corpi di controllo. Vai a capire. FB si è comunque presa una denuncia (la cosa non è più solo amministrativa ma si va sul “penale” ), una bella multa e forse fra un po’ ci sarà il processo, prescrizione permettendo. Intanto il FB va avanti
a fare quel che fa e Ragù a curare lo spaccio in negozio, nel sito e nel suo catalogo che va in edicola mascherato da giornale.
Il personaggio di cui sopra, non è il solo a darsi da fare. Ci sono almeno un altro paio di tizi che però vendono dvd ed ora anche
Blue-ray. Uno è un tedesco, anche lui con un catalogo titoli impressionante ed è ormai noto in tutto l’ambiente. È lui, forse, il
progenitore di tutta la stirpe di grandi taroccari.
E così si arriva al disco dei fratelli Alvin a Gallarate. Ora un conto è fare dei bootleg ‘mascherati’ ai Rolling Stones o a Springsteen. È un illecito ma ci sta. Tutto sommato sono miliardari. Ma rubare denaro agli Alvin?!?
Piaciuta la storiella?
P.S. Ogni riferimento a persone, cose, situazioni, negozi, è puramente casuale e frutto di fantasia letteraria.
116
OUTSIDER
MIXED UP
INTERVIEW
– di Scott Interrante –
SONDRE LERCHE
Please (n. 18 di Outsider) è l’album di
Lerche più eclettico e di successo sinora. Ma ciò che tiene assieme questi 10
brani in un tutto unico sono i testi; anche se scritti ben prima dell’incisione,
parlano tutti di perdita e cuori infranti. Lerche sta andando avanti, ma i
fantasmi del passato lo seguono.
Nel corso di tredici anni e sette album
di studio, il cantante e compositore norvegese Sondre Lerche ha costruito alcune delle più interessanti canzoni pop
dei nostri tempi. Ha esplorato il jazz
influenzato dal pop alla Tin Pan Alley
con The Duper Sessions, il punk e la
new wave su Phantom Punch, il pop
abbellito con Two Way Monologue ed
una miriade di altri stili ma sempre
riuscendo a suonare come null’altro
che… Sondre Lerche. Ma sul suo ultimo album, Please, Lerche trova nuova
energia e produce un disco come non
ha mai fatto in precedenza.
“Non si tratta di un disco che fa riferimento al suono heavy e credo che
sostanzialmente il suono provenga
dalla liberazione di te stesso dagli imponenti riferimenti cui hai dedicato
così tanto del tuo tempo – dice Lerche
– Ero più interessato a fare delle coraggiose affermazioni con la mia musica
e farlo ha un peso. Il mio Mantra era:
“il coraggio è d’oro””. La spinta definitiva verso la decisione di fare qualcosa
di differente con questo disco è stata la
sua vita privata. A metà della composizione e delle registrazioni delle canzoni per il seguito al Sondre Lerche del
2011, ha divorziato. Così, mentre i testi
di Please si focalizzano su quella esperienza e sulla reazione conseguente, il
disco non è probabilmente quello che
vi sareste attesi dopo un divorzio. “Da
un punto di vista tematico e concettua-
le proviene definitivamente da quella
esperienza specifica, ma non l’ho vissuta in stile “Come hai potuto farmi
questo ?!”, non è quel genere di disco
– dice Lerche che spera invece che le
sue canzoni siano universali e aperte
all’interpretazione – Non è un disco,
spero, che si sofferma troppo su quel
genere di emozioni che fanno riferimento a quella specifica situazione”.
Più che dal lato puramente contenutistico, comunque, il disco sembra differente da tutti gli altri da un punto di
vista musicale. La canzoni sono più ritmiche, più energiche. Sono un po’ più
spigolose e arrangiate più rozzamente.
Lerche attribuisce il risultato al modo
in cui si è approcciato alla composizione: “ Avevo voglia di lavorare con
strutture musicali più semplici. Volevo provare a scrivere canzoni di quattro accordi trovare il modo di scrivere
brani con differenti schemi ritmici di
quelli su cui spesso finisci col lavorare
quando usi una chitarra, così
ho deciso di comporre pezzi
con ritmiche completamente
differenti”.
Una canzone come Crickets, il
vibrante secondo pezzo del disco, è dominato da una chitarra
acustica che martella quattro
accordi con un ritmo inusuale.
Il pezzo d’apertura e anche il
primo singolo, Bad Law, era cominciata come una traccia strumentale in attesa di melodia
e testo. “Ho passato un anno
a cercare di tirarne fuori una
canzone, dato che non sapevo
se fosse veramente una canzo-
ne fino all’ultimo minuto in studio. Poi
ho capito, cazzo...è una canzone. Questo ti succede quando scambi la sequenza. Invece di iniziare con pezzi più duri,
inizi con un ritmo emozionante”.
Quel che sembra, in realtà, è l’effetto di
un concerto di Sondre Lerche. Questo
approccio più duro, più confusionario
potrebbe essere inatteso se avevate
ascoltato solo i dischi di Lerche, ma in
concerto lui pervade le sue canzoni di
una energia frenetica. Pigia sul distorsore più spesso e fa del vero rock, sostituendo la produzione raffinata dello
studio con una energia rozza che dona
nuova vita alle canzoni. E questo è il
modo in cui suonano molti dei pezzi di
Please. Possiedono lo stile compositivo
intelligente di Lerche, ma sono suonate con una energia fuori dagli schemi.
Una energia tenuta sotto controllo in
Lucky Guy, il nucleo emozionale del
disco dove Lerche canta di come siano
stati fortunati lui e l’ex-moglie a prova-
OUTSIDER
re l’amore quando ne avevano.
C’è un sottile sarcasmo cjhe scorre attraverso la maggior parte dei testi di
Please donando al disco molto del suo
fascino.
Il brano finale del disco, Logging Off,
pare riassumere tutto questo, nonostante sia stato scritto prima che avvenisse il divorzio. “Descrive i diversi
modi in cui l’uno si cerca con l’altro, in
particolare nei nostri giorni e ai tempi
dei social media e di tutti i differenti
modi in cui siamo connessi l’uno con
l’altro ma dove ancora riusciamo a fallire il più delle volte. Era una sorta di
canzone astratta riguardo a tutto questo, ma tutto d’un tratto non è più sembrata così astratta. Quando la cantavo
pensavo: “Cazzo, sapevo più di quel
che osavo pensare riguardo a quel che
stava succedendo””.
Tre minuti dopo la canzone termina e
sfuma nel silenzio. Salvo poi tornare
indietro con un espressivo e squilibrato assolo di sax di Kjetil Moster.
Nonostante sia stato inciso nel corso di
117
due anni e mezzo, in due diversi paesi,
in sei studi, con tre produttori, quattro
ingegneri del suono ed una miscela poliedrica di collaboratori, Please sembra
la sua più logica dichiarazione artistica
di sempre. Riesce a catturare la reazione emozionale sfumata ed umana alla
sua crisi personale regalandogli vita
con una musica colorata e energica.
Prova che anche dopo dieci anni di
carriera puoi ancora essere all’avanguardia come artista, come persona, e
far funzionare il tutto perfettamente.
EAGLES LA LEGGENDA DEL
COUNTRY-ROCK
SERGIO D’ALESIO
BOOKS
- di Aldo Pedròn -
HOTEL CALIFORNIA
MAURO RONCONI
Questo libro è un doveroso e prezioso vademecum per spiegare ed analizzare la cosiddetta musica della West coast, soprattutto quela degli anni ’60 e ’70. L’autore scrive in modo
attento, raccontando fatti, dettagli, aneddoti e storie di ogni
singolo disco preso in considerazione. La California resta da
sempre la terra promessa e musicalmente parlando è e resta
il non plus ultra. Musica californiana significa raffinate melodie, alta qualità compositiva, suono scintillante e avvolgente, continua ricerca di armonizzazioni oltre ad una metodica
ricercatezza degli arrangiamenti
e delle linee melodiche. Il lettore più attento si accorgerà della
mancanza di alcuni mostri sacri
squisitamente californiani come
Grateful Dead, QMS e Jefferson
Airplane, ma l’intento è di soffermarsi sugli artisti più squisitamente soft-rock o pop. Ecco
così gli Eagles, Jackson Browne,
America, Joni Mitchell, James
Taylor e Carly Simon, Steely
Dan, Byrds, Carole King, Flying
Burrito Brothers, Monkees, Mamas and Papas, Neil Young, Fleetwood Mac, Kenny Loggins ma
anche Burt Bacharach.
Un libro ben scritto, ben fatto e
piacevole da leggere.
A 32 anni di distanza dall’uscita del libro “L’epopea Del
Country-Rock”, edito nel lontano 1982 dalla Lato Side Editori , torna il libreria uno dei giornalisti da sempre votato
a questo genere musicale. Edito da Aereostella sviluppa in
160 pagine una sorta di compendio narrativo di 50 anni di
musica californiana (1964-2014) osservato a volo d’aquila attraverso le cronache evocative, i versi delle canzoni tradotte
in italiano e le dichiarazioni degli Eagles. In coda c’è una ricca appendice dedicata alla carriera solista e alle esperienze
personali di Henley, Frey, Leadon, Meisner, Felder, Walsh
e Schmit al di fuori del gruppo. In parallelo si scrive anche
dei Byrds, Dylan, Joni Mitchell, Gene Clark, Roger McGuinn,
Crosby-Stills-Nash & Young, Fleetwood Mac, America, Linda Ronstadt, Buffalo Springfield, Dillark & Clark Expedition,
Poco, Loggins & Messina, Flying Burrito Bros, Manassas,
Souther-Hillman & Furay, Jim Croce, Jesse Colin Young,
Gram Parsons, Nitty Gritty Dirt Band…
SURFPLAY
FRANCESCO FIORENTINO E
TOMMASO LAVIZZARI
Le massime di questo libro sono: Il migliore
è quello che si diverte di più oppure il Surf, è
un’attrazione destinata a ripetersi nella storia, a proseguire il suo cammino attraverso le
onde, attraverso la letteratura, le arti e la vita…
Aggiungo io …i l surf (da non confondersi mai
e poi mai con il windsurf mi raccomando!) è
una ragione di vita, è uno stile di vita, un credo… e questo è senz’altro un libro sulla cresta
dell’onda! Uno sport dalle radici antiche che
ha influenzato intere generazioni, sempre in
attesa dell’onda perfetta. Un saggio sulla musica e sulla cultura surf. Nel libro vengono
ampiamente ripercorse le tappe dello sport del
surf, la grafica, il cinema, l’abbigliamento.
118
OUTSIDER
MIXED UP
LIVE
- di Daniele Benvenuti -
JIMMY BUFFETT
PARIGI, LA CIGALE,
26&27-09-2014
Un sorriso a 360° dipinto sul volto. Perenne e quasi da fesso. Due ore in compagnia di Jimmy Buffett ti costringono a girovagare con l’espressione di
uno che ha appena vinto al SuperEnalotto senza neppure aver giocato.
Partiamo dal contorno: un concerto
del quasi 68enne orgoglio di Pascagoula, raccoglie talmente tanta sana
allegria e sincera autoironia da parte
del pubblico da far impallidire qualsiasi altro music show. Continuiamo
dal contesto: il teatro ‘La Cigale’ di Parigi (ai piedi del Sacro Cuore e baciato
dalla corrente dei turisti più prevedibili) è un gioiellino di arte barocca
tendente al kitsch con i suoi arredi in
legno intarsiato e le poltrone in velluto rosso con una capienza dai 950
tickets con posti numerati in platea,
fino ai 1.400 con accesso free al pseudo
pit. E chiudiamo giungendo al secco
‘uno-due’ transalpino al cospetto di
James William Buffett, perfettamente
assecondato dalla spassosa Coral Reefer Band. Il gustoso menù, a scanso di
equivoci, è il solito: una travolgente
miscela di west coast cantautorale
tra ‘brother’ Jackson e Warren Zevon
buonanima, country honky tonk, surf,
brezza caraibica, calypso, persino reggae e uno jazz-swing degno di New
Orleans. Un’ondata sonora perfettamente assecondata dal look della variopinta audience dove i rari camicioni alla Fogerty & Young sono strabattuti da coloratissime camicie hawaiane, collane floreali in stile Honolulu,
corone degne di Samoa, noci di cocco,
pinne da squalo, cocktail e birra au go
go, bandane da pirata, ninnoli da Mardi Gras, assurdi copricapo con frutta
esotica e, ovviamente, pink flamingo
e pappagalli di pelouches (divisa ufficiosa dei fedelissimi ‘parrotheads’).
Parecchi i bermuda e anche qualche
ciabatta Maui style. Una doppietta
sotto la torre Eiffel riservata a pochi e
tempestivi motivati, quasi tutti di lingua madre anglofona. Alle 19.36 le
luci si spengono,
intro fuori scena
(Lovely cruis’,
off course…) e
dalle quinte sgattaiolano fuori i
dieci
musicisti
che occupano il
congestionato
palchetto; buon
ultimo, il poliedrico songwriter,
attore, produttore, talent scout,
albergatore
e
persino pilota di
idrovolanti. L’inizio è un incalzante
omaggio
cochraniano con
una
Summertime blues che
presenta Buffett
come il ‘re dei
surfisti’ attempati: polsini arancio a entrambi
gli avambracci,
bermuda gialli, tshirt color Milka,
candida stempiatura da far im-
pallidire il capitano Merrill Stubing e
piedi rigorosamente scalzi dietro un
monitor per i testi francofoni sui quali
si rivelerà piuttosto generoso.
OUTSIDER
Si nota subito che è fresco ed entusiasta, nonostante i 1.396 concerti sul
groppone in 483 diverse località del
globo (solo otto dei quali in due siti
d’Europa). Changes in latitudes offre campo libero ai classiconi e alla
conta delle diverse nazionalità in sala,
mentre palloni da spiaggia che ricordano la Coppertone galleggiano stabilmente nell’aria. My head hurts...
non tradisce come pedana di lancio,
mentre Brown eyed girl è il tradizionale richiamo a Van Morrison, alter
ego al negativo del padrone di casa.
Il suono della marimba esce direttamente dalle tastiere per l’inconfondibile ‘summer time music’ di Son of a
son of a sailor in salsa soul & hula,
mentre le ‘sailing songs’ proseguono
con Grapefruit - Juicy fruit, swing
da onda anomala con il pubblico sempre in piedi in regime di educata correttezza. I will play for Gumbo è il
solito honky tonk sabbioso ad alto tasso salino e gonfio di Pina Colada, mentre la tromba di John Lovell vale una
sezione fiati intera. Torna in scaletta
l’atipico funky lounge hip hop, Autour du rocher, degna introduzione
per Last mango in Paris. I siparietti
con il tastierista Michael Utley, veterano che sta a Jimmy come Paul Shaffer a Dave Letterman, condiscono sonorità affini a quelle di una Band emigrata a Key West insieme a Nicolette
Larson (la deliziosa Come monday).
Brani brevi e senza troppi virtuosismi
strumentali, finché il reggae caraibico
di Volcano conduce al set acustico
con il dobro di Mac McAnally che,
nonostante Little Martha in onore
dell’ABB, spezza l’incantesimo. Finché ‘He went to Paris’, pronta per
evolversi in un reggae alla papaya,
riporta tutti on stage per Cheeseburger in paradise, ovvia esplosione
del cratere parigino in una quadriglia
collettiva. One particolar harbour
(quella dall’attacco che ricorda ‘Lola’
dei Kinks…) lancia il primo medley,
oculata fusione tra Free & Into the
mystic (citazione per Zac Brown compresa…) che rilancia il broncio di Van
‘The Man’.
Ancora una parentesi da chansonnier
indeciso tra swing e be bop (Symphatique), poi l’attacco di Southern
cross targata CS&N con cantato alla
Doobie Bros. A pirate looks at forty
è il solito lentaccio strappamutande
da taverna portuale, in attesa della
straripante Fins introdotta da finte
urla di terrore e suspance acquatica.
Jimmy avvia la sua personale L’inno
incontrastato, Margaritaville, nonostante i suoi piccoli riti non ‘spacca’
del tutto. Forse perché davvero troppo
attesa, anche se il classicissimo “Searching for my lost shaker of salt – salt
– salt” crea una gioiosa e unica interazione. Finto saluto, tre giri di lancette
e nuovamente sul palco per una Sea
cruise (“Whoo-ee, whoo-ee baby,
whoo-ee - Won’t you let me take you
on a sea cruise?”) profumata di sbronze d’amore, in attesa di un epilogo affidato a It’s five o’clock somewhere
(ballatona c&w) con la divertente Wy
don’t we get drunk a ricordare le avventure di Tony Curtis con le indigene
di ‘Operazione sottoveste’.
2h10’ e 24 brani la prima sera; 2h06’
la seconda con scaletta parzialmente
modificata e ben 29 tacche: in termini di energia e omogeneità meglio
lo show inaugurale (più adatto per
un’introduzione graduale al culto…),
benché quello successivo abbia premiato le esigenze di completisti e
clienti abituali.
Da segnalare nel bis del secondo giorno Margaritavill in versione quasi
tex mex (con richiamo aggiuntivo a
Boat drinks) Scarlet begonias e il
saluto al vecchio pard Jesse Winchester (Another saturday night), tratto dal repertorio di Sam Cooke.
119
DEAD FLOWERS
- di Max Stèfani -
BOBBY KEYS
18 DICEMBRE 1943 /
2 DICEMBRE 2014
Ci ha lasciato un altro compagno di
sbronze e di eccessi di Keith Richards.
Presenza fondamentale nei Rolling
Stones.
Cirrosi epatica. Era prevedibile visto l’amore che ha sempre legato Bobby alla
bottiglia di Jack Daniels. Anzi, c’è da
stupirsi che abbia durato così tanto. Chi
segue gli Stones sa che Bobby Keys è
stato la sponda americana per arrivare
a quei suoni sporchi e caldi che hanno
le loro origini nel blues e non c’è di più
normale che sia stato un bianco texano, cresciuto alla corte di Buddy Holly
(nel 1958, appena quindicenne aveva
suonato in tour con Boby Vee e Holly)
a renderlo possibile. I Muscle Shoals
insegnano d’altronde. Si era unito agli
Stones da subito, durante il loro primo
tour americano, ma aveva debuttato in
un loro disco solo cinque anni più tardi, mettendo il suo sax in Let It Bleed
e è poi è da sempre rimasto vicino a
loro, segnando con il suo sax canzoni
come Brown Sugar, Happy, Can You
Hear Me Knocking e alcuni dei
momenti più belli di Exile e di
Sticky Fingers. Il suo sax aveva
servito anche Dion DiMucci,
Eric Clapton, Who, Joe Cocker,
George Harrison, John Lennon
(è suo il ‘solo’ in Whatever Gets
You Thru the Night, unico n.1
di John), Lynyrd Skynyrd, Ringo
Starr, Ron Wood, altro compagno di bisbocce.
Aveva suonato con gli Stones
nel 2013 nel loro debutto al Glastonbury Festival, il 29 giugno.
Riposi in pace, con vicino una
bottiglia dell’amato e traditore
Jack Daniels.
120
OUTSIDER
MIXED UP
INTERVIEW
- Ultimate Classic Rock -
JAIMOE
È stato un anno ricco di eventi per la
Allman Brothers Band, da quando a
gennaio 2014 hanno annunciato che i
chitarristi Warren Haynes e Derek
Trucks lasceranno il gruppo a dicembre, anche se c’è un barlume di speranza che la band possa portare avanti le
cose sotto qualche forma.
Le attività di quest’anno, che segna il
45° anniversario del gruppo, si sono
di colpo trasformate in qualcosa che è
sembrato essere un giro trionfale d’addio. Vedi la partecipazione alla “10°
Mountain Jam” annuale, dove gli Allman hanno eseguito integralmente
il loro album omonimo di debutto del
1969 e il suo seguito del 1970, Idlewild
South.
Ciò che rende speciale tutto questo è
stato il fatto che abbiano eseguito questi due album in sequenza solo un pugno di volte, nel corso degli anni.
“In quarantacinque anni l’abbiamo
fatto forse tre o quattro volte. Sono
sempre stati quei due album assieme,
oppure un altro, come Eat A Peach o
Brothers and Sisters”.
Gli piace l’idea di fare un album intero.
“La gente pensa che sia una figata, e
rende facile capire cosa ci sia in scaletta! [Ride] Ecco perché mi piace”.
Il batterista veterano vede svariate possibilità per il futuro, inclusa l’occasione
di spendere più tempo a concentrarsi sulla sua band, la Jaimoe’s Jasssz
Band. Si è aperto ad alcune riflessioni
su quell’argomento, così come a qualche ulteriore storia sugli Allman Brothers.
Sembra che ciascun album degli
Allman Brothers abbia una qualche storia circa la propria nascita.
Per il primo album, di chi è stata l’i-
dea di far posare nuda l’intera band
per la foto che decorava il lato interno della copertina?
Quando stavo a Muscle Shoals, sostanzialmente eravamo Duane e io. Berry
[Oakley] arrivava a metà settimana,
quando non era davvero troppo occupato. Perché era nei Second Coming,
che includevano anche Dickey [Betts],
e anche sua moglie, Dale [faceva parte
della formazione]. Un giorno eravamo
in studio e ho chiesto a Duane, ho detto: “Hey amico, hai detto di voler avere
due batteristi — perché vuoi avere due
batteristi?”. Lui ha detto: “Perché James Brown e Otis Redding hanno
due batteristi”. Non gli ho mai più chiesto niente in proposito! [Ride]
Non ho idea di chi sia stato a farsi venire in mente quella [foto]. Eravamo fuori, in un posticino dove Otis Redding
aveva il suo ranch, e le proprietà di
Otis e di Alan Walden, il fratello di Phil
Walden, erano confinanti. Scattavamo quelle foto nella proprietà di Alan.
Quel torrentello che scorreva
lì, non ho idea di come diavolo
ci siamo finiti dentro, ma posso
dirti chi ha scattato la foto. Phil
Walden era lì, con questo tizio,
Stephen Paley, un fotografo di
New York.
Non ricordo chi altri ci fosse, ma
ci stavamo dannatamente divertendo, perché qualcuno ha
detto “Toglietevi i vestiti ed entrate tutti nel torrente.. Merda...
lo sa il Signore: è esattamente
come dire a un poliziotto di farsi una
ciambella. Eravamo tutti vestiti e nessuno si era imbarazzato. Siamo finiti
tutti nel fottuto ruscello!
Per te, come batterista, cominciare
a suonare in una formazione a due
batteristi ha richiesto un adattamento?
No, perché avevo suonato nella banda della scuola e c’erano un sacco di
batteristi. È questo ciò che non capisco
di parecchi batteristi. A scuola suonano nella banda, e se hanno suonato in
un’orchestra sinfonica allora dovrebbero capirne di cassa, di rullante, di cembali — le percussioni, perché sostanzialmente è un set da batteria: è questo che
è, un set da batteria. Hanno un qualche
problema, e dicono di non poter suonare con un altro batterista.
Per me è come nel baseball — tutti
vogliono essere il dannato lanciatore!
Non so perché — io non ho mai voluto fare il lanciatore! Ho sempre voluto
OUTSIDER
giocare in prima base o a centro campo!
Billy Cobham un giorno ha sentito
Butch [Trucks] e me suonare assieme.
Ha detto che stava seduto lì, ascoltando, e ha detto: “Amico, quel batterista
sta facendo roba interessante.” Ha detto
che non ce la faceva più, quindi è sceso
a vedere chi fosse il batterista, e ha detto che erano due batteristi. Ha detto che
non poteva crederci. Ha detto che non
avrebbe mai potuto suonare con due
batteristi.
Negli ultimi anni la scena dei festival è diventata una roba grossa
per le band, al punto che potresti
costruire gran parte di un tour sulle partecipazioni a festival come
questo. Suoni di fronte a un grosso
pubblico e, per via della natura di
questo evento, raggiungi costantemente nuovi fan. Deve essere una
bella figata, passare 45 anni così.
È quasi come fare l’insegnante. La gente me lo chiede: insegni? Non insegno.
Se hai un problema, posso aiutarti a risolverlo, ma non sono un insegnante.
Mia moglie è un’insegnante, ed è anche dannatamente brava. Una persona
come me può arrivare alla gente che ha
quantomeno un’idea di quello che sto
facendo, e forse qualche musicista, probabilmente di un’età che vada dai 15
ai 40 o 50 anni. Ma un insegnante può
arrivare a persone che abbiano dagli 8
agli 80 anni, e sanno come farlo.
Come va con la tua band? Hai fatto
uscire l’album Renaissance Man
nel 2011. Sta filtrando nuova musica, su quel fronte?
Abbiamo in progetto un album. Circa
quattro o cinque mesi dopo la pubblicazione del primo album, ero pronto a
farne un altro. Ma ha molto a che fare
col materiale, e voglio che nella band
componga anche altra gente oltre a Junior Mack.
Sembra avere l’abilità di mostrare diversi [lati di sé] e penso [che lo faccia] molto
bene. Non ne so altro, ma ha parecchio
a che fare col fatto che davvero non voglio che le cose suonino simili. Voglio
dire: devono avere un sapore, ma ogni
persona ha la propria personalità, e così
ogni canzone ha la propria personalità.
Vale anche per Stevie Wonder: ascolto alcuni suoi album, a volte — non
tanto come un tempo, ma li ascolto,
cominciano a sembrare una sinfonia
quando semplicemente li metti su e li
fai partire. Schiaccia play e dimenticati
di tutto — cominciano a suonare come
una sinfonia. Puoi sentire delle piccole
sfumature che sono state influenzate
da questo, quello o quell’altro ancora.
La composizione di Dickey Betts
funziona in modo molto simile. Credo
davvero che da parte di Dickey questo
avvenga perché compone per lo più
da solo. Sai, compone assieme ad altra
gente, ma quando lo fa c’è un eccesso
di influenze…. non nella cottura della
torta, ma nel metterci la glassa. Quando
non c’è qualcuno che metta quel tipo di
robe sulle canzoni che stai incidendo o
che stai componendo, questo limita il
livello cui le puoi portare. Hai soltanto
quattro o cinque personalità con cui lavorare.
Hai i doppi shuffle, hai del funk, hai
della roba tipo Stormy Monday, quindi
forse hai quattro o cinque piccole personalità con cui lavorare. La differenza
arriva quando hai qualcuno che faccia
gli arrangiamenti: sono loro a mettere
tutta la glassa e le altre cose sulla canzone. Perché Ray Charles, davvero,
era come Disney — faceva muovere i
personaggi. Ho ascoltato la sua musica per un sacco di tempo, e sostanzialmente fa muovere i personaggi: questo
nei termini di arrangiamento e di quello che usa, usa molto il mambo, un sacco di roba di sapore ecclesiale e questo
succede quando è lui a fare buona parte del lavoro per le sue composizioni,
ed è sostanzialmente la stessa cosa che
fa Disney.
Ho letto una tua frase a proposito
di questa band che amo, a proposito del perché tu abbia fatto questa
band al di fuori degli Allman Brothers, e hai detto: “Posso fare musica, nessuno può licenziarmi, ho i
fiati e un solo batterista”. Quando
la metti così, non c’è ragione perché
tu non faccia quello che stai facendo con la tua band.
La mia band, sostanzialmente ho provato a costruirla sulle stesse cose che
faccio da quarantacinque anni. Voglio
dire, c’è un sacco di roba che è nata
nell’Allman Brothers Band. Un sacco di roba, in senso musicale.
10 SONGS
JACKSON BROWNE
BEFORE THE DELUGE
––––
YOU LOVE THE THUNDER
––––
HERE COME THOSE
TEARS AGAIN
––––
DOCTOR MY EYES
––––
LATE FOR THE SKY
––––
THESE DAYS
––––
THE PRETENDER
––––
SOMEBODY’S BABY
––––
THE LOAD-OUT’/’STAY
––––
RUNNING ON EMPTY’
121
122
OUTSIDER
MIXED UP
#@&*
?
SHORT TALKS
– perle di saggezza
dal mio facebook (M.S.) –
Al primo giorno di naja mi assegnarono
al plotone di un caporale che ascoltava
in continuazione Wind of change degli
Scorpions. Capii di essere nella merda
fino al collo (Gianni Orlando)
Il 99.99 del tempo di ascolto lo dedico
alla musica di cui si parla sulle testate
internazionali in inglese e trovo sempre cose meravigliose. Poi ogni tanto mi
capita di ascoltare qualcosa di cui si parla in Italia e mi sembra di essere capitato in un continuum spazio temporale
dove tutto è andato nella maniera più
sbagliata possibile (Umberto Palazzo)
Gigi D’Alessio in diretta a Capodanno
su Canale 5. Ecco, se avessi avuto dubbi
sullo stare lontano dall’Italia per il 31
dicembre, adesso ne ho certezza. Londra, Amsterdam, la Norvegia, Stretto di
Bering, il Passaggio a Nord-Ovest sono
abbastanza lontani?
(Giancarlo Trombetti)
Ieri sera ho visto ragazzine e ragazzini
in delirio, qualcuna pure con le lacrime
agli occhi, per 50 Special di Cremonini.
Abbiamo perso (Silvano Martini)
La mia compagna.. che è anche mia
moglie mi chiede “Ma non sei curioso
di vedere almeno una puntata di X-Factor che non hai mai visto?”.. ed io “Lo so
come va a finire.. inizi con X-Factor e
poi ti trovi a seguire Amici della De Filippi.. un po’ come iniziare con la cocaina e poi ritrovarti ad iniettarti l’eroina..
Guardiamoci un film”…
(Massimo Bonelli)
Chiudono i teatri x farci i ristoranti della
minchia e riaprono i tendoni di merda
x farci i concerti ottimo complimenti
Milano, grazie, prego (Paolo Vites)
Come cominciare bene la giornata. Entri nell’ascensore dell’albergo e con te
salgono 3 ragazze arabe. Ognuna si é
versata addosso mezza boccetta di profumo. 3 profumi diversi, naturalmente.
Sono uscito dall’ascensore barcollando
(Stefano Dainese)
La melodia dell’ultimo singolo degli U2
ricorda Crying at the Discoteque degli
Alcazar, che era a sua volta una cover
di Spacer di Shaila, si può finire più in
basso di così? (Jacopo Gobber)
I 1O DISCHI
PIU ASCOLTATI DI
Max Stèfani
VARIOUS
TRUE DETECTIVE SOUNDTRACK
Non c’è niente di male nel fatto che alla
gente piacciano le cose leggere e divertenti. Il problema è che oramai scatta il
rifiuto automatico nei confronti di tutto
ciò che abbia un minimo di spessore e
serietà. C’è poco da fare: questa generazione d’italiani è venuta su così
(Umberto Palazzo)
STEPH CAMERON
SAD-EYED LONESOME LADY
Mollica al TG che parla di Woodstok
equivale all’andare a una conferenza il
cui tema è lo scambio di coppie tenuta
da Formigoni (Marco Meraviglia)
TORRES
HONERY
Arrivato alla fine della vita, qualcuno si
volterà indietro e tutto quello che vedrà
sarà una targa vinta al MEI (Pj Cantù)
Spegni i telegiornali, chiudi i news
blogs, diserta le tribune politiche e
guardati in loop ‘Utopia’, ‘Black Mirror’,
‘House of Cards’, ‘True Detective’ etc.
Quantomeno ci guadagnerai in plot
narrativo, editing e fotografia
(Giuseppe Righini)
Quindi l’unico primato che abbiamo al
momento come paese Italia è quello di
essere l’unico paese al mondo dove gli
U2 e Morrissey vanno in televisione
(Marco Cestoni)
Quindi, se ho ben capito, per omaggiare Rick Wright, i due hanno tirato fuori
dagli scatoloni, gli scarti di The Division Bell. Che è un po’ come il tirchio
che per risparmiare sul funerale della
consorte, gli compra una bara di seconda mano (Marco Meraviglia)
Dopo “La Divina Commedia”, “La Costituzione”, adesso Roberto Benigni si
cimenta con “I Dieci Comandamenti”.
Già pronti “Il Contratto dei metalmeccanici” e “I Pensionamenti Anticipati
INPS” (Giancarlo Trombetti)
ANGEL OLSEN
BURN YOUR FIRE FOR
NO WITNESS
NICOLE ATKINS
SLOW PHASER
LAURA CANTRELL
NO WAY THERE FROM HERE
LAURA MARLING
ONCE I WAS AN EAGLE
HURRAY FOR THE RIFF RAFF
SMALL TOWN HEROES
BAND/DYLAN
BASEMENT TAPES
DAMIEN RICE
MY FAVOURITE FADED FANTASY
Giancarlo Trombetti
COLOSSEUM
TIME IS ON OUR SIDE
DAVID CROSBY
LIVE AT THE MATRIX
DECEMBER 1970
CUBY + THE BLIZZARDS
LIVE
PLANET EARTH ROCK
& ROLL ORCHESTRA
PERRO
DAVID BOWIE
ALADDIN SANE 40TH
ANNIVERSARY ED
NUCLEUS
SOLAR PLEXUS SOFT MACHINE
SIXTH
PHISH
LIVE IN BROOKLYN
VARIOUS
BLUES TRIBUTE TO CCR
JACK BRUCE
SONGS FOR A TAYLOR
OUTSIDER
BOOKS
- di Max Stèfani -
LIVE DEAD
THE GRATEFUL
DEAD
PHOTOGRAPHED BY
BOB MINKIN
Siete dei Deadheads? Avrete anelano
di aver fatto parte della scena intorno
alla Grateful Dead, ma siete nati troppo tardi nel paese sbagliato, o apprezzate comunque la grande fotografia?
Beh, questo libro è per voi. È assolutamente splendido.
Non c’è da sorprendersi: Bob Minkin è
un superbo fotografo. Ha messo la sua
impronta sulla musica fotografata. Venendo una generazione dopo la prima
ondata di leggendari fotografi di musica dal vivo (Jim Marshall, Wolman,
Russell, Tarle, Liebovitz etc) - Minkin
aveva tutto sommato poco spazio
dove posizionarsi, e lui non ha perso
un centimetro. E ‘stato lì vicino a tutto
quello che succedeva, dalla fine degli
anni settanta.
Il libro che raccoglie le sue foto della sua materia preferita è un lucido,
squisito rettangolo con copertina rigida. Si inizia con i ricordi scritti da alcuni membri della famiglia dei Dead
vecchia scuola: il tastierista Tom Constanten, Steve Parish, Blair Jackson e il
commento di Bob Weir , Mickey Hart,
Donna Gotchauux, Wavy Gravy, Roccia Scully, Carolyn “Mountain girl”
Garcia, Trixie Garcia, ed Perlstein, e
altro ancora..
Ma, la cosa bella sono le foto. Una
tabella di marcia visiva dei Grateful
Dead e dei loro progetti paralleli, a
partire dal 1977 fino oggi.
C’è anche una foto del 1975, quando
Minkin era un adolescente, presa nel
loro tour orientale nel tardo autunno
del 1975 di quella che io considero
l’unico vero edizione del Garcia Band,
ovvero Jerry Garcia-Nicky HopkinsJohn Kahn-Ron Tutt.
Oltre alle immagini di performance, il
libro mette in mostra scatti intimi del
backstage, foto di scena per tour, come
ad esempio Red Rocks, Winterland,
Radio City, Capitol Theatre, Europa
‘81, e molti altri. Gli anni Dead postGrateful sono rappresentati anche attraverso le immagini di Furthur, Phil
Lesh & Friends, Ratdog, e il rinascimento musicale ora accadendo in Marin County, in California, a Terrapin
Crossroads, Sweetwater Music Hall, e
di Bob Weir TRI Studios.
123
Guardando la cronologia amorevole
di ‘Live Dead’, mi sento un po’ come
un fantasma, che mi aggiro intorno ai
margini della loro storia. E ‘come sbattere contro un vecchio amico che non
avete visto per 30 anni, pensando che
hanno un aspetto diverso, ma in qualche modo lo stesso. È una sensazione
strana.
Per coloro che sono rimasti in questa
particolare strada, ‘Live Dead’ è un bel
viaggiare. Bob Minkin fissa i Grateful
Dead sulla macchina fotografica in un
modo che pochi della sua generazione
hanno saputo fare. 35 euro su Amazon
hard-cover.
124
OUTSIDER
MIXED UP
A MASTERPIECE
– di Well Respected Man –
SOFT MACHINE
THIRD
Recentemente mi sono appassionato molto a questi ragazzi,
ascoltando costantemente questo disco diventandone sempre più colpito ogni volta che lo ascoltavo. Mi sono abituato allo stile di pezzi di venti minuti con diverse sezioni che
si mescolano l’una all’altra. Vedo le potenzialità che crea
nello sviluppare una storia immaginaria o un “mondo” se
volete chiamarlo in quel modo. Third crea distintamente
un’atmosfera fantastica. Si spazia dagli strippati collage sonori a follie jazz. La strumentazione stessa è eccitante; non
posso che essere coinvolto dalle grandi tonalità che i Soft
Machine sono in grado di tirar fuori dai loro strumenti.
I Soft Machine sono stati fondati nel 1966 da studenti
universitari che avevano abbandonato gli studi, Robert
Wyatt e Kevin Ayers, con una formazione in perenne
cambiamento, come un progetto musicale jazz/psichedelico. Potrebbero essere indicati come uno dei gruppi principali nella scena rock ‘progressiva’e’ inglese che include
gruppi come i Caravan, Gong e Matching Mole. Il loro
primo disco pubblicato è del 1968, intitolato Volume One
e seguito nel 1969 da Volume Two, continuando, ovviamente con Third nel 1970. In seguito hanno continuato a
suonare jazz per anni in molti altri album dopo Third. Suggerisco altamente di utilizzare le cuffie ascoltando Third
perché so per esperienza che è difficile sentire le melodie
delicate e le punteggiature mentre le automobili vi schizzano sotto casa ogni dieci secondi. Dopo tutto si tratta di
occupare il proprio tempo libero, no?
Third inizia con Facelift con tonalità molto dolci e basse ed
una leggera combustione sonora come di un organo che
suona ritmi casuali su note occasionali. I toni ritagliati che
seguono danno un
grande esempio di
cosa ci si possa attendere dal resto del
disco. Non lasciate
che il sogno, inteso come stato delle
cose, vi spenga, anche se probabilmente vi crescerà dentro
come è accaduto a
me. Nel complesso
dà vita a una speciale tensione in attesa
che la canzone trovi
il suo sbocco e lo fa
dopo sette minuti
con un folle flauto
jazzato che irrompe in modo inatteso, pazzo. Questo è materiale di prim’ordine per mandare fuori di cervello la vostra
famiglia suonandolo a volume alto. A metà strada il pezzo
cambia completamente direzione mentre gli strumenti sfumano e si eleva un solo di flauto. Gli ultimi dieci minuti
sono una improvvisazione difficile da descrivere e che si
estende da quella iniziale con un sassofono che esce a tratti
e che suona come un mal di gola. Grande pezzo.
OUTSIDER
Il brano successivo è Slightly All The Time e continua su
quelle fondamenta jazz già posate. Di solito a questo punto
dell’album sono confuso e non presto una grande attenzione, devo ammetterlo. Questo è una parte del disco che
suona perfetta come musica di sottofondo. Forse mi sono
abituato, ma adoro il passaggio che c’è a otto minuti. In effetti gran parte della canzone è follemente funky ed è la
cosa migliore che riempie l’intero album.
Il pezzo Moon in June è un capolavoro, e non solo di questo disco, ma di tutti i tempi. Sono stupito da quante volte
l’ho ascoltato e non mi sono ancora stancato. È l’unico brano del disco con il cantato e sicuramente il brano di punta,
a mio parere. Robert Wyatt può toccare grandi note ed il
modo in cui canta è sorprendente. Inizia con una linea di
piano ed è chiaramente un canzone di desiderio e amore,
un brano potente grazie a un organo che accompagna la
sua voce. I primi tre minuti sono senza dubbio la miglior
parte del pezzo. Il basso e la batteria creano una quantità di
punti interessanti da impazzire. Moon In June non è priva
di ironia, comunque, un attimo prima del primo assolo di
organo Robert sembra aver dimenticato la sequenza della
canzone e se ne esce con un “Oh! Aspetta un minuto”. Dopo
il solo, la canzone prende una vena allegra, con rimbalzi
ritmici e testi che parlano di essere di nuovo a casa. Il cantato vi manderà in trance, credetemi. Al decimo minuto la
chitarra fuoriesce con un riff perfetto e distorto e l’organo
si lancia in una piacevole improvvisazione. Il tutto passa
a una marcia alta e il feedback riempie i vostri altoparlanti per poi ricadere improvvisamente di nuovo dentro
un intermezzo tenuto insieme da un solo accordo ripetuto all’infinito. A quel punto possiamo sentire qualcosa di
veramente strano, un violino che corre su e giù come un
nastro rotto creando dei suoni davvero alieni. Altri suoni
riempiono lo spazio lasciato libero facendoci entrare in un
nirvana di suono sperimentale. Un modo perfetto per terminare la canzone.
Alla fine del disco troviamo Out Bloody Rageous. Difficile
spiegare le emozioni che si provano quando sogni morbidi
come suoni ti entrano in testa. A volte ne sono preoccupato; mi fa cadere il cuore dentro allo stomaco. Mi piace
ascoltare questo brano prima di andare a dormire perchè
ti addolcisce l’orecchio, ti rilassa e ti fa pensare più chiaramente. Difatti non solo l’intera canzone è un’intera grande
sequenza da sogno ma al quinto minuto con un ritmo simile alle pazzie di Facelift evidenzia una parte molto godibile di corno. Una delle parti che preferisco. La pazzia dura
sei minuti prima di tornare ai suoni iniziali. Come le altre
canzoni su Third la seconda parte è riservata a un tempo
di cui è difficile entrare nei dettagli. Third finisce in modo
meraviglioso con altri splendidi rumori... Bravi !
In conclusione, mi piacciono molto i Soft Machine ed il
loro suono. Comprendo che alcuni di voi potranno non
trovarlo facile ma incoraggio chiunque almeno a provare
ad ascoltare alcune delle prime cose da One e Two. Potranno non entrarvi intesta subito, ma provateli. E per ciò che
riguarda questo disco, non posso che apprezzare la compagnia e la felicità che mi dona: Moon In June, il miglior brano di tutti i tempi!
125
DEAD FLOWERS
- di Max Stèfani -
BOBBY KEYS
18 DICEMBRE 1943 / 2 DICEMBRE 2014
Ci ha lasciato un altro compagno di sbronze e di eccessi di
Keith Richards. Presenza fondamentale nei Rolling Stones.
Cirrosi epatica. Era prevedibile visto l’amore che ha sempre legato Bobby alla bottiglia di Jack Daniels. Anzi, c’è da
stupirsi che abbia durato così tanto. Chi segue gli Stones sa
che Bobby Keys è stato la sponda americana per arrivare
a quei suoni sporchi e caldi che hanno le loro origini nel
blues e non c’è di più normale che sia stato un bianco texano, cresciuto alla corte di Buddy Holly (nel 1958, appena
quindicenne aveva suonato in tour con Boby Vee e Holly)
a renderlo possibile. I Muscle Shoals insegnano d’altronde. Si era unito agli Stones da subito, durante il loro primo
tour americano, ma aveva debuttato in un loro disco solo
cinque anni più tardi, mettendo il suo sax in Let It Bleed e
è poi è da sempre rimasto vicino a loro, segnando con il suo
sax canzoni come Brown Sugar, Happy, Can You Hear Me
Knocking e alcuni dei momenti più belli di Exile e di Sticky
Fingers. Il suo sax aveva servito anche Dion DiMucci, Eric
Clapton, Who, Joe Cocker, George Harrison, John Lennon (è
suo il ‘solo’ in Whatever Gets You Thru the Night, unico n.1
di John), Lynyrd Skynyrd, Ringo Starr, Ron Wood, altro compagno di bisbocce.
Aveva suonato con gli Stones nel 2013 nel loro debutto al
Glastonbury Festival, il 29 giugno.
Riposi in pace, con vicino una bottiglia dell’amato e traditore Jack Daniels.
126
OUTSIDER
MIXED UP
40 ANNI A-GO
- di Chris Jones -
BAD COMPANY
BAD COMPANY
Originariamente considerato un progetto satellite del manager dei Led Zeppelin, Peter Grant, e della sua etichetta
Swan Song/Atlantic (Island in Europa), non ci volle molto
tempo ai Bad Company per scavarsi la propria nicchia nel
Phanteon del rock.
Il primo disco, Bad Company, catapultato direttamente al
vertice delle classifiche e da allora cinque volte il disco di platino, è divenuto uno dei cinquanta
album che hanno venduto di più
degli anni settanta. Questi risultati erano dovuti ad un approccio al
rock and roll essenziale e ruvido,
che colpiva gli appassionati del genere. Sebbene difficilmente lungimirante, il suono di Bad Company
è distinto, con ognuno dei quattro
esecutori che ha la possibilità di raggiungere individualmente e collettivamente l’ascoltatore.
Il gruppo era stato fondato nel 1973
quando il chitarrista Mick Ralphs
aveva abbandonato i Mott The
Hoople unendosi a due ex-membri
dei Free, il batterista Simon Kirke
e il cantante Paul Rodgers. Quando
Grant decise di gestire il gruppo, aggiunse il bassista dei King Crimson,
Boz Burrell, a completamento del
quartetto, giacchè il bassista dei Free,
Andy Fraser, preferì formare una sua
band, gli Sharks, con Chris Spedding
alla chitarra solista.
La passione di Rodgers per il film Bad
Company, (un western con Jeff Bridges e Barry Brown del 1972) così come
un passo da un libro di etica vittoriana,
dette nome al gruppo.
Prodotto indipendentemente, Bad
Company venne inciso alla Headley
Grange, un ospizio vecchio di cent’anni, con l’aiuto di uno studio mobile,
nel tardo 1973. Quello era il medesimo
luogo dove gran parte del terzo e del
quarto album dei Led Zeppelin, insieme ad alcune canzoni superstiti per
Physical Graffiti, erano state incise,
donando quel suono ricco e spaziale tipico del disco.
Mick Ralphs scrisse Can’t Get Enough che divenne il pezzo
che ebbe miglior fortuna e vendette maggiormente dei Bad
Company. Il suono e l’energia di questo album è immediatamente evidente nell’interazione tra Ralphs e Kirke in questo
brano di apertura e forse nessun brano che segue cattura meglio la dinamica dei Bad Company. Rock Steady ha un sapore
molto più blues rock e non altrettanto accattivante in modo
febbrile quanto il pezzo iniziale, seppur ugualmente orecchiabile. Qua la voce di Rodgers è più dinamica e la canzone
cresce prima di chiudersi un po’ troppo bruscamente. Ralphs
porta con se Ready For Love dai Mott The Hoople, dato che
ne aveva cantato una versione lui stesso nell’album All The
Young Dudes del 1972. Questa è la prima occasione in cui le
vibrazioni svicolano in un tema più sobrio con la voce profonda di Rodgers e il modo con cui il bassista Burrell si illumina
prima che il pezzo dissolva in un ritmo lento e nel pianoforte.
Don’t Let Me Down è una ballata al piano con cori arricchiti
ed un sassofono di un musicista ospite. Prima collaborazione tra Rodgers e Ralphs, la
canzone mostra un ritmo
costante, chitarre minimali ed è costruita per sottolineare un messaggio molto
semplice: “Non deludermi,
dimmi dove posso trovare
l’amore...”.
La seconda facciata inizia
con Bad Company, scritta insieme a Kirke, che
completa lo strano trio
dove brano, artista e titolo
condividono il medesimo nome. Forse il brano
più oscuro del disco, Bad
OUTSIDER
Company potrebbe essere stata influenzata da Alice Cooper
musicalmente, ma ha un cantato molto più convincente. I
versi teatrali, guidati dal piano, sono interrotti mirabilmente nel momento in cui il pieno dell’arrangiamento entra nel
corso del ritornello, condotto dall’immacolata chitarra rock
di Ralphs. Se Rodgers ha scritto la canzone, in realtà sono le
note di chitarra quello che veramente risplende su The Way I
Choose che ha un ritmo da lento valzer di campagna e alcuni
strategici stop e ripartenze.
Movin’ On arriva quanto più vicino possibile all’energia rock
del primo brano, Can’t Get Enough, un brano rock molto orecchiabile e accessibile. Ancora i testi e i ritmi sono essenziali
ma rappresentano un colpo forte, impossibile da ignorare,
dato che questa formula riusciva a portare il brano nella Top
20. Seagull è un brano acustico di chiusura dal gusto folk che
contiene un arrangiamento molto semplice con la sola ag-
UN DISCO TI SALVA (scusa se è poco)
- di Ruben P. Coppolella -
PREFAB SPROUT
STEVE MCQUEEN
(1985)
Il pop, questo soggetto mal conosciuto.
Di solito i fan del rock contrappongono il pop al rock. Premesso che pop è l’abbreviazione di popular, “popolare” nella
127
giunta di percussioni a metà brano. Condita da un gran cantato, la canzone pare fatta per una colonna sonora, anche se
questo è un modo bizzarro per definire questo disco.
Con il secondo disco Straight Shooter, la band ebbe altri due
hit single, Good Lovin’ Gone Bad e Feel Like Makin’ Love.
Guidata da Bad Company, la Swan Song Records ebbe quattro
album nella classifica Top 200 di Billboard meno di un anno
dopo il suo lancio. Questa formazione del gruppo è collegata
direttamente alla durata dell’etichetta dato che il disco finale
del 1982, Rough Diamonds, fu l’ultimo per quell’etichetta che
chiuse nel 1983, per problemi interni ai Led Zeppelin e al cattivo stato di salute di Grant.
L’etichetta produsse anche i Pretty Things, Dave Edmunds
e Maggie Bell. Alla chiusura Page, John Paul Jones e i Bad
Company passarono alla Atlantic. Plant fece la sua etichetta
Es Paranza.
lingua d’Albione, per cui a stretto rigore il pop è la categoria
generale in cui rientra anche il rock, e che, ad ancor più stretto rigore, anche quella che noi chiamiamo musica classica è
in realtà musica popolare, perché tale era ai suoi tempi e tale
è ancor oggi, potremmo dire, semplificando brutalmente e
ponendoci nell’ottica di chi ascolta rock, che è rock quel tipo
di arrangiamento musicale con cui si vuol dare una certa
pesantezza e consistenza ad un brano, mentre ciò che è pop
- perlomeno come lo intendono i fan del rock – è in realtà
un arrangiamento che vuol conferire al pezzo leggerezza,
disimpegno, facilità d’ascolto.
Ho un mio modo di pensare al pop. Avete presente il rumore
che fa una bottiglia di spumante quando viene aperta? Meglio ancora, quel tipo di sensazione che ti dà l’aprirla? Bene,
per me, quello è il Pop (doverosamente scritto con la P maiuscola). Un tocco, piacevolissimo, di leggerezza.
Steve McQueen dei Prefab Sprout è uno dei dischi pop migliori di sempre. Prodotto in modo sopraffino da Thomas
Dolby, che cesella e rifinisce il tutto da par suo, è una gioia
per le orecchie.
Avete presente termini come “classe”, “eleganza”, insomma
cose come queste che in anni trucidi come gli attuali devi
andare a cercare con il lanternino? Ecco, qui quelle qualità
le trovate a profusione.
Il nostro problema, cari noi rocker, è che il pop non ci piace
perché, nella maggior parte dei casi, il pop, soprattutto come
lo si realizza in Italia, è fatto male. Ma quando lo si fa bene…
Un disco come questo, credetemi, vi salva la vita. O, perlomeno, se avete passato una giornata da buttare, ve la risolleverà fino alle stelle (e puoi credermi anche tu, fratello
metallaro).
Ascoltate Appetite, Bonny, When Love Breaks Down, Hallelujah (no, non è quella, sublime, di Leonard Cohen, però
che pezzo!) e sappiatemi poi dire.
Pubblicato negli anni ’80, è uno dei picchi di quella decade.
Molto più creativa di quanto generalmente si pensi e certo
più di quella che – ahinoi… – ci tocca vivere.
128
OUTSIDER
MIXED UP
MOVIE/DVD
– di Andrea Hawkes –
ERIC CLAPTON
PLANES, TRAINS and ERIC
(DVD/BLUE-RAY)
ROLLING STONES
FROM THE VAULT L.A. FORUM (1975)
FROM THE VAULT /
HAMPTON COLISEUM (1981)
Nel corso della sua leggendaria carriera, Eric Clapton ha prodotto molti album dal vivo - con Cream, Derek and
the Dominoes, e i suoi molti documenti da concerto come solista - che è facile
perdere le tracce di tutti.
Questo nuovo prodotto cattura il tour
del 2014 in Oriente (tra cui il suo concerto n. 200 in Giappone).
Il basso di Nathan East romba come un
tuono, e si sente ogni colpo di piatto o
del rullante di Steve. I due veterani stabiliscono una spessa, funky scanalatura, che serve come base per gli assoli di
un Clapton ispirato.
Gli standard ci sono tutti: Layla, I Shot
The Sheriff, Wonderful Tonight, Cocaine, Tears In Heaven, I Shot The Sheriff, Crossroads. Ma oltre a tutto questo
anche Pretending e Little Queen Of
Spades che richiamano alla mente il
Clapton vecchia maniera.
From The Vault è la nuova serie di concerti dal vivo estratti dall’archivio dei
Rolling Stones, ora pubblicata ufficialmente per la prima volta.
Hampton Coliseum – Live In 1981 è il
primo titolo di questa fantastica serie,
che inizia dal quel magico tour americano del 1981 per la release dell’album Tattoo You, in grado di fruttare ben
50 milioni di dollari in biglietti venduti. Furono 50 date
con partenza da
Philadelphia alla
fine di settembre
per poi approdare a Hampton, in
Virginia il 18 e il
19 Dicembre. Lo
show del 18 Dicembre, data del
compleanno di
Keith Richards, fu
il primo concerto
trasmesso in TV
con la formula del
‘Pay per view’. Il tutto (ovvero ben 2
ore e mezza di concerto) è stato completamente restaurato e il suono nuovamente mixato da Bob Clearmountain
Per “L.A. Forum – Live In 1975” il tour
di riferimento è quello del 75, denominato “Tour Of The Americas ’75”, il
primo con il nuovo chitarrista Ronnie
Wood. Dopo un paio di concerti di “riscaldamento” in Louisiana il tour salpò
alla volta di 44 date dal 3 giugno all’
8 agosto 1975. Cinque furono le notti
al FORUM di Los Angeles dal 9 al 13
luglio, questa è quella del 12 luglio.
Un documento imperdibile! Che sia il
DVD, il blu-ray, i 2 CD o il triplo vinile
CULT
HOUSE OF CARDS
Proprio quando si parla delle dimissioni di Napolitano, in Rete molti ironicamente hanno cominciato a diffondere la speranza di vedere al suo posto
non Casini o la Bonino, ma… Frank Underwood.
Underwood, interpretato da un fenomenale Kevin Spacey (con l’attrice Robin Wright nel ruolo di moglie, che lo aiuta nel suo piano), è il protagonista
della serie televisiva ‘House of Cards’, di cui si sono viste in Italia le prime
due stagioni sul canale Sky ‘Atlantic’.
Una serie dalla fortissima matrice politica. Vero che una grande attenzione
viene data ai personaggi e alle loro caratteristiche ma è altrettanto significativa la sotto-trama politica, quella che ha sempre mosso le azioni dei personaggi e del protagonista principale.
La serie si concentra sull’utilitarismo spietato, la manipolazione, il potere, e sul fare di tutto per raggiungere l’obiettivo.
L’ultimo episodio ci ha raccontato l’obiettivo incredibilmente raggiunto dal protagonista e il suo nuovo posto di Presidente degli
Stati Uniti.
Il protagonista ha sempre fatto della ricerca del potere su tutto e tutti la sua arma principale e questa sua smania non si sarà certo
affievolita con la conquista della carica più importante del mondo. Per questo la politica estera giocherà un ruolo fondamentale il
prossimo anno. Dovremo aspettare febbraio 2015 per saperlo.
Per capire la differenza con gli sceneggiati italiani e la ‘democrazia’ che c’è in USA (e non in Italia) ve l’immaginate possibile in Italia
una storia del genere? Anche se ‘fiction’. Il vice presidente che bacia a lingua in bocca la sua guardia del corpo prima di scopare in tre
con la moglie?
OUTSIDER
WE ARE
MAX STÈFANI
Esordisce nel 1971 per la rivista di hi-fi “Suono”, dove cura la parte musicale ‘Music Box’ fino al 1980. Nel 1976 dirige i primi due numeri di “Popster /
Rockstar”. L’anno dopo fonda “Il Mucchio Selvaggio”, giornale che ha editato e
diretto fino a febbraio 2011.
Come editore ha creato anche “Rumore”, “Chitarre”, la rivista di cinema “Duel/
Duellanti”, il sito “Rockol”. Ha scritto per “L’Europeo”, “La Repubblica”, le riviste francesi “Starfix” e “Lesinrockptibles”. Da aprile 2012 a settembre 2013 ha codiretto con Paolo Corciulo “Suono”, curando la parte musicale.
GIANCARLO TROMBETTI
Inizia a vent’anni a scribacchiare per giornaletti minori e a divertirsi in radio;
ma è dal 1979 in poi che tutto inizia a girare positivamente: “Rockstar”, “Tuttifrutti”, “Mucchio”, “Rockerilla”... riesce a rifilare le sue cose un po’ a tutti. Dirige
un paio di riviste Rock: “Metal Shock” e “Flash”. Nel 1988 molla la carta per la
televisione e finisce in quel rifugio di peccatori che era Videomusic. Lavora per
TMC, poi per La7, Super Channel Europa, D+, apre DeeJay Tv, Sky. Rimbalza
tra Milano, Roma e Londra. Nel mezzo riesce a gestire da direttore artistico un
elenco spropositato di eventi speciali, tra cui qualche centinaio di concerti che
lui stesso sostiene: “avrebbe voluto vedere” in primo luogo.
Sopravviveva ritirato in campagna come Cincinnato, finchè Max non ha avuto
l’incoscienza di ospitarlo, prima su “Suono” e adesso su “Outsider”.
129
OUTSIDER
Il rock è qualcosa che mi disturba anche come termine.
Mi frastorna. È cacofonico, è impronunciabile.
È inascoltabile e non mi diverte. (Emilio Fede)
IL MEGLIO DELLA STAMPA ROCK
INTERNAZIONALE
Via San Domenico Savio 1, 73024 Maglie
DIRETTORE:
Max Stèfani - [email protected]
REDATTORI:
Giancarlo Trombetti – [email protected]
PROGETTO GRAFICO:
Giulia Tessari
IMPAGINAZIONE:
Giulia Tessari, Linda Robinson
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Marco Cestoni, Ruben P. Coppolella, Daniele Benvenuti,
Andrea Hawkes, Aldo Pedròn, Emiliano Ra-B,
Tim Tirelli, Carlo Zampolini
FOTOGRAFI:
Getty Images, Chris Walter/Photofeatures
TRADUTTORI:
Lorenzo Balducci, Tito Borsa, Francesco Bucci,
Francesca Fiorucci, Davide Lancieri, Alessandra Maggi
COMITATO DEI GARANTI:
Roberto Gallo, Alessandra Maregatti
SUL NUMERO DI FEBBRAIO DI OUTSIDER
JEFF BECK / ZZ TOP
Gli ZZ Top sono uno dei nostri gruppi americani preferiti, fin dagli
esordi nel 1971. Jeff Beck… beh, inutile dirlo. Comunque Gibbons e
Beck si sono incontrati spesso negli ultimi anni facendo scintille sui
palchi americani ed europei. Vediamoli un po’ più da vicino.
NEW RECORDS
Sceglieremo con la dovuta calma su Waterboys, Brian Ferry, Johnny
Marr, Jon Hopkins, AC/DC, Stevie Nicks, Foo Fighters, Temple Movement, Marcia Ball, Chuck Prophets, Royksopp, Belle and Sebastian,
Brant Bjork, Faith No More, Melissa Etheridge, Bob Seger, Govn.
Mule, TV On The Radio…
GENE CLARK
Harold Eugene “Gene” Clark (1944-1991) fa parte dell’Olimpo dei nostri eroi. Per i Byrds, per Dillard & Clark, per White Light, No Other, per
McGuinn Clark & Hillman etc etc. Una ‘luce bianca’ che non smetterà
mai di brillare.
RISTAMPE
Ormai c’è solo l’imbarazzo della scelta. Comunque prossimamente
Marvin Gaye, Coldplay, David Bowie, Brian Eno, John Prine, Capt.
Beefheart, Kiss, Manic Street Preachers, John Martyn, XTC, Gentle
Giant, Kinks, Bruce Cockburn, Todd Rundgren, Roxy Music, Seeds,
Kinks, Manfred Mann, Dillards, Robert Wyatt…
STUDIO LEGALE:
Mario Caverni, Andrea Di Pietro, Lucia Maggi
MEMORIES:
Fulvio Fiore
DIRETTORE MARKETING, PUBBLICITÀ:
Tiziana Solidoro - [email protected]
DIFFUSIONE, ABBONAMENTI E ARRETRATI:
[email protected]
DISTRIBUZIONE:
Pieroni Distribuzione srl
Viale Vittorio Veneto 24 - Milano
STAMPA:
Arti Grafiche Boccia
Via Tevere 44, Roma
REGISTRAZIONE:
Reg.trib. Milano N. 140 del 10.05.2013
DIRETTORE RESPONSABILE:
Massimo Stèfani
OUTSIDER è una pubblicazione mensile della
Revenge srl, via XX settembre 6, 73020 Cutrofiano (LE)
Sito internet: www.outsiderock.com
SPIRITUAL GUIDANCE:
John Belushi e Stefano Ronzani
Foto di copertina:
DAVID GILMOUR 1977
(CHRIS WALTER)
© Revenge srl - Tutti i diritti di produzione sono riservati.
Chiuso in redazione 27 novembre 2014
SHOP AT www.doria1905.com
THE VELVET UNDERGROUND
TH
45 ANNIVERSARY
ad by: www.filippovezzali.com
6CD SUPER DELUXE BOX-SET / 2CD DELUXE / REMASTERED CD / DOWNLOAD
Udiscoveritalia
Tra il dire
e il fare
ci sono loro.
Le Dike.
E chi le usa.
Le scarpe Dike separano l’uomo dal suolo ma lo ricongiungono alla materia ... non è banale. Una cassa fatta a mano permette
all’uomo di sentire il suono, la vibrazione dell’universo. Una Glider Dike gli fa sentire il suolo, la materia della Terra.
La Terra sotto i piedi.
True stories. Sei storie vere, sei storie Dike. Uom
Uomini
mi che le tengono ai piedi e che fanno sul se
mini
serio. Lavorano. wwww.dikeworkwear.com