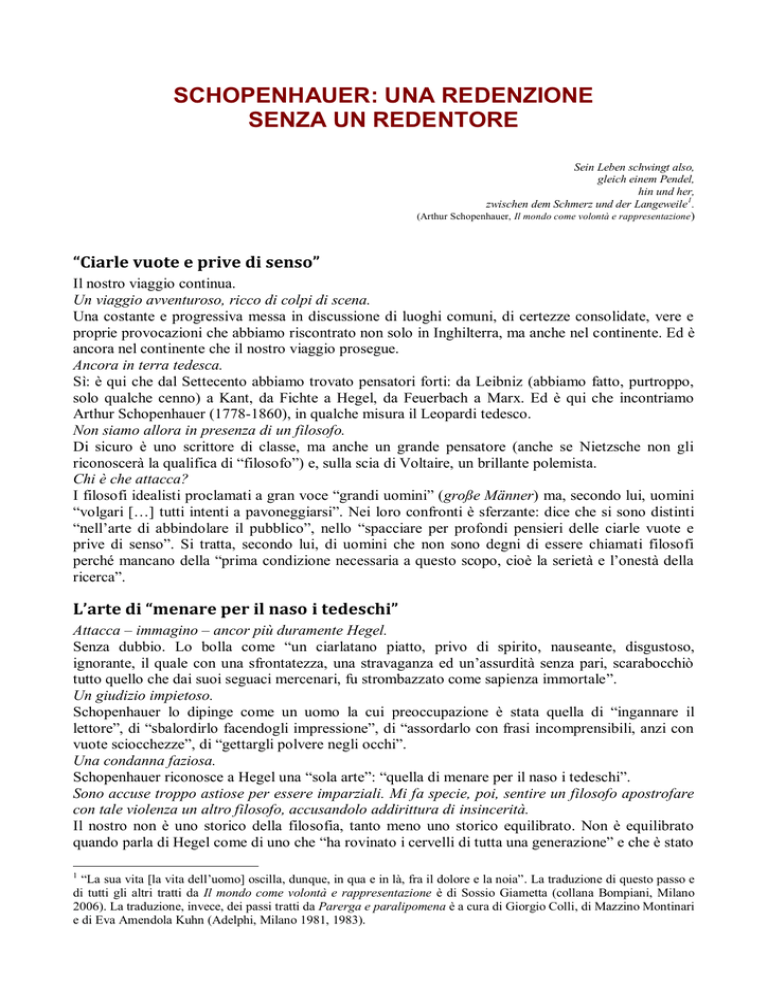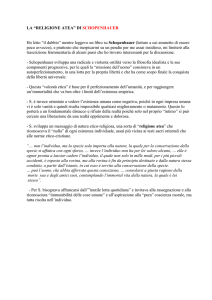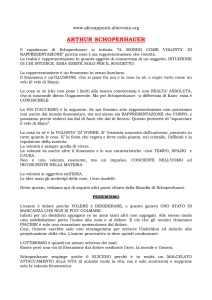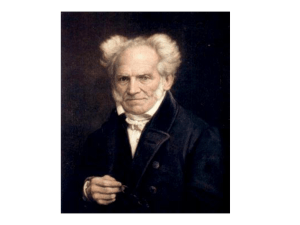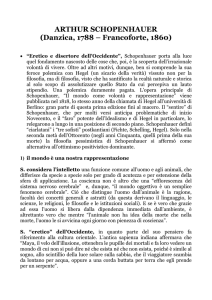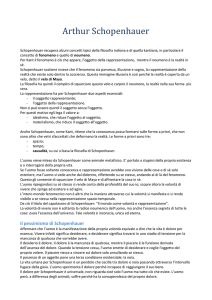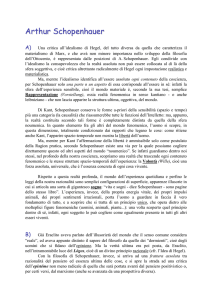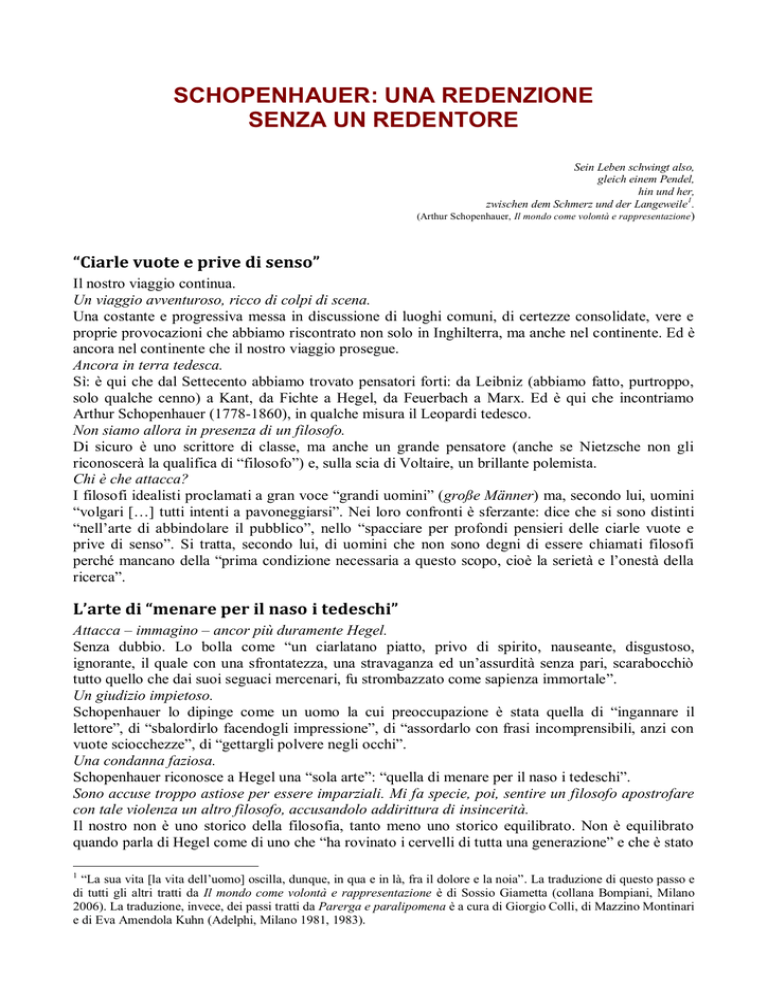
SCHOPENHAUER: UNA REDENZIONE
SENZA UN REDENTORE
Sein Leben schwingt also,
gleich einem Pendel,
hin und her,
zwischen dem Schmerz und der Langeweile1.
(Arthur Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione )
“Ciarle vuote e prive di senso”
Il nostro viaggio continua.
Un viaggio avventuroso, ricco di colpi di scena.
Una costante e progressiva messa in discussione di luoghi comuni, di certezze consolidate, vere e
proprie provocazioni che abbiamo riscontrato non solo in Inghilterra, ma anche nel continente. Ed è
ancora nel continente che il nostro viaggio prosegue.
Ancora in terra tedesca.
Sì: è qui che dal Settecento abbiamo trovato pensatori forti: da Leibniz (abbiamo fatto, purtroppo,
solo qualche cenno) a Kant, da Fichte a Hegel, da Feuerbach a Marx. Ed è qui che incontriamo
Arthur Schopenhauer (1778-1860), in qualche misura il Leopardi tedesco.
Non siamo allora in presenza di un filosofo.
Di sicuro è uno scrittore di classe, ma anche un grande pensatore (anche se Nietzsche non gli
riconoscerà la qualifica di “filosofo”) e, sulla scia di Voltaire, un brillante polemista.
Chi è che attacca?
I filosofi idealisti proclamati a gran voce “grandi uomini” (große Männer) ma, secondo lui, uomini
“volgari […] tutti intenti a pavoneggiarsi”. Nei loro confronti è sferzante: dice che si sono distinti
“nell’arte di abbindolare il pubblico”, nello “spacciare per profondi pensieri delle ciarle vuote e
prive di senso”. Si tratta, secondo lui, di uomini che non sono degni di essere chiamati filosofi
perché mancano della “prima condizione necessaria a questo scopo, cioè la serietà e l’onestà della
ricerca”.
L’arte di “menare per il naso i tedeschi”
Attacca – immagino – ancor più duramente Hegel.
Senza dubbio. Lo bolla come “un ciarlatano piatto, privo di spirito, nauseante, disgustoso,
ignorante, il quale con una sfrontatezza, una stravaganza ed un’assurdità senza pari, scarabocchiò
tutto quello che dai suoi seguaci mercenari, fu strombazzato come sapienza immortale”.
Un giudizio impietoso.
Schopenhauer lo dipinge come un uomo la cui preoccupazione è stata quella di “ingannare il
lettore”, di “sbalordirlo facendogli impressione”, di “assordarlo con frasi incomprensibili, anzi con
vuote sciocchezze”, di “gettargli polvere negli occhi”.
Una condanna faziosa.
Schopenhauer riconosce a Hegel una “sola arte”: “quella di menare per il naso i tedeschi”.
Sono accuse troppo astiose per essere imparziali. Mi fa specie, poi, sentire un filosofo apostrofare
con tale violenza un altro filosofo, accusandolo addirittura di insincerità.
Il nostro non è uno storico della filosofia, tanto meno uno storico equilibrato. Non è equilibrato
quando parla di Hegel come di uno che “ha rovinato i cervelli di tutta una generazione” e che è stato
1
“La sua vita [la vita dell’uomo] oscilla, dunque, in qua e in là, fra il dolore e la noia”. La traduzione di questo passo e
di tutti gli altri tratti da Il mondo come volontà e rappresentazione è di Sossio Giametta (collana Bompiani, Milano
2006). La traduzione, invece, dei passi tratti da Parerga e paralipomena è a cura di Giorgio Colli, di Mazzino Montinari
e di Eva Amendola Kuhn (Adelphi, Milano 1981, 1983).
non a servizio della verità, ma dei potenti, del tutto incomparabile con filosofi del calibro di
Cartesio, Malebranche, Spinoza, Hume, Kant, veri e propri spiriti nobili che hanno pensieri e
suscitano pensieri, pensano e fanno pensare.
Ho la sensazione che dopo Hegel diventi di moda scagliarsi contro di lui.
Schopenhauer lo è molto prima: il suo capolavoro, Il mondo come volontà e rappresentazione (Die
Welt als Wille und Vorstellung), viene pubblicato nel 1819, dodici anni prima della morte di Hegel.
Un successo editoriale come La vita di Gesù di Strauss?
Al contrario: un insuccesso clamoroso, ma che, comunque, gli vale la libera docenza: dal 1820 al
1831 Schopenhauer tiene dei corsi nella stessa università (Berlino) dove insegna Hegel e decide di
tenerli negli stessi orari delle lezioni del maggiore filosofo del tempo.
Una sorta di sfida.
Un sfida persa: le sue lezioni sono quasi deserte.
Un astio, quindi, il suo, frutto anche dell’invidia.
Forse. Un fatto, invece, è certo: Schopenhauer non ha un buon carattere e in più ha un’alta
autostima.
Un presuntuoso
Arriva ad affermare che la sua opera produrrà nel mondo un effetto che nessuno mai ha provocato
“né in epoca antica, né moderna”.
Siamo di fronte a un altro pensatore che – come Feuerbach e Marx – rovescia Hegel.
Sì: egli capovolge letteralmente la visione ottimistica di Hegel.
L’identificazione hegeliana di reale e razionale.
Un’identificazione che è il fondamento dell’ottimismo hegeliano.
Un ottimismo non nuovo.
Anche Leibniz, con la sua tesi secondo cui questo è il migliore dei mondi possibili, lo è stato.
Gli stessi Illuministi (almeno gran parte di loro) che hanno teorizzato l’idea di “progresso”
all’insegna della scienza e della tecnica.
Un ottimismo che abbiamo riscontrato anche in Fichte nel superamento all’infinito dei limiti.
Un ottimismo che non manca neppure in Marx: il treno della storia ci porterà inevitabilmente a
superare tutte le ingiustizie sociali, tutte le forme di alienazione e a instaurare una sorta di
paradiso terrestre.
Sostanzialmente ottimista è anche Kant nella misura in cui teorizza la “pace perpetua”, una stagione
dell’umanità in cui non vi saranno più conflitti tra nazioni.
Un ottimismo “scellerato”
È contro ogni forma di ottimismo da lui definito non solo “assurdo”, ma “scellerato” (“un amaro
scherno sui dolori senza nome dell’umanità”) che Schopenhauer elabora il suo pessimismo: secondo
lui un mondo peggiore di questo non sarebbe stato possibile.
Un pessimismo alla Leopardi.
Sì, ma Schopenhauer segue un suo percorso del tutto parallelo (scoprirà Giacomo Leopardi - dalla
cui lettura trarrà “un grande diletto” – solo verso la fine della sua vita, precisamente nel 1858). I due
autori, poi, hanno punti di riferimento culturali differenti. Nel caso di Schopenhauer troviamo il
“divino Platone”, Kant e la sapienza orientale.
Un pessimismo che, immagino, ha radici anche nel carattere.
Indubbiamente. È stato del resto Fichte che ha messo in evidenza il ruolo importante del carattere
nelle opzioni filosofiche: una persona che non crede nelle sue capacità, tendenzialmente
rinunciatario, pigro, non può certo aderire all’idealismo che è una dottrina che esalta l’attività dello
spirito.
Il ventiseienne Schopenhauer (è a questa età che inizia a scrivere la sua opera principale) è un
giovane malinconico e questo non può che influenzarne i pensieri. Pensieri che vengono rafforzati
da alcune letture, in particolare dalle Upanishad (libri che fanno parte dei testi dell’induismo, i
Veda), che scopre grazie all’orientalista Friedrich Mayer.
Il velo dell’inganno
Siamo di fronte a un giovane catturato dall’Oriente.
Sulla scia di altri pensatori sia dell’antichità sia dell’età moderna. Il nostro sicuramente ruba
all’induismo e al buddismo, oltre che alcuni temi, non poche immagini suggestive.
Ad esempio?
Il “velo di Maja” (das Gewebe der Maja): “è la Maja, il velo dell’inganno, che ricopre gli occhi dei
mortali e fa loro vedere un mondo, di cui non si può dire che sia né che non sia: giacché è come il
sogno, è come il riflesso del sole sulla sabbia, che il viandante scambia da lontano per acqua, o
anche come la corda gettata a terra, che egli prende per un serpente”.
Una metafora poetica.
Più che una metafora: Schopenhauer è convinto che la verità sia nascosta ai più.
Nulla di nuovo. Già i filosofi greci hanno distinto nettamente il mondo dell’“opinione” da quello
della “verità”: solo il sapiente è in grado di uscire dalla “caverna” di platonica memoria e di
vedere la Verità.
Schopenhauer, richiamandosi alla filosofia indiana, dice qualcosa di più: noi siamo ingannati.
L’ipotesi del genio maligno di Cartesio.
Un inganno ancor più diabolico: lo vedremo.
Un inganno tipico delle illusioni ottiche.
Il passo citato è del tutto esplicito: ciò che noi percepiamo è un’illusione. La nostra vita, in altre
parole, non è che un sogno.
Un classico nella letteratura mondiale.
Senza dubbio: vedi, ad esempio, Sofocle, Shakespeare, Calderόn de la Barca.
Ma se la vita fosse davvero un sogno, sarebbe impossibile uscirne, sarebbe impossibile lacerare il
velo che tiene nascosta la verità.
Difficile, secondo Schopenhauer, ma non impossibile. Proviamo a seguire un tema caro al nostro:
l’amore.
L’amore tanto cantato dai poeti.
Il nostro è chiaro: l’amore platonico è solo una nostra illusione perché l’amore, in ultima analisi, è
soltanto sesso.
Lo “zimbello” della natura
Una forzatura.
Secondo Schopenhauer noi non siamo che lo zimbello della natura che ha come scopo esclusivo la
perpetuazione della specie: che cos’è il piacere che accompagna l’atto sessuale se non una trappola,
uno “stratagemma” della natura?
Perché mai dovrebbe essere una trappola? L’istinto sessuale è una potente forza che ha una
funzione positiva.
Schopenhauer la definisce “la più forte e attiva di tutte le molle” (die stärkste und thatigste aller
Triebfedern), dopo l’amore della vita.
Concordo.
Una molla - prosegue il nostro - che “tiene perpetuamente occupata la metà delle forze e dei
pensieri della parte giovane dell’umanità, è il fine ultimo di quasi ogni aspirazione umana […] getta
talvolta in confusione per un certo tempo le menti più grandi […] spezza i legami più saldi, immola
a sé talvolta la vita o la salute, talvolta la ricchezza, il rango e la felicità”.
Un’analisi realistica, ma tutto ciò non ha nulla a che vedere con un inganno: senza lo stimolo
potentissimo dell’istinto sessuale la vita si arresterebbe.
È appunto questo che importa alla natura: la propagazione della specie. Un compito alto,
nobilissimo, che va al di là dei sentimenti degli individui innamorati: “la crescente attrazione
reciproca di due innamorati è in realtà già la volontà di vivere del nuovo individuo, che essi possono
e vogliono generare; anzi, già nel’incontro dei loro sguardi desiosi si accende la sua nuova vita,
annunziandosi come un’armonica, ben composta individualità futura”. E ancora: “l’interesse per la
bellezza, nutrito tuttavia con tanto ardore, insieme all’accurata scelta che ne consegue, si riferisce
dunque evidentemente non a colui stesso che sceglie, sebbene così egli creda, bensì allo scopo vero,
al figlio da generare”. Ecco perché Schopenhauer afferma che, dopo avere soddisfatto l’istinto
sessuale, “dopo il compimento finale della grande opera”, ogni innamorato si ritrova
“infinocchiato”.
Sono i suoi occhiali neri che lo conducono a vedere negativo ciò che invece è positivo: non è bello
il piacere sessuale e non è straordinariamente bello il nascere di una nuova vita?
È vero, ma, secondo lui, la nuda realtà è questa: l’individuo serve uno scopo che non è il suo. Egli si
pone come obiettivo un piacere intenso, ma in questo modo diventa uno strumento della natura. È
“solo la specie” che a essa importa (da qui “l’enorme sovrabbondanza di germi”), non l’individuo:
“l’individuo non è per essa nulla” [das Individuum ihr nichts ist]. Succede a tutti gli animali. Senza
dubbio questi “sono presi da una sorta di illusione, che fa loro vedere il godimento proprio, mentre
con tanto fervore e abnegazione lavorano per la specie: l’uccello costruisce il suo nido, l’insetto
cerca il suo luogo adatto per deporre le uova o va in cerca di preda che, non buona per lui stesso,
debba essere messa accanto alle uova come cibo per le larve future, l’ape, la vespa, la formica
attendono alle loro ingegnose costruzioni e alla loro complicatissima economia”. Ci sono addirittura
delle specie di farfalle che, dopo avere vissuto anni in forma di larve, vivono un solo giorno durante
il quale si accoppiano e depongono le uova.
Gli animali - si sa - agiscono per istinto.
Certo, un istinto che è a servizio della specie. Pensiamo all’“istinto materno”. Così scrive il nostro:
“La lontra marina, quando è inseguita, afferra il suo piccolo e si immerge con esso; quando
riemerge per respirare, lo copre col suo corpo, ricevendo, mentre lo salva, i dardi del cacciatore. Si
ammazza un balenottero solo per attirare la madre, che accorre a lui e raramente lo abbandona,
finché esso è ancora in vita, anche se colpita da molti arpioni”.
Gli esempi in natura sono infiniti.
Schopenhauer racconta il comportamento delle foche colossali, dette elefanti marini, che sono
sempre in pericolo a causa di “certi crudeli nemici, a noi ignoti”: “le femmine partoriscono a riva;
mentre poi allattano, il che dura da sette a otto settimane, tutti i maschi formano un cerchio intorno
a loro, per impedir loro di spingersi, mosse dalla fame, in mare, e quando tentano di farlo glielo
impediscono morsicandole. Così digiunano tutte insieme da sette a otto settimane e dimagriscono
tutte moltissimo, solo affinché i piccoli non vadano in mare prima di essere in grado di nuotare bene
e di osservare la debita tattica, che viene poi inculcata loro a spinte e a morsi”; “l’allodola cerca di
far allontanare il cane dal suo nido offrendo come preda se stessa”.
Comportamenti ammirevoli.
Addirittura commoventi.
Un istinto che è evidente nei comportamenti degli uomini: “l’uomo è incline per natura
all’incostanza in amore e la donna alla costanza”; l’uno “può generare, comodamente, oltre cento
figli l’anno, se altrettanto donne stanno a sua disposizione; la donna potrebbe, invece, anche con
tanti uomini, mettere al mondo solo un figlio l’anno (a prescindere dai parti gemellari). Quindi egli
cerca sempre nuove donne; ella si attacca invece saldamente a quell’uno: perché la natura la spinge
a conservarsi, istintivamente e senza riflessione, il nutritore e protettore della prole futura”. Una
prova in più è data dal fatto che una donna, una volta compiuta la sua missione di procreare e di
allevare i figli, perde presto la sua capacità di attrazione. Un caso-limite è rappresentato nel mondo
animale dalla mantide che dopo l’unione sessuale divora il maschio.
Ma questa è un’eccezione.
Sì, ma prova ancora di più la funzione puramente biologica dell’amore.
Una funzione che oggi, grazie allo sviluppo e alla diffusione delle tecniche di prevenzione, è sempre
più controllata dall’uomo.
Questo è vero: l’uomo è sempre meno a servizio della natura e sempre più libero di dare alla luce o
no dei figli. Ma è uno scenario, questo, che non poteva essere sotto gli occhi di Schopenhauer nella
prima metà dell’Ottocento.
Un “impulso cieco”
Fin qui, comunque, non vedo nulla di particolarmente originale.
Originale è ciò che Schopenhauer vede al di là del velo di Maja, oltre l’illusione dell’amore.
Quella potentissima molla di cui abbiamo parlato.
Il nostro va oltre lo stesso istinto sessuale che, secondo lui, altro non è che “la più perfetta
manifestazione della Volontà di vivere”. Schopenhauer è chiaro: “i genitali sono il vero e proprio
punto focale della volontà” (sind die Genitalien der eigentliche Brennpunkt des Willens).
In questo modo proietta nella natura ciò che è tipicamente umano: la volontà. Fa cioè del mondo
una realtà a sua immagine e somiglianza.
La Volontà di cui parla Schopenhauer non è tout court cosciente: non è un caso che egli la consideri
una forza cosmica.
Sarebbe allora più corretto chiamarla energia, impulso: il termine “Volontà” mi richiama l’idea di
un mostro.
Si tratta di una forza irrazionale, “un impulso cieco e inarrestabile” [ein blinder, unhaufhaltsamer
Drang].
Tutto l’opposto della razionalità del reale di cui parla Hegel e tutto l’opposto della concezione
finalistica (teleologica) dello stesso Hegel. È qui, allora, che Schopenhauer colpisce a morte Hegel.
Come colpisce a morte ogni forma di ottimismo: il nostro non è il mondo della razionalità e dei fini,
ma “il regno del caso e dell’errore [das Reich des Zufalls und des Irrthurms], che vi spadroneggiano
spietatamente, nelle grandi come nelle piccole cose”.
Ma questa è una vera e propria sdivinizzazione del mondo: altro che teofania!
Schopenhauer sostituisce semplicemente la Razionalità hegeliana con la Volontà irrazionale.
Sostituisce cioè un Dio con un altro Dio.
Di sicuro conserva il monismo hegeliano: gli individui non sono momenti della Razionalità, della
stessa Astuzia della ragione, ma sono in balia di una sorta di Dio del male.
Un panteismo rovesciato.
Vi è chi l’ha chiamato “pandiabolismo”, ma forse è più appropriato evitare personalizzazioni: la
Volontà di vivere è un impulso cieco.
Un mondo oscuro.
Già, irrazionale, indecifrabile.
È questo, se vogliamo ricorrere al linguaggio kantiano, il mondo noumenico, la “cosa in sé” che
sta dietro il fenomeno.
È lo stesso Schopenhauer che fa uso del linguaggio kantiano. Egli, tuttavia, conferisce al termine
“fenomeno” una valenza nettamente negativa: si tratta del mondo dell’illusione, del sogno.
Il “velo dell’inganno”.
Sì, il velo della “rappresentazione”. Ecco il senso del titolo del suo capo capolavoro, Il mondo come
volontà e rappresentazione: la rappresentazione è, appunto, il velo di Maja che ci copre gli occhi e
ci nasconde la verità; la “volontà” è, invece, ciò che sta dietro questo velo, la realtà noumenica.
Schopenhauer, inoltre, mutua da Kant non solo il linguaggio: anche secondo lui noi non percepiamo
direttamente le cose, ma tramite le forme a priori.
Gli schemi di spazio e di tempo.
Sì: è per questo che noi cogliamo le cose e gli individui come separati tra loro (grazie allo spazio) e
percepiamo i fenomeni “in divenire” (grazie al tempo). Oltre alle forme di spazio e di tempo,
secondo Schopenhauer, noi leggiamo la realtà fenomenica sulla base del principio di ragion
sufficiente.
Il principio secondo cui se c’è qualcosa, ci deve pur essere una ragione.
Infatti. È questo principio che costituisce il fondamento della scienza: questa c’è solo se riesce a
individuare dei nessi causali “necessari” tra i fenomeni.
Un mondo che rientra nella rappresentazione.
Sì, la cosa in sé è inaccessibile tramite gli schemi a priori dell’intelletto.
Ma se così fosse, non ci sarebbe alcun modo d andare oltre i fenomeni.
Un canale c’è, vale a dire un tipo di “esperienza” che non entra nella percezione dell’intelletto: il
corpo.
Ma anche il corpo è oggetto della rappresentazione come qualsiasi altra cosa.
È vero, ma il corpo non è solo “oggetto” del nostro percepire perché è anche fonte di una esperienza
autonoma: l’esperienza dei nostri desideri, dei nostri impulsi, delle nostre passioni, della nostra
volontà. È grazie a questa esperienza che noi riusciamo a lacerare il velo di Maja, come il sole che
trafigge una nuvola con i suoi raggi e scoprire quella realtà noumenica che è la Volontà di vivere.
Una realtà che noi percepiamo senza le lenti deformanti dello spazio e del tempo.
Infatti: non si tratta di una Volontà separata dalle altre, né di una Volontà che varia nel tempo.
Si tratta, quindi, di una Volontà unica.
Unica e non soggetta al tempo.
Eterna.
Già, e non soggetta neppure al principio di ragion sufficiente: al di fuori quindi dei rapporti causali.
Non soggetta neppure a una qualche forma di finalismo.
È di questa Volontà di vivere che noi siamo in balia.
Infatti. È essa la fonte del dolore universale che caratterizza il mondo: è dalla Volontà di vivere che
nasce il “desiderio” [Wunsch] che muove gli uomini come gli animali.
Un fatto, a mio avviso, positivo: è il desiderio lo stimolo della vita.
Secondo Schopenhauer, il desiderio, proprio perché è figlio di una “mancanza” [Mangel], di una
“scontentezza”, “è dunque sofferenza” [ist also Leiden].
Ma il desiderio è solo una mancanza temporanea che viene meno quando viene soddisfatto.
È la gioia, secondo il nostro, che è fugace: una volta abbiamo soddisfatto il desiderio, ne sorgono
altri, sorgono cioè sempre nuove sofferenze.
Schopenhauer continua a insistere sul desiderio, ma la vita è ricca di gratificazioni profonde
dovute alla realizzazione di desideri.
Quando però possediamo l’oggetto desiderato, questo perde ogni attrazione.
Ma ciò prova che il desiderio ha una componente fortemente positiva: è esso che dà sapore alla
vita.
Un “fardello insopportabile”
È indubbio, tuttavia, che il desiderare sia nella sua essenza un soffrire per ciò che non possediamo,
come è indubbio che il possesso alla lunga genera “noia” [Langeweile]. Così l’esistenza diventa un
“fardello insopportabile” [unenrträglichen Last]. Ecco perché Schopenhauer giunge ad affermare
che la vita dell’uomo oscilla “come un pendolo, in qua e in là, fra il dolore e la noia” [gleich einem
Pendel hin und her, zwischen dem Schmerz und der Langeweile].
Ma non c’è solo l’appagamento che pone fine a un desiderio, ma anche l’intensa gioia che
proviamo, ad esempio, di fronte alla bellezza della natura e di un’opera d’arte.
Il nostro sa bene che vi sono dei godimenti purissimi. Si tratta, tuttavia, di gioie che non derivano
dalla volontà, ma dalla conoscenza. Siamo in presenza, inoltre, di piaceri spirituali inaccessibili ai
più.
Un pessimismo nero, quello di Schopenhauer.
Un pessimismo cosmico: la Volontà di vivere è presente in ogni essere per cui la sofferenza è
davvero universale. Una sofferenza che, naturalmente, varia a seconda dei livelli di vita di cui un
essere vivente è dotato. Schopenhauer esclude la pianta, perché non ha sensibilità, ma riconosce “un
certo grado assai piccolo di sofferenza” anche agli “animali infimi”.
La sofferenza è evidente solo laddove si è già formato il sistema nervoso.
Indubbiamente: sopravviene “in alto grado” [in hohem Grade] […] col perfetto sistema nervoso”
[mit dem volkommemen Nerversystem] che caratterizza i vertebrati.
E, al livello ancora più alto, naturalmente, nell’uomo.
Sì: più “la coscienza si accresce” [das Bewußseyn sich stegert], più “cresce anche il tormento”
[wachst auch die Quaal]. Un tormento che è più intenso più l’uomo è intelligente e che raggiunge la
sua massima espressione nel genio: è lui che soffre più di tutti.
Una tesi, questa, antichissima.
Si trova già nella Bibbia ebraica: qui auget scientiam, auget et dolorem.
Quello che sottolinea Schopenhauer è l’universalità del dolore: “ognuno ritroverà facilmente nella
vita dell’animale la stessa cosa, solo espressa più debolmente, in diversi gradi e potrà convincersi a
sufficienza anche in base al soffrire degli animali, che essenzialmente “ogni vita è dolore” [alles
Leben Leiden ist].
Siamo in presenza di un animalista ante litteram.
È vero: gli animalisti di oggi fanno spesso riferimento a lui.
Schopenhauer dà una nuova linfa al suo pessimismo affermando che la vita è una lotta continua con
la morte (ogni respiro, ogni pasto…), ma alla fine è essa che “è destinata a vincere giacché ad essa
siamo commessi già dalla nascita, e soltanto essa scherza per un po’ con la sua preda prima di
ingoiarla” [er spielt nur eine Weile mit seiner Beute, befor er sie verschlingt].
Nulla di nuovo, neppure la personificazione cruda della morte.
“O stolta foglia!”
Senz’altro. Schopenhauer, comunque, seguendo un altro percorso, tende a sdrammatizzare l’idea
della morte.
Perché con la morte dell’individuo, comunque, la vita continua.
Sì, la vita è immortale perché immortale è la Volontà di vivere. Noi individui siamo come delle
foglie che cadono in autunno, ma che a primavera sono sostituite da altre.
Ma si tratta, appunto, di altre.
Sì. Prova a sentire Schopenhauer: “sei coma la foglia sull’albero che, appassendo in autunno e sul
punto di cadere, si affligge per la sua fine, né vuol lasciarsi consolare dalla vita del fresco verde che
rivestirà l’albero a primavera e lamentandosi dice: ‘Ma quello non sono io! Quelle sono tutt’altre
foglie!’. O stolta foglia! E da dove credi che vengano le altre? Dov’è il nulla di cui temi l’abisso?”.
Una magra consolazione.
Già, ma è l’unica cosa che il saggio può fare: rivolgere “lo sguardo alla vita immortale della
natura”. Secondo il nostro per la specie la morte è “quel che il sonno è per l’individuo e quel che
per l’occhio è il battito di palpebre”. E ancora: “Come per il calar della notte, il mondo scompare, e
però non perciò cessa un attimo di essere, così del pari l’uomo e l’animale periscono in apparenza
con la morte, mentre il loro vero essere continua del pari ad essere indisturbato”.
Schopenhauer nega, di conseguenza, l’immortalità dell’anima.
Infatti. La coscienza, proprio perché “non può essere pensata in un essere privo di corpo” essendo la
sua condizione – la conoscenza – una “funzione del cervello”, non può che morire col corpo.
È questa prospettiva che terrorizza l’uomo.
Sì, l’uomo, rispetto all’animale che teme la morte pur non conoscendola (la teme per istinto), vede
la morte in faccia. Ma dopo la morte del corpo non c’è alcuna necessità della coscienza perché
questa altro non è che un espediente della natura per aiutare gli animali nei loro bisogni, bisogni che
poi vengono meno. Non è per nulla il caso, tuttavia, di enfatizzare tale perdita: siamo in presenza di
una “coscienza cerebrale, animale, un po’ più potenziata”.
Sarà, ma è la coscienza che abbiamo.
Con la morte del corpo si torna allo “stato originario” in cui tale coscienza animale diventa
superflua. Lamentarsene sarebbe come, per un paralitico guarito, volere ancora le stampelle. E poi il
ritorno allo stato unitario non sarà semplicemente uno “stato privo di coscienza, ma uno stato
superiore a quella forma”.
Superiore o no, saremmo comunque sempre in presenza della perdita della nostra coscienza
individuale, di un cadere nel nulla del nostro io.
Ma il “non essere” - precisa Schopenhauer facendo proprio un argomento classico - non dovrebbe
farci paura, come non ci fa paura il non essere che eravamo prima di nascere.
Ma allora non c’eravamo e ora ci siamo, col nostro io e con la nostra individualità.
È lui stesso che lo dice: non è tanto il dolore associato alla morte che noi temiamo, quanto “la fine
dell’individuo” [der Untergang des Individuums].
L’arcobaleno sulla cascata
Se non ci fosse la morte individuale, noi non ci saremmo.
Già, lamentarsi della caducità della vita, secondo il nostro, non ha proprio alcun senso: se non
fossero morti tutti gli uomini che ci hanno preceduto, noi infatti non potremmo esistere.
Sono numerose le immagini a cui ricorre Schopenhauer. Eccone alcune: temere la morte come
annientamento dell’esistenza “non è altrimenti che se si pensasse che il sole potesse la sera
lamentarsi: ‘Ahimé! Discendo nella notte eterna’ […] La terra si svolge dal giorno alla notte;
l’individuo muore; ma il sole stesso arde sempre senza posa in eterno meriggio”; “come sulla sfera
terrestre è dappertutto sopra, così anche la forma di ogni vita è il presente, e temere la morte, perché
ci strappa il presente, non è più saggio che temere di potere, dal tondo globo terrestre sul quale si sta
per fortuna proprio sopra, scivolare giù”.
Immagini efficaci, ma tutto sommato consolatorie.
Senti questa: “come le gocce polverizzate della cascata scrosciante si avvicendano con la velocità
del lampo, mentre l’arcobaleno che esse portano se ne sta saldo in immobile calma, per nulla
toccato dall’incessante vicenda […] così ogni specie di esseri viventi, rimane affatto intatta dal
continuo alternarsi dei suoi individui”.
Stupenda!
Eccone un’altra: il nostro paragona il singolo uomo a un navigante che “siede in una barchetta […]
nel mare in burrasca che, sconfinato da ogni parte, solleva e sprofonda ululando montagne d’acqua”
(Wasserberge).
Un navigante terrorizzato.
No: un navigante che, ciò nonostante, confida “nella debole navicella” dove “siede
tranquillamente”.
L’ululato del mare in burrasca non lo spaventa.
No, si tratta di un mondo che gli è estraneo perché lui, dal suo ristretto osservatorio, conferisce
realtà solo alla sua “persona infinitesimale”, al suo “presente privo di estensione”, al suo “benessere
momentaneo”. Egli, cioè, cerca, in ultima analisi, di godere tutto ciò che è godibile, di vivere il suo
“adesso” (das Jetz).
E fa bene: non è il caso che si carichi sulle spalle la sofferenza del mondo.
Un dato, però, è certo: questo è il mondo del sogno.
Ma almeno è un sogno confortevole: è qui il nostro mondo, non lo sconfinato mare in burrasca.
La redenzione
Indubbiamente l’individuo può decidere di farsi cullare dalle sue illusioni, ma non il saggio. Questi
conosce le radici del dolore e sa di conseguenza che l’unica causa nobile che può abbracciare è
quella di recidere tali radici.
Recidere le radici vuol dire recidere il desiderio, ma recidere il desiderio significa morire.
Secondo il nostro, no: significa liberarsi da quella “sete inestinguibile” che ci incatena al dolore e
alla noia. Un obiettivo che non si può certo raggiungere con il suicidio perché il saggio sa bene che
chi decide di suicidarsi non nega la volontà di vivere: “il suicida vuole la vita ed è solo insoddisfatto
delle condizioni in cui essa gli è toccata. Quindi non rinuncia affatto alla volontà di vivere, ma solo
alla vita, quando distrugge il fenomeno individuale”.
Come sarebbe possibile, allora, a recidere alla radice la Volontà di vivere?
Una prima modalità è data dall’arte: grazie alla contemplazione estetica un individuo, proprio
perché coglie la bellezza in sé (bellezza platonica) al di là dello spazio e del tempo, si libera da tutto
ciò che è tornaconto, interesse, utilità individuale, volontà di possesso.
Ma il godimento estetico dura ben poco.
Si tratta, infatti, di una “consolazione provvisoria”.
Una seconda modalità è data dalla “compassione” [Mitleid]: il condividere (“patire con”)
intensamente le sofferenze altrui.
Ma in questo modo il dolore non si riduce, ma cresce.
In questo modo il saggio esce dal guscio del suo egoismo, dalla sua volontà di fare degli altri dei
mezzi per i suoi fini.
Un altro freno all’egoismo è rappresentato dalla virtù della “giustizia”. Questa, tuttavia, ha solo una
valenza negativa: non fare del male agli altri. Una valenza positiva, invece, si trova nell’amore.
Ma l’amore è sempre figlio dell’istinto sessuale e, di conseguenza, della Volontà di vivere.
Schopenhauer parla in questo caso dell’amore non nel senso di “eros”, ma di carità, di “agape”, di
amore cristiano, di un amore cioè disinteressato.
L’amore di chi dedica la sua vita agli ultimi della Terra: penso a Madre Teresa di Calcutta.
Sì: un amore puro, spogliato da ogni interesse. Un amore non fondato su una “pretesa dignità” di un
altro uomo, ma sulla “compassione”: è questa che ci consente di simpatizzare con lui perché
condividiamo insieme la stessa situazione di dolore. Il saggio, poi, può e deve puntare ancora più in
alto: abbracciare la castità e la povertà, accogliere con gioia ogni offesa come un’opportunità per
umiliare il suo attaccamento alla Volontà di vivere, ricambiare il male con il bene…
Un modello di vita accessibile solo ai santi.
Ma è proprio il saggio che deve diventare santo, anche con i digiuni, la macerazione, l’autoflagellazione “per sempre più spezzare ed uccidere” [mehr und mehr zu brechen und zu tödten] la
volontà in quanto “fonte della dolorosa esistenza propria e del mondo”.
L’ascesi.
Certo. È l’ascesi, secondo Schopenhauer, la vetta su cui deve salire, seppure con grande sacrificio, il
saggio: arrivare a estirpare ogni desiderio (dal sesso ai beni materiali al corpo).
Approdando di fatto al… nulla.
Sì, qualcosa di simile Nirvana dei buddhisti. Un nulla che è assenza di dolore, assenza di
inquietudine, imperturbabilità.
La meta indicata dall’epicureismo e dallo stoicismo.
Sì. La stessa meta indicata da Spinoza.
La filosofia come terapia, come liberazione dal dolore, dal turbamento.
La filosofia come “redenzione”. Schopenhauer, ricorrendo al linguaggio cristiano, vede nell’asceta
l’uomo in stato di “grazia”, l’uomo… redento.
Un uomo che si redime da solo.
Già, la redenzione viene dall’uomo stesso.
In qualche misura, quindi, il pessimismo di Schopenhauer non è poi così nero.
È nerissimo, ma la vita si deve pur vivere. Non bastano le lamentazioni sul vivere di cui la
letteratura mondiale è ricca: occorre andare oltre.
Ma la proposta di Schopenhauer è di fatto una fuga dalla vita.
È una fuga quella di chi si ostina a non vedere la realtà (lo sconfinato mare in burrasca) rimanendo
aggrappato alla sua barchetta.
Ma la volontà di lacerare il velo di Maja e di intraprendere il percorso che conduce all’ascesi
implica che l’individuo sia libero, ma mi pare difficile riconoscere la libertà dentro una concezione
monistica della realtà.
Effettivamente Schopenhauer nega il libero arbitrio: le nostre azioni sono determinate
necessariamente, in ultima analisi, dal nostro “carattere”. Così scrive: “l’intero corso empirico della
vita di un uomo, in tutti i suoi eventi, grandi e piccoli, è necessariamente predeterminato, come il
corso di un orologio”. Del resto, aggiunge, “i grandi pensatori di tutti i tempi, e perfino i dottrinari
religiosi più profondi” hanno negato la libertà.
Si tratta, comunque, di un’incoerenza.
Una incoerenza che caratterizza tutte le forme di monismo. Il nostro si permette di dire con ironia
che il problema del libero arbitrio “è uno dei balocchi più cari ai professori di filosofia”.
Un “debito”
Mi è difficile esprimere un bilancio. Schopenhauer mi affascina come scrittore (estremamente
suggestive sono alcune sue immagini), ma come filosofo no: il suo pessimismo è unilaterale,
ossessivo, martellante. Si sa che il dolore accompagna l’uomo, ma la vita non è solo dolore.
Il nostro non lo nega affatto: se - precisa - si guarda la vita dell’individuo “nel suo complesso […] è
sempre una tragedia [ein Trauerspiel), mentre se la si esamina nei particolari “ha il carattere di una
commedia” [hat es den Charakter des Lustspiel).
È meglio, allora, guardare ai particolari, alle gioie e ai dolori di tutti i giorni.
“I desideri non appagati, le aspirazioni frustrate, le speranze spietatamente calpestate dal destino, i
funesti errori di tutta la vita, col crescente soffrire e la morte alla fine, danno sempre una tragedia”.
Tutto dipende dall’accento che si vuole dare.
Già. Sono numerose le persone che vedono l’esistenza come un “dono”. Schopenhauer, invece, la
vede come un “debito” (Schuld), un debito contratto da proprio genitore (“nel godimento della
voluttà”), per estinguere il quale ci vuole una vita intera. O meglio, coi nostri “impellenti bisogni” e
i “desideri tormentosi” di ogni giorno, noi cancelliamo solo gli interessi. È solo con la morte che
versiamo il capitale.
Vedo una sintonia con la condanna biblica all’espiazione del peccato originale.
Lo afferma lo stesso Schopenhauer: egli ritiene che la dottrina del peccato originale sia “la grande
verità” [die große Wahrheit] che rappresenta “il nucleo del cristianesimo”.
Vedo anche, dopo tante stroncature, una rivalutazione, pur dentro una visione diversa della vita,
del cristianesimo.
Una rivalutazione, più propriamente, di una certa interpretazione del cristianesimo: la condivisione
della sofferenza altrui, la mortificazione della carne, “il morire alla volontà individuale e la rinascita
in Dio”.
Lo stesso amore che è il messaggio centrale del cristianesimo.
Un amore non fondato sull’uguaglianza degli uomini in quanto tutti figli dello stesso Padre, ma sul
fatto che condividiamo tutti lo stesso destino di dolore: “ogni vero e puro amore è compassione”
[alle wahre und reine Liebe ist Mitleid].
Una sintesi, quindi, di sapienza orientale e di sapienza cristiana.
Infatti. Una condivisione che va oltre la specie umana perché abbraccia tutti gli esseri viventi.
Anche gli animali, secondo il cristianesimo, sono creature di Dio.
L’ha ben testimoniato S. Francesco. Questi, anzi, ha abbracciato l’intero creato: dal fratello Sole
alla sorella Luna.
La sintonia col cristianesimo, indubbiamente, c’è, ma la mia impressione è che il messaggio
cristiano, dentro l’impianto ideologico di Schopenhauer, muoia: il cristianesimo è un inno alla vita,
il nostro invece teorizza la rinuncia alla gioia di vivere.
Non è proprio così: la massima gioia, secondo lui, è la “pace imperturbabile”, la “calma profonda”,
l’“intima serenità” a cui punta il saggio. Così il nostro: “ogni appagamento strappato al mondo è
solo come l’elemosina, che tiene oggi in vita il mendicante perché soffra di nuovo la fame domani;
mentre la rassegnazione è come il podere ereditato: sottrae per sempre il possessore a tutte le
preoccupazioni”.
Ma senza preoccupazioni la vita si spegne.
Ne è consapevole lo stesso Schopenhauer. Così scrive: “se si trasportasse questa schiatta in un paese
di Cuccagna, dove tutto crescesse da sé e i piccioni volassero intorno già arrostiti, dove anche
ciascuno trovasse immediatamente la sua amata prediletta, e la ottenesse senza difficoltà: - allora gli
uomini, in parte, morirebbero dalla noia o si impiccherebbero, in parte, invece, si combatterebbero,
scannerebbero e assassinerebbero a vicenda per procurarsi in tal modo più dolore di quanto gliene
imponga la natura”. La stessa religione, secondo lui, è radicata nell’esigenza di sconfiggere la noia.
Schopenhauer allora si contraddice.
No. Il nostro si riferisce al comportamento della gente comune, non ai saggi, non ai santi.
Una cosa mi pare certa: Schopenhauer smentisce categoricamente l’interpretazione del
materialismo storico.
Eppure c’è stato chi l’ha collegato alla borghesia. Il materialismo storico può, indubbiamente,
essere un’utile chiave di lettura, ma può anche trasformarsi in una sorta di “violenza idealistica”.
Più promettente mi sembra l’analisi accurata della storia personale di un autore.
Un’analisi che la psicoanalisi estenderà addirittura all’inconscio.
È qui, nella storia personale dell’autore più che nella struttura economico-sociale del tempo in cui
vive, che possiamo rintracciare la genesi del suo pensiero.
Il suo carattere, la sua scoperta della sapienza orientale, la sua aggressiva ostilità nei confronti di
Hegel, la sua stessa denuncia della insincerità di tutti gli idealisti.
Ma siamo proprio certi che Schopenhauer sia stato sincero?
Vi è chi l’ha dubitato: non è un caso, è stato detto, che il nostro non abbia per nulla percorso la via
dell’ascesi.
Ha predicato bene, ma ha razzolato male.
Già. Vi è chi l’ha stroncato: Nietzsche, ad esempio, l’ha definito uno scrittore che non voleva
conoscere, ma che cantava sempre la sua canzone; il grande romanziere russo, Tolstoj, invece, l’ha
considerato il più grande pensatore del mondo.
A mio modesto avviso, Schopenhauer non è stato né l’uno né l’altro.
Piero Carelli