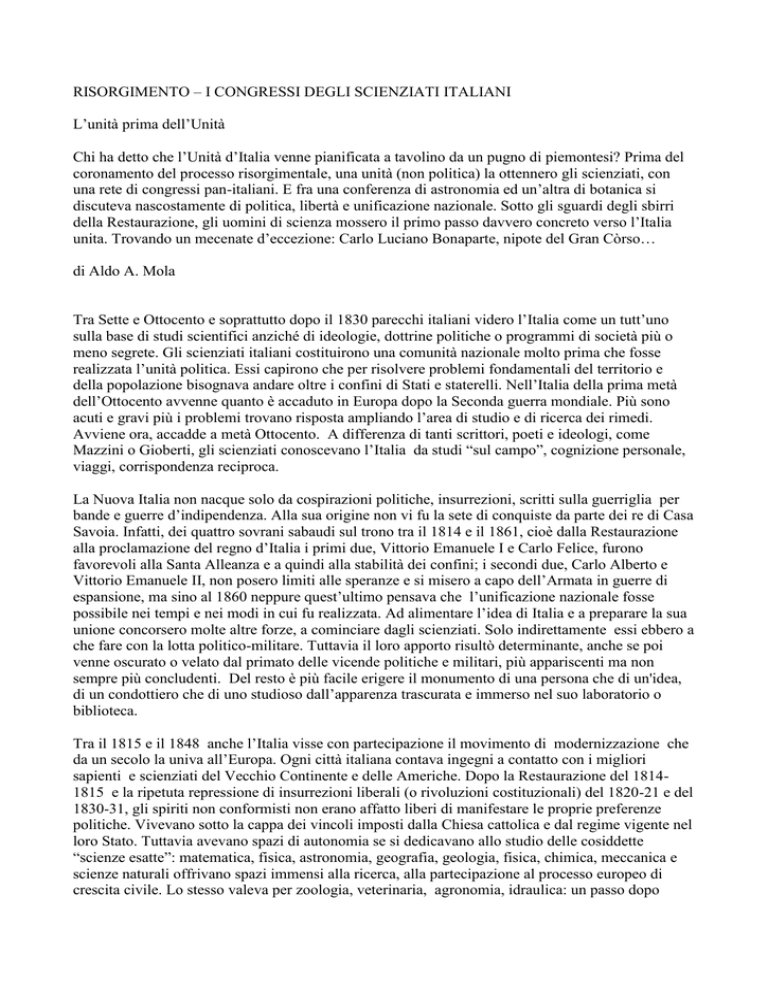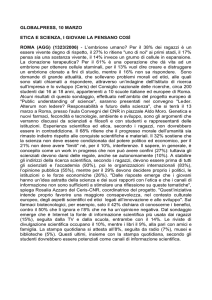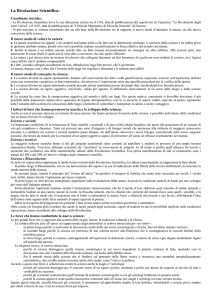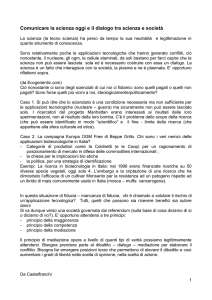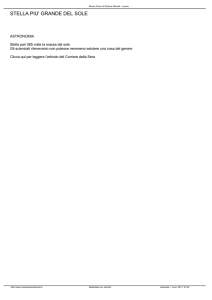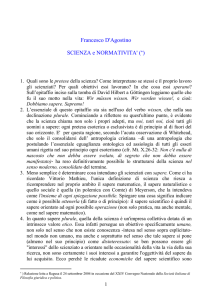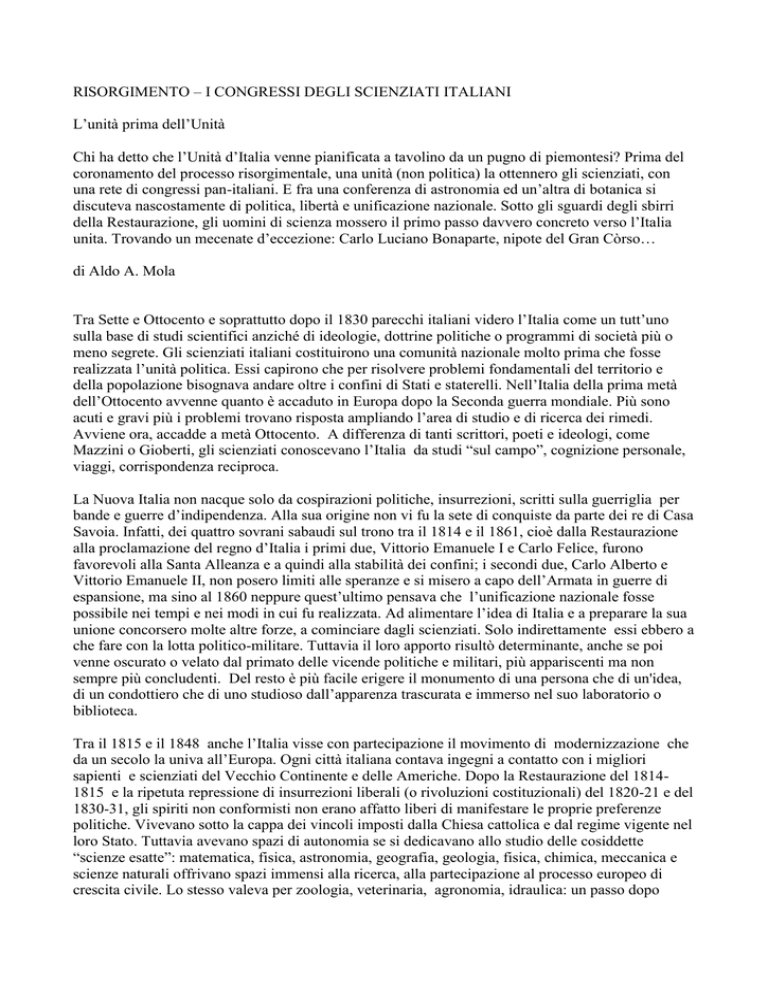
RISORGIMENTO – I CONGRESSI DEGLI SCIENZIATI ITALIANI
L’unità prima dell’Unità
Chi ha detto che l’Unità d’Italia venne pianificata a tavolino da un pugno di piemontesi? Prima del
coronamento del processo risorgimentale, una unità (non politica) la ottennero gli scienziati, con
una rete di congressi pan-italiani. E fra una conferenza di astronomia ed un’altra di botanica si
discuteva nascostamente di politica, libertà e unificazione nazionale. Sotto gli sguardi degli sbirri
della Restaurazione, gli uomini di scienza mossero il primo passo davvero concreto verso l’Italia
unita. Trovando un mecenate d’eccezione: Carlo Luciano Bonaparte, nipote del Gran Còrso…
di Aldo A. Mola
Tra Sette e Ottocento e soprattutto dopo il 1830 parecchi italiani videro l’Italia come un tutt’uno
sulla base di studi scientifici anziché di ideologie, dottrine politiche o programmi di società più o
meno segrete. Gli scienziati italiani costituirono una comunità nazionale molto prima che fosse
realizzata l’unità politica. Essi capirono che per risolvere problemi fondamentali del territorio e
della popolazione bisognava andare oltre i confini di Stati e staterelli. Nell’Italia della prima metà
dell’Ottocento avvenne quanto è accaduto in Europa dopo la Seconda guerra mondiale. Più sono
acuti e gravi più i problemi trovano risposta ampliando l’area di studio e di ricerca dei rimedi.
Avviene ora, accadde a metà Ottocento. A differenza di tanti scrittori, poeti e ideologi, come
Mazzini o Gioberti, gli scienziati conoscevano l’Italia da studi “sul campo”, cognizione personale,
viaggi, corrispondenza reciproca.
La Nuova Italia non nacque solo da cospirazioni politiche, insurrezioni, scritti sulla guerriglia per
bande e guerre d’indipendenza. Alla sua origine non vi fu la sete di conquiste da parte dei re di Casa
Savoia. Infatti, dei quattro sovrani sabaudi sul trono tra il 1814 e il 1861, cioè dalla Restaurazione
alla proclamazione del regno d’Italia i primi due, Vittorio Emanuele I e Carlo Felice, furono
favorevoli alla Santa Alleanza e a quindi alla stabilità dei confini; i secondi due, Carlo Alberto e
Vittorio Emanuele II, non posero limiti alle speranze e si misero a capo dell’Armata in guerre di
espansione, ma sino al 1860 neppure quest’ultimo pensava che l’unificazione nazionale fosse
possibile nei tempi e nei modi in cui fu realizzata. Ad alimentare l’idea di Italia e a preparare la sua
unione concorsero molte altre forze, a cominciare dagli scienziati. Solo indirettamente essi ebbero a
che fare con la lotta politico-militare. Tuttavia il loro apporto risultò determinante, anche se poi
venne oscurato o velato dal primato delle vicende politiche e militari, più appariscenti ma non
sempre più concludenti. Del resto è più facile erigere il monumento di una persona che di un'idea,
di un condottiero che di uno studioso dall’apparenza trascurata e immerso nel suo laboratorio o
biblioteca.
Tra il 1815 e il 1848 anche l’Italia visse con partecipazione il movimento di modernizzazione che
da un secolo la univa all’Europa. Ogni città italiana contava ingegni a contatto con i migliori
sapienti e scienziati del Vecchio Continente e delle Americhe. Dopo la Restaurazione del 18141815 e la ripetuta repressione di insurrezioni liberali (o rivoluzioni costituzionali) del 1820-21 e del
1830-31, gli spiriti non conformisti non erano affatto liberi di manifestare le proprie preferenze
politiche. Vivevano sotto la cappa dei vincoli imposti dalla Chiesa cattolica e dal regime vigente nel
loro Stato. Tuttavia avevano spazi di autonomia se si dedicavano allo studio delle cosiddette
“scienze esatte”: matematica, fisica, astronomia, geografia, geologia, fisica, chimica, meccanica e
scienze naturali offrivano spazi immensi alla ricerca, alla partecipazione al processo europeo di
crescita civile. Lo stesso valeva per zoologia, veterinaria, agronomia, idraulica: un passo dopo
l’altro, dal cielo stellato si passava all’allevamento del bestiame, ai canali irrigui, alla produzione
cerealicola, al mercato, all’amministrazione locale, all’uomo, insomma, alla “politica”, che era il
punto obbligato di riferimento di qualsiasi scienza. Bastava guardare la carta geofisica dell’Europa
per vedere la realtà dell’Italia. Ma non era opportuno dirlo. Meglio, allora, parlare del quadro
anziché della cornice, degli italiani anziché dell’Italia, dei colori anziché del pittore... Il tempo
avrebbe fatto il suo corso e la verità dei fatti si sarebbe affermata da sé.
Nel 1815, appena chiuso il ventennio di guerre, il chimico ginevrino Henry Albert Gosse
organizzò in Svizzera un congresso di studiosi di scienze fisiche e naturali. L’esempio venne
imitato in Germania, Gran Bretagna, Francia e Belgio. Gli scienziati comunicavano, si radunavano,
ragionavano insieme, pubblicavano e si scambiavano i risultati delle ricerche. Rivivevano la
Repubblica delle Lettere in forma di comunità scientifica universale, quando il mondo era l’Europa
e i suoi filosofi parlavano di ragion pura, ragion pratica e ragione morale identificando il loro io con
l’umanità di tutti i tempi e paesi. Anche nel Settecento i sovrani avevano incoraggiato e protetto
Università e accademie, ma l’età napoleonica aveva spezzato gli argini degli Stati dinastici e
avviato un percorso nuovo con esiti irreversibili. I governi della Restaurazione cercarono ancora di
imbrigliare la ricerca scientifica in subordine agl’interessi dei singoli Stati, ma proprio la corsa al
progresso delle scienze e della loro applicazione attraverso la tecnologia favorì la circolazione delle
informazioni e la collaborazione tra studiosi.
Anche molti scienziati italiani presero parte al movimento che pose la ricerca al di sopra dei calcoli
di potere dei singoli Stati. Il primo a promuovere in Italia un congresso degli scienziati fu Carlo
Luciano Bonaparte, principe di Canino (1803-1857). Suo padre, Luciano [vedi “Storia in Rete” n°
54 NdR], era stato il vero artefice del colpo di Stato che il 18 brumaio 1799 aveva aperto a
Napoleone la via trionfale. Il primogenito, Carlo Luciano, si appassionò alle scienze naturali. Nel
1837 fu lui a convincere Leopoldo II di Asburgo-Lorena a ospitare un congresso di scienziati
italiani nel Granducato di Toscana: l’adunata non era politicamente pericolosa e dava lustro.
Organizzare un congresso era un’impresa enorme. Occorreva avere da tempo e istituire nuovi
innumerevoli contatti qualificati per assicurarsi la partecipazione di luminari indiscutibilmente
prestigiosi e assicurarsi il successo di forma e di sostanza. Bisognava individuare il luogo ideale nel
quale radunarsi e, soprattutto, avere il favore o almeno il benestare di un sovrano che aprisse i
confini alla partecipazione di “stranieri”, vale a dire di studiosi provenienti da vari paesi europei e
da quelli in cui era suddivisa l’Italia: basti ricordare che l’area liguro-tosco-romagnola comprendeva
sei diversi Stati, senza un sistema integrato di vie di comunicazione e di porti, a tacere di ferrovie,
ancor tutte da avviare. Ma il principe Bonaparte riuscì nell’impresa.
Il primo congresso degli scienziati italiani fu inaugurato il 1° ottobre 1839 a Pisa, città universitaria
per eccellenza, memore di Galileo Galilei. Vi affluirono 421 iscritti. Il Cancelliere dell’Impero
d’Austria, Metternich, denunciò subito che quell’adunanza era un pericolo per la pace, cioè per il
predominio asburgico su un’Italia immobile. Aveva ragione. Uno dei partecipanti, Mariano
d’Ayala, scrisse che a Pisa “per la prima volta si affermava solennemente l’unità della patria”. Il
guanto era gettato. Era possibile governare contro la scienza o gli scienziati? Molte plaghe d'Italia
erano cantieri. Il Lombardo-Veneto pullulava di manifatture d'avanguardia. Nel rapporto macchineaddetti esse gareggiavano per produttività con quelle delle regioni europee da più tempo
industrializzate. Scienza, tecnologia e artigianato erano tutt’uno con invenzioni, esperimenti, con il
desiderio di fare che alla fine si sintetizza in una sola parola: libertà o, almeno, un po’ più di libertà.
Messa in moto, la macchina dei congressi degli scienziati non s’arrestò più. A Pisa Bonaparte fece
approvare per acclamazione il ringraziamento al “sovrano illuminato” che aveva consentito “la
riunione italiana dei dotti” e l’impegno a ritrovarsi nel 1840 a Torino e due anni dopo a Firenze.
Quasi di sfuggita, a Pisa si parlò anche dell'utilità di una unione doganale tra gli Stati italiani. Un
qualunque prodotto agroalimentare o manifatturiero per andare dalle Due Sicilie a Torino o dal
Veneto alla Toscana doveva passare per Legazioni pontificie e Ducati e doveva pagare tre o quattro
volte un dazio che gravava sul prezzo di vendita, soffocava il mercato, stringeva le caviglie
dell’economia con ceppi medievali. Scoraggiare la circolazione delle merci significava anche
rendere più ardui gli approvvigionamenti in caso di speciali necessità: le ricorrenti carestie causate
da fattori climatici che nessun governo era in grado di fronteggiare o la diffusione di epidemie,
come il colera che dilagò nel 1835. Persino in Toscana, la cui agricoltura vantava una tradizione
fondata anche su Accademie di prestigio, come quella dei Georgofili (Amanti dell’Agraria), il
rapporto tra semina e raccolto per i cereali, frumento in testa, era appena di uno a cinque o sei.
Detratta la scorta per la semina ventura e quanto andava perduto per cattiva conservazione, il
prodotto annuo utile al consumo annuale consentiva scarna sopravvivenza. Fatti tutti i calcoli, nel
migliore dei casi da ogni chicco seminato se ne ottenevano tre o quattro, con tanta fatica e senza
contare gli oneri gravanti sulla proprietà. L’agricoltura era un lusso... Bisognava dunque migliorare
idraulica, scienze agrarie e veterinarie e propiziare il mercato attraverso intese doganali: lo si
volesse o no, da scientifico e tecnico il problema diveniva politico.
Il contrasto tra i congressi degli scienziati italiani e i fautori dell’immobilismo politico emerse
subito. Il governo dello Stato Pontificio e del regno delle Due Sicilie vietarono ai loro sudditi di
parteciparvi. Quello di Torino ne seguì i lavori con apprensione. La filosofia che li ispirava era stata
enunciata quasi dieci anni prima dal profugo dalmata Niccolò Tommaseo in un articolo pubblicato
dall`“Antologia” di Firenze. A sua volta Enrico Mayer additò a modello la “missione del dotto”
trionfante in Germania: i tedeschi mancavano di unità politica, ma la costruivano proprio con
l’associazione degli studiosi e, sul piano economico, con la lega doganale, potente acceleratore per
la diffusione del benessere. La conferma venne con il secondo congresso, forte di 573 membri.
Radunato a Torino nel 1840, sul modello del precedente ebbe sezioni di medicina, zoologia,
botanica e fisiologia vegetale, geologia, mineralogia e geografia, chimica, fisica e scienze
matematiche. Nulla di politico. Furono evitati temi economici e i progetti di leghe doganali che pur
erano nell'aria. I lavori furono presieduti da Alessandro Saluzzo di Monesíglio, dominus della
Regia Accademia delle Scienze e autore dell'“Histoire milítaíre du Piémont”. Carlo Alberto
presenziò all’inaugurazione dei lavori. A quel modo sottrasse al granduca di Toscana l'aureola di
solo principe illuminato d’Italia e il ruolo di unico punto di riferimento dei dotti. Cinque anni prima
il Regno di Sardegna era stato colpito dal colera. Il contagio vi era giunto da Nizza Marittima. Per
scongiurarne la diffusione i governi imponevano a persone e merci in arrivo da territori colpiti dal
morbo, o nei quali ne fosse anche solo sospettato qualche focolaio, di attendere al confine che
trascorresse il periodo di possibile, incubazione della malattia (la “quarantena”). Misure di quel
genere erano però arcaiche e ormai incompatibili con il volume e la velocità di circolazione degli
uomini e degli scambi commerciali. Molto meglio combattere l'epidemia alla radice con misure di
pubblica igiene, piani regolatori adeguati, approvvigionamento idrico, rete fognaria, allestimento di
ospedali e persino riforma carceraria per evitare che i luoghi di pena, ove i condannati vivevano
quasi sempre in condizioni igieniche disastrose, divenissero centri d'infezione incontrollabili. Per
venirne a capo occorrevano però la diffusione dei risultati della ricerca scientifica e l’adozione di
misure simultanee da parte di tutti i governi, a cominciare da quelli dell’Italia. Cacciata dalla porta,
la necessità del coordinamento fra gli Stati e di qualche pur piccolo passo sulla via di una loro lega
o federazione o unione rientrava dalla finestra. A imporla era la ricerca della “pubblica felicità”, che
anche i sovrani politicamente più retrivi dichiaravano di voler conseguire.
I congressi degli scienziati italiani dettero i loro frutti nel volgere di appena un decennio, perché
seminavano su un terreno fertile. A Torino venne vietata la partecipazione di quanti avessero subito
condanne politiche e fu ostacolato l’afflusso di studiosi di orientamento liberale. Il terzo congresso
(Firenze, 1841) contò quasi novecento partecipanti, che al termine dei lavori deliberarono di erigere
una statua a Galileo Galilei, “vittima dell'oscurantismo” e simbolo della contrapposizione fra libertà
di ricerca e ottusità del potere. Anni dopo il clericale e conservatore piemontese Clemente Solaro
della Margarita scrisse che i congressisti in pubblico parlavano di scienze e di arti, ma in privato
affrontavano “affari di ben altra importanza (...); s’affratellarono, strinsero amicizia, stabilirono corrispondenze, si confermarono le speranze, si prepararono a travagliar concordi per essere tutti uniti
dalle Alpi al Faro per il gran giorno del sospirato risorgimento...”. Dunque gli scienziati italiani
cospiravano alla luce del sole, come facevano architetti, scultori, pittori, scrittori, poeti,
compositori, artisti e attori. E’ facile imprigionare persone; è invece impossibile alzare muri contro
la diffusione di idee, che viaggiano con le merci e anzi alzano la voce quando queste non arrivano.
Perciò Massimo d’Azeglio dal 1845 disse e scrisse che bisognava finirla con le sette, i pugnali, gli
attentati. Lo spartiacque era l’Idea di Italia.
Nel 1842 il quarto Congresso degli scienziati ebbe sede a Padova, la città del Santo, di una
prestigiosa università e di una comunità israelitica celebre in Europa per alta cultura. Più di Venezia
e in gara con Verona, Padova era crocevia dei traffici tra Lombardo-Veneto ed Emilia-Romagna.
Un punto nevralgico. Vienna fece buon viso alla sfida ma intralciò l’affluenza, che si ridusse a 514
iscritti. L’anno seguente fu la volta di Lucca. Il duca, Carlo Ludovico di Borbone, non ne fu
entusiasta. I partecipanti scesero a meno di cinquecento. Il protomedico sabaudo Michele Griffa vi
denunziò l’orribile trattamento riservato da taluni governi ai prigionieri politici. Il pensiero dei
congressisti corse alle carceri nelle quali languivano i liberali delle Due Sicilie, segregati da
Ferdinando II di Borbone. Dieci anni dopo la pubblicazione delle “Mie prigioni” di Silvio Pellico,
Griffa fece anche esplicito riferimento allo Spielberg. Irruppe a vele spiegate sul terreno della
politica che i promotori avevano promesso di evitare. Perciò fu escluso dai lavori ed espulso dal
Ducato. Era proprio quel che voleva. Infatti il principe Bonaparte si batté in sua difesa e ne fece un
caso europeo di libertà di pensiero. Lo Spielberg era il carcere nel quale l’Austria chiudeva i
patrioti non solo italiani ma di tutte le nazioni oppresse. I congressisti presero posizioni più nette. I
geologi e i mineralogisti, per esempio, affermarono che per la sua conformazione l’Italia era “per
certo destinata più d’ogni altra nazione a rappresentare una unità, o, se si mira ai bacini parziali o
secondari, è modellata anche a farne un insieme di parti diverse bensì, ma in bello e saldo ordine”:
federazione, dunque, se non Stato unitario. A Lucca gli scienziati s’occuparono anche del commercio di libri, prospettando l'opportunità di una fiera nazionale annuale del libro. Nel sesto
congresso, a Milano (1844), i partecipanti ufficiali balzarono a 1.159, il triplo di quanti s'erano
raccolti a Pisa nel 1839, ma i lavori coinvolsero altre centinaia di persone, migliaia di
corrispondenti e furono seguiti da riviste italiane e straniere. Un successo enorme. Nella capitale
ambrosiana venne proposta l’istituzione di un “deposito di vini per incoraggiare la produzione
nazionale e per disvezzare gli animi dallo stranierismo”. Sempre protagonista, Carlo Luciano
Bonaparte rivendicò l’ italianità dei vini della Corsica. Era la via indiretta per ribadirne
l’appartenenza geostorica all’Italia. Aggiunse: “I còrsi sono nazionali e italiani, come i lombardi.
Quale colpa è la loro se soggiacciono a straniero dominio? Qual è di noi che negherebbe il bacio di
fratelli e il suo soccorso ai lombardi, qualora lo richiedessero per liberarsi alla schiavitù?” Parole
esplosive. Affermare l’italianità della Corsica comportava l’interrogativo sull’unità dell’Italia e
sugli Stati che la impedivano: non solo l’Austria, ma anche la Francia di Luigi Filippo che nel 183031 aveva abbandonato i liberali italiani alla repressione austro-pontificia e al capestro del duca di
Modena.
Il settimo congresso degli scienziati italiani si svolse a Napoli nel 1845. Ferdinando II di
Borbone aveva aperto la strada ferrata da Napoli a Portici e proteggeva manifatture di prestigio
(lavoravano soprattutto per la corte e il notabilato) ma diffidava della libertà di pensiero, sia pure
nella veste di ricerca scientifica. Non presenziò ai lavori. Il principe di Canino l’aveva indotto a
ospitare i lavori ma tra l’assenso e l’adunanza v’erano state la feroce repressione dell'ennesima
cospirazione liberale e la fucilazione dei fratelli Attilio ed Emilio Bandiera nel vallone di Rovito, a
Cosenza. Erano i figli di un contrammiraglio della Marina asburgica. L’idea di Italia separava i figli
dai padri. A Napoli i partecipanti furono circa mille e seicento. Secondo Francesco De Sanctis quel
settimo congresso preluse alla rivoluzione del Quarantotto. Vi intervennero Giuseppe Montanelli e
Atto Vannucci, Angelo Brofferio e Giacinto Collegno, Matteucci, Salvagnoli e persino don Enrico
Napoleone Tazzoli, mazziniano, cospiratore, impiccato nel 1852 agli spalti di Belfiore, a Mantova:
martire nella lotta per le libertà. [1 – continua]
Aldo A. Mola
[email protected]