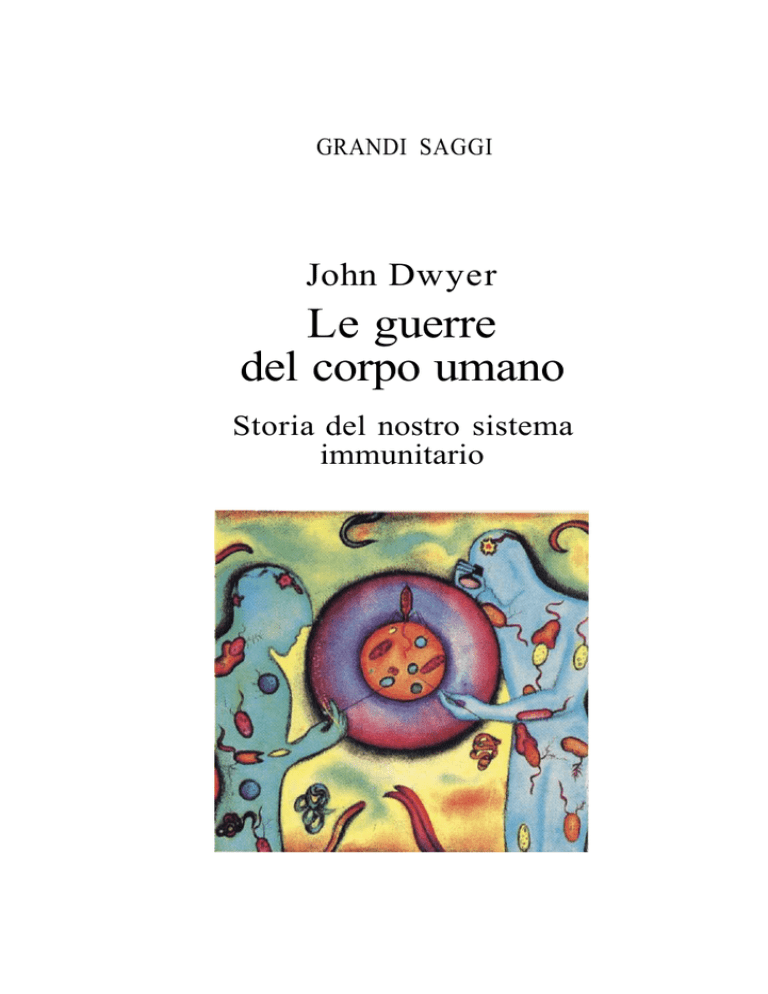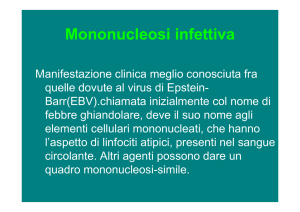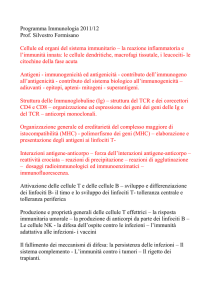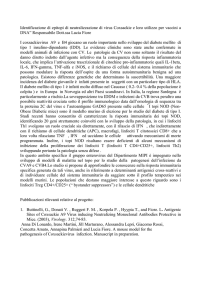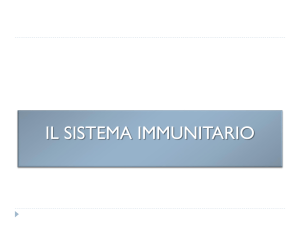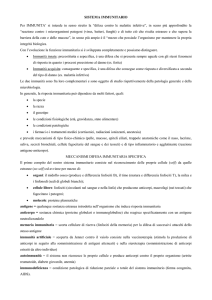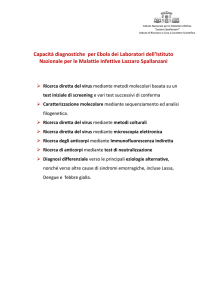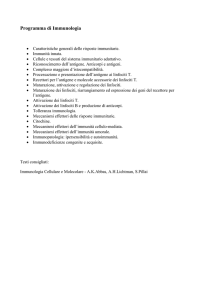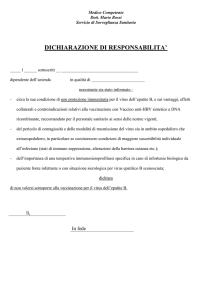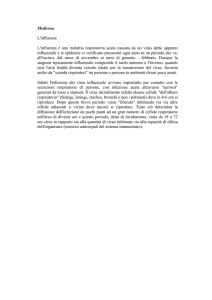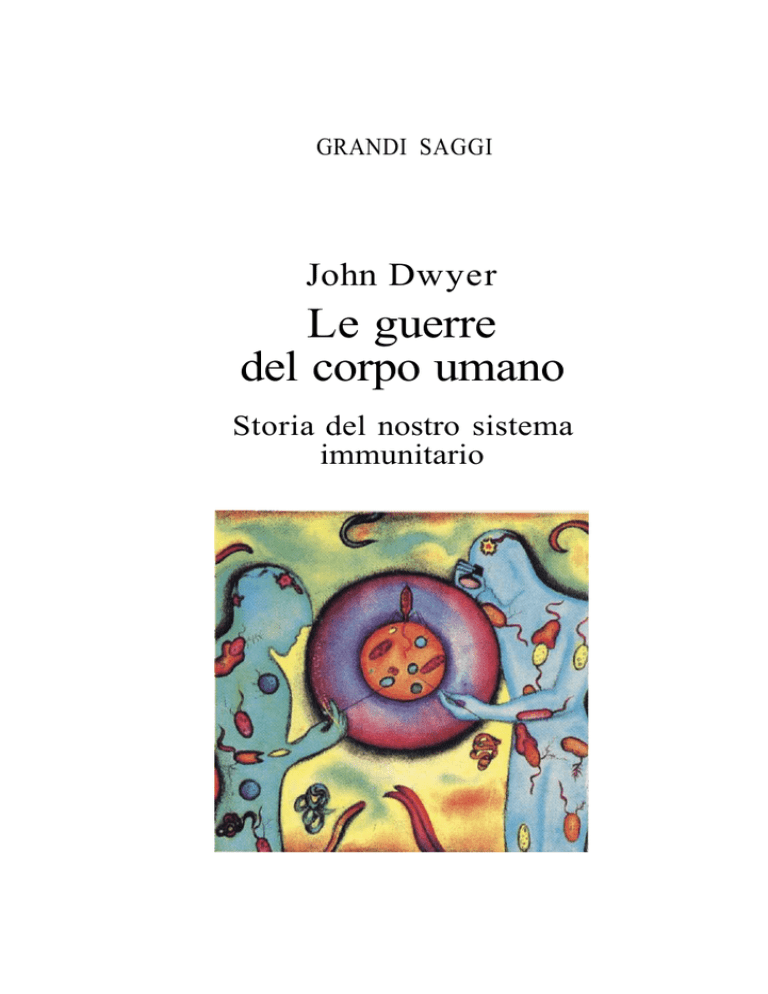
GRANDI SAGGI
John Dwyer
Le guerre
del corpo umano
Storia del nostro sistema
immunitario
John Dwyer
Le guerre del corpo umano
Storia del nostro sistema immunitario
Traduzione di Lucia Maldacea
Arnoldo Mondadori Editore
Introduzione
Quasi sempre, chi scrive libri si profonde nell'introduzione
in ringraziamenti ai familiari. L'abitudine è talmente inveterata che, quando un autore vi si sottrae, si ha il sospetto
che non abbia una famiglia cui essere grato. Se mai avessi
pensato che quelle frasi di gratitudine fossero dettate più
dalla convenienza che dal fatto di riconoscere un merito
reale, il coinvolgimento che la stesura di quest'opera ha richiesto mi ha mostrato il contrario. Quando si è completamente assorbiti da una professione impegnativa, è molto
difficile trovare il tempo per scrivere un libro. Per l'autore,
può comunque trattarsi di una fatica che affronta con passione, ma ciò che la sua famiglia dà è, invece, una vera prova di amore. Tutto il tempo che, normalmente, egli dovrebbe trascorrere con i suoi, lo dedica in realtà a scrivere. Per
ben due anni i miei cari non hanno fatto altro che sentire la
solita scusa: «Devo pensare al libro». È per questo che a
mia moglie Catherine e ai miei figli Justin, Gabrielle e Christopher vanno tutto il mio affetto e la mia riconoscenza. È
merito loro se sono riuscito a giungere alla meta.
Tuttavia, non è a loro che dedico il libro. Lo dedico ai
miei pazienti: per trent'anni i malati e i deboli non hanno
fatto che insegnarmi quanto sano e forte sia lo spirito umano. Nella mia professione, curo individui colpiti da malattie
croniche: ho tratto ispirazione dal coraggio e dalla pazienza
che hanno dimostrato, oltre che dalla loro capacità di strutturare la qualità di una vita che, a prima vista, ha solo
5
quantità. Mi sento un privilegiato per aver potuto lavorare
con loro nel campo dell'immunologia. Nelle pagine che seguiranno verranno raccontate molte storie che li riguardano
e, per tale motivo, questo è il loro libro. Una parola di ringraziamento va, infine, alla Boehringer Ingelheim, che mi
ha concesso di utilizzare le magnifiche microfotografie elettroniche colorate al calcolatore, grazie alle quali si ha l'impressione di assistere a una vera e propria «lotta del corpo».
John M. Dwyer
Le guerre del corpo umano
Storia del nostro sistema immunitario
Prefazione
Immaginate di fare con me un salto indietro nel tempo e di
gironzolare in una fiera di paese nel Gloucester, in Inghilterra, nell'estate del 1794. Ci troviamo a poca distanza da
Londra, verso nord-ovest, e siamo naturalmente molto curiosi di vedere, per la prima volta, da vicino i nostri cugini
di due secoli fa. Le prime impressioni sono meno buone di
quelle che ci saremmo aspettate. Francamente, questi nostri
antenati avrebbero bisogno di un bel bagno e di una spruzzata di acqua di colonia. Hanno una statura inferiore alla
media attuale e molti hanno un aspetto malaticcio o denutrito. Osserviamo i loro volti, studiamo i movimenti del
corpo e guardiamoli negli occhi per cercare di sapere qualcosa di più sulla loro indole.
Ci impressiona la loro brutta carnagione e ci domandiamo, di fronte a tutte quelle facce sfigurate piene di cicatrici,
se per caso il 60-70 per cento della popolazione abbia sofferto di una grave forma di acne.
In un recinto a lato della strada si sta svolgendo una competizione chiassosa. Incitate dalla folla, alcune mungitrici
fanno a gara per riempire il più rapidamente possibile di
latte fresco dei secchi, e spremono con gran lena le mammelle di alcune vacche che recalcitrano. I visi giovani e ardenti di queste ragazze vivaci e piene di energia sono belli:
hanno un colorito sano e non mostrano quelle deturpazioni
rilevate nella popolazione in generale. Perché, ci domandiamo, esse hanno una pelle così splendente?
9
Per molti anni la stessa domanda arrovellò la mente di
Edward Jenner. In questo medico del Gloucestershire la
sensibilità per la bellezza, la capacità di osservazione e il ragionamento deduttivo si unirono per produrre una grande
scoperta medica, capace di dare una risposta a quell'interrogativo e di salvare milioni di individui non solo dalle deturpazioni estetiche, ma anche da una morte prematura.
Per capire bene che cosa realmente si sia mosso nel suo
intelletto, dobbiamo abbandonare l'atmosfera festosa della
fiera e spostarci di un paio di miglia verso sud per andare a
fare visita a uno dei suoi pazienti. Billy Smythe, 12 anni,
sembra abbastanza in buona salute, anche se non gli farebbe male qualche chilo in più. Il suo aspetto non è molto diverso da quello degli altri bambini che circolano nella fattoria e che aiutano i genitori a lavorare la terra del padrone,
tuttavia, se si osserva Billy più da vicino, si nota che il suo
viso ha un colorito acceso, non del tutto normale. Se gli ponessimo una domanda precisa, risponderebbe di non sentirsi affatto bene.
Per tutto il giorno ha avuto male di testa e dolori alla
schiena. Tuttavia ha continuato a ripetersi che non valeva
la pena di preoccuparsi e soprattutto che la sua era una cosa
ben diversa da quella che era capitata a Emily, la sua cuginetta. Due settimane prima, Emily stava giocando in casa e
sembrava piena di energia e di buon umore: ballava con lui
attorno al tavolo della cucina, mentre papà Smythe suonava il violino. Finito di ballare, venne colta da un prolungato
attacco di tosse, ma non sembrava che stesse veramente male. Billy, invece, aveva poi saputo che era «gravissima».
Morì, infatti, sei giorni dopo e Billy le sopravvisse soltanto di due giorni.
Poveretti entrambi! Come milioni di esseri deboli prima
di loro, erano caduti vittime di un minuscolo nemico a forma di barretta, invisibile. E fu proprio Emily a consegnare
il cugino nelle sue mani: tossendogli in faccia, gli aveva
proiettato addosso milioni di minuscoli aggressori turbinanti nell'aria. Fu sufficiente che Billy inspirasse perché
10
quegli esserini devastanti gli penetrassero nei polmoni e
quindi nella circolazione sanguigna, localizzandosi nel fegato e nelle ghiandole linfatiche e moltiplicandosi a parecchie
riprese dentro le cellule fino a farle scoppiare, così da potersi propagare nella parete dei vasi sanguigni e nella cute. Il
corpo torturato di Billy fu assalito da febbri e dolori muscolari. Sulla pelle comparvero vesciche che si sarebbero poi
risolte in ulcerazioni purulente profonde, da cui l'agente infettivo si sarebbe propagato agli abiti, alla biancheria da
letto e perfino alla polvere sul pavimento. Qui l'agente infettivo sarebbe rimasto in agguato, in attesa di una nuova
vittima. I soggetti infettati da questo spietato nemico si indebolivano così rapidamente da poter essere assaliti da altri
agenti che penetravano nei loro polmoni, causando polmoniti e, di conseguenza, un lento soffocamento.
Non tutti coloro che erano impegnati nella lotta tra la vita e la morte con quel nemico invisibile uscivano, però,
sconfitti. Alcuni vincevano, sopravvivevano così da poter
raccontare la loro storia e combattevano nuove battaglie
con nuovi nemici. Le loro facce butterate testimoniavano il
loro successo su quel nemico che, in seguito, sarebbe stato
riconosciuto come virus del vaiolo.
Conoscendo questi antefatti, possiamo capire perché
Jenner rimase così attratto dall'eccezionale resistenza al
vaiolo di molte mungitrici, le quali non avevano bisogno di
combattere la malattia e quindi non correvano neppure il rischio di perdere. Per questo, molte spiccavano nella popolazione per la loro bellezza.
Jenner aveva avuto ragione di supporre che le mungitrici
non contraevano il vaiolo per un motivo che doveva essere
in qualche modo collegato con la malattia che, invece, le
colpiva. Le mucche che quelle ragazze mungevano avevano
spesso ulcerazioni aperte sulle mammelle e chi toccava queste parti infette contraeva una malattia, per la verità non
molto lunga né grave, nota popolarmente come vaiolo vaccino o vaiolo dei bovini. Jenner non sapeva perché, ma osservò che l'infezione con quel tipo di vaiolo, mentre aveva
11
una minima azione sfigurante, offriva una valida protezione contro il vaiolo umano.
Dopo una lunga serie di dibattiti sia tra medici sia con il
pubblico, riuscì a convincere la popolazione locale a lasciargli strofinare sulla cute dei bambini che non erano stati colpiti dal vaiolo un poco del materiale che aveva raccolto dalle ulcerazioni delle mucche. Aveva sentito parlare di inoculazione, cioè dell'introduzione in un organismo sano, generalmente per via sottocutanea, di materiale ottenuto da un
paziente affetto da una malattia per cercare di proteggerlo
da quella malattia. Lady Mary Wortley Montagu, una signora inglese che aveva viaggiato molto, aveva riportato
dal Medio Oriente resoconti di pratiche rischiose, attuate
dai turchi e da molti altri in quelle regioni, per proteggere
dal vaiolo. E sappiamo che i cinesi, fin dal V secolo a . C ,
praticavano l'inoculazione.
Da secoli, coloro che si interessavano della salute dell'uomo, fossero medici o stregoni, sapevano che la crosta formatasi su un'ulcerazione da vaiolo in via di guarigione poteva avere un'azione protettiva. Ma poteva anche avere,
purtroppo, un effetto letale. Se, una volta essiccata, veniva
introdotta mediante scarificazione nella cute (in Cina veniva inalata nei polmoni), al paziente che non aveva mai contratto prima un'infezione vaiolosa potevano accadere due
cose: o si formava una grossa ulcerazione nel punto dell'inoculazione e il paziente poteva essere colto da febbri, emicranie e malessere generale, sintomi che si prolungavano
per alcuni giorni, dopodiché egli riacquistava una salute
splendida, protetto per sempre dal vaiolo; oppure, l'inoculazione poteva provocare un attacco violento di vaiolo, con
formazione di ulcere, che lasciavano cicatrici deturpanti, o
addirittura con un esito letale. (Nel XVI secolo, in Turchia,
i padri insistevano perché le figlie si facessero vaccinare
contro il vaiolo, per proteggere la loro bellezza. Dato il rischio associato al procedimento, il fatto commenta da sé la
mentalità di quel paese, basata sulla discriminazione sessuale.)
12
Per capire in base a quale motivazione così tanta gente
non avesse alcuna esitazione a correre il rischio connesso
con l'inoculazione, si devono tener presenti le circostanze in
cui quelle persone vivevano. In molte zone, il 20 per cento
dei soggetti vaccinati avrebbe contratto il vaiolo dall'inoculazione stessa, ma senza vaccinazione la percentuale delle
vittime del vaiolo avrebbe superato spesso il 75 per cento. E
si poteva prevedere che, di quest'ultimo gruppo, circa il 60
per cento sarebbe morto.
Nella medicina antica, nulla era più apprezzato della
«polvere di vaiolo». Medici di qualsiasi tendenza la raccoglievano con cura e la conservavano come se si trattasse di
oro. In effetti, diversamente dalla gran parte dei medicamenti antichi, era davvero efficace.
Alcuni anni fa, dietro invito della United States Agency
for International Development, ho visitato numerosi paesi
dell'Africa occidentale, in qualità di consulente per vari
problemi. Nell'impossibilità di risolvere tutte le questioni
presentatemi in quella prima visita, ritornai da allora molte
volte per elaborare numerosi progetti.
A Bamako, la capitale del Mali, fui invitato a partecipare
a un importante convegno della Società di Medicina del
Mali, organizzato con l'unico scopo di dare al Ministro della Sanità l'opportunità di persuadere i guaritori tribali a
consegnare alle autorità sanitarie la loro polvere di vaiolo.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva sferrato
una vera e propria offensiva militare contro il vaiolo e aveva potuto dichiarare, come risultato dell'impegno con cui
erano state praticate le vaccinazioni su scala mondiale, che
la malattia era stata debellata. Le vaccinazioni potevano,
dunque, essere interrotte. Rimanevano, tuttavia, due potenziali fonti di reintroduzione della malattia. In alcuni laboratori moderni vi sono scorte di virus vivi a scopo di ricerca, mentre alcune migliaia di guaritori in Africa e in altri
paesi conservano notevoli quantità di polvere di vaiolo, in
cui, allo stato quiescente ma con una virulenza integra, permangono miliardi di virus. Dopo varie discussioni, fu chia13
ro che i guaritori tribali non avrebbero fatto ciò che veniva
loro chiesto. Avevano dovuto combattere il vaiolo da sempre e sempre avrebbero dovuto farlo in futuro: nulla li
avrebbe convinti a cedere quella loro medicina così potente.
La regione dell'Africa occidentale rimane, dunque, disseminata di queste «bombe a orologeria» biologiche.
Pur non sapendo che esistevano microrganismi in grado
di provocare malattie (si ricordi che non era stato ancora introdotto il concetto di infezione), Jenner pensava che il
vaiolo vaccino modificasse l'organismo in modo tale da
non potersi più ammalare di vaiolo umano. Era per questo
motivo che le mungitrici e molti fattori che avevano contratto il primo tipo di vaiolo venivano poi risparmiati dal
secondo. Per onorare il lavoro pionieristico di Jenner con il
vaiolo vaccino (il cui nome tecnico è vaccinia), vengono oggi chiamati vaccini tutti quei materiali che, inoculati in un
organismo, determinano protezione contro una malattia
specifica. Il procedimento con il quale i suddetti materiali
sono introdotti nell'organismo è definito vaccinazione.
Che cosa successe esattamente, in quegli anni lontani,
quando Jenner inoculò nella schiena di un suo giovane paziente, senza dubbio recalcitrante, un poco di pus per proteggerlo dal vaiolo? In che modo il sistema immunitario del
ragazzo venne stimolato e dotato di quelle armi che gli
avrebbero permesso di uccidere il virus del vaiolo? In che
modo la conoscenza di quei meccanismi si collega con i problemi che dobbiamo affrontare oggi e che riguardano la natura degli eczemi, l'AIDS, l'irritazione da Rhus toxicodendron (edera del Canada), il cancro, il mancinismo, la sensibilità alle punture delle api, i disturbi della gravidanza e i
trapianti di midollo osseo? Nelle prossime pagine analizzeremo le risposte da dare a queste e ad altre domande.
Oggi la gente si interessa del modo in cui l'organismo
funziona e, forse ancora di più, del perché non funziona.
Questo è un atteggiamento molto salutare. Ma troppo di
ciò che viene presentato come autorevole è falso. Di recente, in un giornale, un articolo irresponsabile citava una cli14
nica nell'ovest degli Stati Uniti in cui si riusciva a curare il
cancro nei malati di AIDS, somministrando quotidianamente caffeina per clistere. Gente allo stremo, alla ricerca
di un barlume di speranza oltre che di una cura, si precipitò
in quella clinica, solo per essere derubata prima di morire.
La maggior parte delle pubblicazioni mediche divulgative, anche se corrette, sono così generiche che il lettore intelligente, veramente desideroso di sapere il perché, non può
in ultima analisi essere soddisfatto delle semplificazioni che
offrono. Il mio libro è stato scritto proprio con questo intendimento. Mentre può aiutare la gente ad avere una salute migliore, ha lo scopo primario di informare e di illustrare
come possa essere divertente, e perfino affascinante, lo studio del funzionamento del corpo.
Tenendo presente tutto questo, non desidero offendere il
lettore semplificando eccessivamente ed escludendo particolari complessi. Non mancherò, dunque, di usare anche quel
linguaggio incomprensibile che è la terminologia medica.
Desidero sottoporvi ad uno dei più affascinanti, se non il
più affascinante, gioco di pazienza biologico e indurvi a
provare quell'eccitazione che, penso, proverete quando capirete e direte: «Non ha dell'incredibile?».
Naturalmente, l'esplorazione che effettuiamo nel campo
dell'immunologia non deve essere lenta, monotona e senza
ricompense. Il mio non è affatto un libro di testo; l'ho voluto modellare, piuttosto, sulle sinfonie di Sibelius. Quando
la sinfonia raggiunge il culmine, melodie indipendenti si
fondono e si libera d'improvviso una tale voluttà che il cuore comincia a cantare e l'animo a turbarsi. Non posso garantire che chiunque leggerà queste pagine parteciperà a
una simile esperienza, ma è certo che sto costruendo la mia
«sinfonia» con brani che condurranno a quella melodia sostenuta che è la comprensione totale del ruolo del sistema
immunitario nella vita quotidiana.
L'immunologo è chiamato in causa in qualunque settore:
dalle allergie all'artrite, dai trapianti alle malattie virali, dai
linfociti T alla deprivazione. Desidero mostrarvi quanto
15
l'immunologia sia stimolante, quanto essa rappresenti il futuro e vorrei farvi familiarizzare con quel sistema complesso, ma accessibile, la cui integrità costituisce la capacità dell'organismo di combattere contro così tante malattie.
16
Parte I
LA LOTTA E I LOTTATORI
1
Perché serve un sistema immunitario
Nell'autunno del 1972 mi capitò di conoscere una donna intelligente e angosciata. Il suo fu un racconto doloroso,
sconcertante e interessante insieme. Aveva ventotto anni ed
era madre di tre figli. Il primo, un maschio, aveva goduto
di buona salute e si era sviluppato normalmente fino all'età
di tredici mesi. A quell'epoca la giovane famiglia viveva in
campagna, nell'Illinois. Quando, per la prima volta, il piccolo fu colto da un accesso di febbre alta, la mamma non si
preoccupò più di tanto e non fu colta da panico per il fatto
che il medico di famiglia impiegò alcune ore a giungere alla
loro casa. Il dottore, però, constatò subito la grave condizione del bambino, sospettando un'infezione avanzata. Decise quindi per il ricovero nell'ospedale più vicino, anche se
si trovava a un'ottantina di chilometri di distanza.
Egli sospettava una meningite e la sua diagnosi fu confermata quando, nel liquido cerebrospinale del piccolo paziente, furono trovati dei batteri: streptococchi di un tipo particolare, i Pneumococcus. Malgrado la somministrazione di
dosi massicce di antibiotici specifici, il bimbo morì dodici
ore dopo il ricovero. L'autopsia rivelò una sepsi devastante,
ma nessun indizio sul perché questo bambino, che aveva
sempre goduto di buona salute, si fosse ammalato e fosse
morto nello spazio di ventiquattr'ore. Una tragedia, naturalmente, ma con un gran numero di interrogativi senza risposta. «Queste cose succedono di tanto in tanto» cercava
di consolarla il medico di famiglia. «I batteri possono esse19
re mortali. Lei è giovane: il tempo e i figli che avrà in futuro
la aiuteranno ad alleviare la pena che ora prova.»
Il figlio seguente fu una femmina, venuta al mondo ad un
anno dalla morte del primogenito. Ed era vero: il tempo e
questa bella bambina attenuarono quel primo dolore. Perlomeno per un poco. La bambina era in perfetta salute e,
quando ebbe quindici mesi, la famiglia si trasferì a Detroit.
Qui, repentinamente, fu colta da febbre alta e da una grande fiacchezza. I genitori, già toccati dalla precedente esperienza, la portarono immediatamente al Pronto Soccorso
della clinica universitaria.
La piccola fu posta sotto osservazione, ma le sue condizioni peggiorarono rapidamente. Le venne diagnosticata
una meningite associata a polmonite. I genitori furono colti
dalla disperazione quando, sotto i loro occhi, si ripetè la
stessa tragedia già vissuta un anno prima, ma ancora tanto
viva nella loro memoria. Gli stessi batteri che avevano ucciso il primogenito erano stati trovati nel liquido cerebrospinale di questa loro figlia. Anche a lei la somministrazione di
antibiotici a forti dosi si rivelò inutile: entro ventiquattro
ore dalla comparsa della malattia, quei genitori furono colpiti da una nuova tragedia. Anche questa volta l'autopsia
non mise in luce anomalie evidenti: la piccola era stata semplicemente sopraffatta da microrganismi virulenti.
Un medico, chiamato a consulto da un altro reparto della
stessa clinica, cercò di dare una risposta alle domande angoscianti che ponevano quel papà e quella mamma distrutti
dal dolore. Come tutto questo poteva essere accaduto a due
bambini che, nel primo anno di vita, erano entrambi il ritratto della salute? «Potrebbe trattarsi di una coincidenza,»
disse il medico di Detroit «così come potrebbe trattarsi di
una deficienza genetica. Sembra certo che essi non sono stati in grado di mettere in atto un qualsiasi tipo di difesa con
cui combattere i batteri che li avevano invasi.»
Dopo un lungo periodo buio e angoscioso, gli sfortunati
genitori decisero di tentare una terza gravidanza; entrò così
nella loro vita una seconda bambina, bella e sana. Quando
20
quell'esserino tanto adorato raggiunse i nove mesi, la mamma la portò nella mia clinica e mi raccontò tutta la storia.
«So che lei mi dirà che la bambina ha un aspetto normale
e che, non avendo avuto alcun problema grave, oggi non vi
è alcun motivo di preoccuparsi. Ma lo stesso si sarebbe potuto dire anche degli altri due miei figli» disse la donna.
«La prego, prenda la mia bambina e cerchi se ha una carenza che le impedisce di combattere i batteri. Faccia in modo
che non mi venga portata via anche lei.»
Inutile dire che tutti noi, nella clinica, fummo commossi
da questa storia e dal profondo disagio che quella povera
donna stava evidentemente provando. Essa aveva letto molto e sapeva quello che voleva: che fossero controllati tutti
quei meccanismi di difesa, che agiscono di concerto per costituire il «sistema immunitario», allo scopo di mettere in
evidenza imperfezioni nascoste, addirittura impercettibili.
Ci impegnammo quindi al meglio delle nostre capacità.
Interpellammo gli ospedali in cui erano morti i primi due
bambini: non ricevemmo alcuna collaborazione dall'Illinois, mentre Detroit ci comunicò che gli esami del siero del
secondo figlio, per determinare se fossero stati presenti in
giusta quantità gli anticorpi normali (gli anticorpi sono sostanze che combattono i batteri e di cui tratteremo particolareggiatamente un poco più avanti), non presentavano
anomalie.
Cercammo nel sangue e nei secreti della terza bambina la
presenza di anticorpi. La immunizzammo con un nuovo
vaccino contro i pneumococchi. Controllammo in provetta
l'attività dei linfociti e, a ogni test che eseguimmo, tutto
sembrava perfettamente normale.
Sei settimane dopo, la madre, tenendola stretta a sé, udì
dall'immunologo ciò che proprio voleva sentire: «Non so
che cosa non ha funzionato nei due bambini che lei ha perso, ma questa piccola è in condizioni perfette e ha risposto
bene al nuovo vaccino che le abbiamo somministrato. Sono
sicuro che il suo sistema immunitario è in ordine. Metta il
passato dietro le spalle, si rilassi e si goda sua figlia».
21
Quattro mesi dopo, la donna mi telefonò per dirmi che la
bambina era morta. La notizia datami da quella povera madre affranta mi addolorò più di qualsiasi altra morte nel
corso della mia carriera.
La storia era identica alle due precedenti: una madre in
preda a grande angoscia, impossibilitata a salvare il proprio
figlio malgrado l'immediatezza e la competenza delle cure
mediche.
Ho cominciato questa presentazione dell'immunologia a
un tale livello per vari motivi: anzitutto i casi che ho descritto permettono di mettere in rilievo il potenziale letale dei
microbi, nostri avversari, con cui siamo tutti costantemente
in lotta. Effettivamente, ogni giorno, per varie ragioni,
molti individui sono sopraffatti dalle infezioni e muoiono
nello spazio di ventiquattr'ore. I casi che ci hanno tanto
sconcertato nel 1972 illustrano anche con quanta rapidità si
stia muovendo quella che è la più giovane tra le specialità
cliniche. Oggi, di fronte a una simile storia, verrebbe subito
alla mente la diagnosi corretta, che sarebbe poi prontamente confermata e fatta seguire da una rapida terapia.
I tre bambini di cui abbiamo parlato non riuscivano a
produrre certi tipi di anticorpi necessari a difenderli dagli
streptococchi. La parola «immunità» deriva dal latino e significa «protezione». Il sistema immunitario è, dunque, un
apparato protettivo, che difende l'uomo dal momento in
cui lascia l'utero materno fino al drammatico istante in cui
non ha più bisogno di aiuti biologici.
Mi sembra logico cominciare a parlare di immunità spiegando esattamente da che cosa l'uomo ha necessità di proteggersi. La risposta che dà il corpo sembrerebbe: «Da tutto». In effetti, l'essere umano riconosce come sacrosanto il
proprio corpo e non permette che una qualsiasi entità estranea permanga nel suo microambiente. Da questa affermazione si può dedurre in modo immediato e corretto che abbiamo un mezzo per conoscere le differenze tra i milioni di
componenti che costituiscono, in modo del tutto singolare,
il nostro corpo (cioè il sé) e qualunque altra entità (cioè il
22
non-sé). La capacità di compiere una simile distinzione è
l'essenza di quel miracolo biologico che è l'immunità. Dobbiamo, dunque, esplorare i meccanismi con cui l'organismo
svolge questo compito, che è tra i più impegnativi.
Il «non-sé» può essere distinto in due categorie che rappresentano problemi di entità molto diversa. Il «non-sé»
può essere passivo: questo è il caso di corpi estranei che invadono l'organismo non avendo affatto una pericolosità attiva e, certamente, non in grado di aggredire direttamente.
Rientrano in questa categoria la scheggia che si conficca in
un dito e perfino il rene di un individuo trapiantato in un
altro individuo. Il nostro organismo rigetterà violentemente
entrambi: buona cosa nel caso della scheggia, meno buona
nel caso del rene.
D'altra parte, come è già stato spiegato, esistono numerosi esempi di notevole pericolosità, offerti dal «non-sé» e
nei quali il nostro sistema immunitario si imbatte. I migliori
sono rappresentati da quei virus, funghi, batteri e parassiti
che invadono il nostro organismo uccidendolo, se non siamo noi a ucciderli per primi. In casi del genere, il pronto intervento è indispensabile. Spesso si ha a che fare con un nemico adattabile e «intelligente», che conosce la propria immunologia. Per esempio, molti virus possono indurre deliberatamente modificazioni nell'organismo, in modo da
sopprimere la capacità di lottare del sistema immunitario
contro di loro.
Il sistema immunitario affronta un altro nemico e merita
pertanto di essere attentamente considerato. È un nemico
che viene dall'interno. Proprio come la personalità di un individuo può modificarsi per varie influenze, tanto che non
possiamo più dire che una persona che incontriamo oggi è
uguale a come l'abbiamo conosciuta dieci anni fa, così le
parti organiche del sé possono modificarsi in modo tale da
non essere più riconoscibili come sé. Questo equivalente
biologico del cambiamento di personalità è noto come cancro. Una donna affetta da cancro alla mammella non è più
la stessa persona di prima. Le cellule che possono farla mo23
rire sono molto simili a cellule normali, ma vi è in esse una
differenza sottile e potenzialmente letale: benché siano derivate dal normale tessuto della mammella, sono ormai sregolate. Se la donna (attraverso il proprio sistema immunitario) non riesce a ucciderle, rischia di morire per il danno che
esse, con la loro malignità, possono arrecare ai suoi tessuti
normali.
Come analizzeremo nei particolari in un prossimo capitolo, le prove a nostra disposizione suggeriscono con forza
che il sistema immunitario, in molti casi di cancro, riconosce in modo efficace la devianza dalla norma che le cellule
neoplastiche mostrano nel comportamento e nell'aspetto e,
di conseguenza, le distrugge. A volte quando certi tipi di
cancro prendono il sopravvento, sembra che il sistema immunitario non riesca a «rendersi conto» di ciò che sta accadendo e, pertanto, ci pianta in asso, esponendoci alle conseguenti devastazioni.
In tutto questo libro, il termine antigene viene usato per
indicare qualunque cosa, presente nell'organismo, che non
sia il «sé». I nostri sofisticati meccanismi di difesa esercitano il loro compito così rilevante, seguendo una tattica
«giorno per giorno», in modo che, nella maggior parte di
noi, gli antigeni che invadono l'organismo sono rapidamente affrontati senza che la loro presenza arrechi il benché minimo disturbo al nostro benessere.
Come si è detto, alcuni antigeni sono apertamente ostili,
mentre altri, pur arrecando probabilmente dolore (come
una scheggia), sono innocui. Prima di affrontare il tema degli antigeni dannosi che sfidano il nostro sistema immunitario, cioè di quei microbi vivi che ci infettano e arrecano
danno a una o più parti del nostro organismo, provocando
malattie, vi è un'unità biologica fondamentale che deve essere indagata nei particolari, altrimenti tutto quello che seguirà risulterà incomprensibile. Quest'unità è la cellula.
La cellula è il fondamento di tutti gli organismi viventi,
dalle piante all'uomo. È una struttura tridimensionale, di
forma variabile dalla sfera al cubo e costituita da pareti, le
24
membrane, che racchiudono un insieme di complicati congegni interni. Si immagini di aver gonfiato un palloncino
rosso non con aria, ma con acqua. Quando è completamente disteso si fanno cadere all'interno, nell'acqua, alcuni
frammenti di legno e poi si sigilla l'apertura. Ciò offre alla
nostra mente un'immagine grossolana di che cosa sia una
cellula vivente: membrane espandibili che delimitano uno
spazio ripieno di liquido, contenente strutture specifiche e
importanti per il funzionamento della stessa. Si immagini
ora di appoggiare sul pavimento, l'uno accanto all'altro,
venti palloncini del genere. Su ciascuno si sistemi una colonna di palloncini, ponendone venti uno sopra l'altro. Si
otterrà così una parete di 400 palloncini (un'esibizione assicurata per il circo Barnum!). Naturalmente, perché una
struttura così precaria possa rimanere unita senza che i palloncini comincino a rimbalzare sui costosi tappeti del corridoio, riversandovi sopra il proprio contenuto quando le loro fragili membrane si rompessero, queste devono essere incollate tra loro, in modo che ciascun palloncino tocchi quello che gli sta sopra, quello che gli sta sotto e i due che gli
stanno ai lati. Fatto questo, risulta un «muro» di palloncini, che si muove leggermente e che è in grado di ondeggiare
di qua e di là quando è sottoposto a pressione. Ora, cominciate a fare qualche passo indietro da questa insolita costruzione: a mano a mano che vi allontanerete, i singoli palloncini appariranno meno ben definiti e, alla fine, vi sembrerà
di vedere un muro rosso compatto.
Ogni tessuto od organo del nostro organismo è costituito
in questo modo: miliardi di «palloncini» uniti a formare il
nostro «sé». Nel repertorio cellulare distinguiamo palloncini di differenti colori: in blu quelli che ci fanno vedere, in
rosso quelli che servono a secernere l'urina e in color porpora i palloncini che ci fanno ardere di passione. In altre
parole, gruppi di cellule tutte partecipi di un'unica funzione
operano di concerto, costituendo un organo. Tuttavia, esiste una differenza fondamentale tra il modo in cui siamo
soliti costruire un muro di palloncini e il modo in cui la Na25
tura costruisce una parete di cellule. Invece di gonfiare singolarmente milioni di palloncini e allinearli per bene come
farebbe un muratore con i mattoni per costruire un muro,
la Natura raggiunge il suo scopo attraverso la divisione cellulare: ognuno di noi ha inizio da un'unica cellula che si divide molte e molte volte, in pratica quasi all'infinito, per rifornirci di tutte le cellule che sono necessarie a espletare le
varie funzioni corporee.
A un certo punto, i prodotti della divisione cellulare cominciano a modificarsi. Questo differenziamento controllato permette ai vari componenti della macchina corporea di
svilupparsi interagendo. Adottando il sistema di esprimere
concetti mediante analogie, si osservi ora il dorso della propria mano: la pelle sembra uno strato omogeneo. Osservandola con un microscopio essa appare, invece, come se fosse
il muro di palloncini di cui abbiamo detto prima. Con un
maggiore ingrandimento, cominciano a distinguersi i singoli elementi cellulari. Pur non mettendo in dubbio la verità
fondamentale contenuta nelle parole sagge di Alan Sher26
man: «La pelle è necessaria per trattenere le nostre cose
dentro», il tessuto epidermico, il più utile di tutti i tessuti,
quello che ci tiene al caldo e al fresco, agisce anche come
prima linea di difesa per tenere «fuori» dal nostro corpo i
microrganismi. Le secrezioni untuose della pelle, l'urina
escreta dai reni e la saliva prodotta dalle cellule delle ghiandole salivari testimoniano che le cellule dei differenti tessuti
o organi sono, in realtà, vere e proprie «fabbriche», che
svolgono alcune funzioni specifiche, utili a quel possente
conglomerato cellulare che è il corpo di ciascuno di «noi».
Torniamo per un momento ai palloncini. Invece di acqua
e di alcuni frammenti di legno che galleggiano su di essa,
immaginiamo che, all'interno di ogni palloncino gonfiato,
il liquido sia un insieme di materie prime e che alcuni frammenti di legno siano, in realtà, catene di montaggio su cui le
materie prime possono allinearsi secondo un certo ordine
per produrre una sostanza nuova e utile.
Ogni cellula è una fabbrica che ha a disposizione materie
prime prodotte in altre cellule e progettate per un determinato scopo. In essa è presente un nucleo da cui partono le
istruzioni per il suo funzionamento e che indicano quindi
l'esatto compito che la cellula deve svolgere. Archiviati in
ogni nucleo vi sono tutti i messaggi necessari a istruire il
corpo sull'attività di ogni sua singola parte, ma a seconda
delle cellule soltanto uno di questi messaggi viene attivato.
Questo concetto biologico fondamentale è servito da spunto per la trama del romanzo di Ira Levin, i ragazzi venuti
dal Brasile, in cui si parla di clonazione. In teoria, se si riesce a isolare e a conservare una cellula di un individuo qualsiasi, si ha in essa, in codice, tutta l'informazione necessaria
di tutte le funzioni dell'intero organismo.
Per ogni cellula, i piani di produzione, cioè i programmi
per assemblare il prodotto finito di una cellula (le proteine),
sono archiviati in codice nei geni che si trovano nel nucleo.
I geni sono insiemi di sostanze chimiche che trasmettono
messaggi. Queste istruzioni genetiche vengono eseguite nel
compartimento più fluido della cellula, cioè nel citoplasma.
27
Per un certo aspetto, importante, il modello a palloncini
non è adeguato a spiegare la cellula. A meno di non rompere la parete, l'acqua all'interno di ogni palloncino rimarrà
sempre all'interno e l'aria all'esterno rimarrà sempre all'esterno. La membrana che delimita la cellula ha, invece, una
permeabilità selettiva, il che significa che alcune sostanze
possono uscire ed entrare liberamente, mentre i movimenti
degli elementi essenziali per la cellula sono regolati tramite
la membrana cellulare. In un modo ben congegnato questa
controlla attivamente i movimenti di varie molecole da e
per la cellula. Naturalmente, i geni determinano la produzione di un particolare tipo di membrana per una data cellula, in modo da poter anche controllare in modo specifico i
flussi da e per l'ambiente.
All'interno di una cellula, tutti i geni sono uniti tra loro e
formano lunghe catene intrecciate, i cromosomi. Il materiale genetico stesso è costituito da acido desossiribonucleico,
una sostanza nota universalmente come DNA. In un dato
momento, nella cellula, opera soltanto un piccolo numero
di geni, che la istruiscono a eseguire questa o quella funzione. Si può ben immaginare il caos che vi sarebbe altrimenti!
I geni fanno sicuramente in modo che non si abbiano, per
esempio, follicoli piliferi che producono sangue.
I cromosomi consistono in una coppia di catene di unità
chimiche, attorcigliate tra loro. Per capire che cos'è una
molecola di DNA, si immagini di avere due fili metallici e di
avvolgerli a elica l'uno attorno all'altro. Ogni coppia di
cromosomi presente in un organismo proviene da entrambi
i genitori: un filamento dall'uno e l'altro dall'altro. La Natura, che è la vera grande scienziata, compie una costante
sperimentazione, sempre vigile, e sempre alla ricerca delle
migliori combinazioni di geni. I genitori sperano che i loro
figli prendano, da ciascuno di loro, i migliori attributi e, a
questo proposito, la Natura ha potuto constatare che il miracolo della riproduzione sessuale offre buone probabilità
perché ciò avvenga. Naturalmente, il rimescolamento dei
geni può anche non fornire un prodotto migliore.
28
Ereditiamo 23 cromosomi da ciascun genitore. Si immaginino 46 programmi al calcolatore, memorizzati insieme su
un disco rigido. Si può lavorare su un solo programma alla
volta. Utilizzando la stessa analogia, ogni programma si
compone di geni. Sul floppy disk principale, che contiene i
dati relativi alla nostra esistenza, vi sono dai 300.000 ai
400.000 programmi che, nel loro insieme, devono produrre
tutto: dal pensiero più sottile e intelligente al riflesso patellare. A noi interessa particolarmente un gruppo di cellule, i
linfociti, che utilizzano il programma dell'immunologia.
A questo punto esamineremo in sufficiente dettaglio quegli antigeni microbici che provocherebbero la nostra morte
se non disponessimo di un sistema immunitario.
29
I virus
Una volta, nell'area di una stazione di servizio, ho visto un
grande cartellone pubblicitario, illuminato al neon, su cui
era scritto: «Virus è una parola usata dai medici per dire
che la tua ipotesi vale quanto la mia».
Non si sa che cosa avesse motivato il gestore dell'area di
servizio a dare al mondo una simile informazione, ma suppongo che quel californiano fosse stato colpito da una forma di influenza e che, probabilmente, il suo medico gli
avesse detto: «Non posso fare molto per lei. È un virus. Vada a casa, beva molti liquidi e se ne stia tranquillo per alcuni giorni».
Bisogna confessare che una simile ammissione di impotenza sia frustrante, ma, tranne che per pochissimi virus, il
consiglio dato dal medico è giustissimo. Le infezioni virali
sono essenzialmente battaglie private combattute tra un virus e il sistema immunitario del paziente. Sono stati prodotti finora pochissimi agenti antivirali efficaci, dimodoché i
medici, ad esclusione di alcune forme virali del tipo dell'herpes, hanno ben pochi rimedi specifici da offrire. Fino
ad oggi, il successo nel trattamento dei virus è venuto soprattutto dalla produzione di vaccini che bloccano, come
prima cosa, l'infezione.
L'incapacità dei medici di intervenire efficacemente contro i virus, la difficoltà incontrata nel coltivare questi microrganismi e la sintomatologia spesso vaga che essi producono tendono a far pensare che siano oggetti strani e misteriosi. Questo non è del tutto vero perché le nostre informazioni sui virus sono altrettanto abbondanti di quelle che abbiamo sui batteri.
Che cosa sono i virus? Scientificamente parlando e
astraendo dei loro terribili effetti, essi sono forme di vita (o
di quasi vita, visto che - come si vedrà più avanti - non possono sopravvivere da soli) ingegnose e ben riuscite. Perché
possano crescere e moltiplicarsi, occorre che penetrino nel
sancta sanctorum di una o più cellule specifiche diventan30
done ospiti. Pertanto sono parassiti che vivono alle spalle di
altri organismi.
Un virus si compone di materiale genetico, DNA o RNA,
solitamente contenuto in una membrana protettiva di natura proteica. Pertanto, porta con sé «messaggi», cioè istruzioni, che può dare alle cellule viventi che invade e che sono
tutte, come si è visto, fabbriche addette alla produzione di
qualcosa. Il virus istruisce la cellula parassitata ad aggiungere al repertorio delle proprie produzioni la sintesi di altri
virus.
Un virus penetra nel computer di una cellula, chiuso nel
nucleo, modificandone il software. Quando inserisce in esso il proprio programma, istruisce la cellula affinché utilizzi
le proprie materie prime, normalmente presenti per ricavare
qualcosa di utile, nella produzione di nuove particelle virali.
In questo modo, quella semplice forma di vita che è il virus
è in grado di duplicarsi innumerevoli volte.
Le cellule così infettate non hanno alternativa se non
quella di produrre il virus, pur avendo elaborato alcuni
meccanismi di difesa per combatterlo. Quando sono piene
di nuove particelle virali e le loro membrane esplodono sotto la pressione di una simile proliferazione, muoiono. I virus, liberati in questo modo, si spostano verso cellule vicine, non ancora infettate, e un nuovo ciclo si ripete. Anche
se la nuova cellula infettata non muore, il danno può essere
inferto a quei meccanismi di controllo sofisticati, che regolano la vita cellulare. Di conseguenza, può svilupparsi una
neoplasia, cioè può avere origine, da quella cellula, un tumore maligno.
Nella maggior parte dei casi, tra noi e l'assalto dei virus
non rimane altro che il sistema immunitario, la cui capacità
di riconoscere l'infezione virale e di fronteggiarla sarà descritta più avanti. Per ora, sottolineiamo semplicemente il
fatto che i virus diventano parte del nostro organismo e
che, per distruggerli, dobbiamo spesso distruggere le cellule
in cui si sono annidati. Se si ha la sfortuna di ammalarsi di
epatite B, il sistema immunitario può distruggere molte cel31
lule epatiche per sbarazzarsi del virus che si nasconde in esse. Se l'infezione è estesa a buona parte del fegato, si rischia
davvero, nel tentativo di distruggere il virus, di distruggere
l'organismo intero (non potendo l'uomo vivere senza fegato).
I virus sono minuscoli, non possono essere visti al microscopio ottico ed è questa una delle ragioni per le quali tanto
tempo è passato prima che venissero scoperti. In realtà, si
presumeva che esistessero già molti anni prima che fossero
visti e coltivati. Nel 1898 alcuni scienziati tedeschi, mentre
cercavano di stabilire la causa dell'afta epizootica (quella
disastrosa malattia che colpisce il bestiame), riuscirono a dimostrare che la malattia poteva essere trasmessa da un animale all'altro mediante vari liquidi corporei di animali infetti, filtrati su membrane sicuramente in grado di bloccare
anche il più piccolo dei batteri. Pertanto chiamarono l'agente infettivo responsabile «virus filtrabile ultramicroscopico». Oggi questi agenti infettivi sono chiamati semplicemente virus (virus è una parola latina che significa «veleno
che danneggia l'anima») e sappiamo che ne esistono parecchi tipi differenti l'uno dall'altro. I virus hanno forme diverse e spesso un biologo che ne osserva uno può rivelare
molto sulle sue proprietà basandosi semplicemente sulle caratteristiche fisiche.
In realtà, riesce difficile immaginare quanto piccolo sia
un virus. Le sue dimensioni variano da 17 a 300 nanometri
(un nanometro è un miliardesimo di metro). Per avere un
termine di confronto, si immagini di pungere con un ago la
pelle e di fare uscire una goccia di sangue; ebbene, in questa
goccia si trovano all'incirca cinque milioni di globuli rossi,
ciascuno dei quali potrebbe benissimo contenere un migliaio di virus.
Quando un virus viene riprodotto dalla cellula che ha invaso, è spesso racchiuso in un involucro, il capside, costituito da un insieme di proteine e di grassi. Questa struttura
permette a molti virus di vivere indisturbati al di fuori dell'organismo per lunghi periodi di tempo. Nel duplicarsi o
32
nel progettare l'involucro entro cui vivrà, il virus programma in forma tridimensionale, complementare, il che gli consente di interagire specificamente con la membrana della
cellula che sta per invadere. Certe membrane cellulari hanno sulla loro superficie recettori per determinati virus. È
molto importante per la medicina che i virus siano esigenti
riguardo ai loro ospiti. Quelli che causano l'influenza non
infettano i reni in alcuna circostanza; i virus erpetici che
provocano tante sofferenze a livello dei genitali non provocano la polmonite.
Gli esseri umani non sono, certamente, le uniche vittime
delle infezioni virali. Anche le piante, gli insetti e tutti gli altri animali possono venire infettati. Certi virus, poi, hanno
imparato a parassitare pure i batteri; pertanto si potrebbe
essere infettati da un batterio che, a sua volta, è già stato infettato da un virus. Un virus che predilige le piante, però,
infetterà soltanto le piante. I virus sono progettati in modo
così specifico per invadere un unico tipo di cellula che quelli
che provocano malattie negli animali raramente infetteranno gli esseri umani, e viceversa. Se si riuscisse a eliminare
dall'ambiente l'ospite preferito di un virus particolare, questo cesserebbe di esistere. Malgrado ciò, non abbiamo pensato al nostro annientamento come ottimo rimedio per togliere di mezzo le infezioni virali.
Come fanno i virus a penetrare nel nostro organismo?
Quando non sono all'interno del loro ospite preferito, possono trovarsi sul pavimento, attaccati a una particella di
polvere, possono rimanere quiescenti nel terreno, oppure
possono essere intrappolati nel pelo degli animali. L'elenco
potrebbe continuare. Per accedere al nostro organismo, essi
devono trovare una ferita sulla cute, provocata per esempio
da un incidente, oppure la puntura di un insetto o la morsicatura di un altro animale, oppure ancora il foro prodotto
da una siringa, come capita nei tossicodipendenti. In quest'ultimo caso, del liquido infetto può raggiungere i tessuti
corporei o addirittura il circolo sanguigno. Tuttavia, la via
di gran lunga più frequente che i virus seguono per invadere
33
un organismo passa attraverso la bocca. Gli esseri umani, ci
sia consentito dirlo, tengono la bocca troppo aperta: oltre a
parlare e a mangiare troppo, possono in questo modo ingerire facilmente particelle virali sospese nell'aria. Con uno
starnuto, milioni di virus vengono espulsi dal naso e a milioni occupano l'aria quando si spolverano degli oggetti in
un locale. Spesso molta gente si tocca la faccia con le mani
o si mette le dita o anche solo le unghie in bocca. E le dita
possono essere coperte di virus, come le mani, che sono anch'esse una fonte di rischio se non vengono accuratamente
lavate.
I virus passano anche, attraverso la placenta, dal corpo
34
di una donna robusta e con precedenti esperienze immunologiche al corpo fragile del feto che essa porta in grembo e
che è privo di un'esperienza del genere. Pertanto, possono
arrecargli gravi danni, come accade, per esempio, con il virus della rosolia. I medici possono inavvertitamente trasmettere ai pazienti infezioni virali quando gli strumenti che
adoperano per esaminarli, o addirittura per intervenire all'interno del loro corpo, non sono sterili. Persino interventi
che devono essere praticati in condizioni meticolosamente
sterili, come i trapianti di cornea, in grado di ridare la vista,
si sono talvolta conclusi in tragedia quando il tessuto trapiantato è risultato infettato da virus.
Oggi dobbiamo affrontare il problema di virus che hanno
imparato a infettare e a uccidere le cellule del sistema immunitario (come i virus dell'AIDS, di cui si parlerà più
avanti) e siamo stati così costretti a riconoscere ancora una
volta quali pericolosi nemici questi microrganismi siano.
Certamente l'ultimo capitolo della lotta ingaggiata con questi sfidanti non è stato ancora scritto.
I batteri
Ho incontrato per la prima volta Bill al pronto soccorso di
un ospedale: questo giovane bianco di 21 anni era in preda
a convulsioni e sudava abbondantemente per un evidente
attacco febbrile. Dopo avergli protetto la lingua per impedire che se la mordesse, avergli bloccato le convulsioni con il
Valium somministrato per via endovenosa e avergli restituito il colorito normale inalandogli ossigeno, lo abbiamo esaminato più attentamente: era un povero giovane molto malato, che nessuno dei medici dello staff aveva mai visto
prima.
Bill era non proprio emaciato ma quasi, era molto sporco
e aveva una barba di cinque-sei giorni. Il resto dell'esame
fisico ci rivelò tre cose molto importanti per noi. Sulle braccia risultavano evidenti le vene bucate, livide, martoriate,
tipiche del drogato: un'immagine fin troppo consueta. Più
35
insoliti, invece, erano i suoni che provenivano dal suo cuore
impazzito, il cui battito era troppo rapido e irregolare. Tra i
suoni che corrispondevano alla rapida apertura e chiusura
delle valvole cardiache, per far avanzare il flusso sanguigno
quando il cuore si contrae, c'era qualcosa di importante che
non funzionava. Invece del silenzio, foriero del regolare impetuoso procedere del fiume della vita, attraverso lo stetoscopio si sentiva vibrare il suono di una turbolenta cascata.
Allorché il sangue passava da una cavità all'altra, le irregolarità presenti sulle superfici delle valvole, normalmente lisce, facevano deviare il potente getto di sangue, proprio come un getto d'acqua che esce normalmente da un rubinetto
aperto può essere fatto deviare chiudendo parzialmente il
foro di uscita con un dito.
Il terzo segno che ci ha fornito la tesserina rivelatrice di
questo complicato gioco di pazienza venne notato sulle mani di Bill. Sotto le unghie di tre dita, si potevano osservare
alcune macchioline rosse, in corrispondenza del punto in
cui si erano rotti minuscoli capillari sanguigni, che avevano
riversato il loro prezioso carico nel letto ungueale.
Associando tutti questi indizi, qualunque medico che
avesse voluto indagare sul caso di Bill avrebbe potuto descrivere gli eventi che lo avevano condotto a quella situazione critica.
Dieci giorni prima, Bill aveva comprato un poco di eroina con i soldi che aveva vinto a una lotteria. Cresciuto in un
ambiente povero, incapace di lavorare, spesso perseguito
dalla legge e disperatamente dedito alla droga, doveva aver
pensato che vincere 1000 dollari spendendo solo 50 cent era
un segnale inviatogli dagli dei per dirgli che le cose stavano
cambiando. La fortuna, invece, a momenti lo uccideva.
Comprò un poco di «roba buona» e se la iniettò. Tra i tossicodipendenti che fanno uso di droghe pesanti, la siringa e
gli aghi necessari per le iniezioni vengono spesso passati
dall'uno all'altro per essere utilizzati più volte, ponendo
inoltre una ben scarsa attenzione al fatto che rimangano
sterili. Spesso tra un impiego e l'altro si cerca di lavare la si36
ringa in acqua corrente, ma questo è un modo del tutto insoddisfacente di pulire l'ago. In siringhe e aghi come questi,
molti tra i maggiori nemici dell'uomo, tra cui i batteri, possono insediarsi e moltiplicarsi.
I batteri vivono praticamente dovunque. Nel caso di Bill,
alcuni batteri particolari, gli streptococchi, erano stati probabilmente trasmessi dalla cute di una persona all'ago che
egli aveva utilizzato per iniettarsi la «roba». Una volta introdotti nel circolo sanguigno, quei batteri si erano moltiplicati centinaia di volte in ventiquattr'ore. Il sangue è una
fonte eccellente di ossigeno e di glucosio, entrambi necessari per la crescita di questi microrganismi. A questo punto
della storia, è necessario che conosciamo in modo un poco
più approfondito i batteri, la cui scoperta risale a meno di
un secolo fa. Infatti i primi batteri a essere visti furono
quelli che causano la lebbra.* Alla fine del XIX secolo, in
un laboratorio della Norvegia, un paese che non colleghereste di certo alla lebbra, un certo dottor Hansen stava osservando al microscopio il tessuto di un paziente affetto da
questa malattia, quando vide non uno, ma centinaia di migliaia di quei piccoli organismi che la causano (per inciso, la
lebbra è spesso chiamata morbo di Hansen proprio per questo motivo).
I batteri sono molto diversi dai virus descritti nelle pagine
precedenti, soprattutto perché sono forme di vita complete e
non hanno bisogno di altri organismi per vivere. Quelli che
causano il tetano e secernono una tossina (la tossina tetanica) vivono bene sia nel suolo che nell'organismo umano. I
batteri sono organismi solitamente unicellulari, dotati quindi di un nucleo contenente tutta l'informazione genetica necessaria per sapere come essere un batterio. Essi hanno dimensioni molto maggiori di quelle dei virus, anche se sono
ancora troppo piccoli per poter essere visti a occhio nudo.
* La prima osservazione diretta si deve nel 1683 ad A. Van Leenwenhoek,
che li classificò in tre forme base: cocco, bastoncello, spinilo. (N.d.R.)
37
I batteri si nutrono e si dividono ininterrottamente e lo
fanno in maniera ottimale quando le condizioni sono favorevoli. Si possono coltivare ponendoli ad esempio su una
piastra di Petri, e fornendo loro le fonti alimentari, la temperatura, il grado di umidità e l'ambiente gassoso che prediligono. In queste condizioni, essi si riproducono rapidamente e con una tale efficienza da formare ben presto colonie visibili sulla superficie del terreno di coltura.
I batteri possono provocare gravi danni all'organismo
umano in almeno tre modi:
A) Quando si moltiplicano all'interno dell'organismo,
possono secernere sostanze velenose (le tossine) in grado di
danneggiare seriamente una o più funzioni vitali. Alcune
possono paralizzare i nervi, mentre altre bloccano la capacità delle cellule intestinali di assorbire acqua (si pensi alle
terribili diarree provocate dai batteri responsabili del colera).
B) Possono invadere un tessuto, per esempio quello polmonare, e moltiplicarsi in esso così rapidamente che l'enorme numero formatosi e lì accumulatosi finisce per interferire con la funzionalità dell'organo, provocando - nel caso
del tessuto polmonare - una polmonite.
C) Quando il sistema immunitario scatena un violento
attacco contro i batteri che hanno invaso un tessuto, questo, preso nella mischia, può rimanere danneggiato. La distruzione del tessuto dà luogo a un ascesso; i resti dei batteri
digeriti chimicamente, assieme a quelle parti di cellule distrutte inavvertitamente, costituiscono il pus.
Ritorniamo ora a Bill che, come ricorderete, si era da poco iniettato alcuni di questi microrganismi nel sangue. Quei
batteri stavano di certo percorrendo a grande velocità tutto
il suo organismo, non essendovi per loro luoghi inaccessibili, dato che il sangue giunge ovunque.
Ora, se siete mai stati a Ginevra o in altre località in cui si
possono facilmente studiare i laghi quando si riempiono
dell'acqua che scende dalle montagne, avrete notato che,
per controllare il flusso della massa idrica, vengono poste
38
delle paratie. Quando queste sono completamente aperte,
una corrente d'acqua fuoriesce con impeto, a grande velocità, al centro dell'apertura, mentre appena ai lati di questa
forza centrale vi sono zone con acqua tranquilla. Lo stesso
effetto si produce nel cuore. Può capitare che i batteri vengano fermati, nel loro capitombolare a capofitto nel torrente circolatorio, quando qualcuno di loro va alla deriva ai
margini della corrente e giunge in quei punti dove il sangue è
«calmo». Quando ciò accade, i batteri che si trovano in queste zone meno turbolente possono insediarsi sulle superfici
delle valvole cardiache, cioè di quelle «porte» che controllano il flusso del sangue. Qui possono crescere relativamente
indisturbati, in un'atmosfera ricca di gas e di sostanze nutritive. Così facendo, formano colonie, proprio come fanno
nelle piastre di Petri. Si accumulano sulle valvole e formano
escrescenze che assomigliano vagamente alla superficie di
un cavolfiore e per questa ragione si parla di vegetazioni.
Queste vegetazioni portano, a poco a poco, alla distruzione
delle valvole e il danno può essere avvertito acusticamente
come un «murmure» (in realtà, si tratta spesso di un crepitìo). Se l'alterazione del flusso sanguigno è sufficientemente
grave, la turbolenza può spesso essere avvertita direttamente attraverso la parete toracica, ponendo la mano piatta sopra la posizione del cuore. È come mettere la mano sulla calotta di un altoparlante che emette musica ad alta intensità.
Il cuore di Bill era dunque in difficoltà, ma questo era solo il principio. Poiché non poteva più funzionare come una
pompa regolare, alcune vegetazioni batteriche, sviluppatesi
sulle sue valvole, si erano staccate unendosi di nuovo al
flusso sanguigno nel momento in cui questo fuoriusciva dal
cuore. A questo punto, però, i batteri non si spostavano più
come singole cellule, ma come ammassi. Uno di questi ammassi era salito rapidamente al cervello e, nel portarsi sul
lato sinistro della corteccia cerebrale attraverso alcune arteriole, era rimasto incastrato, fisicamente incuneato, in una
di esse. Anche in questa sede i batteri furono in grado di dare origine a una colonia, sviluppandosi rapidamente nel ric39
co ambiente cerebrale, saturo di zuccheri; alla fine, formarono localmente un ascesso che danneggiò il tessuto cerebrale stesso, provocando convulsioni e, successivamente
(dato che Bill è ancora vivo mentre sto scrivendo queste pagine), una paralisi della maggior parte del lato destro del
corpo. Si ricorderà che il lato sinistro del cervello controlla
il lato destro del corpo.
Analogamente, alcuni batteri si erano staccati dalle vegetazioni cresciute sulle valvole, andando a finire nei vasi sanguigni che si trovavano sotto il letto ungueale, dove il danno provocato era visibile attraverso la cuticola. In questo
modo abbiamo scoperto che cosa era successo a Bill. Furono necessari l'intervento di un cardiochirurgo, per sostituirgli le valvole cardiache lese, una somministrazione accurata
e prolungata di antibiotici e molta terapia riabilitativa. Purtroppo egli è rimasto parzialmente paralizzato e anche la
sua mente è stata danneggiata; tuttavia, è vivo e non più
tossicodipendente.
Il nemico batterico può vivere indipendentemente, moltiplicarsi così rapidamente e produrre tanti e tali danni che è
necessario intervenire con speciali sostanze antibatteriche
per rafforzare i meccanismi di difesa dell'organismo.
I batteri sono solitamente classificati con termini di derivazione greco-latina. La maggior parte dei lettori avrà senza dubbio sentito parlare di Streptococcus e di Staphylococcus. La componente coccus della parola, che significa
«chicco», rimanda alla forma sferica del batterio, così come gli spirilli denotano batteri a bastoncello spiraliforme, i
bacilli microrganismi di tipo cilindrico e i vibrioni quelli a
virgola. Solitamente vivono isolati o in insiemi sparsi, ma in
alcuni casi possono formare ammassi pluricellulari, detti
batteri pluricellulari. La loro classificazione, basata naturalmente, oltre che sulle caratteristiche morfologiche, anche
sulle specifiche proprietà biochimiche e cromatiche, permette ai clinici di instaurare un'adeguata terapia (generalmente a base di antibiotici), efficace contro quello specifico
organismo.
40
Alcuni batteri (tra essi si annoverano gli agenti causali
della tubercolosi e della lebbra) vivono all'interno delle cellule corporee, dove sono ben protetti dalle forze antibatteriche, in agguato nel circolo sanguigno. Come è già stato ricordato, i batteri constano di cellule dotate di nucleo; pertanto, dividendosi ripetutamente, sono in grado di adattarsi
a qualsiasi circostanza ambientale. Per esempio, quando si
imbattono in un nuovo antibiotico, l'informazione genetica
contenuta nei loro nuclei permette loro di determinare, in
gran parte per tentativi ed errori, alcuni cambiamenti nella
loro costituzione in modo da poter resistere agli effetti di
quell'antibiotico. Allora, dopo una stasi iniziale, l'infezione proseguirà e un nuovo ceppo di batteri resistenti verrà
diffuso nel mondo.
Questa capacità di apprendere nuovi e pericolosi stratagemmi è una caratteristica comune a tutti gli organismi che
si dividono rapidamente. Se noi, esseri umani, diventiamo
progressivamente più «indolenti», in un milione di anni
avremo un aspetto diverso, ma i cambiamenti evolutivi che
potranno fare scomparire le nostre gambe pigre si svolgeranno molto, molto lentamente. Invece i batteri possono
evolversi (cioè modificarsi in maniera significativa) in brevissimi periodi di tempo e questo, evidentemente, li rende
molto pericolosi per noi.
Riporterò un esempio chiarificatore di ciò che intendo dire: Stewart era in ottima salute e di ottimo umore. Lui e la
sua ragazza, Helen, erano felicemente innamorati. Un giorno, dopo un party, si ritrovarono soli nella camera di lei.
Desideravano molto fare l'amore, ma Helen esitava. Era al
secondo giorno di un periodo mestruale abbondante e non
sapeva se, in quelle circostanze, avrebbe provato piacere nel
rapporto. Ma Stewart rimosse i suoi dubbi. Helen si spogliò, tolse il tampone impregnato di sangue e fecero l'amore.
La sera seguente, Stewart non stava bene: era febbricitante e aveva male di testa. Attorno a mezzanotte era in
condizioni disperate e un compagno di stanza, preoccupa41
to, lo portò precipitosamente al Pronto Soccorso dell'ospedale, dove fui chiamato per visitarlo.
Quel giovane e ben piantato giocatore di football delirava, aveva febbre alta e pressione anormalmente bassa. Un
esantema ricopriva ormai quasi tutta la superficie del suo
corpo e la pelle si stava già seccando e desquamando. L'interno della bocca presentava, sulla delicata mucosa, chiazze
rosse infiammate. A un certo punto egli cominciò anche a
vomitare in modo incontrollabile. Prove cliniche, effettuate
sul sangue, rivelarono che la funzionalità epatica era compromessa e che, nel sangue, quelle particolari cellule che sono necessarie per la coagulazione erano pericolosamente
scarse.
Non era possibile sapere qualcosa da Stewart, conoscere
la sua storia, e benché fossimo consapevoli che era preda di
una grave infezione, non riuscivamo a stabilire quale microrganismo ne fosse responsabile. Avviammo così un trattamento empirico e tutta una serie di prove diagnostiche.
Quando, profondamente costernata, Helen giunse in
ospedale, un brillante giovane interno, evidentemente ben
aggiornato, le chiese se stava bene, se aveva le mestruazioni
e se aveva avuto in quei giorni rapporti sessuali con Stewart. Avuta risposta positiva a tutte queste domande, richiedemmo la sua cooperazione e le prelevammo sangue
mestruale dalla vagina per metterlo in coltura. Potemmo
così identificare in esso lo Staphylococcus aureus, assieme a
due pericolose tossine batteriche, note come tipi C e F.
Stewart stava soffrendo di una nuova malattia, la sindrome da «shock tossico»: forse a causa di un'abrasione della
cute, le tossine e probabilmente anche alcuni batteri erano
giunti attraverso il pene nel resto del corpo e ora stavano
mettendo a dura prova la sua resistenza. La malattia di Stewart avrebbe potuto benissimo evitare a Helen un'analoga
battaglia. Ci aspettavamo, infatti, che anche lei sarebbe stava colpita dalla stessa sindrome nello spazio di 48 ore. Una
tempestiva somministrazione di antibiotici riuscì fortunatamente a proteggerla.
42
La sindrome da shock tossico è un nemico da poco riconosciuto nella lotta cronica che conduciamo contro i batteri. Dopo aver abbondantemente sperimentato, alcuni stafilococchi hanno imparato come produrre, nelle debite circostanze, sostanze potenzialmente letali (le tossine), che causano quel tipo di collasso drammatico subito da Stewart.
Per quanto ne sappiamo, in precedenza nessun batterio aveva prodotto queste sostanze. Le circostanze ideali in cui i
batteri possono secernere le loro tossine contemplano la simultanea presenza di Staphylococcus aureus, di sangue mestruale e di tamponi, che forniscono, a quanto pare, l'ambiente ideale in cui i batteri possono accrescersi rapidamente e secernere tali tossine. Come è facile immaginare, le vittime più numerose dello shock tossico sono le donne, in genere di età inferiore ai trent'anni. Esse assorbono le tossine
attraverso la vagina.
Le avvertenze sulla necessità di essere prudenti nell'uso
dei tamponi e, in caso di impiego, sulla necessità di sostituirli frequentemente sono così diffuse e ormai ovvie che,
negli ultimi due anni, casi di shock tossico si sono verificati
con una frequenza molto minore. Tale sindrome è certamente un esempio di come i batteri possono modificarsi in
fretta per avere una migliore probabilità di sopravvivenza.
Pur avendo a disposizione il meglio nel campo della medicina moderna, rischiavamo di perdere Stewart. Un giovane
meno robusto di lui sarebbe sicuramente morto.
Di recente, gli scienziati hanno pensato che, non potendo
eliminare i batteri, forse si potevano usare a beneficio dell'umanità. Una cellula batterica, come qualunque altro tipo
di cellula, è una fabbrica entro la quale vengono prodotte
tutte quelle sostanze che i geni le ordinano di produrre. Siamo oggi in grado di inserire un gene, portatore di un messaggio specifico, in un cromosoma presente in numerose
cellule batteriche, modificando gli schemi sintetici di queste
cellule, in modo che producano qualcosa di specifico. Ogni
cellula non produrrà molto, naturalmente, ma quando le
cellule si riprodurranno alla velocità tipica dei batteri, non
43
vi sarà alcun problema. Miliardi di cellule potranno rapidamente essere messe all'opera, perché producano qualcosa di
specifico per quell'essere geniale che le ha soggiogate. In
questo modo, si possono ottenere in forma estremamente
pura grandissime quantità di insulina per i diabetici e di ormone di crescita per i bambini con sviluppo rallentato. Il
più delle volte il nostro sistema immunitario riesce a «giocare d'astuzia» con i batteri, anche se non sempre questo è un
compito facile.
I funghi
Mary Beth aveva sedici anni quando la vidi per la prima
volta. Si trovava nella nostra unità di cure intensive, con le
braccia avvolte da fitte bende e legate alle sponde del letto.
La notte prima aveva tentato di suicidarsi tagliandosi i
polsi.
Diversamente da molti aspiranti suicidi, Mary Beth aveva
veramente voluto togliersi la vita e ci era quasi riuscita.
Aveva perso molto sangue ed era ancora sottoposta a una
trasfusione. Era perfettamente consapevole e, quando mi
avvicinai al suo letto, mi fissò con uno sguardo assente.
Mary Beth aveva tentato di uccidersi perché si sentiva brutta. La sua era una bruttezza che faceva rabbrividire la gente: nel vederla, tutti si giravano dall'altra parte, evidentemente per l'imbarazzo di non riuscire a mascherare il proprio shock. Quale posto c'era, in questo mondo che venera
talmente la bellezza, per una ragazza di 16 anni così deturpata?
Il naso era grosso il doppio del normale ed era quasi totalmente ricoperto da una crosta nera. Anche la faccia era
quasi tutta cosparsa di ulcere profonde da cui fuoriusciva
pus; il labbro superiore era gonfio e attorcigliato. Avevo
già visto numerosi soggetti colpiti da un analogo male: una
malattia associata a una grave disfunzione del sistema immunitario.
Dopo che mi fu dato un distaccato assenso a continuare
44
l'esame sul resto del corpo, notai che Mary Beth aveva difficoltà ad aprire la bocca: era evidente, comunque, che la
lingua e l'interno delle guance erano ricoperti da una sostanza bianca lattiginosa. Il resto del corpo presentava ulcere isolate senza un ordine particolare. La pelle tra le gambe,
verso l'alto, era di colore rosso acceso, come lo era la vulva,
molto tumefatta. Dalla vagina le usciva un'abbondante scolo cremoso. La poveretta era stata colpita da un'infezione
provocata da un fungo (Candida albicans), chiamata candidiasi mucocutanea cronica. Era in grado di difendersi dai
batteri, ma non dai funghi. Questi agenti patogeni richiedono ciascuno un diverso sistema di difesa.
Tutti noi, nella nostra vita, siamo venuti in contatto con
qualche fungo. Le muffe sono funghi: possono svilupparsi
su un pezzo di pane o diffondersi lentamente sulla tenda
della doccia. Esistono letteralmente migliaia di funghi, la
grande maggioranza dei quali è del tutto innocua per l'uomo. I funghi sono anch'essi una forma di vita antica e ben
adattata e sono costituiti da numerose cellule unite in filamenti che si ramificano in modo caratteristico, assumendo
talvolta una struttura arborescente. In soggetti il cui sistema immunitario è represso, le infezioni fungine a carico
della cute, dell'intestino, dei polmoni e del cervello sono
estremamente frequenti. I funghi hanno spesso una limitazione geografica: certe malattie da loro provocate si riscontrano solo in certe zone del mondo. Il fungo che aveva ridotto così Mary Beth l'aveva colpita fin dall'età di sei settimane.
In realtà, Candida (chiameremo semplicemente così questa specie particolare) è il fungo meglio conosciuto dal nostro organismo, dato che si sviluppa nell'intestino di ciascuno di noi. E poiché l'intestino pullula di batteri (conseguenza inevitabile se si pensa a quello che introduciamo in bocca), sono stati messi a punto meccanismi di difesa per far sì
che i batteri non solo non ci danneggino, ma addirittura
operino a nostro vantaggio. I batteri sintetizzano vitamine e
degradano le proteine, aiutandoci a digerire e a riassimilare
45
le sostanze nutritive essenziali che mangiamo. Ma, come
abbiamo visto, essi possono molto facilmente sfuggirci di
mano e svilupparsi così rapidamente nell'intestino da sommergere i nostri meccanismi di difesa. Per impedire questa
evenienza, vengono poste in atto numerose strategie. Una
di esse utilizza Candida, facendola crescere nell'intestino in
modo che competa con i batteri per le sostanze nutritive essenziali. Viene mantenuto un equilibrio ecologico che impedisce uno sviluppo eccessivo sia dei batteri sia del fungo.
È molto facile, tentando di risolvere un problema, crearne un altro: questo è il caso dei bambini sottoposti a terapia
antibiotica contro, per esempio, un'infezione polmonare o
all'orecchio. Mentre eliminano l'infezione in questione, gli
antibiotici possono uccidere anche i batteri presenti nell'apparato gastrointestinale. Di conseguenza, Candida può diffondersi in tutto quest'apparato e fare la sua comparsa in
bocca come patina bianca che riveste la lingua (il «mughetto»). Può comparire anche a livello dell'ano e provocare irritazione alla cute circostante.
Data la vicinanza dell'ano alla vagina, nelle donne capita
frequentemente che l'infezione si estenda a questa parte, oltre che alla vulva, dove il fungo si sviluppa rigogliosamente
sulla mucosa tumida. In soggetti normali, ciò provoca solo
un'infezione superficiale, in cui il fastidio principale è dato
da uno scolo e da prurito. Raramente le nostre difese lasciano penetrare il fungo nei tessuti, in modo da agire in profondità. Al contrario, se il sistema immunitario è represso,
ciò avviene e allora possono svilupparsi patologie serie, come nel caso di Mary Beth. Gli immunologi sono oggi in grado di reintegrare nella loro piena attività i sistemi immunitari repressi dei pazienti in queste condizioni. Ne riparleremo più avanti: basta dire qui che Mary Beth ha combattuto
con coraggio la sua battaglia e oggi è una donna che lavora,
felicemente sposata e madre di figli.
46
I parassiti
Alcuni anni fa, nel Senegal occidentale, stavo guidando una
piccola Renault scalcinata sulla strada che conduce alla capitale, Dakar. Era una domenica pomeriggio e, accaldato e
assetato, fermai la macchina nei pressi di un minuscolo villaggio con la speranza di trovare un chiosco sul bordo della
strada, che vendesse Coca-Cola. Non ebbi fortuna, perché
non c'era alcun venditore nei dintorni e, di fatto, non si vedeva nessuno attorno alle sei-otto capanne che costituivano
l'abitato. Mi fermai allora sul lato della strada per bere un
poco della mia acqua minerale ormai calda e assistetti a una
scena di desolazione. Improvvisamente, da dietro le capanne, erette in un campo arido, sbucò un uomo alla guida di
quella che risultò essere una processione di una trentina di
persone, che procedevano lentamente e in fila indiana sul
terreno incolto vicino al punto dove avevo parcheggiato.
La processione era principalmente costituita da uomini,
tutti vestiti dalla testa ai piedi dei loro abiti migliori, avviluppati in lunghe, sciolte e voluminose vesti, malgrado il
caldo implacabile. Come molti abitanti di quella regione,
chi guidava la processione era un uomo molto alto e magro.
Si muoveva con determinatezza, ma lentamente, con le
spalle all'indietro e la testa alta, malgrado il piccolo fagotto
legato, che portava sulle braccia leggermente tese. Quando
la colonna si avvicinò, potei vedere le lacrime che scorrevano lungo le sue guance; egli non guardava, tuttavia, nella
mia direzione.
Subito mi resi conto che doveva trattarsi di un funerale.
Il capofila portava sulle braccia la salma del figlioletto e gli
abitanti del villaggio, così legati tra loro, si snodavano dietro di lui procedendo tutti verso il sepolcro, una fossa poco
profonda scavata sotto un albero di baobab. Li osservai
mentre seppellivano il bambino, e poi mentre pregavano e
ritornavano alle loro capanne, di nuovo in fila indiana, deferenti e spaventosamente tristi.
Mi diressi verso il gruppo e appresi un maggior numero
47
di particolari su quel triste evento. Quella mattina, un bambino di cinque anni era morto dopo quattro giorni di convulsioni quasi ininterrotte. Aveva contratto il «paludismo»,
cioè la malaria, che si era propagato al punto da coinvolgere il cervello e da provocare il decesso. Tre giorni prima era
stato consultato un guaritore ambulante, che aveva esaminato il piccolo (il quale si era tagliato con i denti la lingua a
metà) e aveva detto alla comunità allarmata, ma in fondo
neanche tanto sorpresa, che egli era stato colpito da malaria
al cervello e sarebbe morto da lì a poco. Né lui né alcun altro potevano fare qualcosa, disse loro mentre partiva.
Nel pieno della stagione della malaria, in paesi come il
Senegal non è raro che, nell'ospedale locale, muoiano da sei
a più bambini al giorno. Ogni anno milioni di individui soccombono a questa terribile malattia che mette a così dura
prova i meccanismi di difesa umani.
La malaria non è causata da virus o da batteri, e neppure
da funghi, ma da una quarta, e importante classe di microrganismi ostili: i parassiti.
A rigor di termini, parassita è qualunque organismo che
dipende in un modo o nell'altro, per la sua sopravvivenza,
da un altro organismo, senza contribuire al benessere o alla
sopravvivenza di quest'ultimo. In termini biologici, un virus può essere considerato un parassita. Tuttavia, quando si
parla di parassiti come esseri ostili si escludono i virus e, per
convenzione scientifica, si considerano solo quegli organismi complessi e generalmente di maggiori dimensioni che
infettano cronicamente gli esseri umani, particolarmente
nei paesi in via di sviluppo (questo è il termine più macroscopicamente improprio che vi possa essere). Malattie come
la malaria e altre dai nomi esotici (tripanosomiasi, leishmaniosi, filariasi e via dicendo) sono sicuramente responsabili
della maggior parte delle sofferenze e dei decessi umani che
si verificano nel mondo. La nostra capacità di fronteggiarne alcune sta facendo progressi, ma molte altre sopravanzano e in forma ancor più grave che in passato. Questo vale in
particolar modo per la malaria.
48
La zanzara che diffonde la malaria sta diventando sempre più resistente agli insetticidi, mentre il parassita che
provoca la malattia appare sempre più refrattario ai farmaci che vengono usati per curare l'infezione. E i governi, infine, sono sempre più restii a spendere le enormi somme di
denaro che servono a tenere il problema sotto controllo.
Mentre leggete queste parole, nel mondo almeno 200 milioni di persone ne sono affette. Soltanto in Africa, ogni trenta secondi un individuo muore di malaria. Ciò significa
3000 individui al giorno e più di un milione di individui all'anno. Tuttavia, la malaria non è soltanto un problema del
Terzo Mondo. Negli Stati Uniti circa 4000 casi vengono
abitualmente curati ogni anno e questo numero sta aumentando. I viaggi intercontinentali espongono molte persone
al rischio di essere infettate.
I parassiti si possono dividere in due gruppi principali: i
protozoi e gli elminti. I protozoi annoverano molti differenti tipi di organismi e il parassita della malaria è uno di essi.
«Elminti» è il termine tecnico al posto di vermi. Tre forme
di vermi banchettano sul corpo umano o, più correttamente, nel suo interno. Alcuni sono nematelminti, cioè vermi
dal corpo cilindrico, e comprendono l'ascaride, frequente
parassita dell'uomo. Altri sono platelminti, cioè vermi dal
corpo piatto come le sogliole, e annoverano le tenie, che
causano a noi e ai nostri cani una quantità di guai. La Taenia saginata è un piccolo verme da cui possiamo essere infettati quando mangiamo una deliziosa bistecca alla tartara. L'infestazione si verifica in tutti i paesi dove si consuma
carne bovina cruda o poco cotta, ma è particolarmente frequente in Messico e nell'America meridionale. Il terzo tipo
di vermi è costituito dai trematodi, che causano la schistosomiasi (detta anche bilharziosi) in 200 milioni di individui,
abitanti in 71 paesi sparsi in tutto il mondo. Il più piccolo
verme che infesta l'uomo può essere lungo soltanto due millimetri, mentre il più lungo può raggiungere i dieci metri.
Protozoi ed elminti trascorrono una parte del loro ciclo
vitale in un ospite intermedio, cioè vivono nel suolo, nel49
l'acqua o nei tessuti animali, ma possono migrare in un altro animale per svilupparsi in una forma adatta a infettare
un soggetto umano. Se l'anofele, la zanzara che diffonde la
malaria, potesse essere completamente sterminata, il problema della malaria sarebbe risolto.
Attualmente, in tutto il mondo, la malaria è la più grave
delle malattie infettive. Quando un'anofele si nutre di sangue umano, la puntura che pratica nella cute della vittima è
associata all'introduzione di saliva. Se la zanzara è infettata
da parassiti della malaria, questi si troveranno anche nella
saliva e passeranno così nel circolo sanguigno del soggetto
che viene punto. Dal foro dell'iniezione, essi si portano rapidamente al fegato, penetrando nelle sue cellule. Qui si
moltiplicheranno con prontezza, fino a quando queste povere cellule, comportandosi da ospiti involontari, scoppieranno letteralmente con tutto il carico di parassiti che portano al loro interno. Un parassita in una cellula è in grado
di produrre 40.000 duplicati di sé. I parassiti liberati dopo
che la cellula è esplosa cercano una nuova dimora. In milioni di anni hanno «stabilito» che per loro l'interno dei globuli rossi umani (eritrociti) è l'ambiente più congeniale.
I parassiti si attaccano alla membrana dei globuli rossi e
vi sprofondano. Poiché la loro sopravvivenza è della massima importanza, all'interno dei globuli si svolge un altro ciclo di moltiplicazioni. Dopo 48 o 72 ore (l'intervallo di tempo varia secondo i differenti membri della famiglia dei Plasmodium) dal momento dell'invasione, gli eritrociti scoppiano e migliaia di parassiti vanno alla ricerca di altri eritrociti da parassitare.
A questo punto si svolge uno dei più interessanti meccanismi di sopravvivenza di tutta la Natura. I parassiti avvertono che le loro attività possono uccidere l'ospite e, di conseguenza, devono fuggire in un altro organismo prima che
sia troppo tardi. Alcuni si moltiplicano nei globuli rossi
senza romperli e rimangono in attesa di una zanzara che
torni a nutrirsi di sangue.
Quando i globuli rossi infetti vengono risucchiati nell'ap50
parato digerente della zanzara, i parassiti li fanno esplodere
fuoriuscendone, si sviluppano in agenti infettanti maturi e
migrano nelle ghiandole salivari, pronti a partire per il
prossimo inebriante giro nel corpo di un povero vulnerabile
essere umano.
Molte persone muoiono di malaria perché i plasmodi, distruggendo moltissimi globuli rossi, causano una grave anemia, invadono il cervello e danneggiano a tal punto il sistema immunitario che l'organismo, così indebolito, cadrà vittima di altre infezioni. Tuttavia, la maggior parte di coloro
che sono stati colpiti stabilisce una tregua precaria con il nemico. Questo non li ucciderà ed essi non lo uccideranno: si
instaurerà così uno stato di malessere cronico. Questa forma cronica di infezione, molto frequente, ha un impatto sociale ed economico disastroso nei paesi in via di sviluppo.
Dal deserto del Sahara nell'Africa settentrionale al deserto del Kalahari a sud, il parassita Trypanosoma brucei provoca una delle malattie più gravi, addirittura letali: la malattia del sonno. Nell'America meridionale, un suo primo
cugino, il Trypanosoma cruzi, infetta molti milioni di individui, provocando gravi danni al cuore e all'apparato gastrointestinale.
Il parassita che provoca la malattia del sonno in Africa
viene trasmesso agli esseri umani da numerose specie di mosca tsè-tsè. Alcune forme vivono solo negli animali e non
sono direttamente pericolose per l'uomo, pur danneggiandolo di sicuro in maniera indiretta. Si ritiene impossibile allevare animali a scopo alimentare in più di dieci milioni di
chilometri quadrati, semplicemente per la presenza di mosche tsè-tsè. Tutti gli animali che fossero trasportati in quest'area morirebbero di malattia del sonno.
Gli esseri umani infetti sviluppano caratteristiche ben definite. Il loro viso assume un'espressione assente, le palpebre si abbassano di continuo come se fossero appesantite
dalla stanchezza e il labbro inferiore pende senza ritegno.
Diventa sempre più difficile mantenere vigile il paziente e
attirare la sua attenzione. Se gli viene messo il cibo davanti
51
mangia, ma non lo chiederà mai. Non avvierà mai una conversazione e diventerà sempre più chiuso in se stesso fino a
quando il coma e le convulsioni segnaleranno il passaggio
alle fasi finali della malattia.
La mosca tsè-tsè preleva i parassiti da vari animali, per
esempio dal tragelafo striato. I parassiti rimangono quindi
in attesa all'interno di quest'ospite intermedio fino a quando questo pungerà un essere umano. Trasferiti sotto lo strato superiore della cute, i tripanosomi, che sono filiformi
con una coda mobile, sprofondano nella cute per poi passare dal circolo sanguigno al cuore ed elettivamente al cervello. È proprio la distruzione di quest'ultimo organo che provoca la «malattia del sonno».
Se non curata, essa è sempre fatale. Diversamente da
quello che succede con la malaria, la protezione personale
dei viaggiatori in aree in cui essa costituisce un problema
non può essere garantita. Tuttavia, repellenti contro gli insetti e indumenti protettivi sono in genere efficaci; inoltre,
solo il 5 per cento delle mosche che si trovano in qualsiasi
area endemica è infettato dal parassita.
Dal Cile e dall'Argentina fino al Messico, la malattia del
sonno colpisce più di 12 milioni di sudamericani ed è la causa prima delle malattie cardiache. Il 25 per cento dei decessi
che si verificano in persone tra i 25 e i 44 anni di età è attribuito alla tripanosomiasi. Nell'America meridionale, tuttavia, la malattia non viene trasmessa da mosche, ma da piccole cimici, conosciute localmente, e con valide ragioni, come cimici assassine. Talvolta, sono anche chiamate cimici
«baciami». Questi deliziosi esemplari sono diffusi in tutta
l'America meridionale e vivono, di preferenza, nelle tane
degli animali, anche se possono insediarsi nelle fenditure o
nelle canne con cui vengono costruite le povere capanne dei
contadini. Le cimici escono di notte dai loro nascondigli per
nutrirsi di sangue e avanzano lentamente sui corpi umani
alla ricerca del punto adatto da morsicare: non la pelle, ma
la delicata mucosa, che trovano in genere sulle labbra della
vittima, laddove la cute più resistente cede il passo alla sot52
tile membrana che riveste poi l'interno della bocca. In questo punto esse «baciano» le loro vittime: spesso morsicano
l'angolo dell'occhio, se raggiungono prima questa posizione.
Diversamente dalle mosche, le cimici non iniettano i parassiti nel sangue della vittima. Ma da otto a dieci giorni
prima del banchetto, ingeriscono i parassiti, che hanno raggiunto la maturità nel loro stomaco, e quindi hanno il massimo di infettività. Quando morsicano la vittima e le succhiano un poco di sangue, svuotano di riflesso l'intestino e
fanno cadere il materiale fecale, ricco di parassiti, nella ferita provocata dalla morsicatura. Per questa forma americana della malattia non esiste alcun tipo soddisfacente di
trattamento.
In parti dell'Europa, dell'Asia, dell'Africa e dell'America centrale e meridionale, si trova una malattia debilitante,
la leishmaniosi o kala-azar. Le leishmanie vivono in generale nei cani e nei roditori e vengono trasmesse agli esseri
umani da flebotomi succhiatori di sangue. Nell'area mediterranea circa il 10 per cento dei cani è infetto, mentre nelle
regioni meridionali dell'Unione Sovietica lo è circa il 90 per
cento dei gerbilli selvatici. Quando si nutrono, le femmine
dei flebotomi aspirano i parassiti nel proprio intestino,
comportandosi così da ospiti intermedi. Allorché pungono
un essere umano, iniettano in esso i parassiti, che nel frattempo hanno raggiunto la maturità. Le vittime umane sono
più di 12 milioni.
Dopo un'incubazione di tre mesi, può comparire la febbre, associata a un rigonfiamento delle ghiandole linfatiche, a un'accelerazione del polso, a diarrea e a tosse. Il midollo osseo risulta infettato e, di conseguenza, i globuli rossi che vengono generalmente prodotti in esso si impoveriscono e possono instaurarsi anemie e infezioni. Nel 90 per
cento dei colpiti, la morte sopraggiunge tra i tre e i trenta
mesi. Tuttavia, la malattia, se viene colta in tempo, può essere curata in modo adeguato.
La schistosomiasi (bilharziosi) è la più grave elmintiasi
53
(infestazione da vermi) che colpisce l'uomo. Ne sono affetti
più di 200 milioni di individui che vivono fra il Tropico del
Cancro e il Tropico del Capricorno. Più di mezzo milione
di persone, che ora si trovano negli Stati Uniti, ne è rimasto
vittima prima di prendere la residenza in questo paese. I parassiti che la provocano sono trematodi della famiglia schistosomitidi. Vivono nelle vene che drenano il sangue dall'intestino al fegato e in esse, come pure nella vescica, nel
colon, nel fegato stesso, nei polmoni e nel cervello, e vi depongono le uova. Provocano, di conseguenza, gravi lesioni
all'organismo che li ospita.
I vermi adulti hanno una lunghezza variabile da uno a
due centimetri e si sviluppano nell'area epatica. I maschi
presentano un solco centrale che decorre per tutto il corpo e
dentro al quale la femmina rimane giorno e notte, nutrendosi di continuo e simultaneamente accoppiandosi.
Gli schistosomi possono vivere una trentina d'anni e possono deporre fino a 3000 uova al giorno. Il maschio trasporta la femmina controcorrente rispetto al flusso sanguigno, proprio come un salmone che, per andare a riprodursi,
risale con fatica i corsi d'acqua. In questo modo le uova
vengono deposte in molti differenti luoghi. Alcune sopravviveranno e secerneranno una sostanza che danneggia i tessuti circostanti. Alcune devono, per assicurare la sopravvivenza della specie, raggiungere la vescica o il colon in modo
da poter fuoriuscire dall'organismo con le urine o con le feci. (Come abbiamo già visto, i parassiti devono avere la certezza di poter penetrare in un nuovo organismo se uccidono
il primo ospite.)
I vermi che vengono depositati sul terreno assieme alle
urine o alle feci attendono lì la loro prossima vittima. Per
sopravvivere devono però, entro otto giorni da quando
hanno abbandonato l'ospite, trovare una chiocciola ed entrarvi; in essa si moltiplicano e poi l'abbandonano di nuovo
per portarsi nell'acqua, dove si attaccano alla cute di qualsiasi essere umano che passi nelle loro vicinanze, sprofondando in essa. Non c'è da meravigliarsi che la malattia sia
54
così diffusa nei paesi del Terzo Mondo, in cui le colture di
riso sono concimate con feci umane. Il suo controllo è
estremamente difficoltoso, poiché richiederebbe profondi
cambiamenti nel costume e, d'altra parte, non è disponibile
per la cura alcun sussidio farmacologico veramente utile.
Le tenie sono vermi nastriformi, segmentati e ermafroditi. Vivono nell'intestino di molti vertebrati e, diversamente
da altri vermi, non hanno sistema digerente; pertanto assorbono le sostanze nutritive dall'intera superficie corporea.
Sul capo hanno una ventosa, mentre sul collo sono localizzati piccoli uncini. Ventose e uncini servono loro per attaccarsi saldamente alla parete intestinale. La parte superiore
della tenia si accoppia con quella inferiore. Il gruppo nel
suo complesso è cosmopolita; comprende differenti specie a
distribuzione geografica più circoscritta.
La più drammatica infezione da tenie è la difillobotriasi,
comune nei paesi baltici e scandinavi, oltre che in Giappone
e in Russia. Il verme viene ingerito da pesci, che lo trovano
in mare, dove viene riversato assieme alle acque di fogna.
Se i pesci vengono mangiati crudi (come spesso avviene), il
verme trova un'occasione ideale per penetrare in un nuovo
ospite. Può allora accrescersi in esso e raggiungere i dieci
metri di lunghezza; può vivere fino a venticinque anni. Una
volta diagnosticata, l'infezione può essere curata. Forse il
suo aspetto più straordinario è che, spesso, il paziente accusa solo sintomi secondari: qualche disturbo addominale e
anemia. Di tanto in tanto, i vermi lasciano spontaneamente
l'ospite umano. Questo rimarrà per un certo periodo alterato, se non fisicamente, almeno psicologicamente.
Il 25 per cento della popolazione mondiale è infettato da
un nematode, l'ascaride. Gli adulti di questo verme possono raggiungere i 40 centimetri di lunghezza. La femmina riversa milioni di uova nella massa fecale nel corso della sua
esistenza, che varia dai sei ai diciotto mesi: la quota giornaliera è di circa 200.000 uova al giorno. Liberate da ogni vincolo con l'ospite, le uova possono permanere nel suolo per
circa sei anni e penetrano nella loro prossima vittima quan55
do questa ingerirà cibo e terra contaminati. In climi aridi e
ventosi, le uova possono venire trasportate dall'aria ed essere ingerite inavvertitamente. Il danno provocato dall'ascaride è limitato all'intestino e ai polmoni; in generale, la maggior parte dei pazienti ha meno di cinquanta vermi in corpo
in qualunque momento, ma la cifra di 2000 non è rara. La
terapia è soddisfacente, ma solo l'istruzione e un'igiene personale di prim'ordine, assieme ad attrezzature sanitarie
adeguate, ridurranno l'entità degli attacchi di questo molesto parassita.
Ora che abbiamo dato un'occhiata al nemico, possiamo
rivolgere la nostra attenzione a quell'esercito di cui la Natura ci ha dotato per la nostra difesa.
56
L'organizzazione delle difese
Proprio come gli arsenali moderni cambiano in continuazione a mano a mano che le armi di un potenziale nemico diventano sempre più sofisticate, il nostro sistema immunitario si è adattato a più riprese alle contromosse che il mondo
microbico ha messo in atto per proteggere se stesso e sopravvivere. Tutti gli esseri viventi sono soggetti alle rigide
regole imposte dalla Natura per la selezione naturale, regole
che si sintetizzano nel principio della «sopravvivenza del più
idoneo». Data la capacità che hanno i geni di ristrutturarsi,
nessuna specie vivente è destinata a rimanere bloccata in un
progetto di sopravvivenza inadeguato. Le pressioni in mezzo alle quali vive (o, ancor meglio, in mezzo alle quali non
riesce a vivere), spingono al cambiamento. Così, per la maggior parte del tempo, gli avversari biologici hanno investito
il grosso delle loro energie naturali in tentativi per superarsi
reciprocamente in astuzia, e quindi per sopravvivere.
Il cambiamento nel mondo naturale può essere rapido: in
pochi anni, molti batteri sono diventati resistenti a determinati antibiotici; tuttavia, il più delle volte, il cambiamento è
molto lento in rapporto agli standard umani. Quando si
parla di difese dell'organismo, si vuole indicare un sistema
che si è evoluto per centinaia di milioni di anni tra specie in
via di sviluppo. Ed era già a uno stadio progredito quando,
dai 40.000 ai 50.000 anni fa, gli esseri umani cominciarono
le loro lotte con i parassiti e con altri nemici. Occorre molta
umiltà per pensare che, se la storia della Terra potesse esse57
re condensata in 24 ore e, nell'ultimo secondo prima della
fine di questo giorno, si emettesse un fascio di luce, questa
luce momentanea rischiarerebbe tutto il tempo da noi trascorso sul pianeta che crediamo oggi di dominare.
Se potessimo risalire a quel tempo primitivo in cui i lombrichi cominciarono a scavare nel suolo e le prime meduse
sciabordavano contro le linee costiere che si stavano modellando, troveremmo che queste creature semplici avevano
già avviato quegli esperimenti accurati che avrebbero portato ad assemblare l'apparato necessario per difendersi. Da
quegli inizi modesti si è sviluppato il nostro sistema immunitario moderno che, come vedremo, è complesso. Questa
complessità è la risultante di tutta una serie di successivi
perfezionamenti tanto importanti quanto apparentemente
impercettibili. Il suo sviluppo è in un certo senso analogo al
modo in cui si è gradualmente e logicamente sviluppata la
complessità di una sinfonia di Mahler dalle semplicissime
armonie del madrigale rinascimentale.
Il sistema che stiamo per analizzare è straordinariamente
potente. Solo poche minuscole cellule del sistema immunitario di un topo, quando vengono iniettate in un animale di
un ceppo leggermente diverso, in cui è stata deliberatamente paralizzata l'attività immunologica, possono distruggerlo
grazie alla violenza dell'attacco che sarà da loro lanciato
nello spazio di alcuni giorni.
Una potenza di questo tipo apporta, oltre a benefici, vari
problemi. In buona parte, la necessaria complessità del sistema immunitario è generata dall'esigenza di controllare
queste forze all'interno del nostro corpo. Di tutti i meccanismi di controllo che abbiamo ereditato da millenni di sperimentazione, ve n'è uno con cui il nostro sistema di difesa ha
avuto soprattutto a che fare. È un meccanismo che dovrebbe impedirci di fare il più spaventoso di tutti gli errori immunologia: quello di attaccare se stessi.
Chi si erge a sempre vigile difensore di quell'ambiente sacrosanto che è il nostro corpo dovrebbe rapidamente individuare e rimuovere qualunque entità estranea che tenti di in58
vaderlo. Tuttavia, può essere molto difficoltoso trovare
certi invasori e riconoscerli come tali e questo perché alcuni
fra essi presentano sorprendenti somiglianze, a livello molecolare, con le nostre stesse strutture costitutive, a tal punto
da riuscire ad ingannare il nostro sistema di controllo e vigilanza. Può essere altrettanto arduo per il nostro sistema immunitario scoprire un'entità estranea quanto lo sarebbe per
un caucasico individuare un intruso cinese a una cerimonia
affollata sulla piazza Tien an men di Pechino.
Il nostro sistema immunitario è all'altezza di questo compito quando tutto funziona regolarmente, ma per alcuni dei
nostri nemici l'assomigliare a noi può essere molto vantaggioso per la loro sopravvivenza. Per esempio, parte dei batteri che vivono nel nostro intestino hanno caratteristiche
molto simili a quelle delle cellule intestinali.
Considereremo il nostro arsenale immunologico e i suoi
impieghi da un punto di vista evolutivo, partendo dal sistema più primitivo per raggiungere, aggiungendo strato dopo
strato, una visione globale dell'intero sistema.
Immaginate di dover controllare il sistema di sicurezza di
un ultraimportante, ultrasegreto complesso industriale e di
trovare che è stato progettato nel seguente modo: tutto il
personale autorizzato nell'impianto e tutte le merci che sono state legittimamente introdotte in esso esibiscono, in posizione evidente, un cartellino di identificazione di colore
vivace. Qualunque cosa, o qualunque persona, che non esibisca questo cartellino sarà considerata un pericolo da rimuovere rapidamente. È stato perfezionato un sistema in
cui personale del servizio di sicurezza non fa altro che perlustrare di continuo il complesso, alla ricerca di ciò che non
è in regola.
Poiché il complesso è così vasto e l'area così varia, coloro
che effettuano la sorveglianza sono specializzati e ciascuno
è istruito in modo da identificare una certa situazione specificatamente sospetta. Per esempio, un impercettibile cambiamento in un programma specifico per far funzionare un
calcolatore oppure un riassetto nel modo usuale di sistema59
re la merce confezionata nei grandi magazzini sarebbe riconosciuto da differenti gruppi come deviazione dal normale.
Queste persone che ispezionano non sono istruite per correggere il problema nel quale si imbattono, ma hanno piuttosto l'autorità e la capacità di segnalarlo in modo appropriato per attivare le opportune forze di sicurezza che possono fisicamente affrontarlo. Poiché situazioni diverse possono richiedere differenti tipi di risposta, molti sistemi di
arma sono a disposizione delle forze di sicurezza del complesso e possono essere attivati individualmente. Spesso,
però, se il complesso è gravemente minacciato, possono essere utilizzati simultaneamente molti sistemi d'arma per assicurare l'efficienza massima nello sforzo di difesa.
Se un possibile sabotatore penetrasse nel complesso nelle
prime ore del mattino, gli ispettori riconoscerebbero l'eventualità che egli sia un intruso, e per verificare tale ipotesi si
servirebbero di un sistema televisivo a circuito chiuso in
grado di riprendere la persona sospetta e fissare il suo volto
con un'immagine ravvicinata sulla metà dello schermo di
un monitor. Un calcolatore passa in rassegna tutte le caratteristiche fisiche del personale legittimo del complesso, che
compaiono sulla seconda metà dello schermo, dimodoché
con incredibile precisione vengono confrontate le sembianze della persona estranea e dei componenti legittimi dell'azienda. Attraverso tale procedura si determineranno le
istruzioni per gli uomini della sicurezza di questa «prima linea di difesa» essenziale, i quali potranno allora essere sicuri che quel soggetto è proprio un intruso e giustificare così
la severità della risposta che devono mettere in atto.
Nel momento in cui sono certi della gravità della situazione, questi strateghi devono allertare i «soldati» addetti all'impianto riguardo al pericolo e dirigerli verso il bersaglio.
I soldati sono un'organizzazione strutturata su una gerarchia basata sull'intelligenza e sull'addestramento. Certuni
sono dotati di apparecchi riceventi per captare i messaggi
che provengono dagli ispettori che hanno localizzato l'infrazione. Poiché anche questi elementi sono molto specia60
lizzati, un ispettore addestrato per riconoscere il particolare
problema incontrato attiverà lo specifico segmento del
gruppo di risposta preposto per affrontare quel particolare
problema.
Un gruppo di risposta includerà commando che guideranno un reparto di individui variamente armati nella zona
di guerra, incitandoli ad attaccare. Alcuni di questi reparti
tattici potranno essere maggiormente impegnati nell'azione
di disarmo e di immobilizzazione che non nell'uccisione diretta. 11 modo di procedere del gruppo è così ben organizzato da prevedere che alcuni uomini siano specificamente addetti alla ripulitura, rimuovendo i cadaveri e altri resti dal
campo di battaglia, che si è svolta fuori dall'impianto, in
modo che la pace possa regnare di nuovo.
Ora, come ben potete immaginare, la battaglia sarà breve
o protratta, violenta o meno violenta, secondo la rapidità
con cui l'intruso verrà riconosciuto (una volta che si sia insediato in un luogo sicuro, potrà essere molto più difficile
snidarlo), le armi di cui egli dispone per difendersi e le forze
che lo stabilimento può effettivamente schierare. Una cosa
è certa: in questo impianto estremamente sofisticato, dotato di un equipaggiamento prezioso e sensibile, va assolutamente evitato l'impiego di forza non necessaria. Non ha
nessun senso sparare sull'intruso nella stanza del calcolatore e, nel contempo, danneggiarla irrimediabilmente. Qualche danno secondario può essere tollerato, ma appena possibile bisogna sempre ridurre al minimo questo rischio.
Come è facile immaginare, i commando possono lasciarsi
trasportare dal successo in battaglia e usare un missile laddove una granata a mano sarebbe stata più che sufficiente.
Pertanto, quando gli ispettori allertano il reparto che deve
reagire, passano anche la stessa informazione al gruppo che
è responsabile della gestione dello stabilimento che da questo momento avrà il controllo sulle varie operazioni. Dovrà
determinare la natura e l'intensità della risposta da dare,
poiché è sotto la sua responsabilità assicurare che tale risposta sia appropriata: si dovrà impegnare una forza sufficien61
te per realizzare l'intervento, ma senza eccedere, poiché gli
eccessi possono danneggiare senza necessità l'impianto.
I responsabili della gestione sono anche addestrati specificamente per riconoscere chi è della famiglia e chi no, potendo in tal modo controllare il potere decisionale del gruppo che ha lanciato l'allarme. Attraverso comunicazioni radio, questi supermanager possono intervenire con autorità
massima sia sugli ispettori sia sui soldati. In questo modo
viene mantenuta la sicurezza e il danno all'impianto è ridotto al minimo.
Un attacco a uno stabilimento del genere è sempre istruttivo e una sicurezza ben gestita vuole rafforzata l'area in cui
un attacco, o un'infrazione, ha avuto in precedenza un esito positivo, anche solo parziale. Se, in due occasioni, degli
intrusi hanno avuto un certo successo entrando nello stabilimento attraverso i grossi condotti per il condizionamento
dell'aria, il gruppo che sorveglia questo settore sarà adeguatamente potenziato ed attrezzato per rispondere più rapidamente e intensamente, nel caso di un nuovo assalto a quest'area.
La specializzazione del lavoro di ciascuno di questi gruppi richiede un notevole addestramento del personale. Non
sorprende che vi siano delle istituzioni in cui sia possibile
acquisire e perfezionare queste capacità, in modo che i candidati che hanno superato con successo l'esame di licenza
siano pronti per svolgere un ruolo particolare nella catena o
nella rete di misure di sicurezza che proteggono l'impianto.
Il breve brano immaginario appena riportato contiene,
come avrete senza dubbio indovinato, i principali tratti distintivi del sistema immunitario umano. Ora descriveremo
lo sviluppo di tale sistema biologico che opera sulla base dei
suddetti principi.
Dieci milioni di anni fa, quando la Natura stava progettando i suoi primi meccanismi difensivi, vennero costruite
cellule in grado di rimuovere grossi pezzi di materiale estraneo penetrati nell'organismo. Quell'unico tipo di cellule
reagiva indiscriminatamente a tutte le minacce, non esisten62
do ancora meccanismi di controllo. Per esempio, una medusa poteva rigettare in modo non specifico una spina che
si fosse conficcata nella sua massa corporea. Quindi, col
trascorrere di molti anni, vennero aggiunte al repertorio difensivo di quelli che erano ancora, sotto molti aspetti, animali primitivi cellule in grado di riconoscere gli antigeni
(qualunque corpo estraneo che penetrasse nell'organismo) e
di attaccarli, e nel corso di successive fasi dello sviluppo
comparvero pure i meccanismi di controllo. A grandi linee
questa è la storia evolutiva di quel sistema generalmente superefficiente che abbiamo la fortuna di possedere.
Ora è interessante esaminare nei particolari tale processo
evolutivo, osservando come un minuscolo feto umano, che
ha all'origine solo poche cellule, riesce a edificare la complessità del proprio sistema immunitario. Dopo alcune settimane soltanto di vita intrauterina, il feto ricapitola tutte le
fasi evolutive che si sono svolte prima di lui; in questo modo, ciascuno di noi, durante questa fase dello sviluppo, diventa un libro di storia biologico.
Il timo è l'anima del sistema immunitario e i suoi principali prodotti sono i linfociti T (T da timo), o cellule T. Esso
è situato appena sopra il cuore e avvolge intimamente i
grandi vasi che portano il sangue alla pompa della vita e lo
riportano poi verso la periferia. È già in questa posizione
quando il feto umano ha soltanto 10 settimane di vita. Ogni
ghiandola si sviluppa con la saggezza genetica delle età manifestate nelle cellule del suo archivio biologico, a completa
disposizione delle cellule neofite che, durante il loro soggiorno nella ghiandola, apprenderanno quelle capacità che
hanno un'importanza vitale.
Il timo, per poter attirare le cellule dentro di sé e istruirle,
secerne sostanze che ne attraggono irresistibilmente certune, in maggioranza provenienti dal fegato del feto. Quest'organo ha una scarsa attività durante la vita fetale, in
confronto al ruolo importantissimo che svolge dopo la nascita, ma è molto importante la sua funzione generatrice di
cellule multipotenti. Nelle primissime settimane di vita,
63
queste cellule «staminali» primitive (vengono chiamate così) abbandonano il fegato e si diffondono nel corpo attraverso i vasi sanguigni. Come è già stato spiegato, ciascuna
di esse rinserra nel proprio nucleo tutta l'informazione genetica disponibile per l'organismo nel suo insieme. L'espediente che trasformerà la cellula staminale «primitiva», non
istruita, in elementi utili della macchina corporea comporta
l'attivazione di programmi genetici specifici all'interno di
una cellula particolare.
Rispondendo alla sollecitazione del timo, alcune cellule
del fegato fetale cominciano a occupare gli spazi vuoti nel
suo interno. Una volta che si sono insediate, il timo deve tener conto di ciascuna cellula dei miliardi di cellule che faranno parte del sistema immunitario umano. Il soggiorno
nel timo non è agevole: il 95 per cento delle cellule che vi entrano moriranno.
Le cellule che sopravvivono vengono in contatto fisico
con ormoni specifici secreti dal timo. Questi ormoni possono penetrare nelle cellule neofite e, una volta dentro, possono influenzarne il nucleo e attivare la loro potenzialità di essere linfociti T.
A questi linfociti T che proliferano viene prima di tutto
insegnato a riconoscere se stessi. Per il riconoscimento di
sé, ogni cellula del nostro corpo, davvero singolare, espone
una raccolta di proteine praticamente uniche. Ciò rappresenta, per le cellule del sistema immunitario, una specie di
specchio biologico in cui potersi guardare e simultaneamente confrontare con l'oggetto estraneo. Fin dallo sviluppo
iniziale del sistema immunitario, nulla è più importante dell'accertarsi che non vengano attaccati i propri tessuti.
La membrana esterna di ogni linfocito T assume una caratteristica fisica specifica, che complementa (nel senso di
immagine speculare) quei marchi di fabbrica biologici, o
antigeni «del sé» (self antigens, in inglese), come sono chiamati con maggiore precisione, che sono esposti su tutte le
cellule umane.
Il concetto di antigene «del sé» è importante. A prima vi64
sta il termine può sembrare contraddittorio. Abbiamo definito prima l'antigene come qualcosa di estraneo al nostro
corpo e, pertanto, in grado di avviare una risposta immunologica. 11 termine, invece, viene applicato ai nostri marchi di fabbrica biologici perché, come diremo nel capitolo
sui trapianti, sono proprio questi antigeni «del sé», presenti
sulle cellule dell'organo offerto da un donatore, a stimolare
la reazione del sistema immunitario di chi riceve il trapianto. Questi antigeni possono anche essere chiamati antigeni
di istocompatibilità (isto = tessuto), un altro termine preso
in prestito dalla biologia dei trapianti. L'insistenza della
Natura a considerarci tutti entità immunologiche individuali rende molto difficoltosi i trapianti di organi da un essere
umano all'altro.
In un certo senso, questi antigeni «del sé» provocano, e
devono provocare, una risposta da parte del nostro sistema
immunitario, anche se non si tratta di una risposta aggressiva. I linfociti T possono interagire fisicamente con le nostre
cellule corporee. Se la connessione è perfetta, la cellula sa
immediatamente di aver riconosciuto il «sé» e non qualcosa
di estraneo. Il riconoscimento del «sé» è un preliminare essenziale per poter programmare le cellule a riconoscere l'aggressore.
Quando un singolo linfocito T abbandona il timo, comincia a svolgere il proprio ruolo di protettore dell'organismo umano. Da solo può compiere questa funzione per sessant'anni. All'interno del timo, ogni linfocito T è programmato per riconoscere un oggetto estraneo e soltanto uno
(per esempio, una parte specifica del virus del morbillo). La
regola è: un linfocito T, un antigene. Poiché il corpo, data
la sua fragilità, ha molti nemici, è necessario programmare
nei linfociti T che fuoriescono dal timo la capacità di riconoscere un milione o più di antigeni distinti. La membrana
di ogni linfocito T possiede una miriade di recettori identici, conformati in modo tale che l'unica cosa in grado di interagire perfettamente con loro è l'antigene specifico che il
linfocito deve riconoscere. Ogni linfocito T, dunque, ha la
65
capacità di riconoscere simultaneamente una componente
del sé e qualcosa di estraneo.
Quando ho detto che i linfociti T imparano a riconoscere
il «sé», ho spiegato che il «sé» doveva, in questo senso, essere inteso come «marchio di fabbrica» universale. Ogni
cellula del corpo, tranne i globuli rossi del sangue, espone
lo stesso insieme di proteine caratteristiche sulla propria superficie. Le membrane delle cellule renali e gastriche mostrano le bandierine che proclamano un'unica nazionalità
biologica. Le cellule espongono fino a otto marcatori principali, che dichiarano che siamo noi stessi in modo unico,
più una miriade di marcatori meno importanti.
Per essere precisi, quegli otto marcatori non sono unici in
assoluto per un singolo individuo. Gli scambi e le combinazioni che la Natura può effettuare con essi sono in numero
finito. Pertanto, siamo in grado di calcolare che all'incirca
due persone su 200.000 sono identiche. Questo fatto è molto importante quando si ha a che fare con i trapianti di tessuti o di organi.
Certi linfociti T vengono programmati nel timo non solo
per riconoscere questi specifici marcatori del «sé», ma anche quei marcatori unici che dichiarano che una cellula renale non è una cellula di un pelo, la quale a sua volta non è
una cellula cerebrale. La Natura, nello sforzo che compie
per assicurare che sia da noi riconosciuta qualunque cosa
estranea, ha stabilito che il timo deve generare cellule che
possono riconoscere tutto. Ciò significa, per esempio, che
nella circolazione sanguigna è possibile trovare un linfocito
T in grado di riconoscere il virus del morbillo accanto a un
linfocito T in grado di riconoscere un marcatore unico sulle
cellule della tiroide. Un linfocito T programmato per riconoscere tali cellule ha comunque la stessa capacità di attaccare la tiroide del linfocito T programmato per attaccare il
virus del morbillo.
Questo è, chiaramente, uno dei pochi errori compiuti dal
Grande Immunologo in cielo. Poiché, nell'organismo, circolano cellule che possono riconoscere tessuti specifici esat66
tamente nello stesso modo in cui altre cellule possono riconoscere oggetti estranei, gli esseri umani diventano vittime
potenziali dell'autoimmunità, cioè del fatto che il sistema
immunitario si rivolta contro il «sé». Ciò accade con una
relativa frequenza. Se i linfociti T che reagiscono contro il
«sé» non si fermano, potremmo concludere la nostra esistenza con malattie come l'artrite reumatoide, l'anemia perniciosa, il diabete, la tiroidite e una schiera di altri malanni.
La Natura, nel programmare il riconoscimento, da parte
dell'organismo, letteralmente di tutto ciò che esiste sulla
Terra, non è stata in grado di programmare fino in fondo il
riconoscimento delle caratteristiche dei nostri singoli tessuti.
L'avere dentro di noi queste «bombe a orologeria» potenzialmente autoreattive significa che esse devono venire
selettivamente controllate. In altre parole, a un linfocito
che tenderebbe ad attaccare il polmone, si deve «dire» di
non farlo: il tessuto che viene riconosciuto, cioè il tessuto
polmonare, non è il vero nemico. Si ricordi l'ispettore nella
fabbrica di munizioni che vagliava i sospetti degli altri prima che avesse luogo un attacco.
Poiché molti linfociti T possono vivere una sessantina
d'anni, le istruzioni che contengono non devono essere ripetute di frequente e, in generale, ciò va bene. Conviviamo
con i potenziali attaccanti del nostro io, controllandoli meticolosamente. Il problema biologico che deve essere ancora
risolto è correlato, naturalmente, con la programmazione
interna del riconoscimento della vera estraneità, mentre viene programmato verso l'esterno il riconoscimento del «sé».
Per questo compito sarebbero necessarie così tante informazioni genetiche che occorrerebbero probabilmente alcuni
cromosomi supplementari se tentassimo di sviluppare un simile sistema. Sembra essere questo il motivo per il quale la
Natura ha dovuto giungere a un accomodamento per un
compromesso potenzialmente pericoloso.
I linfociti T, di cui abbiamo parlato, sono progettati per
dare l'allarme immunologico quando l'integrità dell'organi67
smo viene violata. Sono noti come linfociti T induttori (un
nome più preciso di quello di linfociti T coadiuvanti, in inglese helper, usato fino a quando nozioni più recenti hanno
suggerito il cambiamento). Vi sono, però, quattro tipi principali di linfociti T.
Perché? potreste chiedervi. Perché non un tipo soltanto,
che riconosca l'antigene e lo distrugga senza tanto chiasso?
È necessario che il sistema sia più complesso per ragioni
evolutive ben fondate. Tanto per cominciare, ci occorrono
differenti tipi di linfociti T per disporre di differenti tipi di
meccanismi di attacco: l'eliminare un verme di dieci metri è
un compito ben diverso dallo sconfiggere un virus misurato
in micron. Cosa più importante, tuttavia, è che la diversità
tra i linfociti T offre migliori meccanismi di controllo per le
violente reazioni che si svolgono durante il conflitto. Una
rete di cellule integrate è meno pericolosa nel caso che una
parte dell'apparato immunologico sia danneggiata. In un
simile frangente è meglio non avere tutte le uova (i linfociti
T) in un unico paniere.
I linfociti T induttori hanno la particolare proprietà di allertare altre cellule e di spingerle all'attacco. Quando avvertono la presenza del nemico, possono liberare una sostanza
simile agli ormoni, l'interleuchina, che hanno immagazzinato nel citoplasma e che porta i messaggi da un globulo
bianco, o leucocito, all'altro. Tutti i linfociti T sono membri della famiglia dei leucociti, di cui parleremo con maggiori particolari più avanti.
Un altro gruppo di cellule viene preparato nel timo per
poter circolare nel corpo alla ricerca del proprio antigene.
Tuttavia, quando queste cellule avvertono la presenza dell'antigene, devono attendere un segnale dai linfociti T induttori, che danno loro il permesso di attaccare. Il messaggio per questi linfociti T che devono attaccare giungerà sotto forma di interleuchina o di altre sostanze ad essa affini.
Le «istruzioni» date alle cellule sono sufficientemente
chiare: se avvertite quello che pensate essere il nemico in
quanto si adatta bene al vostro recettore di membrana, date
68
un colpo d'occhio al «sé» per essere sicuri che sia diverso e,
in caso positivo, preparatevi a piombargli addosso. Se la
vostra valutazione della situazione è giusta, i linfociti T induttori invieranno l'interleuchina. Una volta che avrete reagito con questa sostanza, saprete di poter attaccare.
Interessante anche la procedura di uccisione ed eliminazione degli invasori ad opera dei linfociti T, che li uccidono
e li rimuovono nell'uno o nell'altro dei due modi, anche se
entrambi i sistemi di difesa vengono spesso fatti intervenire
contemporaneamente nella lotta.
Un particolare insieme di linfociti T ha la capacità di lanciare un attacco contro un nemico, liberando sostanze in
forma di enzimi (facilitanti una reazione chimica) attorno
all'aggressore, dopo che i linfociti T induttori hanno dato il
«permesso» di intervenire in questo modo. Questi enzimi
fanno entrare in azione cellule particolari, i macrofagi (dai
termini greci macro, grande, e fagein, ingoiare). Si tratta di
cellule più grosse dei linfociti T, che vengono attivate da
questi ultimi e possono letteralmente ingoiare germi e ucciderli con gli enzimi preconfezionati nel loro interno. Non
sempre, però, ingoiano l'avversario; talvolta liberano sostanze che provocano un grande danno e questo può bastare.
I macrofagi si formano nel midollo osseo, cioè in quello
spazio all'interno di certe ossa che funge da fabbrica addetta alla produzione dei globuli rossi e bianchi. I globuli rossi
hanno questo colore perché contengono nel loro interno un
pigmento, l'emoglobina, di colore rosso; i globuli bianchi
non sono realmente bianchi, ma incolori. I macrofagi cominciano la loro esistenza nel circolo sanguigno, dopo essere stati liberati dal midollo osseo in una forma leggermente
immatura. A questo stadio sono chiamati monociti. Una
volta attratti nei tessuti per contrastare un invasore, maturano rapidamente e vengono chiamati macrofagi.
Altre cellule prodotte dal timo, i linfociti T killer (o assassini), o cellule T assassine, possono produrre una differente forma di attacco immunologico contro un invasore.
69
Come le cellule che richiamano i macrofagi, esse attendono
un segnale emesso dall'interleuchina prima di attaccare. Si
muovono verso il nemico, per esempio, una cellula neoplastica, e si attaccano ad essa come sanguisughe; poi, da un
repertorio di oltre cento sostanze tossiche immagazzinate
nel loro citoplasma, scelgono quelle che, secrete, lo uccideranno.
Il sistema immunitario è potente, ha molteplici sfaccettature ed è splendidamente in equilibrio tra perfezione e perfidia. Pertanto il timo programma un quarto tipo di linfocito
T, che può svolgere il compito più significativo e difficoltoso di tutti.
Questo quarto tipo di linfocito T è la cellula immunore70
golatrice, che determina l'appropriatezza della risposta data contro un qualunque attacco in un qualunque momento.
Troppe distruzioni prodotte dai linfociti T killer causano
grandi danni non necessari ai tessuti, danni che devono necessariamente essere limitati. Le sostanze liberate dalle cellule immunoregolatrici possono far variare l'intensità e l'efficacia della risposta immunitaria. Inoltre, questo tipo di
cellule può impedire che si realizzino reazioni non appropriate, messe in atto da cellule che non riescono a distinguere tra il «sé» e il «non sé».
Abbiamo così visto in che modo il timo programmi quattro gruppi di linfociti T: i linfociti T induttori, che rappresentano la prima linea di difesa, i due gruppi di linfociti T,
che provocano infiammazione e liberano il campo dagli antigeni; infine le cellule immunoregolatrici, che supervisionano lo scenario. Vi suggerisco di riandare all'analogia del
piano di sicurezza se tutti i concetti non hanno trovato la
giusta collocazione.
Tutto quanto è stato detto ha trovato conferma di recente: per la precisione meno di dieci anni fa. Trent'anni fa, se
aveste cercato di dire che un linfocito T, prodotto dal timo,
si modifica gradualmente, assumendo la capacità di riconoscere un antigene che aggredisce l'organismo, sareste stati
messi in ridicolo. È quanto accadde nel 1896 al grande
scienziato Paul Ehrlich, quando raffigurò una cellula molto
simile a un linfocito T, sostenendo che essa poteva avere,
per esempio, la capacità di riconoscere i batteri della difterite e niente altro.
Rispetto al suo tempo Ehrlich era in anticipo di settant'anni. Ancora venticinque anni fa gli scienziati consideravano i linfociti simili a morbide palline di gomma. Essi sostenevano che, quando un antigene (per esempio, un tipo
specifico di batteri) rimbalzava sulla parete di una di queste
cellule immunitarie, produceva una intaccatura che si sarebbe conservata, e la forma ottenuta a seguito di questi
cambiamenti fisici poteva fungere da stampo per la produzione di sostanze specifiche che avrebbero attaccato l'anti72
gene. Questa «teoria dello stampo» dominò per lungo tempo il pensiero immunologico ed è naturalmente interessante, oggi, leggere che Ehrlich l'ha ridicolizzata già prima della fine del secolo scorso.
Tutti i linfociti T che abbiamo descritto sono pronti all'azione ancor prima della nascita. Questo fatto molto importante ha uno stretto legame con la nostra capacità di sopravvivere ai rischi che corriamo vivendo per nove mesi nell'utero materno (e questo sarà trattato nel capitolo sull'immunologia della riproduzione). Sembra che un messaggio
molto importante sia dato ai giovanissimi linfociti T che
escono dal timo durante le prime settimane di vita. Se essi si
precipitano contro qualunque cosa che riconoscano prima
che il feto in cui circolano abbia all'incirca 18 settimane, il
timo li programma in modo che si rendano conto che quella
«qualunque cosa» deve essere parte integrante del feto in
via di sviluppo. In fin dei conti, nascosti nell'utero materno, si dovrebbe essere, e generalmente si è, tagliati fuori da
quel mondo ostile ed estraneo, che si trova solo a qualche
centimetro di distanza. Tutti i tessuti, propri del nostro
«sé», si differenziano fin da quando abbiamo soltanto diciotto settimane di vita. Così un linfocito killer, che è, per
esempio, in grado di riconoscere il tessuto tiroideo, lo sorveglierà mentre si sviluppa e potrebbe, di fatto, legarsi ad
esso. In questa prima fase, però, gli viene comunicato che si
tratta del «sé» e che, pertanto, lo si deve lasciare stare. In
altre parole, il linfocito viene reso tollerante nei riguardi di
quel tessuto. I linfociti T immunoregolatori dovrebbero servire a mantenere tollerante quella potenziale cellula assassina, che potrebbe attaccare le nostre proprie cellule nel corso
dell'esistenza.
Se, per un caso qualsiasi, qualcosa di estraneo passa dalla
madre al bambino prima che i tessuti propri abbiano raggiunto lo sviluppo completo, può darsi che i linfociti T diventino tolleranti a questo qualcosa che, in realtà, è dannoso. L'esempio classico è quello del virus della rosolia. Se
questo virus passa attraverso la placenta nei primi tre mesi
73
di gravidanza, non si avrà alcuna reazione contro di esso e
il bambino contrarrà una grave forma di infezione e, di
conseguenza, nascerà gravemente leso. Se esattamente lo
stesso virus appare dopo 18 settimane di gravidanza, sarà
eliminato efficacemente.
Quando un qualsiasi linfocito T che abbiamo descritto
entra in contatto con il «proprio» antigene per la prima
volta, la reazione che ne seguirà viene chiamata, ragionevolmente, risposta immunitaria primaria. Si tratta di una
risposta un poco lenta perché i linfociti T specifici hanno
bisogno di tempo per incontrare il loro antigene e suonare
l'allarme. Potrebbero passare alcuni giorni anche tra l'infezione e la reazione effettiva. La seconda volta che esso si
imbatte nello stesso antigene, invece, è molto meglio preparato. I primi incontri non solo portano a un attacco da
parte dell'invasore, ma causano anche un aumento in progressione geometrica delle cellule con capacità di riconoscere l'invasore. Durante tutto l'arco della nostra esistenza, incontreremo probabilmente poche cose del milione e
più che possiamo riconoscere. Questo stato di accresciuta
preparazione si chiama memoria immunologica ed è il fondamento su cui operano i vaccini: se si riceve una dose di
un antigene invasore in forma innocua, si diventa realmente pronti per quando l'antigene farà il suo ingresso nell'organismo in forma pericolosa.
A questo punto dobbiamo introdurre un concetto, che è
senza dubbio il più importante di tutta la biologia. Noi esseri umani, e di fatto tutti gli esseri viventi, siamo votati all'autodistruzione. La Natura si prende cura delle specie
con tutta la devozione e la tenerezza di una madre di primissimo ordine, ma non si occupa affatto del singolo individuo. Dobbiamo morire per fare strada ai giovani, i quali,
molto lentamente, cercano di perfezionare il vecchio modello.
Per esempio, il timo funziona molto attivamente nei primi anni di vita, per poi bloccare rapidamente la produzione, lasciandoci con una dotazione di linfociti T che dura
74
per tutto il resto dell'esistenza. Una volta che i linfociti T si
sono esauriti, anche per noi è finita.
Nella maggior parte degli esseri umani, all'età di 60-65
anni, il numero e l'integrità funzionale dei linfociti T diminuiscono. Come conseguenza, queste cellule tumorali che
distruggiamo con facilità a 21 anni diventano un problema
più importante, come lo diventano con le persone anziane
le infezioni, a causa dell'invecchiamento dei linfociti T.
Tutto ciò significa, naturalmente, che dobbiamo porre attenzione ai linfociti T che possediamo: sono preziosi. Come
vedremo quando si parlerà di AIDS, la loro distruzione nella vita adulta pone l'individuo in una situazione senza speranza. Potesse un inafferrabile elisir di giovinezza farli ringiovanire!
Disponiamo di un sistema di linfociti T composto da cellule regolatrici, cellule che lanciano segnali d'allarme e cellule distruttrici. Per mantenerci in vita, tutte queste cellule
devono funzionare perfettamente e in armonia giorno per
giorno. Il sistema in sé è molto antico: in una fase di sviluppo precoce, primitiva e incerta, lo si trova già nel lombrico.
Il nostro sistema sofisticato è il frutto di una notevole sperimentazione protrattasi per milioni di anni. La capacità dei
linfociti di riconoscere, di «apprendere» per esperienza, di
conservare informazioni in memoria ed essere in grado di
agire in modo differenziato (eppure appropriato) in qualsiasi situazione, rende queste cellule creazioni veramente
stupende della Natura.
I linfociti T hanno una dimora, o più precisamente alcune dimore, all'interno dell'organismo, anche se per la maggior parte della loro esistenza si spostano costantemente
lungo i vasi sanguigni, seguendo «percorsi» più ristretti che
servono solo per le cellule del sistema immunitario.
Quando Cristina, una bambina di nove anni, cadde dalla
bicicletta su un cespuglio spinoso, subì lievi abrasioni alle
mani, ma fu un grave colpo per il suo «sé», perché quell'incidente aveva dimostrato la sua incapacità di tener testa al
fratello di undici anni. La mamma le lavò le mani, posò un
76
bacio e un cerotto sul piccolo taglio che si era fatta su una
mano, e tutto ricominciò come prima. In quella ferita insignificante, però, erano penetrati alcuni batteri che si trovavano sulle spine del cespuglio e che, il giorno successivo, fecero sentire la loro presenza. La ferita era arrossata e un
poco dolente, ma c'era qualcosa che meritava maggiore attenzione: una stria rossa molto visibile, che si estendeva dal
taglio sulla mano lungo l'avambraccio fino alla piegatura
del gomito.
In varie posizioni strategiche del nostro organismo si trovano «stazioni» che fanno parte del sistema immunitario e
che si chiamano linfonodi. Nella cute, vi sono vasi che decorrono a fianco dei vasi sanguigni e in cui circola un liquido, la linfa: sono i vasi linfatici che, con la linfa, costituiscono la via maestra e il mezzo di trasporto per i linfociti T;
possono, inoltre, catturare un antigene invasore, penetrato
nella pelle, trasportandolo al più vicino linfonodo lungo la
forte corrente del flusso linfatico. Nel linfonodo, l'antigene
invasore viene accerchiato, senza tante cerimonie, dall'esercito impegnato nella difesa immunitaria. Nelle ascelle, all'inguine, nella piegatura del gomito, dietro la gola (tonsille
e adenoidi), nel collo e nel ventre (milza) vi sono ammassi di
cellule immunitarie, raggruppate in modo tale da poter valutare qualunque cosa passi nei linfonodi lungo i vasi linfatici, che ricevono la linfa da vasi afferenti ramificati e mescolati con le cellule che formano la massa del linfonodo. In
questo modo, la Natura rende più facile il riconoscimento
di un antigene invasore da parte di quelle poche cellule dotate di un'elevata specificità e della necessaria capacità di
identificarlo.
Talvolta gli organismi invasori, involontariamente trascinati via lungo i vasi linfatici, secernono tossine che irritano
le pareti di questi vasi; può capitare allora che, mentre si
trovano ancora in essi, comincino a essere attaccati dalle
cellule immunitarie. Si sviluppa un'infiammazione per cui i
vasi si arrossano, diventando ben visibili. Si parla, in questo caso, di linfangite («ite» è il suffisso che designa sempre
77
un'infiammazione). Per questo motivo Cristina aveva una
stria rossa lungo l'avambraccio. Quando i primi microrganismi penetrati attraverso la ferita raggiunsero i linfonodi,
essa guarì rapidamente, poiché da lì numerosi linfociti furono inviati nei vasi linfatici, o in qualsiasi altra sede, per uccidere i microrganismi ancora presenti in essi.
I linfonodi, quindi, sono i siti in cui la Natura preferisce
che si svolgano le battaglie immunitarie: in casa, per così dire. Quando ciò accade, i linfonodi si gonfiano. Si pensi al
gonfiore delle ghiandole del collo nei bambini, che accompagna così spesso il mal di gola.
Gli stessi linfonodi sono un esempio meraviglioso di pianificazione organizzativa: i linfociti T sono localizzati in un
settore del linfonodo mentre i linfociti B (di cui dobbiamo
ancora parlare) si trovano in un compartimento anatomico
ben distinto. I linfociti tappezzano la parete dei vasi afferenti, lungo i quali fluisce la linfa e proiettano verso il centro della corrente le loro antenne di riconoscimento dell'antigene. In questo modo, i virus e gli altri microrganismi, che
sono trasportati con il flusso della linfa all'interno del linfonodo, si trovano sotto il tiro incrociato dei recettori fino
a quando uno o più linfociti li riconoscono, li catturano e
lanciano l'allarme. Questo aspetto organizzativo e anatomico del sistema immunitario ha un'importanza vitale poiché
accresce la nostra capacità di riconoscere la presenza di antigeni.
Alcuni vasi linfatici e linfonodi nel torace sono molto voluminosi, e grandi quantità di linfa scorrono in quest'area.
Il vaso più grosso di tutti è il dotto toracico. Di recente sono stato chiamato a visitare un ragazzo di quindici anni,
che era stato ricoverato per un intervento chirurgico, allo
scopo di correggergli un difetto congenito dell'aorta, il
principale vaso sanguigno che trasporta il sangue dal cuore
alla periferia. Nell'effettuare l'operazione, in sé ben riuscita, il chirurgo aveva inavvertitamente scalfito il dotto toracico con la lama del bisturi. Di conseguenza, la linfa, contenente molti linfociti T, fuoriusciva nel torace del paziente.
78
Sostanze che attivano i LINFOCITI T KILLER
Alla base dei polmoni si stava così accumulando tanto liquido, che era stato necessario inserire un tubo di drenaggio per permettere al liquido di fuoriuscire dalla cavità toracica per non menomare la funzionalità polmonare. Ma che
dire di tutti quei linfociti T che scorrevano via e andavano
perduti per sempre? Miliardi di cellule d'importanza vitale
potevano andare perdute in un solo giorno e poteva trascorrere una settimana o anche più prima che le lesioni del dotto
toracico si cicatrizzassero e lo stillicidio si arrestasse.
Data l'importanza dei linfociti T, ci premurammo di raccogliere tutta la linfa fuoriuscita, la portammo in tutta fretta in laboratorio dove separammo i linfociti temporaneamente privi di una loro sede, accertandoci che rimanessero
vitali e sterili, quindi li inoculammo di nuovo al legittimo
proprietario. In questo modo vennero sostituiti in una settimana più di 200 milioni di linfociti T.
Un altro importante aspetto della biologia dei linfociti T
richiede una spiegazione. Non nasciamo tutti uguali per
quanto concerne i linfociti T. All'interno della famiglia
umana vi è tutta una gamma di prestazioni. Ciò significa
che l'ideale di cui ho parlato non si realizza sempre in un
dato individuo. Le conseguenze dell'avere un sistema di linfociti T di seconda classe sono enormi, come vedremo. Anche se i fattori ambientali ne possono influenzare l'attività,
questa è fondamentalmente determinata geneticamente,
perché ciascuno di noi eredita un sistema di linfociti T migliore o peggiore secondo il modo in cui si combinano le informazioni genetiche dei nostri genitori.
Il sistema dei linfociti B
Mentre descrivevo nei particolari il sistema dei linfociti T,
forse vi sarete chiesti in che punto della storia dell'immunologia sarebbero entrati in scena gli «anticorpi». Questo termine viene usato comunemente e quasi di sicuro avrete sentito parlare di queste proteine. Gli anticorpi entrano nella
nostra trattazione adesso e non prima, perché stiamo af80
frontando il sistema immunologico dal punto di vista evolutivo. I linfociti T funzionavano già 200 milioni di anni prima che gli anticorpi facessero la loro comparsa. Da che cosa nasceva questa necessità di estendere il nostro repertorio
immunologico?
Lo sviluppo e il funzionamento del sistema dei linfociti T
è sicuramente mirabile, ma le loro capacità presentano ancora delle pecche. I linfociti T non compaiono a livello delle
mucose, per esempio delle mucose che rivestono la gola,
l'intestino e la vescica. Se dovessimo basarci interamente
sul loro sistema, dovremmo sempre aspettare che gli organismi invasori si insedino dentro di noi prima di poter scatenare la battaglia vera e propria.
I principali problemi, che hanno letteralmente perseguitato le specie in via di sviluppo mentre perfezionavano il loro sistema di difesa immunitaria basato sui linfociti T, sono
venuti dal mondo dei batteri. Come abbiamo già ricordato,
i batteri possono dividersi (in biologia ciò significa moltiplicarsi) con estrema rapidità e diffondersi repentinamente per
tutto l'organismo. In confronto ai virus sono grossi e possono occupare talmente tanto spazio da alterare pesantemente la funzionalità di un organo anche solo per la loro
presenza fisica. Così, mentre i linfociti T riuscivano con relativa facilità a fronteggiare i virus, i parassiti e i funghi, si
trovavano in grande difficoltà con la maggior parte dei batteri. Pertanto, la Natura continuò incessantemente a sperimentare un meccanismo di difesa antibatterico, nuovo e
ben distinto, il quale, per ironia della sorte, fu ampiamente
compreso dagli uomini di scienza molto tempo prima di
quello di gran lunga più antico, basato sui linfociti T.
I meccanismi responsabili dell'immunità interessarono da
sempre i medici. Agli antichi era noto che chi guariva da alcune malattie infettive non le contraeva più, anche se doveva accudire qualcuno che soffriva in forma acuta delle stesse malattie.
Verso la fine del XIX secolo, gli scienziati scoprirono che
il siero (cioè il sangue senza le cellule circolanti in esso) con81
teneva un elemento protettivo, il quale poteva essere individuato solo dopo che l'organismo aveva vinto con successo
la battaglia contro uno specifico microrganismo. Naturalmente questo fatto non potè essere rilevato fino a quando
essi non scoprirono e videro realmente i batteri.
Con la scoperta dei batteri e la messa a punto di metodi
per coltivarli in provetta, fu possibile effettuare esperimenti
in cui un determinato batterio veniva messo in presenza di
siero di un individuo ritenuto immune a quel microrganismo. Siero e microrganismo potevano essere mescolati e si
poteva osservare il risultato. La presenza di qualcosa nel
siero che fosse in grado di danneggiare i batteri portò alla
scoperta degli «anticorpi».
Il sistema venne chiamato (e ancora lo è per ragioni nostalgiche) «sistema immunitario umorale». Perché? Perché
quei primi scienziati intuivano che qualche molecola nel siero doveva essere responsabile delle proprietà antibatteriche,
ma essendo a quei tempi la chimica incapace di determinarla, questi «fattori chimici» venivano chiamati collettivamente «umori», sostanze misteriose con proprietà meravigliose. I primi esperimenti mostrano che, scaldando il siero
a 5 6 ° C , gli «umori» sparivano. Il notevole interesse mostrato per la natura dei fattori del siero indusse ad effettua82
re esperimenti pionieristici da cui scaturì che quegli «umori» erano proteine specifiche, dette oggi anticorpi, o più
correttamente immunoglobuline o gammaglobuline. Una
globulina non è, come mi disse una volta uno studente,
qualcosa che si aggira in fondo a un giardino irlandese. Una
globulina è una proteina che ha attaccata a un'estremità
una molecola di carboidrato.
Le immunoglobuline sono molecole affascinanti, senza le
quali non potremmo vivere. Hanno caratteristiche fisiche
tali per cui una parte della loro molecola risulta complementare di un antigene specifico. Idea, questa, senza dubbio analoga al fatto che i linfociti T hanno un recettore per
l'antigene. Gli anticorpi sono le più mirabili «serrature» che
la Natura abbia mai costruito e nelle quali si inserisce solo
una «chiave» molto specifica. Come tutte le sostanze chimiche presenti nel nostro organismo, essi vengono prodotti da
cellule. Nel loro caso, le cellule appartengono alla famiglia
dei linfociti, ma sono linfociti B invece di linfociti T. La
storia di come e perché vennero chiamati linfociti B è interessante e istruttiva.
Tutti gli uccelli, a breve distanza dalla cloaca, posseggono una struttura simile a una ghiandola linfatica, che si
chiama «borsa di Fabrizio». Dopo aver insegnato per tanti
anni agli studenti che cos'era questa borsa, decisi di saperne
qualcosa di più sull'uomo Fabrizio. Era un eminente professore dell'Università di Padova alla fine del XV secolo.
Scienziato, conferenziere, medico e anatomico, descrisse
per primo le valvole che, nelle vene, impediscono il reflusso
del sangue. Non è facile scoprire perché quest'uomo famoso, nel 1492, dissezionasse il dorso degli uccelli, ma è un
fatto che egli descrisse la borsa e l'immortalità fu sua. Tutti
gli uccelli hanno la borsa di Fabrizio, ma a che cosa serve?
Come spesso accade nella scienza, una serie di esperimenti e di osservazioni fortuite, eseguite simultaneamente in
molti laboratori, ci ha fornito la risposta a questo interrogativo. Alla fine degli anni Sessanta, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti stava effettuando esperimenti
83
per vedere se i pulcini potevano essere fatti crescere più rapidamente, aumentando così la resa in un tempo inferiore
al normale. Alcuni scienziati ebbero l'idea di iniettare il testosterone (ormone sessuale maschile) in embrioni di pollo
prima della schiusa per vedere se da quegli embrioni sarebbero derivati polli più carnosi. È da supporre che tutti sperassero di veder uscire dal guscio pulcini con petti muscolosi molto sviluppati. Invece, gli esperimenti non diedero
buoni risultati e i pulcini che, con una certa riluttanza, uscirono dal guscio morirono dopo pochi giorni a causa di
un'infezione batterica devastante. All'esame autoptico,
mostrarono di non possedere la famosa, ma misteriosa,
borsa di Fabrizio. Da questa e da altre osservazioni più dirette risultò chiaramente che quell'organo, negli uccelli, era
la sede in cui si sviluppavano linfociti che producevano anticorpi. Gli uccelli privi di borsa di Fabrizio non avevano la
capacità di combattere contro i batteri.
Questa scoperta pose un interessante interrogativo: dov'è, negli esseri umani, l'equivalente della borsa di Fabrizio? Lo si è trovato nel midollo osseo. Per questo motivo
(midollo osseo in inglese si dice bone marrow), le cellule che
«imparano» in esso a produrre anticorpi sono chiamate linfociti B.
Nel feto umano, le cellule staminali migrano dal fegato
nel midollo osseo in modo analogo a come migrano nel timo. Dopo la nascita, il midollo osseo produce le proprie
cellule staminali e le «istruisce» sul posto.
I linfociti B vivono al massimo alcune settimane, diversamente dai linfociti T. Di conseguenza, il midollo osseo deve
avere una linea di produzione che sforna linfociti B in grande quantità per ogni giorno della nostra esistenza. Ogni linfocito B ha sulla membrana esterna quasi mezzo milione di
recettori per un solo antigene. Il principio biologico in questo caso è simile a quello che abbiamo descritto per i linfociti T. I linfociti B attendono nel linfonodo più vicino l'arrivo
dell'antigene per il cui riconoscimento sono stati programmati. Se ciò avviene, il recettore sulla membrana cellulare,
84
che è esso stesso un anticorpo o immunoglobulina, riconoscerà l'antigene. Il «permesso» di attaccare l'antigene invasore deve essere dato da un linfocito T prima che il legame
dell'antigene sulla superficie di un linfocito B possa dar
luogo a un'azione immunologica.
Un linfocito B a cui sia stato dato ordine di attaccare, lo
fa trasformandosi in una fabbrica che produce e secerne anticorpi. Ciò che il linfocito produce è la molecola di anticorpo o immunoglobulina, che cattura l'antigene sulla sua
membrana, cioè produce e secerne il proprio recettore di superficie. Quando si trova nella forma di massima attività, il
linfocito B prende il nome di «plasmacellula». Le plasmacellule possono secernere 2000 molecole di anticorpo al secondo. Non si intende dire con questo che i linfociti B perlustrino l'intero corpo, attaccando, se li trovano, gli antigeni
nemici; essi rimangono piuttosto nei linfonodi e inviano gli
anticorpi in circolo a tutta velocità, alla ricerca del nemico.
Così, il nostro sistema immunitario umorale consiste in
linfociti B a vita breve, che riconoscono l'antigene e quindi
ricevono il permesso di attaccare da un linfocito T a vita
lunga. In questo modo, i linfociti T possono impedire ai linfociti B che riconoscono i nostri tessuti di attaccarci, un
meccanismo di controllo di cui abbiamo parlato quando ci
siamo resi conto che i linfociti T autoreattivi andavano controllati. Quindi i linfociti B secernono l'immunoglobulina
che va ad uccidere il nemico.
Gli esseri umani producono cinque differenti tipi di immunoglobulina, che vengono chiamati classi e che si sono
evoluti uno per uno. Con la comparsa di ogni nuovo modello, abbiamo aggiunto qualcosa al nostro arsenale per la lotta alle infezioni. Produciamo sempre le cinque immunoglobuline in un ordine rigoroso. Conoscendo quelle presenti in
un qualsiasi campione di sangue, possiamo stabilire lo stadio della risposta alla sfida.
Il primo anticorpo che esce dalla catena di montaggio di
una plasmacellula è l'immunoglobulina M, chiamata anche
IgM: primo tentativo della Natura di produrre un anticor85
po. Non è, in realtà, molto efficiente, non dura a lungo ed è
«codarda». Cinque di queste molecole si riuniscono in
gruppo e stanno in allerta, in attesa del nemico. Il gruppo
delle cinque IgM è così grande che non può penetrare nei
tessuti e continua a essere sospeso nel sangue circolante.
Pertanto, la sua capacità di contribuire alla lotta contro i
microrganismi è limitata.
Alcune specie primitive che vivono ancora oggi sulla Terra (per esempio, certi squali) possono produrre soltanto
IgM. Invece, gli esseri umani non riuscirebbero a sopravvivere nel mondo attuale se producessero soltanto questa forma primitiva di anticorpo. Saltuariamente i medici si trovano a dover curare bambini nati con una capacità immunitaria limitata in questo modo e che moriranno se non riceveranno trasfusioni contenenti le classi più importanti di anticorpi.
Quando, a un bambino di sei settimane, viene praticata
la prima vaccinazione contro la difterite, la pertosse e il tetano, vengono stimolati i linfociti B in grado di riconoscere
gli agenti etiologici di tali malattie. Ben presto compaiono
nel circolo sanguigno immunoglobuline M (IgM) contro tali
agenti, ma il bambino deve andare oltre questo punto per
sviluppare meccanismi di difesa più sofisticati.
Il successivo tipo di anticorpo che compare dopo la sfida
con un antigene è l'immunoglobulina D (IgD), di cui sappiamo molto poco, dato che, a quanto pare, viene secreta
soltanto in minuscole quantità prima che le plasmacellule
secernano il tipo successivo. Può avere importanza nel favorire la reazione dei linfociti B ai linfociti T.
Il terzo tipo di anticorpo prodotto è l'immunoglobulina
E (IgE). (Per inciso, è il linfocito T che dice alla fabbrica
rappresentata dalla plasmacellula quando deve passare alla
produzione di un nuovo modello.) L'IgE è un'immunoglobulina affascinante e sarà argomento a sé di un prossimo
capitolo, perché è l'anticorpo che, se viene prodotto in eccesso, è responsabile della comparsa di «allergie».
La maggior parte dei linfociti che si precipitano in difesa
86
di un tessuto quando viene attaccato da un antigene è trasportata nel punto dove è avvenuta l'invasione dalla corrente sanguigna. A mano a mano che si avvicina alla zona attaccata, incontra vasi sanguigni dilatati e con i pori della
parete stirati al punto da raggiungere una dimensione sufficiente a far passare i linfociti a caccia dell'antigene, che abbandonano i vasi per muoversi nei tessuti. Se i vasi non si
dilatassero, i linfociti rimarrebbero intrappolati per sempre
nel loro interno. Per realizzare questo fine, l'IgE è fatta
specificamente in modo da costringere cellule specifiche a
liberare agenti di tipo istaminico. Per questo motivo, essa
viene spesso denominata «il guardiano della porta immunologica».
Dopo la produzione di IgE, i linfociti T passano alla produzione di IgG, il principale anticorpo prodotto dagli esseri
umani. Questa molecola è stata così importante per i nostri
meccanismi di difesa che con il passare degli anni ha subito
numerosi cambiamenti. Oggi possiamo riconoscerne quattro sottotipi.
Le variazioni minori nelle molecole che produciamo sono
molto importanti. Queste molecole si chiamano (e la cosa
sembra sufficientemente logica): IgGl, IgG2, IgG3, IgG4.
La IgGl protegge i tessuti umani dalla maggior parte dei
batteri, esclusi quelli che sono protetti da un rivestimento
di natura glucidica. I microrganismi in grado di formare
un rivestimento del genere includono il meningococco, responsabile della meningite, il gonococco che provoca la gonorrea, malattia trasmessa per via sessuale, e il pneumococco, causa di un elevato numero di problemi ai polmoni,
alle vie respiratorie superiori e agli orecchi di giovani e anziani.
Come risposta a questa strategia difensiva dei batteri, la
Natura ha sviluppato l'immunoglobulina G2, capace di attaccare e di distruggere in modo specifico questi microrganismi. Una carenza ereditaria della capacità di produrre
questa particolare forma di anticorpo è stata la causa dei disastri descritti nel primo capitolo, quando la giovane madre
87
perse ben tre figli per colpa di questi batteri protetti da una
capsula polisaccaridica.
L'IgG3 neutralizza certi virus che si spostano a grande
velocità nella corrente sanguigna prima di mettersi al sicuro
all'interno di una cellula. Una volta dentro, essi sono al riparo dagli effetti degli anticorpi, incapaci di penetrare nella
cellula attaccata dal virus.
Il quarto tipo di IgG (IgG4) assomiglia un poco a IgE, essendo in grado di agire sulle cellule che contengono la sostanza chimica che fa dilatare i vasi sanguigni; sembra che
svolga un ruolo importante nel proteggere le vie respiratorie
inferiori.
La quinta e ultima classe importante di immunoglobuline
che viene prodotta dopo l'attacco da parte di un oggetto
estraneo è quella delle immunoglobuline A (IgA), un tipo di
anticorpo che svolge la sua attività sulle mucose e forma
una barriera protettiva per la nostra «pelle» interiore, cioè
per quella delicata membrana che riveste le cavità nasali, la
bocca, l'intestino, la vescica e la vagina. Con l'ampliamento del repertorio di anticorpi, il nostro organismo fu così in
grado di acquisire una notevole flessibilità nella capacità di
difendersi.
Un anticorpo è molto simile alla puntina di un costoso
impianto ad alta fedeltà: questa può chiaramente rivelare la
differenza tra la Quinta Sinfonia di Beethoven e un brano
dei Rolling Stones, ma la musica deve essere amplificata
perché si possa udire con quale precisione la puntina ne ha
seguito la traccia sul disco. Così anche il riconoscimento di
un invasore da parte degli anticorpi deve conseguire all'amplificazione di un messaggio perché possa essere lanciato un
attacco globale.
Proprio come i linfociti T ricorrono ai monociti, così anche gli anticorpi hanno compagni d'armi ai quali possono
chiedere appoggio. Uno di questi è il sistema del complemento, un'affascinante serie di ben undici sostanze, sempre
presenti nel circolo sanguigno. Queste sostanze possono dare origine a una catena di reazioni, ovvero quando una vie88
ne attivata, attiva a sua volta il membro successivo della catena. Gli anticorpi IgM e IgG, allorché si legano all'antigene, possono attivare la prima sostanza delle undici, una volta che hanno riconosciuto l'invasore. L'attivazione delle
undici sostanze, normalmente silenti, all'interno del circolo
sanguigno provoca l'amplificazione della risposta che conduce alla distruzione dei batteri.
Ogni componente del sistema del complemento attivato
aiuta in qualche modo a eliminare l'aggressore. Alcune sostanze fanno dilatare i vasi sanguigni, altre possono distruggere le membrane delle cellule batteriche. Ma, cosa più importante di tutte, alcune coinvolgono nella lotta una cellula
la cui funzione è fondamentale. Si tratta del granulocito, o
cellula polimorfonucleata, così chiamata per i diversi aspetti che può assumere e per avere più di un lobo nel proprio
nucleo: è estremamente importante perché la classe che rappresenta annovera i migliori divoratori e distruttori di batteri.
Non c'è niente che le cellule polimorfonucleate gradiscano di più di un «sandwich» di batteri, spalmato di anticorpi
e di complemento. La distruzione dei batteri avviene nel sistema di linfociti B. Naturalmente non è di grande utilità
essere in grado di produrre anticorpi se poi mancano il
complemento o i granulociti. Gli immunologi clinici si trovano spesso di fronte a pazienti che producono anticorpi,
ma hanno problemi negli altri due settori; fortunatamente
questi guai sono rari.
L'IgA è il membro «tranquillo» della famiglia degli anticorpi. Si lega semplicemente all'antigene e lo immobilizza,
in modo che il complesso IgA-aggressore possa essere eliminato dall'organismo quando viene secreta la mucina, il liquido viscoso che tappezza le mucose.
La Natura sa benissimo il fatto suo e tiene conto che gli
esseri umani devono produrre le IgM prima delle IgG e le
IgG prima delle IgA. E allora, proprio per questa successione temporale nella produzione anticorpale, devono esistere
particolari accorgimenti di protezione dei neonati, i quali
89
altrimenti potrebbero essere colpiti da infezioni batteriche.
A questo stadio dell'esistenza, gli esseri umani sono così
fragili e i loro sistemi incompleti che potrebbero essere sopraffatti dai batteri se non venissero difesi con prontezza.
Per questo, i neonati vengono adeguatamente riforniti di
IgG e di IgA. Dalla diciottesima settimana di gestazione, le
IgG che circolano nel sangue materno possono attraversare
la placenta e entrare nel sangue fetale. Questo è importante,
perché è probabile che il bambino nasca nello stesso ambiente popolato da microbi contro il quale il sistema immunitario della madre ha reagito durante tutti i mesi che hanno preceduto il parto. Pertanto, il sistema immunitario materno sarà colmo di anticorpi contro quegli organismi potenzialmente pericolosi che il bambino avrà la probabilità di
dover affrontare dopo la nascita.
Pertanto, la madre può offrire al figlio una protezione
passiva, donandogli in questo modo la sua esperienza immunologica. Attraverso un simile meccanismo, i bambini
nascono con livelli di IgG da adulto. La quantità di anticorpi che ricevono durerà circa tre mesi, una soluzione soddisfacente dato che, dopo il secondo mese di vita, gli esseri
umani sono in grado di produrre in modo efficiente le loro
proprie IgG.
Questo sistema funziona meglio quando è la Natura che
lo gestisce. Per esempio, in molti paesi del Terzo Mondo le
donne, per partorire, si allontanano solo per alcune ore dal
lavoro, si accoccolano e lasciano che il bambino cada direttamente per terra. La madre taglia con i denti il cordone
ombelicale e la vita prosegue per entrambi. In una situazione del genere, è certamente probabile che gli organismi che
il bambino potrebbe essere costretto ad affrontare subito
siano già stati «avvistati» di recente dal sistema immunitario della madre.
I sistemi sanitari moderni hanno interferito in modo significativo con tali stili di vita. Quando oggi un bambino
nasce in ospedale rischia di dover entrare in contatto con
organismi propri di questo luogo e assenti dalla comunità
90
generale (in questo caso si parla di infezioni nosocomiali).
Di conseguenza, di tanto in tanto in certi neonati si presentano seri problemi causati da questi microrganismi d'ospedale: le IgG della mamma non sono in grado di reagire con
questo agente insolito.
Se un bambino nasce prematuro, riceverà dalla madre
una quantità di IgG inferiore alla quantità auspicabile e ciò
può fare aumentare il rischio di infezione per esserini così
delicati. Fortunatamente, oggi siamo in grado di portare al
massimo i livelli di IgG di questi bambini con fleboclisi di
IgG concentrate, disponibili in commercio.
Che dire delle IgA? È molto probabile che i neonati debbano affrontare l'assalto di microrganismi potenzialmente
pericolosi, che si stabiliscono sulle loro mucose. Il discorso
è valido in particolar modo per l'intestino. La Natura ha risolto il problema dell'incapacità nei neonati di produrre
IgA, assicurando la presenza nel latte materno di abbondanti quantità di questi anticorpi. Nessun liquido biologico
ha una concentrazione più elevata di IgA del colostro, il latte secreto dal seno materno nei primi giorni dopo il parto.
Anche dopo che il latte comincia a fluire regolarmente, esso
si mantiene ricco di IgA.
Ciò che è stato detto a proposito delle IgG vale anche per
le IgA. È molto probabile che qualunque microrganismo
che infetti l'intestino di un neonato abbia di recente infettato anche la madre; pertanto le IgA di questa dovrebbero
proteggere il figlio. La IgA è un anticorpo notevole, in grado di attraversare indenne lo stomaco, fatto particolarmente importante per i bambini che devono fare il loro ingresso
nel mondo in circostanze igieniche non certo ideali. Questo,
naturalmente, è il motivo per cui gli immunologi auspicano
che, nei paesi del Terzo Mondo, sia enfatizzata l'alimentazione al seno dei neonati e non quella artificiale. Da un punto di vista immunologico, sembra che la Natura si preoccupi
perché le madri allattino al seno i propri figli per i primi sei
mesi di vita. Dopo questo periodo, la quantità di IgA nel
latte materno comincia a diminuire in misura significativa.
91
Negli anni recenti, i medici hanno cercato di trarre vantaggio dalle proprietà immunologiche del latte materno,
utilizzando il colostro e perfino il latte stesso come sostanza
medicamentosa. Si è trovato che il latte umano ha una notevole efficacia quando viene usato come collirio o come gocce per uso otoiatrico o nasale. In effetti, se ve ne fosse in
abbondanza, la sua somministrazione ai neonati affetti da
diarrea sarebbe probabilmente un metodo di cura molto più
comune. In diverse località della Scandinavia, vi sono banche del latte dove è stato immagazzinato latte umano in
quantità sufficiente per scopi terapeutici.
A parte le IgA e altri aspetti nutrizionali portentosi, il latte materno contiene anche numerosi globuli bianchi, ovvero
quantità significative di linfociti sia T sia B, anche se non è
chiaro perché ciò avvenga. È stato suggerito che la presenza
di cellule estranee nell'intestino del neonato possa accelerare la maturazione dei linfonodi che si trovano nelle pareti.
Di tanto in tanto può capitare che una madre allatti al seno
il proprio figlio senza sapere che è nato senza linfociti T; in
queste circostanze i linfociti T presenti nel suo latte possono
riconoscere il bambino come «estraneo» e lanciare un attacco che può essergli fatale. Di solito, invece, il piccolo numero di linfociti T presente nel latte materno non riuscirà a tener testa al sistema di linfociti T perfettamente equipaggiato del bambino.
Cellule killer e non killer
Vi sono cellule che circolano nell'organismo e vivono nei
linfonodi: esse sono simili ai linfociti, ma probabilmente
appartengono a una genealogia distinta. Non hanno, infatti, sufficienti caratteristiche fisiche in comune con i linfociti
T o B per essere comprese nell'una o nell'altra famiglia.
Conosciamo meglio la funzione di queste cellule che non il
loro «asse ereditario». Un gruppo viene definito cellule killer o K, che non sono da confondere con i linfociti T, in
grado anch'essi di uccidere; sono, piuttosto, cellule che
92
hanno somiglianze con i linfociti e che sono in grado di uccidere le cellule rivestite di anticorpi.
Questo fatto può essere particolarmente importante nella
difesa contro il cancro. Le cellule neoplastiche non possono
essere distrutte dagli anticorpi. Il nostro organismo produce
anticorpi contro numerose di esse, ma non sembra che questi anticorpi siano molto efficaci nel distruggere quelle cellule maligne, sregolate e spesso invadenti. Invece, sembra
che le cellule K abbiano la capacità di uccidere le cellule ricoperte da anticorpi. Non è ancora chiaro quanto esse siano
importanti nel sistema di difesa umano, ma probabilmente
svolgono un ruolo significativo in situazioni specifiche.
Forse di maggiore interesse sono quelle cellule che sono
anch'esse simili ai linfociti, ma che non possono essere classificate come linfociti T o B. Si tratta delle cellule NK, killer
«naturali». Esse hanno la capacità di uccidere certi microrganismi e cellule, a quanto pare senza alcun aiuto da parte
di altri componenti del sistema immunitario. Sembra che
funzionino in modo più efficiente quando sono in presenza
di sostanze prodotte dai linfociti T attivati.
Abbiamo già parlato dell'interleuchina, che può lanciare
segnali di autorizzazione sia ai linfociti T sia ai linfociti B.
Un'altra sostanza potente prodotta dai linfociti T è l'interferon. Essa ha certe proprietà antivirali e antitumorali, ma
pare anche che stimoli le cellule NK a uccidere cellule infettate da virus e cellule tumorali. Come vedremo più avanti,
sembra esservi un collegamento tra la prestazione delle cellule NK e vari fattori psicologici, collegabili allo stress. Tutta questa materia sarà analizzata in notevole dettaglio più
avanti.
Bene, ora lo conoscete. È un esercito sofisticato, ben integrato, che nella maggior parte di noi funziona splendidamente per settant'anni e più. Esso è chiaramente uno dei
vanti della biologia.
93
Parte II
COME DOMARE I LOTTATORI
3
La gravidanza,
versione naturale del trapianto
Quando l'incontrai per la prima volta, Caterina era sposata
già da undici anni. Come molte altre giovani coppie, lei e il
marito non avevano voluto avere subito figli. Dopo tre anni
di matrimonio, però, lei decise che era giunto il momento di
fare aumentare la famiglia. Non prese più contraccettivi e,
dopo tre mesi, annunciò con gioia al marito di essere incinta. In piena forma fisica e rilassata, pensava alla sua maternità con grande emozione.
Purtroppo quella prima gravidanza si interruppe dopo
dieci settimane. Perse il bambino senza difficoltà, con scarsi disturbi, non dopo un litigio col marito, non dopo una
caduta né dopo una cavalcata. Era a cena con degli amici
quando sentì un rivolo di sangue scenderle lungo una gamba e alcuni crampi allo stomaco. Tutto si concluse in brevissimo tempo.
Caterina e il marito erano amareggiati, ma non allarmati.
Migliaia di donne sane abortiscono. Seguirono, però, altri
tre aborti. Una volta, Caterina riuscì a portare la gravidanza fino alla dodicesima settimana, ma generalmente perdeva il bambino tra l'ottava e la decima settimana.
Le conseguenze di tutte queste delusioni furono considerevoli: l'assalì una forte depressione, dimagrì, divenne sempre più introversa. Il marito era angosciato per lei quanto lo
era per la mancata paternità.
Un ostetrico, interpellato, ipotizzò che forse il collo dell'utero era troppo rilassato e consigliò alla donna di tentare
97
un'altra gravidanza, di rimanere a letto per l'intero periodo
e di lasciare che egli le suturasse quella parte dopo che era
rimasta incinta, per impedire che il bambino fuoriuscisse
dall'utero prima del tempo. Caterina fece tutto quello che
le era stato detto, ma perse ugualmente il quinto figlio dopo
nove settimane. (Per inciso, l'ostetrico aveva ragione di dire
che alcune donne abortiscono perché hanno problemi con il
collo dell'utero, ma non era questa la causa dei guai di Caterina.)
Un altro dottore avanzò l'ipotesi che Caterina avesse
abortito perché tutti i suoi figli erano anormali, imperfetti
sotto il profilo genetico. Egli aveva spesso esaminato feti
abortiti e vi aveva trovato anomalie. Ma sembrava improbabile che cinque bambini in fila fossero stati eliminati per
questa ragione.
Quando incontrai Caterina, che era cilena, mi assicurò
che (questione di settimane) avrebbe potuto comprare un
bambino a Santiago per 10.000 dollari. Tuttavia, moriva
dalla voglia di avere un figlio suo.
Con il suo problema, Caterina partì per gli Stati Uniti:
per l'esattezza si recò a Providence, Rhode Island. Le era
stato detto che, in quella città, svolgeva la propria attività
un ostetrico di origine cilena, ma naturalizzato americano,
che si interessava delle donne con i suoi stessi problemi. Si
recò da lui, lui ascoltò la sua storia e poi mi telefonò, dicendomi: «Ho qui, nel mio ufficio, la "sorella gemella" di
Mary e desidero sottoporla ad alcuni semplici test. Ma, se i
risultati sono normali, vuole per piacere dimetterla?».
Una promessa del genere non poteva che rallegrarmi, in
quanto quell'ostetrico cileno-americano e quella Mary avevano destato in me un interesse immunologico per il problema che devono affrontare le donne che, spontaneamente e
ripetutamente, abortiscono.
La «Mary» della nostra conversazione telefonica era
un'infermiera ventottenne, con una capigliatura rosso fiamma da irlandese. Aveva appena partorito, sebbene con un
mese di anticipo, una bambina sana, dai capelli rossi, ritrat98
to della madre. Era la prima gravidanza conclusasi felicemente. I sette precedenti concepimenti erano sfociati spontaneamente in un insuccesso. Il problema per Mary era di essere troppo «affine» al marito. Anche per Caterina, forse,
c'entrava un inusitato concorso di circostanze biologiche?
Già nei primi anni di medicina si apprende che la gravidanza di una donna è connessa all'affinità con il marito, e
tale situazione non si riferisce certo a tratti fisici o psicologici ma, come si chiarirà più avanti, ad una particolare determinazione immunologica.
Come risultò poi, le supposizioni su Caterina erano giuste. Lei e il marito erano cugini in terzo grado e i profili riguardanti la loro istocompatibilità erano molto somiglianti.
Ma, prima di chiudere con questa storia, dobbiamo ancora
avere qualche informazione di fondo.
La concupiscenza, l'amore e i linfociti sono inestricabilmente legati in quella trama complicata che è responsabile
della sopravvivenza delle specie. Ci concentreremo qui sul
ruolo dei linfociti. Quando analizziamo nei particolari l'immunologia del concepimento e della gravidanza, vediamo
che la Natura ha sviluppato numerosi meccanismi per perfezionare e proteggere l'unica cosa della massima importanza che possiamo fare: riprodurre noi stessi. Non vi è spazio
qui per avere tutte le uova in un unico paniere.
Con l'orgasmo, la donna contrae la vagina per favorire la
risalita di migliaia di cellule spermatiche, donatele così generosamente dal partner all'imboccatura dell'utero, fino a
quei sottili canali che si dipartono da ogni lato dell'utero e
che sono noti come tube uterine o trombe di Falloppio. Naturalmente il concepimento è possibile anche senza orgasmo, ma è più difficoltoso. Migliaia di spermatozoi, dotati
di code che vibrano senza tregua, risalgono controcorrente
verso le tube. In questo modo, l'uomo impregna la donna
di materiale estraneo. Da un punto di vista immunologico,
quegli spermatozoi invadenti e mobilissimi sono altrettanto
incompatibili, per l'organismo femminile, dei gonococchi.
E la donna non tralascerebbe di respingerli!
99
Ma, se respingesse quelle cellule spermatiche estranee,
eliminandole senza cerimonie, non verrebbe mai fecondata
e la specie finirebbe per estinguersi. Potrebbe solo accettare
quegli spermatozoi che portano un'informazione genetica
identica, o quasi identica, alla propria, trattandoli in modo
privilegiato, come se facessero parte del proprio «sé», ma
questo non apporterebbe alcun vantaggio alla specie. La
sperimentazione è la regola in natura. La donna deve offrire un vantaggio selettivo agli spermatozoi che provengono
da un individuo che sia molto diverso da lei. La Natura mostra indifferenza per il destino di quelle cellule che sono simili a quelle della nostra madre potenziale. D'altra parte, il
non respingere quelle cellule richiederebbe sicuramente la
soppressione della capacità immunitaria della donna, il che
sarebbe pericoloso: è inutile restare incinta per poi morire
di polmonite.
La mucosa vaginale, abbondantemente irrorata dal sangue, è in contatto per un certo periodo di tempo con il liquido seminale estraneo e le cellule spermatiche in esso contenute. Dato che le proteine estranee a cui un organismo è ripetutamente esposto dovrebbero generare in esso una risposta sempre più vigorosa, perché (in generale) la donna non
respinge lo sperma?
Nella profondità dei testicoli, «fabbriche» di cellule producono centinaia di migliaia di spermatozoi, i quali, quando sono pronti, si spostano nella prostata. Questa fa parte
dell'apparato sessuale maschile e produce quel liquido ricco
di sostanze in cui gli spermatozoi sono sospesi. Il liquido seminale ha proprietà meravigliose, non ultima la capacità di
bloccare le infiammazioni; e a lui va in gran parte il merito
di bloccare la reazione immunologica contro gli spermatozoi e le altre proteine introdotte con il liquido seminale, che
altrimenti si scatenerebbe nella vagina. Anche se non vi sono certezze definitive pare che nel liquido seminale si troverebbero sostanze simili alle prostaglandine, le quali - come
sappiamo - sono potenti antinfiammatori.
Dopo che tutto questo materiale estraneo è stato riversal00
to nella vagina e, grazie a quel calmante immunologico che
è il liquido seminale, ogni reazione locale è stata bloccata,
molti spermatozoi giungono nelle tube uterine, si liberano
del liquido seminale e cominciano a risalire, nuotando, nel
liquido prodotto localmente, tutti aspirando a penetrare in
un ovulo, la piccola cellula germinale femminile prodotta
da un'ovaia. Il loro potenziale antigenico (estraneo) viene
esibito al sistema immunitario locale delle tube, che reagisce, questo sì, alla sfida. Quanto più gli spermatozoi sono
estranei, cioè quanto maggiore è la differenza genetica tra
uomo e donna, tanto più l'apparato immunitario locale della donna ha probabilità di venire attivato.
Comunque sia, la risposta immunologica all'interno delle
tube non intralcia affatto la fecondazione, ma anzi la favorisce. Date le migliaia di cellule estranee che la invadono, la
reazione che la donna oppone con il proprio sistema immunitario non è sufficientemente rapida per distruggerle tutte.
Quello che basta è che una e una sola cellula spermatica incontri l'ovulo, penetri in esso attraverso la membrana e lasci avviluppare i propri geni maschili ai geni femminili ivi
presenti, nel più amoroso di tutti gli amplessi: quello che fa
scoccare la scintilla della vita.
L'ovulo è il sommo fautore della monogamia. Dopo la
fecondazione, la sua membrana protettiva diventa impenetrabile: la porta viene chiusa in faccia. Tutti gli aspiranti
che non hanno avuto successo vengono quindi distrutti ed
eliminati. Quando ciò accade, come è abituale in ogni tipo
di infiammazione, le tube vanno soggette a un rigonfiamento locale. Di conseguenza, il loro diametro si restringe e viene notevolmente rallentato il passaggio del minuscolo ovulo
fecondato (zigote), che già comincia a dividersi e il cui ruolo è ormai così rilevante. Ciò ha notevole importanza, perché altrimenti lo zigote potrebbe cadere lungo le tube e poi
nella vagina e andare perduto.
II rallentamento dell'ovulo fecondato è importante per
un'altra ragione. La destinazione finale dell'ovulo è la parete dell'utero e deve trascorrere il tempo necessario perché
101
quest'organo sia pronto a ricevere l'ospite che vi dovrà rimanere, secondo il programma, ben nove mesi.
I ratti si comportano in maniera diversa, ma i nostri meccanismi di fisiologia riproduttiva sono stati svelati proprio
studiando questi impagabili partner. Le femmine dei ratti
hanno un utero diviso da una membrana in due «ali» separate. Alcuni ricercatori hanno introdotto spermatozoi di
ratto in una delle due ali e hanno osservato una reazione infiammatoria solo in questa parte, dimostrando così l'attività antigenica dello sperma e la presenza di reazioni immunitarie nell'utero. Successivamente, quando quei ricercatori
hanno lasciato che i maschi si accoppiassero naturalmente
con le femmine e che queste diventassero gravide, l'infiammazione compariva sempre nell'ala che era stata precedentemente stimolata dalle iniezioni. La risposta immunologica
nell'utero è risultata una componente essenziale del meccanismo necessario a instaurare una gravidanza.
Quanto appena detto servirà a non rimanere sorpresi nel
sentire che i topi deliberatamente inincrociati, e quindi geneticamente molto simili, hanno meno successo dei ceppi
selvatici negli accoppiamenti.
Abbiamo già trattato il concetto di marchio biologico negli esseri umani: sulla superficie di ogni cellula vi sono
«bandierine» di natura proteica a indicare, per ciascuno di
noi, la propria individualità. Questa «firma» che portiamo
sulla membrana di tutte le nostre cellule è una creazione
praticamente unica. Abbiamo già detto che ci serviamo di
questi marcatori per differenziare il «sé» dal «non sé». Per
esempio, il nostro sistema immunologico reagisce con un virus a livello della gola, lo confronta con il nostro marchio,
si rende conto della differenza e attacca.
Quando i marcatori del «sé» penetrano in un altro organismo, questo reagisce in modo violento, a meno che, per
puro caso, essi non siano duplicati perfetti dei marcatori di
quell'organismo: un'evenienza però molto improbabile. In
notevole misura la violenza con cui attacchiamo le cellule di
un organismo estraneo è graduata dalla differenza che esi102
ste tra noi e quell'organismo. Del sistema fanno parte almeno otto principali marcatori proteici e moltissimi altri marcatori minori. Se due individui sono identici tranne che per
un marcatore principale, la reazione immunitaria provocata
avrà un'intensità minore che se i due individui fossero totalmente diversi. (Questo concetto verrà ripreso con maggiori
particolari nel capitolo sui trapianti.)
Quanto più diverse saranno le cellule di un uomo e di una
donna, tanto meglio avverrà il rimescolamento genetico di
cui abbiamo parlato. Siamo oggi in grado di esaminare in
laboratorio le cellule di una coppia in modo da stabilire
quanto siano diverse o simili dal punto di vista della istocompatibilità (compatibilità dei loro tessuti). Quando questo esame è stato effettuato su numerose coppie senza figli,
in cui la donna aveva subito ripetuti aborti e per le quali
non vi era alcuna causa evidente di incapacità a procreare,
non c'è stato da sorprendersi nel trovare che tra molti coniugi l'affinità genetica era notevole.
Mescolando in una provetta cellule maschili e femminili
di ciascuna di queste coppie e lasciandole poi reagire fino in
fondo, abbiamo trovato che rispondevano molto debolmente all'«estraneità» l'una dell'altra, mentre di solito si
scatena una lotta mortale. È questa la situazione che abbiamo trovato analizzando i problemi che assillavano Mary e
Caterina: entrambe avevano una stretta compatibilità genetica con il marito.
Tuttavia, se questo è vero, perché Caterina ha portato
avanti la gravidanza per dodici settimane prima di abortire?
Grazie al grande zelo con cui opera l'apparato sessuale e all'assoluta superiorità numerica degli spermatozoi, una gravidanza può svolgersi anche in caso di compatibilità genetica, benché con una minor efficienza rispetto alle altre coppie. Ma il fatto dei ripetuti aborti di Caterina ha indotto a
pensare che la reattività immunologica avesse importanza
non solo nel mettere in moto una gravidanza, ma anche nel
mantenerla.
Una volta che l'ovulo fecondato si è annidato (impianta103
to) nella parete dell'utero appositamente predisposta, collegandosi mediante il suo primitivo cordone ombelicale alla
circolazione sanguigna materna, la lotta per la sua sopravvivenza ha inizio. Il bambino che risulta (geneticamente)
troppo simile alla madre è a rischio per tutto il periodo.
Basta pensarci un momento per rendersi conto che una
gravidanza avviata crea, in definitiva, una situazione analoga a quella dei trapianti. Quello che è dentro l'utero materno non è un rene, o un cuore, o un fegato, ma un intero essere umano. Il suo corredo genetico è per metà quello della
madre, ma per l'altra metà è quello del padre e questo è
spiacevole dal punto di vista immunologico. Se, dopo la
gravidanza, o addirittura durante la gravidanza stessa (anche se in questo caso è più difficile operare), un lembo di
cute del bambino viene trapiantato sulla superficie cutanea
della madre, sarà subito rigettato: lo sappiamo da esperimenti compiuti su animali, utilizzando ceppi identici inincrociati, che possono fornirci un animale vivo identico a
uno che si sta sviluppando nell'utero. Quando nasce un
bambino, il sangue della madre è pieno di anticorpi contro
quegli antigeni presenti nel bambino che portano il marchio
del padre e che sono diversi da quelli della madre. Nella
realtà, ci serviamo delle donazioni di questo sangue per riuscire a classificare, secondo il tipo, il profilo genetico di un
individuo. Sotto questo aspetto, una donna che abbia avuto
sei figli da sei uomini diversi è un vero e proprio patrimonio
biologico, dato che il suo sangue è pieno di anticorpi contro
una vastissima gamma di antigeni di istocompatibilità.
È pertanto evidente che dobbiamo ora discutere e quindi
demolire uno dei miti sulla maternità, rendendoci conto che
soprattutto in questo caso, le apparenze sono ingannevoli.
Abbiamo sempre dinnanzi a noi l'immagine di una madre
contenta, con un sorriso da Monna Lisa, che guarda con
benevolenza il proprio addome sporgente, con le mani appoggiate leggermente su quel «tumore» che essa, chiaramente, desidera ardentemente. Nel profondo però, il suo
corpo sta facendo del proprio meglio per respingere quel
104
parassita estraneo. È tuttavia inesplicabile la furia di quell'attacco che consente, comunque, al feto di sopravvivere.
In che modo una continua reazione immunologica contro
un feto in via di sviluppo finisce per proteggerlo, anziché
distruggerlo?
Per rispondere ad un simile quesito, dobbiamo introdurre nel racconto due nuovi personaggi. Uno, che vi partecipa
solo remotamente, è il grande scienziato Sir Isaac Newton,
vissuto nel XVII secolo; l'altro, che è di fatto molto intimamente coinvolto in tutto questo, è il bambino dotato di intelligenza immunologica.
In una giornata d'inverno Newton stava pattinando su
uno stagno ghiacciato con un amico e, scherzando, lo spinse lontano. Mentre lo guardava scivolare sul ghiaccio, si accorse che anch'egli si stava spostando all'indietro. Sul
ghiaccio, in assenza di attrito, il suo amico, passivamente,
aveva spostato lui tanto quanto lui (Newton) aveva spostato
l'amico. Newton corse alla ricerca di un bastoncino, lo appoggiò sul ghiaccio e i due rimasero con la punta del piede
contro quel pezzo di legno che sarebbe diventato presto famoso, ciascuno contro una o l'altra estremità del bastoncino. Newton diede una spinta ed entrambi i pattinatori si
staccarono dal bastoncino. Come egli aveva previsto, la distanza che entrambi avevano percorso era uguale. Quanto
più Newton spingeva con energia l'amico (che doveva essere
un'anima paziente e mite), tanto più essi si allontanavano
l'uno dall'altro. Tuttavia, la distanza percorsa da entrambi
rimaneva sempre uguale. Ci sembra di immaginare Newton
che, pattinando velocemente sul ghiaccio, grida a chiunque
lo possa sentire: «Per ogni azione, vi è una reazione uguale
e contraria!». O qualcosa di simile.
Le armi del sistema immunitario sono cellule che producono l'infiammazione e cellule regolatrici che le controllano
assicurando che qualunque risposta sia appropriata. Quanto più forte è l'attacco immunologico lanciato, tanto più intenso è l'effetto smorzante delle cellule immunoregolatrici.
Nella risposta immunitaria vi è una leggera variazione del
105
tema newtoniano. Se entrambi i segnali di via libera e di arresto fossero sempre uguali, non accadrebbe nulla. Pertanto, la reazione ricorda maggiormente due squadre che giocano al tiro alla fune, con una delle due (la squadra d'attacco) che ha all'inizio alcuni uomini forti in più. Ben presto,
però, questi perdono il loro vantaggio, quando l'altra squadra (che ha funzione di regolazione) recluta degli aiutanti
ed entrambe le squadre ritornano ancora una volta alla posizione di partenza. Entrambe agiscono simultaneamente e
il risultato è una situazione di equilibrio. Ciò che stiamo
cercando, nella fisiologia della gravidanza, è questa situazione di equilibrio, in cui la risposta immunologica contro il
bambino metta in vantaggio le forze soppressive.
Sappiamo che, se madre e figlio sono simili, si generano
forze soppressive relativamente deboli, con il risultato che il
sistema immunitario della madre continua in modo lento,
ma persistente, a rigettare il bambino.
In che modo, durante la gravidanza, la «squadra di attacco» si è indebolita e la «squadra regolatrice» si è rafforzata?
L'imperversare dei linfociti materni contro il bambino è
ostacolato da tre importanti fattori che spostano l'equilibrio in suo favore: le cellule regolatrici materne, soggette a
una potente stimolazione, esercitano sui linfociti aggressori
un'influenza «calmante», la parete che il bambino si è costruita tutt'attorno lo difende dall'attacco dei linfociti,
mentre il sistema immunitario contribuisce a sopprimere
quei linfociti T materni che potrebbero mettere in pericolo
la sua sopravvivenza.
A dieci settimane, il sistema immunitario del feto comincia a esplorare l'ambiente in cui si trova e si prepara per la
difesa. Ma contro chi ha a che fare? All'esterno c'è la madre, tutto amore e devozione, che sferruzza scarpine di lana, ed è presa da incomprensibili voglie che soddisfa giustificandosi con un «solo per questa volta!», e proprio per la
prova ardua a cui è sottoposta appare molto sciupata. Ma
nel proprio intimo essa attacca il bambino: i conati di vomi106
to mattutini sono il riflesso del suo indefesso lavorio biologico nei riguardi di quell'essere che le cresce nell'addome.
Il povero esserino deve essere separato dalla madre da
una serie di membrane, erette per isolarlo da un ambiente
profondamente ostile. In determinati punti (in corrispondenza della placenta), queste membrane sono organizzate in
modo da lasciare che certi elementi del sangue e fattori nutritivi della madre possano filtrare verso il bambino. Se
sono integre, i linfociti T aggressori della madre non possono raggiungere il feto; una lesione, invece, determina l'aborto.
Tuttavia, la Natura dota il bambino di un meccanismo
proprio di difesa istintiva, che contribuisce a fare diminuire
il pericolo che è tutt'attorno. Il sistema immunitario del feto consente a tutte le giovani cellule regolatrici di secernere
sostanze soppressive. Poiché, per il momento, nessuna lotta
è in corso all'interno del feto che si sta sviluppando, questo
può permettersi il lusso di essere immunodepresso. Le sostanze vengono inviate nel corpo della madre attraverso la
placenta per ammansire i linfociti T.
Le cellule regolatrici non fanno che eseguire il loro compito, ma ciò pone il bambino di fronte al rischio di essere
sopraffatto da un agente infettivo che, in questo periodo
vulnerabile, riesca ad attraversare la barriera costituita dalla placenta. Tuttavia, desta più preoccupazione l'aggressione da parte della madre. Se non intervengono altri meccanismi, il contare solo sulle proprie forze può non essere sufficiente a salvare il bambino, ma può comunque essere quella
forza soppressiva supplementare che completa il divario tra
sopravvivenza e rigetto.
Una simile mossa da parte del bambino può essere di
grande aiuto per certe madri. Come diremo a proposito delle malattie autoimmuni, quelle tremende situazioni in cui
un organismo viene attaccato dal proprio sistema immunitario (è il caso, per esempio, dell'artrite reumatoide), ciò
che manca fondamentalmente è la regolazione. Le vittime
di queste malattie non hanno sufficienti sostanze regolatrici
107
per bloccare l'autoaggressione. Quando una donna, affetta
da una malattia autoimmune, rimane incinta, il bambino
può, attraverso la placenta, inondarla con una quantità di
sostanze immunoregolatrici sufficienti a sopprimere le tendenze autoaggressive che essa ha sviluppato e che sono causa della sua malattia. Durante la gravidanza essa rifiorirà,
ma il problema si ripresenterà ventiquattr'ore dopo il parto.
Un altro rischio mette a repentaglio la sopravvivenza dei
feti di sesso maschile. La maggior parte degli aborti spontanei si riferisce a questi soggetti. Se il bambino è un maschio,
le madri sono davvero spinte a compiere uno sforzo supplementare per rigettarlo. Perché? Perché i maschi esibiscono
con fierezza il loro sesso mediante un marcatore biologico
che, ovviamente, non compare mai sulle cellule femminili e,
pertanto, viene considerato estraneo dalle madri.
I padri determinano il sesso dei propri figli. I loro spermatozoi possono contenere geni sia maschili sia femminili,
mentre gli ovuli materni contengono solo geni femminili.
Quando uno spermatozoo determina un figlio maschio, lo
condanna a un ulteriore rischio immunologico.
Il sapere che le donne che vivono in uno stato di notevole
stress possono subire un grado di immunosoppressione da
moderato a elevato ha una notevole attinenza col tema trattato in questo capitolo. Come risultato esse sono meno capaci del solito di rigettare i loro feti. Pertanto, non si deve
rimanere sorpresi del fatto che, in periodi di stress, nascano
più maschi che femmine. Ciò è stato chiaramente dimostrato durante la seconda guerra mondiale, in cui il tasso di natalità per i maschi vivi si è innalzato. Per inciso, il marcatore maschile rende leggermente più arduo trapiantare un rene maschile in una donna affetta da malattia renale. Ciò
che si è detto, unitamente agli effetti dello stress sulla risposta immunitaria, saranno trattati in seguito in maniera più
particolareggiata.
La gravidanza, l'esempio più sorprendente di adattamento perfetto, consente a un corpo «trapiantato» di sopravvivere all'interno di una donna immunocompetente. Come si
108
La genetica della sopravvivenza fetale
Cellula della madre
Cellula del padre
Antigeni del SÉ esposti alla superficie troppo simili tra loro: rigetto
Cellula della madre
Cellula del padre
Antigeni del SÉ esposti alla superficie diversi tra loro: successo
può ben immaginare, gli immunologi stanno cercando di
sviluppare la conoscenza e la tecnica necessarie per usare tale metodologia al fine di impedire il rigetto di organi trapiantati come il cuore, il fegato, i polmoni e, naturalmente,
quando si vogliono curare le molto frequenti malattie autoimmuni.
Come abbiamo già ricordato, le madri producono molti
anticorpi contro gli antigeni paterni posseduti dai loro figli.
Gli anticorpi possono, e devono, attraversare la placenta ed
entrare nel circolo sanguigno del feto se, al momento della
nascita, il bambino deve essere in qualche misura protetto
dalle grandi quantità di batteri che lo assalgono. Perché gli
anticorpi diretti contro i tessuti fetali non danneggiano il
bambino? Sembra che, nella placenta, vi sia una disposizione a spugna molto ingegnosa, in cui si esprime molto intensamente (visibilmente) una schiera di antigeni paterni. Gli
anticorpi diretti contro il bambino saranno assorbiti in questo «pozzo», mentre gli anticorpi buoni penetreranno nel
feto (sono questi gli anticorpi che non reagiscono con i tessuti del feto).
La placenta è anche in grado di secernere fattori ormonosimili. Tra questi il più interessante è la proteina plasmatica
associata alla gravidanza (PAPP, dall'inglese Pregnancy
Associated Plasma Protein). Si tratta di una sostanza molto
importante per il mantenimento di una gravidanza normale
e, cosa affascinante, la placenta la libera solo quando, nel
feto, vi è una risposta immunitaria. Sembra che essa amplifichi la funzione di quelle cellule immunologiche che regolano, smorzandola, l'attività dei linfociti aggressori. La Natura è determinata ad avere una quantità di tecniche «che
garantiscono il successo» e che operino all'unisono nel proteggere il suo esperimento più prezioso: il rimescolamento
genetico che si attua al concepimento.
Torniamo ora a Caterina, privata della gioia di essere
mamma. Le abbiamo spiegato tutto quanto abbiamo fin
qui detto e le abbiamo dato i risultati del test effettuato sulle sue cellule e su quelle del marito. Il grado di somiglianza
110
genetica tra i due era nell'ambito che sospettavamo. C'erano buone probabilità che riuscisse a scatenare una reazione
di rigetto nei riguardi del feto.
Le venne detto che aveva una probabilità ragionevolmente buona di portare a termine con successo la gravidanza se
era d'accordo di prendere, per tutto il periodo della gestazione, una piccola dose di un farmaco simile al cortisone. Il
cortisone può, tra i numerosi altri effetti, reprimere le risposte immunologiche. Con questo metodo c'erano per lei e
per il bambino alcuni rischi di minore importanza, ma eravamo fiduciosi di poterli tenere sotto controllo senza eccessiva difficoltà.
Così è stato. Scommetto che, nel momento in cui scrivo,
il figlio di Caterina sia già diventato un ottimo cavallerizzo.
La terapia che verrebbe attuata oggi, a pochi anni di distanza, non è più la stessa. La ricerca in questo campo ha
compiuto rapidi progressi. Le donne che si trovano nella
stessa situazione di Caterina vengono «immunizzate» con i
tessuti dei mariti prima di iniziare la gravidanza. L'iniezione di cellule e di estratti di tessuti del marito nella cute e nel
circolo sanguigno può fare aumentare, in numerose occasioni, la reattività immunologica della donna alle differenze
di minore importanza. I risultati ottenuti in questi primi
tempi di applicazione del nuovo metodo sono incoraggianti. In un gruppo, il 78 per cento delle donne fino ad allora
incapaci di portare a termine una gravidanza, a causa dei
problemi di compatibilità con il marito, hanno dato alla luce bambini normali.
111
4
I tentativi umani di trapianto
Questo libro celebra quel vero prodigio che è il corpo umano quando è in perfetta salute. Il corpo umano, la più sofisticata tra tutte le creazioni della Natura (anche se su questo
punto si potrebbe discutere) funziona, infatti, con una precisione, o addirittura una perfezione, che non è mai stata
raggiunta neppure dai più ingegnosi manufatti dell'uomo.
Siamo le creature più intelligenti e, pertanto, siamo in grado di analizzare il dono che ci è stato fatto per rivestire l'anima e di valutarlo. La stessa intelligenza, però, ci dice che
non siamo perfetti. E una delle nostre imperfezioni è proprio la giovinezza. A dire il vero, i corpi giovani sono molto
vicini alla perfezione, ma molto spesso sono guidati dall'intelligenza e non dalla saggezza. Ne consegue che spesso si
vedono corpi in sé molto belli, irreparabilmente rovinati da
diete sbagliate, o corrosi da sfrenati «divertimenti» e licenze
di ogni genere contrabbandate come libertà. Se soltanto la
materna saggezza, come gli anticorpi, potesse attraversare
la placenta e proteggere i giovani fino a quando non sono in
grado di provvedere da soli!
Fu proprio una mancanza di saggezza che spinse due giovani sorelle ad abusare del loro corpo con un veleno che le
portò alla mia attenzione in un momento in cui un filo
estremamente sottile le teneva ancora in vita. Susan e Marion avevano rispettivamente quindici e quattordici anni a
quell'epoca. Studiavano e abitavano in una fattoria nel
Connecticut settentrionale.
112
Erano persone sane: la natura e i genitori avevano lavorato bene. Ma, a un certo punto, cominciarono a prendere
il vizio di fiutare la benzina. Non è un fatto raro: l'abitudine di fiutare sostanze aromatiche pericolose, dalla colla alla
benzina, per provare una «piacevole» sensazione di liberazione dalla realtà, è in continuo aumento.
Come spesso accade, un groviglio di circostanze aveva
permesso alle ragazze di scivolare verso una tossicodipendenza mortale. Gli affari della fattoria non andavano molto
bene. I prezzi del petrolio erano lievitati e la piccola azienda
agricola era molto meccanizzata. Il padre delle due ragazze
riusciva a ricavare un profitto solo utilizzando le più recenti
macchine agricole; ma, anche con una buona attrezzatura,
era costretto a lavorare dall'alba al tramonto per far quadrare i conti. Perciò la madre, anche se con una certa riluttanza, tornò a lavorare in una città vicina non appena capì
che i figli potevano badare a se stessi per un'ora, o poco
più, dopo la scuola. Susan e Marion avevano quattro fratelli più giovani, due maschi e due femmine. Erano in piena
salute e non soffrivano dei problemi che hanno di solito le
sorelle maggiori.
All'interno della proprietà vi era un grande capannone,
in cui venivano riposti i trattori e gli altri macchinari agricoli. In esso il padre teneva anche grandi fusti di benzina. Sue
mi disse, in seguito, di ricordare che, già da piccola, amava
sentire l'odore della benzina e che quel capannone era sempre stato un luogo particolare per loro bambini, una specie
di caldo, irreale rifugio per giocare e fantasticare. Così, ritengo che nessuno fosse particolarmente sorpreso dal fatto
che Sue togliesse i tappi dai fusti di benzina per sentire l'odore che si spandeva nell'aria.
Purtroppo, un infausto giorno, essa si chinò sul fusto e
inalò profondamente i vapori aromatici. Perché, non riuscì
mai a dirlo. Potè riferire, invece, i meravigliosi effetti che
l'inalazione di quei vapori aveva prodotto in lei. Si era sentita «così bene»! Le preoccupazioni erano scomparse non
appena all'ansia si era sostituito un sentimento di sciocca
113
spensieratezza. Aveva indotto anche Marion a partecipare a
quelle sedute e ben presto esse avevano preso l'abitudine,
ogni giorno tornando da scuola, di andare subito al capannone per una «sniffata». Avevano continuato così per tre o
quattro mesi, mentre i loro genitori, stanchi e pieni di
preoccupazioni, non sospettavano nulla.
Il primo segnale venne da Marion, quando cominciò a
coprirsi di lividi. Bastava urtasse una coscia contro la tavola perché le comparisse un brutto livido; in poco tempo ne
era piena. Parlando con la madre, mi disse di aver notato,
prima che comparissero i lividi, che le due ragazze erano
apatiche e svogliate da un paio di settimane.
Allarmata, fissò un appuntamento con il medico di famiglia il quale ordinò di effettuare alcuni esami del sangue,
con l'accordo di ritrovarsi, Marion e la madre, dopo quattro giorni per esaminare i risultati. Ma già prima che trascorressero ventiquattr'ore le chiamò al telefono per avvisarle che il sangue di Marion manifestava qualcosa di molto
grave. Spiegò che il problema principale sembrava essere un
conteggio estremamente basso di piastrine.
Le piastrine sono cellule prodotte nel midollo osseo, che
circolano nel sangue svolgendo un ruolo fondamentale nella coagulazione. Quando un vaso sanguigno è danneggiato
(anche di poco) si determina una fuoriuscita di sangue dovuta alla pressione esistente nell'apparato circolatorio di cui
è responsabile la pompa cardiaca; al di là della gravità della
lesione vasale essa viene rapidamente tappata in modo che
non possa sfuggire altro sangue prezioso.
I vasi sanguigni lesi secernono una sostanza vischiosa a
cui aderiscono le piastrine, le quali, a loro volta, tappano
efficacemente la falla, attivando quindi i fattori di coagulazione presenti nel sangue. Attorno alla lesione si forma un
coagulo. Questo poi si dissolverà lentamente e, comunque,
soltanto dopo che la ferita si è completamente cicatrizzata.
Di solito, in ogni goccia di sangue sono presenti circa
25.000 piastrine. Quelle di Marion erano scese a 4000, ma
essa doveva anche far fronte ad altri problemi: le cellule che
114
aiutano gli anticorpi a lottare contro i batteri, i cosiddetti
neutrofili, erano molto ridotte di numero. Inutile dire che
la giovane Marion non collegava questo suo problema al
fatto di aver fiutato la benzina. La madre e il medico di famiglia, entrambi molto preoccupati, l'avevano fatta visitare
subito da un ematologo. Dopo aver ascoltato la storia e
aver esaminato la piccola paziente, lo specialista ordinò il
ricovero immediato.
Quella sera stessa, dopo la doccia, Susan, allarmata, mostrò agli increduli genitori numerose ecchimosi che si stavano formando. Essa raggiunse subito la sorella in ospedale,
visto che le anomalie del suo sangue erano identiche a quelle di Marion. Dato che le due sorelle avevano lo stesso problema, i medici, per spiegare la loro condizione, cominciarono subito a ricercare a quale sostanza tossica entrambe
fossero state esposte e presto scoprirono che sniffavano la
benzina. Da tempo è noto che i vapori di benzina sono tossici e in grado di distruggere molte cellule che circolano nel
sangue umano. A questo punto la causa delle anomalie
ematiche riscontrate in Marion e Susan era ovvia, ma la
prognosi non lo era affatto.
I velenosi vapori di benzina inalati dalle due ragazze erano giunti nei polmoni, dove erano passati facilmente nel
sangue e, una volta in circolo, erano giunti nel midollo osseo. I delicati meccanismi, responsabili dell'istruzione, nel
midollo osseo, di un numero così elevato di cellule d'importanza vitale, erano così alterati. Talvolta, con misure di sostegno, come le trasfusioni di sangue totale e di piastrine, si
può guadagnare tempo per permettere al midollo di guarire
dagli effetti tossici dei vapori. In alcune occasioni anche gli
ormoni possono favorire il processo. Nessuna di queste terapie, però, aiutò Sue e Marion e le due ragazze erano davvero gravi quando le vidi per la prima volta.
Allorché fu evidente che sarebbero morte prima della ripresa dell'attività del loro midollo (supponendo che lo potesse), si concluse che la guarigione sarebbe stata possibile
solo con un buon trapianto di midollo osseo, cioè grazie al
115
dono di cellule del midollo da parte di una persona sana.
Una volta introdotte nel circolo sanguigno delle due ragazze, queste cellule si sarebbero precipitate negli spazi liberi
del midollo e avrebbero riparato il danno.
Sia la madre sia il padre si offrirono subito come volontari, ma altrettanto rapidamente comunicammo loro che né
l'uno né l'altra sarebbero stati idonei. Le ragazze avevano
bisogno di cellule di midollo indistinguibili dalle loro. Perché? Perché se queste cellule fossero state diverse, avrebbero potuto verificarsi o l'uno o l'altro di due eventi, entrambi fatali.
Se i linfociti T di Marion e Sue erano intatti (come effettivamente lo erano, non essendo stati danneggiati dalla benzina), cellule di midollo diverse dalle loro sarebbero state
attaccate senza pietà e non avrebbero potuto attecchire. Se,
per contro, avessimo represso farmacologicamente i linfociti T delle due sorelle (cosa che potevamo fare, ma sarebbe
stato pericoloso), le cellule di midollo non identiche, trapiantate in Marion e Sue, avrebbero potuto ucciderle. Il midollo contiene molti linfociti T, che risiedono abitualmente
in esso ed esercitano una notevole influenza sulla produzione di tutte le cellule ematiche, non solo sui linfociti B che
danno origine agli anticorpi. Questi linfociti T potrebbero
«riconoscere» come estranee le due fanciulle e avere nei loro riguardi una reazione di «rifiuto», che li indurrebbe ad
attaccare simultaneamente molti tessuti.
La conseguenza di ciò sarebbe una reazione di rigetto dell'ospite da parte delle cellule trapiantate. Infatti, i linfociti
T del donatore vagherebbero per il corpo, attaccando in
primo luogo la cute, il cervello, il fegato e l'intestino, ma alla fine tutti gli organi cadrebbero di fronte a un simile attacco. Una morte causata da una situazione di questo tipo è
davvero una brutta morte. No, Marion e Sue dovevano ricevere cellule di midollo identiche o sarebbero state spacciate!
I genitori avevano dato entrambi il 50 per cento dell'informazione genetica che ora era il patrimonio genetico di
116
ciascuna delle due ragazze. La ragione di questo 50 per cento è importante. Tutta l'informazione genetica è codificata
nei cromosomi. Più precisamente nei geni che sono allineati
su ciascun cromosoma. Ora si immagini che i geni siano
canzoni, incise su un nastro (il cromosoma). I cromosomi
sono, di fatto, strutture appaiate (come se fossero due nastri magnetici avvolti l'uno attorno all'altro). Quando una
cellula germinale (cellula uovo o spermatozoo) si forma, riceve solo uno dei due cromatidi avvolti l'uno attorno all'altro a costituire il cromosoma (cioè il 50 per cento dell'informazione). Per questa ragione, in senso genetico, le due figlie non potevano essere identiche né alla madre né al
padre.
Nel nucleo di ogni cellula umana vi sono ventitré paia di
cromosomi. Ogni paio è nettamente diverso dagli altri e i
genetisti sono in grado di identificarli tutti. A ciascuna delle prime ventidue paia sono attribuiti numeri (1-22), mentre
i cromosomi del ventitreesimo paio, che determinano il sesso di un individuo, sono chiamati «cromosomi sessuali».
Al momento del concepimento, un cromosoma di ciascuna
117
Piccolo segmento di CROMOSOMA 6
delle ventitré paia sarà trasmesso alla prole sia dal padre
che dalla madre.
Se ciascuno dei ventitré programmi genetici (cromosomi)
della madre viene diviso in due quote uguali, indicate con
W e X, e ciascuno di quelli del padre in due quote anch'esse
uguali, indicate con Y e Z, è ovvio che, per un qualsiasi
paio di cromosomi, tutti i figli della coppia devono avere
una o l'altra di queste quattro possibili formule genetiche:
WY, WZ, XY o XZ. Ad ogni gravidanza l'uscita di una di
queste quattro formule è equiprobabile. Così, in una famiglia, tre figli nati uno dopo l'altro potrebbero avere la stessa formula oppure potrebbero essere tutti diversi. Questo
sarebbe dovuto puramente al caso, mentre è certo che, se in
una famiglia vi sono cinque figli, uno qualsiasi degli appaiamenti genetici particolari deve essere ripetuto almeno
una volta.
A Sue e Marion vennero somministrati in continuazione
118
sangue, steroidi, piastrine, antibiotici e... preghiere. Ma esse avevano un'unica speranza cui aggrapparsi: avevano entrambe bisogno di trovare un fratello o una sorella che
avesse lo stesso profilo tissutale del loro, programmato geneticamente.
I geni per gli otto principali marchi di fabbrica biologici
(cioè gli antigeni del «sé» o antigeni di istocompatibilità) e
per una miriade di marchi minori, che punteggiano la superficie delle nostre cellule, sono localizzati sulla coppia
cromosomica numero 6. Marion e Susan avevano bisogno
di un fratello o di una sorella che avesse ereditato la stessa
loro combinazione di geni materni e paterni per gli antigeni
di istocompatibilità.
Da come si concluse la vicenda, possiamo affermare che
le due ragazze furono davvero fortunate: avevano entrambe
un fratello o una sorella che era la loro copia perfetta. Paul,
il fratello di Susan, aveva dieci anni. Rachel, la sorellina di
Marion, ne aveva solo quattro. Naturalmente, c'erano alcune remore di natura etica nell'utilizzare soggetti in età così
giovane, ma i genitori, i medici e il comitato etico dell'Istituto furono concordi nel riconoscere l'opportunità di ricorrere a quelle misure in extremis per tentare di salvare le ragazze.
I due piccoli donatori furono anestetizzati e grossi aghi
vennero loro inseriti nell'osso iliaco per estrarne il prezioso
midollo. Le cellule di midollo così ottenute vennero lavate,
diluite e iniettate per via endovenosa nelle due malate gravissime. Una volta introdotte nell'organismo, le cellule del
midollo dal circolo arrivano al midollo osseo del ricevente e
si insediano negli spazi precedentemente intossicati. Non finisco mai di meravigliarmi per il modo in cui le cellule sanno esattamente dove vogliono stare; comunque, la capacità
di orientamento di ogni tipo di cellula che viva in tessuti
specializzati all'interno di un organismo è infallibile.
Dopo il trapianto, per un paio di settimane, prima che il
midollo cominci a produrre nuove cellule, la situazione è
sempre incerta. Ma, sono felice di dirlo, le due ragazze gua119
rirono perfettamente e i loro fratelli, come conseguenza della loro generosità, non ebbero alcun danno. Le loro famiglie sono oggi più unite di prima e le due damigelle molto
più sagge. Dubito che avranno mai la voglia di provare anche solo una boccata di marijuana.
Ora, tranne il caso dei gemelli identici, la situazione appena descritta è quella che si verifica nei trapianti. Finché si
opera all'interno di un gruppo familiare, le variazioni tra
antigeni di istocompatibilità sono limitate; una volta che si
esce dal gruppo familiare, la probabilità che due persone
che siedono l'una a fianco dell'altra su un aereo siano identiche in questo senso è di circa 200.000 a 1. Di conseguenza,
se ci si trova in ospedale in attesa di un trapianto di rene, le
probabilità che il «donatore giusto» sia trasportato al Pronto Soccorso praticamente morto, con un biglietto nel portafoglio così stilato: «In caso di mio decesso, dispongo che
siano utilizzati i miei organi», sono davvero esigue.
Prima di trattare i trapianti d'organi consideriamo ancora un po' più particolareggiatamente i «marchi di fabbrica»
biologici che rendono i trapianti così difficoltosi.
A chiunque debba essere sottoposto a un trapianto viene
praticata la «tipizzazione dei tessuti», cioè vengono caratterizzati i suoi marchi di fabbrica biologici, presenti come
proteine di membrana. Con l'aiuto di calcolatori e di sieri
di donne che hanno avuto molti figli sono oggi disponibili
grandi quantità di materiale da utilizzare per i test e contenente anticorpi contro tutti i differenti antigeni di istocompatibilità della nostra comunità. A questi marcatori sono
stati dati dei nomi. Sul cromosoma 6 vi sono quattro loci,
in cui si trovano i geni che li producono: essi sono contrassegnati dalle lettere A, B, C e D. Nella comunità umana vi
sono molti geni diversi, che potrebbero occupare ciascun locus. In un individuo qualunque, in corrispondenza di ciascun locus sarà presente un unico gene, ma si ricordi che i
cromosomi sono appaiati e pertanto vi saranno in tutto otto
geni interessati nel maggior complesso di istocompatibilità.
Ciò significa che gli esseri umani ereditano da ogni geni120
tore un corredo completo di loci A, B, C e D. Possiamo
mettere cellule di un potenziale donatore d'organi o ricevente in minuscoli pozzetti, ricavati in una bacinella di plastica, e quindi sospenderle in una piccola quantità di liquido. Possiamo quindi aggiungere ad ogni pozzetto una goccia di un anticorpo che sappiamo essere in grado di reagire
con un particolare antigene di istocompatibilità. Dato che
generalmente utilizziamo globuli bianchi umani (leucociti
umani) per questo compito, il sistema viene spesso citato
come sistema HLA (dalle iniziali delle tre parole inglesi Human Leucocyte Antigen). Se gli anticorpi aggiunti si legano
con le cellule presenti nel pozzetto, le cellule si aggregheranno e finiranno sul fondo, dove potranno essere osservate
come una piccola chiazza bianca. Uno degli otto antigeni è
stato così «tipizzato». Continuando allo stesso modo, si potrà avere alla fine un profilo come questo: il tipo HLA del
signor Smith è A3, A24, B8, B27, C2, C7, D2, D4.
Un donatore d'organi perfetto avrà tutti gli 8 marcatori
HLA uguali a quelli che il ricevente possiede ed espone. In
più dovrà avere lo stesso gruppo di marcatori dei globuli
rossi ad esempio del sistema AB0. Dove si può trovare un
simile soggetto? Al di fuori della cerchia familiare le probabilità sono davvero scarse. Per questo motivo, all'epoca dei
primi trapianti, i donatori d'organi erano solitamente parenti vivi del ricevente. Naturalmente, il trapianto si limitava al rene, perché in questo caso la disponibilità era doppia,
mentre non sarebbe facile chiedere a un membro della propria famiglia di donare il fegato o il cuore!
Non è necessario essere associati a un programma di «donatori viventi» per capire che le questioni immunologiche
sono di gran lunga oscurate, come importanza, dai drammi
umani inevitabilmente associati in questi casi.
Per capire che cosa voglio dire, immaginate il seguente
scenario. Vostro fratello, di cinque anni maggiore di voi,
sta morendo per una malattia renale: può salvarlo soltanto
un rene nuovo. È un brav'uomo, un lavoratore e ha una famiglia a carico. Voi, invece, siete sano e siete l'unico della
121
famiglia il cui tipo HLA coincida con il suo. Era contrario a
chiedervi un favore così grosso, ma, sollecitato dalla moglie
e dai genitori, si è fatto coraggio: «Vorresti sottoporti a una
grave operazione per far sì che uno dei tuoi due reni sani ti
sia asportato e sia trapiantato al posto dei miei reni ormai
morti?».
Tutti gli occhi sono su di voi. Cosa potete rispondere?
Certo non vi fa piacere, si tratta di una grossa operazione.
Talvolta vi sono degli imprevisti in chirurgia, non è forse
così? Rimarreste con un solo rene, e che cosa capiterebbe se
succedesse qualcosa a questo rene? Sareste davvero in un
bel pasticcio! Tuttavia, volete molto bene a vostro fratello,
e la famiglia desidera che gli diate questa possibilità. I vostri rapporti non sarebbero più gli stessi se diceste di no ed
egli morisse. Numerosi donatori mi hanno confessato che
inevitabili pressioni hanno impedito loro di sentirsi sereni
nel giudicare l'altruismo dell'atto in questione. Si sentivano
defraudati di quella giusta soddisfazione che viene dall'essere stati sobriamente generosi. Decidete, dunque, di farvi
operare e vostro fratello ha così un rene nuovo. Provate solo a immaginare i sentimenti di tutti coloro che sono coinvolti nella faccenda se sei settimane dopo l'intervento il rene trapiantato morisse e i chirurghi dovessero di nuovo intervenire per estrarre il vostro rene ormai inutile. Il vostro
sacrificio non sarebbe servito a nulla.
Purtroppo questo può capitare. Benché dall'80 al 90 per
cento dei reni trapiantati sopravviva e si mantenga sano e
funzionante, non è sempre così. La ferita o l'organo stesso
possono infettarsi, il delicato innesto del rene ai vasi sanguigni e all'uretere (il condotto che trasporta l'urina dal rene alla vescica) può incorrere in qualche complicazione oppure può succedere che il sistema immunitario del ricevente
rigetti il rene stesso.
Il sistema immunitario del ricevente può talvolta reagire a
una lieve differenza che non abbiamo potuto rilevare nel
nostro programma di tipizzazione dei tessuti. È necessaria
una breve spiegazione per quest'ultimo evento. Indubbia122
mente vi sono antigeni di istocompatibilità di cui sappiamo
pochissimo. Con l'eccezione dei gemelli identici, non possiamo avere il 100 per cento di sicurezza che due individui,
anche membri della stessa famiglia, siano perfettamente
compatibili. Con le famiglie abbiamo una sicurezza del 90
per cento, e questa è la situazione attuale. Così, il rene di un
fratello può essere rigettato e la tempesta che esplode in una
famiglia quando ciò accade è devastante. Il donatore è frustrato per l'insuccesso che il suo atto magnanino, causa di
tanto dolore ed angoscia, ha avuto. Il ricevente è sopraffatto dal senso di colpa di aver rigettato un organo, che con
tanto sacrificio gli era stato donato.
A causa di questo groviglio di emozioni e per il fatto che
la maggior parte dei pazienti con insufficienza renale non
hanno un parente vivo che sia perfettamente compatibile
con loro, le unità per il trapianto di organi sono state costrette, per poter procedere con il loro lavoro, ad accettare
due compromessi: devono raccogliere organi da cadaveri
(cioè individui legalmente morti) e devono reprimere il sistema immunitario del ricevente. Le équipes per i trapianti
cercano di procurare al loro paziente un donatore che abbia
nei suoi riguardi il massimo di compatibilità, ma nella realtà è necessario, perché l'organo trapiantato possa sopravvivere, che il sistema immunitario sia parzialmente paralizzato. Il perché è evidente: se non si riesce più a rigettare il rene
incompatibile, non si potrà neppure respingere il prossimo
virus o batterio che si «trapianterà» nel nostro organismo.
Che cosa succede quando un organo trapiantato viene attaccato? Posso assicurarvi che quel che accade è una cosa
orribile. I linfociti T che suonano l'allarme riconoscono
certe proteine HLA sulle cellule dell'organo trapiantato e
dei suoi vasi sanguigni. L'allarme scatta e i linfociti B e T
entrano in azione, distruggendo completamente il trapianto.
Il sistema immunitario ha, come sappiamo, una memoria
di proporzioni mastodontiche. Se si dovesse tentare un secondo trapianto con un tessuto simile in qualche modo al
123
primo, questo secondo trapianto verrebbe di fatto rigettato
prima ancora che il chirurgo termini di alloggiarlo nella
nuova sede. Un rene, ad esempio, potrebbe rigonfiarsi e diventare nero sotto gli sguardi inorriditi dell'equipe medica.
Non vi è nulla di nuovo sotto il sole e, pertanto, nulla di
nuovo circa il sogno dell'umanità di riuscire a sostituire
parti vecchie consunte o malate del proprio organismo con
altrettante giovani e sane. Vi è un dipinto famoso e molto
antico che raffigura i santi Cosma e Damiano nell'atto di
eseguire un trapianto su un nobile ricco. Un uomo benestante, di grande levatura, aveva bisogno di una gamba
nuova e il donatore, uno schiavo negro, viene rappresentato
nel quadro con una gamba sola. C'è sul suo volto un sorriso
di intensa soddisfazione per avere avuto la fortuna di essere
stato richiesto di donare una delle sue gambe (naturalmente
dopo aver firmato una dichiarazione di consenso, con tutte
le precisazioni del caso). La gamba del negro, attaccata alla
coscia del nobile, appare in buone condizioni e non vi sono
sintomi che il sistema immunitario del ricevente sia stato represso. (Naturalmente, i santi possono controllare il sistema immunitario meglio di come lo possiamo fare noi.)
Noi, invece, dobbiamo usare potenti farmaci immunorepressori, se non addirittura della vernice, per realizzare una
simile impresa. Uno dei grossi scandali dell'immunologia
moderna coinvolse tempo fa un giovane scienziato di New
York, il quale cercava il modo di fare accettare a topi bianchi il trapianto di cute di topi neri. Le pressioni esercitate
nel mondo estremamente competitivo della medicina accademica per raggiungere il successo lo fecero cadere in una
trappola fatale per un giovane ricercatore. Egli, infatti, simulò il successo dipingendo un quadrato nero sul dorso dei
topi bianchi e inneggiando poi a questo «ibrido», trionfo
della ricerca medica. Fu facilmente scoperto e la sua carriera fu così irreversibilmente rovinata.
Ogni giorno vengono effettuate migliaia di trapianti, dato che medici e pazienti hanno accettato i compromessi di
cui abbiamo parlato prima. Un caso recente può illustrare i
124
problemi coinvolti. Carrie, undici anni, ha bisogno urgentemente di un nuovo fegato. Bambina felice, assolutamente
normale, ha avuto la sfortuna l'anno prima di essere stata
coinvolta in un grave incidente d'auto. Era l'ultimo giorno
del weekend della Festa del Lavoro e la famiglia stava percorrendo l'autostrada del New Jersey in direzione di New
York con un traffico intenso e condizioni meteorologiche in
rapido peggioramento.
Nella loro corsia, una macchina deviò sconsideratamente; troppo vicino per evitarla. Il padre di Carrie frenò, forse
troppo, e come risultato la loro auto cominciò a girare su se
stessa, poi rimbalzò in aria, capitombolò e alla fine si
fermò.
Sia i genitori sia Carrie rimasero vivi. Il papà e la mamma
erano legati con le cinture di sicurezza. Carrie no. Il suo
corpicino sbandò all'interno della vettura impazzita, rimbalzando e martoriandosi. Si ritrovò in una unità di cure intensive in preda a commozione cerebrale, dolorante in ogni
punto del corpo e facendo fatica a respirare a causa delle
costole rotte. Nell'incidente, la milza, che è alloggiata sotto
il diaframma a sinistra, si era rotta e del sangue si era riversato nell'addome. Fortunatamente, i chirurghi erano arrivati in tempo per arrestare l'emorragia, ma Carrie aveva
comunque perduto più della metà del sangue.
Nulla di tutto questo era direttamente collegato con la
sua necessità di avere un fegato nuovo. Carrie poteva guarire completamente da quelle terribili lesioni, come di fatto
avvenne. Quella che fece più danno dello stesso incidente
d'auto fu, invece, la trasfusione di sangue, praticatale per
rimpiazzare tutto il sangue che aveva perduto nell'incidente.
E fu per un'incredibile avversità che alla piccola Carrie
venne somministrato un flacone di sangue contaminato da
un virus che provoca l'epatite.
Vi sono almeno tre virus che causano questa infiammazione del fegato. Il virus dell'epatite A fa il suo ingresso nell'organismo attraverso la bocca, dove viene portato da dita
125
sporche, che hanno toccato feci. L'epatite A viene anche
chiamata «epatite infettiva», una definizione abbastanza
strana, visto che tutte le epatiti lo sono. Il virus dell'epatite
B viene trasmesso attraverso il sangue o i prodotti del sangue, oppure attraverso secrezioni sessuali infette. L'epatite
B si diffonde in maniera identica all'AIDS, ma è più infettiva. Sia per l'epatite A sia per l'epatite B è possibile effettuare uno screening e tutto il sangue conservato nelle emoteche
è controllato per essere sicuri che né l'uno né l'altro agente
virale possa infettare un ricevente. Ma vi è anche un terzo
virus che provoca l'epatite, e forse anche un quarto, un
quinto e un sesto. Esso si diffonde come il virus dell'epatite
B, ma non può essere attualmente riconosciuto nel sangue
donato alla Croce Rossa o a fonti analoghe. La forma di
epatite che provoca viene chiamata epatite non-A, non-B.
Di solito si manifesta come una blanda infiammazione transitoria del fegato, a cui segue la guarigione. Non sempre,
però. Per Carrie, l'infezione, dato il suo stato debilitato,
aveva preso il sopravvento e le aveva distrutto troppa parte
di tessuto epatico perché si potesse ragionevolmente pensare a una sua sopravvivenza.
Carrie venne dunque ricoverata nel reparto trapianti e
l'equipe che la seguiva cominciò la ricerca dell'organo adatto. Si procedette alla tipizzazione HLA delle sue cellule e il
profilo ottenuto fu introdotto in un calcolatore. Qualunque
potenziale donatore di fegato che, naturalmente, o era già
morto o doveva ancora morire, sarebbe stato vagliato in
modo che il suo organo potesse andare al ricevente più
adatto dal punto di vista della compatibilità, in qualunque
parte del paese si trovasse.
Nessuno pensava di poter trovare l'optimum, la compatibilità perfetta, ma in ogni caso per Carrie non si poteva agire diversamente; in ogni caso, l'importante era attenuare
l'attività dei linfociti B e T.
Come previsto, la tragedia di una persona fu la salvezza
di un'altra. Una telefonata dal Tennessee annunciò che in
una unità di cure intensive si trovava il cadavere di una ra126
gazza di diciotto anni, uccisa con una pallottola in testa dall'amico geloso. Il suo cervello era ormai morto e il resto del
corpo avrebbe seguito rapidamente lo stesso destino. I genitori, benché distrutti dalla tragedia, avevano dato il permesso di prelevare gli organi. Una équipe di chirurghi dell'ospedale dove si trovava Carrie raggiunse rapidamente il jet di
una compagnia aerea che gentilmente, e non eccezionalmente, era stato offerto per la missione in questione. Quando
arrivarono, c'erano già tre altre équipe in attesa: una, dalla
California, per l'espianto del cuore della ragazza, un'altra
per i reni e il pancreas, e una terza, infine, per le cornee.
Questa sorta di macabro, ma essenziale, smembramento
del cadavere è diventata possibile grazie alla diffusa accettazione da parte delle comunità mediche, legali, filosofiche e
teologiche dell'idea che la morte cerebrale è l'unico requisito necessario per poter dichiarare deceduta una persona.
Non è più necessario che il cuore cessi di battere e che la
gabbia toracica cessi di sollevarsi prima che i chirurghi, naturalmente con un senso di gratitudine e tenendo conto delle sensibilità di tutte le persone coinvolte, estraggano dal
morto la vita per un moribondo.
Il fegato non era, fortunatamente, troppo grosso per
Carrie; la donatrice era molto piccola di statura. Nell'intervento durato undici ore, il vecchio fegato venne eliminato e
al suo posto fu sistemato il nuovo organo. I chirurghi ebbero la meglio e Carrie la sua buona dose di fortuna. Le fu
somministrato un farmaco, la ciclosporina, che presenta
una sofisticata attività tossica nei riguardi dei linfociti T.
Purtroppo può danneggiare le cellule renali ed epatiche e
deve essere usata con la massima attenzione. Quando viene
somministrata con abilità, è però in grado di arrestare il rigetto, mantenendo la tossicità a un livello accettabile. Lo
stato dell'arte dei trapianti è, comunque, ancora ben lungi
dall'ideale.
Il nostro obiettivo è di riuscire a padroneggiare quei processi immunologici che permettono a una gravidanza di essere portata a termine. Dobbiamo imparare a fare accettare
127
al sistema immunitario di un ricevente un nuovo organo
come parte del suo «sé», pur non intaccando la sua capacità combattiva verso il «non sé». L'immunorepressione
prolungata si accompagna a rischi elevati di infezione e a
una maggiore probabilità di sviluppare forme di cancro per
motivi che saranno spiegati in seguito. La via del futuro è
quindi l'induzione della tolleranza.
Nel descrivere il sistema immunitario, ricorderete l'accenno al fatto che ogni linfocito è programmato per riconoscere un antigene specifico e uno soltanto. Allora, se
tutte quelle cellule preposte al riconoscimento di un certo
organo potessero essere eliminate o paralizzate, un trapianto avrebbe ottime probabilità di riuscita. È possibile indurre una tolleranza specifica per un organo in un topo o in
un ratto, ma non è un'operazione istantanea. Sono necessari almeno alcuni giorni. Nei trapianti umani, invece, non
appena un organo è disponibile deve essere subito trapiantato.
La ricerca lungo un certo numero di direttrici diverse
sembra essere promettente. Stiamo vieppiù migliorando
per quanto concerne la conservazione di organi in coltura
in vitro. Se potessimo tenere un rene o un fegato in vita e
in buone condizioni in una incubatrice per un periodo dalle
tre alle sei settimane, prima di trapiantarlo, potremmo trovare per quell'organo un individuo perfettamente compatibile, potremmo tentare di provocare una tolleranza a quel
tessuto in un eventuale ricevente e di diminuire il grado di
estraneità dell'organo. Sembra che, con il passare del tempo in coltura, gli organi perdano buona parte del loro profilo HLA.
Sappiamo che i linfociti T e B sono vulnerabili ai farmaci soprattutto quando si dividono. E la loro divisione è
parte necessaria della risposta di attacco contro l'antigene.
Se potessimo produrre farmaci che uccidono solo quei linfociti T e B che si dividono dopo essere stati stimolati da
un antigene, elimineremmo tutti quei linfociti che sono in
grado di rigettare un organo. Un simile meccanismo viene
128
chiamato «delezione clonale» (clone è una famiglia di cellule) e senza dubbio esso diventerà realtà.
Oggi siamo in grado di attivare speciali linfociti soppressori, che ridurranno la nocività dei linfociti aggressori, che
attaccano il fegato, o il rene o altri tessuti trapiantati.
Desidero ritornare sull'argomento del trapianto di midollo osseo. In questo campo stanno succedendo fatti importanti che rivoluzioneranno il metodo di cura di una delle
malattie più letali, la leucemia. Come al solito, illustreremo
le procedure più recenti descrivendo un caso clinico.
Kay, ventitré anni, è una studentessa universitaria che si
sta specializzando in musica. È una giapponese-americana,
ovvero è di origine orientale, ma è nata e vive in America.
Un giorno andò a farsi visitare dal medico dell'università
perché si sentiva insolitamente stanca e debole. Lo stress
dovuto agli esami non era sufficiente a spiegare le sue sensazioni e specialmente la mancanza di respiro che provava
quando saliva una rampa di scale. Era pallida, ma per il resto il suo aspetto era buono.
Le venne effettuato un normale conteggio delle cellule
ematiche e il quadro fu chiaro. Kay era affetta da una forma acuta di leucemia. Che cosa significa? La leucemia è
una proliferazione anomala dei globuli bianchi del sangue,
cioè una moltiplicazione incontrollabile, indesiderata e
molto pericolosa, di tali cellule. Il capitolo sul cancro descriverà in modo molto più particolareggiato il dramma che
conduce le cellule a comportarsi in modo così disastrosamente errato. È importante capire che uno tra le centinaia
di miliardi di linfociti T, presenti nel corpo di Kay, era diventato un disertore. Una cellula soltanto è necessaria perché si sviluppi una simile situazione. Il linfocito, diventato
così una cellula neoplastica, si divide incessantemente e affolla rapidamente gli spazi in cui vivono e si spostano i linfociti T normali. In un primo momento saturano il sangue,
i linfonodi, la milza e il midollo osseo, quindi i linfociti T si
riversano nei polmoni e in altri tessuti. Nel caso di Kay, occupavano anche parte del cervello.
129
Questa era una vera emergenza medica. Non c'era tempo
di chiedersi che cosa il trattamento potesse fare ai linfociti
normali e alla loro capacità di combattere le infezioni. Se
quelle cellule maligne non fossero state uccise o, come minimo, bloccate nella loro corsa precipitosa a dividersi, non vi
sarebbe stata più una Kay per la quale preoccuparsi. Per tale motivo essa fu subito trasportata in ospedale e, nello stesso giorno, le vennero somministrati per endovena cinque
farmaci antitumorali, noti per la loro particolare efficacia
contro le cellule che si dividono rapidamente, quindi efficaci anche verso le normali cellule corporee che si dividono regolarmente: i maggiori danni provocati da questi farmaci li
sopporteranno le cellule pilifere e dunque i capelli, le cellule
che tappezzano l'intestino e, caso più pericoloso di tutti, le
cellule normali del midollo osseo, che producono piastrine,
globuli rossi, linfociti B, cellule polimorfe e monociti. Tutte
queste cellule sono già comunque danneggiate dal fatto che
le cellule leucemiche le stanno estromettendo, competendo
con loro con maggiore successo per le sostanze nutritive.
Malgrado questo trattamento intensivo, i linfociti T maligni di Kay continuarono a produrre danno in quanto avevano peggiorato la situazione: infatti non solo la malignità del
cancro era immutata ma avevamo danneggiato le cellule
normali.
Vi sono differenti forme di leucemia, classificate a seconda del tipo di leucociti che diventa maligno. I monociti e i
linfociti B possono diventare leucemici. La leucemia da linfociti T è una delle forme peggiori e i risultati ottenuti con
Kay non erano purtroppo insoliti. Il piano formulato per
salvare la studentessa comportava tre «se» rischiosi. Se potevamo trovare un donatore adatto (non perfetto), potevamo tentare di uccidere tutte le cellule neoplastiche di Kay,
con dosi di farmaci e di radioterapia che avrebbero anche
ucciso tutte le cellule normali del midollo. In questo modo
avremmo potuto eliminare il cancro, ma per sopravvivere
Kay aveva bisogno di un trapianto di cellule normali che,
ancora una volta, le avrebbero fornito gli elementi essenzia130
li del sangue. Se non poteva essere trovato un donatore perfetto, era comunque necessario trovarne uno quanto più
possibile affine, onde ridurre al minimo i rischi che comportava questo tipo di procedimento. Occorreva l'aiuto di
un calcolatore. Avremmo utilizzato nuove tecniche anche
per prelevare dal midollo osseo donato quanti più linfociti
T possibile. Se potevamo sbarazzarci di ciascuna di queste
ultime cellule, non vi sarebbe stato pericolo di rigetto. La
pignoleria con cui affrontiamo questa eliminazione di linfociti T è terribilmente importante, dato che gli esperimenti
sugli animali hanno dimostrato che è sufficiente un unico
linfocito T per uccidere un topo immunodeficiente, totalmente indifeso.
Kay fu fortunata: la ricerca col computer ci rivelò un uomo, in Inghilterra, disposto a venire negli Stati Uniti per
donarle il suo midollo pressoché identico. Cinque degli otto
antigeni principali erano uguali e Kay venne preparata per
l'intervento: era ormai l'unica speranza che le rimaneva.
Venne trattata con dosi massicce di farmaci antitumorali e
venne perdipiù irradiata. Fu curata in una speciale camera
sterile, attrezzata con un condizionamento d'aria sofisticato, per cui l'aria che usciva non sarebbe rientrata e quella
che entrava nella stanza era preventivamente trattata con
radiazioni ultraviolette. Chiunque entrava nella stanza doveva essere il più sterile possibile. Medici e infermiere, oltre
ad aver fatto la doccia, entravano nella stanza con la maschera, i guanti e il camice. Il donatore arrivò, fece la conoscenza di Kay e della sua famiglia (il lato sentimentale di
questo tipo di avventura), venne anestetizzato e la donazione procedette. Centoquarantadue volte i chirurghi inserirono aghi nelle ossa iliache per aspirare dalla profondità quelle preziose cellule del midollo, di cui avevano bisogno.
Una volta ottenutele, queste cellule furono portate d'urgenza in un laboratorio sterile, dove si tentò di rimuovere
tutti i linfociti T del donatore. Per una qualche ragione, i
linfociti T aderiscono in modo caratteristico ai globuli rossi
di pecora (e solo di pecora). Abbiamo così aggiunto un po131
co di globuli rossi sterili di pecora al midollo e molti linfociti T presenti si sono agglutinati con essi; centrifugando
l'intero preparato abbiamo trovato sul fondo delle provette un numero elevato di linfociti T del preparato, divenuti
pesanti perché attaccati ai globuli rossi. Aspirando con cura il supernatante e quindi dopo aver aggiunto alcuni
estratti di arachidi, di cui è nota la capacità di fare agglutinare i linfociti, abbiamo nuovamente centrifugato il preparato. Per dodici ore abbiamo ripetuto più volte queste diverse operazioni fino a quando meno di una cellula su cento rimaste nel midollo è risultata essere un linfocito T. Non
era la perfezione, ma era il meglio che potevamo fare.
Finalmente Kay ricevette le cellule di midollo senza linfociti T, somministrandole altri farmaci per coprire il rischio che alcuni linfociti T rimasti nel midollo donatole
potessero essere pronti ad attaccarla. Le abbiamo anche
somministrato forti quantitativi di anticorpi ottenuti da
sangue normale. Abbiamo mantenuto tutto sterile e aspettato. (È necessario che trascorra un mese prima di poter
stabilire il successo o no.) Occorreva somministrare a Kay
anche piastrine e cellule polimorfe di soggetti normali. Essa aveva inoltre bisogno di una quantità di antibiotici complessi. Prima di procedere alla trasfusione irradiavamo il
sangue per essere sicuri che non fossero presenti in esso linfociti T vivi.
II trapianto di midollo attecchì e Kay fu salva. Tuttavia,
la leucemia può ritornare. Naturalmente speriamo di no,
ma se avessimo lasciato vive anche soltanto alcune cellule
leucemiche quando abbiamo preparato Kay per il trapianto, allora sicuramente la malattia sarebbe ricomparsa. Invece, Kay ha avuto fortuna: qualcosa che non sarebbe stato possibile, nelle stesse condizioni, solo alcuni anni fa.
L'intervento è costato complessivamente circa 100.000 $.
Esso è molto impegnativo dal punto di vista tecnico e richiede un intensissimo lavoro, con la partecipazione di un
grande numero di medici e di infermieri specializzati. Dobbiamo sperare che la nostra capacità di manipolare il siste132
ma difensivo umano ci permetterà presto di agire nelle
stesse condizioni con molto meno rischio e costi inferiori.
Può sorprendere il fatto che, di tutte le operazioni di trapianto, quella del cuore sia la più semplice e destinata ad ottenere maggiore successo. Non sempre è stato così, ma in
questo settore sono stati compiuti notevoli progressi. Il trapianto simultaneo di cuore e polmone, che sfortunatamente
abbiamo spesso la necessità di compiere, continua a essere
meno soddisfacente, anche se va via via migliorando. Vengono, invece, trapiantati regolarmente e con successo i reni,
il fegato, la cute, il midollo osseo, il cuore e i tessuti dell'occhio. Finora non ha avuto successo il trapianto di pancreas
(che potrebbe guarire i diabetici), ma la ricerca per questa
forma di terapia sta procedendo bene. Continua ad essere
notoriamente difficile il trapianto di tessuto nervoso (nervi
e lo stesso cervello) e probabilmente rimarrà tale. Non è
l'immunologia a creare difficoltà qui, ma il problema delle
connessioni: si provi a immaginare una tavola totalmente
ricoperta di spaghetti e un coltello affilato che taglia tutti
gli elementi in due. Le due metà sono quindi separate e presentate con le istruzioni per riunire tutti i pezzi in modo da
riavere la configurazione originale: un simile compito sarebbe facile in confronto a quello di saldare insieme i molti
milioni di elementi che costituiscono il tessuto nervoso
umano.
Abbiamo messo in evidenza i numerosi problemi connessi con i trapianti, ma è doveroso ricordare che oggi essi salvano molte vite. A Sydney, di recente, è stato celebrato un
matrimonio che era davvero qualcosa di più di un evento un
poco insolito. Sia la sposa che lo sposo avevano subito un
trapianto di cuore e con successo. Dopo essere stati dichiarati marito e moglie si sono abbracciati, hanno abbracciato
i loro genitori e poi sono andati ad abbracciare i genitori dei
due giovani i cui cuori battevano dentro di loro: sono sicuro
che, in quel momento, la perdita di quei figli è parsa ai rispettivi genitori sicuramente più sopportabile.
133
Parte III
LA SCONFITTA DEI LOTTATORI
5
L'argomento cancro
Che cosa ha in sé il cancro di tanto preoccupante? Tutti
sanno che è una malattia che può essere letale, e così noi esseri umani, che siamo, anche se in modo inconscio, costantemente preoccupati della brevità della vita, siamo angosciati (ed è naturale!) per qualcosa che tanto spesso è responsabile della nostra morte.
Dei lettori di questo libro, uno su quattro morirà di cancro. Ma la consapevolezza che un tumore può ucciderci è
una spiegazione sufficiente per il terrore che la parola «cancro» incute? In definitiva, un maggior numero di noi morirà per problemi cardiaci, e non per cancro. Eppure, il pensiero di un attacco di cuore, anche se angoscioso, è più tollerabile.
Forse in quest'ultima frase sta proprio il motivo per cui il
cancro è così temuto. Sappiamo che possiamo sopravvivere
e convivere con malattie cardiache, ma con il cancro?
Quante persone conosciamo che sono guarite dal cancro?
Anche se in verità le guarigioni spontanee o determinate terapeuticamente non sono rare, nella maggior parte della
gente la paura fa novanta.
Forse la convinzione che la morte sarà l'esito certo di un
cancro è responsabile di quella cattiva fama che fa del cancro stesso la malattia dalla diagnosi più infausta. Come succede spesso ai medici, ho imparato da uno dei miei pazienti
l'atteggiamento della gente nei riguardi di questa patologia.
Jennifer era un'eccellente infermiera che aveva lavorato
137
per molti anni nel nostro ambulatorio. Quarantanove anni,
quattro figli, con una madre vecchia a carico, aveva sempre
goduto di buona salute, a parte una bronchite cronica, ma
non debilitante. Un giorno mi confidò di essere preoccupata perché, per tre mattine di seguito, tossendo aveva sputato un poco di sangue. La sintomatologia era tutta qui: non
sentiva dolore, non mostrava alcun peggioramento nell'aspetto fisico, anche se ammise di aver perso un po' di chili
negli ultimi mesi. Mi interessai per farle fare un esame radiografico al torace. Un cancro già in fase avanzata, che
partiva dall'albero bronchiale e progrediva verso i polmoni,
si stagliava in netto rilievo dalle strutture normali del torace, così chiaramente evidenziabili nell'immagine ottenuta.
Naturalmente, è più difficile dare cattive notizie a una collega che a una persona estranea e sono sicuro che comprenderete la carica emotiva che si accompagna a simili episodi.
Dopo aver conversato sulla vicenda per qualche minuto,
Jennifer mi chiese se poteva vedere la radiografia, non dubitando certo della diagnosi che le avevo fatto, e facendo appello a quella specie di alterigia che gli esseri umani mettono
in atto per difendere la loro psiche, fissò la lastra per lungo
tempo, dopo aver sentito che non era possibile sradicare chirurgicamente il tumore. Il silenzio era greve. Alla fine, dopo
una pausa che parve lunga vari minuti, si girò verso di me.
«Non è l'immagine che vedo sullo schermo che mi distrugge,» disse con calma «ma ciò che attende me e la mia
famiglia. È questo che vedo quando osservo la radiografia.
So bene che cosa comporta morire di cancro.»
Da questa e da altre analoghe conversazioni, traggo il
convincimento che è la connotazione di una lunga lotta con
un'alta probabilità di dolorosa sconfitta che spesso colora
la diagnosi di cancro di una grande e, in effetti, infondata
paura.
Il cancro è una condizione doppiamente frustrante per il
clinico. Ancora di recente, il fallimento nell'aiutare i pazienti a lottare contro di esso è andato di pari passo con
l'impossibilità di capire i processi biologici così grossolana138
mente sconvolti e responsabili per questo di una simile sofferenza; e tutto ciò in un periodo in cui altri problemi medici complessi sono rapidamente risolti. Fortunatamente, oggi tutto sta cambiando tanto rapidamente che il tono di
questo capitolo può essere senz'altro ottimistico.
A questo punto, potreste chiedervi perché si parla di cancro in un libro che si occupa del sistema immunitario. La risposta è semplice. Certe cellule tumorali possono, anche se
con difficoltà, essere distinte dalle cellule normali e abbiamo tutti i motivi per ritenere che i linfociti siano in grado di
riconoscere queste differenze. Sappiamo anche che essi possono uccidere (e frequentemente lo fanno) certe cellule tumorali. Pertanto, le questioni che gli immunologi devono
affrontare sono le seguenti: un cancro clinicamente avanzato è forse il risultato di un'insufficienza del sistema immunitario? Questo sistema ha la responsabilità di scandagliare
costantemente il «sé» per scoprire nelle ossa, nelle mammelle, nell'intestino o in altri organi modificazioni di tipo neoplastico? Se la risposta è positiva, il cancro può allora essere considerato una malattia da immunodeficienza? Devono
tutte le cellule tumorali essere riconosciute come pericolose
dal sistema immunitario, oppure alcune di esse sono abbastanza abili da non farsi distinguere dal sé, traendo così in
errore anche il più perfetto dei sistemi immunitari?
Credo sia superfluo sottolineare l'importanza e la portata
di tali questioni. Quando avremo le risposte alle domande
appena esposte, non solo avremo scritto un capitolo fondamentale dell'oncologia, ma disporremo anche di metodi
nuovi e razionali per poter affrontare la cura del cancro.
Per essere razionali, dobbiamo anzitutto analizzare quegli eventi che trasformano una cellula normale in una cellula ribelle, che disubbidisce a tutti i segnali regolatori ai quali
fino a quel momento si è attenuta. Una volta capito perché
la cellula ha modificato così drasticamente il proprio essere
e la propria funzione, possiamo analizzare la sua interazione, o mancanza di interazione, con il sistema immunitario.
In Jennifer il cancro si era sviluppato in una frazione di
139
secondo: a un dato momento essa non aveva niente e il momento successivo il cancro era lì. In un attimo, il funzionamento normale di una singola cellula era stato scompaginato per sempre. Proprio allora, magari mesi o addirittura anni prima che la malattia clinica si manifestasse, il destino di
Jennifer era stato segnato: una cellula, tra miliardi di analoghe cellule che tappezzavano le vie aeree (albero bronchiale), aveva imboccato in forma maligna la via che l'avrebbe condotta al suo futuro ruolo biologico.
Quella cellula cominciò a dividersi senza tregua, dando
origine a una famiglia di cellule identiche, in continua
espansione: cellule che mostravano nei riguardi del controllo un identico atteggiamento. Con trasporto, queste nuove
cellule si dispersero, invadendo e danneggiando i tessuti
normali nella loro spietata ricerca di immortalità. Perché,
in definitiva, di questo si tratta: ricerca di immortalità. Solo
l'incapacità della vittima di sostenere le richieste nutrizionali delle cellule tumorali che proliferano frustra questo loro
proposito.
Sempre più di frequente gli scienziati riescono a coltivare
in provetta singole cellule tumorali e a osservarne la palese
immortalità. Finché sono nutrite vivono e si moltiplicano.
Non così le cellule normali: la loro mortalità in simili sistemi artificiali si manifesta nell'arco di alcuni giorni.
Riteniamo che le cellule normali, in qualunque parte del
corpo, possiedano, come elementi integranti del loro corredo genetico, istruzioni chiaramente definite per quanto riguarda crescita, differenziamento (sviluppo di una funzione
specifica) e divisione (duplicazione di sé). Ogni cellula normale, nessuna esclusa, è sotto il più rigido dei controlli. Essa è programmata dal concepimento alla morte: in modo
molto ben preciso, quest'ultima è preprogrammata nella
cellula, la quale si dividerà un numero finito di volte e quindi morirà. La morte simultanea di una massa di cellule fondamentale in un organo vitale condurrà alla morte dell'intero organismo. A mano a mano che l'organismo invecchia,
le cellule che sono in grado di riparare i tessuti e perfino di
140
riparare il materiale genetico danneggiato muoiono. Noi
siamo benvenuti come ospiti del nostro ambiente biologico,
ma solo per un tempo limitato.
Dal canto loro, invece le cellule neoplastiche si sono liberate dalle pastoie della loro mortalità autonomamente imposta. Hanno spento, dentro il loro nucleo, il timer biologico che le avrebbe avvisate quando autodistruggersi. L'ironia è fin troppo evidente: nel cercare di afferrare l'opportunità per essere immortali, esse accelerano la morte delle cellule normali che le circondano e, in ultima analisi, nel fare
questo distruggono se stesse. Sappiamo a questo punto che,
quando noi esseri umani invecchiamo, le nostre cellule si ribellano e diventano cellule tumorali molto più facilmente.
Sappiamo anche che ogni cellula del nostro organismo ha la
potenzialità di trasformarsi in una cellula tumorale.
Il cancro è così un processo patologico in cui una cellula
subisce una ridistribuzione interna del proprio materiale informativo e, pertanto, non vive più secondo le leggi di uno
sviluppo biologico e di una fine ordinati. Stimola, al contrario, la propria crescita e duplicazione. Non aspira più a
una morte biologica e si diffonde in maniera invasiva sia
negli angoli contigui sia in quelli più remoti dell'organismo,
riproducendosi incessantemente e producendo, nel fare
questo, devastanti effetti di massa.
Come si svolge questa disastrosa tornata di eventi? Due
fattori devono essere presi in considerazione. In primo luogo, analizzeremo il concetto secondo cui tutte le cellule hanno la potenzialità di trasformarsi in cellule tumorali; quindi
prenderemo in considerazione le nozioni di cui disponiamo
sui fattori innescanti, che possono esercitare il loro impatto
su una cellula, liberando la tendenza a indulgere ad un comportamento maligno.
Osservate il dorso della vostra mano. Vi pare uguale a un
mese fa? Probabilmente sì, ma in realtà non lo è. Molte cellule che vedete ora, ben unite l'un l'altra a formare il rivestimento cutaneo, non erano presenti un mese fa. Il nostro
corpo continua, per la maggior parte, a morire e a essere so141
stituito in un processo vitale, che risulta impercettibile nella
vita quotidiana.
Questo continuo bisogno di riparare e di cambiar pelle fa
aumentare il rischio che si sviluppi in noi un cancro. Cellule
normali vengono attivate e obbligate a dividersi e, dopo che
lo hanno fatto, sono definitivamente disattivate. La complessità insita in questo tipo di processo ci espone a un rischio, se il sistema dovesse vacillare e se i segnali di disattivazione dovessero essere disattesi.
Ma, prima di trattare tali argomenti, ritorniamo a Jennifer e alla sua storia. Per confermare la diagnosi e determinare il tipo di cancro che le aveva colpito i polmoni, le venne
introdotta una sonda, attraverso la gola e la trachea, giù fino all'albero bronchiale. Utilizzando una soluzione fisiologica calda, le venne effettuato un lavaggio delle vie respiratorie, che permise di raccogliere le cellule staccatesi in profondità e di esaminarle al microscopio. La loro natura maligna fu prontamente identificata. Dopo un consulto con radioterapisti, chirurghi e medici esperti in chemioterapia (avvelenamento delle cellule tumorali mediante sostanze chimiche), fu deciso che la radioterapia offriva la migliore opportunità di rallentare la diffusione della malattia. Con coraggio, Jennifer cominciò la sua battaglia contro il cancro. Lo
scenario che aveva previsto divenne realtà con una precisione infallibile, fino a quando non ebbe luogo un'insolita variazione del copione.
Il carcinoma di Jennifer era confinato soprattutto nella
parte superiore del polmone destro. Nel suo accrescersi verso l'esterno, alla fine raggiunse quel settore del polmone che
è più vicino alla parete toracica. In questa posizione il polmone è rivestito da una sottile pellicola, la pleura. (Questa,
talvolta, si infetta e, quando si respira profondamente, si
stira e fa male; l'infezione prende il nome di pleurite.) L'interno della gabbia toracica è anch'esso rivestito da pleura;
durante l'atto respiratorio, i due strati pleurici scorrono
senza difficoltà l'uno sull'altro; un liquido oleoso ne lubrifica la superficie, per cui il movimento non provoca l'attrito.
142
Il carcinoma di Jennifer, originatosi nell'albero bronchiale, aveva poi proliferato dal polmone allo spazio pleurico. Quando Jennifer cercava di respirare, l'aria, seguendo il
percorso del carcinoma, penetrava nello spazio pleurico che
si gonfiava come un pallone. La pressione faceva collassare
l'altra parte del polmone destro e, come era prevedibile,
provocava dolore e mancanza di respiro. Ma il peggio doveva ancora venire. Batteri, provenienti dalle vie respiratorie,
si insediarono nello spazio pleurico, provocando un ascesso, che si estese al polmone schiacciato dal tumore.
Malgrado gli antibiotici che le venivano somministrati,
Jennifer continuava ad avere brividi e sudorazione, mentre
la febbre tormentava il suo corpo. Per dieci giorni, fu sospesa tra la vita e la morte. Era però robusta e sopravvisse
per continuare la sua lotta contro il cancro. Ma quale cancro? Quando l'ascesso si risolse, lasciando il posto a una cicatrice, anche il tumore si ridusse e scomparve. A tre anni
di distanza, mentre scrivo questo libro, e due anni e mezzo
dopo il suo appuntamento con la morte, Jennifer sta bene e
lavora: a quanto pare, si è liberata del carcinoma.
Un miracolo? Bene, un fatto sicuramente miracoloso, nel
senso che si è avuta una svolta insolita negli eventi. Ma forse esso è stato forgiato dal sistema immunitario della paziente: i linfociti potrebbero benissimo essere stati i subalterni di cui l'Onnipotente si è servito per salvare, in un modo del tutto insolito, quella meritevole signora. La descrizione dei meccanismi che avrebbero assicurato la guarigione merita una considerevole attenzione. Ritorneremo su
questo argomento in seguito.
Prima di proseguire nella trattazione del funzionamento
interno delle cellule dovremmo definire alcuni termini, per
essere certi che quello che seguirà sia facilmente comprensibile. Lo studio del cuore sano e malato è detto cardiologia;
lo studio della cellula che diventa neoplastica è detto oncologia (dal greco onkos, che significa «massa» o «tumore»).
Un medico che si specializza nello studio del cancro è un
oncologo.
143
Il concetto di malignità non ha un valore esclusivamente
medico: maligno è l'opposto di benigno. Entrambi i termini
sono spesso usati per descrivere proliferazioni (tumori) riscontrate in un corpo. Non tutti i tumori sono maligni; ve
ne sono di benigni, ma essi hanno uno scarso interesse clinico.
Tutto questo ci riporta alla scoperta più importante nel
campo della ricerca oncologica degli ultimi vent'anni: gli
oncogeni, geni che provocano il cancro.
Nel 1910, al famoso Rockefeller Institute for Medical Research di New York, un giovane scienziato, Francis Rous,
stava studiando il cancro negli animali. Il suo lavoro ebbe
una certa pubblicità e, di conseguenza, fu organizzato un
importantissimo simposio. Un astuto agricoltore era preoccupato perché alcune delle sue galline Plymouth Rock erano affette da tumori che avrebbero finito per farle morire.
Egli decise di consultare il brillante dottor Rous su quello
che aveva osservato e portò con sé all'Istituto una delle galline malate. Rous rimase affascinato perché sembrava che
questi «cancri» fossero infettivi. Troppe erano le galline
ammalate perché si potesse pensare che quel cancro fosse
casuale.
Così si mise al lavoro e fu presto in grado di dimostrare
che, se si prendeva un piccolo pezzo di tumore e lo si impiantava in un'altra gallina della stessa razza, anche questa
gallina si ammalava di una uguale forma di cancro. In una
serie di esperimenti divenuti famosi, Rous riuscì a dimostrare che la sostanza che dà l'avvio al cancro era più piccola di
una cellula, più piccola anche di una cellula batterica, dato
che era riuscito ancora a produrre dei tumori dopo aver fatto passare il tessuto tumorale attraverso il più sottile dei filtri allora disponibili. Suppose allora che il cancro potesse
essere causato da un virus.
Ciò di cui stiamo parlando non è affatto simile al meccanismo che i virus mettono in atto per provocare un comune
raffreddore. In questo caso, i virus si insediano, per esempio, nel naso, si moltiplicano e vengono attaccati dal siste145
ma immunitario, il quale vince, ma non senza una certa sofferenza. Il naso diventa, dunque, il campo di battaglia per
la guerra biologica.
Nel cancro, invece, desumiamo che i virus, nient'altro
che un insieme di informazioni genetiche, si insinuino nelle
cellule, modificandone il sistema di programmazione in
modo tale da indurle a proliferare nel modo sopra descritto. Numerosi virus possono comportarsi così e molti ne sono stati scoperti e studiati nel mondo animale. Quelli esaminati in modo più approfondito sono virus che, fatto piuttosto interessante, appartengono alla stessa famiglia del virus
che provoca L'AIDS.
In che modo i virus riescono a trasformare una cellula rispettabile, con un comportamento normale, in una cellula
assassina? È qui che gli oncogèni entrano in scena. Certi virus includono, nel loro repertorio genetico, geni che sono in
grado di stimolare la crescita neoplastica nelle cellule che
hanno invaso (parassitato). Questi geni incorporeranno
l'informazione genetica che la cellula parassitata avrà bisogno per fare la volontà del nuovo padrone e per produrre
sempre nuovi virus.
Ma perché un virus dovrebbe voler trasformare la cellula
ospite in una cellula neoplastica? Le cellule neoplastiche si
dividono in continuazione ed è durante la divisione che i virus si riproducono con la massima efficacia. Inutile dire, il
virus non si preoccupa del destino della cellula che ha invaso.
Vi è ancora un anello mancante tra il virus e il comportamento neoplastico, di cui dobbiamo parlare. I geni, come
abbiamo detto, istruiscono le cellule a sintetizzare un prodotto specifico e forniscono programmi per la formazione
di proteine specifiche, cioè sostanze chimiche che influenzano la funzione biologica. Se ne deduce, dunque, che le proteine prodotte da una cellula infetta, come risposta al messaggio trasmesso dagli oncogèni, possono realmente provocare la proliferazione neoplastica. Il virus che Rous scoprì
può certamente fare questo.
146
Detto ciò, dobbiamo immediatamente far rilevare che gli
oncogèni virali innescanti il cancro sembrano essere più
l'eccezione che la regola nelle proliferazioni neoplastiche.
La maggior parte dei tumori maligni, specialmente negli esseri umani, non può essere affatto correlata con un'infezione virale. Questo enigma ha cominciato a delinearsi meglio
solo con la scoperta recente e più significativa che gli oncogèni si possono trovare nelle cellule umane normali non infettate da virus.
Una simile, sensazionale scoperta ha scompaginato numerose ipotesi ritenute fino ad allora prestigiose. Gli oncogèni nelle cellule normali! Ma la natura è impazzita? Milioni di esseri animali, uomo compreso, muoiono ogni anno di
cancro, che si sviluppa nei più svariati tessuti. Sicuramente
un simile errore nel progetto fondamentale deve essere stato
sradicato dai nostri sistemi biologici a questo stadio del
processo evolutivo.
Se consideriamo con maggior circospezione e meno emotività le priorità della Natura, troviamo una risposta parziale alla domanda: se la specie deve sopravvivere, noi singoli
non possiamo vivere in eterno. Nel caso degli esseri umani,
ben difficilmente ci si poteva attendere dalla Natura che
prevedesse così tanti sedentari, obesi, col problema del colesterolo e dediti all'alcool e, pertanto, morti in anticipo sul
tempo per attacchi cardiaci e altre malattie. Il cancro potrebbe essere visto come la soluzione finale della Natura
contro il rischio rappresentato dalla longevità. Sappiamo,
per esempio, che se gli uomini vivono a lungo sviluppano
tutti il cancro alla prostata. Così abbiamo oncogèni che, di
tanto in tanto, vengono trasmessi da virus, mentre sembra
che altre cellule siano in grado di alterarsi producendo esse
stesse i propri oncogèni.
Ma la storia degli oncogèni è ancora più affascinante di
quanto suggerisca questo scenario. Questi geni sono presenti nelle cellule normali e molti, se non proprio tutti, appartengono ad esse: non sono geni cattivi buttati via da un virus di passaggio. Sembra che essi, con uno straordinario
147
voltafaccia, «infettino» i virus. Ecco come questi meccanismi potrebbero produrre il cancro per infezione.
Richard, un dirigente di medio livello, molto affaticato,
quando gli veniamo presentati si sorregge alla maniglia di
un treno suburbano che, sobbalzando, lo sta riconducendo
a casa dal lavoro. In ufficio non è stata una buona giornata
per lui ed egli non vede l'ora di arrivare a casa per bersi una
birra fresca con la moglie, sulla quale può riversare tutte le
frustrazioni subite. Una moltitudine di preoccupazioni lo
angoscia, ma non si cura (e come potrebbe!) per quella cellula, nella parte posteriore della gola, che è diventata maligna e che, in due mesi, si trasformerà in un piccolo tumore
che raggiungerà le corde vocali. Entro sei mesi noterà per la
prima volta una leggera raucedine, e fra un anno dovrà sottoporsi a un intervento necessariamente mutilante che comporta la totale asportazione della laringe. La speranza che
possa sopravvivere è tutta qui, ma tutto dipende dal futuro.
Un dramma biologico più immediato sta, invece, per iniziare.
Su questo palcoscenico della vita compare il personaggio
n. 2. Samuel barcolla quando il treno sobbalza. Egli si sorregge a tre maniglie di distanza da quella alla quale è appeso
Richard. Oggi è tornato al lavoro per la prima volta da una
settimana, guarito da un'infezione alle vie respiratorie superiori. Nel vagone affollato, con suo grande imbarazzo, è
preso da un'irresistibile necessità di starnutire. Cerca di
proteggersi il naso, ma scoppia uno starnuto. Non un'anima sembra averlo notato.
Tuttavia, con quello starnuto ben sei milioni di particelle
virali sono proiettate nell'aria. Alcune si depositeranno sul
pavimento, altre sugli abiti e sui giornali, altre ancora continueranno a volteggiare nell'aria che Richard tranquillamente inala mentre aspetta di concludere il suo tragitto.
Una di quelle particelle si deposita sulla superficie della
cellula neoplastica che si trova nel retrogola di Richard. Penetra nella membrana cellulare e si dirige verso il nucleo.
Questo è come un porto, in cui si insedierà temporanea148
mente e si riprodurrà, dando origine a parecchie copie di sé.
Ben presto la cellula ne sarà zeppa e, alla fine, esploderà,
lasciando che le particelle neosintetizzate vadano a infettare
altre cellule dell'organismo, oppure che siano emesse con
un colpo di tosse nell'ambiente, da dove partiranno alla ricerca di un nuovo ospite.
La cellula che è diventata la dimora del virus di Samuel
ha già un problema: i suoi oncogèni hanno attivato un tipo
di sviluppo che è neoplastico. Quando essa produce le particelle virali (che sono di fatto geni virali), queste catturano
un oncogène attivato, operosissimo nella cellula neoplastica. Le nuove particelle virali hanno, dunque, aggiunto al
loro corredo genetico l'oncogène attivato, che porteranno
con sé quando andranno a infettare la prossima cellula. Penetrando in questa assieme all'oncogène che trasportano
come fosse un passeggero, potrebbero innescare in essa un
mutamento neoplastico. In questo senso, il cancro può essere «infettivo». La prima volta che Richard tossirà in treno
esporrà altre persone non solo al virus di Samuel, ma anche
ai propri oncogèni attivati.
Sembra essere questa la spiegazione più esauriente del
cancro studiato da Rous tanti anni fa nelle galline Plymouth Rock. Il virus che egli aveva trovato non causava di
per sé il cancro; trasportava solo da una gallina all'altra il
segnale per attivare la proliferazione neoplastica. Il cancro
indotto da virus può così essere al seguito di un'infezione
provocata da un virus che possiede il proprio oncogène, o
che semplicemente porta con sé un gene promotore di cancro, «donatogli» da una cellula già infettata. Non v'è alcun
dubbio che questa minaccia mediata da un virus sia importante, ma non è comunque la via principale lungo la quale si
sviluppano le varie forme di cancro.
Per esaminare la tappa successiva in questo itinerario che
ci porta a chiarire la causa del cancro, dobbiamo ritornare
all'apparente enigma di fronte al quale ci siamo trovati scoprendo che le cellule normali possiedono propri oncogèni.
All'inizio gli scienziati hanno considerato questi oncogèni
149
come bombe a orologeria: essi sarebbero rimasti quiescenti
nella cellula fino a quando o qualche timer biologico intrinseco avrebbe dato il via all'esplosione, o la quiete della cellula sarebbe stata turbata da un processo che avrebbe innescato prematuramente l'esplosione che avrebbe condotto al
cancro. Visto in questa prospettiva il dramma della cellula,
gli oncogèni possono solo essere considerati come geni che
la Natura ha progettato per scopi distruttivi. Nuove informazioni, tuttavia, pongono il loro problema in un'ottica
migliore.
Gli oncogèni non sono, intrinsecamente, geni cattivi.
Non se ne stanno in una cellula senza fare altro se non
aspettare il giorno in cui comincerà la tragedia. La verità è
che svolgono costantemente un ruolo nella più importante
attività che qualunque cellula svolge: l'autoduplicazione.
L'alcool in sé non è un male, ma tutti sappiamo quanto
devastanti possono essere gli effetti di un'eccessiva indulgenza, priva di ogni controllo, a questo tipo di droga.
«Controllo», «disciplina», «appropriato» sono tutte parole
che evocano le connotazioni associate con il consumo non
dannoso di alcool. Lo stesso discorso vale per gli oncogèni.
Quando essi sono sotto controllo, tutto va bene. Quando
non lo sono, compare il cancro.
Per capire questa parte della storia, dobbiamo chiederci
che cosa sappiamo sulla funzione «normale» degli oncogèni. Tutti i geni, come abbiamo detto ripetutamente, istruiscono le cellule affinché producano proteine con una determinata funzione biologica. Le proteine prodotte dagli oncogèni hanno un'importanza vitale nella duplicazione e,
pertanto, nella crescita o nella riparazione dei tessuti.
Nel 1975, un ben noto scienziato che si interessava di duplicazione cellulare riassunse così questo aspetto della vita
della cellula: «L'attributo più straordinario degli organismi
viventi è la loro capacità di autoduplicarsi in modo preciso,
una proprietà che si può considerare la vera quintessenza
dello stato vivente».
Il professor Lehningen non stava parlando della propaga150
zione di una specie. Quando un uomo e una donna danno origine a un figlio non si può parlare di autoduplicazione, ma
piuttosto della creazione di una novità unica. Noi stiamo discutendo, invece, della duplicazione del «sé»: il concetto implicito nella sostituzione della pelle del dorso della mano, cui
si è già accennato. Va a finire così che gli oncogèni sono essenziali per quell'ordinato processo di divisione che è indispensabile perché una cellula possa riprodursi. Un simile
processo prende il nome di mitosi. Solo quando qualcosa non
funziona nelle prestazioni dell'oncogène, compare il cancro.
Per questa ragione gli oncogèni sono stati chiamati con un
nome, in realtà, errato e naturalmente hanno avuto una pessima fama, venendo considerati vere e proprie canaglie biologiche. Il loro giusto nome dovrebbe essere mitogèni.
Possiamo così presentare la storia del cancro nel suo giusto significato. Una cellula è solo una minuscola componente di un potente sistema. I geni emettono costantemente
istruzioni perché essa produca qualcosa di essenziale per lo
sforzo massiccio che l'organo, a cui la cellula appartiene,
compie. (Per esempio, muovere una gamba, pompare sangue, produrre insulina, e via dicendo.) In un momento della
vita febbrile della cellula, che viene stabilito in modo preciso, geni regolatori attivano gli oncogèni, sopprimendo altre
istruzioni. Gli oncogèni entrano in azione e i meccanismi
cellulari coinvolti nel processo per cui da uno si ottiene due
procedono di buon passo.
Quando le divisioni si sono completate senza inconvenienti, gli oncogèni sono disattivati da un altro insieme di
geni regolatori, spesso localizzati vicino agli oncogèni su un
determinato cromosoma. Se un oncogène attivato viene separato dai suoi meccanismi di controllo (per esempio, se
viene catturato da un virus), oppure se i suoi meccanismi di
controllo vengono alterati, non ha più luogo una divisione
ordinata e alle cellule viene impartito di continuare a duplicarsi. Continuano allora a dividersi ininterrottamente e,
procedendo così, alla fine si instaura una proliferazione
neoplastica di varia forma e malignità.
151
A questo punto si pone una domanda, che ha la massima
importanza per gli oncologi: quali sono i fattori che attivano gli oncogèni, che turbano la loro regolazione, promuovendo così lo sviluppo del cancro? Notevoli sono stati i progressi compiuti in questo settore di vitale importanza. È
certo che, per sconvolgere la regolazione della divisione cellulare, non sono sempre indispensabili i fattori esterni; la
regolazione può alterarsi, e di fatto si altera, all'interno della cellula senza alcun contributo dal mondo esterno. Ma
molte forme di cancro, forse il maggior numero, comportano uno sconvolgimento del controllo sugli oncogèni, esercitato da fattori ambientali. Per esempio, l'amianto nei polmoni può provocare un carcinoma polmonare.
Abbiamo parlato dei virus con una certa abbondanza di
particolari, ma ancor meglio studiate sono le sostanze chimiche che promuovono il cancro. Tra queste sostanze, definite cancerogene, molte possono interferire con il messaggio dell'oncogène, trasmesso con il DNA, e con i meccanismi che lo controllano.
Nei ratti, la somministrazione di nitrosometilurea provoca un carcinoma mammario, modificando in modo imponderabile il messaggio del DNA. Gli effetti sono, tuttavia,
tutt'altro che imponderabili: nelle cellule della mammella
gli oncogèni vengono attivati e si sviluppa il carcinoma.
Viviamo in un «mondo chimico». Tutti noi siamo costantemente esposti a sostanze chimiche naturali e sintetiche,
siano esse sotto forma di conservanti per alimenti, farmaci
che passano dal banco del farmacista alle nostre case o additivi per la benzina. Lo strano è che, di tutte le sostanze alle quali siamo esposti, relativamente poche hanno un potenziale cancerogeno. Ne consegue, quindi, che il cancro negli
esseri umani è innescato perlopiù da altri fattori, oppure si
instaura spontaneamente. Ciò non dovrebbe in alcun modo
far diminuire la nostra determinazione a trovare e ad eliminare dall'ambiente quegli elementi che hanno sicuramente
la potenzialità di provocare il cancro.
La nostra trattazione sul cancro è ora giunta al punto in
152
cui dobbiamo fermarci ed esaminare la questione del fumo
delle sigarette. Il catrame, le sostanze chimiche e la nicotina, contenuti nelle sigarette, sono di gran lunga i cancerogeni più pericolosi presenti nel nostro ambiente e sarebbe
ingiusto non esaminare l'argomento in modo esauriente.
Cercherò di farlo in modo non emotivo, ma non è facile. I
medici sono costretti ad assistere a così tanta sofferenza
non necessaria derivata direttamente dal fumo, che è difficile parlare spassionatamente dell'argomento, dato anche il
nostro miserevole successo nel tentare di fare cessare alla
gente l'abitudine di fumare e, cosa ancora più importante,
di riuscire a trattenerla dall'iniziare.
Ricorderete Jennifer, naturalmente. Come si è visto, una
paziente fortunata. Bene, raramente essa era stata vista in
società senza una sigaretta tra le labbra. La sua bronchite
era causata dal fatto che fumava più di trenta sigarette al
giorno, e questo per più di trent'anni. La semplice verità,
alla quale non si può sfuggire, è che il fumo uccìde, uccide,
uccide. Che, in una società colta, ai fabbricanti di tabacco
debba essere concesso di parlare del «lato affascinante» di
questo prodotto mortifero è una vergogna. Essi impiegano
individui insinuanti e abili fascinatori che con argomenti
capziosi seminano il dubbio e l'incredulità sulle asserzioni
della comunità scientifica, che sono invece basate su prove
inconfutabili: il fumo delle sigarette rappresenta per il fumatore attivo e passivo un pericolo mortale. La situazione è
molto diversa da quella dell'alcool.
Vi sono studi secondo cui un'assunzione moderata di alcool non è dannosa. Nel fumo, invece, nessun livello è innocuo; anche una sola sigaretta a basso contenuto di catrame alla settimana comporta rischi che dovrebbero essere
considerati inaccettabili. In realtà, come vedremo, anche
l'inalare il fumo di un'altra persona (il cosiddetto fumo
passivo) è altrettanto pericoloso.
Perché il fumo è così pericoloso? Ignorando per il momento tutti i rischi che nulla hanno a che fare con il cancro,
il fatto è che le sostanze associate con il catrame, assieme al153
la capacità della nicotina di modificare la portata dei vasi
sanguigni, irritano le cellule in misura tale che si ha come
esito prevedibile la mancata regolazione dell'attività oncogènica. Se si fiuta il tabacco, ci si può ammalare di cancro
al naso. Se lo si mastica o si fuma la pipa, vi è un notevole
rischio che si sviluppi un cancro nella bocca. Se si inala il
fumo nelle vie aeree, le cellule che tappezzano l'albero
bronchiale vengono intossicate giorno dopo giorno. Ogni
anno, centinaia e migliaia di Jennifer scoprono la vera natura del catrame e degli oncogèni nel più devastante dei
modi.
Il fumo delle sigarette provoca bronchite che può condurre a un enfisema, cioè alla distruzione del tessuto polmonare. Promuove anche la formazione di ulcere nello stomaco e
di trombi nelle vene. Questi possono staccarsi dalle pareti
dei vasi e portarsi velocemente nei polmoni o al cervello,
dove causano gravissimi danni. Il fumo delle sigarette è responsabile, inoltre, della formazione di vene varicose; fa diminuire pericolosamente il peso alla nascita dei bambini di
madri che hanno continuato a fumare durante la gravidanza e fa aumentare in modo molto marcato il rischio di malattie cardiache. In media i fumatori hanno il 30 per cento
di giornate di malattia in più dei non fumatori. Il fumo,
combinato con l'assunzione di contraccettivi orali, fa aumentare nelle donne al di sopra dei trentacinque anni di età
il rischio di un attacco cardiaco di ben trentanove volte e
quello di un colpo apoplettico di ventidue volte. Le forti fumatrici corrono un rischio molto più grande di ammalarsi
di cancro all'utero. Infine, il fumo fa diminuire la fertilità
di uomini e donne.
Nella maggior parte dei paesi occidentali, il fumo è responsabile di un numero di decessi all'anno cinque volte superiore a quello per incidenti stradali. Negli Stati Uniti d'America, dove la speranza di vita maschile supera i settant'anni di età, il quaranta per cento dei fumatori con venticinque o più sigarette al giorno muore prima dei quarantacinque anni di età. I fumatori abituali, con venti sigarette al
154
giorno, accorciano la durata della loro vita, in media, di almeno cinque anni e molti l'accorciano molto di più.
Se vi piace divertirvi con la statistica, potete calcolare che
il fumatore medio accorcia la propria vita di cinque minuti
e mezzo ogni sigaretta che fuma. Uomini al di sotto dei
quarantacinque anni di età che fumano quindici sigarette al
giorno o più hanno una probabilità di morire di malattie
coronariche nove volte superiore a quella degli uomini della
stessa età che non fumano.
Le cifre sono schiaccianti, i dati scientifici indiscutibili.
Eppure, nella maggior parte dei paesi, la percentuale di individui che fumano, soprattutto donne, è in aumento. I governi devono essere apertamente criticati per la loro capitolazione di fronte alla fiorente industria del tabacco. Tutte le
forme di pubblicità per le sigarette dovrebbero essere bandite e sulle confezioni dovrebbero esservi avvertimenti che
proclamano con molta evidenza che «il fumo uccide».
Medici, educatori, sociologi e psicologi hanno totalmente
fallito nell'elaborare strategie che riducessero in modo significativo l'incidenza dei giovani che cominciano a fumare. Quale ragazzo di dodici anni si preoccupa di come sarà
la sua salute quando avrà quarant'anni? Forse l'unica speranza per il prossimo futuro è l'atteggiamento sempre più
comune tra i non fumatori di considerare il fumo un'abitudine antisociale. Il costo, l'alito cattivo, la cenere dappertutto e altro ancora non sono mai stati deterrenti per i fumatori, ma se il fumo venisse considerato dalla società come una debolezza antisociale, disgustosa, folle, non virile,
allora forse si potrebbe ottenere qualcosa.
Le prove che si stanno accumulando rapidamente sul pericolo che l'inalazione del fumo altrui (il fumo passivo) rappresenta possono segnare una svolta. Ma sono i mutamenti
di ordine sociologico e non le verità mediche a influenzare
gli schemi sociali nei riguardi del fumo. I ristoranti, gli aerei
e i luoghi di lavoro sono soltanto alcuni degli spazi che si incontrano comunemente e in cui coloro che non fumano sono danneggiati dal fumo prodotto da altri.
155
Il fumo è una sostanza interessante e pericolosa. Osservatene uno sbuffo che esce dalla bocca di un fumatore e vedrete che il flusso può essere suddiviso in una corrente principale e in correnti laterali. Queste probabilmente raggiungeranno il punto dove vi trovate ed entreranno nei vostri
polmoni. Proprio per le sue proprietà di dispersione, il fumo delle correnti laterali contiene una quantità considerevolmente superiore di sostanze più pericolose rispetto al fumo della corrente principale. Per esempio, c'è più monossido di carbonio, più catrame, più nicotina: Tre quarti della
nicotina trattenuta nel filtro delle sigarette vengono liberati
nell'aria e si trovano proprio nel fumo delle correnti laterali. Di conseguenza, la maggioranza dei non fumatori presenta nei liquidi corporei, per la maggior parte della sua esistenza, quantità riconoscibili di nicotina. È stato calcolato
che chi lavora in un ufficio dove si fuma può inalare una
quantità di fumo equivalente a quella di cinque sigarette al
giorno.
Si può continuare all'infinito ed è indubbio che, a questo
punto, anche il più educato e timido tra noi, alla domanda:
«Le dà fastidio se fumo?» deve rispondere con un enfatico
«Sì». Parliamo di cancro, e non di altro, e non è esagerato
dire che, se la gente non fumasse, il cancro polmonare potrebbe essere ridotto di più del 95 per cento. E, come abbiamo detto, il cancro polmonare non è l'unica forma di neoplasia associata con il fumo.
Dati i costi, le sofferenze e gli esiti letali causati dal fumo,
abbiamo tutti il dovere di saperne di più e di compiere la
nostra parte nel rimuovere una ben definita causa di cancro
e di tante altre malattie.
Molti altri fattori ambientali interagiscono con le cellule
per innescare alterazioni neoplastiche. Il cibo troppo cotto
può provocare cancro intestinale (le comunità giapponesi in
cui viene consumato solo pesce crudo non presentano mai
cancro all'intestino); giapponesi espatriati che vivono in altri paesi dove il cibo viene cotto hanno la stessa probabilità
di ammalarsi di cancro all'intestino delle popolazioni indi156
gene. Il virus dell'epatite B può far precipitare lo sviluppo
di un cancro al fegato. Il virus che provoca la febbre ghiandolare (mononucleosi infettiva) può causare cancro in gola
e nei linfociti B, e via di questo passo con centinaia di altri
esempi.
Per riassumere, il cancro si instaura quando viene alterato quel processo ordinato che induce le cellule ad autoduplicarsi. Gli oncogèni vengono attivati o spontaneamente (intrinsecamente) o per mezzo di prodotti chimici, virus o altri
fattori estrinseci. Se questi oncogèni attivati non vengono
rapidamente disattivati, la divisione cellulare proseguirà in
modo incontrollato e si svilupperà un tumore. Questa massa di cellule comprimerà i tessuti locali normali e le cellule
infrangeranno le pareti dei vasi sanguigni e linfatici. Esse si
trasferiranno (il processo prende il nome di metàstasi) in altre parti dell'organismo, per continuare la loro mortale
espansione. Gli organi vitali verranno così danneggiati e il
paziente morirà.
Arriviamo, per finire, all'immunologia del cancro. Allestiamo la scena. Per una ragione o per l'altra, una cellula ha
assunto un comportamento maligno. È ancora se stessa o è
diventata estranea? Questa domanda ha sfidato per cinquant'anni o più la comunità scientifica, essendo la risposta
della massima importanza. Se le cellule neoplastiche, pur
dannose, fanno ancora parte del «sé», non vi è allora alcuna ragione perché i linfociti le attacchino e le distruggano.
Se, nella loro condizione di cellule maligne, sono solo leggermente diverse dal «sé», allora dovrebbero essere distrutte. Lo sviluppo del cancro potrebbe allora essere imputato,
almeno parzialmente, ad un sistema immunitario inefficiente.
Una cinquantina d'anni fa alcuni scienziati prelevarono
tumori da animali e li trapiantarono in altri animali. Il sistema immunitario dei riceventi scatenò un violento attacco,
eliminando rapidamente le cellule tumorali non desiderate.
Quei ricercatori sostennero, non senza ragione, che le cellule neoplastiche potevano essere rigettate dai meccanismi im157
munitari e dedussero che il sistema immunitario degli animali donatori doveva essere difettoso. Il problema, in realtà, era che gli animali rigettavano il tumore non perché era
un tumore, ma perché era un tessuto estraneo. Si trattava di
un rigetto di trapianto, non di un rigetto del tumore.
Mentre si tentava di classificare questa situazione, i medici non avevano alcun dubbio. I pazienti immunodepressi, o
per malattia o per cura, sono soggetti a un rischio di ammalarsi di cancro notevolmente maggiore. Questo fatto risulta
assolutamente più evidente nei soggetti che hanno subito un
trapianto d'organo. Un paziente in cui sia stato trapiantato
il rene di un altro individuo aveva assoluta necessità di quel
rene nuovo per sopravvivere e non si poteva lasciare che il
suo sistema immunitario rigettasse l'organo donatogli.
Quando vengono utilizzati farmaci per smorzare la risposta
immunitaria contro l'organo trapiantato, nel paziente aumenta l'incidenza di nuovi tumori. Chiaramente deve essere
stato compromesso qualche meccanismo omeostatico.
Da queste osservazioni si possono ricavare due idee correlate. Secondo la prima, le cellule neoplastiche devono svilupparsi piuttosto di frequente nell'organismo di ciascuno
di noi, mentre in base alla seconda idea, la situazione normale, ma potenzialmente pericolosa, viene tenuta sotto
controllo da linfociti competenti, che riconoscono un'alterazione di tipo tumorale in una cellula, che quindi distruggono. Tutto il giorno, ogni giorno, i linfociti svolgono una
«sorveglianza immunologica» per assicurare un riconoscimento precoce del cancro. Entrambe le idee sono state confermate come vere.
Avendo sviluppato la capacità di «rappresentare» in provetta l'attacco del sistema immunitario a cellule neoplastiche, abbiamo potuto dimostrare che perlomeno tre tipi distinti di cellule, nell'ambito del sistema immunitario, possono uccidere le cellule tumorali. Un ramo della famiglia dei
linfociti T, i linfociti T «citotossici», può attaccare le cellule
tumorali fisicamente, aggrappandosi alle loro membrane, e
quindi distruggerle.
158
Un secondo gruppo di cellule, in grado di distruggere il
cancro, è costituito dalle cellule killer naturali (NK). Si tratta di cellule simili ai linfociti, che dipendono dalla disponibilità dell'interferon per attivare il loro attacco chimico sulle cellule tumorali. Infine, vi sono le cellule K, cellule simili
ai linfociti, che possono uccidere (la K viene dalla parola inglese to kill, che significa appunto uccidere, assassinare) le
cellule tumorali rivestite da un anticorpo contro qualche
componente della parete della cellula neoplastica. L'anticorpo guida la cellula K verso il bersaglio.
Perché una cellula neoplastica venga uccisa, è necessario
che essa, metaforicamente parlando, tiri fuori la lingua davanti alle potenziali cellule killer: deve esservi qualcosa sulla
sua superficie che dimostri il suo rinnegamento. Inoltre,
forse lo ricordate, almeno i linfociti T attaccano soltanto
quando vedono, simultaneamente, il «sé» in forma di antigeni di istocompatibilità e l'estraneità. Così ci si può aspettare l'uccisione delle cellule tumorali solo se queste espongono simultaneamente, sulle loro membrane cellulari, «antigeni specifici tumorali» e una parte del sé.
Fortunatamente per noi, fanno proprio questo per la
maggior parte del tempo e perciò vengono uccise. Ogni
giorno c'è un «nuovo noi»: otto miliardi di cellule che non
avevamo ieri e tra le quali alcune sono maligne. Da mattina
a sera, uccidiamo le nuove cellule tumorali prima che possano arrecare danno.
Il problema è che, in certi tessuti, possono insorgere tumori le cui cellule espongono solo pochi di questi essenziali
marcatori che rivelano il «rinnegamento». Inoltre, essi possono proteggersi in almeno due modi. In primo luogo, sono
in grado di mascherare deliberatamente quei marcatori, tipici del cancro, che si trovano sulla loro superficie, e, in secondo luogo, possono attivare linfociti T regolatori, presenti nell'ambiente circostante, per smorzare l'attacco contro loro stessi. Davvero ingegnosi, bisogna riconoscerlo.
In tutta questa immunologia del cancro vi è una componente familiare. Come in tante altre situazioni biologiche,
159
alcuni di noi riescono meglio di altri nella lotta contro il
cancro. Questo variabile grado di efficienza può valere per
il cancro in generale o forse solo per un tipo di cancro, che
intacca determinati tessuti.
Per illustrare l'argomento, riporto qui una vera anamnesi. Margaret, all'età di trentasei anni, aveva notato sulla
mammella destra una piccola protuberanza, che le venne
asportata chirurgicamente e risultò essere maligna. Tutte le
forme di cancro che possono essere asportate, però, se sono
identificate per tempo, possono essere guarite. Cinque anni
dopo Margaret stava ancora bene ed era considerata davvero fortunata, anche se non si può mai essere certi che qualche cellula non sia sfuggita all'intervento.
A quarantasette anni, uno striscio effettuato a livello del
collo dell'utero mostrò la presenza di un tumore maligno a
uno stadio precoce. Il chirurgo fece un buon lavoro e a
cinquantun anni Margaret stava bene. Tuttavia, di recente,
essa aveva notato un poco di sangue nelle feci. Non sangue visibile a prima vista, ma sangue rivelato da una cartina impregnata di sostanze chimiche che reagiscono con
esso.
Perché Margaret era così ansiosa di trovare quel sangue
nelle feci? Sua madre era morta all'età di cinquantadue anni di cancro al colon. E anche due sue zie erano morte di
cancro prima dei sessant'anni. Una di cancro al pancreas e
l'altra di cancro al colon. La nonna di Margaret, poi, era
morta di una forma di cancro che aveva preso inizio da
qualche punto dell'apparato genitale. Infine, la sorella di
Margaret aveva avuto anch'essa un carcinoma al seno, ma
non era stata così fortunata come lei: era ancora viva, ma
con una metastasi al fegato.
Il cancro colpisce in questo modo alcune famiglie e, anche se ciò non accade particolarmente spesso, la frequenza
è tale da farci concludere che particolari costellazioni geniche possono predisporre i componenti di una stessa famiglia alla malattia. Poiché il sangue nelle feci è spesso un sintomo molto precoce di carcinoma intestinale, Margaret era
160
stata consigliata di controllare le proprie feci nel modo descritto. Trovato il sangue, fu effettuata una colonscopia
(esame del colon con una sonda sottile a fibre ottiche, che
permette l'osservazione anche oltre le piegature dell'intestino). Fu diagnosticato un carcinoma precoce, che venne debitamente asportato dagli strumenti attaccati al colonscopio. Margaret vinse così la sua battaglia.
Vi sono anche prove che suggeriscono una propensione a
sviluppare tumori, ereditata da singoli individui piuttosto
che da famiglie, come nel caso della famiglia di Margaret.
Abbiamo già detto che, quando il sistema immunitario
incontra un antigene per la seconda volta, la risposta dell'organismo sarà più intensa. Una volta sensibilizzata, la
memoria immunologica dà un livello di protezione molto
più elevato. Se si prelevano cellule da un tumore, introducendole in una provetta in cui vengono aggiunti linfociti T
estratti dal sangue di una persona sana e scelta a caso, subito non succede granché. Quei linfociti T non sono sensibilizzati al cancro: non hanno mai «visto» quel tessuto
prima.
Ma con certi tumori, se i linfociti T non vengono prelevati dal proverbiale «uomo della strada», ma da un individuo
sano, in qualche modo fisicamente vicino al malato di cancro, anche se non necessariamente parente, le cose vanno in
maniera diversa. I linfociti T delle persone che hanno uno
stretto rapporto con il malato, sia esso un rapporto amoroso, un rapporto di coabitazione o un rapporto di parentela,
purché vissuto nella stessa casa, attaccano spesso con rapidità le cellule tumorali con le quali entrano in contatto, dato il loro genere di relazione. Una conclusione sembra inevitabile: tutte queste persone con linfociti T sensibilizzati
hanno avuto nel loro corpo lo stesso tipo di cancro e lo hanno sconfitto, oppure hanno «visto» la sostanza che innesca
il cancro, o altro fattore, che ora le cellule tumorali dell'amico, o parente, o amante, espongono sulla loro superficie,
e l'hanno sconfitta. Questa e altre prove depongono fortemente in favore del fatto che, di fronte a un tumore inali161
gno, la prestazione di un individuo varia: alcuni di noi sono di gran lunga più resistenti di altri.
Malgrado ciò, gli immunologi non sono disposti ad accettare la teoria che, quando il cancro prende il sopravvento e si diffonde, ne è responsabile a priori un'insufficienza
del sistema immunitario. Tumori maligni gravi possono
svilupparsi in chiunque e sfuggono alla sorveglianza immunologica per il numero estremamente scarso di antigeni del
cancro e del «sé» esposti sulla superficie delle loro cellule.
A parte questo, la risposta immunitaria può essere resa vana da espedienti che le cellule tumorali possono mettere in
atto.
La storia della guarigione miracolosa di Jennifer non è
affatto unica, anche se, sfortunatamente, casi come il suo
sono rari. Quando i patologi prelevano una parte del tessuto tumorale infettato secondariamente, come nel caso di
Jennifer, trovano che, nell'attacco immunologico furioso
scatenato contro i batteri, vengono uccise anche cellule dell'innocente tessuto polmonare e cellule della meno innocente massa tumorale. Le cellule tumorali sono prese nel
fuoco incrociato biologico.
Grazie a queste osservazioni, l'unità di cui sono a capo
ha cominciato a compiere prudenti tentativi per riprodurre
le circostanze in cui è avvenuta la guarigione di Jennifer.
Una volta localizzato un tumore maligno nel polmone, mediante diagnosi per immagini effettuata con l'aiuto di un
calcolatore, abbiamo iniettato al centro di questo tumore
alcuni bacilli tubercolari uccisi (batteri che, da vivi, causano la tubercolosi). Avevamo immunizzato i pazienti con lo
stesso preparato due settimane prima. Nella massa tumorale si è avuta una reazione, con un riversamento in essa di
linfociti T, ma la battaglia alla quale speravamo di assistere non è avvenuta. In modi che non capiamo il tumore era
riuscito a manipolare la risposta immunitaria, dimodoché i
linfociti T che giungevano in quell'area erano «disattivati»
e non «attivati». Per questo motivo la storia di Jennifer è
così insolita. Essa riusciva ad avere nei propri tessuti linfo162
citi killer contro i batteri che la invadevano; la maggior
parte dei malati di cancro no.
Per riassumere: il nostro sistema immunitario è in grado
di riconoscere nella maggior parte dei tessuti, e per la maggior parte del tempo, le cellule tumorali. Lo fa costantemente, dato che cellule maligne sono frequentemente presenti nel nostro organismo. La sua depressione fa aumentare in modo marcato il rischio di ammalarsi di cancro. Alcuni soggetti riescono meglio a dominare immmunologicamente il cancro di altri. Alcuni tumori sono molto più difficilmente riconoscibili di altri e potrebbero trarre in inganno
il sistema immunitario di chiunque. Possono, inoltre, essere
molto difficili da distruggere, o perché non espongono in
superficie quegli antigeni rivelatori necessari per stimolare
quelle cellule dell'organismo preposte ad eliminare le cellule
neoplastiche, o perché mascherano i loro stessi antigeni, o
perché sopprimono il sistema immunitario attorno ai linfociti T soppressori. Il cancro è davvero un formidabile avversario.
Di seguito vengono riportati alcuni dati utili e interessanti
sui differenti tipi di cancro.
Negli Stati Uniti, in un anno qualsiasi, il carcinoma
mammario viene diagnosticato in più di 120.000 donne. Per
le donne tra i 35 e i 45 anni di età esso è la principale causa
di morte. La sua incidenza in scala mondiale è massima tra
le donne caucasiche e minima tra le donne delle tribù indiane. È simile nella maggior parte dei paesi occidentali, ma è
più bassa in Oriente. Le donne orientali che si trasferiscono
in Occidente corrono gli stessi rischi delle donne che vivono
in questa parte del mondo. Le cause di queste differenze
non sono conosciute.
Il rischio di morire di carcinoma mammario diventa più
elevato di anno in anno, tranne per un periodo attorno ai
cinquant'anni, in cui si osserva un inspiegabile plateau. Le
donne in cui le mestruazioni sono comparse prima o sono
terminate dopo i cinquantacinque anni di età corrono un rischio maggiore delle donne con una storia mestruale più ti163
pica. Irregolarità nei periodi mestruali si associano a un
maggior rischio di cancro. Se una donna ha il primo figlio
dopo i trent'anni, il rischio che si ammali di carcinoma
mammario è tre volte superiore a quello di una donna che
ha il primo figlio a diciotto anni.
Il carcinoma mammario ha un andamento tendenzialmente familiare. Se una donna ha una madre o una sorella
affette da questa forma di cancro, ha una probabilità tre
volte superiore di ammalarsi dello stesso male che se non vi
fossero stati questi casi nella sua famiglia. Il rischio è ancora più elevato se ha una sorella ammalatasi di carcinoma
mammario prima della menopausa.
Altri fattori che fanno aumentare il rischio sono le diete
ad alto contenuto di grassi animali, l'obesità e le radiazioni
al torace (raggi X e radiazioni da bombe atomiche). Si ebbe
un marcato aumento di carcinomi mammari nelle donne
giapponesi sopravvissute a Hiroshima.
La prevenzione è certamente il miglior modo di affrontare questa malattia. Il 90 per cento delle donne scopre il proprio carcinoma da sé, ma troppo spesso ciò avviene incidentalmente. È dimostrato che la migliore arma è l'autoesame,
compiuto regolarmente e con la dovuta preparazione. Le
donne dopo i quarant'anni, che appartengono a una categoria a rischio, dovrebbero sottoporsi annualmente a una
mammografia (esame radiologico della mammella), dato
che questa è un'arma affidabile nella maggior parte dei casi
e può essere effettuata oggi con dosi straordinariamente
basse di radiazioni.
Molte donne affette da carcinoma mammario hanno cellule maligne con membrane su cui si trovano i recettori per
gli estrogeni (ormoni sessuali femminili). Questi ormoni,
una volta legati ai recettori, stimolano la crescita e la diffusione del tumore decisamente maligno. I farmaci che bloccano l'interazione tra ormone e cellula neoplastica si stanno
dimostrando molto utili.
È stata sviluppata una procedura per stabilire prontamente se particolari cellule tumorali di un paziente usano
164
per il loro sviluppo ormoni sessuali o no. Si può somministrare una terapia anti-estrogeni se le cellule dipendono da
questi ormoni; in caso di insuccesso, si può dare seguito a
misure più drastiche, come la rimozione delle ovaie in donne in pre-menopausa e delle surrenali, piccole ghiandole situate alla sommità dei reni. Le ovaie e le surrenali producono entrambe ormoni sessuali.
Per carcinomi di piccole dimensioni, diagnosticati precocemente, si raccomandano la chirurgia e la radioterapia.
Per tumori già in fase di diffusione, può essere necessario
un intervento chirurgico più radicale, associato a radioterapia, a terapia anti-ormonale e a chemioterapia (una terapia
che uccide le cellule tumorali mediante farmaci, i quali sono
però molto tossici). Con tumori non invasivi, i tassi di sopravvivenza cinque anni dopo la diagnosi sono presumibilmente compresi tra il 40 e l'80 per cento. Anche con il miglior trattamento possibile, un tasso di sopravvivenza del 10
per cento a cinque anni è tutto quello che ci si può aspettare
per un carcinoma della mammella già in metastasi.
Oggi, il carcinoma mammario è curato molto meglio che
in passato, ma rappresenta ancora un rischio elevato per le
donne (e anche per 900 uomini all'anno negli Stati Uniti). Si
può concludere questo paragrafo solo sollecitando ogni
donna a essere sempre vigile e attenta nel praticare con
estrema attenzione l'autoesame al seno.
Il carcinoma polmonare
Per motivi che ho già ricordato, nessuna forma di cancro è
più penosa da descrivere di quella del carcinoma polmonare. La malattia scomparirebbe se la gente cessasse dì fumare. Negli Stati Uniti, più di 100.000 uomini e 50.000 donne
si ammalano ogni anno di questo tipo di tumore maligno.
L'incidenza sta aumentando in maniera straordinaria nelle
donne, che hanno tendenza a fumare sempre di più, al contrario degli uomini. È tragico che qualunque grafico in cui
viene illustrata la crescente incidenza del carcinoma polmo165
nare e del carcinoma mammario nelle donne preveda che,
nei prossimi anni, il primo posto tra i tumori che maggiormente uccidono le donne toccherà non più al carcinoma
mammario, ma al carcinoma polmonare.
I tassi di mortalità da carcinoma polmonare in entrambi i
sessi raddoppiano ogni quindici anni. Per gli uomini al di
sopra dei trentacinque anni di età, questo flagello rappresenta la via principale alla morte da cancro. La maggior
parte dei casi si verificano tra i cinquantacinque e i sessantacinque anni di età, ma migliaia di trentacinquenni muoiono ogni anno di carcinoma polmonare.
Forse la statistica più convincente per quei pochi lettori
ancora vogliosi di fumare dopo aver letto le precedenti parti
di questo capitolo è la seguente: al momento della diagnosi,
la malattia è incurabile nel 70 per cento dei casi. La sopravvivenza di cinque anni con questa forma di cancro si raggiunge solo nell'8 per cento dei pazienti.
Il carcinoma polmonare è, in realtà, un carcinoma dei
bronchi e si instaura quando agenti cancerogeni vengono
inalati nelle vie respiratorie. Esso si sviluppa lentamente,
ma il guaio è che i sintomi associati con la sua crescita compaiono ancor più lentamente. Viene diagnosticato nel 16
per cento degli affetti solo in seguito a un esame radiografico di routine; la maggioranza degli altri vanno dal medico
dopo aver sputato sangue tossendo, oppure semplicemente
perché afflitti da una tosse fastidiosa. Come abbiamo detto, è troppo tardi per la guarigione nel 70 per cento dei casi.
La maggior parte dei pazienti con carcinoma polmonare
sono immunodepressi dalla malattia stessa e questo, naturalmente, facilita la metastatizzazione del tumore. Abbiamo prove eccellenti che il fumo, oltre a stimolare gli oncogèni, danneggia i normali meccanismi di sorveglianza che si
trovano nelle vie respiratorie e, per questa ragione, il fumo
costituisce un doppio rischio.
A parte il fumo, l'unica altra causa di carcinoma polmonare, numericamente significativa, è l'amianto. L'inalazione cronica di particelle di amianto nei polmoni può provo166
care la malattia in una percentuale allarmante di individui
esposti. Per questa ragione, nella maggior parte dei paesi è
in atto uno sforzo massiccio per essere certi che l'amianto,
usato in tantissimi edifici come mezzo per ritardare la propagazione degli incendi, sia completamente ricoperto. Purtroppo, in molte città sono state emanate ordinanze che obbligano a togliere tutto l'amianto dagli edifici pubblici. La
realizzazione di quest'opera di rimozione è estremamente
rischiosa e può essere fonte di un numero di problemi molto
maggiore di quello che si avrebbe se l'amianto venisse lasciato al suo posto e si ricorresse, invece, alle opportune
tecniche di manutenzione per impedire che le fibre si disperdano nell'aria.
Il carcinoma intestinale
Roland aveva cinquantasei anni quando, improvvisamente,
il suo intestino cominciò a funzionare in modo diverso.
Aveva sempre avuto una tendenza alla stitichezza e ora, invece, aveva notato a parecchie riprese che le sue feci erano
diventate sorprendentemente molli. Si sentiva bene e quel
sintomo non lo affliggeva troppo. Circa due mesi dopo essersi accorto di questo cambiamento, si infilò un paio di
pantaloni e si rese conto di essere dimagrito parecchio: quei
pantaloni sembravano non avere più forma. Era stupito.
Aveva un buon appetito e gli sembrava di mangiare come
sempre. Non pensò, in quel momento, che la situazione fosse tale da richiedere una visita medica.
Tre mesi dopo, continuava a perdere peso e aveva un po'
di fastidio nella parte bassa del ventre; nulla di grave, ma solo un po' di molestia. Finalmente, quando un giorno notò
sangue con le feci, si allarmò e consultò immediatamente un
medico. Questi riuscì a diagnosticare senza difficoltà, tramite esplorazione digitale, un tumore al retto ben sviluppato.
Per dargli una possibilità di combattere, un chirurgo gli
asportò il retto e, simultaneamente, gli deviò l'intestino in
modo che potesse svuotarsi attraverso un foro praticato
167
nella cute dell'addome (colostomia). Ma fu troppo tardi. II
carcinoma si era già diffuso al fegato e il paziente morì nello spazio di pochi mesi.
Il carcinoma del crasso e del retto è una delle forme più
comuni di cancro. Negli Stati Uniti il 5-6 per cento della popolazione maschile e femminile ne è colpito. L'incidenza
della malattia e la sopravvivenza dei pazienti dopo intervento chirurgico non sono aumentate negli ultimi quarant'anni. Nuovi metodi di cura, come l'immunoterapia, appaiono
promettenti e sono indispensabili.
Il più importante e idoneo tentativo fatto di questi tempi
riguarda l'identificazione di sostanze alimentari che potrebbero provocare il cancro, di cibi che potrebbero prevenirlo
e di modi per proteggere l'intestino da sostanze pericolose.
Altri provvedimenti urgenti che dovrebbero essere attuati
comprendono lo screening dell'intera popolazione sopra i
cinquant'anni per rivelare la presenza di un cancro precoce
e l'identificazione, per un esame più attento, di quegli individui che corrono un rischio superiore al normale di ammalarsi di tale patologia.
Un'osservazione estremamente affascinante e potenzialmente utile è stata fatta nel corso di studi scientifici sul carcinoma intestinale in Africa. Dove la dieta è ricca di fibre e,
di conseguenza, la massa delle feci è grande, si osserva
un'incidenza di carcinomi molto più bassa che nelle aree in
cui vengono consumate poche fibre. La teoria che è stata
formulata (ma che aspetta prove formali) suggerisce che le
fibre (la crusca di frumento e le fibre di agrumi sono le fonti migliori) fanno aumentare la massa di scorie non assorbibili nell'intestino, che vuole comprensibilmente liberarsene.
Pertanto viene accelerato il tempo di transito in questa parte dell'apparato digerente. Dunque, sostanze cancerogene
potenziali che potrebbero essere state ingerite non vengono
lasciate attardare in esso ed interagire con gli oncogèni. Esistono anche alcune prove che certe sostanze potenzialmente
cancerogene si legano alle fibre e quindi vengono eliminate
assieme ad esse dal nostro organismo.
168
E, invece, per quanto riguarda la dieta, non vi è alcun
dubbio che i regimi alimentari ricchi di grassi (in particolare
quelli contenenti grassi insaturi) fanno aumentare i rischi di
carcinoma al colon. In Giappone, il carcinoma intestinale
era una malattia estremamente rara fino a quando la popolazione non ha adottato le cattive abitudini del mondo occidentale. Quando il livello di colesterolo si è innalzato rapidamente, è aumentata anche l'incidenza di carcinoma intestinale.
Una delle osservazioni più pertinenti e interessanti degli
ultimi tempi riguarda il concentramento geografico di casi
di carcinoma intestinale in aree in cui il selenio, un elemento in tracce, è assente dal suolo. Sarebbe una meravigliosa
opportunità se, aggiungendo selenio alla dieta (proprio come si aggiunge fluoruro all'acqua per sciacquare i denti), si
riuscisse a bloccare o a ridurre l'incidenza del carcinoma intestinale.
Se l'intera popolazione potesse essere sottoposta annualmente a uno screening per il carcinoma intestinale, la forma
incurabile della malattia quasi scomparirebbe. Purtroppo,
ciò non è realizzabile sotto il profilo economico, anche nei
paesi occidentali. Diversamente dal carcinoma polmonare,
questa forma di cancro si sviluppa lentamente. Tra l'inizio
dello sviluppo e la comparsa dei sintomi, e certamente prima della metastatizzazione, trascorre un periodo dai due ai
cinque anni. Se, per esempio, il cancro viene scoperto, nel
corso di un esame di routine, prima della comparsa dei sintomi, dall'80 al 100 per cento dei pazienti viene curato chirurgicamente. La domanda è, dunque: è possibile effettuare
un'efficace prevenzione?
Prima di tutto, identifichiamo i gruppi ad altissimo rischio. Per cominciare, dobbiamo dire che tutti, al di sopra
dei quarant'anni, sono a rischio (una persona su venticinque svilupperà questa forma di cancro nel mondo occidentale). Corrono un maggior pericolo quei pazienti che soffrono di certe forme infiammatorie intestinali, per esempio
di una colite ulcerativa. Stranamente, le donne che sono
169
state colpite da carcinoma mammario o agli organi genitali
corrono un rischio considerevolmente superiore di ammalarsi di carcinoma intestinale rispetto alle donne che non
hanno avuto i loro problemi. I pazienti che presentano polipi intestinali, cioè piccole protuberanze della parete intestinale, sono a rischio e dovrebbero essere tenuti strettamente
sotto controllo. Gli individui nella cui famiglia si sono avuti
casi di carcinoma intestinale hanno una probabilità di ammalarsi della stessa malattia che è quattro volte superiore a
quella degli altri individui.
Dopo aver identificato i gruppi a rischio elevato, come
possiamo sottoporli a uno screening per il cancro? La tecnica più promettente per uno screening di massa utilizza cartine per il sangue occulto. Queste cartine sono impregnate di
una sostanza estremamente sensibile che è in grado di rilevare la presenza di sangue, anche in tracce, nelle feci. Se
ciascuno si sottoponesse regolarmente a questo test per rilevare anche microscopiche quantità di sangue, migliaia di vite potrebbero essere salvate. Non che il test sia completamente infallibile. Non tutti i carcinomi sanguinano finché
sono curabili. Ciò che è importante, naturalmente, è che la
maggioranza di essi sanguina. I pazienti non devono mangiare carne bovina, pollo e pesce per ventiquattr'ore prima
di sottoporsi al test, mentre sono consigliati di mangiare
una grande quantità di crusca durante il periodo che precede il test per aumentare la probabilità che una lesione neoplastica precoce venga irritata e sanguini.
Malgrado i problemi associati con il test, almeno il 50 per
cento dei pazienti con risultato positivo è affetto da cancro
e l'86 per cento di questi pazienti è curabile, il che evidenzia
l'importanza di tale procedura.
A parte le cartine per il sangue occulto, l'identificazione
di un carcinoma richiede un esame dell'intestino stesso.
Tutti coloro che si trovano nei gruppi ad alto rischio, prima
ricordati, possono voler discutere con il loro medico sull'utilità di sottoporsi ogni due anni circa a una radiografia ai
raggi X dell'intestino e/o a una sigmoidoscopia.
170
Si ricordi che la perdita di sangue nelle feci, un cambiamento nella funzionalità intestinale (stitichezza o diarrea),
molestie a livello del basso addome, nausea e vomito, oltre
al dimagrimento, sono tutti sintomi di carcinoma intestinale.
Carcinoma al collo dell'utero
Issa Bella è una donna alta, di una bellezza ormai sfiorita,
pur avendo solo ventiquattro anni. Fa la prostituta a St.
Louis, una città pateticamente povera e popolosa sulla costa dell'Africa occidentale, a nord di Dakar. Per trovare
clienti, lavora soprattutto nelle sale da ballo alla periferia
della città, luoghi di ritrovo notturni estremamente popolari, data la passione che gli abitanti dell'Africa occidentale
dimostrano per la danza e il modo straordinario che hanno
di ballare. Si apprezza particolarmente la loro abilità quando si ascoltano i difficili ritmi che essi prediligono. Issa Bella lavora da quando aveva quindici anni. Gli africani invecchiano rapidamente, ma le donne cronologicamente giovani
come lei invecchiano ancora più in fretta che in Occidente.
Non stenteremmo a darle quarant'anni.
Issa Bella mi fu presentata dal suo medico francese,
quando, lavorando a Dakar, mi recai in visita a St. Louis.
Marcel, un uomo straordinario, e sua moglie Lisette dirigevano un'emoteca e una clinica per pazienti affetti da malattie trasmesse per via sessuale. Egli era allarmato dalla quantità di casi di carcinoma al collo dell'utero che aveva riscontrato nelle giovani donne africane, particolarmente se dedite alla prostituzione. Issa Bella, per esempio, a ventiquattro
anni aveva una grossa ulcera maligna al collo dell'utero e
Marcel era convinto che quel tipo di cancro fosse causato
da un virus introdotto nelle vie genitali con il coito.
A questo punto è indispensabile conoscere alcuni dettagli
anatomici. Attorno all'imboccatura dell'utero vi è un piccolo passaggio molto ricco di fibre muscolari. Questo guardiano del «santuario» è il collo dell'utero. Esso serve a trat171
tenere ciò che deve rimanere dentro (per esempio, il feto) e
a fare uscire ciò che deve uscire (il flusso mestruale). Si protende in basso nella vagina come labbra increspate (muso di
tinca) e, in questo modo, riesce ad essere in stretta comunicazione con qualunque cosa giunga nella volta della vagina.
È tappezzato da una membrana delicata, fatta di cellule che
spesso diventano maligne, dando origine al carcinoma del
collo dell'utero.
Issa Bella, che già da dieci anni faceva la prostituta, non
prendeva alcuna precauzione. Era stata affetta da numerose e ripetute malattie trasmesse per via sessuale. Malgrado
lavorasse parecchio, era molto povera. In quelle piccole città, dove la concorrenza è feroce, le prostitute guadagnano
solo da circa 500 lire a 1300 lire per cliente. Di sicuro, non
poteva permettersi di usare la pillola.
Aveva avuto due gravidanze. La prima volta aveva abortito, la seconda volta aveva dato alla luce un bambino, che
era stato accolto bene dalla sua famiglia, ma era morto di
malaria all'età di due anni. Il periodo successivo alla seconda gravidanza era stato molto duro. Issa Bella aveva avuto
un'infezione all'utero e le sue tube erano state gravemente
lese, rendendola praticamente sterile. Ora, a ventiquattro
anni, era affetta da un terribile carcinoma al collo dell'utero. Marcel pensava giustamente che essa potesse essere un
prezioso soggetto per un progetto di ricerca volto a indagare sulla causa del carcinoma del collo dell'utero.
Da molti anni gli epidemiologi dicevano che il rischio di
ammalarsi di carcinoma al collo dell'utero è nettamente superiore nelle donne che cominciano l'attività sessuale in giovane età ed è direttamente collegato al numero di partner
sessuali che esse hanno avuto.
Ricorderete forse, dal capitolo sulla gravidanza, che il liquido seminale ha proprietà che possono sopprimere la risposta immunitaria attorno al collo dell'utero. Può darsi
che esso riesca a smussare un simile attacco da parte dei linfociti T, che tentano di eliminare le cellule del collo dell'utero appena diventate maligne. Certamente il cancro in que172
sta regione del corpo è praticamente sconosciuto in donne,
come le monache, che non hanno una vita sessuale attiva.
La spiegazione più probabile, e che tiene conto dei rischi
associati con la promiscuità, metterebbe invece in rilievo il
fatto che quanti più partner sessuali una donna ha, tanto
maggiori sono le probabilità che essa ha di essere esposta a
virus trasmessi per via sessuale, come il virus erpetico o un
altro virus incriminato di recente, il papillomavirus. Certamente il virus che causa l'herpes genitale e che si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo, il virus dell'herpes
simplex di Tipo 2, si trova più comunemente nel collo dell'utero di donne affette da carcinoma che non nelle altre.
Questa forma di cancro predomina nelle donne dell'America Latina e dell'Africa, e soprattutto tra quelle di condizione socio-economica disagiata, che hanno avuto molteplici gravidanze. Questi ultimi fattori sono spesso, naturalmente, collegati. Un avvertimento del quale oggi si tiene
conto proviene da studi in cui risulta che le figlie di madri a
cui sono stati somministrati ormoni sessuali durante la gravidanza hanno, quando diventano adulte, un'incidenza di
carcinoma del collo dell'utero molto superiore al normale.
Fortunatamente è stato dimostrato a chiare lettere che questo tipo di cancro non è da mettere in relazione con l'uso
della pillola contraccettiva.
Si possono evitare le gravi conseguenze del carcinoma al
collo dell'utero con l'identificazione precoce. Pap test regolari ad anni alterni (Pap deriva dal nome del dott. Papanicolau che ha descritto l'utilità di questo metodo), in cui dal
collo dell'utero vengono prelevate cellule che sono poi esaminate al microscopio per vedere se vi sono modificazioni
maligne, eviteranno che questa malattia incurabile si sviluppi di nascosto. Se il cancro si sviluppa, si annuncerà sotto
forma di piccole emorragie dopo il coito, uno scolo o mestruazioni più abbondanti del normale. L'American Cancer
Society, che tiene conto del rapporto costo/beneficio del
Pap test, raccomanda che le donne di vent'anni o più, ma
senza alcun sintomo, e quelle sotto i vent'anni, ma con atti173
vita sessuale, facciano un Pap test ogni anno per due anni
consecutivi e almeno una volta ogni tre anni fino all'età di
sessantacinque anni. Le donne con un rischio superiore dovrebbero fare il Pap test ogni anno.
Il melanoma
La pelle è un organo davvero miracoloso. Non solo, come
sottolinea la canzone di Allan Sherman, «tiene dentro il nostro io interiore», ma funge da linea di difesa primaria contro le infezioni. Una pelle integra permette di entrare solo a
ciò che vuole che penetri dentro.
A meno che non siate di pelle nera, sareste indubbiamente folli ad esporre deliberatamente il vostro prezioso rivestimento esterno ai raggi del sole. La pelle, contrariamente ai
suoi proprietari, odia i raggi solari. Si raggrinza e si spacca,
invecchia e protesta, ma un numero sempre maggiore di
persone espone una superficie sempre maggiore di pelle al
sole. I dermatologi trovano che l'abbronzatura rende la pelle disgustosamente brutta; come può la gente rovinare deliberatamente qualcosa di tanto perfetto come la pelle non
esposta?
La conseguenza più grave dell'esporre la pelle al sole è
una forma particolare di cancro cutaneo, il melanoma. Sotto l'influenza cancerogena della luce solare, gli oncogèni
delle cellule pigmentate della cute sono attivati e compare
un tumore che è indiscutibilmente la più pericolosa di tutte
le forme di cancro. Anche quando sono sane, le cellule della
cute si dividono tutte rapidamente; pertanto il cancro della
pelle si moltiplica e si diffonde molto in fretta.
Piccoli e innocui rilievi pigmentati sulla pelle si chiamano
nei e molta gente ne ha centinaia sparsi su tutta la superficie
corporea. Il fatto di essere abituati a vedere macchie pigmentate sulla pelle può non farci notare la comparsa di una
varietà maligna.
Nel mondo occidentale l'incidenza dei melanomi maligni
è raddoppiata negli ultimi dieci anni e non mostra alcun se174
gno di rallentamento. Se avete la pelle chiara e gli occhi grigio-azzurri e vi esponete al sole solo durante i fine settimana e in costume da spiaggia, correte il maggior rischio di essere colpiti da melanoma.
Questa forma di cancro risponde molto poco anche ai più
potenti farmaci anticancerogeni e si fa beffe della radioterapia. Alcuni melanomi si diffondono in ogni parte del corpo
e sono quindi incurabili; il riconoscimento precoce, seguito
da un'escissione chirurgica, è l'unica strategia valida. Dovrebbe essere facile estirparlo, dato che è ben visibile a tutti
coloro che lo guardano con occhio aperto. Il melanoma è
da considerarsi un'emergenza medica e la sua rimozione
quanto più precoce possibile è essenziale.
Il melanoma è un tumore che il nostro sistema immunitario può riconoscere e si hanno anche guarigioni spontanee,
sfortunatamente troppo rare. Con una vista più o meno
buona, dovremmo tutti ispezionare spesso la nostra pelle
per cercare i seguenti segni indicatori, che dovrebbero indurci a ricorrere subito al medico.
• Qualunque macchia pigmentata sulla pelle, che abbia un
bordo irregolare o una mancanza di colore uniforme
(cioè con più di una sfumatura rilevabile), deve essere
asportata chirurgicamente. I colori che sono più importanti come segni di melanoma maligno includono tonalità di rosso, di blu o di bianco. Le lesioni maligne possono anche essere uniformemente colorate e allora sono di
solito nere bluastre, grige bluastre o rosse bluastre. Devono essere asportate.
• Ogni macchia pigmentata che cambia rapidamente e in
modo significativo di dimensione o di colore deve essere
rimossa.
• Una macchia che diventa pruriginosa o dolorosa deve essere rimossa.
Le probabilità di sopravvivenza al melanoma possono essere stabilite esaminando lo spessore del tessuto neoplastico
dopo che è stato rimosso chirurgicamente.
175
Maschi e femmine che hanno uno scarso grado di tolleranza alla luce solare (cioè che mostrano scottature anche
dopo brevi esposizioni al sole e che si abbronzano poco)
hanno un'altissima probabilità di ammalarsi di melanoma e
non dovrebbero correre questo rischio. A lungo andare essi
non beneficerebbero più, in ogni modo, dei risultati della
ripetuta esposizione al sole.
Le donne, più degli uomini, sono colpite da melanoma,
anche se questo si diffonde più rapidamente negli uomini. I
melanomi che si formano sul torace, sul dorso o sull'addome sono tendenzialmente peggiori di quelli che si sviluppano sulle braccia o sulle gambe. Riconosciuti precocemente,
possono guarire nell'80-100 per cento dei casi. Basta che sia
cominciata la loro diffusione, solo il 10 per cento dei pazienti sarà ancora in vita a cinque anni dalla diagnosi. L'immunoterapia, come vedremo, può contribuire in maniera significativa all'annientamento di questa forma di cancro.
La cura del cancro
Viviamo in un'epoca in cui chi smercia medicine alternative
pubblicizza chiassosamente di essere in grado di guarire il
cancro con ogni cosa: dai noccioli di albicocche ai clisteri di
caffeina. È questa una forma particolarmente tragica di
frode, che fa presa sulle paure dei pazienti con cancro già
esteso, i quali non trovano aiuto nelle procedure scientifiche correntemente accettate. La scienza medica sembra
prossima a migliorare la nostra capacità di far fronte a numerose forme di cancro, e si deve sottolineare che grandi
passi sono già stati compiuti con i metodi convenzionali di
cura del cancro, che ora verranno descritti.
La chirurgia può essere curativa e, pertanto, il miglior
modo di affrontare i tumori accessibili al bisturi in mani
esperte è l'asportazione. Se il cancro non si è diffuso oltre
l'area interessata dall'intervento, allora si può prevedere
che il trattamento avrà il 100 per cento di successo. La maggior probabilità di guarigione in seguito a intervento chirur176
gico si ha in quei tumori che annunciano la loro presenza
precocemente. Le forme di cancro che colpiscono la pelle,
la mammella, lo stomaco, l'intestino e l'utero sono tra
quelle che possono essere guarite chirurgicamente, se vengono scoperte con sufficiente anticipo. Per questa ragione
viene posta una comprensibile enfasi, nella medicina preventiva, sui controlli regolari per individuare segni e sintomi precoci di una proliferazione maligna. Anche se la chirurgia non è curativa, è spesso meglio rimuovere la massa
del tumore, in modo che non interferisca con una funzione
locale e vitale, per esempio ostruendo l'intestino. Dopo la
rimozione della massa principale del tumore, si può ricorrere ad altri procedimenti «di rifinitura».
Talvolta le nuove apparecchiature per la radioterapia
possono emettere radiazioni sufficienti con una tale precisione da poter considerare curativa questa forma di terapia,
che difatti rappresenta la prima linea di intervento terapeutico. Spesso, invece, la radioterapia è usata come palliativo
in quanto rallenta la crescita del tumore e riduce il dolore
associato a una proliferazione che si infiltra tra i tessuti,
erodendo i nervi sensitivi.
Le radiazioni distruggono le cellule neoplastiche (e normali), danneggiandone i cromosomi. Di conseguenza, le
cellule perdono la capacità di dividersi. Quando tentano di
farlo, diventano preda di una tale disorganizzazione genetica da morirne. Quanto più rapidamente una massa di cellule tenta di dividersi, tanto più quella massa diventerà sensibile agli effetti della radiazione.
I maggiori problemi associati alla radioterapia sono la
possibilità di far giungere al tumore una quantità di radiazioni sufficiente senza danneggiare i tessuti circostanti e,
fatto ancora più importante, la necessità di proteggere i tessuti vitali sani, come il midollo osseo, dato che anche piccole quantità di radiazioni possono danneggiare le giovani delicate cellule, necessarie per la sopravvivenza. Si ricorderà
che il midollo osseo è responsabile della produzione di globuli rossi e bianchi (con l'eccezione dei linfociti T) e di quel177
le cellule che promuovono la coagulazione del sangue note
con il nome di piastrine.
La tattica convenzionale ultima per affrontare il cancro
ricorre alla chemioterapia. Si somministrano farmaci per
bocca o per via endovenosa e si attende che queste sostanze
tossiche giungano, attraverso la circolazione sanguigna, al
tumore. Il vantaggio del metodo è che, nella maggioranza
dei casi, dovrebbe essere possibile raggiungere con il farmaco ogni cellula neoplastica presente nell'organismo. Il problema è che le cellule normali di tutti i tessuti rimangono
esposte alla tossina come le cellule neoplastiche. Pertanto,
gli scienziati hanno cercato di allestire una serie di veleni
cellulari, assunti dalle cellule neoplastiche in modo preferenziale.
Vi sono cellule, nel nostro organismo, che si dividono di
norma rapidamente, ma, diversamente dalle cellule neoplastiche, lo fanno in modo controllato. I farmaci utilizzati per
uccidere queste ultime cellule penetreranno anche nelle cellule normali, senza tener conto di questo fatto, e le uccideranno. Tra le cellule più frequentemente colpite vi sono
quelle che tappezzano l'intestino e la vescica, le cellule del
midollo osseo e i follicoli piliferi. Se si osservano bambini e
adulti in una clinica per la cura del cancro non si potrà fare
a meno di osservare quanti, tra loro, hanno perso i capelli.
La chemioterapia può guarire certe forme di cancro, specialmente alcune forme di leucemia che colpiscono l'infanzia, ma perlopiù essa produce una remissione (scomparsa
dei sintomi) per periodi di tempo variabili e, in questo senso, prolunga la vita. L'arte del chemioterapista consiste nel
prolungare una vita che abbia una qualità accettabile. Tutti
i chemioterapisti desiderano comunque che giunga il giorno
in cui la loro abilità non sia più necessaria.
Oggi, come abbiamo già riferito nell'apposito capitolo,
la nostra capacità di effettuare trapianti di midollo osseo ci
permette di riconsiderare la chemioterapia. Se il midollo del
paziente, nell'avvelenare le cellule neoplastiche, viene inevitabilmente danneggiato, c'è una via di scampo, anche se ri178
schiosa. In ultima analisi, però, la chemioterapia non è la
soluzione al problema del cancro. Qual è, dunque, questa
soluzione? Certamente, oggi, le maggiori promesse vengono dalla immunomanipolazione, ed è questo che ora tratteremo.
Oggi si pensa che il cancro sia percepito dalla Natura,
quando colpisce i giovanissimi (sfortunatamente troppo di
frequente), come una minaccia per la specie. Secondo il
progetto della Natura, dovrebbe essere tipico degli anziani.
In età avanzata, il livello della nostra attività immunitaria si
abbassa e l'incidenza del cancro aumenta; tutto in modo
molto ordinato. Prima di quest'epoca, invece, il sistema immunitario può proteggerci, come effettivamente fa, in numerosi modi.
Mentre si ha una buona conoscenza dei linfociti T citotossici, dei linfociti killer e non killer (di cui abbiamo già
parlato), l'attenzione dei ricercatori è stata attirata di recente dal fatto che la maggior parte dei linfociti T, se non tutti,
indipendentemente dalla natura dell'antigene con il quale
sono entrati in contatto di giorno in giorno, può essere attivata per attaccare le cellule neoplastiche. È come se i linfociti che riconoscono il morbillo, assieme a tutti i loro fratelli, ricevano una seconda istruzione nel timo per uccidere il
virus del morbillo, o qualsiasi altro agente sia stato loro insegnato di riconoscere, in più per collaborare nell'attacco a
qualsiasi tipo di cellula tumorale che riescano a individuare.
Che cosa vedono tutti questi linfociti T quando vanno alla ricerca delle cellule neoplastiche? Non sappiamo. A questo punto l'osservazione è in vantaggio rispetto all'interpretazione, ma le osservazioni devono essere analizzate e capite.
Si immagini questa situazione. A un uomo è stato trovato
un melanoma sul petto; il chirurgo lo asporta, ma le analisi
dimostrano che il tumore si è già diffuso al fegato. A meno
che non si riescano a uccidere le cellule tumorali, il paziente
è spacciato. Ammettiamo di riuscire a risvegliare i linfociti
T in modo che convergano sul fegato per uccidere le cellule
179
metastatizzate del melanoma! Purtroppo, il nostro paziente
mostra una totale inerzia immunologica verso la sua grave
situazione.
Se riusciamo a prelevare dal suo organismo tutti quei linfociti T troppo compiacenti e a metterli in un'incubatrice
assieme a un poco di interleuchina-2 (il fattore ormonosimile, che i linfociti T induttori secernono per attivare i linfociti T killer), la loro capacità di riconoscere il cancro può benissimo attivarsi. Dopo alcuni giorni, la reintroduzione di
queste cellule può avere effetti immediati e drammatici. Le
cellule stimolate corrono come piccole sfere di nitrato d'argento verso le cellule tumorali presenti nel fegato e le uccidono.
Non sappiamo se questo fenomeno, indotto all'esterno
dell'organismo dall'interleuchina-2, avvenga normalmente
nelle persone sane e se serva a impedire che si ammalino di
cancro. Può darsi che sia così, ma il fenomeno descritto e
così utile clinicamente potrebbe essere del tutto artificiale.
In favore di quest'ultima eventualità vi sono osservazioni
secondo le quali la somministrazione dell'interleuchina-2 a
pazienti, nel tentativo di far sì che i loro linfociti uccidano
le cellule tumorali, non ha successo, in quanto le dosi necessarie per realizzare tutto questo sono troppo tossiche. Naturalmente, in un corpo che funzioni normalmente, dosi molto elevate di interleuchina-2 possono essere efficaci e possono venir liberate senza rischio solo in quei compartimenti
dove sono necessarie.
Così, l'osservazione che i linfociti T, prelevati dall'organismo e coltivati con l'interleuchina, possono uccidere le
cellule tumorali dopo reinfusione, ha avuto due pregi. In
primo luogo, essa ci ha fornito uno strumento potenzialmente molto utile da sfruttare nella lotta contro il cancro.
La ricerca per la messa a punto delle apparecchiature necessarie per prelevare dall'organismo grandi quantità di linfociti T e per coltivarli per giorni senza rischio, infine per
reintrodurli nel paziente, è a uno stadio molto avanzato e,
d'altra parte, sono in corso le prove cliniche. In secondo
180
luogo, però, essa ci costringe a prendere in considerazione i
soggetti normali e a vedere se la messa in moto della maggior parte dei linfociti T contro le cellule neoplastiche sia un
fenomeno naturale. In caso positivo, abbiamo bisogno di
sapere quale segnale la cellula neoplastica, presumibilmente
in modo non intenzionale, dà per scatenare una simile risposta. Un'altra proprietà straordinaria di queste cellule
che distruggono le cellule neoplastiche e che sono stimolate
dall'interleuchina-2 è che non hanno bisogno di vedere gli
antigeni del «sé» prima di uccidere.
Questa non è una considerazione solo teorica. Per esempio, pazienti con melanomi, con carcinomi intestinali e con
tumori ai reni già diffusi nel corpo li hanno visti scomparire
dopo reinfusione dei propri linfociti trattati con interleuchina-2. Oggi possiamo dire che in alcuni c'è stata una ricaduta dopo un certo tempo, mentre in altri, a diciotto mesi dalla conclusione della terapia, non è visibile alcun tumore. La
potenzialità di questo procedimento è incoraggiante.
Un'altra area di uguale se non maggiore interesse, nell'immunoterapia del cancro, riguarda l'impiego di anticorpi
monoclonali per attaccare le cellule tumorali. Lasciate che
ve lo spieghi con una storia neanche troppo fantasiosa, accaduta cinque anni fa.
Nancy osservava la radiografia del suo torace mentre
l'immunochirurgo le spiegava la situazione.
«Questa massa bianca che può vedere sul lato destro del
torace è cancro, provocato dalla sua abitudine, pateticamente antisociale, di fumare» le disse. Nancy sapeva che
aveva ragione, naturalmente. La gente saggia non fumava
più, ma lei non riusciva a resistere.
Il chirurgo continuò: «Guardi qui, Nancy. Il tumore ha
raggiunto lo stadio in cui sicuramente si è già diffuso nel
corpo. La chirurgia convenzionale non può far niente, ma
l'immunochirurgia sì».
Il chirurgo asportò dunque con notevole perizia il polmone di Nancy seguendo le tecniche tradizionali, ma a questo
punto fu utilizzata una nuova procedura terapeutica. Men181
tre un assistente ricuciva il torace di Nancy, il chirurgo lasciò la sala operatoria ed entrò nel laboratorio adiacente.
Su un banco, in questa stanza, c'era una gabbia contenente
otto topolini: essi avrebbero salvato la vita di Nancy.
L'immunochirurgo tagliò accuratamente, dal polmone
che aveva asportato, una parte del tessuto tumorale, lo introdusse in un apparecchio che lo frammentò in singole cellule, le quali vennero poi lavate in un liquido speciale, che
fornì loro anche il nutrimento. Aspirò, quindi, le cellule
neoplastiche in una siringa, alla quale appose un ago, avvicinandosi infine alla gabbia con i topi.
I topi - o meglio il loro sistema immunitario - avvenuta
l'inoculazione, si misero subito al lavoro. I linfociti si precipitarono immediatamente nella pelle per dare un occhio a
quel tessuto malefico appena messo lì. Alcuni esaminarono
le cellule tumorali e reagirono ai caratteristici antigeni che
videro. I linfociti B produssero anticorpi antiumani e i linfociti T accelerarono i tempi per scatenare un attacco.
Due settimane dopo l'operazione, Nancy era quasi rimessa dall'intervento, ma doveva ancora far fronte alla necessità di liberarsi delle cellule che non erano state eliminate chirurgicamente. I topi avevano ormai ucciso tutte le sue cellule tumorali. Ora, nella loro milza, c'erano linfociti B che
avevano prodotto e ancora stavano producendo anticorpi
contro questi antigeni specifici, che distinguevano le cellule
tumorali di Nancy.
A questo punto, l'immunochirurgo ritornò e fece dolcemente addormentare i topi, per poter asportare loro la milza. Mise tutti quegli organi in un mortaio, spappolandoli
per ottenere le singole cellule. Ne prelevò alcune tra milioni,
che lavò e pose in una provetta che saldò accuratamente.
Alla fine di quest'operazione, si concesse un po' di riposo,
guardando la provetta in controluce. Troppo piccole per essere viste a occhio nudo, le cellule della milza galleggiavano
ora in un liquido nutritizio. In mezzo a loro c'erano alcuni
linfociti B, che erano in grado di produrre anticorpi contro
il tumore di Nancy.
182
Anche nelle condizioni più favorevoli, i linfociti B vivono
solo alcuni giorni in laboratorio. Come farà allora questa
nuova razza di medico oncologo a trovare, tra milioni di
cellule presenti nella provetta, quei particolari linfociti B
che producono anticorpi contro il tumore di Nancy e niente
altro? Anche se un ricercatore le trova, come può separarle
e mantenerle in vita abbastanza a lungo da poter far loro
produrre una quantità di anticorpi sufficiente da raccoglierli e iniettarli nel corpo di Nancy perché uccidano le cellule
neoplastiche? Giustizia facile e, in un certo senso, romantica, sarà fatta grazie anche all'abilità delle stesse cellule neoplastiche. Queste permetteranno agli anticorpi del topo di
uccidere il tumore di Nancy.
Come ricorderete, abbiamo già detto che le cellule neoplastiche sono immortali: mettetele in una provetta, alimentatele e vivranno per sempre. I topi, come gli esseri umani,
si ammalano di una forma di cancro che colpisce le cellule
che producono anticorpi (plasmacellule). Questa forma di
cancro si chiama mieloma. Quando plasmacellule maligne
sono poste in provetta all'interno di un'incubatrice, vivono
per sempre; non per quattro giorni come i linfociti B normali. Le plasmacellule sono fabbriche di anticorpi: duemila
al secondo. Si ricorderà che le singole plasmacellule producono solo un tipo di molecola di anticorpo; cioè ciascuna di
queste fabbriche produce un unico modello. L'anticorpo
prodotto da un'unica cellula e la sua progenie identica (clone) prendono il nome di anticorpo monoclonale.
Se si prende una cellula tumorale e la si attacca mediante
glicolpolietilene a un linfocito B normale ma a vita breve,
l'informazione genetica che è stata attivata all'interno di
questa cellula migra nella plasmacellula. Al suo arrivo in essa, attiva a sua volta questa fabbrica di anticorpi, resa immortale, che comincia a produrre massicce quantità di quel
tipo di anticorpo che il linfocito B stava cercando di sintetizzare.
Prelevando linfociti B dalla milza dei topi che avevano
ucciso con successo le cellule polmonari neoplastiche di
183
Nancy e attaccandole alle plasmacellule neoplastiche, si forma un «ibridoma», reso anch'esso immortale e che produrrà letteralmente anticorpi a catinelle contro l'antigene, o gli
antigeni, che i linfociti B avevano riconosciuto come cancro-specifici.
I linfociti B dei topi sono attaccati alle plasmacellule.
Ogni nuova cellula viene messa in un po' di liquido in uno
scomparto separato e viene lasciata continuare a moltiplicarsi. Dopo alcuni giorni, l'immunologo e i suoi collaboratori saggiano un poco dell'anticorpo che viene prodotto per
vedere se quello che proviene da una particolare fusione
reagisce con le cellule neoplastiche di Nancy, delle quali, al
momento dell'intervento chirurgico, erano stati tenuti da
parte alcuni campioni.
Centinaia di campioni di anticorpi dei vari ibridomi vengono verificate fino a quando si trova un clone che produce
anticorpi che reagiranno contro l'antigene, o gli antigeni, di
differenziamento presenti sulle cellule polmonari neoplastiche di Nancy. Le cellule che producono questo prezioso anticorpo vengono isolate e il resto scartato. Viene rapidamente prodotto un notevole volume di liquido contenente
l'anticorpo puro, cioè l'anticorpo monoclonale contro
qualcosa che è esposto alla superficie delle cellule neoplastiche di Nancy, all'interno del suo corpo. Quando questo anticorpo sarà iniettato nel corpo di Nancy, si legherà a quelle
cellule neoplastiche e a niente altro.
Ora, se fosse tutto qui, sarebbe già una grande storia. In
realtà il nostro immunochirurgo può fare di più. Sa che gli
anticorpi sono specifici, ma che non uccidono molto bene le
cellule neoplastiche: possono trovare i tumori meglio di
qualsiasi altra cosa, ma non possono uccidere come fanno
altri agenti. L'immunochirurgo sorride mentre prepara un
cocktail tossico di anticorpi per il cancro di Nancy.
Ricordate la tragica storia del terrorista spietato, che voleva sopprimere un certo Jumbo pieno di innocenti? Consegnò alla sua innamorata una borsa piena di esplosivo, invece del danaro che le aveva promesso, dandole istruzioni su
184
come raggiungere un particolare aereo. Quindi si sedette comodamente e attese che il suo folle atto uccidesse tutti i passeggeri, compresa la fidanzata. Tutto quello che voleva da
lei era che raggiungesse l'aeroplano giusto: l'esplosivo
avrebbe fatto il resto.
L'immunochirurgo di Nancy aveva idee e capacità simili
a quelle del terrorista appena descritto. Radunò i colleghi
chimici, che presero gli anticorpi monoclonali, precedentemente preparati contro le cellule tumorali di Nancy. Gli anticorpi consistono in lunghe catene di amminoacidi con specificità di legame a un'estremità. All'altra estremità i chimici legarono solidamente tre killer.
Il primo killer fu la ricina, il veleno più potente per l'uomo: una volta che si lega con una cellula, questa non sopravvive. La sua notorietà risale a quando un agente del
KGB la usò per uccidere un diplomatico bulgaro. La punta
affusolata di un ombrello era stata immersa nella ricina e il
tizio, senza che potesse sospettare alcunché, venne colpito
in mezzo alla folla. Ebbe un collasso e morì nello spazio di
alcuni secondi.
Oltre alla ricina, l'immunochirurgo chiese ai suoi colleghi
di accoppiare all'anticorpo il clorambucile, un farmaco antitumorale estremamente tossico. Venne aggiunto anche un
poco di iodio radioattivo. Questo isotopo può essere preparato in modo che irradi in modo letale, ma solo per una distanza cortissima di una-due cellule. A questo punto, l'anticorpo monoclonale era pronto. Era un anticorpo in grado
di riconoscere con una precisione eccellente le cellule neoplastiche di Nancy, e solo quelle. Avrebbe liberato i tre killer (le tre tossine) solo in corrispondenza del bersaglio. Nessun'altra cellula sarebbe stata vittima, mentre nessuna cellula neoplastica avrebbe potuto nascondersi.
Nancy venne convocata e l'anticorpo di topo, caricato
con i tre agenti in grado di uccidere le cellule tumorali, fu
iniettato nelle sue vene. Il trattamento fu ripetuto a giorni
consecutivi e, a parte un po' di brividi e una sensazione di
freddo, non diede luogo a effetti collaterali. Le cellule tu185
morali morirono e Nancy guarì. Per essere superprudenti,
possiamo dire che le plasmacellule che producevano il prezioso anticorpo furono in grado di vivere. Se il cancro fosse
riapparso, quello stesso anticorpo poteva essere usato di
nuovo.
Fantascienza? Non proprio. Anticorpi monoclonali contro gli antigeni del differenziamento di cellule di melanoma
e di carcinoma umani, della mammella, del colon, dell'ovaia e del polmone sono stati prodotti e utilizzati in esseri
umani. Sono stati marcati con composti chimici e isotopi e,
in questo modo, hanno guarito alcuni animali dal cancro.
Abbiamo appena cominciato a perfezionare la nostra competenza clinica con gli esseri umani. Cionondimeno, si può
affermare che l'immunoterapia del cancro è oggi una
realtà.
È certo che il trattamento del cancro sarà rivoluzionato.
Forse, quando il cancro si sviluppa, il sistema immunitario
è colpevole; ma può anche darsi di no. In entrambi i casi,
sembra che esso voglia veramente aiutarci a vincere questa
importantissima battaglia di un corpo che è sempre in lotta.
186
6
Come affrontare L'AIDS
È il 1969. Un bambino negro di dieci anni cammina su e giù
per le tondeggianti colline della fertile piana del distretto
Mengo, in Uganda, vicino al villaggio dove abita. Chiunque, anche il più superficiale osservatore, può vedere che è
ammalato, distrutto, con quell'enorme pancione, caratteristico di chi è gravemente denutrito. Grossissimi linfonodi
gli hanno deformato il collo. Cammina zoppicando: sul piede sinistro ha un nodulo marrone-rossastro, ulcerato e sanguinolento, che ovviamente gli fa molto male. Altri noduli
di analoga natura, forse venti in tutto, sono presenti sul resto del corpo, ma non sono ulcerati.
La mamma lo ha portato dallo stregone, che ha tentato
di curarlo con differenti erbe. Ma nessuna ha avuto esito
positivo. La salute del bambino ha continuato a peggiorare
e altri noduli color porpora sono apparsi sulla sua pelle.
Quel «medico» che cura con le erbe è un uomo ricco di
esperienza e, benché non abbia mai mostrato alle persone
affidate alle sue cure la minima incertezza sulla sua onnipotenza, conosce i suoi limiti. Di recente ha visto molti casi
analoghi e pensa che il bambino probabilmente non riuscirà
a superare l'estate. Parla ai genitori della connaturata cattiveria di quel loro figlio e glissa per trovare un caso più adatto al suo talento.
Il bambino, naturalmente, non è cattivo: è solo la vittima
di una nuova, terribile, malattia, che si diffonde sempre più
rapidamente attraverso l'Africa tropicale. È stato infettato
187
da un virus letale, che può distruggere il sistema immunitario. Diciotto mesi prima era stato sottoposto a una trasfusione di sangue, dopo essersi ammalato gravemente per un
violento attacco di malaria. A causa di quest'infezione,
molti dei suoi globuli rossi erano andati distrutti ed era stato colpito da una grave anemia.
Come poteva sapere lo stregone che il sangue somministrato al fanciullo apparteneva a un uomo destinato anch'egli a morire per i danni provocati da un virus che aveva invaso le cellule del suo sangue? In seguito, il fanciullo ebbe il
sistema immunitario distrutto dallo stesso virus e divenne,
di conseguenza, facile vittima di una forma particolarmente
brutta di cancro, nota nel mondo occidentale come sarcoma
di Kaposi. Questa forma si manifestò nel ragazzo sotto forma di noduli color porpora, quei noduli di cui abbiamo
parlato prima.
Che cos'è dunque il sarcoma di Kaposi? Rispondiamo
alla domanda cominciando, innanzitutto, dall'uomo che
ha dato il nome alla malattia. Nel 1872, il dottor M. Kaposi, uno specialista ungherese in malattie della pelle,
scrisse un articolo in cui raccontava una terribile storia.
Descriveva, in particolare, un giovane uomo nel quale si
erano sviluppati noduli di colore marrone rossastro, dapprima sui piedi, poi sulle mani e quindi, ancora più rapidamente, su tutto il corpo. Kaposi commentava il caratteristico aspetto spugnoso di questi noduli e il fatto che, con
il tempo, mentre egli rimaneva smarrito senza sapere che
cosa fare, i noduli, specialmente quelli sul viso del paziente, cambiavano colore, tingendosi di rosso bluastro. Il giovane fu colpito anche da una febbre tubercolare, perse peso e, mentre le forze gli venivano meno, comparve una
diarrea sanguinolenta. Morì tossendo, soffocato dal sangue che gli aveva riempito i polmoni. Kaposi richiese
un'autopsia e, quando vide gli organi interni del morto,
notò che gli stessi noduli blu rossastri che erano disseminati sulla pelle si ritrovavano anche nel fegato, nei linfonodi,
nei polmoni e in molte altre sedi. Tutto ciò che Kaposi po188
té fare fu informare i suoi colleghi di questo strano quadro
patologico.
Nei primi ottant'anni circa di questo secolo, i medici del
mondo occidentale, che si occupavano di cancro, videro un
numero sufficiente di casi di sarcoma di Kaposi da poter
giungere a una conclusione sicura. La forma più aggressiva
e letale di questa rara malattia compariva nei pazienti immunodepressi; sembrava dunque che un indebolimento del
sistema immunitario li predisponesse a questa forma di
cancro.
Più recentemente è stato notato che il sarcoma di Kaposi
compariva in alcuni pazienti che avevano avuto un trapianto di rene. Per evitare il rigetto del nuovo rene, a questi pazienti erano stati somministrati farmaci tossici per i linfociti
T. Questa terapia ha il fine di mantenere l'equilibrio tra il
rischio di rigetto e il rischio che le infezioni prendano il sopravvento. Quando l'equilibrio è alterato le infezioni diventano troppo comuni e, in questa situazione, un paziente
può ammalarsi di sarcoma di Kaposi o di altre forme di
cancro. In simili circostanze, alla cessata somministrazione
di farmaci immunodepressori si è talvolta associata la reintegrazione del sistema immunitario, che può allora rigettare
il cancro.
Nel 1981, negli Stati Uniti, solo due casi di cancro ogni
10.000 riportati sono stati sarcomi di Kaposi. Questa forma
così aggressiva, pur rimanendo rara nel mondo occidentale,
era diventata però molto più comune in certe parti dell'Africa. Nei quindici anni precedenti al 1981, in molti paesi
africani, l'aumento era decuplicato.
Il sarcoma di Kaposi colpiva la popolazione negra, mentre venivano riportati pochissimi casi nelle popolazioni indiana e bianca di paesi come l'Uganda. Nella forma epidemica, infieriva sui giovani: la maggior parte delle vittime
era, infatti, al disotto dei vent'anni. Sappiamo oggi che,
agli inizi degli anni Settanta, era ugualmente diffuso in
Tanzania, nello Zaire e in Angola e si apriva la strada attraverso la fascia tropicale africana.
189
Alcuni medici e missionari si chiedevano perché una forma così rara di cancro, generalmente associata a una grave
immunodepressione (perlomeno nel mondo occidentale)
fosse così frequente in Africa. Nessuno poteva rispondere
alla domanda, anche perché pochi erano realmente interessati al fenomeno. A quell'epoca nessuno immaginava che la
strana epidemia di cui si parlava fosse l'inizio di quel flagello che oggi ha un nome: AIDS. In effetti, l'AIDS fu scoperto negli Stati Uniti e solo dopo un intenso lavoro investigativo le sue origini furono fatte risalire all'Africa tropicale.
Al Center for Diseases Control (CDC) di Atlanta, in
Georgia, gli epidemiologi (che sono i veri detective nel campo della medicina) e altri specialisti segnalano, mediante
rapporti che giungono loro dagli ospedali e da medici di tutto il paese, le infezioni che in una settimana qualsiasi colpiscono la popolazione degli Stati Uniti. Nell'aprile del 1981,
lo staff del CDC notò due strani rapporti, uno proveniente
da New York e l'altro da Los Angeles. Da ciascuna di queste città, giungeva notizia di omosessuali ammalatisi di una
grave forma di polmonite, provocata da Pneumocystis carimi.
Pneumocystis carinii è uno strano microrganismo. Non è
né un virus né un batterio, ma appartiene a un gruppo di
microrganismi, noti collettivamente come protozoi. Abbiamo già parlato di alcuni membri di questa famiglia, per
esempio degli agenti della malaria, della malattia del sonno
in Africa e di una malattia di cui soffrono comunemente gli
esseri umani, che vivono in stretto contatto con i gatti domestici. Pneumocystis carinii non è uno dei membri più potenti della famiglia. Non rappresenta alcun rischio per un
sistema immunitario normale, i cui linfociti T lo distruggono facilmente. Però trae spesso vantaggio dagli stati di immunodepressione e, quindi, può provocare un'infezione
grave, anche fatale, ai polmoni. Esso si può trovare spesso
nella trachea di individui sani, come se, nell'insediarsi lì,
«sperasse» in un qualche disastro immunologico che gli permettesse di calarsi fin nei polmoni, dove si svilupperebbe in
190
forma di minuscole cisti (da cui il nome). I polmoni degli
individui infettati da questo microrganismo si ammalano di
una grave forma di polmonite.
Nell'arco di due mesi, il CDC aveva avuto notizia di numerosi altri casi, tutti verificatisi in omosessuali. Tra questi
ce n'erano molti affetti non soltanto da questa caratteristica
forma di polmonite, ma anche dal sarcoma di Kaposi. Il
CDC ritiene oggi che i primi due casi di AIDS siano stati
quelli riscontrati nell'area metropolitana di New York nel
1978 e 1979. Entrambi riguardavano omosessuali, affetti
anche da sarcoma di Kaposi. I medici cominciarono subito
a chiedersi perché proprio negli omosessuali dovessero essere rilevate due gravi conseguenze dell'immunodepressione.
Quei giovani gay disperatamente malati di sarcoma di
Kaposi e di una grave forma di polmonite avevano sempre
goduto di buona salute e non avevano mai sofferto di gravi
malattie. Per mancanza di conoscenza specifica, si disse che
avevano acquisito una sindrome da immunodeficienza (sindrome è un insieme di sintomi e di segni, che permettono di
identificare una determinata malattia). Dall'espressione inglese Acquired Immuno Deficiency Syndrome è nato il termine AIDS.
Sappiamo ormai che l'AIDS è causata da un virus particolarmente dannoso, chiamato per ovvie ragioni il virus
dell'immunodeficienza umana (HIV, dall'inglese Human
Immunodeficiency Virus). Con questa informazione, le tesserine del gioco di pazienza sembrano inserirsi facilmente in
uno schema, mentre all'epoca in cui quei primi due casi venivano studiati negli Stati Uniti la questione era ancora
molto misteriosa. Certamente nessuno legava quegli strani
avvenimenti descritti su entrambe le coste degli Stati Uniti a
un qualsiasi avvenimento svoltosi in Africa.
Per quanto ne sappiamo, il virus responsabile dell'AIDS
causò i primi problemi in Africa, avviando così forse venti
o addirittura trent'anni fa l'invasione della popolazione
umana. I fatti fondamentali sono semplici: il virus dell'AIDS può distruggere il sistema immunitario di un indivi191
duo infettato, che può allora diventare facilmente preda di
malattie come il sarcoma di Kaposi e la polmonite da Pneumocystis carinii. Ma da dove proveniva la maggior parte di
quei virus micidiali? Come si erano trasferiti dall'Africa all'America? Perché negli Stati Uniti, e almeno inizialmente
in settantaquattro altri paesi, è stato un problema che riguardava soprattutto gli omosessuali?
Per approntare le risposte a queste domande, bisogna
prima di tutto rendersi conto che i virus continuano la loro
autotrasformazione genica con rapidità e senza tregua. I risultati della loro attività possono condurre allo sviluppo di
virus apparentemente di nuova marca. Questa apparenza,
tuttavia, può trarci in inganno, in quanto ciò che percepiamo come nuovo virus può, in realtà, non essere altro che
l'ultimo di una lunga fila di modelli continuamente migliorati.
Le migliori informazioni di cui disponiamo suggeriscono
che il virus che causa l'AIDS si sia evoluto da una serie di
prototipi meno fortunati e riteniamo che ciò sia avvenuto in
Africa. Un'attenta analisi della struttura del virus ci mostra
che appartiene alla famiglia dei retrovirus.
Questa famiglia ha numerosi rami. Ci si è resi conto per
la prima volta che alcuni suoi membri potevano essere patogeni quando abbiamo studiato alcune malattie negli animali. È risultato che certi retrovirus causano una fastidiosa infiammazione nel cervello dei cavalli, una malattia cerebrale
degenerativa negli ovini e la leucemia nei gatti. (La leucemia è una malattia in cui globuli bianchi specifici, nel sangue, cioè quei globuli coinvolti nella difesa dell'organismo,
e non nel trasporto di ossigeno, cominciano a dividersi in
modo incontrollato.) La ricerca ha poi posto molta attenzione alla leucemia dei gatti, in quanto responsabile annualmente della morte di milioni di questi nostri beniamini: un
vaccino commerciale avrebbe, naturalmente, un estremo
successo. Ciò che è emerso, in era pre-AIDS, era che i retrovirus tendevano ad attaccare i globuli bianchi e/o il cervello
e a danneggiare principalmente gli animali. Attualmente,
192
prove particolareggiate e schiaccianti suggeriscono che un
retrovirus in grado di infettare animali si sia mutato così da
poter infettare e quindi uccidere gli esseri umani.
Di solito, i virus animali non infettano gli uomini e viceversa. Come abbiamo visto parlando di parassiti, tutti i microrganismi invasori hanno un ospite favorito e, all'interno
di questo, una sede in cui preferirebbero risiedere. I cani
non si ammalano di influenza e gli esseri umani non contraggono il cimurro (anche se entrambi si ammalano di una
forma molto simile). Molti accettano oggi l'idea che un retrovirus degli animali abbia casualmente infettato, in Africa, alcuni giovani immunodepressi, che non lo hanno potuto eliminare con la facilità con la quale un virus patogeno
degli animali verrebbe distrutto da un sistema immunitario
umano sano.
Il primissimo caso noto di infezione da parte del virus
HIV si è avuto in un ugandese. Egli era già ammalato nel
1965, ma non si conosce la data d'inizio dell'infezione. I ricercatori che effettuavano lo screening del sangue, conservato da venticinque anni e raccolto originariamente per ricerche sull'epatite, trovarono l'HIV in un campione. Se
davvero il virus cominciò la sua marcia attraverso l'Africa
partendo dall'Uganda, allora le terribili privazioni imposte
dal regime di Amin, associate a malattie croniche, avrebbero facilitato questa diffusione. In effetti, la denutrizione e
la malaria sembrano cofattori molto importanti e potrebbero benissimo aver contribuito a creare un ambiente meno
che ostile per il virus, facendolo mutare in un agente letale
per l'uomo. Sappiamo che i virus possono acquisire virulenza permanendo in individui dotati di bassa resistenza e diventando a mano a mano più selvatici e più pericolosi. Alcuni dei prototipi dell'HIV raggiunsero una virulenza tale
che permise loro di infettare anche esseri umani sani.
In che modo il virus degli animali è entrato negli esseri
umani la prima volta? Certamente può essere stata responsabile l'ingestione di cibi di origine animale, specialmente
cervello e sangue non adeguatamente cotti. Vi sono prove
193
eccellenti che suggeriscono che l'immediato precursore del
virus dell'AIDS in Africa potrebbe aver infettato certe
scimmie e che esseri umani morsicati da questi animali potrebbero essersi infettati con il virus. Inoltre, in numerose
parti dell'Africa le scimmie vengono mangiate e il loro sangue bevuto.
È stato scoperto che i cercopiteci verdi dell'Africa tropicale sono infettati da un virus molto simile al virus dell'AIDS, che oggi sta devastando l'organismo umano. Questo virus non provoca però effetti patologici nelle scimmie.
Potrebbe essere lui quel virus che si è modificato una volta
entrato in alcuni esseri umani immunodepressi? Un altro
virus, strettamente imparentato con il virus dell'AIDS, infetta le scimmie della Guinea-Bissau e delle isole di Capo
Verde, esercitando effetti letali sui loro linfociti T. Vi sono, in effetti, oggi cinque tipi di virus isolati dai linfociti T
di esseri umani con l'AIDS: essi differiscono l'uno dall'altro per minuti, ma significativi, particolari. Tutti vengono
fatti risalire alle scimmie africane. I primi due scoperti sono stati chiamati HIV1 e HIV2; gli altri verranno indubbiamente classificati in modo analogo. Il 99 per cento dei
casi di AIDS in tutto il mondo è causato dall'HIV1 (in genere citato semplicemente come HIV), ma l'HIV2 sta progredendo. Si è diffuso dall'Africa al Portogallo e procede
verso il cuore dell'Europa, dove sta raggiungendo la Germania. Fino al momento in cui scrivevo queste pagine, esso non era ancora giunto negli Stati Uniti o nell'emisfero
australe. Il dottor Robert Gallo, uno dei maggiori esperti
in questo campo, pensa che molti retrovirus dei primati
siano mutati in organismi potenzialmente in grado di causare l'AIDS. Sappiamo che individui che hanno la sfortuna
di essere infettati simultaneamente da due virus che provocano l'AIDS muoiono più rapidamente di quelli infettati
soltanto da uno. Dai risultati delle recenti ricerche sembrano esservi pochi dubbi sul fatto che, in qualche fatidico
momento della storia della biologia, uno o più di questi virus dei primati sia penetrato nell'uomo, modificando le
194
proprie caratteristiche e dando così inizio a un vero e proprio flagello.
Il virus dell'immunodeficienza umana (HIV) si è sviluppato in Africa, dove è rimasto per forse venti o trent'anni,
prima di diffondersi quasi contemporaneamente nei Caraibi e in Belgio. Non si sa come raggiunse i Caraibi e perché si
stabilì in modo più evidente ad Haiti. Abbondano le congetture: secondo alcuni il virus sarebbe stato portato dalle
truppe di Castro che rientravano in patria dall'Angola; secondo altri sarebbe stato importato ad Haiti da poveri emigranti di questo paese, che ritornavano dall'Africa dove si
erano recati in cerca di lavoro. Non vi è alcun dubbio che il
virus è stato portato in Europa da visitatori delle ex colonie
africane (soprattutto da studiosi).
Da quando il virus dell'AIDS è stato introdotto ad Haiti,
con tutta probabilità agli inizi del 1978, gli avvenimenti che
hanno permesso lo sviluppo dell'epidemia nel mondo occidentale sono di gran lunga più chiari. Le particelle infettive
di HIV, come quelle di molti altri agenti infettivi, sono concentrate nel liquido seminale di individui infetti. È pertanto
facile, per un essere umano infettato dall'HIV, contagiare
un altro essere umano scambiando con esso il liquido seminale. Quasi sicuramente il virus è stato contratto da omosessuali americani in visita ad Haiti e poi trasportato nella
comunità gay di Manhattan e, quindi, con una sempre maggiore accelerazione, alle comunità gay di tutto il mondo.
Per capire la velocità con la quale l'infezione si è diffusa e
le dimensioni dell'epidemia che ne è risultata, si deve sottolineare che due sviluppi molto significativi, uno biologico e
uno sociale, hanno coinciso, quando addirittura non sono
entrati in collisione, creando una ricetta per il disastro.
Abbiamo già menzionato l'arrivo del virus dell'AIDS a
Haiti assieme alle caratteristiche che hanno determinato la
presenza e la vitalità dello stesso nelle secrezioni sessuali. Il
virus è anche presente nel circolo sanguigno e l'importanza
di tale fatto sarà presto evidente. L'avvenimento sociologico è stata la «rivoluzione gay», avvenuta nelle principali cit195
tà come New York e San Francisco e in molte altre città di
tutto il mondo. Questo fatto ha portato a nuovi costumi
sessuali che si sono rivelati una «via regia» per la diffusione
del virus.
A questo punto, prima di entrare in maggiori dettagli, è
meglio ricapitolare. Un virus che poteva danneggiare il sistema immunitario fece la sua comparsa alla fine degli anni
Sessanta e agli inizi degli anni Settanta tra gli africani poveri, denutriti e ammalati. Esso era presente in notevoli quantità nel sangue e nelle secrezioni sessuali. Fu confinato in
Africa per un certo tempo, quindi si diffuse quasi simultaneamente in Europa e ad Haiti. Ad Haiti contagiò per via
sessuale gay americani in visita sull'isola. Costoro lo portarono poi a San Francisco e New York, dove vigeva la massima libertà sessuale, e da qui l'epidemia si sviluppò nel mondo occidentale.
L'omosessualità deve essere comunque considerata come
un cofattore, ovvero solo uno dei modi della diffusione dell'AIDS. Se questa malattia continua a diffondersi nelle comunità gay di tutto il mondo, il già terribile tributo di morte (più di 60.000 individui oggi) aumenterà ancora e si raggiungeranno centinaia di migliaia di decessi. Per questa ragione, gli scienziati hanno dovuto togliere il velo della privatezza che generalmente avvolge le abitudini sessuali della
gente e analizzare molto al dettaglio il comportamento intimo degli omosessuali nella speranza di poter capire meglio
qual è la via di diffusione della malattia. Le strategie di prevenzione lo esigono tassativamente.
È necessario ovviamente che i nostri sofisticati meccanismi di difesa funzionino al massimo livello se vogliamo vincere la battaglia contro il mondo dei microbi. L'ignorare i
consigli per una buona nutrizione e il mangiare in modo così errato da privare le nostre difese di quelle sostanze nutritive che sono loro necessarie porteranno sicuramente a uno
stato di immunodepressione e a un maggior rischio di infezione. Analogamente, è indiscutibile che sia pericoloso e altrettanto innaturale drogare a più riprese i nostri corpi e in196
trodurre liquido seminale (specialmente se proveniente da
numerosi partner sessuali) nel tratto intestinale.
Questo giudizio non ha nulla di moralistico, a meno che
non si consideri il vivere secondo Natura, ovvero il seguire
le leggi della Natura, come la morale ultima, basilare. È un
fatto innegabile che, anche ignorando l'AIDS, molti, nella
nostra società, corrono seri rischi per la salute, in quanto,
per non rinunciare al piacere, si lasciano coinvolgere in attività che li mettono in condizione di prendere gravi infezioni
e di danneggiare il proprio sistema immunitario. Anche se
l'epidemia di AIDS ha indotto molti omosessuali a modificare il loro stile di vita, non c'è dubbio che i costumi sessuali esistenti fra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni
Ottanta hanno rappresentato un rischio reale. L'AIDS è solo uno dei numerosi problemi che possono emergere e che
sono emersi, anche se certamente è il più significativo. Mi si
lasci subito dire che molto di quello che ora riporterò vale
in ugual misura per buona parte dei rapporti eterosessuali.
Il liquido seminale può trasmettere agenti infettivi come
il virus dell'epatite B, il cytomegalovirus responsabile di
una malattia simile alla mononucleosi o peggiore, batteri
come Chlamydia e Gonococcus che causa la gonorrea, la
piccola spirocheta responsabile della sifilide e molti funghi
che provocano una grave forma di diarrea, se il liquido seminale in cui si trovano viene introdotto direttamente nel
retto. Ultimo, ma non il minore per i danni che provoca, è
un virus erpetico ubiquitario, che infetta almeno venti milioni di americani e può essere considerato oggi come l'agente patogeno più comune tra quelli trasmessi per via sessuale.
Come possono attestare milioni di omosessuali e di eterosessuali, l'herpes genitale è davvero un brutto guaio. Forse
il 20 per cento dei giovani negli Stati Uniti ne è colpito e il
tasso di infezione sta aumentando rapidamente. Uomini e
donne possono trasmettersi reciprocamente il virus. Un
omosessuale con un'infezione da virus erpetico all'ano soffre per la presenza in questa zona di vesciche estremamente
197
dolorose. La maggior sciagura, nell'herpes, è che in un caso
su tre non scompare dopo il primo episodio, ma ricorre a
intervalli più o meno regolari e queste sgradite riapparizioni
possono ripetersi per anni. Quando le lesioni sono recenti, è
improbabile che possa aver luogo un rapporto sessuale per
il dolore che provocherebbe, ma se, dopo un attacco, l'attività sessuale viene ripresa, il virus può ancora essere presente sulla superficie degli organi genitali o sulla mucosa rettale, pronto ad attaccare di nuovo.
Le gestanti con herpes genitale hanno un terribile problema. Nel 60-80 per cento dei casi, i loro figli, se partoriti per
via naturale attraverso la vagina, si infetteranno. E l'infezione erpetica nei neonati può essere fatale. Quindi, quando
si presenta una situazione del genere, il bambino deve essere
fatto nascere con parto cesareo.
La ragione per cui si parla adesso di questo argomento è
che si vuole sottolineare come, molto spesso, i rapporti sessuali con partner di cui si conosce poco, o addirittura niente, presentino gravi rischi. Uomini omosessuali con molti
amanti hanno quasi tutti sofferto di epatite B, sifilide, gonorrea, numerose infezioni batteriche intestinali, infezioni
fungine e herpes anale. Essi tendono a socializzare a notte
avanzata, fumano e usano droghe leggere. Naturalmente,
molti tra loro usano anche droghe pesanti che si iniettano
per endovena. La conseguenza di questo stile di vita è che
molti uomini omosessuali sono cronicamente malati e non
possono avere un sistema immunitario al massimo dell'efficienza, nel caso sfortunato in cui dovessero entrare in contatto con il virus dell'AIDS.
Sembra ormai certo che i gay americani andati in vacanza
ad Haiti siano stati infettati lì dal virus dell'AIDS trasmesso
attraverso rapporti sessuali con uomini del posto, molti dei
quali, essendo così poveri, si vendono per denaro. Non sorprende molto che, in metropoli come New York, l'infezione
nella comunità gay si sia diffusa rapidamente. La maggior
parte delle vittime della malattia afferma che, nell'arco della loro giovane vita, potrebbero esservi stati dai 500 ai 5000
198
differenti partner sessuali. Non è neppure insolito il numero
di trenta differenti partner sessuali al giorno.
Forse, l'analisi particolareggiata della vita di una delle
giovani vittime gay dell'AIDS può aiutare a comprendere le
dimensioni di una tragedia. James, disteso sul letto, pallido
e chiaramente esausto, aveva solo trentadue anni, ma ne dimostrava venti di più. Aveva perso di recente la vista, in
quanto un virus gli aveva infettato e distrutto la retina. Di
conseguenza, muoveva di continuo la testa, perché bisognoso di localizzare i suoni che gli giungevano agli orecchi.
Cercava di parlare, ma anche questo richiedeva uno sforzo
fisico che lo lasciava senza respiro; pertanto, il suo discorso
era punteggiato di boccheggiamenti per introdurre aria nei
polmoni, sebbene gli venisse somministrato ossigeno dal
naso. Un microrganismo gli aveva altresì infettato e distrutto la maggior parte dei polmoni.
La perdita di peso di quindici chili subita negli ultimi tre
mesi lo aveva reso emaciato, e la pelle delle braccia, che ancora di recente appariva abbronzata e tesa sopra muscoli
giovani e robusti, era pallida e inaridita. Da questo pallore
si stagliavano numerose macchie rotonde violacee, alcune
delle quali, rilevate rispetto alla superficie cutanea, formavano protuberanze ben distinte. Un attento esame rivelò
una lesione analoga all'interno della guancia.
Cellule tumorali si erano sviluppate nei vasi sanguigni cutanei e stavano ora moltiplicandosi e migrando fuori d'ogni
controllo: si trattava del sarcoma di Kaposi. Il paziente,
quando cercava di parlare, dava segni evidenti di incoerenza e di estraneamento dalla realtà. Grazie al cielo, egli era
solo parzialmente consapevole di quanto lo circondava e
della sua situazione. Era stato, infatti, infettato da un altro
microrganismo, il quale, non trovando alcuna resistenza da
parte di quelle forze difensive che combattono le infezioni,
gli aveva invaso il cervello e aveva prodotto quelle alterazioni mentali che ora apparivano così evidenti.
Il caso di cui abbiamo appena parlato è quello di un giovane, sensibile e intelligente avvocato. James esercitava la
199
professione in un piccolo studio legale nel Connecticut, che
lo occupava per tutta la settimana, ma nel weekend era libero. Era il secondo di tre figli. Il fratello maggiore, sposato
con due bambini, conduceva con successo una piccola impresa familiare. James era stato uno straordinario atleta a
scuola. La sorella minore aveva appena ottenuto il diploma
in amministrazione aziendale e tutto sembrava filare bene
per la famiglia.
Se qualcuno della famiglia avesse saputo che James era
gay (ed egli supponeva che sua madre lo sapesse), non lo
avrebbe mai ammesso davanti a lui. Negli anni recenti, essendo un chitarrista pieno di talento, aveva sviluppato una
simpatia più per la musica che per lo sport. Era snello e di
bell'aspetto, un poco fragile. Portava lenti spesse, che lo facevano apparire più serio e studioso di quanto in realtà
fosse.
Certamente non gli dispiacevano le donne. Si ricordava
di essere stato eccitato sessualmente da una donna un paio
di volte. Tuttavia, fin dal quindicesimo anno, si era reso
conto di sentire quelle sensazioni che suo fratello maggiore
descriveva così animatamente e frequentemente, molto più
in presenza di uomini che di donne. All'età di sedici anni
capì che la sua preferenza sessuale era per gli uomini.
In un sabato, o forse molti sabati, tra il 1979 e il 1981, incontrò una o più volte il virus che l'avrebbe ucciso. Essendo
scapolo e con una libera professione, poteva ora incontrare
in ambienti accoglienti, quando si recava a New York, uomini con le sue stesse tendenze. Considerava, dunque, le
sue avventure sessuali attuali soddisfacenti, civili e più sicure che non quelle dei primi tempi.
In passato, talvolta era stato preso da una forte passione
sessuale per persone totalmente estranee, perfino in una toilette. Ma, nel corso di una sua giornata tipica, le cose si
svolgevano oggi in modo molto diverso. A metà mattina si
recava in auto a New York. Entrava in una palazzina ad appartamenti, piuttosto anonima, e saliva tre piani di scale
senza difficoltà. Stava bene ed era pieno di vitalità.
200
L'ultimo piano dell'edificio era stato trasformato in
quello che a prima vista sembrava un club per la fitness del
corpo, frequentato da clienti di alto livello. Dopo aver usato la chiave per entrare, veniva accolto dal suono familiare
di una risata maschile e dal rumore degli schizzi, prodotti
dalle braccia che, battendo sull'acqua, spingevano in avanti
i corpi, solcando l'acqua clorata e l'aria umida ricca di vapore di questo solarium in cui egli si muoveva a grandi passi, perfettamente a suo agio.
Lungo il perimetro della sala vi era forse una dozzina di
spogliatoi, contenenti armadietti e una confortevole sedia a
sdraio per riposare in privato. Porte di legno a persiana vi
davano accesso; non avevano serrature. La maggior parte
degli uomini nella sala era nuda; pochi portavano pantaloncini corti o un costume da bagno. Non era, però, un gruppo
di giovani divinità della fitness: tutte le forme e le dimensioni, oltre a una vasta gamma di età, vi erano rappresentate.
James, con un rapido sguardo alla scena, riconobbe almeno
il 50 per cento delle persone presenti. Entrò in uno spogliatoio vuoto e si mise in costume da bagno.
Il suo primo amante quel giorno fu un vecchio amico con
cui, in molte occasioni, aveva avuto esperienze sessuali; si
ritirarono per il loro incontro nella privatezza di uno degli
spogliatoi. Altri, meno inibiti, facevano l'amore stesi sui
bordi della piscina. Certamente un'attrazione più che libidinosa lo portò, in quella sua prima riunione sessuale, non
solo a baciare sulla bocca il suo partner, ma a prendere in
bocca il suo pene e il seme, e a baciare con la lingua l'ano
dell'amante. Quasi certamente un'attrazione fatale dovette
spingerlo, prima della fine di quel giorno, ad avere altri
quattro rapporti sessuali, di cui due con estranei, uomini
che non aveva mai visto prima.
Durante la giornata si ricordò di un problema cui aveva
dovuto far fronte per due anni. Soffriva di herpes genitale:
minuscole lesioni simili a vesciche, situate vicino all'ano.
Non erano nelle condizioni peggiori, ma comunque erano
dolorose. Per accogliere il pene dei suoi amanti nell'ano,
201
usava molta crema come lubrificante per ridurre al minimo
il dolore. La crema conteneva cortisone e l'aveva acquistata
senza prescrizione medica dal farmacista.
Negli incontri appassionati di quel giorno, provò numerosi orgasmi. Con ciascuno dei suoi amanti esperti, aveva il
tempo, all'avvicinarsi del momento, di aprire una piccola
capsula contenente nitrito di amile, un farmaco che inalava
attraverso il naso e che gli faceva sentire tutto il corpo infiammato da una calda sensazione; quando riusciva a calcolare i giusti tempi, questa sensazione coincideva con gli orgasmi: l'intensità del piacere era straordinaria.
Al culmine dell'eccitazione sessuale, quel giorno, uno dei
suoi amanti, per aumentare il piacere che stava provando,
si girò e spinse il pugno nell'ano ben lubrificato di James.
Questi avvertì un dolore per il notevole stiramento e per la
lacerazione di alcuni dei delicati tessuti attorno all'ano, che
gli provocò una piccola emorragia. Tuttavia, accettò di
buon animo quella sofferenza perché il piacere sessuale superava di gran lunga il dolore fisico che provava. Alla fine
della giornata, cinque uomini diversi gli avevano scaricato
nel retto il loro liquido seminale ed egli aveva restituito il
favore a tre di loro.
James si fece una doccia, lavandosi meticolosamente, come fecero gli altri presenti. Ritornò nel Connecticut, soddisfattissimo dei piaceri della giornata, già prevedendo altri
incontri con quegli uomini, soprattutto con quelli che aveva
incontrato per la prima volta. Egli voleva che Robert, l'uomo con cui aveva vissuto da quattro anni, venisse a New
York e condividesse con lui queste esperienze. Ma Robert
non era interessato, non amava sperimentare, non voleva
prendere farmaci e desiderava soltanto una tranquilla vita
monogamica.
Mentre guidava lungo la strada a pedaggio del Connecticut, James pensava a uno degli uomini con cui aveva avuto
un rapporto quel giorno. Appassionato, certamente; con
una normale prestazione, sì; ma, a parte tutto questo, certamente non in buona forma. Era sicuramente troppo ma202
gro e poi i suoi occhi erano spenti. Era solo la sua immaginazione, o quell'uomo era depresso? E poi c'erano sulle sue
mani quei due strani noduli rosso-violacei. James non aveva mai visto nulla di simile prima.
Ora, James è morto e Robert sta morendo. Non può esservi altra conclusione di quella che James ha trasmesso al
suo partner fedele una infezione letale.
Riesaminando l'attività di James nella giornata appena
descritta, vengono messi in evidenza alcuni dei fattori di rischio che contribuiscono alla diffusione dell'AIDS. L'agente infettivo capace di provocare l'AIDS è presente nelle secrezioni sessuali. James ricevette quelle secrezioni nella bocca e nel retto. Mentre la pelle, fino a quando la sua integrità
non viene infranta, è una barriera eccellente e quasi impenetrabile, le mucose, rivestimenti sottili, lisci e sempre umidi, che tappezzano l'interno della bocca e il lume intestinale, sono proprio l'opposto, essendo state progettate per facilitare l'accesso di materiali nelle aree vitali del nostro corpo. Nell'intestino esse assorbono liquido e sostanze nutritive dal cibo digerito. Virus e molti altri agenti infettivi penetrano facilmente in esse. La Natura non è stata così folle da
lasciarle senza protezione e abbiamo già parlato del ruolo
speciale svolto dal sistema immunitario secernente. È certo,
tuttavia, che, per numerosi organismi, il nostro rivestimento protettivo interno rappresenta un'eccellente via di penetrazione.
Per assorbire le sostanze nutritive provenienti da una
buona cena a base di carne arrosto, l'intestino tenue fa dilatare i vasi sanguigni che lo irrorano. A mano a mano che
questi vasi aumenteranno di dimensione, una quantità sempre maggiore di sangue scorrerà nella zona. Di conseguenza, venendo stimolato il metabolismo, si noterà un aumento
della temperatura di tutte le cellule attorno. La membrana
di molte di queste cellule si stirerà e, sulla superficie esterna, si apriranno minuscoli pori, che permetteranno ai fattori nutrizionali che devono essere assorbiti e ad altre sostanze di passare selettivamente dal lume intestinale al sangue.
203
Una volta qui, questi fattori potranno essere o trasportati
via rapidamente per un impiego immediato o immagazzinati nel fegato.
Lo stesso aumento nel flusso sanguigno e nella facilità di
assorbimento di sostanze chimiche (e, ovviamente, di virus
opportunisti) si osserverà dopo l'uso di nitrito di amile.
Questo farmaco fa dilatare i vasi sanguigni, dando quella
sensazione di calore che, secondo alcuni, fa aumentare il
piacere sessuale.
Non occorre molta immaginazione per riconoscere, in
quanto appena detto, alcuni fattori di rischio per James.
Probabilmente il liquido seminale che gli è stato riversato in
bocca o nel retto proveniva da un uomo affetto da AIDS; la
dilatazione dei vasi sanguigni ha poi facilitato la penetrazione nel suo corpo del virus e di altri microrganismi mortali.
Se si tiene conto poi che le superfici delle sue mucose erano
già lesionate per la presenza di herpes genitale e che il suo
modo di fare l'amore era davvero traumatico, appare evidente che James invitava realmente il suo ospite mortale a
entrare. La crema a base di cortisone che lui e molti omosessuali usano come lubrificante anale prima del rapporto
non avrebbe certo favorito i meccanismi di difesa locali, dato che il cortisone deprime il sistema immunitario.
E allora, quali sono le conclusioni? Un nuovo virus, potenzialmente letale per gli esseri umani, vive in Africa per
un certo periodo di tempo, quindi rapidamente migra ad
Haiti e, per finire, nelle popolazioni gay degli Stati Uniti. A
questo punto, sappiamo che si trova nel liquido seminale e
che penetra nel corpo degli omosessuali attraverso l'intestino. Se, dunque, il virus può essere trasmesso sessualmente
agli uomini, che dire delle donne?
Ho saputo molto presto, nella storia dell'AIDS, che le
donne non erano esenti da questa sciagura. Poco dopo aver
avviato a Yale i nostri studi clinici e la ricerca sulla malattia, incontrai una coppia fuori dall'ordinario, che mise in
atto un esperimento terribile e decisivo.
Jane e Barbara erano due lesbiche, che avevano vissuto
204
assieme da tre anni nel nord del Connecticut. Sembravano
soddisfatte della loro relazione e mi assicuravano che si
trattava di un rapporto stabile. La loro più grande frustrazione nella vita era l'impossibilità di avere un figlio («di
rendere il nostro matrimonio normale» dicevano) e, in questo campo, ma in nessun altro, ammettevano che gli uomini
erano utili. Dato che anche l'adozione era fuori questione,
giunsero a una soluzione che, mi assicuravano, era frequente tra le coppie lesbiche.
Jane e Barbara conoscevano molti gay. Cominciarono a
cercare un padre genetico, adatto per il bambino che Barbara aveva deciso di avere (Jane, naturalmente, sarebbe stata
il padre putativo). Erano essenziali gli occhi azzurri e i capelli biondi; su questo erano molto d'accordo. Alla fine, si
decisero per un bel giovane di nome Tom.
Jane chiese a Tom se voleva aiutarle ad avere quel bambino tanto desiderato. Egli rimase stupefatto e nel tempo stesso lusingato, anche se, naturalmente, la cosa non gli interessava affatto sotto il profilo sessuale. Fu stabilito che si
sarebbe recato nel loro appartamento la sera successiva,
quando, in base alle indagini fatte da Jane, Barbara doveva
essere, con il suo ciclo, nel periodo di massima fecondabilità. Tom si masturbò in una bacinella, il suo liquido seminale fu aspirato in una piccola siringa ed egli fu libero di andarsene.
Jane aveva saputo che la fecondazione viene facilitata se
l'ovulo incontra lo sperma al momento dell'orgasmo. Pertanto prese la siringa con il seme di Tom, la portò in camera
da letto e fece l'amore con Barbara. Quando sentì che Barbara stava raggiungendo l'orgasmo, le infilò la siringa nella
vagina quanto più profondamente possibile e le inoculò il
liquido seminale. Questo copione fu ripetuto esattamente
per sei sere di fila e Tom ogni sera veniva a dare il liquido
seminale.
Chiese 50 dollari per il disturbo le ultime tre volte. Li ottenne. Ma Barbara non rimase incinta; in compenso fu infettata dal virus dell'AIDS.
205
Questo caso, naturalmente, sta a dimostrare che, se un
uomo è infettato dal virus dell'AIDS e ha un rapporto sessuale normale con una donna, la donna è esposta a un rischio enorme di contrarre la malattia. Il virus dell'AIDS,
una volta nel canale genitale della donna, può da lì diffondersi nel resto del corpo, dove provoca il danno.
Il liquido seminale in bocca, particolarmente quando viene deglutito, si deve presumere che sia infettivo, mentre il
liquido seminale eiaculato nel retto di una donna è, da un
punto di vista infettivo, non meno pericoloso di quanto lo è
per l'uomo.
Dopo aver letto questa storia, non vi sorprenderà sapere
che, in numerosi paesi, donne sposate con mariti sterili si rivolgono alle banche dello sperma. Lo sperma raccolto dalla
banca viene inseminato artificialmente nella donna che desidera rimanere incinta e, in molti casi, questo tentativo ha
successo. Molte banche dello sperma, però, pagano i donatori. Di conseguenza, non è raro che il guadagno sia la ragione principale, anche se non l'unica, per cui un uomo decide di donare il proprio sperma. Triste a dirsi, negli anni
recenti, numerosi donatori erano infettati dal virus HIV.
Poiché anche la cronistoria più accurata e l'esame più minuzioso del donatore non hanno potuto rivelare questa situazione, numerosi campioni di sperma contenenti il virus
vivo dell'AIDS sono stati inseminati in donne in molte parti
del mondo. Di esse, numerose donne si sono ammalate.
Se gli uomini possono infettare gli uomini e gli uomini le
donne, che dire della trasmissione del virus dalle donne agli
uomini?
Hermann era un ingegnere tedesco che lavorava, negli
Stati Uniti, a un progetto per la propria società. Quel lavoro lo avrebbe trattenuto nella parte nordorientale dell'America per un paio di anni. La costruzione nella quale
svolgeva un ruolo importante stava procedendo a grandi
passi e solo una volta all'anno aveva il tempo per ritornare
a casa per alcune settimane. Hermann e la sua famiglia
avevano già provato questa lontananza prima: analoghi
206
progetti lo avevano occupato in Asia e nell'Africa settentrionale.
Hermann amava sua moglie, come pure i loro tre figli. In
sedici anni di matrimonio, non aveva mai pensato di tradirla, perlomeno non secondo la definizione che lui dava della
parola. Un diversivo con una prostituta era un'altra cosa.
Sedici mesi prima che lo incontrassi, Hermann era arrivato negli Stati Uniti e due mesi dopo il suo arrivo si era scelto
con cura una prostituta. Faceva sempre così, mi disse. Trovane una che ti piace, rassicurati che sia pulita e compatibile e attaccati a lei. In ogni caso, i clienti regolari ottengono
un miglior trattamento. Sapeva che Priscilla, la ragazza che
aveva scelto, si bucava. Ma non erano forse tutte tossicodipendenti? Comunque, era certo che egli non voleva entrare
nel giro della droga.
Si trovava bene con lei. Era una negra e gli piacevano le
donne nere. Lei gli insegnò il sesso anale; ebbero sei rapporti di questo tipo in un periodo di quattordici mesi. Alla fine,
successero due cose. Nelle settimane immediatamente precedenti al nostro incontro, Hermann non era stato bene.
Aveva notato un rigonfiamento delle ghiandole sotto le
braccia e all'inguine e qualche volta, durante la notte, era
stato preda di abbondantissime sudorazioni. Non sapeva
nulla dell'AIDS. Due giorni prima di venire da me aveva
avuto l'ultimo rapporto con Priscilla ed era successa una
cosa terribile: lei gli aveva rubato il portafoglio.
Egli si sentiva ingannato; quindi, molto infastidito e senza alcun senso di imbarazzo, chiamò la polizia. Catturarono di sorpresa la giovane, che aveva ancora il portafoglio
nella borsa, e la portarono in prigione.
All'inizio, naturalmente, non sapevamo che cosa Hermann avesse, ma avevamo seri sospetti. Di sicuro, i suoi linfociti T avevano quelle alterazioni caratteristiche riscontrabili in soggetti infettati dal virus dell'AIDS. Una volta conosciuta la storia, ci mettemmo in contatto con il medico
della prigione, che fu molto comprensivo e ci inviò Priscilla
per un controllo. Costei giunse alla clinica con le manette
207
alle mani e ai piedi (un po' eccessivo, pensammo). La sottoponemmo a un test e trovammo che era infettata dal virus
dell'AIDS.
Hermann decise di rientrare in Germania ed attendere lì
la sua sorte. Visse altri due anni. Lo vidi soltanto una volta
sei mesi dopo, quando inaspettatamente piombò nella mia
clinica. Era ritornato dalla Germania, malato e conciato com'era, per testimoniare contro Priscilla. Egli aveva un rigoroso senso del dovere. Priscilla aveva ottenuto la libertà
provvisoria. La sentenza del tribunale la condannò a sei
mesi, ma non scontò neanche un giorno. Venne liberata per
ragioni di salute e scomparve. A questo punto, naturalmente, la sua situazione sanitaria era nota, e nessuno, nel carcere locale, voleva avere a che fare con una vittima dell'AIDS.
È evidente da quanto sopra riportato che è uno sbaglio
pericoloso definire l'AIDS la «peste dei gay»: il virus dell'AIDS non ha affatto preferenze sessuali. Negli Stati Uniti
e in molti paesi occidentali il serbatoio contenente il virus
fu, per qualche tempo, isolato all'interno della comunità
gay e i membri di questa si infettavano l'un l'altro.
Dall'inizio della storia dell'AIDS, invece, in Africa è successo il contrario. Qui la maggior parte delle infezioni aveva avuto luogo nel corso di rapporti eterosessuali. La malattia continua a diffondersi in questo modo con una velocità allarmante. Studi recenti su come l'AIDS stia propagandosi in modo strisciante attraverso l'Africa mostrano il
grande pericolo che potrebbe sorgere, per la diffusione della malattia tra gli eterosessuali della società occidentale, se,
in questa popolazione, si costituisse un serbatoio importante di HIV.
In Africa, parecchi milioni di persone sono infettati con
l'HIV e sono interessate almeno ventiquattro nazioni di
quel continente. Maschi e femmine sono infetti in uguale
misura e il 90 per cento di loro, a parte l'attività eterosessuale, non presentano alcun fattore di rischio identificabile.
In paesi in cui la questione è stata studiata, i pazienti infet208
tati con l'HIV hanno avuto una media di trenta differenti
partner sessuali, mentre quelli che non risultano infetti solo
quattro.
In parecchi di questi paesi, il tasso di infezione tra le prostitute è molto elevato. Il 43 per cento delle prostitute nel
Ruanda è infettato con l'HIV, mentre in Uganda e nel Kenya sono state registrate percentuali ancora più elevate. In
alcuni studi, è risultato infetto fino all'81 per cento delle
prostitute, che pertanto possono diffondere la malattia. Si
stima che, in un anno qualsiasi, una prostituta infetta potrebbe trasmettere la malattia ad almeno cinquanta clienti.
Un terzo delle vittime da HIV in Africa ha avuto perlomeno un'altra malattia trasmessa per via sessuale e sembra
probabile che l'attività sessuale svolta casualmente e il frequente ricorso a prostitute siano responsabili della maggior
parte dei casi africani.
Sembra che le donne africane siano infettate dagli uomini
più facilmente delle donne di alcune società occidentali. Si
ritiene che questa sia una conseguenza probabile della frequenza con cui le donne africane, malnutrite e spesso ammalate, contraggono ulcerazioni agli organi genitali e all'utero: queste lesioni renderebbero più agevole la penetrazione del virus nelle mucose e quindi l'accesso all'interno dell'organismo.
Dopo che l'AIDS arrivò a New York e a San Francisco e
fu identificata come una malattia trasmessa per via sessuale
all'interno della comunità gay, la gente si rese conto rapidamente che questo non era l'unico modo in cui la malattia si
poteva diffondere. Per capire la successiva bomba epidemiologica che fece esplodere l'AIDS al di fuori della popolazione gay, dobbiamo vedere come il virus dell'AIDS provoca un danno così grave al sistema immunitario.
Per evitare confusioni, devo ora spiegare perché il virus
che causa l'AIDS, cioè quel particolare retrovirus di cui abbiamo parlato così a lungo, ha subito un cambiamento di
nome. Agli inizi dell'epidemia, venne chiamato HTLV III.
Il nome era impreciso, ma può darsi che qualcuno abbia co209
nosciuto il virus così, quando questa terminologia era in
uso. Il nome si compone delle iniziali delle parole Human T
Cell Leukemia Finis. Poiché è del tipo III, ci devono anche
essere i tipi I e II.
I tipi I e II provocano la leucemia (cancro dei globuli
bianchi del sangue) negli esseri umani, anche se raramente.
Il tipo I provoca una leucemia che interessa i linfociti T; il
tipo II una leucemia che interessa i linfociti B. Questa è
davvero peculiare. I linfociti B sviluppano protuberanze superficiali che, al microscopio, appaiono come peli, dimodoché questa forma di leucemia è anche detta «leucemia dei
linfociti pelosi». Benché siano entrambe provocate da retrovirus, le due malattie non sono strettamente correlate
con il virus dell'AIDS, anche se, agli inizi, le ricerche avevano erroneamente suggerito che forse questa correlazione
stretta c'era.
Quando ricercatori francesi che cercavano di isolare il virus lo trovarono nei linfonodi rigonfi di soggetti infettati
dall'agente che provoca l'AIDS, lo chiamarono LAV, cioè
virus associato a linfoadenopatia, cioè al rigonfiamento dei
linfonodi (Lymphadenopathy Associated Virus). Per evitare confusione, gli scienziati si sono poi fissati sul nome HIV
(Human Immunodeficiency Virus), oggi universalmente accettato.
Sembra che il virus HTLV I sia vissuto per tre secoli o più
nel Giappone meridionale, causando problemi solo in quel
paese, fino alla conclusione degli anni Sessanta, quando
passò in Giamaica, negli Stati Uniti e in Israele; oggi si trova nella maggior parte dei paesi.
Quando il virus HIV è introdotto nel retto, si attacca alle
cellule del rivestimento del lume intestinale e passa nei vasi
sanguigni che lo irrorano. Il passaggio del virus può essere
facilitato da lesioni locali. Qualche virus può portarsi nei
linfonodi locali e fermarsi lì; qualche altro rimane nel circolo sanguigno.
Come fa il virus HIV a distruggere il sistema immunitario? Sembrerebbe che i cambiamenti evolutivi che distin210
guono il precursore del virus dell'AIDS, presente nelle
scimmie, dal virus HIV, che infetta gli esseri umani, siano
stati progettati da qualche virus «architetto» che conosceva
bene l'immunologia umana, tanto ingegnose sono le modificazioni apportate. Eppure, in termini biologici, questi
trionfi chiaramente meritati assomigliano a quelli di un uomo che, non avendo alcuna idea di quale sia la combinazione di una cassaforte, continua a girare pazientemente a caso
la manopola fino a quando, improvvisamente, fa la combinazione giusta e la cassaforte si apre.
La giusta combinazione permette al virus di aprirsi un
varco nella membrana di un linfocito T4 e di penetrare in
esso.
Il virus HIV è circondato da un involucro costituito da
proteine specifiche, una delle quali sporge dalla superficie
sotto forma di sonda. La forma fisica di questa sonda è
l'immagine speculare di una proteina, chiamata C D 4 , che si
trova sulla superficie dei linfociti T umani, che lanciano
l'allarme. Le due strutture complementari permettono al virus e al linfocito T di «agganciarsi» come veicoli spaziali.
La sonda dell'involucro del virus si comporta come fosse
una chiave che si inserisce in una serratura molto specifica,
presente sulla membrana di un linfocito T. Un tale legame
intimo con la membrana del linfocito attiva in questo dei
meccanismi, che sono programmati per far entrare nella cellula sostanze chimiche, aventi il diritto di conoscere la combinazione. Generalmente si tratta di elementi nutritivi. I linfociti T4 inglobano, dunque, involontariamente il nemico.
Mai prima un virus, che può essere riconosciuto o distrutto solo se i linfociti T4 lanciano l'allarme, avrebbe fatto in modo di darsi un vantaggio per la sopravvivenza attaccando direttamente il nemico. Una volta al sicuro, all'interno della cellula, il virus perde l'involucro e dà inizio alla fase successiva.
Tutta l'informazione genetica dell'HIV è contenuta nell'RNA, un linguaggio proprio dei virus, ma non delle cellule umane. Queste utilizzano un programma scritto nel
211
DNA. Normalmente i messaggi in linguaggio RNA e DNA
sono incompatibili tra loro, ma il virus vuole comunque utilizzare il linfocito T per riprodurre se stesso. Per far questo
deve procurarsi un messaggio in DNA, contenuto nel computer (nucleo) del linfocito, e modificare le istruzioni già
codificate. Porta con sé un enzima (la transcriptasi inversa),
che modifica il programma; in altre parole, il messaggio in
RNA diventa un messaggio in DNA, che viene inserito nel
nucleo del linfocito T. Questo non ha ormai alcuna scelta se
non quella di trasformare la propria fabbrica in modo che
possa produrre particelle di HIV. Per ciascun virus che entra in un linfocito T, ne sarà prodotto un migliaio di copie
identiche. Quando questi nuovi virus, pigiati all'interno del
linfocito parassitato, cominciano ad aprirsi un varco per
uscire, rompono la membrana e, in questo modo, uccidono
la cellula.
L'HIV ha così attaccato e ucciso il nemico, ma non prima di averlo fatto vivere abbastanza a lungo da produrre
nuovi virus, in grado di uscire dal linfocito e di andare a parassitare altri linfociti T. Queste proprietà del virus lo rendono da una parte attraente e dall'altra terrorizzante e possono permettergli di uccidere lentamente, ma senza remore,
ogni linfocito T presente nel nostro organismo.
Un'ultima caratteristica dell'involucro merita di essere
approfondita. A parte la sonda già menzionata, il resto dell'involucro modifica costantemente la propria struttura. È
questo un espediente ben noto in parassiti come quello della
malaria. Il termine tecnico per questo fenomeno è «mascheramento (drift) antigenico» e il suo significato sarà subito
chiarito. Le cellule del sistema immunitario riconoscono
una struttura specifica e chiedono aiuto ad altre cellule in
grado di attaccare questa particolare conformazione tridimensionale. Se scatta l'allarme per attaccare il virus che ha,
ad esempio, l'involucro rosso, e questo cambia di colore diventando blu prima che gli attaccanti arrivino, il virus riesce a sfuggire alla mischia. Vale la pena di analizzare nei
particolari questi attributi biologici del virus, in quanto,
212
una volta che la gente si è resa conto della sfida che esso
lancia, può capire perché sia improbabile che il progresso
della scienza medica nell'individuare un metodo di cura sia
rapido. Pertanto l'enfasi immediata deve essere posta sulla
prevenzione dell'infezione da HIV.
Abbiamo già incontrato virus che si sono evoluti fino a
un punto in cui potevano, almeno temporaneamente, danneggiare parte del sistema immunitario. Per esempio, il virus di Epstein-Barr, che causa la mononucleosi, può danneggiare i linfociti B, ma alla fine i linfociti T uccideranno
tutti i linfociti B infettati e, in questo modo, elimineranno il
virus. In confronto al virus dell'AIDS essi sono dei dilettanti.
Dal punto di vista biologico, ciò che è realmente significativo riguardo all'AIDS è il fatto che un virus abbia imparato come paralizzare il sistema immunitario eliminando
l'unica cellula veramente decisiva in questo sistema di attacco. Un essere umano in buona salute possiede in circolo dai
200 ai 300 miliardi di linfociti T4, ma, per quanto enorme
questo numero possa sembrare, la verità biologica è che gli
adulti non sono più in grado di produrne altri. Raggiunta
l'età adulta, il timo si è messo a riposo.
Lentamente, ma senza indecisioni, il virus comincia a far
diminuire il numero di linfociti T nel sangue. Dall'avere
1000 o più linfociti T in ogni minuscola goccia di sangue,
l'organismo può passare gradatamente a non averne assolutamente alcuno, quando il virus dell'AIDS svolge a puntino
il suo lavoro. Un simile danno non è prodotto in una sola
notte, ma la malattia e il suo lungo periodo di incubazione
sono compresi meglio se si considera che, per molti pazienti
colpiti dal virus dell'AIDS, ad ogni tic tac dell'orologio
vanno distrutti alcuni linfociti T. Verrà inevitabilmente il
giorno in cui non saranno rimasti sufficienti linfociti T per
proteggere l'organismo e l'AIDS si renderà manifesta.
Dobbiamo ora parlare del sangue infetto. Il sangue delle
vittime dell'AIDS è altrettanto infetto, se non di più, del liquido seminale. Esso contiene linfociti T4, questi contengo213
no il virus e pertanto la malattia può essere diffusa se il sangue contenente linfociti T4 infetti viene introdotto in un organismo.
Così, poco dopo la comparsa dell'AIDS e l'aver rilevato
il suo legame con il comportamento sessuale, la stessa sindrome è comparsa tra i tossicodipendenti che si bucano, tra
gli emofiliaci e tra coloro che hanno ricevuto una trasfusione di sangue infetto.
I miei primi pazienti con AIDS contratta in seguito all'uso di droga per via endovenosa furono Peter e Jo, marito e
moglie.
Non erano tossicodipendenti tipici; sembravano dall'aspetto esteriore persone di successo e felici. Peter curava
una rubrica per una catena di giornali su scala nazionale, in
cui dava consigli su come mantenere le piante in casa. Jo
era infermiera psichiatrica, molto coinvolta dalla sua professione e occupata a tempo pieno presso l'Istituto di psichiatria dell'Università. Non avevano figli.
Jo aveva cominciato a usare eroina fin dai tempi dell'università. Ricorda di essere stata atterrita dal mondo della
droga per quasi tutto il periodo degli studi e, infatti, solo
nell'ultimo anno era caduta in quella morsa, purtroppo
sempre più diffusa. Una sera, dopo aver fatto l'amore, il
suo ragazzo le disse di aver trovato che l'eroina dava all'atto sessuale un piacere ancora più intenso e insistette perché
provasse a condividere quell'esperienza con lui. Lei lasciò
che le iniettasse un poco di eroina, la quale evidentemente
ebbe l'effetto descritto.
Per molti mesi essi continuarono a prendere insieme l'eroina dopo aver fatto l'amore e così, insidiosamente, diventarono tossicodipendenti. Alla fine, Jo ruppe la relazione,
ma non interruppe l'uso della droga. Poco dopo la fine di
questa storia Peter entrò nella vita di Jo, la quale lo introdusse a sua volta agli stessi piaceri e orrori.
Al nostro primo incontro, la loro tossicodipendenza era
in una certa misura sotto controllo. Dati i costi enormi che
implicava la loro abitudine di prendere eroina tutti i giorni,
214
si erano messi a regime. Questo consisteva in una terapia di
mantenimento giornaliera, a base di metadone (un narcotico preso per bocca), che Jo rubava nell'ospedale dove lavorava. In tal modo, si mantenevano piuttosto bene dal lunedì
al venerdì, ma durante i fine settimana si concedevano il
lusso di andare per conto loro a New York, in una sala da
tiro. Tutti i sabato mattina partivano in macchina dalla loro casa di campagna nel Connecticut e si recavano a New
York. Lì, in una delle parti più povere di Brooklyn, in una
sala da tiro che, secondo la loro stessa testimonianza, era
cadente e trascurata, erano soliti comprare l'eroina.
Erano consapevoli dei rischi d'infezione associati con la
tossicodipendenza. Jo curava numerosi drogati e aveva visto quanti avevano contratto l'epatite B, passandosi gli aghi
per bucarsi dall'uno all'altro, quando l'effetto della droga
esplodeva in loro. È difficile procurarsi siringhe e aghi; per
questo essi vengono usati più e più volte dai tossicomani,
che non si preoccupano tanto di pulirli bene. A dire il vero,
aghi e siringhe moderni sono studiati per essere gettati via
dopo l'uso e, pertanto, non è possibile pulirli adeguatamente.
Jo e Peter evitavano questi problemi utilizzando materiale sterile ogni volta che prendevano la droga per via endovenosa. L'ospedale in cui Jo lavorava ne era l'inconsapevole
fornitore. Spesso portavano con sé, nella sala da tiro di
Brooklyn, dove compravano la droga, aghi, siringhe e una
bottiglia d'acqua sterilizzata per iniezioni: sospendevano la
droga nell'acqua sterile e subito dopo se la iniettavano.
La coppia fu in grado di individuare con grande precisione il momento esatto in cui ebbe il primo contatto con il virus dell'AIDS. Solo una volta Jo, che procurava e portava
l'attrezzatura, pensava di averla messa in macchina, mentre
l'aveva lasciata sulla tavola della sala da pranzo. Arrivarono così a Brooklyn, ormai con un bisogno disperato di eroina, ma non trovarono siringhe e aghi sterili. Al limite dell'esasperazione decisero di rischiare e di utilizzare materiale
già usato da altri.
215
L'uomo da cui avevano preso in prestito ago e siringa era
gentile, ma chiaramente emaciato e con un aspetto generale
non sano. Lo conoscevano per nome di battesimo, avendolo già visto in numerose occasioni nella sala da tiro; in seguito mi dissero di aver saputo, diciotto mesi dopo, che era
in ospedale, in condizioni disperate, con quella strana nuova malattia chiamata AIDS.
Jo e Peter, circa due settimane dopo essere stati alla sala
da tiro, furono colpiti entrambi gravemente da una malattia
che sembrava influenza. Per una settimana circa, soffrirono di abbondanti sudorazioni, che li lasciarono esausti; si
recarono dal medico del luogo, il quale disse loro che si
trattava di una forma di influenza, di cui c'erano tanti casi
in giro, e di rimanere a riposo fino a quando non fosse passata. I sintomi se ne andarono, ma il virus no.
Per un anno, Jo e Peter non ebbero altri problemi di salute. Tuttavia, nei sei mesi che precedettero il nostro incontro, avevano subito un rigonfiamento di ghiandole, una diminuzione di peso, frequenti sudorazioni la notte, rigidità
alle mani la mattina svegliandosi, ed esantemi periodici sul
torace e sulla schiena. Peter appariva maggiormente colpito
di Jo.
Negli Stati Uniti e in molti altri paesi, l'uso della droga è
ancora un fattore importante nella diffusione continua dell'epidemia di AIDS. Bastano due gocce di sangue infetto,
contenente linfociti T4 infettati dal virus, per fornire una
dose fatale di virus dell'AIDS quando sono introdotte nel
circolo sanguigno di una persona. L'esperienza ha dimostrato che è molto più difficile modificare il comportamento dei tossicodipendenti di quanto lo sia, per esempio, modificare i comportamenti sessuali degli omosessuali.
Vedremo ora perché l'AIDS sia diventato un problema
così grave per i pazienti che soffrono di emofilia. Questo
gruppo di persone è quello più gravemente colpito dall'epidemia di AIDS e certamente la sua sofferenza deriva dai
problemi connessi al sangue contaminato. In loro si riscontra amarezza e frustrazione più di altre vittime della stessa
216
infezione. L'emofilia è una malattia genetica abbastanza
rara, che colpisce soltanto gli individui di sesso maschile. Il
gene difettoso che ne è responsabile è portato dalla madre,
la quale, pur non essendo affetta dalla malattia, può trasmetterla a un figlio maschio, che si ammalerà. Molti conosceranno persone che soffrono di emorragie che durano
ore, o addirittura giorni: basta che si facciano un piccolo
taglio. Non tutte queste persone sono emofiliache, ma la
maggior parte si.
Quasi altrettanto interessante del sistema immunitario, e
progettato lungo linee analoghe, è il sistema di coagulazione del sangue. Quando un vaso sanguigno viene reciso o
punto, in modo che dalla lesione possano uscire gocce, o
addirittura fiotti, di sangue, viene segnalata immediatamente un'emergenza. Tutto il sangue dell'organismo circola lungo i principali vasi sanguigni ogni sessanta secondi;
pertanto, se venisse lesionato un grosso vaso, sarebbe possibile morire dissanguati molto in fretta.
Le cellule che tappezzano i vasi sanguigni lesionati liberano sostanze chimiche che attirano particolari elementi del
sangue: le piastrine. Si tratta di cellule prodotte nel midollo
osseo, il cui ruolo biologico consiste nel tappare le falle prodotte nei vasi. Lo fanno per noi ogni giorno, dato che, se
prendiamo un colpo in un fianco, urtando nello spigolo di
un tavolo, i minuscoli capillari si rompono perdendo sangue e dando origine a un ematoma. Tutti ci lesioniamo ininterrottamente, senza neppure accorgercene.
Le piastrine tappano la falla con il loro corpo cellulare,
ma segnalano che un'opera di riparazione più robusta e
permanente venga avviata con immediatezza. Nel circolo
sanguigno vi sono dodici fattori, chiamati, secondo un criterio abbastanza logico, fattori di coagulazione del sangue.
Si attivano a catena e, quando la reazione giunge alla fine,
una nuova parete di fibrina è eretta e può durare fino a
quando la parete del vaso si è riformata.
Gli emofiliaci sono privi di uno di questi fattori: il fattore
VIII. Di conseguenza, non sono in grado di riparare la ben217
chè minima lesione nella parete dei loro vasi. Non potendo
sintetizzare il fattore VIII, sono in costante e terribile pericolo di emorragia, che può condurli alla morte. Alcuni
emofiliaci sono in grado di produrre un poco di fattore
VIII e, pertanto, nella loro malattia vi sono vari gradi di
gravità.
Fino ad anni recenti, i malati gravi di emofilia conducevano una vita miserabile quanto tediosa e, per proteggerli,
venivano quasi letteralmente avvolti nella bambagia; se invece erano attivi, allora spesso erano soggetti a gravi emorragie. Ne soffrivano particolarmente le loro articolazioni,
in quanto naturalmente esse sono soggette di continuo a
tensioni e urti: piccole quantità di sangue che dovessero
spandersi in esse finirebbero per distruggerle, dando origine a un'artrite deformante.
Gli scienziati sono riusciti a scoprire come estrarre il fattore VIII dal sangue normale. Non solo lo si può estrarre,
ma anche concentrare e confezionare, in modo che l'emorragia possa essere messa rapidamente sotto controllo con
un'iniezione endovenosa del fattore mancante.
La produzione di quantità commerciali del fattore VIII
richiedeva però una quantità enorme di sangue; così ci si
rese conto ben presto che la donazione da parte di volontari non avrebbe fornito abbastanza sostanza rossa, preziosa
per questo scopo. Il pool dei volontari non era sufficientemente vasto da poter conservare le normali scorte e, nello
stesso tempo, da poter avere sangue a sufficienza per produrre il fattore VIII. Le società commerciali interessate decisero così che bisognava acquistare il sangue; di conseguenza, furono istituiti centri in cui uno poteva andare a
vendere per contanti un'unità del proprio sangue.
Fin dagli inizi, ci si rese conto che i «venditori» sarebbero stati, in gran parte, gente disperata, e che numerosi tossicomani e simili avrebbero approfittato del sistema per fare rapidamente soldi. Tutti i donatori erano, e sono, però
passati al vaglio dai medici e tutto il sangue raccolto era,
ed è, accuratamente controllato per vedere se contiene il vi218
rus dell'epatite e ogni altro agente infettante noto. Il sistema funzionava. La vita degli emofiliaci fu rivoluzionata.
La loro tragedia, naturalmente, fu l'AIDS. Tossicodipendenti e omosessuali infettati dal virus facevano la coda
per vendere il loro sangue per la produzione del fattore
VIII. Il sangue prelevato, e poi riunito per praticità commerciale, si infettò con il virus HIV, che a quell'epoca nessuno era in grado di scoprire. Piccole quantità del virus letale vennero distribuite agli emofiliaci di tutto il mondo in
migliaia di flaconi contenenti il fattore VIII. Su base pro
capite, gli emofiliaci sono di gran lunga il gruppo ad alto rischio più colpito e infetto. Per esempio, negli Stati Uniti,
più del 70 per cento dei 12.000 emofiliaci è stato infettato
dal virus. Lasciate ora che vi presenti uno dei casi più notevoli.
Quando lo incontrai, Michael aveva trentadue anni: cercava una cura per una forte tosse e per una difficoltà di respirazione. Aveva febbre alta ed era chiaramente stremato,
ma aveva una di quelle personalità incoercibili, che tendono
a minimizzare la propria sofferenza. La sua fidanzata,
un'infermiera, era con lui; il loro matrimonio era programmato entro pochi mesi. Michael aveva fatto qualcosa che
nessun altro, colpito dalla stessa malattia, era riuscito a fare. Fin dai primissimi anni, egli era pazzo per il volo e, come tanti ragazzi, voleva diventare pilota di un grosso jet
commerciale. Un'ambizione non realizzabile per un emofiliaco, ma la sua era una forma piuttosto blanda, per cui all'età di trentadue anni divenne capitano di una linea aerea
commerciale.
Nel corso della sua vita, aveva avuto bisogno del fattore
VIII solo in poche occasioni e non ne aveva ricevuto da
molti anni, quando, nel 1980 si torse una caviglia. Si recò
all'ospedale locale, preoccupato che quel trauma potesse
provocare una pericolosa emorragia a livello articolare. Gli
fu fasciata la caviglia e il medico gli consigliò, anche se tutto sembrava procedere bene, di farsi somministrare un poco
di fattore VIII per via endovenosa, «tanto per essere al sicu219
ro». Michael aveva dei dubbi, ma alla fine accettò. Ricevette così un flacone di fattore VIII contaminato.
Quando lo vidi la prima volta aveva la polmonite. Presentava anche una grave forma di anemia. La polmonite
era di un tipo che colpisce spesso le vittime dell'AIDS, mentre l'anemia ci lasciava perplessi. Egli non aveva mai avuto
emorragie e le nostre indagini rivelarono ben presto che una
forma fastidiosa di tubercolosi gli aveva invaso il midollo
osseo, impedendogli di produrre sangue.
Per i successivi nove mesi, egli lottò contro la malattia.
Era molto religioso e la sua fede e il suo coraggio lo mantenevano allegro, anche quando si coprì di pustole, prodotte
da un'infezione erpetica. Cosa sorprendente, morì sereno.
Come fanno i bambini a prendere l'AIDS? Come gli
adulti, possono contrarre la malattia ricevendo una trasfusione di sangue contaminato o di prodotti del sangue contaminati, ma questo non è il modo più comune per entrare in
contatto con il virus.
Seth aveva solo due anni quando fu portato per la prima
volta alla mia clinica: un negretto sveglio figlio di una donna negra e di un padre, anch'egli negro, intelligente ma trascurato, ora per due anni sotto custodia dello Stato.
Seth «non riusciva a crescere robusto». Aveva grossi noduli nel collo e una milza enorme; inoltre era afflitto da
un'infezione dopo l'altra. Impiegammo alcuni mesi, nella
prima fase dell'epidemia di AIDS, per stabilire che cosa
non funzionasse bene in quel bambino, ma quando finalmente capimmo, fummo ansiosi di sapere come egli, a soli
due anni, avesse potuto contrarre il male.
Sottoponemmo a un test la madre e trovammo che era
colpita da una forma precoce di infezione. Sottoponemmo
allo stesso test anche il padre (che si trovava in prigione) ed
egli risultò perfettamente sano. La donna giurò di non essere mai stata tossicodipendente e le credemmo; non aveva
neppure mai ricevuto trasfusioni di sangue. Confessò però
di avere un amante, che si iniettava la droga e che era infettato dal virus dell'AIDS. Questo virus quell'uomo lo aveva
220
trasmesso sia alla madre sia al bambino: lei, infatti, era incinta quando lo conobbe.
Il virus dell'AIDS può attraversare la placenta, e passa
così dal circolo sanguigno materno ai linfociti T in via di
sviluppo del bambino. È questo il modo in cui la maggior
parte dei bambini prende la malattia.
Di recente abbiamo trovato che il virus dal seno della madre passa nel latte: così un lattante, succhiandolo, viene infettato. Come abbiamo già ricordato, la Natura si è preoccupata che nel latte materno fossero presenti linfociti T; se
questi vengono infettati, presumiamo che il bambino, ingerendoli, diventi a sua volta infetto.
I casi citati mostrano come si può essere contagiati dal virus dell'AIDS. I modi indicati sono gli unici in cui ci si può
ammalare. Non si può, invece, prendere l'infezione accettando danaro da un gay o facendo lavare i propri indumenti
in un lavasecco frequentato da omosessuali, e così neppure
frequentando piscine, gabinetti pubblici, toccando coltelli,
terraglie e così via.
La tragedia dell'AIDS è stata resa incommensurabilmente più grave, se così si può dire, dall'ignoranza della gente
per ciò che riguarda la malattia, un atteggiamento che ha
portato ad avere molti timori ingiustificati e, pertanto, a rifuggire in modo ingiustificato dalle vittime della malattia.
Vi sono individui che hanno perso il posto di lavoro e le
amicizie semplicemente perché si sussurrava che fossero stati sottoposti a un controllo per l'AIDS. Il ruolo dei mezzi di
comunicazione in tutto questo e perfino il comportamento
non adeguato di alcune persone in campo medico meritano
di essere analizzati e censurati.
A causa della lenta evoluzione della malattia, possiamo
riconoscere i diversi stadi dell'infezione. Appena infettati, i
soggetti generalmente non mostrano alcun sintomo. Solo
l'accortezza degli individui appartenenti ai gruppi ad alto
rischio li indurrebbe ad andare in ospedale chiedendo di essere sottoposti a un test a questo stadio precoce.
Alcuni individui rivelano un certo grado di resistenza al221
l'infezione, mentre altri soccombono presto. Quando i pazienti mostrano sintomi e segni tipici, entrano nel secondo
stadio della malattia, caratterizzato da un rigonfiamento
delle ghiandole, abbondante sudorazione notturna e dimagramento; altri sintomi comuni sono una rigidità delle articolazioni, perdita di libidine e malessere generale. Anche
questi pazienti possono, almeno per molti anni, rimanere
statici, tanto da far pensare di aver raggiunto una qualche
forma di compromesso con il virus. Purtroppo la maggior
parte di loro finirà per scivolare nella malattia. Studi effettuati nel mondo occidentale hanno dimostrato che il 36 per
cento dei soggetti, inizialmente infettati dal virus, hanno
mostrato i sintomi dell'AIDS dopo sette anni di controlli
approfonditi. Non disponiamo di alcuna sfera di cristallo
che ci possa indicare quale percentuale alla fine si ammalerà
di AIDS, ma sfortunatamente il numero di malati, in base
alla nostra esperienza, è aumentato di anno in anno.
Nel momento in cui leggerete queste pagine, siamo fiduciosi che una certa educazione in merito avrà ridotto in misura significativa l'incidenza di nuovi casi. La paura della
malattia sarà diminuita nella popolazione in generale (e, ovviamente, tra coloro che leggono questo libro).
Basandosi sull'esperienza clinica e sulla conoscenza del
sistema immunitario, gli scienziati devono fornire due strategie che possano essere utilizzate simultaneamente sui pazienti di AIDS nel tentativo di guarirli. Anzitutto è necessario reintegrare la funzionalità dei linfociti T nei pazienti ormai terminali e contemporaneamente occorre produrre e
somministrare farmaci in grado di contrastare il virus bloccandone la moltiplicazione.
In molti paesi viene oggi sperimentato il Retrovir, un farmaco dalle grandi promesse, di cui si tratterà più avanti.
Con questo farmaco e un trapianto di midollo osseo, probabilmente si è riusciti a guarire dalla malattia almeno un
paziente. In America, un uomo era abbastanza fortunato
da avere un gemello identico sano. Come si è già detto prima, il midollo osseo normale contiene linfociti T. Per la
222
maggior parte dei trapianti di questo tessuto ci siamo sempre preoccupati di eliminarli. Invece, con un gemello identico il problema non sussiste e, in effetti, i linfociti T nel midollo osseo trapiantato hanno potuto ripopolare l'organismo del malato, che altrimenti sarebbe morto di AIDS. Utilizzando un farmaco per rendere inefficiente il virus, i nuovi linfociti T hanno potuto attaccare l'HIV e sradicarlo.
Pochissimi dispongono di un gemello identico, ma questa
anamnesi ha almeno dimostrato a immunologi e biologi che
il metodo combinato di migliorare la funzionalità dei linfociti T (il che può richiedere un trapianto di timo) e di utilizzare simultaneamente agenti antivirali può servire a mettere
a punto una cura per l'AIDS.
Il virus HIV è stato sicuramente scoperto in 136 paesi; nei
rimanenti non si sa, e questo perché molti di tali paesi hanno in realtà eluso il problema, sia per ragioni economiche
sia per ragioni organizzative. L'Organizzazione Mondiale
della Sanità ritiene siano infettati dal virus ben 12 milioni di
individui, di cui il 36 per cento morirà nei sette-otto prossimi anni, a meno che non si abbia un'importante scoperta in
campo terapeutico. L'Africa ha probabilmente sei milioni
di infetti; gli Stati Uniti un milione e mezzo. La tragedia
umana, lo scompiglio creato nei servizi sanitari e l'onere finanziario dell'epidemia sono addirittura disastrosi.
Nel 1990, negli Stati Uniti, più di 174.000 casi di AIDS
sono stati ricoverati in ospedale e la metà circa è deceduta.
Nei prossimi anni la cura dei malati di AIDS e la lotta per
prevenire nuove infezioni costeranno agli Stati Uniti miliardi di dollari. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha
costituito a Ginevra un'enorme e costosa unità operativa
per combattere l'AIDS su scala mondiale. Da lì ci viene costantemente ricordato che l'AIDS è una tragedia globale,
che esigerà una risposta da tutti noi.
Le infezioni da HIV continuano a diffondersi rapidamente in Africa. Quasi tutti i casi sono dovuti alla trasmissione eterosessuale del virus; la malattia, infatti, è propria
degli individui giovani che hanno un'attività sessuale. Que223
sto fatto ha permesso agli epidemiologi di escludere la zanzara come vettore ancor prima che fossero compiuti studi
specifici sulla trasmissione dell'HIV. Per la trasmissione da
parte delle zanzare, sarebbe stata necessaria una nuova varietà di zanzare, che prediligesse il sangue dei giovani africani con attività sessuale. In alcune città dell'Africa tropicale, l'80 per cento della popolazione delle gestanti è infettata dal virus. Quando si considera che la maggior parte dei
paesi africani può dare solo dai diciassette ai quaranta centesimi di dollaro pro capite l'anno ai servizi sanitari e che
un test per gli anticorpi contro l'HIV costa un minimo di
due dollari, è subito chiaro che tutti dovremo fare uno sforzo enorme per offrire un sostegno tecnico e finanziario ai
paesi sottosviluppati che stanno lottando contro quel virus.
L'AIDS ha oggi raggiunto l'Asia con quasi 300 casi documentati. Data la scarsa attenzione rivolta fino ad oggi al
virus in questo continente, la cifra è allarmante. Molti asiatici ritengono, in modo inesatto, di poter essere maggiormente immuni di altre razze agli effetti dell'HIV. La geografia, non la genetica, ha protetto l'Asia nei primissimi anni dell'epidemia. Di grandissimo significato è la scoperta
che l'AIDS in Asia si diffonde mediante l'attività eterosessuale e che in paesi come l'Indonesia, le Filippine e la Malaysia sia la salute genitale delle donne il determinante singolo probabilmente più importante della velocità con la
quale si diffondono le malattie.
Principali problemi e controversie
L'epidemia di AIDS ha inesorabilmente evidenziato luci ed
ombre del contesto sociale delle comunità umane. Pregiudizio e ignoranza, sempre cattivi consiglieri, hanno indotto ad
atteggiamenti e determinato decisioni che non solo hanno
fatto aumentare la sofferenza, ma hanno intralciato l'applicazione di linee di condotta in grado per lo meno di contenere al minimo la diffusione della malattia. D'altra parte,
molti individui e organizzazioni hanno operato con slancio,
224
pietà e intelligenza per fronteggiare la sfida. Di conseguenza, vi sono numerose controversie di cui occuparsi, ma anche molti fatti nuovi a cui si può dare un contributo con
questo lavoro.
il test per gli anticorpi contro l'HIV
Cercare le «impronte digitali» del virus HIV in un individuo, analizzandone il sangue per trovarvi gli anticorpi prodotti contro di esso, rimane la nostra arma migliore per seguire l'andamento dell'epidemia, pianificare i servizi sanitari del futuro ed aiutare un individuo infetto mediante una
diagnosi precoce. Malgrado la validità del test per gli anticorpi, i programmi di screening rimangono controversi.
Il test in sé non è più controverso: i suoi limiti e la sua affidabilità sono stati chiaramente definiti. L'80 per cento degli individui infettati dall'HIV mostra che le cose stanno
proprio in questi termini, producendo due o tre settimane
dopo l'infezione anticorpi contro il virus, circolanti nel sangue. Quasi il 100 per cento lo fa a tre mesi dall'infezione.
Un recente rapporto finlandese, che cita due individui i
quali non hanno prodotto anticorpi per quindici mesi dopo
l'infezione, è interessante, ma il caso è così raro che non è
significativo nel contesto generale dell'esame clinico e della
diagnosi. In ogni caso, i dati finlandesi sono stati messi in
discussione da numerosi scienziati, che ritengono che i problemi in essi riportati dipendano più dai metodi usati per effettuare il test che dal sistema di anticorpi dei pazienti.
Il test per gli anticorpi ha però un punto debole: se qualcuno ha un test negativo, tutto quello che si può dire è che,
se non è possibile che sia stato infettato dall'HIV nei tre
mesi precedenti il test, egli non è infetto. Se, invece, è possibile che, in quel periodo, abbia avuto un contatto con il virus, allora dovrà necessariamente sottoporsi a un secondo
test dopo tre mesi in cui sicuramente non ci sia stata una
nuova esposizione. Allora, e solo allora, si può essere sicuri. Nella maggior parte degli studi, un qualsiasi ritardo nella
sieroconversione non è un problema.
225
Il modo in cui vengono manipolati i risultati, non il modo in cui vengono eseguiti i test, continua a generare controversia. Lo screening degli anticorpi contro l'HIV non è
semplicemente un altro test. Un risultato positivo annuncia
a un individuo che è affetto da un'infezione letale in grado
di trasformare la sua rimanente vita in un inferno di sofferenze fisiche, psicologiche, forse emarginato da tutti. Di
tanto in tanto, anche qui, ho visto individui perdere di colpo un amico per averlo reso partecipe della loro angoscia,
avendo saputo di essere stati infettati dall'HIV (un problema condiviso dovrebbe essere un problema dimezzato).
Alcune famiglie si chiudono in se stesse, quando addirittura non gettano in strada un loro membro infettato dall'HIV. Le scuole rifiutano i bambini infetti. Di recente, un
tribunale in Florida, dopo aver passato in rassegna tutte le
testimonianze scientifiche, ha ordinato a una scuola di accettare tre bambini infetti. Insegnanti e genitori hanno obbedito, ma hanno però comperato a loro spese un caravan,
ponendolo nell'angolo più lontano del cortile, confinandovi in esso i tre bambini durante le ore di scuola e utilizzando
volontari per dar lezione a quei piccoli «lebbrosi».
Se un individuo considera di dover essere sottoposto a
controllo in un simile clima, ovviamente soppeserà con cura
tutti i pro e i contro. Se il test sarà negativo, potrà essere
enormemente sollevato, ma se il test sarà positivo, potrà il
fatto di essere informato aiutarlo come individuo? Se deve
rischiare la discriminazione, che cosa può importargli il nostro desiderio di raccogliere statistiche sulla velocità con cui
si diffonde la malattia? Se governi senza giudizio hanno introdotto, come purtroppo è il caso in numerosi paesi, penalità per quegli individui infettati dall'HIV, che hanno rapporti sessuali con chicchessia senza avvisare dell'infezione
da cui sono stati colpiti, allora la gente sarà ancora meno
portata a sottoporsi volontariamente allo screening per gli
anticorpi contro l'HIV. Un amante geloso potrebbe accusare chi indaga di mancanza di discrezione e di tatto. Se, come capita in molti posti, sono state promulgate leggi che
226
consentono agli ufficiali sanitari di richiedere ai medici nome e indirizzo degli individui sottoposti al test, qualora ritengano di avere bisogno di quell'informazione, gli individui che meditano di sottoporsi al test saranno ulteriormente
inibiti.
La diagnosi precoce di un'infezione da HIV è utile per un
dato paziente. La sua battaglia con l'HIV può essere aiutata e le complicazioni curate. Ma per la comunità, ancor più
che per l'individuo, l'esecuzione del test è essenziale ed è
pertanto necessario che tutti i paesi si impegnino diligentemente a rimuovere gli impedimenti ai programmi di screening volontario.
Vale la pena di esaminare, o meglio di ricercare, perché
una simile diffusa discriminazione continui. Data l'irrefutabile prova che si può prendere l'HIV da un altro solo se il
suo sangue o le secrezioni dell'apparato sessuale penetrano
nel corpo, perché tanta paura, che porta addirittura al rifiuto? Il pregiudizio contro gli omosessuali fa parte del problema. A una riunione di addetti all'obitorio, che si erano rifiutati di assistere alle autopsie di pazienti morti di AIDS,
mi venne chiesto: «Perché dovremmo esporci al rischio dissezionando un invertito?». Nessuna spiegazione dei fatti,
tra cui quella ovvia che non tutte le vittime dell'AIDS sono
omosessuali, ebbe effetto su quella gente.
Di recente, un mio paziente, in fase terminale nella lotta
contro l'AIDS, decise di passare un ultimo weekend nel suo
bell'appartamento in riva al mare. Eterosessuale e scapolo
cinquantenne, si era infettato durante un rapporto sessuale
con una prostituta. Per tutta la vita era stato impegnato nel
movimento per il salvataggio dei surfisti ed era campione e
istruttore di nuoto. Il club era la sua vita. Uno dei suoi giovani prodigi, al quale era stato chiesto di portare un poco di
cibo nell'appartamento per quell'ultimo fine settimana a
casa, mi chiamò per chiedermi se Bill stava abbastanza bene
da poter provare gioia per una sorpresa. Venti giovani dell'associazione volevano essere presenti per rendergli omaggio quando sarebbe arrivato a casa, mostrargli la loro rico227
noscenza per l'aiuto che aveva dato loro negli anni trascorsi
e dirgli tristemente arrivederci. Si sapeva bene che Bill stava
morendo. Egli non aveva nascosto la verità ai suoi amici,
ma aveva scelto di dire che stava morendo di cancro.
Pensai che quella sorpresa era un'idea meravigliosa. Venne ordinata un'ambulanza per portare Bill a casa il sabato
pomeriggio per il fine settimana.
La domenica mattina, mentre facevo il giro delle visite ai
miei pazienti nel reparto dei malati di AIDS, passai davanti
alla camera di Bill. Con mia sorpresa, era nel suo letto e
singhiozzava sommessamente. Una rapida indagine mi rivelò presto come la riunione-sorpresa era andata tristemente a
monte.
Gli uomini dell'ambulanza, venuti a prelevare Bill dal reparto dei malati di AIDS, malgrado le proteste del paziente
e del personale, indossavano tute spaziali. Erano coperti
dalla testa ai piedi e portavano spessi guanti gialli di gomma. Bill era sorpreso ma non sapeva che cosa lo aspettava a
casa e, pertanto, si rassegnò alla loro stupidità e al proprio
imbarazzo. Quando il gruppo che attendeva Bill lo vide trasferire dall'ambulanza nel suo appartamento da questi portantini vestiti in modo così strano, la sorpresa lasciò il passo
alla costernazione. La vera causa della malattia di Bill fu
così rivelata agli amici e ai vicini rimasti a bocca aperta.
Non ci fu naturalmente alcuna festa. Tutti quei giovanotti ben intenzionati, ma ignoranti, svanirono nel nulla, tranne uno, e un Bill sconvolto, che non aveva voluto che i suoi
amici sapessero della sua malattia, lasciato solo a soffrire
del loro rifiuto, tornò in ospedale per morirvi nel tormento
due giorni dopo.
Ero furioso con gli infermieri dell'ambulanza che non
avevano seguito la linea di condotta, definita e accettata
dalla loro organizzazione, per il trasporto dei malati di
AIDS. Quando li affrontai direttamente, uno di loro difese
il suo comportamento con uno sprezzante: «Voi non conoscete in realtà quanto pensate di sapere». Questa è una frase significativa, tipica di un nuovo at228
teggiamento che si sta diffondendo tra molte persone nei
riguardi della scienza medica e di coloro che la esercitano.
Vediamo costantemente persone intelligenti, a cui non
può essere sfuggita l'informazione che una relazione di tipo sociale (cioè un rapporto non sessuale) non può trasmettere l'AIDS, agire in modo non intelligente: magistrati che rifiutano di avere nelle aule giudiziarie individui infettati dall'HIV, poliziotti che richiedono un risarcimento
in danaro per il rischio che corrono arrestando una prostituta infettata dall'HIV, personale delle aviolinee che
non vuole avere persone del genere sul proprio aereo, e
così via.
L'atteggiamento mutevole di molte persone nei riguardi
della scienza ortodossa e dei medici può essere attribuito,
senza dubbio, a molti fattori. Con un progresso alle nostre
spalle, che ha visto vaccini e antibiotici spazzar via tanta
sofferenza dall'umanità, ci troviamo oggi in un periodo in
cui i problemi ardui rimangono tali e rivelano con riluttanza i loro segreti. Abbiamo bisogno di nuovi successi nel
campo dell'oncologia, della cardiologia e anche della gerontologia per riconquistare molti che si aspettavano che il
flusso dei miracoli in medicina sarebbe continuato.
I medici devono assumersi parte della responsabilità.
Troppi di loro, e le ragioni di guadagno non sono secondarie, praticano la medicina a colpi di scena, dispensando
farmaci validi e a volte no, poco curandosi dei loro effetti
terapeutici o di placebo o addirittura iatrogeni. È triste
constatare che molti di noi, insegnanti di medicina, pensano che lo standard della pratica medica nel mondo occidentale stia precipitando, malgrado gli innegabili progressi
scientifici rispetto al passato.
In effetti, la rapidità con cui si è accumulata una conoscenza genuina, utile e complessa, sul virus HIV e le devastazioni di cui è responsabile rappresenta un trionfo della
medicina moderna. Naturalmente c'è ancora molto da imparare su questo virus, ma un dato incontrovertibile è che
ci si infetta solo quando secrezioni contenenti HIV (della
229
sfera sessuale, sangue e di tanto in tanto il latte materno)
penetrano in un organismo.
La comunità scientifica mondiale ha accettato un nuovo
sistema di classificazione per le infezioni da HIV: esso assicurerà un'uniformità nella raccolta dei dati. Il test per gli
anticorpi è una parte di vitale importanza per questo sistema di classificazione. I pazienti con infezione da HIV vengono classificati in uno dei quattro gruppi. I pazienti del
Gruppo I sono quelli infettati solo di recente, che soffrono
di una malattia del tipo dell'influenza, così comune che nella maggior parte dei casi non viene neppure ricordata. Essa
coincide con la comparsa nel circolo sanguigno degli anticorpi contro l'HIV. Il Gruppo II comprende la maggior
parte dei pazienti infettati dall'HIV. Clinicamente stanno
bene, ma sono infetti e, ciò che più conta, infettivi. Il Gruppo III annovera individui che accusano un rigonfiamento
delle ghiandole linfatiche e alcuni dei sintomi generali associati con un'infezione da HIV: sudorazioni notturne, perdita di peso, e così via. Il Gruppo IV comprende, infine, quei
pazienti con una qualsiasi delle gravi conseguenze che derivano da un'infezione da HIV, compresa la più grave di tutte: l'AIDS.
A questo stadio compare spesso il sarcoma di Kaposi e
gravi complicanze neurologiche dovute all'invasione del
cervello da parte dell'HIV. Quest'ultima situazione, che
viene vieppiù riscontrata, può distruggere così rapidamente
il tessuto cerebrale che un essere umano intelligente e in piena attività fisiologica può essere portato a una forma di demenza senile in solo sei settimane.
Chi dovrebbe essere sottoposto al test?
• Chiunque tema, per una qualsiasi ragione, di essere infetto. Spesso un test serve a dissipare paure ingiustificate,
che comunque non scompariranno del tutto, anche dopo
un consulto con un esperto.
• Tutti gli uomini omosessuali, che abbiano avuto rapporti
sessuali negli ultimi anni.
230
• Tutti gli emofiliaci nei quali è stato trasfuso il fattore
VIII.
• Chiunque sia stato sottoposto a trasfusione di sangue o
dei suoi prodotti (plasma, piastrine, ecc.) tra il 1978 e il
maggio del 1985, data in cui è stato introdotto per tutti i
donatori di sangue il test per gli anticorpi. Alcuni paesi
non usano ancora questo test e, dunque, permane in essi
il rischio di acquisire l'HIV in seguito a una trasfusione.
• Uomini che hanno avuto rapporti sessuali (specialmente
anali) con una prostituta, particolarmente in Africa e in
Asia.
• Tutti gli individui, di entrambi i sessi, dediti alla prostituzione.
• Tutti i tossicomani che si iniettano la droga e che hanno
usato la stessa siringa o lo stesso ago con altri.
• Tutti i partner sessuali di tossicomani che si iniettano la
droga per via endovenosa.
• Tutti i figli di madri infettate dall'HIV.
• Tutti i donatori per le banche dello sperma.
• Tutti i donatori di organi per trapianti.
• Tutti i donatori di sangue.
• Tutti i carcerati.
• Tutti i membri delle forze armate.
• Tutti i diplomatici inviati in paesi in cui l'AIDS è un problema importante e le scorte di sangue non sono sottoposte a screening.
In molte società, in cui l'infezione da HIV costituisce un
problema importante, le donne che progettano di mettere al
mondo un figlio dovrebbero essere sottoposte al test, così
come lo dovrebbero gli emigranti che si spostano da quei
paesi ad altri. I membri di una nuova coppia cercheranno
sempre più spesso di convincersi reciprocamente che le loro
precedenti esperienze sessuali non li hanno esposti all'HIV.
Questa sicurezza sarà necessaria prima che, nel loro rapporto, trovi posto senza rischi l'intimità sessuale. Ciò non è romantico? Certamente no. È necessario? In molti posti, cer231
tamente sì. Il consiglio servirà per molti altri paesi e città in
un futuro non troppo lontano, a meno che non riusciamo
ad arrestare la diffusione della malattia.
A causa di persistenti problemi di discriminazione, nessuno dovrebbe essere sottoposto al test per gli anticorpi contro l'HIV senza un precedente consulto circa le conseguenze
di un eventuale risultato positivo. Il colloquio prima del test
dovrebbe fornire informazioni sulla discriminazione che
imperversa, sulla necessità di dare notizia del risultato positivo solo a un numero ristretto di persone, sull'impossibilità
per gli individui positivi di stipulare un'assicurazione per la
vita, sul fatto che l'essere positivo non è sinonimo di essere
affetto da AIDS, e così via.
Il test per l'antigene
Un problema tecnico associato al test per gli anticorpi può
essere risolto dal test per l'antigene. Non scompariranno,
tuttavia, i problemi relativi alla discriminazione. Eseguire
un test per l'antigene significa scoprire il virus stesso, piuttosto che l'anticorpo contro il virus. Il test si sta rapidamente perfezionando via via che vengono proposte tecniche
sempre più sensibili, che ci consentono di ricercare, nel sangue del paziente, minime quantità di proteine che costituiscono sia l'involucro sia la parte centrale del virus. Queste
proteine possono essere individuate entro ventiquattro ore
dall'infezione, ma la quantità presente nel sangue comincia
da allora a diminuire per un considerevole periodo di tempo, prima che il virus ritorni al pieno delle forze. Le tecniche usate nel test per l'antigene devono essere molto sensibili per essere certi che non vengano riportati falsi negativi.
Nel momento in cui vengono scritte queste pagine, siamo a
questo punto. Il test per l'antigene, in combinazione con il
test per gli anticorpi, diventerà di routine molto presto.
Il test per l'antigene avrà un valore incommensurabile
nell'aiutarci a diagnosticare un'infezione da HIV nei neonati di madri infette. Tutti questi bambini hanno nel sangue
anticorpi contro l'HIV, ma può darsi che questi siano pro232
Figura 1. Un macrofago (in questo caso una cellula che presenta l'antigene) emette un
Prolungamento per sondare un oggetto su cui ha qualche sospetto. Si tratta di un batterio,
che il macrofago catturerà per mostrarlo a un linfocito T induttore e determinare se si tratta
di qualcosa che fa parte del «sé» o di qualcosa di estraneo (un antigene).
Figura 2. La vita delle cellule del sistema
immunitario ha inizio nel fegato del feto.
Q u i , in un preparato bioptico di fegato di
feto di 10 settimane, appaiono come
macchioline b l u . Migreranno poi nel t i m o
per essere istruite come linfociti T, oppure
nel midollo osseo per diventare linfociti B.
figura 5. I linfociti B che hanno
riconosciuto l'antigene (e si sono legati ad
esso) si trasformano in una vera e propria
fabbrica di anticorpi, che ne secernerà
duemila al secondo. A questo punto
prendono il nome di plasmacellule.
Figura 3. D o p o essere stati istruiti,
i linfociti T e B circolano nel sangue.
Le due cellule rotondeggianti, al centro
della fotografia, fanno parte delle forze
immunitarie: si tratta di un linfocito B,
che sembra sospeso su un linfocito T.
Figura 6. G l i anticorpi attivano quelle
sostanze che producono infiammazione
e che costituiscono il sistema del
complemento. Questo, a sua volta, attiva
i neutrofili, importanti cellule «spazzine»,
che fagocitano e uccidono i batteri.
Figura 4. P r i m a di secernere gli anticorpi,
i linfociti B devono riconoscere un antigene
specifico, che si legherà ad alcune delle
centinaia di migliaia di recettori degli
anticorpi, che ne ricoprono la superficie.
Figura 7. Ipersensibilità immediata e
reazioni allergiche hanno luogo quando gli
allergeni (pollini di graminacee e di altre
piante, polvere, m u f f e , ecc.) si legano alla
immunoglobulina E (IgE) su mastcellule,
come quella che appare nella fotografia
a lato, che possono liberare istamina
e sostanze analoghe dai granuli scuri.
Figura 8. A sinistra: Si nota qui un linfocito B
umano che si sta legando a batteri (in colore
verde) per mezzo di recettori di superficie, che gli
permetteranno di riconoscere quei particolari
antigeni. Il linfocito si dividerà, f o r m a n d o
plasmacellule che secerneranno gli anticorpi
i quali potranno attaccare questi batteri.
Figura 9. Sotto: A un maggiore ingrandimento,
si riesce a vedere chiaramente come un macrofago
estenda i p r o p r i pseudopodi (appendici per
catturare gli antigeni) e afferri i batteri.
Figura 10. In alto: A l c u n i macrofagi fagocitano e uccidono
antigeni. Q u i ne vediamo u n o , attivato da linfociti T o
dall'antigene presente sui batteri verdi, che sta proprio
fagocitando, uno alla volta, questi batteri.
Figura 11. In basso: Un macrofago attivato sta emettendo
decine di pseudopodi simili a tentacoli per catturare gocce d'olio
(globuli gialli).
Figura 12. In alto: U n a mastcellula rivestita di immunoglobuline E
(anticorpi) è esplosa dopo che un antigene, riconosciuto dalle
immunoglobuline, è andato ad appoggiarsi sulla sua superficie.
Nei granuli che si notano nella fotografia sono contenute sostanze
potenti, come l'istamina. Il 20 per cento degli esseri umani soffre
di «allergie» quando queste sostanze, liberate in quantità eccessiva,
agiscono sui vasi sanguigni e sull'albero bronchiale.
Figura 13. In basso: In queste microfotografie si nota l'invasione
di un linfocito T da parte d e l l ' H I V . Il virus, spostandosi da sinistra
a destra, si lega alla molecola C D 4 , che viene quindi fagocitata dal
linfocito T. Le due microfotografie in alto, sempre da sinistra
a destra, mostrano un nuovo virus d e l l ' A I D S che si stacca come una
gemma da un linfocito T che sta morendo.
Figura 14. I virus d e l l ' A I D S fuggono da un linfocito T che sta morendo e sono p r o n t i
a infettare nuovi linfociti T, e, di conseguenza, a produrre ulteriori danni al sistema
immunitario.
Figura 15. Si nota, nella fotografia, una cellula tumorale piatta e di colore marrone,
che viene attaccata da linfociti T. Due linfociti T, allungati, stanno morendo; due altri
sono invece vivi e in buona salute, mentre la cellula tumorale è praticamente m o r t a .
dotti dalla madre, non da loro. Solo quando tutti gli anticorpi materni scompaiono e sono sostituiti dalle gammaglobuline del bambino (all'incirca all'età di un anno), si può
effettuare una diagnosi di infezione da HIV mediante screening degli anticorpi. Il test per l'antigene risolverà questo
problema ed eliminerà anche la possibilità di infezione che
tanto preoccupa le banche del sangue. Teoricamente, i donatori che sono stati infettati nei tre mesi precedenti la donazione potrebbero rispondere positivamente al test per gli
anticorpi. Mentre, in pratica, questo non è stato un problema, i vantaggi del test per l'antigene sono ovvi.
L'AIDS degli eterosessuali
Si può notare un atteggiamento spocchioso tra molti eterosessuali circa la possibilità che l'epidemia di AIDS colpisca
anche loro. Perché è così difficile raggiungere il tono giusto
nel dibattito sul rischio di trasmissione dell'HIV attraverso
l'attività eterosessuale? Da una parte vi sono individui non
informati a sufficienza, che dichiarano perentoriamente che
gli eterosessuali con rapporti vaginali non hanno nulla da
temere dall'HIV. Essi sostengono che la richiesta di una
modificazione del comportamento sessuale tra eterosessuali
può provenire solo da moralisti o omosessuali che desiderano che la comunità eterosessuale sia ostacolata come loro
sul piano sessuale. All'altro estremo, vi sono individui che
vedono nell'AIDS una punizione contro il peccato e prevedono che ben presto la comunità eterosessuale sarà colpita
da un enorme flagello, che finirà per spazzar via coloro che
praticano la promiscuità sessuale.
Come accade così spesso nelle discussioni accese, la verità
sta nel mezzo. Questi sono i fatti. Potete decidere voi stessi.
Le donne che hanno rapporti sessuali anali, in cui il liquido seminale infettato dall'HIV, o addirittura le secrezioni
che fuoriescono dal pene prima dell'eiaculazione, penetrano nel retto, corrono gli stessi rischi di un uomo omosessuale in una situazione analoga. Mentre è quanto mai possibile
che un simile episodio possa portare a un'infezione fatale,
233
l'analisi statistica dei dati disponibili ci dice che la probabilità che una donna si infetti dopo dieci-cinquanta episodi di
questo tipo con un uomo infetto è all'incirca del 48 per cento. Il trauma è necessario? Non penso, ma non vi è dubbio
che la perdita di sangue da parte delle mucose o la lacerazione delle mucose stesse aumenterebbe il rischio, come lo
aumenterebbe qualsiasi piaga anale o rettale. Molti uomini
e donne che praticano regolarmente il sesso anale riescono a
dilatare facilmente il loro sfintere anale, così da non essere
traumatizzati dal pene in erezione. Studi recenti, compiuti
negli Stati Uniti, mostrano che il 10 per cento delle donne
hanno regolarmente rapporti sessuali anali per piacere; il 25
per cento solo occasionalmente. Sulla base di queste cifre,
sono più le donne che gli uomini, negli Stati Uniti, ad avere
rapporti sessuali anali.
Quali sono i rischi per una donna che abbia solo rapporti
sessuali vaginali con un uomo infetto? Vanno considerate
qui alcune variabili. L'infettività delle secrezioni sessuali
dell'uomo aumenta con il trascorrere del tempo. Diventa
ancora più pericolosa allorché il conteggio dei linfociti T
comincia a diminuire. Via via che passano gli anni dalla
comparsa dell'epidemia, si nota un enorme aumento nel numero di donne infette, sposate con emofiliaci, o di uomini
infettati da una trasfusione di sangue. Così, è importante
per le donne sapere che alcuni uomini infetti sono di gran
lunga più pericolosi di altri. Un uomo africano in visita in
Europa, che aveva avuto solo rapporti sessuali vaginali con
sedici donne europee, ne infettò nove.
Come nel caso dei rapporti sessuali anali, i rapporti sessuali vaginali possono dar luogo a un'infezione già dopo un
solo episodio. Io ho in cura numerosi pazienti che hanno
avuto questa esperienza. Tuttavia, le statistiche dicono che,
generalmente, è necessaria una esposizione ripetuta. Per
cercare di quantificare il rischio, una rassegna della letteratura mondiale e la mia personale esperienza suggerirebbero
che una donna che ha rapporti vaginali da dieci a cinquanta
volte con un uomo infetto ha un 17-33 per cento di probabi234
lità (probabilità media 26 per cento) di essere infettata.
Queste statistiche possono però essere fuorviami.
Un recente rapporto di un'agenzia d'informazioni dava
alle donne di tutto il mondo una buona notizia. Da uno studio era emerso che il 66 per cento delle mogli o delle amanti
regolari di uomini infettati dall'HIV, che avevano vissuto
con questi uomini per un anno, non era infetto. In fin dei
conti, il virus non era poi così cattivo!
Quel resoconto avrebbe in realtà dovuto avere un'enfasi
ben diversa. Quale tragedia, infatti, per quel 34 per cento di
mogli o amanti di uomini infettati dall'HIV, diventato esso
stesso infetto con il virus mortale. In Inghilterra c'è un cartellone pubblicitario con una giovane donna elegante che vi
guarda negli occhi e dice, concisamente: «Mi piace il sesso,
ma non sono preparata a morire per esso».
L'altra variabile sulla quale si deve porre nuovamente
l'accento è la salute dell'apparato genitale femminile. Mentre l'infezione che le donne subiscono in seguito a inseminazione artificiale ci dice che non sono necessari né un trauma
né una lesione manifesta del rivestimento vaginale perché si
instauri un'infezione, dati rigorosi mostrano che le donne
affette da ulcere genitali o da erosioni al collo dell'utero, o
che in passato hanno subito interventi chirurgici ginecologici o malattie trasmesse per via sessuale, hanno una vulnerabilità nettamente superiore. Problemi di carattere genitale si
riscontrano molto spesso nei paesi sottosviluppati, ma sono
tutt'altro che rari anche nelle società occidentali. Senza un
regolare controllo dell'apparato genitale, molte donne potrebbero rimanere all'oscuro dell'esistenza di alcuni di essi,
dato che i sintomi possono essere minimi.
Che dire del sesso orale? Se una donna lascia entrare nella propria bocca le secrezioni sessuali di un uomo (o di
un'altra donna) e addirittura le ingoia, può risultare infetta? Qui i dati dipendono dalle circostanze. Sappiamo che
l'HIV può infettare i lattanti nutriti dal latte materno infetto. Sappiamo che sangue infetto, inavvertitamente aspirato
nella bocca da personale sanitario, ha prodotto infezione. È
235
stato poi riferito il caso di una lesbica infettata per essersi
introdotta in bocca le secrezioni genitali infette della sua
amante. Ritengo che il rischio derivante da rapporti sessuali
orali sia minimo, ma sicuramente esistente: in definitiva
stiamo sempre trattando di un virus letale!
L'infezione in uomini eterosessuali
Un uomo che abbia rapporti sessuali anali con una donna
infetta corre gli stessi rischi che correrebbe se il partner fosse un uomo infetto. Le sue probabilità di infettarsi in seguito a un solo rapporto sessuale vaginale possono essere considerate statisticamente. Se ha avuto da dieci a cinquanta
rapporti vaginali con una donna infettata dall'HIV, ha dal
12 al 15 per cento di probabilità di rimanere infetto. Anche
qui, numerosi fattori variabili modificano parecchio il rischio per un dato individuo. Abrasioni, tagli o ulcere sul
pene fanno aumentare considerevolmente il pericolo, ma si
dovrebbe porre l'accento sul fatto che non è necessaria per
l'infezione la presenza di lesioni macroscopiche (contrapposte alle microscopiche) sulla pelle del pene. È possibile che
le secrezioni sessuali di una donna contengano così tanti
HIV che qualcuno di essi riesce a penetrare nell'organismo
attraverso l'uretra (cioè lo sbocco del pene).
Di recente, sedici ingegneri inglesi sani hanno trascorso
sei mesi in Africa, inviati dalla loro ditta per commesse edili. Quindici sono ritornati a casa infettati dall'HIV, contratto durante rapporti sessuali vaginali con prostitute africane.
Nei paesi sottosviluppati, sembra che il rischio per gli uomini sia maggiore: il 55 per cento dei partner maschili di donne infettate dall'HIV ad Haiti è stato infettato.
Le secrezioni vaginali e del collo dell'utero di donne infettate dall'HIV contengono episodicamente il virus e linfociti T infettati. Questo può essere ritrovato nelle secrezioni
vaginali in un momento in cui non lo si ritrova, invece, nel
sangue. Il virus vaginale non è collegato al ciclo mestruale e
non proviene dal sangue. Tuttavia, una donna nel periodo
mestruale può essere più vulnerabile all'infezione.
236
L'HIV non si diffonderà mai nella comunità eterosessuale del mondo occidentale alla velocità con cui ha devastato
la comunità omosessuale. Articoli rassicuranti sono stati
scritti su questo argomento, spesso citando il fatto che, negli Stati Uniti, solo dal 3 al 6 per cento dei casi noti di infezione da HIV si è verificato in uomini e donne eterosessuali,
per i quali il solo rischio consiste nell'avere rapporti sessuali
con un portatore. Ma immaginate di prendere in mano un
quotidiano, una bella mattina, e di leggervi il seguente titolo: «Novantamila americani eterosessuali infettati da un virus mortale, diffuso attraverso i rapporti sessuali». Questa
è la realtà negli Stati Uniti e il Center for Diseases Control
ci comunica che il tempo di raddoppiamento per i nuovi casi eterosessuali è di dieci mesi. Il tre per cento non sembra
molto, ma rappresenta certamente un'enorme sofferenza
quando ci si rende conto che gli americani colpiti dall'infezione sono ben un milione e mezzo.
È sicuramente necessario fare ogni sforzo per impedire a
questo virus di diffondersi tra la comunità eterosessuale.
Esso si diffonderà in questa comunità in maniera relativamente lenta, ma inesorabile, se il comportamento sessuale
non verrà modificato, e noi non dovremmo in alcun modo
essere compiacenti su questo punto. Studi effettuati nelle
società occidentali hanno rivelato dati molto simili. Dal 30
al 35 per cento di giovani tra i quindici e i ventisette anni di
età hanno regolarmente rapporti sessuali che faciliteranno
la diffusione della malattia.
I profilattici
Dovunque la promozione dei condom come arma utile per
combattere l'AIDS è stata contestata. I dati scientifici sono,
invece, chiari. L'HIV non può passare attraverso un profilattico intatto. Ammesso che il condom sia usato per l'intero atto sessuale, che non si rompa e che il suo contenuto
non fuoriesca quando il pene si ritira dalla vagina o dall'ano, il rischio di trasmissione dell'HIV in entrambe le direzioni è minimo. Il problema è che anni di esperienza nel237
l'impiego dei profilattici per scopi contraccettivi ci dicono
che il rischio è prevedibile nel 5-10 per cento dei casi. La
rottura del condom è la causa per l'1 per cento e il rischio è
maggiore se il rapporto è anale. La causa principale è stata,
e rimane, l'errore umano.
C'è molta resistenza all'impiego del profilattico, principalmente da parte degli uomini. A meno che l'inguainamento del pene in erezione venga eseguito come parte dei
giochi amorosi, il profilattico non viene usato. Richiede
pratica. Nella maggior parte delle società occidentali le donne dovranno insistere e portare sempre dei profilattici con
sé, dato l'atteggiamento degli uomini nei riguardi di questo
mezzo protettivo. Numerosi studi hanno dimostrato che gli
uomini utilizzeranno il profilattico se verrà chiesto loro di
farlo, mentre è molto meno probabile che l'iniziativa parta
da loro stessi. Vi sono dati scientifici attendibili che suggeriscono che i profilattici contenenti l'agente antivirale spermicida nonoxinolnina danno una protezione migliore di
quelli che ne sono privi.
Ci si scontra con una vera contestazione quando le autorità sanitarie cercano di promuovere l'uso del profilattico.
Alcuni sostengono che simili promozioni faranno aumentare l'attività sessuale tra i giovani; tuttavia, non c'è alcuna
prova in questo senso. Altri obiettano che si discuta dell'argomento in televisione e non accetterebbero mai il tipo di
dimostrazioni che si è avuto in Scandinavia e nel Regno
Unito, in cui è stato utilizzato un modello di pene in erezione per dimostrare la tecnica corretta per utilizzare il
condom.
Le società possono essere ipocrite sotto questo aspetto.
Di recente, stavo aspettando, in uno studio televisivo, di discutere sul fatto che fosse stata eliminata dalla televisione,
in seguito al turbamento manifestato dagli spettatori, quell'efficace pubblicità sui profilattici. Nello studio in cui attendevo vidi sul monitor, a splendidi colori, un film su un
uomo che in una villa sul Mediterraneo amoreggiava corrisposto molto liberamente con due donne. Mentre le sequen238
ze dei tre che si divertivano tutti insieme sui bordi di una
splendida piscina erano in onda, le telefonate di coloro che
desideravano intervenire al dibattito calarono di colpo.
L'intervistatore televisivo e io, dopo esserci guardati l'un
l'altro, scoppiammo a ridere, rilevando l'ironia ipocrita
della situazione.
Le organizzazioni religiose si pongono il problema della
liceità (teologico-morale) dell'uso del condom quale misura
anti-AIDS. Se si usa il profilattico per proteggere se stessi
dal virus dell'AIDS e, nel contempo, questo tipo di intervento impedisce il concepimento, può un emofiliaco sposato avere ancora rapporti sessuali con la propria moglie?
Una adolescente che non avesse alcuna intenzione di avere
rapporti sessuali con chicchessia sarebbe sulla via del peccato se portasse qualche profilattico nella borsetta? Mentre
alcuni di noi non danno alcun peso a queste domande, esse
sono importanti per migliaia o addirittura milioni di persone che si rivolgono alle autorità ecclesiastiche per avere una
guida di comportamento su questa faccenda.
Sesso e AIDS nell'educazione scolastica
Molte società hanno ancora difficoltà ad accettare la raccomandazione della maggior parte delle autorità sanitarie, secondo cui i bambini fin dai dodici anni devono essere edotti, con un linguaggio appropriato per la loro età, ma cionondimeno esplicito, sull'AIDS. I sistemi scolastici non sono abituati a essere chiamati in causa per aiutare nelle emergenze sanitarie. Molti di loro in Europa e negli Stati Uniti
hanno risposto prontamente, ma la maggior parte no, e
un'indagine dopo l'altra ci ha dimostrato che i bambini sono ancora disorientati. Di recente, nei sobborghi occidentali di Sydney, in Australia, un ricercatore a caccia di risposte
all'allarmante aumento dell'uso dell'Anfetamina IV tra gli
adolescenti chiese loro, tra le altre cose, se non fossero
preoccupati di contrarre l'AIDS con tutto quello scambio di
aghi che c'era. «Ebbene, no» fu la risposta. «Non siamo
omosessuali.»
239
L'AIDS e l'impiego dell'Anfetamina IV
La maggior parte di coloro che utilizzano l'Anfetamina IV
e si scambiano gli aghi non sono tossicodipendenti, ma usano la droga per «svago». Entrambi i gruppi, però, corrono
un ugual rischio di essere infettati dall'HIV. In molte parti
degli Stati Uniti lo scambio degli aghi è diventato il mezzo
principale di trasmissione dell'HIV. Il New Jersey è il migliore (o peggiore?) esempio. Sull'isola di Manhattan,
275.000 utenti di Anfetamina IV sono infetti e le autorità
sanitarie hanno già deciso di ignorarli, dato che stanno impegnando tutte le energie nella prevenzione di nuovi casi.
Che cosa si può fare con le persone che usano l'Anfetamina IV? Secondo un recente rapporto proveniente da San
Francisco, alcuni individui possono essere istruiti e possono
cambiare certe cattive abitudini. A certuni può essere insegnato come lavare aghi e siringhe con la candeggina prima
di passarli al prossimo utilizzatore. Altri possono essere distolti dall'abitudine di usare l'Anfetamina IV, inducendoli
ad accettare un programma disintossicante in cui compresse
di metadone sostituiscono l'Anfetamina IV. Forse la mossa
migliore, ma anche la più contestata, è la distribuzione gratuita di aghi e siringhe ai drogati su una base di scambio.
Ad Amsterdam, dove è stato realizzato il programma pilota, l'80 per cento degli aghi e delle siringhe è stato restituito
ai distributori. Per molti, però, il fatto di fornire siringhe e
aghi sterili a persone che le utilizzeranno per drogarsi è angoscioso. Di recente, nel patrocinare l'accettazione di un simile programma da parte di un gruppo di ecclesiastici, certamente molto restii, ho usato la frase «il fine giustifica i
mezzi». Un arcivescovo si è alzato in piedi, rimproverandomi garbatamente per questa mia posizione e, ponendo l'accento sulla differenza che esiste tra «il fine giustifica i mezzi» e «il minore di due mali», ha narrato l'aneddoto di San
Tommaso d'Aquino e dei suoi sforzi per fare aprire i bordelli, non perché fosse favorevole alla prostituzione, ma
perché non sopportava di vedere ruberie e delitti associati
240
ad essa, liberamente praticata, senza alcun controllo, per le
strade. Credo che in definitiva avesse ragione lui.
Tutti gli esperti concordano sul fatto che, nella società
occidentale, chi utilizza l'Anfetamina IV è in gran parte responsabile dell'introduzione del virus nella comunità eterosessuale. È interessante che, negli Stati Uniti, la maggior
parte delle partner sessuali di uomini che fanno uso dell'Anfetamina IV non usino drogarsi. Quando il maggiore
dei mali sociali si mescola con la maggiore delle malattie sociali, si forma davvero un cocktail disastroso.
Il Retrovir (AZT)
Di recente, un'entusiasmante conquista nella terapia dell'infezione da HIV ha posto governi e società di fronte a un
dilemma etico. La Burroughs Wellcome, gigante farmaceutico britannico, ha prodotto un farmaco che riduce marcatamente la velocità con cui il virus dell'AIDS può moltiplicarsi. Il farmaco è un terminatore di catena del DNA.
Quando il virus istruisce i linfociti T perché cementino insieme i «mattoni» che costruiranno un nuovo virus dell'AIDS, il farmaco si lega a uno di questi mattoni, impedendo al mattone successivo di allinearsi correttamente.
Somministrato a pazienti del gruppo III, cioè a pazienti che
stanno perdendo la battaglia con il virus, ma che non hanno
ancora l'AIDS, il farmaco può migliorare il loro stato di salute e concedere al 60 per cento di questi malati uno o due
anni di vita di buona qualità. Esso non guarisce ed è meno
utile ai pazienti con l'AIDS che a quelli con complicazioni
meno gravi da infezione di HIV. La maggior parte dei pazienti affetti da AIDS è giovane e il nostro modo di affrontare il problema si basa sulla speranza che un'importante
conquista nel campo della terapia sia dietro l'angolo. Il Retrovir è valido per tenere i pazienti quanto più possibile in
buona salute per un tempo il più lungo possibile.
Si tratta di un progresso molto significativo. Il problema
è la spesa. Il farmaco costa circa 8000 dollari l'anno per pa-
ziente e non porta a guarigione. Molti non possono permetterselo, avendo perso il posto di lavoro ed avendo già l'aggravio delle parcelle mediche. Negli Stati Uniti, solo coloro
che sono ricchi o che sono aiutati dalla famiglia o dagli amici possono concederselo. Nei paesi con un servizio mutualistico statale, lo Stato si tira indietro di fronte ai conti, specialmente perché si stanno accumulando prove scientifiche
che suggeriscono di somministrare l'AZT a pazienti del
gruppo II, cioè a pazienti infetti e infettivi, ma che stanno
bene. Il farmaco può aiutarli a combattere l'infezione da
HIV, e sappiamo già che riduce il rischio di infettare il partner sessuale. In numerosi paesi, però, lo Stato ha detto
«Basta!». È stato introdotto un sistema di contributi e dopo che questi sono stati concessi, lo Stato non darà altro danaro per il farmaco.
Questo atteggiamento ha dato luogo ad un dibattito profondo e di lunga portata. Sta a noi, nella società, decidere
quanti, dei progressi tecnici che sono oggi disponibili o lo
saranno presto per prolungare la vita di un individuo, possiamo o vogliamo permetterci. Dall'AZT ai cuori artificiali,
il dibattito deve portare a una discussione che coinvolga
tutta la società sulle priorità che poniamo sulla vita di un individuo. Certamente quelli tra noi che devono guardare negli occhi un paziente colpito dal virus dell'AIDS e dirgli che
è in ritardo di una settimana per ricevere aiuto dall'AZT
pensano che finora nessuna società occidentale abbia speso
abbastanza per questo farmaco. Comunque, tutti ci rendiamo conto che deve esserci un limite. Questo limite non può
essere stabilito dai medici. Per quaranta centesimi di dollaro la settimana per paziente, potremmo eliminare la malaria, ma non spenderemo quel denaro. Problemi come
l'AIDS possono costringerci a cimentarci con decisioni che
riguardano il concedere ciò che è disponibile, ma è molto
costoso. Può una città costruire un nuovo teatro dell'opera
e non mostrarsi capace di fornire un farmaco a migliaia di
giovani per conservare loro la vita? Io lo dubito.
242
Le scorte di sangue
Prima del maggio 1985, molte persone infette (dato che la
maggior parte degli individui infettati dall'HIV continua a
star bene per anni) hanno donato o venduto il proprio sangue alla Croce Rossa o ad altre banche del sangue commerciali. Il sangue donato viene il più delle volte ripartito tra
due riceventi: i globuli rossi possono essere dati a un paziente e il plasma a un altro. Migliaia di pazienti in tutto il
mondo sono stati infettati in tal modo: il 100 per cento delle
persone a cui è stato trasfuso sangue infetto si è infettato.
Dicerie malevole circolavano in vari continenti sostenendo che maschi omosessuali, infettati dall'HIV, avevano dato deliberatamente il proprio sangue alle emoteche per fare
in modo che anche la comunità eterosessuale si infettasse.
In nessuna parte del mondo vi sono prove che queste dicerie
abbiano un fondo di verità.
Nel maggio del 1985 la maggior parte delle banche del
sangue, nel mondo occidentale, avviò lo screening di tutto il
sangue donato per cercare gli anticorpi contro l'HIV: un
compito laborioso e costoso, ma ovviamente essenziale.
Molto prima di questa data erano state introdotte misure
per dissuadere gli individui appartenenti ai gruppi ad alto
rischio dal donare sangue. Sono state date informazioni
scritte agli eventuali donatori spiegando in modo esplicito il
motivo per il quale non dovevano dare sangue. Combinando lo screening per la ricerca degli anticorpi con la compilazione di un questionario molto dettagliato, le banche del
sangue hanno così praticamente abolito il rischio di contrarre l'infezione da HIV dal sangue o da un suo derivato.
Quando sarà disponibile il test per l'antigene, scomparirà
anche quel piccolissimo rischio che rimane, e cioè che qualche individuo patologico, infettato dall'HIV qualche settimana soltanto prima della donazione, possa cavarsi d'impiccio mentendo sul questionario e sfuggendo così al riconoscimento tramite lo screening per la ricerca degli anticorpi. Tuttavia, rimangono numerosi problemi.
In molti paesi centinaia, o addirittura migliaia, di indivi243
dui infettati da sangue contaminato sono inconsapevoli di
esserlo. È una brutta notizia per loro e naturalmente significa che i loro partner sessuali sono a rischio. Negli Stati Uniti finora ne sono stati trovati solo 3000 su 12.000, che pensavano di essere stati infettati in tal modo. Per questa ragione molti paesi che possono permettersi di farlo stanno chiedendo ai pazienti che hanno ricevuto sangue o prodotti del
sangue nel periodo vulnerabile per il loro paese (il periodo
1978-1985 per gli Stati Uniti) di sottoporsi al test per la ricerca degli anticorpi contro l'HIV. È difficile realizzare un
simile programma senza causare panico e senza rinfocolare
la paura sulla validità delle odierne scorte di sangue. A Sydney, in Australia, sarà necessario sottoporre allo screening
275.000 persone nel tentativo di trovare i 400 riceventi infettati.
Affrontiamo ora un ulteriore problema di notevole interesse per i viaggiatori. Molti paesi non sottopongono a
screening i donatori di sangue. La maggior parte non può
permetterselo (Africa, Filippine, Indonesia e altri), mentre
alcuni sono molto riluttanti a introdurre queste misure.
Quando leggerete queste righe, si spera in una situazione
cambiata. I viaggiatori dovrebbero comunque sapere se un
paese che progettano di visitare ha oppure no una banca del
sangue sicura. Questa informazione viene fornita dalla
maggior parte delle compagnie aeree.
La mancanza di una procedura standard per effettuare il
test fa sì che molte sedi diplomatiche esigano che tutto il loro
personale sia sottoposto al test per l'HIV prima di essere inviato nelle rispettive destinazioni. In questo modo possono
fare assegnamento l'uno sull'altro se dovesse rendersi necessaria una trasfusione di sangue. Un simile ragionamento è
alla base della decisione di molti paesi di sottoporre a test
tutto il personale delle forze armate. In quest'ultimo caso,
l'aver capito che l'infezione del cervello da parte dell'HIV
può alterare la validità del potere decisionale, prima che si
rendano manifeste le principali manifestazioni dell'infezione da HIV, ha dato impulso al programma di screening.
244
L'epidemia di AIDS ha visto il proliferare di numerose
emoteche private, che conserveranno il vostro sangue per
voi nel caso ne abbiate bisogno in piccola quantità vicino a
casa vostra. Questa è un'idea ragionevole, anche se costosa.
Naturalmente queste banche non saranno in grado di aiutarvi se un grosso incidente richiederà una trasfusione immediata oppure se i vostri problemi insorgono lontano da
casa. Per questa ragione, è importante che tutti si rendano
conto che il sangue fornito da banche che fanno riempire
questionari ai loro donatori e ne sottopongono il sangue a
screening possa oggi essere considerato perfettamente sicuro.
Le zanzare
Molte persone hanno difficoltà a credere che le zanzare non
diffondono l'HIV. Ma è proprio così. E oggi sappiamo anche perché. Un'analisi scientifica accurata su zanzare, alimentate deliberatamente con sangue infettato dall'HIV, ci
ha insegnato che, dopo un pasto, non rimane sufficiente
sangue sull'apparato pungente della zanzara per cui vi sia
un numero abbastanza elevato di linfociti T infetti da trasmettere l'HIV alla prossima vittima della zanzara. Inoltre,
il virus che giunge nello stomaco della zanzara non può
moltiplicarsi e infettare la zanzara stessa. Il virus viene, ai
fatto, ucciso. Senza duplicazione esso non può concentrarsi
nelle ghiandole salivari della zanzara, uno stadio indispensabile perché, al momento della puntura, i microrganismi
possano essere trasmessi. Quelle malattie che le zanzare diffondono comportano la partecipazione di parassiti o virus
che hanno adattato il proprio stile di vita per poter sopravvivere e, in alcuni casi, prosperare all'interno della zanzara.
Siamo fortunati che, nel modellarsi, l'HIV abbia trascurato
le fasi di adattamento necessarie per utilizzare le zanzare.
Vi sono numerosi altri problemi connessi con l'AIDS,
che non possiamo discutere qui, ma che sono notevolmente
importanti. Le polizze di assicurazione per la vita, nel caso
di persone infettate dall'HIV e per coloro che appartengono
245
a gruppi ad alto rischio, il controllo della diffusione dell'HIV nelle carceri dove sono così comuni l'uso di droghe
iniettabili per via endovenosa e il «sesso istituzionale», politiche intelligenti per l'insegnamento scolastico a bambini infettati dall'HIV, l'ampliamento dei servizi della comunità
per fronteggiare la morte di così tanti giovani e l'accettazione da parte dello Stato delle loro responsabilità globali sono
solo alcuni degli argomenti urgenti che richiedono determinazione.
L'HIV ci si sta presentando con molte gravi sfide. Nei loro documenti, un giorno gli storici potranno raccontare
molto su di noi (sempre che non vinca l'HIV), se saremo
stati sufficientemente intelligenti da sradicare un virus non
con un farmaco o un vaccino, ma semplicemente modificando il suo comportamento pericoloso. Poiché non vi sono segni che ci siamo evoluti fino al punto in cui possiamo
accettare questa sfida, raddoppiamo i nostri sforzi per trovare una cura. Mentre leggevate questo capitolo almeno
cinque persone sono morte di AIDS e altre cinquanta sono
state infettate dal virus.
246
Parte IV
DOVE SONO I GENERALI?
7
Capire le allergie
Nel 1905, lo scienziato austriaco Clemens von Pirquet condusse una ricerca in cui per la prima volta fu introdotto il
termine «allergia», dando con ciò un decisivo contributo allo sviluppo dell'immunologia, una scienza appena agli albori. I risultati del suo lavoro furono condensati in un manoscritto che, nel 1911, fu pubblicato su una rivista medica
americana. Tra un articolo in cui si esponevano i rischi per
la salute delle donne che indossavano corsetti troppo stretti
e uno sui rischi di infezione incrociata nei treni poco ventilati, c'era il suo resoconto di ben 85 pagine, intitolato «Allergia».
Per capire il significato della ricerca di von Pirquet, dobbiamo spendere un po' di tempo per inquadrare lo stato
dell'arte in cui si muoveva la scienza dell'epoca. Agli inizi
del secolo si sapeva che la protezione immunologica (cioè la
ragione per cui non si prende la stessa infezione due volte)
era da mettere in relazione con la comparsa di sostanze nel
sangue degli individui guariti da un'infezione iniziale. Queste sostanze furono chiamate «anticorpi». In tutto questo
non c'era alcuna cognizione del ruolo del timo, né si conoscevano i linfociti T. Il concetto di cellule che attaccano
specificamente gli invasori dei tessuti sarebbe emerso solo
una quarantina d'anni dopo.
Tra le malattie infettive che flagellavano l'Europa, nessuna era più devastante della tubercolosi, un killer che non rispettava alcuna età. Dagli organismi che la causavano, von
249
Pirquet aveva isolato ed estratto una proteina molto utile,
la tubercolina. Essa era in sé innocua, non essendo infettiva, ma quando veniva iniettata nella cute di un individuo
poteva dar luogo a due effetti. O non si notava alcuna reazione o, lentamente, dopo quarantotto ore, nel punto di
iniezione compariva una macchia rossa rilevata, pruriginosa: era la reazione alla tubercolina. Quest'ultimo evento era
molto importante, in quanto indicava che i batteri responsabili della TBC erano stati o erano ancora presenti nell'organismo e il sistema immmunitario aveva reagito o stava
ancora reagendo ad essi. I pazienti con TBC sospetta, ma
con test cutanei negativi, dovevano cercare un'altra causa
per i loro problemi di salute.
Oggi, possiamo affermare che la proteina estratta dai
batteri è riconosciuta dai linfociti T, presenti nella cute, e
che questi danno l'allarme. I meccanismi di difesa vengono
lanciati a capofitto nella battaglia e, se uno ha già avuto
una precedente esperienza con gli stessi microrganismi, la
sua capacità difensiva sarà così efficiente che, alla fine delle
quarantotto ore, un attacco massiccio sarà già stato sferrato e sarà ormai chiaramente visibile. Tutto ciò che von Pirquet sapeva di sicuro era che una reazione positiva significava che il paziente, in un dato momento, era entrato in
contatto con i microrganismi responsabili della tubercolosi.
Negli esperimenti che progettò per capire meglio questa
reazione, von Pirquet si servì di cavie e di un'altra proteina
più facile da trovare, l'albumina, la proteina del bianco
d'uovo. Se la sua teoria sulla reazione della tubercolina era
giusta, sarebbe bastato immunizzare o sensibilizzare un animale con una proteina qualsiasi e verificare la reazione cutanea rivelatrice. Iniettando albumina da bianco d'uovo
nella cute di una cavia sensibilizzata, si sarebbe prodotta la
stessa reazione osservata quando l'estratto dei microrganismi che causano la TBC era stato iniettato in un paziente
affetto da quella malattia.
Ciò che von Pirquet trovò non era però quello che si
aspettava. Quando iniettò albumina d'uovo nella cute di
250
una cavia, notò una reazione immediata. Nello spazio di
minuti, talvolta di secondi, nel punto di iniezione comparve
un arrossamento. Questa era chiaramente una reazione diversa da quella che aveva impiegato quarantotto ore a svilupparsi con l'estratto di tubercolina.
Ulteriori ricerche mostrarono che la reazione immediata
non preannunciava affatto l'immunità e, in effetti, poteva
essere pericolosa. Talvolta, quando von Pirquet ed altri
scienziati interessati agli stessi fenomeni iniettavano certe
proteine come l'albumina del bianco d'uovo nella cute di
animali immunizzati, questi non solo mostravano una reazione immediata, ma potevano anche presentare una sintomatologia preoccupante. Alcuni animali cominciavano a
respirare affannosamente fin quasi all'asfissia per poi morire in poco tempo sotto gli occhi attoniti dei ricercatori.
Nell'articolo del 1911, von Pirquet condensò tutte le sue
esperienze di laboratorio e formulò alcune ipotesi. Chiaramente, immunizzando un animale (o anche un essere umano), si altera il livello di energia della risposta del sistema
immunitario al materiale iniettato. Una risposta vigorosa
caratterizza l'individuo sensibilizzato. Questo stato alterato
di energia immunologica è stato chiamato da von Pirquet
«allergia», un termine che deriva da due parole greche: allos, che significa «diverso», e ergon, che significa «attività». Von Pirquet distinse l'allergia in due forme: l'utile e
l'inutile. Una reazione immediata a una sostanza qualsiasi
alla quale si sia stati sensibilizzati è una forma inutile, forse
addirittura pericolosa, di allergia. D'altra parte, la reazione
ritardata è molto utile.
Dal 1911, la definizione rigorosa del termine «allergia»,
come è stata data da chi ha coniato il termine, si è modificata. Nella maggior parte dei casi, il termine definisce soltanto quella forma inutile, ma potenzialmente pericolosa, di
immunità che è nota più correttamente come ipersensibilità
immediata. Le reazioni del tipo della tubercolina, invece,
fanno parte della ipersensibilità ritardata.
L'affascinante storia di von Pirquet annovera molti altri
251
episodi riguardanti la scoperta originale: dalle osservazioni
sui benefici effetti della luce solare dal punto di vista medico a nuove importanti cognizioni sulla nutrizione.
Von Pirquet aveva la reputazione di non vedere di buon
grado gli sciocchi (era un terribile autocrate nel suo ospedale) e una moglie che tutti ritenevano non adatta per lui. Essa
non era al suo stesso livello mentale e sociale. Era grassa,
pigra, irragionevolmente esigente e viziata. Malgrado ciò,
in un modo o nell'altro, riusciva a fare di lui quello che voleva: spesso gli telefonava in ospedale e, anche se egli aveva
una conferenza stampa o un esperimento urgente da completare, correva a casa per fare ciò che lei gli ordinava. Era
veramente il rapporto più strano che si potesse immaginare.
Al sommo della fama, mentre era ancora molto attivo,
von Pirquet una sera tornò a casa dal lavoro, predispose bene le cose per l'assenza dall'ospedale che aveva programmata, ed ebbe con la moglie una piacevole cena, allietata da
una buona bottiglia di vino. Insieme, poi, con un paio di
capsule di cianuro, diedero l'addio a questo mondo. L'umanità era così imperfetta e opponeva una tale resistenza al
cambiamento che lui e sua moglie avevano deciso di averne
abbastanza.
E così siamo giunti a esaminare questo importante argomento che è l'«allergia», una branca dell'immunologia di
cui si occupano in pari misura i migliori e i peggiori scienziati nel nostro campo, nonché alcuni guaritori non medici
bene intenzionati, ma fuorviati, e quei ciarlatani opportunisti, che accumulano fortune sulla sofferenza altrui.
Dal 17 al 24 per cento degli esseri umani subisce gli effetti
spiacevoli delle reazioni di ipersensibilità immediata. Che
queste reazioni siano scatenate dal polline nel naso o lungo
le vie respiratorie, dai gamberi nell'intestino o da una dose
di penicillina nei glutei, i meccanismi messi in atto sono
identici a quelli osservati da von Pirquet quando iniettava
la proteina del bianco d'uovo nelle cavie.
Dobbiamo cominciare descrivendo i meccanismi che provocano le reazioni di ipersensibilità immediata. Da molto
252
tempo sappiamo che la causa è in circolo nell'organismo e,
pertanto, con tutta probabilità si tratta di un anticorpo.
Dobbiamo questa scoperta a Prausnitz e Kustner, due
membri di quella scuola tedesca, che con le sue indagini
d'avanguardia stupì la medicina nei primi anni di questo secolo.
I due scienziati erano la prova vivente di quello che Pasteur aveva voluto dire, affermando che la fortuna favorisce le menti preparate. Prausnitz e Kustner uscirono una sera a cena. Il secondo ordinò pesce, lo gustò moltissimo, ma
ebbe subito dopo una violenta reazione. Gli si sviluppò sulla pelle un'orticaria con molto prurito e il respiro gli divenne affannoso: l'albero bronchiale era stato preso improvvisamente da spasmi, che diedero origine a un attacco acuto
d'asma. Chiaramente, si era prodotta in lui una «allergia»
da pesce. Si tratta di una risposta immunitaria inutile, ma
clinicamente importante, come è ovvio: si può anche morire
con reazioni allergiche di questo tipo.
Dopo che Kustner si fu ripreso, i due amici discussero il
fatto e decisero che una delle loro teorie predilette poteva
ormai essere verificata. Se certi anticorpi nel sangue erano
responsabili di reazioni allergiche ad alimenti come il pesce,
i pomodori, le noci e il cioccolato, si poteva pensare che
un'iniezione di siero di individuo allergico a un particolare
alimento (per esempio, al pesce) nel corpo di un ricevente
non allergico alterasse in quest'ultimo lo stato di energia
immunologica, facendogli così acquisire passivamente lo
stato allergico del donatore?
Venne prelevato sangue da Kustner e il siero (cioè il sangue senza i globuli in esso contenuti) fu iniettato sotto la cute del braccio di Prausnitz. Realizzato questo intervento
senza alcun effetto negativo, Kustner procedette al test importante. Che cosa sarebbe accaduto se un poco di estratto
di pesce fosse stato iniettato nella cute dove era stato iniettato il siero?
Ebbe luogo immediatamente una violenta reazione allergica locale. I due scienziati, in modo non convenzionale ma
253
convincente, dimostrarono che essa era causata da qualcosa
che circolava nel sangue, presumibilmente un anticorpo.
Questo anticorpo noi lo chiamiamo oggi IgE, immunoglobulina E (E per emergenza, se volete).
Ora, come è già stato messo in rilievo descrivendo il sistema immunitario, non vi è nulla di anormale nella produzione e nella secrezione della IgE. Quanta se ne produce è il
punto che qui importa.
Quando vi graffiate nel potare le rose e qualche batterio
penetra nella lesione che vi siete prodotta, è necessario che
si scateni una battaglia locale se il sistema di difesa deve sterilizzare la ferita e permettere la cicatrizzazione. Le cellule e
gli anticorpi necessari per questo scopo devono essere trasportati nel punto infetto attraverso il sangue che fluisce nel
vaso più vicino. Sarebbe chiaramente un vantaggio se si potesse aumentare la portata del sangue vicino alla lesione. Se
i minuscoli vasi sanguigni nella pelle circostante si dilatassero, una maggiore quantità di sangue potrebbe fluire nella
zona lesa.
In seguito alla dilatazione, i pori nella parete dei vasi sanguigni, attraverso i quali le cellule devono passare per entrare nei tessuti, si stirerebbero bene. I vasi sanguigni hanno
un rivestimento costituito da fibre muscolari circolari.
Quando queste fibre si contraggono, una minor quantità di
sangue fluisce nel vaso. Quando esse si rilasciano, avviene
l'opposto. Il corpo può così irrorare un'area specifica con
una maggiore o una minore quantità di sangue, secondo le
circostanze. Certe sostanze fanno rilasciare le pareti dei vasi
sanguigni, mentre altre le fanno contrarre. Dei numerosi
prodotti chimici interessati in una simile reazione, il più noto è l'istamina.
La Natura ha progettato una serie di piccole mine chimiche, cioè cellule ripiene di differenti tipi di sostanze, che si
possono far esplodere nei tessuti quando è necessario. Esse
si chiamano mastcellule e sono generosamente disperse nei
tessuti.
Per liberare le sostanze in esse contenute, è necessaria la
255
IgE. Le mastcellule che sono piene, ad esempio, di istamina
hanno una membrana che si può legare all'immunoglobulina E. Sulla loro parete esterna, una porzione fisica è complementare a una sezione della coda della molecola dell'IgE. Una volta che la IgE si è legata ad esse, le mastcellule
vengono definite «armate». Tutto ciò che serve è che qualcosa si leghi all'estremità frontale della IgE, che sporge «in
fuori», cioè lontano dalla membrana cellulare. Fatto questo, la reazione esplosiva avrà luogo.
Una volta che antigene e anticorpo si combinano, la mastcellula esplode e libera il proprio contenuto chimico. Producendo l'IgE molto precocemente nel corso di una reazione immunitaria, la Natura ci ha fornito di un «custode» per
i vasi sanguigni. Utilizzando le sostanze presenti nelle mastcellule, possiamo fare deliberatamente dilatare i vasi sanguigni in zone colpite dall'attacco e liberare dal circolo sanguigno quell'esercito immunologico che vincerà il combattimento per noi. Così la IgE, con la sua capacità di liberare
sostanze simili all'istamina, non è inutile. Anzi. Questa forma di ipersensibilità immediata controllata è un elemento
essenziale della difesa umana.
Le sostanze liberate dalle mastcellule sono destinate ad
agire localmente e certamente non ad avere effetti remoti
dal luogo in cui hanno luogo gli eventi promotori. Ma, come capita molte volte nella vita, anche di una cosa buona
può essercene troppo. Troppa IgE significa che troppe mastcellule esploderanno, troppa istamina verrà liberata e
l'effetto locale sarà esagerato. Le sostanze liberate dalle
mastcellule si faranno strada verso altre parti dell'organismo.
Agendo in gruppo, le sostanze delle mastcellule tendono
a dilatare i vasi sanguigni, facendo rilasciare i muscoli circolari della parete che li delimita, mentre hanno effetti opposti sui muscoli che circondano le vie respiratorie, cioè su
quei condotti che trasportano l'aria che inaliamo fin nei
polmoni, dove l'ossigeno viene ceduto al sangue.
Durante una reazione allergica generalizzata, i muscoli
256
delle vie respiratorie vanno soggetti a spasmo e la respirazione si fa difficoltosa, mentre nel medesimo tempo i vasi
sanguigni possono dilatarsi in modo eccessivo. I vasi cutanei interessati in questo fenomeno lasceranno sfuggire nei
tessuti una quantità eccessiva di liquido. I tessuti, di conseguenza, si stirano e, per la presenza di sostanze, si infiammano. Questo accumulo di liquido irritante provoca pomfi
rossi pruriginosi, tecnicamente definiti orticaria.
Alla luce delle conoscenze attuali, von Pirquet avrebbe
dovuto modificare, dunque, il suo concetto di allergia inutile. Essa è inutile e dannosa soltanto se è eccessiva; opportunamente controllata, è invece un grande sistema.
Perfino l'inutilità di reazioni eccessive della IgE viene oggi messa in discussione. Gli scienziati hanno ponderato a
lungo sul fatto insolito che fino al 24 per cento della popolazione mondiale soffra di reazioni allergiche o di un tipo o
dell'altro. La Natura non compie generalmente grossi errori
cronici come questo. Col trascorrere degli anni, le popolazioni con risposte biologiche inferiori tendono a scomparire. Potrebbe dunque l'ipersensibilità immediata essere un
esempio di baratto biologico? Forse la Natura ha trovato
che le potenti reazioni mediate dalla IgE ci proteggono da
qualcosa di gran lunga peggiore del fastidio di avere la febbre da fieno, l'asma o l'orticaria?
Vi è una serie di precedenti biologici per questa forma di
accomodamento. Ecco un esempio. In certe parti del mondo in cui la malaria costituisce un grosso problema, è frequente una carenza enzimatica, che produce una forma
blanda di anemia che reca fastidio alla popolazione, ma
protegge anche le sue vittime dalla malaria, un problema
ben peggiore dell'anemia.
Più di trenta studi, nella letteratura medica, affermano
che gli individui che soffrono di allergie sono meno colpiti
dal cancro di altri. Se fosse vero, questo sarebbe certamente
un bell'esempio di baratto biologico. Purtroppo, vi sono
molti altri studi nella letteratura che negano quest'associazione. Tuttavia, qualche vantaggio nell'essere «atopici»
257
(termine medico usato per descrivere la tendenza ad avere
troppa IgE) può ancora emergere.
Esaminando esattamente il caso clinico che gli si presenta, un medico può determinare che i sintomi della febbre da
fieno sono limitati a quelle sei settimane l'anno in cui il polline dell'ambrosia abbonda nell'aria. Il paziente può riferire che gli occhi che pizzicano, gli starnuti, il naso tappato e
via dicendo gli danno veramente fastidio solo durante l'estate o quando è al lavoro. Non è allergico al lavoro estivo,
ma può essere benissimo allergico al fungo che cresce sui
filtri del condizionatore d'aria in ufficio. Questi organismi
possono venir proiettati nel locale con quella bell'aria fresca, della quale provano un ardente bisogno.
Qualcuno può anche soltanto entrare nell'automobile di
un appassionato di gatti per cominciare a starnutire. Anche
se i gatti non sono nell'automobile, ma vi sono stati in precedenza, hanno lasciato dietro di sé qualche «bighellone»,
cioè minuscole (e pertanto facilmente disperse nell'aria) desquamazioni della pelle, che provocano così tanto fastidio
alle persone che ne sono allergiche.
Il lavoro dell'investigatore storico è importantissimo per
affrontare alla base un problema di allergia. Allergie presenti tutto l'anno significa esposizione tutto l'anno a uno o
più elementi a cui reagire. Una delle cause più comuni in tale situazione è la polvere di casa, o, più specificamente,
qualcosa contenuto nella polvere di casa.
Qualcuno che sia fiero della pulizia della propria abitazione può notare che, quando rifà il letto, se i raggi del sole
entrano dalla finestra secondo una giusta angolatura, milioni di piccole particelle appaiono disperse nell'aria. La stessa
cosa accade ogni volta che si sposta un tappeto o ci si lascia
cadere di peso su un divano imbottito. La polvere delle nostre case contiene spesso gli escrementi di un visitatore comune, ma non gradito, delle abitazioni: l'acaro della polvere.
Si pensa che, in un materasso medio, in Nordamerica, si
trovino centinaia di queste piccolissime creature di nome
258
acari e parecchi studi suggeriscono che, nei materassi in Europa, se ne trovino ancora di più. Questi animaletti prosperano nell'intimità del materasso e al tepore (talvolta calore)
del corpo che vi è adagiato sopra.
In sé gli acari arrecano poco danno, ma producono per
contro molti escrementi, i quali sarebbero innocui se non
fosse per la natura tipicamente meticolosa dell'animale. Diversamente dalla maggior parte delle altre specie, gli acari
avvolgono le loro feci in un liquido colloso: per così dire, le
imballano per poi eliminarle. Per coloro che hanno i geni
giusti (o sbagliati), questo rivestimento è estremamente immunogeno. Si hanno così problemi a livello delle vie respiratorie quando le particelle fecali così confezionate vengono inalate e scatenano reazioni mediate dalla IgE.
Per rendersi conto di come, per esempio, il polline di ambrosia provochi un raffreddore che tappa completamente il
naso o lo fa colare come un rubinetto aperto, basta guardare chi soffre di raffreddore da fieno. John, 36 anni di età,
soffre da molti anni di rinite stagionale (infiammazione del
naso). Per sei settimane l'anno egli ha il naso completamente tappato.
Il naso ci serve per discernere gli odori. In realtà, le papille gustative sulla lingua sono inutili per un compito così delicato come è quello di distinguere una salsa da gourmet da
una varietà di salsa comune. La lingua riesce a distinguere
la differenza tra dolce, acido, amaro e così via, ma non riesce a differenziare i sapori in sottocategorie: con il naso
completamente bloccato, una mela e una cipolla hanno lo
stesso gusto. A livello del naso, nervi dalla funzione meravigliosa riescono invece a distinguere gli odori da cui dipende il piacere che proviamo nel mangiare un cibo gustoso e a
segnalarci il pericolo in altre situazioni. Tutto questo in uno
stile tipicamente immunologico. Le singole fibre nervose
che terminano nel naso presentano piccoli prolungamenti
che sporgono nella cavità della narice. Proprio come i linfociti possono riconoscere un solo antigene, così qualunque
cellula nervosa può riconoscere un solo odore. Quando un
259
nervo particolare riconosce il proprio «odore», invia un
messaggio al cervello, sotto forma di scarica di impulsi elettrici, e noi allora potremo «sentire» quell'odore, che sarà
poi evocato nel cervello stesso. Questa meravigliosa capacità di discernimento viene a mancare quando il naso è tappato.
Il naso serve anche ad aumentare il grado di umidità dell'aria che inaliamo. Per la Natura noi dovremmo respirare
con il naso. La ricca vascolarizzazione di questa parte del
corpo (che spiega anche la facilità con cui si verificano
emorragie) e la presenza di ghiandole mucose, che contengono acqua in abbondanza, stanno a significare che l'aria
che inaliamo può essere da noi rapidamente riscaldata e
umidificata. I peli nel naso trattengono una grande quantità
di particelle trasportate dall'aria e che non devono entrare
nei polmoni. Tutto considerato, il naso è un organo complicatissimo, sofisticato ed essenziale; pertanto, il renderlo
non funzionante è molto più che un semplice fastidio.
Quando il polline dell'ambrosia entra nel naso di John,
viene assorbito in parte attraverso la mucosa vascolarizzata. Ciò accade a tutti. L'antigene viene presto riconosciuto
dai linfociti B, ma questi, sfortunatamente per John, sono
programmati per produrre contro di esso una quantità eccessiva di IgE. Una successiva inalazione dello stesso tipo di
polline da parte di John stabilirà una situazione in cui il
polline, assorbito attraverso la mucosa nasale, incontra una
grande quantità di immunoglobuline E già formate. Come
abbiamo già descritto, le IgE presenti alla seconda esposizione, o alle esposizioni successive ai pollini dell'ambrosia,
si trovano alla sommità delle mastcellule. Una volta che esse interagiscono con i granuli pollinici, le mastcellule liberano il loro contenuto. Questo provocherà un rigonfiamento
o una dilatazione della vasta rete sanguigna del naso. Procedendo la dilatazione, i pori della parete dei vasi si dilateranno e molto liquido fluirà nei tessuti circostanti. Ciò provocherà un rigonfiamento delle delicate mucose nasali che
determinerà un'occlusione delle narici. Può darsi che la mu260
cosa si rigonfi a un punto tale che, alla fine, per il peso dell'acqua che contiene, darà luogo a un prolasso e formerà un
polipo nasale. È questa la natura della rinite allergica.
John ha problemi con il polline dell'ambrosia perché produce troppa IgE contro un antigene di questo particolare
polline. Sua moglie no. Può darsi che anch'essa abbia nel
sangue, e forse perfino nel naso, un poco di IgE contro il
polline dell'ambrosia, ma non a sufficienza per produrre la
reazione eccessiva responsabile della sintomatologia di suo
marito.
Per riuscire a determinare quali sintomi descritti dal paziente siano causati da una reazione di ipersensibilità immediata, un medico deve basarsi sulla conoscenza del tipo di
disturbi che le varie sostanze possono provocare e sulle proprie capacità investigative. Può ricevere un considerevole
aiuto dal test cutaneo di von Pirquet, ammesso che ne conosca le insidie. Molti medici allergologi, mi sento di dover
mettere sull'avviso, le ignorano.
Se si scalfisce la cute e si lascia cadere nella lesione una
quantità in tracce di qualcosa alla quale si sospetta che il
paziente sia allergico, una reazione immediata confermerà i
sospetti, mentre un risultato negativo lascerà dubbi sull'argomento. Preferiamo, per due ragioni, ricorrere alle scarificazioni piuttosto che alle iniezioni intracutanee. L'iniezione
di quantità anche piccole di antigene nella cute di un soggetto estremamente sensibilizzato può provocare una reazione
così violenta da determinare addirittura il decesso, del paziente. In secondo luogo, quando sottoponiamo un paziente a un test cutaneo cerchiamo le forme estreme della sensibilità. Come già spiegato, una reazione non è, in sé, un fatto anormale. Sono le forme estreme della reazione che ci interessano. I soggetti normali non produrranno una reazione
immediatamente visibile alle quantità in tracce del materiale
su cui indagare.
Ricordo bene che, come giovane interno, ero impaziente
di praticare un piccolo intervento chirurgico. In rare occasioni gli interni, che gerarchicamente si trovano al livello
261
più basso dello staff medico, ricevono il permesso di suturare una ferita o di eseguire qualche intervento chirurgico
molto, molto secondario. Alla fine di un lunghissimo giorno con molti interventi, un chirurgo si rivolse a me dicendo
che il mio grande momento era arrivato. L'ultimo paziente
in lista aveva sulla schiena un piccolo polipo, simile a una
verruca, che potevo rimuovere da solo. Tutto quello che
dovevo fare era iniettare nella zona circostante un poco di
anestetico, tagliare la protuberanza e quindi applicare uno
o due punti per arrestare l'emorragia. Non era esattamente
un trapianto di cuore, ma accettai.
Con solo un paio di infermiere estasiate, lasciate lì a vedere quale era la mia abilità, cominciai a iniettare l'anestetico locale nella schiena del paziente. Non potevo aver somministrato più di una goccia di liquido ed ecco che il paziente crollò sul tavolo, cominciando rapidamente ad ansimare
in modo orribile e sbiancando in viso, fino ad assumere un
pallore mortale. Aveva avuto una reazione di ipersensibilità
immediata all'anestetico locale. Perché ritornasse normale
furono necessari due giorni nell'unità di cure intensive, con
ogni sorta di apparecchiature sofisticate e di farmaci. Da
quel momento in poi ebbi un sano rispetto per l'ipersensibilità immediata.
Oggi test molto sensibili sul sangue sono in grado di misurare le IgE contro tutta una schiera di antigeni (o allergeni, come sono spesso chiamati in questo contesto). Essi utilizzano isotopi radioattivi che possono essere chimicamente
legati alle IgE. Sono, in effetti, molto sensibili, anche se
non molto facili da interpretare.
Di recente ho visitato un dirigente della IBM, pallido ed
emaciato, che mi era stato inviato perché aveva un terribile
problema allergico. Da sei mesi il pover'uomo era stato colpito da una forma cronica di orticaria e da allora aveva vissuto miseramente, senza intermittenza o quasi, a causa del
gonfiore e del prurito, localizzati agli occhi, alle mani e ai
piedi. II medico di famiglia lo aveva indirizzato da un allergologo, il quale gli aveva ordinato una miriade di test sul
262
sangue, alla ricerca di anticorpi (IgE) contro più di settanta
differenti sostanze alimentari, oltre che contro farmaci,
graminacee, pollini e via dicendo. Tremiladuecento dollari
dopo, il paziente ricevette la brutta notizia: aveva nel sangue anticorpi contro quasi tutti gli alimenti per i quali erano
stati approntati i test.
Protestò immediatamente, assicurando che, in vita sua,
non era mai stato allergico ad alcuna cosa. Certamente
quell'orticaria non poteva essere messa in relazione a quello
che mangiava. L'allergologo, tuttavia, ribatté che tutto era
ora cambiato in lui e gli studiò una dieta, per la quale il pover'uomo poteva mangiare soltanto riso, lattuga e un poco
di agnello. Tutto quello che gli piaceva era stato bandito.
Combatté coraggiosamente per molti mesi, cercando di
osservare la dieta. In questo periodo perse peso, cosa che
non era affatto necessaria per lui, e l'orticaria. Il medico fu
soddisfatto, il paziente meno perché pensava che la cura
fosse peggiore della malattia. A questo punto si ribellò e andò in cerca di una seconda opinione.
Parlando con lui, seppi che il medico che aveva consultato per primo si era basato esclusivamente sui test ematici,
invece che sulla storia delle reazioni, la quale, come risultò,
conteneva importanti indizi. Appresi anche che non era stato fatto alcun tentativo per eliminare un gruppo di alimenti
alla volta. Dopo averlo interrogato con grande attenzione,
non ero affatto convinto che egli avesse bisogno di una dieta così stretta.
Quando fu colpito da orticaria, si trovava in uno stato di
grande tensione dovuta al lavoro: ebbi il sospetto che il suo
problema non avesse nulla a che fare con l'allergia. Non
tutta l'orticaria, cioè l'anormale dilatazione dei vasi sanguigni cutanei, è provocata da meccanismi correlati con le immunoglobuline E. A poco a poco restituimmo quell'uomo a
una dieta normale e l'orticaria non fece più la sua comparsa.
La morale in tutto questo è che un trattamento drastico,
basato sull'impiego esclusivo di questi test molto sensibili
263
sul sangue, è un errore. I test che riescono a trovare l'immunoglobulina E contro vari elementi sono importanti nel
confermare i sospetti basati sull'anamnesi e sui test cutanei
e ci forniscono uno strumento di ricerca utile. Tuttavia i loro risultati devono essere vagliati da clinici molto preparati.
Negli Stati Uniti, chi cerca un allergologo è consigliato di
rivolgersi a un medico laureato presso la cattedra di allergia
e immunologia, una sottospecialità sanzionata dalla American Medicai Association per esaminare chi si specializza in
questo settore e proclamarne l'avvenuto completamento degli studi con successo.
Ritengo che sia particolarmente importante evitare quei
medici che praticano la chirurgia dell'orecchio, del naso e
della gola e considerano l'allergia come un «extra». Purtroppo, in Nordamerica e altrove questi individui sono in
numero sempre crescente. Tranne alcune eccezioni, la maggior parte dei medici, che sono fondamentalmente medici
chirurghi, è molto impreparata quando deve affrontare una
malattia allergica. Di tanto in tanto, ricevo ancora pazienti
che mi sono inviati e che sono stati curati in modo del tutto
disonesto da questi individui.
Per molti medici chirurghi, l'allergia è una occupazione
secondaria lucrativa. Siate particolarmente diffidenti del
medico che vi dice che siete fortunato perché ha nel suo studio una macchina che esegue i test sul sangue descritti prima. Questi test, che con poca probabilità possono essere
letti correttamente da un osservatore non pratico, potranno
costarvi una fortuna.
Uno dei principali problemi che riguardano le allergie sta
per essere risolto, ma lentamente. Finora veramente poche
sostanze che provocano reazioni allergiche sono state purificate.
Supponete di avere una reazione ogni volta che mangiate
pomodori. Usando una terminologia scientifica in senso lato, potreste dire di essere allergici «ai pomodori». Ciò che
volete dire, in verità, è che reagite a qualcosa che è presente
nella complessa costituzione del pomodoro. Questo qualco264
sa potrebbe addirittura non essere presente nel pomodoro
indigerito, ma potrebbe comparire solo dopo che il vostro
organismo ha cominciato a demolire metabolicamente le
sostanze presenti nel pomodoro che avete mangiato. Per
questo motivo, i test per le allergie, che utilizzano estratti
grezzi di un particolare alimento, tendono ad essere molto
inaffidabili.
Di recente, un gruppo di eccellenti immunologi di San
Antonio, nel Texas, ha esaminato scientificamente tutti i
test disponibili per diagnosticare l'allergia di origine alimentare, tra cui quelli che abbiamo descritti. Essi hanno
concluso che l'unico modo di diagnosticare questo tipo di
allergia è quello di una buona anamnesi, seguita dalla rimozione dalla dieta di un alimento, o di un gruppo di alimenti, su cui esistono sospetti. Se il paziente migliora, si
potrebbe lanciare una sfida, reintroducendo nella dieta
quell'alimento, o quel gruppo di alimenti. Questo procedimento, se effettuato con cura, in condizioni controllate, è
sicuro e non priva il paziente, senza necessità, di uno dei
grandi piaceri della vita. Tutto si riduce a questo: i pazienti
con allergie alimentari sospette hanno bisogno che il loro
caso sia accuratamente accertato e poi seguito da medici
esperti, che capiscano i meccanismi in esso coinvolti e abbiano consapevolezza dei limiti delle nostre attuali conoscenze.
Può darsi, ed è in effetti probabile, che, in rari casi, una
persona mostri gravi sintomi dopo aver mangiato qualcosa
di specifico e che ciò accada attraverso un meccanismo che
non ha nulla a che fare con l'allergia. Un alimento è nulla
più di un mucchio di sostanze correntemente accettabili,
dotate di proprietà nutrizionali o in grado di soddisfare
l'appetito. Il metabolismo di alcuni individui può essere diverso da quello della maggior parte degli esseri umani e la
reazione di questi individui all'ingestione, per esempio, di
succo di mele può essere differente dalla mia o dalla vostra.
Talvolta l'ingestione di una sostanza particolare può
265
portare alla liberazione di alcuni composti chimici che le
stesse IgE producono. In questo caso, tuttavia, il fenomeno
non è attivato attraverso un meccanismo immunologico.
Alcuni anni fa, sono stato coinvolto come «testimone
esperto» in un caso tragico, che diede luogo a un processo.
Un errore da parte di un sanitario aveva provocato la morte
di una giovane madre e decretato la fine di una carriera medica.
Susan, trentatré anni, era madre di tre bambini. La sua
salute generale era buona, ma era sotto esame perché aveva
periodi mestruali eccezionalmente dolorosi, associati a fortissimi mali di testa. Prima della maternità, che la occupava
a tempo pieno, Susan era stata infermiera. L'esperienza le
aveva fatto nascere il sospetto che il suo problema avesse
qualcosa a che fare con qualche proliferazione nell'utero.
Mentre, appunto, era sotto esame, iniziò il suo periodo mestruale e, alle 11 della mattina del secondo giorno, si sentiva
così male che, presi con sé i tre giovani figli, si recò al Pronto Soccorso dell'ospedale più vicino. Qui venne esaminata
subito da un'infermiera che cominciò a compilare in breve
la cartella clinica.
Alla domanda di rito: «Siete allergici a qualcosa?», Susan rispose: «Sì, all'aspirina». A quindici anni, le era stata
somministrata l'aspirina per un attacco di tipo influenzale e
le era comparso un esantema di tipo congestizio, associato
a una grave difficoltà respiratoria. Un medico le aveva detto che non avrebbe mai dovuto prendere di nuovo quel farmaco. Alla fine, venne visitata dal medico del Pronto Soccorso, che ascoltò la sua storia, la esaminò e giunse alla seguente conclusione: la paziente era sotto cura da un valente
ginecologo; il suo compito era dunque quello di alleviarle i
disturbi che accusava in quel momento, e nulla più.
Come, purtroppo, avviene non di rado nel caos dei vari
Pronto Soccorso, quel medico aveva da visitare simultaneamente quattro o cinque altri pazienti, sistemati in varie cabine e, tentando di seguire tutto, volteggiava dall'uno all'altro. Le annotazioni delle infermiere per ogni paziente erano
266
sulla sua scrivania: tutto lavoro da completare e mettere a
posto in un momento di calma.
Quel giovane medico si stava specializzando in medicina
interna e manteneva se stesso, la giovane moglie e il figlioletto aiutando al Pronto Soccorso. Era intelligente, ma non
aveva esperienza. Prescrisse a Susan un preparato analgesico-rilassante e alle 14.16 la dimise. Il preparato conteneva,
tra le altre componenti, quantità significative di aspirina.
Alle 14.35 Susan ritirò la prescrizione dal farmacista. Alle
15.15 aveva già preso la prima compressa e, dopo aver lasciato i bambini a una vicina di casa, si era buttata contenta
sul letto, attendendo che i dolori si calmassero.
All'incirca alle 16.30, il giovane medico in ospedale stava
guardando gli appunti delle infermiere. Quando giunse alla
scheda di Susan, si ricordò del caso e poi notò, sottolineato,
l'avvertimento dell'infermiera: «Paziente allergica all'aspirina». Dopo lo choc iniziale dovuto alla consapevolezza del
proprio errore e delle possibili conseguenze di ciò che aveva
fatto, cercò di rassicurare se stesso pensando che, probabilmente, la paziente non avrebbe subito alcun danno. Tuttavia, era chiaro che bisognava telefonarle e dirle di non prendere altre compresse.
A casa di Susan, nessuno rispose. Pur pensando che, con
tutta probabilità, il telefono squillava a vuoto perché Susan
era uscita, qualche segno premonitore lo lasciò turbato,
tanto che, alla fine del servizio, alle 17.30, andò a bussare
alla sua porta. Susan era morta e il decesso doveva essersi
verificato all'incirca alle 16.00. L'autopsia rivelò che causa
della morte era stato un broncospasmo acuto: in seguito all'ingestione di aspirina, era soffocata. Date le circostanze, il
marito di Susan chiamò in giudizio l'ospedale e il medico;
la famiglia ricevette come risarcimento una grossa somma
di danaro, ma certo tutto questo era di ben scarsa consolazione.
Ho raccontato la storia dell'aspirina perché non vi è alcuna prova che, in questo particolare tipo di reazione, l'immunoglobulina E sia in qualche modo interessata. Quando
267
Susan aveva detto di essere allergica all'aspirina, non era
stata precisa da un punto di vista scientifico. Numerosi
composti chimici, dopo essere stati ingeriti, modificano in
vario modo il nostro metabolismo. In alcuni pazienti, come
abbiamo già detto, alterazioni metaboliche portano alla liberazione di quelle stesse sostanze che, in una reazione allergica, agiscono sui vasi sanguigni e sulle vie respiratorie.
Diversamente da queste, però, causano un danno diretto e
non tramite gli anticorpi.
L'aspirina agisce su alcune vie metaboliche cerebrali, eliminando il dolore, ma è anche molto utile come agente antinfiammatorio. Per esempio, è spesso efficace quando
compaiono sul corpo rigonfiamenti caldi e arrossati, come
avviene nel caso dell'artrite. Produce i suoi effetti bloccando le vie metaboliche che portano a quelle sostanze che producono proprio l'infiammazione.
Il guaio con numerosi farmaci è che non si sa quando si
fermano. In altre parole, se si riesce a sbloccare una via metabolica che, per esempio, migliora lo stato delle articolazioni in caso di artrite, si può simultaneamente bloccare
una seconda via, o forse addirittura stimolare una seconda
via che produce effetti dannosi. Il significato di questi effetti potenzialmente dannosi può avere un'importanza clinica
solo in pochi individui. È quanto accade quando si ingerisce
l'aspirina. Poche persone sono così sensibili fino al punto
che essa, oltre a produrre gli effetti normali, porta anche all'accumulo nell'organismo di quelle sostanze che sono interessate in reazioni di tipo allergico. Tali sostanze possono
far dilatare i vasi sanguigni e restringere le vie respiratorie.
L'immunologia non c'entra per niente in questa storia.
Lo stesso meccanismo può verificarsi con numerosi conservanti alimentari e coloranti. Per esempio, la tartrazina,
un conservante alimentare, e i coloranti rossi e gialli che
troviamo oggi in così tanti alimenti possono causare problemi del genere in un individuo che sia particolarmente sensibile ad essi.
Medici e scienziati, data la loro conoscenza di situazioni
268
del genere, devono tenere un occhio aperto sulla possibilità
che qualche sintomatologia bizzarra, che ci è stata occasionalmente descritta dai nostri pazienti, sia di fatto indotta
biochimicamente dalla particolare sensibilità metabolica di
quell'individuo a qualche sostanza ingerita. È di vitale importanza, però, che il medico sia estremamente obiettivo di
fronte a una situazione del genere. Mentre è necessario riconoscere che questi problemi esistono, anche se sono rari, si
deve essere estremamente cauti nel non minimizzare problemi psicologici genuini tirando in causa, per spiegarli, questi
meccanismi.
Il problema sta diventando sempre più serio in numerosi
paesi occidentali e, in particolar modo, nell'America settentrionale. Numerosi individui, indotti in errore o senza scrupoli, stanno guadagnando forti somme di denaro a spese di
pazienti con gravi disturbi psichiatrici, ai quali fanno credere che i loro malanni sono da mettere in relazione a reazioni
allergiche a oggetti presenti nell'ambiente. In altre parole,
essi danno una spiegazione organica di quella bizzarra sintomatologia che colpisce numerosi pazienti, i quali sono più
portati a credere in questo che ad affrontare il fatto di avere
una malattia mentale. Naturalmente, vi sono persone che
presentano nel loro organismo vie metaboliche davvero insolite, le quali possono renderle estremamente sensibili ai
fattori ambientali, ma tutto questo non provoca nulla nella
maggior parte di noi.
Il caso che descriverò ora mostra a quali estremi possa
giungere un modo di pensare non scientifico e quali rischi
medici e finanziari possano derivare da esso.
Rebecca ha ventinove anni e vive a New York. Intelligente, attraente e colta, non lavora da molti anni, chiaramente
perché non riesce a trovare lavoro. È un'assistente sociale
ben preparata che ha compiuto ricerche sui problemi dei
carcerati agli arresti domiciliari e sulla loro reintegrazione
nella società. L'infanzia di Rebecca non è stata felice, anche se, per la verità, non le accadde nulla di veramente
straordinario. La madre non era all'altezza, il padre era un
269
prepotente ubriacone e un fratello era dedito alla droga.
Tutto questo le provocò grande sofferenza. Fin dall'età di
quindici anni soffrì inoltre di rinite allergica e depressione.
Nel 1980, Rebecca ebbe un problema medico assolutamente insolito: un'allergia alla Avery Fisher Hall di New
York. Data la sua passione per la musica, questo fu per lei
un vero problema; molti dei principali concerti della città
erano tenuti in quella sala.
Per essere precisi, Rebecca aveva problemi solo nel ridotto del teatro: non ce la faceva a rimanere lì senza star male.
Le bastava oltrepassare la porta di ingresso ed ecco che era
presa da improvvisa debolezza, le venivano le vertigini, respirava affannosamente e alla fine cadeva sul pavimento,
priva di conoscenza. Accadeva la stessa cosa quando andava in casa di un paio di amici. Nel parlare di questa faccenda con gli amici, indubbiamente molto turbati, le venne
consigliato di consultare un «ecologo clinico», che esercitava a New York. Prese un appuntamento e le fu detto che
doveva entrare in una clinica per sottoporsi a una lunga serie di prove. Andò nel sud degli Stati Uniti per due settimane in una clinica appositamente attrezzata per studiare questi problemi.
Incontrai Rebecca alcuni mesi dopo nella mia clinica per
pazienti esterni alla Yale University. Quando, con la mia infermiera, entrai nell'ambulatorio dove venivano visitati i
pazienti, salutai come d'abitudine. Non ricevetti alcuna risposta e, in effetti, Rebecca era del tutto immobile. L'infermiera e io ci avvicinammo e le parlammo di nuovo. Con
uno sforzo evidente, cominciò a muovere lentamente la mano, tese il dito e lo puntò verso la tasca della giacca. L'infermiera tolse dalla tasca un foglietto con un'annotazione e
una bottiglietta con un contagocce, contenente un liquido
limpido. L'annotazione era di poche parole, ma molto chiara: in caso di catatonia, mettere tre gocce di istamina sotto
la lingua.
La catatonia comporta un'immobilità rigida dei muscoli.
Rebecca aprì lentamente la bocca ed era chiaro che cosa si
270
aspettava facessimo. Le mettemmo con attenzione sotto la
lingua le tre gocce del liquido della bottiglietta su cui era
scritto «istamina» ed ecco accadere il miracolo: nello spazio
di due secondi, si rilassò, sorrise e ci salutò.
Dopo quell'inizio insolito, la interrogammo e registrammo il suo caso. Rebecca era venuta a farsi visitare da me
perché non si sentiva ancora bene dopo il soggiorno in quella clinica del sud, ma perlomeno adesso sapeva che il suo
problema era dovuto a una disfunzione dei linfociti T. Potevo fare qualcosa per lei?
Venimmo a sapere che era stata ricoverata due volte nell'unità di «ecologia clinica» di quell' «ospedale». Alla prima
visita le dissero, dopo una serie di prove per un ammontare
di 4800 $, che aveva una sindrome di allergia totale: cioè era
allergica ad ogni cosa. Era stata dimessa con ben trentadue
bottigliette, il cui contenuto doveva iniettarsi a piccole dosi.
Rebecca tornò a casa, peggiorò invece di migliorare, le
comparvero quegli strani attacchi di rigidità muscolare e ritornò alla clinica per ulteriori esami. Dopo una settimana,
uno degli «specialisti» della clinica le disse che la sua era la
forma più grave della malattia. Le spiegarono che il suo caso veramente grave di sindrome allergica totale era dovuto
a una mancanza di linfociti T normali. La dimisero per la
seconda volta: chiaramente con grandi difficoltà se ne ritornò a New York e venne a trovarmi.
Alla prima visita, vuotò il contenuto della sua borsa marrone sulla mia scrivania. Comparvero le trentadue bottigliette di estratti iniettabili, tutte con etichette scritte a mano e confezionate alla clinica. C'erano vitamine e preparati
di amminoacidi, tra cui uno prodotto a partire dai testicoli
di un toro della Nuova Zelanda.
Rebecca era chiaramente una giovane donna affetta da
disturbi psichici e sono lieto di dirvi che, con l'aiuto di uno
psichiatra di un'importante università di New York, oggi ha
un impiego e, al momento in cui scrivo, non ha più praticamente alcun sintomo.
Abbiamo parlato dell'importanza dell'anamnesi ogni271
qualvolta ci si imbatte in un problema medico, particolarmente quando si ricerchino potenziali allergeni. Non ci volle molto per trovare che il fidanzato di Rebecca l'aveva
piantata proprio lì, nel ridotto della Avery Fisher Hall, una
sera. Non è necessario essere Freud per ricostruire il resto
della storia.
A questo punto, penso che dovremmo dire quattro parole
sull'asma. C'è molta confusione a proposito di questa importante malattia. Tra il 4 e l'8 per cento della popolazione
vive in condizioni penose per esserne stata colpita in un momento o nell'altro della propria esistenza.
La parola asma deriva da due parole greche che significano «respirazione difficile» e, se vi è mai capitato di vedere
una persona in preda a un attacco di asma, sarete sicuramente d'accordo nel dire che il nome dato a questa terribile
condizione è troppo moderato. L'asma costituisce uno dei
grossi problemi sanitari del mondo odierno, provocando
una notevole sofferenza a molte persone, sia adulti sia bambini, e costando miliardi di dollari per perdita di produttività. Preoccupa in particolar modo il fatto che, in molti paesi, il tasso di mortalità per asma, dopo essersi abbassato per
parecchi anni, si sta di nuovo alzando.
Abbiamo già menzionato il fatto che i vasi sanguigni sono circondati da un rivestimento di fibre muscolari ad anello, che possono contrarsi e pertanto restringere il diametro
dei vasi, oppure rilasciarsi e aumentare il diametro degli
stessi. Uguale discorso vale per l'albero bronchiale. L'aria
inspirata attraverso il naso o la bocca deve raggiungere i
polmoni attraverso tutta una rete di condotti che, nel loro
insieme, costituiscono l'albero bronchiale. La prima parte
di questo sistema è la trachea, che si può toccare mettendo
una mano sul collo proprio davanti al piccolo pomo che si
trova (nei maschi) alla fine della gola. Qui si possono individuare gli anelli cartilaginei rigidi che rendono la trachea
quel grosso tubo così palese che è. Quando l'albero bronchiale si suddivide, portando l'aria fin nei polmoni, la cartilagine che sostiene le principali vie respiratorie scompare e
272
il diametro del lume è allora controllato dai muscoli, disposti esattamente nello stesso modo di quelli che circondano i
vasi sanguigni.
Quando un individuo soffre di attacchi episodici in cui vi
è uno spasmo (restringimento) delle piccole vie respiratorie,
soffre d'asma (cioè di un'ostruzione reversibile delle vie respiratorie).
La meccanica e la fisiologia della respirazione sono molto
complicate, ma gli elementi di base sono facili da esporre.
Quando respiriamo, inaliamo nei polmoni aria contenente
circa il 20 per cento di ossigeno. I polmoni estraggono l'ossigeno e lo cedono ai globuli rossi del sangue, i quali lo trasportano rapidamente in tutto il corpo, cedendolo ai muscoli e ai tessuti, che non potrebbero sopravvivere più di alcuni minuti senza questo prezioso bene. È ovviamente necessario espirare prima di inspirare di nuovo, ma la Natura
non spreca la parte espiratoria del ciclo della respirazione.
Quando espiriamo, emettiamo da tutto il corpo, e dai polmoni in particolare, anidride carbonica in forma gassosa.
L'anidride carbonica è un prodotto secondario di molti
processi metabolici e deve essere regolarmente eliminata
dall'organismo; altrimenti forma un acido estremamente
pericoloso nel sangue.
Quando si respira profondamente, il torace si espande e
la pressione all'interno dei polmoni diminuisce; di conseguenza, c'è da parte delle vie respiratorie una tendenza naturale a dilatarsi. Si tratta di un adattamento raffinato del
nostro organismo perché consente, proprio al momento
giusto, di far entrare la massima quantità di aria nei polmoni. Quando si espira succede l'inverso: la pressione nelle vie
respiratorie aumenta ed è quindi normale che, in questa fase del ciclo respiratorio, l'albero bronchiale si contragga.
I pazienti che soffrono d'asma hanno le vie respiratorie
così ristrette che non solo hanno difficoltà a far entrare una
sufficiente quantità di aria nei polmoni, ma riesce loro impossibile anche eliminare l'anidride carbonica dal corpo.
Quando tentano di espirare, le vie respiratorie si restringo273
no, ma spesso a un punto tale che non è possibile alcun movimento dell'aria. Aria priva di ossigeno, e quindi inutile,
viene in tal modo trattenuta nei polmoni. Il cervello, avvertendo che non vi è sufficiente quantità di ossigeno per arricchire il sangue in circolo, invia ai polmoni e al torace ogni
tipo di segnali di emergenza. I pazienti cominciano a lottare
per avere più aria e spesso rimangono sfiniti da questa
lotta.
Il problema importante, naturalmente è: perché le vie respiratorie di alcune persone sono soggette a spasmi? Perché
queste vittime dell'asma rischiano di essere soffocate dai
muscoli che circondano l'albero bronchiale? Per capire bene le risposte a queste domande, si deve tener conto del fatto che la Natura ama controllare quasi tutto, nel nostro organismo, con il sistema del tiro alla fune. Proprio ora il vostro cuore sta battendo con un certo ritmo, che è il risultato
netto di due insiemi di stimoli nervosi simultaneamente attivi, ma contrapposti. Un insieme di nervi cerca di accelerare
il battito cardiaco mentre l'altro cerca di rallentarlo; l'equilibrio tra queste due squadre opposte di tiro alla fune determina il ritmo effettivo del battito cardiaco.
Esattamente lo stesso si può dire per i muscoli che controllano il diametro delle vie respiratorie. In un momento
qualsiasi, lungo i nervi si propagano segnali che, liberando
composti chimici, istruiscono le cellule muscolari delle vie
respiratorie affinché si rilascino. Simultaneamente, però,
da altri nervi provengono messaggi che dicono alle medesime cellule di contrarsi. Il tono del muscolo, che è la differenza netta delle due forze contrapposte, determina il grado
di apertura o di chiusura delle vie respiratorie in un qualsiasi momento.
L'asma è provocata da un controllo difettoso delle cellule
muscolari della parete delle vie respiratorie. Queste cellule
hanno sulla membrana piccoli recettori che possono interagire con i messaggi chimici liberati dai nervi per far rilasciare i muscoli. Essi si chiamano recettori beta. Recettori diversi accettano, invece, messaggi per far contrarre le cellule
274
muscolari. Quando il tiro alla fune è ben bilanciato, una
delle due squadre vincerà se, dalla sua parte, viene aggiunto
un uomo. Esattamente lo stesso risultato si otterrà se un uomo verrà tolto dalla parte opposta. In entrambi i casi, il risultato sarà un movimento in una direzione. Tenendo presente questa analogia, si può immaginare che l'asma sia dovuta a una accresciuta sensibilità ai segnali che fanno contrarre i muscoli, o parimenti a una perdita di sensibilità ai
segnali che fanno rilasciare gli stessi. Nella maggior parte
dei casi, sembra che quest'ultima sia responsabile dei problemi degli asmatici. Le cellule muscolari non sono particolarmente sensibili ai segnali che cercano di attivare i recettori beta. Un certo dibattito è in corso attualmente per stabilire se, nei pazienti con asma, questi recettori siano danneggiati oppure se siano semplicemente presenti in quantità insufficiente. Il risultato è, però, chiaro. Anche la normale
stimolazione da parte di quelle sostanze che fanno contrarre
i muscoli non troverà opposizione in quelle forze normali
che la controbilanciano e che bloccano la contrazione. Il risultato netto sarà un restringimento significativo delle vie
respiratorie.
È importante aver discusso questi meccanismi perché l'asma viene da molti considerata una malattia allergica, cioè
provocata da fenomeni che coinvolgono le immunoglobuline E. La verità è che l'asma è un disturbo delle vie respiratorie e le reazioni allergiche attorno a queste vie, per il fatto
che liberano sostanze che fanno contrarre i muscoli nelle loro pareti, possono innescare un attacco. Il difetto di base
deve essere presente prima che una reazione allergica produca broncospasmo.
Un paziente con l'asma è come un uomo che cammini sul
bordo di un precipizio pericoloso. Se cammina lungo il bordo senza inciampare, è sicuro. Però, quanto più egli è vicino al bordo tanto più è in pericolo. Se vacilla, basta una
spinta e la tragedia è compiuta. In altre parole, un paziente
con l'asma, anche quando sembra stia perfettamente bene,
avrà sempre le vie respiratorie più strette delle mie o delle
275
vostre. Non avrà più alcuna capacità di riserva, in quanto
ogni ulteriore restringimento di queste vie impedirà il loro
normale funzionamento. In simili circostanze, una reazione
allergica provocherà un attacco d'asma, cioè spingerà il paziente giù dal precipizio.
Con la vulnerabilità causata da questi squilibri nelle vie
respiratorie, un asmatico può subire un attacco d'asma a
seguito di un'emozione, di uno sforzo fisico, di un'improvvisa esposizione all'aria fredda, di un'infezione, oppure per
effetto dell'inquinamento atmosferico, di determinati farmaci e di reazioni allergiche. La terapia moderna è studiata
in modo da identificare i fattori innescanti che possono
provocare un attacco d'asma e, se possibile, rimuoverli dall'ambiente. A questa tattica viene associato il trattamento
della condizione sottostante. Oggi, ciò comporta fondamentalmente tentativi per rendere i recettori beta più sensibili alle sostanze che di norma li attivano, mentre nel contempo si somministrano alle vie respiratorie farmaci che stimolano i recettori. La malattia costituisce un problema così
importante, che ritengo di dover aggiungere alcune annotazioni per quelli tra voi che sono asmatici, allo scopo di aiutarli a determinare se la cura che stanno facendo sia o no la
miglior terapia attualmente disponibile.
Sono in buone mani se il medico ha avuto un gran da fare
a spiegare i meccanismi che ho appena descritto, in modo
che possano sentirsi sicuri di aver capito che cos'è la malattia che li ha colpiti; se egli pone l'accento sul fatto che le cure moderne si concentrano sulla somministrazione dei farmaci necessari direttamente nelle vie respiratorie invece che
per bocca o per iniezione; se, nel sottoporre il paziente a un
trattamento farmacologico per inalazione, ha controllato
attentamente più di una volta che la tecnica usata per inalare il prodotto sia corretta; se li ha forniti di un piccolo flussometro per misurare il massimo dell'espirazione, in modo
da poter determinare autonomamente quali progressi si
compiono nei riguardi della malattia. Questi minuscoli apparecchi misurano quanto ristrette o dilatate siano le vie re276
spiratone e segnalano se il paziente risponde o no al farmaco che gli è stato chiesto di inalare. Un abbassamento nei
valori Ietti fa pensare che il paziene si stia avviando verso un
grave attacco d'asma; egli ha così il tempo di avvertire il medico. Il medico dovrebbe anche garantire che i controlli sul
sangue siano fatti frequentemente, in modo da poter determinare la dose giusta di teofillina, che è necessaria per dare
il massimo di risposta terapeutica (la teofillina è un farmaco
che fa dilatare l'albero bronchiale). Stabilito poi che gli attacchi d'asma sono provocati o da uno sforzo fisico o dall'aria fredda, egli dovrebbe spiegare al paziente che si possono evitare inalando lo stimolante dei recettori beta prima
di compiere lo sforzo fisico o di avventurarsi al freddo. Dovrebbe anche riferire al paziente che solo in circostanze molto insolite si autorizzano per gli asmatici interventi di desensibilizzazione.
L'aver menzionato questo termine rende necessaria un'ulteriore spiegazione. La desensibilizzazione è una tecnica già
in uso da molti anni da parte degli allergologi, nel tentativo
di ridurre la sensibilità mediata dalla IgE. Praticata su milioni di persone tutte le settimane dell'anno per ogni anno,
essa comporta ripetute iniezioni di minime dosi dell'allergene che si ritiene sia la causa dei sintomi accusati dal paziente, e tutto questo per un lungo periodo di tempo.
Perché questa tecnica dovrebbe essere considerata utile?
Fino ad epoca recente la teoria più in voga su come potesse
operare la desensibilizzazione chiamava in causa la produzione di immunoglobuline G contro l'allergene in questione,
in seguito alle iniezioni desensibilizzanti. Quando avveniva
un'esposizione naturale all'allergene, doveva esserci in attesa nell'organismo un altro anticorpo in grado di competere
con esso e, alla sommità delle mastcellule, l'immunoglobulina E. Se questa è presente nel circolo sanguigno in quantità
sufficiente da piombare sull'allergene non appena entra nel
corpo, può darsi che riesca a legarlo quasi tutto, in modo
che ne resta in circolo molto poco per fare entrare in azione
l'immunoglobulina E in attesa nei tessuti, sulle mastcellule.
277
La teoria ha una sua logica e, effettivamente, potrebbe
esservi una qualche verità nei suggerimenti che dà; tuttavia,
certamente, non si tratta di una risposta completa. Studi recentissimi propongono con enfasi che i linfociti T immunoregolatori, che controllano la produzione di IgE contro un
allergene specifico, possano essere stimolati occasionalmente dalle iniezioni desensibilizzanti. Ciò può permettere al
paziente di riacquistare il controllo sulla propria produzione di IgE. Si ricordi che, all'inizio di questa discussione sull'allergia, abbiamo affermato che il termostato che determina quanta IgE l'organismo produrrà o non produrrà è insito nell'apparato genetico dei linfociti T.
Sfortunatamente è molto difficile assicurare che la desensibilizzazione di un paziente qualsiasi abbia successo. La
tecnica può provocare problemi seri in quanto si ha a che
fare con un sistema molto potente. Se viene somministrato
troppo allergene, si può scatenare, già nello studio del medico, una reazione allergica di proporzioni pericolose. Cionondimeno, in mani esperte, i rischi associati a questa tecnica sono accettabili e il rapporto costo/beneficio richiede
di essere esaminato attentamente finché non saremo in grado di formulare in modo più scientifico la giusta dose per
un individuo. Ciò sarà molto più facile quando diventeranno disponibili allergeni più puri. Troverete che la maggior
parte degli immunologi clinici sono molto prudenti nell'affrontare la desensibilizzazione, tendendo piuttosto a trovare l'allergene responsabile del disturbo e, di conseguenza,
ad aiutare il paziente ad evitarlo. Se ciò non è possibile, ci si
affida allora ai metodi farmacologici che bloccheranno le
conseguenze delle reazioni mediate dalla IgE.
Nel momento in cui scrivo, posso dire con fiducia che siamo a buon punto nel desensibilizzare contro allergeni come
il polline di ambrosia e la forfora dei gatti, e che ci si possono aspettare risultati positivi quando gli allergeni che provocano problemi a un particolare paziente siano chiaramente identificabili e pochi di numero. Se la cute del paziente risplende come Times Square nella notte di San Silvestro
278
quando viene sottoposta ai test per gli allergeni, è estremamente improbabile che la desensibilizzazione riuscirà a controllare i problemi da cui è afflitto. In lui si saranno sviluppate allergie nei riguardi di troppi e diversi elementi.
Esistono certamente indicazioni per tentare di desensibilizzare soggetti allergici e un caso classico è quello della sensibilità al veleno delle api e delle vespe. Si verificano numerosi decessi ogni anno a causa di un'imponente reazione allergica, che consegue a una puntura d'ape. Vi sono persone
che diventano estremamente sensibili al veleno delle api.
Ma la cosa interessante è che sono più le persone che
muoiono per la paura di essere punte di quelle che muoiono
per essere state realmente punte. Le statistiche dimostrano
che chi sa di essere allergico al veleno delle api o delle vespe
spesso si terrorizza quando nell'automobile in movimento
entra un'ape o una vespa, al punto da incorrere spesso in un
incidente.
I primi tentativi fatti per desensibilizzare al veleno delle
api e delle vespe utilizzavano un estratto grezzo degli stessi
insetti. I corpi di un tipo particolare di ape o di vespa sospettato di causare l'allergia venivano schiacciati e frantumati in un mortaio e il liquido spremuto da quelle sfortunate creature era diluito in modo opportuno e iniettato nel paziente. I risultati non furono molto incoraggianti. Oggi, invece, sono disponibili, per vari tipi di api e di vespe, estratti
del veleno di gran lunga più puri ed è possibile praticare test
cutanei sui pazienti per trovare a quale particolare varietà
di insetto va attribuita la responsabilità del problema di cui
essi soffrono. I risultati ottenuti con la desensibilizzazione
al veleno sono molto incoraggianti.
In generale, in base ai casi che sono stati seguiti e documentati, si può dire che la desensibilizzazione ha ottenuto
risultati di gran lunga migliori nel controllare sintomi riferibili al naso e agli occhi, e non al torace. È molto più probabile trarre beneficio da una terapia di desensibilizzazione se
si è affetti da rinite allergica che non se si è affetti da asma.
Un compito molto difficile è anche quello di diagnostica279
re reazioni allergiche genuine al cibo. Se al primo boccone
di cibo cucinato con olio di arachidi vi si gonfia la lingua e
la faringe, non ci sono molti dubbi sulla diagnosi. Ma non
è altrettanto facile quando le reazioni al cibo sono ritardate, come spesso capita. La ricostruzione storica dei possibili eventi precipitanti diventa tanto più difficile quanto più
il tempo di reazione è lontano dal momento dell'ingestione.
Molti allergologi sostengono di riuscire a diagnosticare
le allergie per il cibo con grandissima precisione. Come nel
caso del dirigente dell'IBM di cui abbiamo già parlato,
possono dirvi che siete allergici a molte cose, il che, in realtà, non vi aiuta molto. I test che utilizzano rappresentano
uno dei peggiori esempi di empirismo nella moderna pratica medica. Passano dai «test citotossici» in cui alcune delle
vostre cellule ematiche vengono prelevate e quindi esposte
a estratti di cibo, per morire se ne siete allergici, a prove
d'immunità in cui vi viene somministrato un alimento e a
intervalli di un'ora il vostro naso viene pulito con un tampone. La comparsa nel naso di certe cellule, secondo alcuni, indica che siete allergici a quel cibo. Tutti questi test sono inutili e si dovrebbero evitare quei medici, o quel personale paramedico, che praticano simili procedimenti.
Se, invece, l'allergologo vi ha spiegato tutte queste cose,
siete probabilmente in buone mani. Ma se vi ha chiesto di
prelevare un poco di polvere dal pavimento di casa e di
portargliela in studio, in modo che possa preparare un
estratto da usare per la desensibilizzazione, cominciate a
preoccuparvi. Se poi prepara l'estratto e vi chiede di metterlo sotto la lingua, avete a che fare con un medico che si
è distaccato parecchio dal corso principale del moderno
pensiero immunologico. Se vi ha detto che tutti quei raffreddori di cui soffrite, e specialmente quella gola infiammata dell'inverno scorso, possono essere dovuti ad allergie
ai prodotti batterici e vi sta, pertanto, desensibilizzando
con «vaccini batterici», correte rapidamente dal più vicino
allergologo autorizzato per avere qualche informazione più
280
attendibile. In molti paesi del mondo, tutti questi tipi di
approccio sono penosamente comuni.
Dobbiamo discutere ora di un ulteriore aspetto delle malattie allergiche che riguarda quel meraviglioso immunomodulatore che è il latte materno. La Natura deve fronteggiare
il problema di proteggere l'intestino e le vie respiratorie superiori del neonato dalle infezioni batteriche. Nei primi mesi di vita, il sistema immunitario del bambino deve maturare, imparando dapprima come produrre le IgM, poi le IgG
e, infine le IgA, quegli anticorpi che proteggono le nostre
mucose delicate. Per avere la sicurezza che le IgA siano presenti nell'intestino del bambino, la Natura ha predisposto
che le madri allattino i loro figli al seno e ha realizzato adattamenti specifici per far sì che quantità adeguate di IgA siano presenti nel latte materno a protezione dell'intestino del
bambino.
Negli anni recenti, è emerso chiaramente che esiste un'associazione tra un'incapacità naturale di produrre IgA e allergie a numerose sostanze, in particolare a certi cibi. Ricerche di questi ultimi anni hanno rivelato che la sensibilizzazione a sostanze come le proteine del glutine, della soia e del
latte, che ha causato tanta sofferenza a così tanti individui,
avviene nel primo anno di vita. Le molecole di IgA, a parte
la capacità di proteggerci dalle infezioni batteriche e virali,
possono anche avere un ruolo importante nel proteggerci
dalle allergie. La presenza in abbondanza delle IgA nell'intestino può certamente ridurre al minimo l'assorbimento
delle proteine del glutine, della soia e del latte e, probabilmente, di molte altre sostanze ancora.
In assenza di IgA, queste proteine, che normalmente non
assorbiamo in una forma allergenica, stimolano la produzione di IgE ed è a questo punto che comincia la cascata
delle reazioni allergiche.
Ricercatori scandinavi hanno dimostrato che un bambino
nato da genitori affetti entrambi da allergie ha una probabilità molto elevata di mostrare sintomi di allergie prima di
raggiungere un anno di età. Questo rischio, però, si riduce
281
in misura molto significativa se, nel primo anno di vita, il
bambino viene allattato al seno. È evidente che, se si riescono a mantenere sempre disponibili le IgA nell'intestino del
bambino fino a un anno di età, l'assorbimento del materiale che può sensibilizzare il bambino rimane bloccato. Come
ho già ricordato, in Scandinavia sono state istituite parecchie banche del latte, cosicché latte umano è sempre disponibile per «finalità terapeutiche».
Concludiamo con una nota positiva. Quelli fra voi che
trovano che le reazioni di ipersensibilità immediata producono sintomi che interferiscono con la qualità della loro vita dovrebbero essere rincuorati dal sapere che esistono immunologi clinici competenti, in grado di aiutarli a risolvere
la maggior parte dei problemi in questo settore. Certamente
nei prossimi anni importanti progressi in immunologia e in
farmacologia miglioreranno notevolmente il modo di gestire questa «inutile allergia», così chiaramente riconosciuta
da von Pirquet all'inizio di questo secolo.
282
8
Il penoso argomento dell'autoimmunità
L'uomo in questione aveva brutalmente aggredito la moglie
in casa, dopo una discussione.
Uno psichiatra stava discutendo questo caso con gli studenti di medicina del quart'anno, che erano presenti quando aveva esaminato l'uomo. Essi, che avevano visto dalle
foto le condizioni in cui si trovava la moglie subito dopo
l'aggressione, erano molto ostili nei suoi riguardi, anche se
lui proclamava il proprio rimorso e prometteva di cambiare. Volevano fosse rinchiuso in carcere per anni e mostravano articoli di giornale in cui si riportavano storie di uomini
come questo, trattati con indulgenza dai tribunali e che, in
seguito, avevano inferto danni ancora peggiori alle loro vittime, perfino uccidendone qualcuna.
Lo psichiatra cercava, invece, di dare al caso una prospettiva più professionale e obiettiva. L'uomo non era chiaramente uno psicotico, in quanto riusciva a distinguere tra
realtà e fantasia. Da nessuna parte, nei test che erano stati
eseguiti su di lui, erano state messe in luce alterazioni del
pensiero, a suggerire che la sua personalità si librava su
quella pericolosa «corda da funambolo», che separa il puro
e semplice nevrotico dall'individuo francamente psicotico.
Anche se il soggetto in esame non era particolarmente intelligente, egli riconosceva ciò che era giusto da ciò che era
sbagliato e riusciva, il più delle volte, a tenere sotto controllo se stesso e le sue tendenze aggressive.
Tutti i suoi episodi di violenza si erano verificati dopo
283
che aveva consumato una quantità rilevante di alcool in un
periodo di crisi finanziaria familiare.
«Vi sono migliaia di uomini e donne come questo nel
mondo reale» sottolineò lo psichiatra agli studenti. «Non
hanno forti personalità, ma, se aiutati, molti di loro possono acquisire un miglior controllo su se stessi, specialmente
se vengono sorvegliati con cura da una terza persona, indifferente sul piano emotivo, autoritaria e potenzialmente punitiva. Libertà condizionata, aiuto vigile per i problemi inerenti al consumo di alcool e suggerimenti da parte di un
consultorio familiare potevano salvare quell'uomo. Oh, naturalmente, il tasso di insuccesso è elevato, ma quali sono le
alternative? Rinchiuderlo sotto chiave per molti anni, nel
caso che non si ravveda? Come società, dobbiamo generare
limitazioni accettabili universalmente, che rafforzino l'esigenza di un autocontrollo.»
Il caso sopra riportato e la discussione sono puramente
ipotetici, anche se sappiamo che, con tutta probabilità, essi
riflettono situazioni reali. Io spero, però, che le analogie tra
gli eventi riportati sopra e le deviazioni di un sistema immunitario che attacchi il «sé» siano lampanti. Quando parliamo di autoimmunità, ci riferiamo a una situazione in cui un
materiale genetico di partenza meno che perfetto, combinato con uno stress ambientale, può condurre a un'attenuazione dell'autocontrollo, che può generare malattia.
Tra i 400-600 miliardi di linfociti che difendono il nostro
corpo ve ne sono alcuni potenzialmente «sociopatici»: anzi,
in questo senso, penso che si potrebbe dire «organopatici».
Proprio come accade con la personalità umana, vi sono numerose permutazioni e combinazioni genetiche che influiscono sulla prestazione dei linfociti.
Sappiamo che tutti i linfociti, nessuno escluso, possono
riconoscere soltanto un antigene ciascuno e che, per questo
compito, utilizzano il recettore di membrana. Questo ha
una configurazione spaziale tridimensionale che lo fa fungere da serratura in cui può entrare bene solo una chiave. Il
problema che può sorgere con tutto questo individualismo
284
dei linfociti è che la Natura abbia generato cellule che possono riconoscere «noi» come pure un oggetto estraneo.
Molte cellule riconoscono le cellule renali esattamente come
riconoscono il virus dell'herpes.
A un dato momento, nell'evolversi della scienza immunologica, si è pensato, o per meglio dire presunto, che in
circostanze normali la Natura avesse istituito un sistema per
eliminare le cellule con un «potenziale di attacco» per il
«sé». Questo «aborto clonale» (uccisione di una famiglia di
cellule reattive contro se stesse) avrebbe avuto probabilmente luogo nel momento stesso in cui le cellule si formavano. Come conseguenza di quest'azione intelligente, non vi
sarebbe più stata allora alcuna possibilità di comparsa di
una malattia autoimmune, in cui un organo potesse essere
selvaggiamente attaccato e danneggiato da una cellula «organopatica».
Quando risultò evidente, invece, che questi attacchi ai
tessuti avevano effettivamente luogo, la teoria venne modificata. Si pensò allora che alcuni di noi fossero tanto sfortunati da non avere la possibilità di indurre l'aborto clonale;
così, queste potenziali «bombe a orologeria» sopravvissero
nel nostro organismo.
Nessuno di noi, a conti fatti, fa abortire quelle cellule che
riconoscono i tessuti propri. Dobbiamo accettare il fatto
che milioni di cellule, nel nostro corpo, ci attaccherebbero
senza pietà se seguissero le loro fondamentali inclinazioni.
Per la nostra sopravvivenza, dunque, devono sapere che
questo non è per loro il modo giusto di comportarsi: di conseguenza, è probabile che esercitino una misura di autocontrollo sulla loro natura autoaggressiva. È necessario che
sappiano che il «fratello maggiore» veglia su di loro, consigliandole di essere passive. È la stessa situazione dell'uomo
violento che abbiamo descritto: l'autocontrollo e le pressioni regolatrici di una terza persona offrono le migliori possibilità di evitare pericolose deviazioni da un comportamento
accettabile.
Per esempio, i linfociti possono riconoscere soltanto un
285
settore specifico del nostro sistema nervoso, perché la selezione genetica ha dato loro il recettore per fare così. Un uomo violento nei riguardi della propria moglie ha meno scuse
di comportarsi in tal modo di quante ne abbiano i nostri linfociti autoaggressivi per attaccare il sistema nervoso. Cionondimeno, se ci attaccano, non obbediscono a norme ben
stabilite. Esaminiamo, allora, i controlli che la società immunologica ha istituito per loro.
Il nostro sistema immunitario, non essendo ancora perfetto, deve accettare una situazione di compromesso, così
come la società umana tollera le finzioni ipocrite delle interazioni umane, che sono ben lungi dal rispecchiare quelle
ideali. Il controllo principale dell'autoaggressione dipende
da un semplice evento già evidenziato in precedenza parecchie volte: in qualunque reazione immunitaria vi è l'emissione di segnali permissivi da parte di un tipo particolare di
linfocito T, i linfociti T induttori o coadiuvanti. Se queste
cellule ordinano: «Attaccate!», allora un vero e proprio
esercito di cellule con equipaggiamenti diversi entra subito
in azione.
Ogni giorno e per tutto il giorno, i linfociti T di questa
famiglia di induttori «scrutano» i nostri tessuti, li riconoscono e decidono di non attaccarli. Una decisione così importante e, naturalmente, corretta significa che quegli altri
linfociti T e B che possono riconoscere i nostri tessuti non
ricevono i segnali per «procedere», di cui hanno bisogno
per attaccare. Rimangono tutti tranquilli e i nostri organi
possono svolgere la loro attività senza essere assaliti.
Perché i linfociti T che ci riconoscono, servendosi di un
recettore di membrana specifico e perfettamente legittimo,
non attaccano il «sé», mentre altri, che sembrano prendere
parte esattamente allo stesso tipo di interazione, ma con il
«non sé», si lanciano nella battaglia? Vi sono, come probabilmente immaginate, numerose ragioni alla base di questa
limitazione, dato che sarebbe molto pericoloso avere in un
unico cesto tutte le uova dell'autocontrollo.
Genericamente parlando, i nostri linfociti T «tollerano»
286
la presenza del «sé». Questa tolleranza può essere distinta
in due tipi: passiva e attiva. La tolleranza passiva è «autonoma». Immaginate un cane randagio che ha scelto di vivere nella vostra famiglia. Voi non lo volete, ma i vostri bambini desiderano tenerlo. Allora discutete la questione, scrollate le spalle, sorridete ai bambini e il cane, intanto, si avvicina al focolare. Questa è tolleranza passiva. D'altra parte,
desiderate ardentemente scacciare quel cane rognoso e lo
fareste se non intervenisse un'autorità superiore. «Henry,»
dice vostra moglie in tono deciso «i bambini avrebbero il
cuore infranto se tu non permettessi loro di tenere il cane:
non pensare neppure lontanamente di liberartene.» Questa
è tolleranza attiva. Il cane andrà subito ad acciambellarsi
nella vostra poltrona favorita.
In termini immunologici, molti linfociti T induttori, che
possono riconoscere i nostri tessuti, hanno una tolleranza
passiva. Durante la vita fetale, quando cellule immature e
davvero semplici si raggruppano per formare i primi tessuti
e organi, i linfociti T ricevono un'istruzione genetica per
scrutare quelle strutture che si stanno sviluppando. Se le riconoscono durante la fase critica dello sviluppo fetale, vengono istruiti da messaggi genetici che provengono dall'interno del loro nucleo a essere tolleranti. Prima delle diciotto
settimane di vita fetale, i linfociti sono istruiti in modo tale
che qualunque cosa riconoscano è «sé»: pertanto deve essere lasciata stare. Nel corso della vita fetale l'unica cosa attorno da scrutare dovremmo essere «noi»; quindi l'istruzione data ai linfociti dovrebbe assicurare che si sviluppi una
tolleranza soltanto verso il «sé». Poiché molti di questi linfociti T, presenti - diciamo - a dieci settimane di vita fetale,
saranno ancora in funzione sessant'anni dopo, l'istruzione
data in giovanissima età può controllare le tendenze autoimmuni per la maggior parte dell'esistenza di un individuo.
In modo simultaneo e, secondo alcuni, più importante,
durante la vita fetale sono attivi linfociti T immunoregolatori ai quali viene insegnato a riconoscere il «sé» e quindi a
287
secernere sostanze specifiche che impediranno attivamente
a un linfocito T induttore di abbandonare la retta via, caso
mai avesse una tale tendenza. Questa è una forma di tolleranza molto attiva.
La tolleranza può essere «infettiva». Linfociti T, di formazione chiaramente recente, derivati dal timo in una fase
successiva della vita, ricevono segnali sia dai linfociti dotati
di tolleranza passiva sia da quelli con tolleranza attiva.
Non ci preoccupiamo troppo, in questo sistema, dei linfociti B. Essi vivono solo alcuni giorni e sarebbe uno spreco
di energia biologica insegnar loro la tolleranza: la loro vita
è, infatti, troppo corta e non possono comunque fare nulla
senza l'aiuto dei linfociti T.
Come potete immaginare, quanto bene tutto questo funzioni e quanto sia in grado di operare per tutto il corso dell'esistenza dipende dalla qualità del programma genetico
che lo controlla. La qualità dell'informazione varia da individuo a individuo, come per tutte le situazioni umane. Alcuni individui controllano in modo eccellente le bombe a
orologeria potenzialmente letali, che sono presenti nel loro
organismo, mentre altri hanno solo una tenue presa sull'autoaggressione.
Stiamo cominciando a imparare come riconoscere questo
secondo gruppo, e questo è un importante passo avanti nella medicina preventiva. Un controllo genetico dell'autoreattività potenziale più debole del normale ci fa camminare per
tutta la vita più su una corda da funambolo biologica che
nel mezzo di un ampio lungomare, riservato ai pedoni. Chi
cammina su una corda può cadere spontaneamente, ma può
anche facilmente essere spostato dal proprio baricentro e
perdere l'equilibrio. Le malattie umane risultano in buona
parte da un'interazione tra informazione genetica «di seconda classe» e circostanze ambientali.
Mi spiegherò con un esempio. Il diabete è una delle malattie più comuni e di una certa gravità che affliggono il genere umano. Nella sua forma più seria, che colpisce tragicamente il più delle volte i giovani (talvolta addirittura i bam288
bini), il pancreas, la ghiandola endocrina che secerne l'insulina, è vittima di una autoaggressione.
Esso ha due funzioni importanti. Produce sostanze che
aiutano a digerire il cibo e che vengono riversate nel duodeno quando si mangia. Di esse possiamo anche fare a meno,
mentre non possiamo vivere senza quell'ormone vitale, secreto all'interno della ghiandola, dalle cellule beta: l'insulina.
L'insulina ha un'importanza vitale per molti processi metabolici che si svolgono all'interno del nostro organismo e il
più semplice dei quali è il pompaggio dello zucchero all'interno delle cellule. Senza insulina lo zucchero rimane nel
sangue dove non solo è inutile, ma può addirittura provocare effetti dannosi al cervello e ad altri tessuti. Ma si hanno
conseguenze ben più numerose di queste. Senza insulina il
nostro organismo invecchia prematuramente: un diabetico
di quarant'anni sembra un non diabetico di sessantacinque.
Quando il diabete colpisce in età infantile, la speranza di vita può diminuire di anche ventisette anni. I bambini diabetici mostrano spesso un indurimento prematuro delle arterie, il che provoca attacchi cardiaci, cecità e gravi patologie
renali. Tendono a formarsi cataratte negli occhi e il paziente, con tutto quello zucchero nel sangue e nell'urina, è più
suscettibile alle infezioni: i batteri amano lo zucchero. Anche se la terapia insulinica viene effettuata correttamente, il
diabetico deve affrontare molti altri problemi.
A poco a poco, in un periodo di mesi o più spesso di anni, egli rimane senza cellule beta, distrutte dai loro stessi
linfociti T: un esempio drammatico di autoimmunità. A
quest'azione distruttiva non si associa dolore e, quando va
dal medico perché avverte i primi sintomi della malattia,
l'80 per cento delle cellule beta è già stato distrutto. Mentre,
da una parte, siamo duramente impegnati a mettere a punto
metodi per un trapianto di pancreas, dall'altro abbiamo un
vivo interesse verso una soluzione del problema che appare
ancora più attraente. Stiamo tentando di perfezionare metodi che ci permettano di individuare i soggetti il cui pan289
creas è stato colpito da un attacco autoimmune prima che
questa ghiandola endocrina sia danneggiata in maniera grave e permanente. Raggiunto questo scopo, dovremo cercare
di fare ritornare le cellule responsabili di ciò sulla retta e
stretta via della non reattività verso il «sé»: si revochi l'attacco al pancreas e il diabete non si svilupperà.
L'identificazione di potenziali diabetici in una fase in cui
essi stanno ancora bene è possibile data la nostra capacità
di ricercare marcatori genetici che ci facciano sospettare
che, nell'autocontrollo, vi sia qualcosa che non va nel verso
giusto.
Vi ricorderete che noi tutti, esseri umani, abbiamo contrassegni biologici sulla superficie delle cellule, che proclamano orgogliosamente: «Sono io! un individuo praticamente unico». Questi contrassegni sono proteine esposte alla superficie di globuli bianchi del sangue, per cui parliamo
di sistema HLA, dall'inglese Human Leucocyte Antigen
System. In un precedente capitolo, abbiamo anche detto
che questi marcatori rendono difficili i trapianti.
Gli otto antigeni principali del «sé» e i molto più numerosi secondari non sono stati posti nella sede che occupano,
dal Grande Immunologo in cielo, per rendere difficili i trapianti; sono lì per aiutare il nostro sistema immunitario a
distinguere tra il «sé» e il «non sé». Si ricordi bene il principio fondamentale: niente attacco se ci sono questi antigeni
HLA.
Con l'era dei trapianti, si è sviluppata la tecnologia per la
tipizzazione dei tessuti umani per quanto riguarda gli otto
principali antigeni del sistema HLA. In base all'informazione così ottenuta, si possono cercare individui perfettamente
compatibili.
Con molti profili in mano, ottenuti sia per i candidati al
trapianto sia per i potenziali donatori, un francese perspicace ha fatto un'osservazione sorprendente: alcuni di questi
profili HLA sembravano ripetersi nelle persone affette da
certe malattie. Talvolta sembra che solo uno degli otto antigeni principali sia associato alla malattia (o di tanto in tanto
290
a una insolita resistenza alla malattia): in altri casi, invece,
una costellazione di antigeni HLA è parsa legata in modo
non compreso a una malattia specifica.
Con tutto il cammino che la ricerca ha percorso da quelle
osservazioni pionieristiche, siamo oggi in grado di dire che
conosciamo più di cento malattie, che sembrano associate
in un modo o nell'altro a un profilo HLA. Questi profili genetici possono fornire migliori informazioni profetiche di
quelle che si possono ottenere leggendo il proprio oroscopo.
Ora, l'importante interrogativo sollevato dalle suddette
osservazioni era: «Perché la presenza di antigeni HLA, talvolta su ogni cellula del nostro organismo (si ricordi che,
solo per convenienza, ci serviamo dei leucociti per i test),
dovrebbe avere qualcosa a che fare con la comparsa di una
malattia in un dato organo, per esempio la psoriasi che colpisce la cute, l'artrite che colpisce le circolazioni, il cancro,
il diabete e via di seguito?».
Bene, le malattie non hanno nulla a che fare con gli antigeni HLA in sé (anche se, per un certo periodo, alcuni studiosi hanno pensato che certi antigeni potessero agire come
recettori dei virus o altro): è una questione di associazione.
Se vi capita di trovarvi in uno di quei lunghi e poco illuminati passaggi della 11th Avenue di New York e dall'estremità opposta arriva un ragazzino che ha tutta l'aria di fare
parte di una turbolenta banda di quartiere, non vi sorprendereste di trovare, quattro secondi dopo, che dieci-dodici
altri membri della banda vengano dondolandosi verso di
voi, lungo il passaggio. Il primo ragazzino può essere inerme, ma tende ad aggregarsi a una combriccola che è tutt'altro che disarmata. Non è necessario vedere l'intera compagnia per rendersi conto del rischio che c'è a percorrere quel
passaggio; basta uno sguardo al primo ragazzino per decidere di accelerare il passo: è chiaro che fa parte di una brutta banda.
Alcuni geni HLA tendono a mescolarsi a una compagnia
disdicevole sotto il profilo immunologico. Questi geni, che
producono gli antigeni che scopriamo procedendo alla ti291
pizzazione dei tessuti, sono in realtà innocui, ma la loro
presenza indica che, sul sesto cromosoma, sta in agguato un
gruppo di cattivi geni immunoregolatori, che tendono a
consentire lo svolgimento di processi patologici, come le
malattie autoimmuni.
Ora, naturalmente, il ragazzino della gang potrebbe in alcuni casi essere tenuto d'occhio da qualche membro dell'Esercito della Salvezza: non è lui il cattivo. Analogamente,
non è detto che la presenza di un certo antigene HLA significhi una propensione ben definita verso una certa malattia:
semplicemente fa aumentare la probabilità che quella malattia compaia.
Tuttavia, con certi profili, questa associazione è molto
più stretta. Uno di essi consiste in cellule che possiedono i
geni del locus D, noti come geni 3 e 4. È questa una cattiva
combinazione, che fa aumentare il rischio che siano presenti geni responsabili di molte malattie, tra cui la sclerosi multipla, l'artrite reumatoide e il diabete. Tuttavia, circa il 30
per cento delle persone in tutto il mondo non è influenzato
dalla presenza di DR3 e DR4.
La ragione per la quale certi geni HLA e alcuni geni che
codificano per prestazioni regolatrici si associano nel corso
di parecchie generazioni richiede una spiegazione. Durante
la divisione cellulare i cromosomi si scindono e poi si uniscono di nuovo, ma si tratta di un processo casuale (stesso
vecchio tema: il rimescolamento dei geni). Immaginate di
avere un pezzo di legno lungo un metro e ottanta e di tagliarlo in due pezzi a occhi chiusi. Se dipingete due bolli sul
legno, uno blu e l'altro rosso, in modo che siano distanti
l'uno dall'altro un metro e mezzo, le probabilità maggiori
sono che, quando brandite con impeto l'ascia per tagliare il
legno a metà, il bollo rosso rimanga su un pezzo di legno e
quello blu sull'altro. Si ripeta il procedimento, ma i bolli
rosso e blu saranno questa volta distanti l'uno dall'altro solo quindici centimetri e le probabilità che entrambi rimangano su un unico pezzo di legno dopo che è stato tagliato
sono molto alte. I geni immunoregolatori che sovrintendo292
no a fenomeni come la non reazione al «sé» sono vicinissimi (in senso geografico) ai geni che codificano per gli antigeni HLA. Pertanto, se vedete un bollo rosso, vi sono probabilità che un bollo blu sia vicino.
Un ragazzo con il diabete, che presenta anche lui la combinazione DR3 DR4, avrà molto probabilmente un fratello
che presenterà sulle proprie cellule gli antigeni DR3 DR4 e
potrà essere colpito dal diabete. Con un simile sospetto è
possibile diagnosticare precocemente la sua malattia, in
modo da prevenire la distruzione della maggior parte delle
cellule beta del pancreas?
Il glucagone è un ormone che stimola la liberazione dell'insulina dal pancreas nella circolazione sangugina. Un
pancreas sano risponderà immediatamente a un'iniezione
dell'ormone, liberando una quantità specifica di insulina.
Questa risposta normale può essere quantificata e, pertanto, una secrezione di insulina anormalmente bassa farebbe
pensare ad un pancreas in difficoltà, anche se ancora ben
lontano dal diabete clinicamente riconosciuto. Se si seguono per dieci anni i fratelli (e le sorelle) di bambini diabetici
o addirittura i loro genitori, quelli che hanno lo stesso profilo HLA del membro della famiglia affetto da diabete hanno una probabilità di quasi il 100 per cento di essere colpiti
dalla malattia. Da qui il nostro interesse per la diagnosi precoce.
Per ricapitolare, alcuni di noi ereditano un insieme di geni che non instaurano i normali meccanismi di controllo atti
ad arrestare gli attacchi sul «sé» con la precisione di un altro insieme di geni (ovviamente preferibile) ereditato da altri individui. Di conseguenza, alcuni di noi camminano per
tutta la loro esistenza su una fune biologica da equilibrista.
Ma cosa tende ad alterare il nostro equilibrio precario?
Per la persona che ha una immunoregolazione non proprio perfetta, i rischi ambientali noti sono lo stress, i farmaci e le infezioni, specialmente quelle virali. L'imperfezione
può essere spontanea o provocata da alcuni meccanismi per
il momento a noi ancora sconosciuti.
293
Uno stress psicologico, specialmente in situazioni frustranti, può drasticamente disturbare la funzione immunologica.
Che dire della capacità che hanno i farmaci di intralciare
il controllo immunitario? Tutti gli eventi biologici possono
essere ricondotti a reazioni biochimiche, in cui le molecole
solubili si spostano nel microambiente dando luogo a reazioni complesse. Quando ingoiate una capsula, quando fate
una smorfia mentre vi praticano un'iniezione, od osservate
un qualche prodigio terapeutico che, goccia a goccia, vi viene fatto penetrare nelle vene, affrontate un rischio calcolato, associato al fatto di aggiungere a un sistema in delicato
equilibrio prodotti chimici potenti.
Molti farmaci hanno un'efficacia meravigliosa e sono sicuri per la maggior parte della popolazione; tuttavia, provocano una quantità di problemi a chi si muove su una corda da funambolo immunologica. Gli antibiotici, i farmaci
che controllano la pressione sanguigna, le sostanze diuretiche, che fanno orinare molto, gli agenti che controllano il
ritmo cardiaco, eccetera, di fatto più di 100 farmaci comunemente usati, possono innescare una reazione autoimmune nell'individuo suscettibile.
Che dire delle infezioni? I virus sono qui i principali colpevoli, e dobbiamo ancora imparare molto sul modo in cui
danneggiano i meccanismi di autocontrollo. Sappiamo che
essi possono alterare anche il migliore dei sistemi immunitari (per esempio, nel caso dell'AIDS), ma alterazioni meno
spettacolari hanno luogo anche con i virus erpetici, come
quello che provoca la mononucleosi, per non parlare poi di
numerosi altri virus che riteniamo possano essere coinvolti
in malattie specifiche.
Un piccolo virus pericoloso, il Cocksachie, è un candidato valido per il diabete. Vi sono almeno due possibilità che
non si escludono reciprocamente. Secondo la prima, un virus potrebbe decidere di trovarsi un'abitazione ideale nelle
cellule beta del pancreas. Una volta installatosi, egli può, o
non può, danneggiare la residenza che si è scelta. Se i virus
294
danneggiano le cellule beta, l'aspetto di queste cellule potrebbe essere così alterato da farle apparire come cellule
«estranee», cioè i profili delle loro membrane non sono più
uguali a quelli delle cellule normali. In tali circostanze, le
cellule del sistema immunitario possono gettarsi a capofitto
su ciò che, di fatto, percepiscono come estraneo e possono
provocare più male che bene distruggendo non soltanto il
virus, ma anche le cellule beta. Quanto più debole è il nostro autocontrollo immunologico, tanto più probabile è che
attacchiamo il «sé» alterato. Secondo la spiegazione in alternativa, i virus danneggiano direttamente i linfociti T, con
il risultato che questi non si comportano più in modo appropriato e attaccano il «sé». Probabilmente, in molte occasioni, questi eventi si svolgono simultaneamente.
Con quest'informazione di base, prendiamo ora in esame
alcune malattie autoimmuni.
Devo sottolineare che queste malattie sono essenzialmente femminili. Per la maggior parte delle situazioni patologiche di cui parleremo, i medici visitano dieci donne per un
solo uomo. È però vero che gli uomini, comunque in meno
ad essere affetti dalla malattia, vengono colpiti in maniera
più grave. Perché? Colleghe immunologhe di mia conoscenza sostengono che i maschi con queste imperfezioni non
escono neppure dall'utero per combattere. Può esserci una
dose di verità in questo, in quanto gli ormoni sessuali hanno un ruolo importante nell'istituire la regolazione del sistema immunitario.
Benché parliamo di «questo» e «quel» sistema, interni al
nostro corpo, come se fossero moduli indipendenti anche se
ben integrati, nell'organismo vivente reale l'integrazione è
così completa e l'interdipendenza così profonda che, in effetti, vi è un unico sistema totale funzionante. Non capiamo come, ma un eccesso di ormoni sessuali maschili (testosterone) rispetto ai femminili (particolarmente gli estrogeni)
tende ad avere un ruolo nel perfezionare l'immunoregolazione. Giovani femmine di topo sono colpite da una malattia autoimmune che raramente si vede nei maschi della stes295
sa figliata. Se si somministra testosterone alle femmine fin
dalla nascita, si impedisce in esse la comparsa della malattia. (Naturalmente, si arresta anche la loro femminilità.)
Le malattie che chiamiamo autoimmuni rientrano in due
grossi raggruppamenti. In uno tendono ad essere presi come bersaglio organi specifici: ne è un chiaro esempio il diabete. Nell'altro, i sintomi che accusa il paziente sono in
gran parte provocati da danni immunologici ai vasi sanguigni. Vengono interessati nel danno anche quei tessuti che ricevono il sangue dai vasi colpiti.
Il primo gruppo di malattie autoimmuni tende a colpire
le donne e spesso vi è una storia familiare per queste malattie anche tra altre donne della stessa famiglia. Le vittime
hanno profili HLA che fanno pensare che il loro stato sia
causato da una deficienza immunogenetica, per cui può
aver luogo un attacco autoimmune. Per ragioni completamente sconosciute, casi del genere si riscontrano spesso in
donne la cui chioma ingrigisce prematuramente e la cui pelle presenta piccole macchie di depigmentazione (vitiligine).
296
Vengono riportate qui alcune anamnesi per mostrare la
gamma di questi attacchi orientati verso un bersaglio.
Un giorno stavo osservando una donna che urlava contro
un bambino di quattro anni, reagendo ovviamente in modo
eccessivo al fatto che il gelato che egli aveva in mano aveva
obbedito alle leggi della fisica e, a una temperatura di
40° C, gli era rapidamente scivolato dalle mani sul pavimento. Guardando la donna, mi accorsi che aveva le mani
che tremavano terribilmente, che era in un bagno di sudore
e che aveva gli occhi molto sporgenti come se stessero per
schizzare via dalla testa. Avvicinandomi, la diagnosi fu
confermata. Un rigonfiamento rivelatore nel collo diceva
tutto. La donna aveva una tiroide ingrossata e iperattiva,
che riversava nel sangue tiroxina, un ormone che controlla
numerosi processi metabolici nell'organismo umano. Troppa tiroxina ed ecco che tremiamo, perdiamo il controllo sul
piano emotivo, soffriamo di diarrea, subiamo alterazioni
nelle unghie e nei capelli, disturbi nel periodo mestruale, un
grave dimagramento, tachicardia e molti altri sintomi.
Senza esitazione, ma spero gentilmente, chiesi alla donna
se sapeva di avere qualcosa che non funzionava alla tiroide.
Per un momento pensai di aver creato un grave problema,
dal terribile sguardo che essa mi lanciò, ma si calmò e mi
disse anche che non aveva pensato di rivolgersi a un medico
e chiedergli aiuto per i malesseri che avvertiva. Feci in modo che il mio professore la visitasse la settimana successiva
e, in effetti, essa trasse un beneficio significativo dal trattamento urgente cui venne sottoposta.
Quello di cui non mi ero reso conto allora era che, nella
sua sfortunata tiroide, i linfociti T e B si erano radunati e
stavano letteralmente distruggendo la ghiandola. Alcuni degli anticorpi che essa produceva e che erano diretti contro le
cellule della tiroide stimolavano, in effetti, queste cellule a
produrre quantità sempre maggiori di ormone. Quando la
regolazione dei linfociti T si perde, la tiroide diventa un
bersaglio favorito per l'autoimmunità.
Una delle mie pazienti predilette, Ellen, soffre di diabete
297
e di un'altra malattia autoimmune. All'età di ventinove anni, mi venne raccomandata dal suo medico a causa di episodi di debolezza muscolare, che si andavano facendo sempre
più frequenti. Ella gestiva un vivaio e aveva quella personalità delicata e piena di attenzioni che è propria di chi si occupa di fiori e piante.
Era una ragazza robusta, ma non grossa. Aveva l'abitudine, nel suo vivaio, di sollevare le piante e trasportarle di
qua e di là, come pure di rovesciare sul terreno il contenuto
di sacchi di fertilizzante e altre cose analoghe. Nei mesi immediatamente precedenti la sua prima visita in studio aveva
notato che, salendo una rampa di scale, le gambe accusavano un'estrema debolezza. Riusciva a scaricare un paio di
sacchi di fertilizzante dal camion del fornitore, ma poi stranamente ogni successivo sacco diventava sempre più pesante, fino a non riuscire del tutto a muovere le braccia. Dopo
un poco di riposo, ricuperava. Si lamentò anche di disturbi
agli occhi. Quando leggeva, indipendentemente dalla lunghezza del periodo di tempo, la vista le si sdoppiava.
Nel chiederle di aprire e chiudere le mani ripetutamente,
si poteva vedere subito come si stancasse in fretta. Ci venne
immediatamente il sospetto che soffrisse di miastenia grave,
cioè di una grave forma di debolezza muscolare. Le nostre
ulteriori indagini confermarono la diagnosi. La facemmo
subito ricoverare in ospedale e i nostri migliori chirurghi le
aprirono il torace per asportarle il timo. Togliere il timo?
L'«anima» del sistema immunitario? Sì, so che è traumatizzante, ma lasciate che vi spieghi.
La miastenia grave è forse la più seducente delle malattie
autoimmuni (e può anche essere la più grave). Per capirla,
bisogna sapere come i nervi facciano muovere i muscoli.
Dunque, provate ad ordinare alla vostra mano sinistra di
chiudersi subito a pugno. Dal momento in cui la vostra
mente dice «Sì» alla mia richiesta al momento in cui la vostra mano si chiude a pugno passa una frazione di secondo.
Dalla corteccia cerebrale un messaggio è partito ed è sceso a
incredibile velocità lungo i nervi nel midollo spinale, per poi
298
uscirne e scendere ancora lungo i nervi del braccio fino alla
mano.
Quando il messaggio elettrico propagatosi lungo i nervi è
giunto al muscolo, però, ha luogo un cambiamento. Tra la
terminazione del nervo e il punto di innesco sul muscolo,
che deve essere attivato affinché il muscolo possa muoversi,
vi è uno spazio, attraverso cui il messaggio proveniente dal
nervo, che comanda alla mano di muoversi, viene trasportato non sotto forma di elettricità, ma sotto forma di una
sostanza chimica. È come se un messaggero, arrivando di
corsa e senza fiato alla riva di un fiume, chiedesse a un uomo di trasportarlo con la sua barca a remi all'altra riva,
permettendogli così di consegnare un messaggio a una persona che attende di là. La reazione chimica è, tuttavia, quasi altrettanto rapida di quella elettrica. La sostanza chimica
attraversa velocemente lo spazio e si lega al punto di innesco sul muscolo, che viene così stimolato da essa. Per la
maggior parte dei muscoli la sostanza è l'acetilcolina
(ACH, dall'inglese acetylcholine) e il punto di innesco sul
muscolo è chiamato, abbastanza ragionevolmente, recettore per l'ACH.
La miastenia compare quando ha luogo un attacco immunologico su questo recettore, che si copre di conseguenza
di anticorpi. Pertanto, è molto difficile per l'ACH trasmettere il messaggio.
Tutti sentiamo stanchezza ai muscoli quando li facciamo
lavorare ininterrottamente, ma già dopo poche contrazioni
i soggetti con miastenia grave non producono quantitativi
di acetilcolina sufficienti a superare la barriera di anticorpi
e andare a stimolare i muscoli. Se i recettori bloccati si trovassero su quei muscoli che fanno muovere la cassa toracica, i pazienti, senza l'aiuto di respiratori meccanici, morirebbero.
Perché asportare il timo? Migliaia di anni fa, il timo aveva due compiti: la produzione dei linfociti T, naturalmente,
ma anche la produzione di un ormone, di cui sembra non
abbiamo più bisogno e che facilitava realmente la trasmis299
sione neuromuscolare. Per produrre l'ormone, il timo aveva nel contesto dei propri tessuti alcune cellule muscolari
isolate con recettori per l'acetilcolina. Queste cellule muscolari insolite si trovano ancora nel timo umano.
Nei pazienti con miastenia grave, i linfociti T presenti nel
timo attaccano improvvisamente quelle cellule muscolari
come se fossero estranee; sembra che l'antigene specifico
che li stimola sia il recettore per il neurotrasmettitore. Ciò
non importerebbe molto se l'attacco rimanesse localizzato
nel timo, una ghiandola che, come abbiamo già detto prima, si atrofizza dopo l'adolescenza. Ma i linfociti T e B,
che in questa malattia si aggregano nel timo, lasciano quest'organo e attaccano i recettori nei muscoli periferici determinando il quadro clinico prima descritto. La disseminazione di queste cellule autoaggressive a partire dal timo può essere ridotta al minimo, asportando chirurgicamente la
ghiandola. Si cerca di farlo in una fase della malattia quanto più precoce possibile.
Altre malattie sostenute da un simile meccanismo d'azione, cioè un attacco immunologico deliberato a un tessuto
specifico, includono l'anemia perniciosa, in cui si forma un
anticorpo che blocca la capacità di un agente intestinale simile a un ormone, noto con il nome di «fattore intrinseco»,
di assorbire la vitamina B12. Questa è essenziale per la produzione dei globuli rossi del sangue e per il benessere del sistema nervoso. In altre malattie autoimmuni, le ovaie, i testicoli, le paratiroidi, ghiandole che controllano il metabolismo del calcio, i globuli rossi e le piastrine, elementi figurati
del sangue, possono tutti essere attaccati e gravemente danneggiati.
Vi è, però, un secondo grosso gruppo di malati in cui un
comportamento alterato del sistema immunitario ha esiti
diversi. Il prototipo di queste malattie è il Lupus Eritematoso Sistemico, abbreviato da medici e pazienti con LES. Sono a migliaia gli individui che ne soffrono e alla sua base vi
è un danno ai vasi sanguigni.
La signora L., trentacinque anni, era madre di due bam300
bini che erano il ritratto della salute. Tornando da una vacanza di due settimane in Giamaica, si era sentita decisamente non bene, con dolori alle articolazioni, una febbre
per la verità moderata, una sensazione di incombente sciagura e uno strano esantema sul viso. Al primo momento
pensò a una scottatura solare, ma si rese ben presto conto
che si trattava di tutt'altro. Da una guancia all'altra era
comparso un fugace esantema congestizio, rosso e desquamato, che si restringeva per superare il naso, formando una
figura simile a una farfalla. Il medico di famiglia riconobbe
che si trattava del caratteristico esantema del Lupus Eritematoso Sistemico e la inviò da noi. Siamo riusciti a tenere
sotto controllo la malattia, ma non a guarirla; essa sta ora
solo moderatamente bene.
Che cosa le era accaduto? Si era innescato in lei un cattivo funzionamento dei linfociti T, come spesso accade in
questi casi, in seguito ad esposizione alle radiazioni ultraviolette (che possono danneggiare cellule immunoregolatrici
non proprio perfette). Come conseguenza, essa aveva cominciato a produrre anticorpi contro i propri tessuti. Nel
caso del Lupus Eritematoso Sistemico, il bersaglio sembra
abbastanza innocuo. Ogni giorno rigeneriamo costantemente cellule perdute, quella parte di noi morta ieri, e i
frammenti di queste cellule vengono generalmente eliminati
dal nostro sistema da un'organizzazione interna di raccolta
dei rifiuti, sotto forma di cellule «spazzine», che possono
letteralmente ingoiare i frammenti dei tessuti. Tale organizzazione è concentrata soprattutto nel fegato e nella milza.
I poveri linfociti della signora L. producevano anticorpi
contro i nuclei nudi delle cellule che erano morte e che venivano rimosse. Questi anticorpi anti-nucleo venivano prodotti in grande quantità. Mentre il sistema di raccolta dei rifiuti cercava di togliere il materiale nucleare, gli anticorpi si
legavano a questo, formando grossi complessi che le cellule
spazzine avevano difficoltà a gestire. Di conseguenza, alcuni di questi complessi non venivano eliminati con sufficiente rapidità dai vasi sanguigni. Rimanevano allora intrappo301
lati in certi siti corporei, generalmente in minuscoli vasi
sanguigni, e la risposta immunitaria che ne seguiva si configurava come un grosso danno ai vasi sanguigni che avevano
avuto la sventura di rimanere ostruiti da quei complessi. I
vasi sanguigni si infiammavano, perdevano la loro pervietà
e numerosi tessuti ne soffrivano.
Il Lupus Eritematoso Sistemico colpisce in primo luogo
la cute, le articolazioni, il sistema nervoso centrale e i reni.
Questi ultimi sono particolarmente vulnerabili. Non è chiaro perché improvvisamente i pazienti comincino a produrre
anticorpi contro frammenti del «sé», ma sono sicuramente
molto importanti i fattori genetici e ambientali (in questo
caso le radiazioni solari). Molte malattie autoimmuni si
configurano con questo tipo di patologia piuttosto che con
una patologia che ha come bersaglio un organo e che abbiamo visto, per esempio, nel caso del danno alla tiroide. Un
altro esempio classico è l'artrite reumatoide.
Con l'invecchiamento vi è una tendenza naturale a una
riduzione dell'autocontrollo; pertanto, le malattie e i fenomeni autoimmuni possono fare la loro comparsa tardivamente nel corso dell'esistenza, quando comincia a declinare
l'integrità del nostro sistema di linfociti T, certissimamente
circoscritto. Fortunatamente, possiamo fare molto per parecchi di questi problemi, anche se poi non riusciamo a risolverli. L'argomento delle malattie autoimmuni, dunque,
è penoso e offre un ulteriore esempio di come la messa a
punto di armi sempre più sofisticate per la difesa lasci i difensori in grande pericolo, se le forze che essi controllano si
rivoltano contro di loro. Come nel caso del povero Guillotin (1738-1814), che rischiò lui stesso di essere decapitato
proprio dalla lama della sua famosissima invenzione.
302
La sindrome da fatica cronica:
una misteriosa malattia immunitaria
Per l'immunologia, e di fatto per la maggior parte delle discipline mediche, la frase «quanto più si sa, tanto più ci si
rende conto di quanto non si sa» è indubbiamente esatta.
Ciò non vuol dire che la maggioranza dei medici la consideri tale. La storia che viene raccontata qui di seguito suggerirebbe, caso mai, il contrario. Le anamnesi mostrano come
pazienti con sintomi insoliti, che sfuggono per il momento a
una qualsiasi spiegazione, vengano considerati troppo superficialmente ipocondriaci, cioè vittime di una nevrosi.
Carol ha ventotto anni e mi è stata presentata come una
«hostess di linee aeree colpita da grave debilitazione». Fino
all'età di ventiquattro anni aveva condotto una vita normale; poi, nell'arco di pochi mesi, la felicità e un futuro promettente si tramutarono in disperazione.
Carol volava su rotte internazionali per una ben nota
compagnia aerea e lo aveva fatto dall'età di diciannove anni. Era graziosa e benvoluta, e perdipiù era un'eccellente
atleta. Naturalmente era stanca dopo otto ore di volo su un
Jumbo con 400 persone, ma ricuperava in fretta e si rallegrava per le soste tra un volo e l'altro. Aveva molteplici interessi che riusciva a soddisfare, malgrado il suo febbrile
spostarsi attorno al mondo.
I suoi problemi iniziarono in un volo per Londra. Ricordava di aver lasciato New York in perfetta salute, ma di essersi sentita decisamente male dopo tre ore di volo. Le era
venuto il mal di testa, poi un'infiammazione alla gola e, in303
fine, qualche dolore muscolare. Riuscì a continuare il suo
lavoro, ma ricorda di essersi detta: «Mi sono proprio buscata una brutta influenza». All'arrivo a Londra, tutti i sintomi erano peggiorati ed era sicura di avere la febbre. Si recò all'albergo e alle 7 della mattina era a letto, sperando che
sei ore di sonno avrebbero avuto partita vinta sul virus e che
sarebbe tornata in buona salute.
Cadde in un sonno profondo e si svegliò alle 5 del pomeriggio, decisamente peggiorata. La camicia da notte era inzuppata di sudore ed aveva un freddo che la faceva tremare. Non si ricordava di aver mai avuto una gola così irritata
come quella che si ritrovava: mai si era sentita così a pezzi.
Rendendosi conto della gravità del suo stato, chiamò il medico dell'albergo, che venne subito, la esaminò accuratamente e confermò che aveva la febbre alta. Le disse anche
che quasi certamente la sua era una febbre ghiandolare,
chiamata anche mononucleosi infettiva. La informò che la
grave faringite che la affliggeva era tipica di questa particolare infezione virale. Le prescrisse quindi aspirina e antibiotici, la prima per la febbre e i dolori, i secondi per tenere alla larga qualsiasi complicazione batterica secondaria. Per
confermare la diagnosi, le ordinò di fare gli esami del sangue il giorno successivo. Nel frattempo doveva bere molti
liquidi e stare a completo riposo. Carol non aveva altra
scelta se non seguire il secondo consiglio, dato che, come ricordava, si sentiva terribilmente spossata.
Dopo quattro giorni a letto, si sentì molto meglio: benché
ancora debole, mal di gola e febbre erano quasi scomparsi.
Combinò per tornarsene a casa (volando come passeggero:
non si sentiva abbastanza bene per lavorare) e ricorda di essere rimasta un poco turbata quando il medico di Londra le
disse, al momento di partire, che tutti gli esami del sangue
erano stati negativi e che quindi egli non era in grado di
confermare la diagnosi di febbre ghiandolare. Malgrado
questo, rimaneva dell'idea che la mononucleosi era la causa
dei suoi problemi e che in sei settimane essa si sarebbe ripresa e sarebbe tornata di nuovo quella di prima.
304
Abbiamo già trattato i problemi associati alla mononucleosi infettiva. Questa malattia è causata da un virus della
famiglia dei virus erpetici, che in un qualche periodo della
nostra esistenza (in generale prima dei venticinque anni) infetta quasi il 100 per cento di noi. Per ragioni che non sono
del tutto chiare, le infezioni nei bambini, specialmente al di
sotto dei sei anni, raramente danno luogo a sintomi significativi. Quando il virus infetta un individuo, lo si può trovare nella saliva e quindi può essere disperso assieme a goccioline di questa, che raggiungono facilmente altre persone in
stretto contatto con l'individuo infettato. Un colpo di tosse
o uno starnuto può scaricare migliaia di particelle virali nell'aria circostante. Si trasmette anche particolarmente bene
con i baci e pertanto viene spesso chiamata, un po' romanticamente, «malattia del bacio».
Il virus interessato è noto come virus di Epstein-Barr, dal
nome dei suoi due scopritori. È unico nel senso che, oltre a
invadere la gola e le cellule epatiche, si insedia anche nei linfociti B. Una volta che ha invaso queste cellule produttrici
di anticorpi, l'unico modo di liberarsene è di ucciderle. E si
impegnano a farlo i linfociti T. Poiché la maggior parte dei
linfociti B vive nelle ghiandole linfatiche, la battaglia tra il
virus di Epstein-Barr e i linfociti T ha luogo proprio in queste ghiandole, che diventano gonfie e doloranti: da qui il
nome alternativo di «febbre ghiandolare».
Per un periodo che varia da un individuo all'altro, il sistema immunitario risulta alterato dall'infezione del virus
della mononucleosi e, pertanto, si svolgono reazioni immunologiche improprie. Per esempio, durante la fase della malattia precedente l'attacco dei linfociti T contro il virus, i
pazienti sono spesso colpiti per la prima volta da allergie.
Parecchi di loro rimangono malati per mesi, mentre combattono il virus: hanno un'infezione che va per le lunghe,
cioè continua. Altri pazienti infettati dalla stessa dose dello
stesso virus non sanno neppure di essersi imbattuti in esso,
tanto efficacemente il loro sistema immunitario controlla
l'invasione. La gamma di scenari osservati a seguito di
305
un'infezione con il virus di Epstein-Barr è determinata dalla
varietà di programmi genetici disponibili per dirigere, in
modo più o meno efficiente, l'attacco immunologico contro
il virus. La potenza del virus è costante, la risposta dell'ospite variabile. La mononucleosi di cui abbiamo parlato
non è quella che aveva colpito Carol, ma poiché nella nostra misteriosa malattia il virus di Epstein-Barr diventerà un
attore di primo piano, la spiegazione che abbiamo appena
data era necessaria.
Di ritorno a New York, Carol fu visitata dal suo medico,
secondo il quale la diagnosi formulata dal collega londinese
era con tutta probabilità esatta: pertanto le vennero prescritte altre due settimane di assoluto riposo a letto. Buona
paziente, Carol fece quello che le era stato ordinato e ne fu
ricompensata. Trascorso quel periodo, si sentiva meglio al
95 per cento e pronta a ritornare al lavoro. Ulteriori esami
del sangue non avevano mostrato la presenza di anticorpi
contro il virus di Epstein-Barr e pertanto la diagnosi di mononucleosi infettiva sembrava insostenibile. Il medico le
disse che il suo problema, ora praticamente risolto, doveva
essere stato causato da qualcosa di analogo al virus di Epstein-Barr.
Dietro insistenza del medico, Carol si prese altri dieci
giorni di riposo prima di ritornare al lavoro, pronta a riprendere la sua vita normale. Poco dopo, però, la misteriosa malattia colpì di nuovo, e in pieno.
Dopo due mesi di vita normale, Carol era sul punto di
riacquistare totalmente la salute, avendo raggiunto (così
pensava) l'85 per cento del suo stato di benessere. Ma ecco
che una mattina, che non ha avuto alcuna difficoltà a ricordare, si svegliò e si rese subito conto che, nello spazio di
una notte, il suo corpo se ne era fuggito e un nuovo corpo
era scivolato nel suo letto.
Questo nuovo corpo era quello di una donna molto vecchia, questa era la sua impressione. Obiettò che non voleva
muoversi e che era esausta. Inoltre, aveva male dalla testa
ai piedi. Sentiva che ogni muscolo, anche se lei rimaneva
306
immobile nel letto, reclamava. Al tatto molti erano doloranti. Con il massimo di forza di volontà, trascinò questo
nuovo «sé» fino alla stanza da bagno, quindi ricadde sul
letto, terribilmente esausta per lo sforzo compiuto. Era stata colta da stanchezza altre volte, ma non aveva mai provato nulla di paragonabile a questa sensazione. La testa le
martellava e, come ricordava poi, era confusa. Certamente
non poteva lavorare in quello stato e la cosa era inquietante, perché credeva che quel giorno fosse lavorativo. Tuttavia, tentando come poteva, non riusciva a costringere la
mente a concentrarsi sugli orari. Mentre cercava di analizzare gli spostamenti che, nella precedente settimana, aveva
compiuto per lavoro, si sentì incapace di raggiungere quell'agilità mentale che le era necessaria. Chiamò la compagnia aerea, seppe che, in effetti, avrebbe dovuto volare a
Francoforte, si scusò, disse che era malata e si dimise, con
grande dispiacere del funzionario che distribuiva i turni di
lavoro.
Quando arrivò il dottore, gli disse come si sentiva e subito scoppiò in una crisi di pianto incontrollabile. Si ricordava, quando venne da me, il singhiozzare che aveva accompagnato quella schiacciante sensazione di abbattimento. Il
medico, lo stesso premuroso medico che aveva consultato al
suo rientro dall'Inghilterra, constatò che era in uno stato
confusionale. Non riusciva a trovare nulla di anormale esaminandola e così le disse: «Lei potrebbe essere stata colpita
da un altro virus, Carol, oppure potrebbe trattarsi di un ritorno inaspettato del vecchio virus. Può capitare, sa. In
ogni caso, rimanga a letto, si riposi e sono sicuro che questo
virus o si dichiarerà o passerà via rapidamente, e lei potrà
così tornare al lavoro». Carol non è più tornata al lavoro e
sono ora quattro anni dalla prima comparsa del suo malessere.
Quello che seguì per Carol può solo essere immaginato
nel contesto di un incubo. Il suo nuovo corpo era lì per torturarla. C'erano giorni in cui il suo abbattimento in parte si
diradava, ma se provava a fare anche la cosa più semplice
307
da sola, l'avrebbe scontata con tre giorni di una spossatezza
così intensa da impedirle di attraversare una stanza.
Fece ritorno dai suoi genitori, dove venne accolta con
comprensione. Tuttavia, con il passare dei mesi, questo sentimento lasciò il posto a perplessità e frustrazione da parte
sia della paziente sia della famiglia. Il medico le fece fare
tutta una serie di esami e nulla di anormale risultò in alcuno
di quei programmi di screening ad alta tecnologia, cui erano ricorsi per analizzare il suo sangue.
Continuando quell'agonia, alcuni sintomi principali comparivano con maggiore costanza di altri: mali di testa, che
non erano tipici né della tensione né dell'emicrania, la assalivano ogni mattina: la confusione mentale e la labilità
emotiva che calavano su di lei «come un velo posto sulla
mente» continuavano e addirittura peggioravano. Questa
giovane donna, un tempo piena di energia e di risorse, era
l'ombra di quel che era stata. Oltre ai due sintomi costanti,
continuava ad essere preda di un'estrema spossatezza e di
dolori muscolari.
Notò altri cambiamenti su di sé. Talvolta, quando mangiava, si sentiva ancora più stanca e l'incubo diurno non la
abbandonava neppure nel sonno. Era assalita, quasi sempre
di notte, da incubi privi di senso, che la atterrivano e che si
distinguevano per i colori vivaci delle immagini. Quando
cercava di muovere i muscoli, trovava spesso che si contraevano e davano strappi in modo incontrollabile.
Naturalmente venne inviata da un nuovo medico per un
consulto. Il primo medico pensava che il maggiore affaticamente notato dopo aver mangiato fosse dovuto a bassi livelli di glucosio nel sangue, un problema non raro associato
a un'eccessiva liberazione di insulina dopo ingestione di
zuccheri. Le normali manipolazioni dietetiche, che aiutano
i pazienti con questo problema, non servirono per Carol.
Dopodiché molti medici affrontarono il suo caso, rimanendo tutti disorientati e incapaci di emettere qualsiasi diagnosi
di fronte alla costellazione dei suoi sintomi. Il terzo consultato, di una serie di ben sedici medici, guardò i risultati dei
308
suoi esami (risultati che, certo, non premiavano), osservò
per bene Carol e poi le disse, calmo e sicuro, che il male di
cui soffriva era di natura psicologica, più che organica. La
sua era una grave nevrosi ed era essenziale un urgente consulto psichiatrico.
Carol accettò rispettosamente il consiglio e si recò da uno
psichiatra, un uomo anziano saggio e con i piedi per terra.
Dopo parecchie ore di conversazione e di esami, disse a
quella paziente angosciata e ai suoi genitori disperati che
non riusciva a trovare nulla nella sua personalità che non
fosse completamente spiegato dalla frustrazione provata
per una simile situazione. Poiché non sembrava che le conclusioni dell'anziano dottore avrebbero in qualche modo
aiutato Carol, fu deciso di consultare un secondo e più giovane psichiatra, il quale giunse a conclusioni diametralmente opposte. Costui si attaccò al fatto che, immediatamente
prima di quel dannato viaggio a Londra, quando si ammalò
la prima volta, Carol aveva chiuso con una love story e questo, secondo lui, era l'indubbia causa del suo problema.
Quando Carol fece rilevare che era stata lei a rompere il
legame e che si era sentita davvero sollevata per essere uscita da una situazione che non la soddisfaceva, la sua spiegazione venne colta da orecchie freudiane che individuarono
una pletora di ragioni subconscie nella sua supposta malattia psicosomatica. Indotta dai genitori, Carol iniziò una terapia da quello psichiatra. Dopo sei mesi, però, paziente e
medico, entrambi frustrati per l'assenza di un qualsiasi progresso, furono d'accordo di troncare l'analisi.
Purtroppo la psicoterapia non giovò a Carol per due motivi: non solo non la aiutò, ma addirittura le fece del male.
La compagnia presso la quale lavorava, gli amici e perfino i
suoi familiari erano convinti che l'essere stata sottoposta a
psicoterapia significava essere affetta da una malattia psichiatrica. Sintomi bizzarri di fronte a esami del sangue normali vengono facilmente liquidati come nevrosi.
Dopo due anni di un simile calvario, Carol era spiritualmente sola, gravemente depressa, debole, in uno stato con309
fusionale e pietoso. Il suo sorriso un tempo vivace e i suoi
occhi sfavillanti avevano lasciato il posto a uno sguardo fisso, depresso e privo di vitalità. Alcuni medici che consultò
nel corso del suo penoso itinerario furono sufficientemente
umili da riconoscere la loro ignoranza e la possibilità che la
sua fosse una malattia sì strana, ma anche ben definita. Che
cosa potevano fare di una paziente i cui muscoli apparivano
normali (perfino al microscopio), non erano alterati, come
accade con i pazienti affetti da poliomielite, rispondevano
in modo normale se stimolati elettricamente, eppure impedivano a Carol di fare anche soltanto il giro dell'isolato, a
meno che essa non pagasse una penalità di tre giorni di assoluto riposo a letto prima di essere ancora capace di muoversi?
Carol non era certo la prima paziente con questo problema che mi era capitato di visitare: anzi. Avevo avuto circa
duecento pazienti in una situazione analoga. E, all'incirca
quindici anni prima, ero stato consultato da un pilota di linee aeree (una coincidenza, lo so; non voglio con questo dire che vi sia un legame tra il fatto di volare e il problema che
stiamo analizzando). Egli non poteva più volare sul suo
Jumbo, non solo perché era troppo debole, ma anche perché non riusciva a prendere quelle decisioni rapide e precise
che la sua professione richiedeva. Il suo racconto era stato
per molti aspetti simile a quello di Carol, ma il suo problema era meno grave. I disturbi erano cominciati con un attacco ben documentato di febbre ghiandolare. Durante
quella malattia che somigliava a un'influenza, produsse anticorpi contro il virus di Epstein-Barr, facilmente individuabili.
Come molti di voi sapranno dalla recente pubblicità che è
stata fatta in tutto il mondo, la sindrome da fatica cronica
di cui stiamo parlando è ben lungi dall'essere rara. Secondo
la parte del mondo in cui vivete, viene chiamata con vari
nomi: sindrome d'Islanda, malattia del Royal Free, neuromiastenia epidemica, sindrome cronica del virus di EpsteinBarr, encefalomielite mialgica, sindrome da fatica postin310
fettiva oppure, con il termine che abbiamo usato in questo
capitolo, sindrome da fatica cronica. Preferisco quest'ultimo perché non pretende di far credere che ne sappiamo di
più di quello che in realtà sappiamo. Per situare in una prospettiva storica ciò che veramente conosciamo di questa
malattia, guardiamo come essa, indipendentemente dal nome che le diamo, abbia attirato la prima volta l'attenzione
dei medici.
Nel 1955, a Londra, in una delle grandi cliniche universitarie, il Royal Free Hospital, stava lievitando (incubando
potrebbe essere la parola più adatta) un grave problema.
Quella clinica, antica, mirabile, accademica, poteva essere
fiera per molte cose. Una delle più efficienti unità di epatologia del mondo era stata installata in essa e i medici che vi
lavoravano potevano benissimo fare tutti parte del Who's
who della medicina britannica. Il 13 luglio di quell'anno,
due componenti dello staff, un medico e un'infermiera, si
presentarono al clinico dell'ospedale con un problema simile e misterioso. Vennero ricoverati per indagini. Nelle successive due settimane, altri settanta componenti dello staff
accusarono la stessa malattia e furono ricoverati. Mentre
tutti erano naturalmente interessati agli sviluppi della faccenda, nessuno fu preso dal panico perché, in definitiva,
quella era una clinica la cui équipe medica si era occupata
per anni della pericolosa epidemia di poliomielite. Poiché i
dirigenti della clinica non sapevano per certo che cosa stava
capitando al loro staff, sembrò loro prudente chiudere la
clinica: in ogni caso, il personale ormai era troppo scarso. Il
25 luglio le porte di quel grande ospedale si chiusero, per
riaprirsi solo in ottobre. Durante quel periodo, vennero visitati ben 292 membri dello staff con sintomi analoghi e 255
furono ricoverati. Ovviamente, doveva trattarsi di un'epidemia, ma quale?
I pazienti accusavano tutti sintomi analoghi, anche se variavano la gravità e l'associazione tra vari sintomi. Mali di
testa, labilità emotiva, stanchezza estrema, dolori alla
schiena, al collo e spesso a un arto, vertigini, una fastidiosa
311
indefinitezza della visione e un rigonfiamento delle ghiandole linfatiche erano sintomi comuni. Più preoccupanti di
tutti, c'erano chiari segni che i principali nervi che decorrevano nel capo non funzionavano bene. Il 20 per cento dei
pazienti accusò paralisi ai muscoli della faccia, molti avevano difficoltà a inghiottire, spasmi muscolari, sdoppiamento
della visione e disturbi sensoriali.
La maggior parte dei membri dello staff guarì abbastanza
rapidamente, ma il sintomo comune a tutti era un'estrema
spossatezza muscolare. Non fu trovato alcun agente infettivo che potesse spiegare l'epidemia, ma si ipotizzò che qualche nuovo agente, probabilmente un virus, si fosse diffuso
in tutta la clinica e avesse una predilezione specifica per i
muscoli e il sistema nervoso. Per alcuni membri dello staff
la malattia non scomparve rapidamente, ma persistette per
molte settimane, o mesi, o addirittura, per un piccolo numero, all'infinito. Non avendo trovato l'agente causale, era
comprensibile che la malattia si chiamasse, in attesa di una
precisazione scientifica, «malattia del Royal Free».
Quello che i medici impegnati a fronteggiare la situazione
del Royal Free Hospital non sapevano era che, nel febbraio
di quello stesso anno, un'epidemia con sintomi molto simili
era esplosa in tre zone della parte nordoccidentale di Londra. Ai sintomi del Royal Free si erano aggiunti una frequenza del polso molto elevata e incubi con immagini in technicolor a tinte vivaci. A parte questi sintomi in più, i problemi descritti dai pazienti erano identici a quelli dello staff
del Royal Free.
Con la pubblicazione, nel 1957, della storia del Royal
Free nella letteratura medica, cominciarono ad arrivare da
tutto il mondo resoconti di analoghe epidemie. Per esempio, nel febbraio del 1955, quando era scoppiata l'epidemia
nella parte nordoccidentale di Londra, un'altra epidemia simile si era verificata in un ospedale di Durban, in Sudafrica.
I ricercatori che si occupano di questo problema sono
concordi nell'affermare che la prima esplosione della «ma312
lattia del Royal Free» si è verificata al County General Hospital di Los Angeles nel 1934. Più di 35 epidemie sono state
registrate in tutto il mondo e le principali hanno avuto luogo nel 1948 in Islanda, nel 1949 ad Adelaide, nel sud dell'Australia, e in numerosi altri luoghi, il che fa pensare che
non si tratti di un problema delimitato geograficamente.
Alla fine degli anni Sessanta, gli scienziati stavano cominciando a interessarsi della malattia del Royal Free,
quando ebbe luogo un «evento» infausto. Proprio mentre
alcuni ricercatori proponevano il nome di encefalite mialgica (infiammazione del cervello e dei nervi con dolori muscolari), una classificazione soddisfacente per la malattia,
due psicologi, involontariamente ma con arroganza, provocarono un brusco arresto del normale corso della ricerca.
I due psicologi in questione avevano ottenuto di recente
un trionfale successo personale e ora stavano seguendo il
caso. Erano stati interpellati per esaminare un'epidemia di
spasmi muscolari dolorosi, che avevano colpito alcune studentesse di una scuola superiore femminile in Inghilterra.
Interessati al problema, esperti di isteria di massa, furono
subito in grado di attribuire i dolorosi spasmi delle mani e il
fremito delle labbra, accusati dalle ragazze, a un'eccessiva
attività respiratoria: un'isteria di massa che portava a panico e iperventilazione in forma epidemica. Quando aumenta
l'attività respiratoria senza che ciò sia richiesto da un'attività fisica, il corpo libera presto una quantità eccessiva di anidride carbonica. Il contenuto acido del sangue e dei tessuti
diminuisce, i nervi diventano molto eccitabili e ne consegue
uno spasmo.
I due medici chiesero al Royal Free Hospital il permesso
di esaminare le cartelle cliniche di quei pazienti che erano
stati colpiti durante la famosa epidemia. Secondo l'ipotesi
che volevano verificare, le persone colpite avrebbero dovuto essere predisposte a psiconevrosi. Nel 1970 essi pubblicarono un articolo nel quale esprimevano l'opinione che l'epidemia verificatasi al Royal Free Hospital era, di fatto, un
esempio meraviglioso di isteria di massa e che analoghe epi313
demie nel mondo potevano essere spiegate allo stesso modo. La sicurezza di questi psicologi era difficilmente giustificata quando si considera che essi non avevano mai visto i
pazienti e non avevano notato alcuna incongruenza associata al fatto che il 79 per cento di loro aveva avuto un ingrossamento delle ghiandole linfatiche, l'89 per cento la febbre,
il 45 per cento la paralisi dei muscoli oculari e il 19 per cento era incapace di muovere i muscoli facciali: tutti sintomi
che è difficile produrre per isteria!
Il danno fu fatto, tuttavia. E i mezzi di comunicazione di
massa si appropriarono di quella sensazionale spiegazione
quale esempio di come l'estrema raffinatezza raggiunta in
medicina permettesse ai medici dei nostri giorni di capire
che non nuove malattie organiche, bensì disturbi della personalità sono all'origine di nuove sindromi.
Il «Sunday Times» di Londra e una fonte non meno autorevole, il «Time magazine», accettarono senza discutere
la tesi dell'isteria e, nel fare questo, peggiorarono notevolmente la sofferenza di molte migliaia di individui, affetti
dalla sindrome da fatica cronica e ben lungi dall'essere isterici. Il grosso pubblico, molti degli stessi pazienti e innumerevoli medici, a disagio per non essere capaci di comprendere la malattia in termini organici, accettarono la tesi dell'isteria, e la sindrome venne quasi sempre considerata una
nevrosi.
Gli scienziati migliori sono simili ai migliori detective.
Non possono scartare indizi importanti solo perché stravolgono qualche vaga idea preconcetta. Sicuramente i nostri
psicologi avrebbero dovuto presentare le loro conclusioni
su una montagna di riserve, ammettendo che c'erano alcuni
punti che potevano benissimo inficiare la loro ipotesi. Certamente la loro inequivocabile diagnosi di isteria di massa
poteva calzare per qualche individuo, ma cozzava senz'altro con i dati che le cartelle cliniche di molti pazienti riportavano, e cioè che era stato necessario alimentarli con una
sonda gastrica, tanto grave era la paralisi (oggettiva) dei
muscoli necessari per inghiottire.
314
I medici che hanno in cura pazienti affetti da malattie
croniche sanno, se sono dotati di intuito, che i problemi psicologici si sviluppano come conseguenza della frustrazione
di vivere con così poca salute. Spesso una simile situazione
stimola il medico a utilizzare sia la sua arte sia la scienza per
separare il funzionale dall'organico. Entrambi gli elementi
del processo patologico richiedono una cura, ma una cura
di tipo diverso. Non è in alcun modo sorprendente che molti, anzi la maggior parte, dei pazienti affetti dalla sindrome
da fatica cronica abbiamo qualche serio turbamento psicologico, che accresce l'infelicità estrema inevitabilmente associata alla malattia di base.
La rilevanza di sintomi come la labilità emotiva, la depressione, il deterioramento della memoria e del potere di
concentrazione è costante. Secondo il mio parere, questa
sintomatologia è causata dalla malattia stessa e non certamente il contrario.
Per riassumere fino a questo punto, sindromi da fatica
cronica sono state descritte fin dal 1934. È perfettamente
ragionevole presumere che esse si siano verificate anteriormente a tale data, ma siano state classificate o confuse con
le più svariate malattie che mettono a repentaglio la vita.
Nei pazienti affetti da sindrome da fatica cronica l'invalidità può essersi sviluppata come postumo sia di una malattia
di tipo influenzale che ha colpito la loro comunità (un'epidemia) sia di un evento patogeno, che li ha selezionati in seno a una maggioranza sana (forma endemica). Nel primo
caso, si può presumere che il responsabile sia un agente infettivo non ancora identificato (virus?). Per quelli con complicazioni a lungo termine, in contrapposizione alla maggioranza che è guarita rapidamente, sembra probabile che
la responsabilità risalga ad un difetto intrinseco che compromette in qualche modo le difese contro l'agente causale.
In questa seconda situazione, una forma meno virulenta
dello stesso agente, inefficace nel tentativo di danneggiare
la maggioranza, potrebbe essersi accontentata di un ospite
meno in grado di resistere, per ragioni genetiche, a quella
315
particolare infezione. In alternativa, potremmo discutere
due malattie nettamente separate.
In entrambi gli scenari suggeriti, un difetto dell'ospite
viene promosso a fattore predisponente lo sviluppo della
sindrome da fatica cronica. Quale potrebbe essere? Un difetto genetico che sminuisca l'efficienza di una risposta all'infezione dovrebbe tradursi in un difetto immunologico e
questa ipotesi è stata ormai comprovata come verità. La dimostrazione riproducibile di anomalie a carico dei linfociti
T in pazienti affetti da sindrome da fatica cronica è la ragione per la quale stiamo parlando di questa malattia.
Nel momento in cui scrivo, siamo ben lungi dall'aver raggiunto una comprensione completa degli eventi molecolari
che producono, in definitiva, sintomi così devastanti per i
nostri pazienti, ma non vi è più alcun dubbio che la sindrome di cui stiamo trattando è in primo luogo organica, e non
psicologica. Migliaia di pazienti etichettati in precedenza
come nevrotici sono stati riscattati. Sfortunatamente, l'ignoranza diffusa, sempre presente, di tale situazione patologica perpetua in molti individui un tormento psicologico.
I pazienti con sintomi classici di sindrome da fatica cronica quasi sempre hanno, nel sangue, un numero ridotto di
cellule immunoregolatrici. Spesso è anche ridotto il numero
dei linfociti T induttori o che lanciano l'allarme. Un altro
risultato quasi universale, conseguito dai ricercatori della
mia unità, è stata l'anergia: i pazienti con sindrome da fatica cronica non riescono a rispondere in modo soddisfacente
agli antigeni che vengono loro iniettati sotto cute. Queste
anomalie sono così costanti che, quando sono associate a
sintomi specifici, permettono di fare una diagnosi «positiva», invece di una diagnosi fatta escludendo altri problemi.
Il concetto di difetto genetico che dà luogo a una prestazione meno che ideale delle cellule immunoregolatrici ci
permette di capire meglio un dato sulla sindrome da fatica
cronica, che sta raccogliendo crescenti apprezzamenti.
Nella forma endemica, sembra che molti e diversi agenti
estranei («non sé») siano in grado di innescare la sindrome
316
da fatica cronica. È questa la ragione per la quale non mi
piace il termine «sindrome da fatica postinfettiva». La sindrome può essere innescata da proteine estranee, incapaci
di provocare un'infezione. È ciò che si osserva soprattutto
in seguito alla somministrazione di un vaccino o di un antigene per accrescere la risposta immunitaria.
Harry, a trentasei anni, era un uomo felice sia per la sua
situazione familiare sia per il lavoro come ispettore di un
parco nazionale. Ed ecco che, improvvisamente, viene colpito dalla sindrome da fatica cronica. Come è tipico delle
persone che passano la loro vita a proteggere la natura, egli
parlava sommessamente, aveva una salute vigorosa ed era
in pace con sé e con il mondo che lo circondava. Un giorno
stava ripulendo una zona della foresta che era stata insozzata da alcuni visitatori. Questi avevano abbandonato sul luogo lattine e bottiglie, a dimostrazione di quanto poco avessero apprezzato la bellezza che erano venuti a esplorare.
Prendendo da terra una lattina, Harry si tagliò un dito, non
malamente, ma forse - egli pensò - quella ferita avrebbe richiesto un punto. Si recò in macchina all'ospedale locale,
dove il medico ritenne che un bendaggio sarebbe stato sufficiente; ordinò tuttavia, a scopo precauzionale, un'iniezione
di richiamo contro il tetano. Harry non aveva ricevuto un'iniezione del genere da dieci anni e il consiglio era, dunque,
giusto. Dodici ore dopo l'iniezione, stette male: aveva la
febbre alta, un freddo che lo faceva tremare e un forte male
di testa. Tornò a letto. Non c'era alcuna reazione nel punto
dell'iniezione antitetanica, il che escludeva una reazione immunitaria estremamente vigorosa contro lo stesso antigene
del tetano come causa del problema. Reazioni di questo tipo compaiono se si fanno troppo spesso iniezioni antitetaniche.
Per tre giorni Harry non migliorò; poi ebbe un parziale
ricupero. Ritornò al lavoro dopo una settimana, ma si sentiva assolutamente esausto. Il suo stato di affaticamento
persisteva. Tre anni dopo non era ancora ritornato nella foresta. Per lui fare il giro attorno alla casa voleva dire essere
317
condannato a rimanere sei ore a letto per ricuperare. Egli è
ancora tormentato da mali di testa e da confusione mentale
che provoca un deterioramento della memoria e della capacità di concentrazione. Ho osservato questo tipo di reazione
molte volte, eppure sappiamo che, per la grande maggioranza, un'iniezione antitetanica è innocua, è uno stimolo
per il sistema immunitario, che preserva la vita. Essa, comunque, non provoca la sindrome da fatica cronica, ma
può innescare una catena di eventi, finora poco compresi,
che possono portare a quella malattia.
Nel Regno Unito gli agenti scatenanti più comuni per la
sindrome da fatica cronica sono gli enterovirus. Si tratta di
una famiglia di minuscoli virus, che prediligono il nostro
intestino (da cui il nome: enteron in greco significa intestino). Può avere un considerevole significato il fatto che il
particolare enterovirus associato nel Regno Unito con la
sindrome da fatica cronica, e cioè il virus Cocksackie, è
molto affine ai demoni che provocano la poliomielite. I virus Cocksackie furono scoperti quarant'anni fa nelle feci di
due bambini con una diagnosi sospetta di poliomielite. Oggi
sappiamo che vi sono ben settantun membri della famiglia
degli enterovirus, che includono non solo i virus che causano la poliomielite e la famiglia dei Cocksackie, ma anche i
virus ECHO, responsabili di numerose malattie. Tutti si
moltiplicano nell'intestino.
Cocksackie è un delizioso piccolo villaggio sulle rive del
fiume Hudson, nello Stato di New York. Gli abitanti considerano con un certo dispiacere il fatto che esso sia diventato
famoso perché quei cattivi enterovirus di cui stiamo parlando sono stati isolati proprio lì.
Non vi è alcun dubbio che, sia negli animali sperimentali
sia nei soggetti umani, il virus Cocksackie possa danneggiare i muscoli e il sistema nervoso. Esso è un virus estremamente infettivo, tanto che, se un membro di una famiglia
viene infettato, vi è il 76 per cento delle probabilità che anche gli altri membri della famiglia lo siano. Dati recenti fanno pensare che, in individui geneticamente programmati,
318
un particolare virus Cocksackie possa innescare sul pancreas un attacco immunologico che potrebbe portare al diabete giovanile.
Negli Stati Uniti, il virus di Epstein-Barr, che può causare la febbre ghiandolare e fare precipitare numerose forme
di cancro, è considerato da tempo uno dei principali agenti
innescanti della sindrome da fatica cronica. Indipendentemente da quale lato dell'Atlantico ci troviamo, indipendentemente da quale agente funga da innesco (il virus Cocksackie, la tossina tetanica, i parassiti, il virus di Epstein-Barr,
e via dicendo), la sindrome è identica.
La logica esige che estendiamo quell'ipotesi di cui abbiamo parlato prima. Un virus particolare può provocare un'epidemia di sindrome da fatica cronica, ma un numero qualsiasi di proteine estranee (tra cui una forma meno virulenta
del virus che provoca l'epidemia), penetrando in un ospite
con un difetto specifico del sistema immunitario, può produrre la stessa sindrome.
Una scoperta recentissima ha dimostrato che c'è un nuovo candidato che potrebbe innescare la sindrome da fatica
cronica. Si tratta di un virus erpetico (questi virus portano
sempre brutte notizie), di nome HBLV (dall'inglese Human
B cell Lymphocyte Virus, cioè virus che vive nei linfociti B
umani). Ricercatori americani hanno trovato anticorpi contro di esso in molti dei loro pazienti affetti da sindrome da
fatica cronica. Abbiamo cercato nei nostri pazienti e abbiamo trovato la stessa cosa. Il problema è che è chiaro ormai
che l'infezione con il virus non ha confini; la maggior parte
dei nostri controlli è stata anch'essa prima o poi infettata.
Così l'HBLV può essere un altro agente innescante della
sindrome da fatica cronica in forma endemica, ma non è
l'unica causa, poiché non produce la malattia nella maggior
parte della gente che infetta.
Negli ultimi due anni, una serie di anomalie ben definite è
stata scoperta in pazienti con sindrome da fatica cronica.
Con questi dati nuovi e affascinanti, gli scienziati hanno
davanti a loro un complicato puzzle, con il 50 per cento dei
319
pezzi disponibile. Mentre i contorni del progetto biologico
sono ancora sfumati, vi sono sufficienti elementi caratteristici per poter formulare una serie più attendibile di ipotesi
verificabili. Quali sono questi nuovi dati?
I sintomi dei pazienti affetti da sindrome da fatica cronica fanno pensare che il loro problema si sia sviluppato all'interno dei muscoli. Hanno dolori e si sentono deboli.
Sintomi come questi potrebbero insorgere anche in persone
con muscoli perfettamente normali se quella parte del cervello che, normalmente, è deputata a interpretare i segnali
che provengono dai muscoli fosse anch'essa difettosa. Ma,
nella sindrome da fatica cronica, è di gran lunga più probabile che siano proprio i muscoli a essere danneggiati dalla
malattia. Quindi i messaggi di debolezza e di dolore che
vengono ricevuti dal cervello vengono chiaramente e accuratamente interpretati come un desiderio, da parte dei muscoli, di non muoversi. C'è qualche prova di questo danno
ai muscoli?
La diagnosi per immagini, basata sulla risonanza magnetica, è un progresso tecnologico di notevole importanza.
Come le tecniche che si basano sui raggi X, così anche quelle che si basano sulla risonanza magnetica danno origine a
immagini che vengono elaborate al calcolatore. Come potenti fotocamere installate su satelliti possono oggi fornirci
dallo spazio le immagini delle mosse di una partita a scacchi
compiute da una coppia di anziani seduti in un parco, così
le fotocamere usate in medicina possono oggi osservare gli
eventi molecolari che si svolgono nel nostro organismo. I
muscoli, per esempio, constano di fibre e queste di fibrille,
le quali sono fatte di proteine, a loro volta costituite da atomi, fatti di elettroni, neutroni e protoni, che si muovono
l'uno attorno all'altro in quella che è la più ordinata danza
di tutta la biologia. La risonanza magnetica per immagini ci
permette di osservare questi eventi in un dato tessuto e di
confrontare gli eventi molecolari visti in un tessuto malato
con quelli osservati in un tessuto sano. Grazie a questa tecnologia, cominciano ad arrivare resoconti su pazienti affetti
320
da sindrome da fatica cronica, nei cui muscoli sono state rilevate anomalie biochimiche distinte.
Un esame al microscopio elettronico di campioni bioptici
di muscolo rivela alterazioni tenui, ma ben definite, a carico delle fibre muscolari e delle cellule che le costituiscono.
Ed ecco allora che la vecchia affermazione di molti medici
che non vi è nulla di anormale nei muscoli di pazienti affetti
da sindrome da fatica cronica deve essere riconsiderata. I
precedenti ricercatori non avevano usato tecniche in grado
di rilevare quelle tenui alterazioni che sono osservabili oggi.
Poiché è ovviamente più difficile fare una biopsia del cervello che non del tessuto muscolare, dobbiamo presumere
al momento che analoghi eventi biochimici influiscano anche sul funzionamento del sistema nervoso centrale.
Che cosa provoca quelle reazioni biochimiche difettose
che danno origine a un'alterata funzione? Vi sono numerose possibilità, che non si escludono reciprocamente. Una di
esse chiamerebbe in causa la persistenza, in un tessuto colpito, di particelle non eliminate dell'agente innescante, le
quali interferirebbero direttamente con gli enzimi del muscolo, o con altre sostanze biochimiche vitali, necessarie per
la funzione muscolare. Un'altra vedrebbe in quelle particelle degli stimolatori di un attacco immunologico cronico che
danneggerebbe i tessuti normali vicini non implicati. Secondo un'altra possibilità ancora, programmi genetici portati
da virus riprogrammerebbero le cellule normali, le quali, di
conseguenza, comincerebbero a funzionare in modo anomalo. Tutte queste spiegazioni incriminano senza mezzi termini il sistema immunitario, il quale avrebbe dovuto, entro
pochi giorni dal loro ingresso nell'organismo, mandare tutti
gli agenti innescanti nel «mucchio dei rifiuti» immunologia.
Studi effettuati di recente nel Regno Unito, con tecniche
modernissime, hanno permesso di scoprire che almeno alcune particelle di virus Cocksackie persistono nei muscoli di
alcuni pazienti con sindrome da fatica cronica. Questo risultato sicuramente rafforza la tesi di coloro che sostengo321
no che antigeni parzialmente degradati siano responsabili
della malattia.
Che sia importante o no per questa sindrome, oggi si nutre un notevole interesse per dati recenti, che hanno confermato la possibilità che un'insolita forma di infezione virale
persistente sia responsabile di numerosi processi patologici.
Sappiamo che, una volta che sono penetrati nel n o 6 t r o organismo, i virus herpetici non lo abbandonano più. Per la
maggior parte di noi non è un problema. Se ne stanno tranquilli e inermi lungo le guaine dei nervi o nei linfociti B,
senza disturbare la funzione di un tessuto o delle cellule che
hanno invaso. Questa condizione di tranquillità non ha nulla a che fare con una eventuale «bontà» intrinseca del virus.
Se gli occhi attenti del nostro sistema immunitario dovessero avere un momento di esitazione, il virus afferrerebbe subito l'opportunità per moltiplicarsi e invadere: il fuoco di
Sant'Antonio ne è l'esempio classico.
Ciò di cui ci stiamo rendendo conto ora è che i virus possono penetrare in un tessuto o in una cellula e modificarne
la funzione mentre il sistema immunitario non mostra alcun
interesse. Questo è un nuovo concetto di infezione. Sia
l'uomo della strada che i medici sono avvezzi al concetto
che i microrganismi invadono e danneggiano un tessuto
moltiplicandosi, liberando tossine, eccetera. La battaglia
che segue, in cui le forze immunologiche danno vita a una
loro guerra chimica, si somma ai tormenti del tessuto invaso e dell'organismo a cui appartiene. Una battaglia all'apogeo, che generalmente vede la vittoria del sistema immunitario: l'invasore viene respinto e il tessuto innocente che ha
ospitato la battaglia a poco a poco ricupera se stesso.
L'ingegnosità dei virus ci mette, tuttavia, oggi di fronte a
un altro scenario. In questa versione dell'infezione, un virus
si immerge in una cellula e inserisce il proprio programma
genetico nel computer della cellula stessa (cioè nel DNA del
nucleo), modificando in questo modo le istruzioni per il suo
funzionamento. Noi oggi riteniamo che alcuni virus possano fare questo senza interferire con i meccanismi riguardan322
ti la parete esterna della cellula. Questo secondo stratagemma è essenziale perché il sistema immunitario sia raggirato.
Di solito, quando i virus invadono le cellule, il fatto viene
riconosciuto dal nostro sistema immunitario da componenti
«non sé» che compaiono sulla superficie di quelle cellule. I
linfociti T distruggeranno poi queste cellule e i virus che
contengono.
Nel parlare di sindrome da fatica cronica, ci interessa l'idea che alcuni virus, forse solo in persone geneticamente
suscettibili, possano causare la malattia non distruggendo le
cellule che invadono, ma alterandone la funzione specializzata. Un'impercettibile invasione delle cellule nervose e muscolari in un modo che potrebbe distruggere la funzione
normale senza distruggere le cellule e sfuggire ai meccanismi di sorveglianza immunologica, parzialmente compromessi, spiegherebbe il mistero della sindrome da fatica cronica. Una simile concezione si concilia male con l'osservazione che agenti innescanti la sindrome siano proteine non
vitali (per esempio, del tetano).
Analizzeremo ora la teoria secondo cui un numero indefinito di antigeni localizzati nei muscoli e nel sistema nervoso
può essere attaccato in modo cronico, ma subottimale, da
un insieme di linfociti T difettosi. Il tessuto normale è danneggiato dalla concentrazione di sostanze che dovrebbero
essere presenti nei tessuti solo per un breve periodo di tempo. Se si esaminano gli effetti secondari dell'interferon, un
prodotto dei linfociti T normalmente liberato in modo transitorio nel corso di un'infezione, ma oggi disponibile per
scopi terapeutici, questi effetti, associati a una dose troppo
elevata del prodotto, sono molto simili ai sintomi della sindrome da fatica cronica.
Questo ci ha indotti ad adottare una terapia immunologica che sicuramente rappresenta il successo più eccitante che
abbiamo avuto in tutti i nostri tentativi di aiutare i soggetti
colpiti da tale malattia. Gli immunologi sono sempre stati
affascinati dai benefici effetti di dosi molto elevate di gammaglobulina, somministrate per fleboclisi. Sono oggi dispo323
nibili in commercio preparati di immunoglobulina G quasi
pura, estratta e concentrata dal sangue di 3000 o più esseri
umani sani.
Mentre la somministrazione di questi preparati a pazienti
che non possono produrre immunoglobulina G salva loro la
vita, siamo rimasti entusiasti dalla scoperta che molti pazienti, colpiti da malattie autoimmuni, siano notevolmente
migliorati dopo aver ricevuto forti dosi di questi preparati.
Pazienti il cui sistema immunitario alterato sta loro distruggendo piastrine o globuli rossi, bloccando le interazioni
neuro-muscolari, corrodendo le articolazioni, distruggendo
la cute e via dicendo, sono stati aiutati, talvolta in modo
drammatico, da una fleboclisi di gammaglobulina.
Siamo ben lungi dall'essere certi su come le dosi farmacologiche che somministriamo producano il loro incantesimo,
ma non ci mancano le teorie. Per me, l'osservazione più interessante è quella del miglioramento della funzione dei linfociti T regolatori in seguito a queste fleboclisi. Può darsi
che forti dosi di IgG rimettano in sesto l'attività disordinata
dei linfociti T.
Nel 1986, un mio amico del New Jersey mi disse di aver
somministrato una forte dose di IgG a un paziente affetto
da sindrome da fatica cronica e di aver ottenuto un notevole miglioramento. Avanzammo alcune ipotesi sui possibili
meccanismi intervenuti e decisi di tentare lo stesso procedimento su un giovane affetto da una grave forma della malattia.
Jason, diciannove anni, era distrutto dalla debolezza, per
descrivere la quale «non vi sono parole». Era così debilitato
che poteva impiegare un'ora per portarsi dal soggiorno al
bagno. Un simile sforzo lo lasciava esausto, al punto che
avrebbe avuto bisogno di passare cinque-sei ore a letto per
ricuperare quel tanto di energia che gli permettesse di stare
seduto e di conversare con il resto della famiglia.
Due anni prima era avviato verso una brillante, anche se
insolita, carriera: era campione di surf e, all'età di diciassette anni, si era piazzato terzo nella classifica mondiale. Gior324
no dopo giorno, passava il suo tempo a danzare fra cresta e
ventre delle onde. Era perfettamente in forma.
Un destino avverso lo colpì, facendolo ammalare di una
tipica mononucleosi, simile a un'influenza, con febbre per
una settimana, infiammazione alla gola, rigonfiamento delle ghiandole linfatiche e un inizio di debolezza, che non lo
avrebbe più abbandonato. Col passare dei mesi, Jason divenne più debole e si avviò su quel troppo noto cammino
costellato di frustrazioni, che va a sommarsi ai tormenti di
chi è colpito da sindrome da fatica cronica. Venne consultato un medico dopo l'altro, inutilmente.
Alla fine, un eminente psichiatra disse, senza tentennamenti, a lui e ai suoi genitori delusi che la paura delle difficoltà incontrate nella competizione aveva prodotto una paralisi psicologica. Era il modo con cui Jason, dignitosamente, si ritirava di fronte alle pressioni del giro dei surfisti professionali, nel quale si stava imbarcando. I genitori credettero alle parole del medico e imbottirono di antidepressivi
quel loro figlio completamente depresso. Non ottennero alcun miglioramento.
Quando, finalmente, Jason venne nella nostra clinica,
non potemmo trovare nulla di anormale a un esame fisico.
Dico «finalmente» perché era mancato due volte agli appuntamenti, essendo stato preso da imbarazzo nel chiamare
un taxi, perché temeva di non essere in grado di ricordare
dove il taxi avrebbe dovuto portarlo. Solo quando i suoi genitori, che lavoravano entrambi, lasciarono delle istruzioni
scritte, Jason giunse alla nostra clinica.
Voleva provare la terapia con la IgG e la sua risposta fu
molto incoraggiante. Nella settimana successiva a una serie
di fleboclisi, praticate per tre giorni, a dire il vero ebbe un
peggioramento: i suoi muscoli erano doloranti e potevamo
realmente vedere il fremito, sotto forma di una miriade di
contrazioni, che correva lungo le fibre muscolari. Aveva
dolori al petto e una sensazione di angoscia. Quindi, un
mattino, «come se un diavolo fosse scappato dal suo corpo», si risvegliò incredibilmente leggero: si sentiva come se
325
stesse galleggiando in una piscina. Quando si alzò dal letto,
per la prima volta in tre anni fu pieno di energia. Tre mesi
dopo stava di nuovo sfidando le onde dell'oceano e ora, a
un anno di distanza, pensa di essere pronto per la competizione. Sono stato molto lieto di poter descrivere in una lettera al suo psichiatra il seguito della vicenda.
Con la stessa terapia abbiamo finora curato più di ottanta pazienti con forme gravi di sindrome da fatica cronica: il
70 per cento ha avuto miglioramenti significativi e pensiamo che il 40 per cento sia guarito, anche se la nostra sicurezza su questo dato aumenterà quando sarà passato un po'
più di tempo.
Nella scienza, il cammino che porta all'inferno è lastricato di prove incontrollate e di aneddoti. Sono prudentemente
ottimista che la terapia appena descritta sfocierà in un duplice successo nella lotta che stiamo conducendo con la sindrome da fatica cronica. In primo luogo, aiuterà molti pazienti a guarire, anche se è già sicuro che non tutti daranno
una risposta positiva: e su questo dovrà essere fatta una seria ricerca. In secondo luogo, lancerà una sfida agli immunologi affinché trovino il motivo per cui la IgG aiuta i pazienti a guarire. Se si troverà la spiegazione, saremo più vicini a capire la causa fondamentale della malattia.
Può darsi che il pool delle gammaglobuline contenga gli
anticorpi contro un virus specifico, presente in molti individui che danno a quell'agente una risposta immunitaria adeguata e non subiscono i postumi di quell'incontro. Il loro
know-how immunologico, sotto forma di anticorpi, può
portare all'eliminazione dello stesso virus, ubiquitario ma
sconosciuto, che non è stato neutralizzato fino in fondo dal
sistema immunitario dei pazienti di sindrome da fatica cronica. Non abbiamo alcuna prova per sostenere questa teoria, ma la reazione nei muscoli in seguito a una fleboclisi di
gammaglobulina evoca alla mente immagini di anticorpi
che raggiungono i muscoli per attaccare qualcosa.
In alternativa, la gammaglobulina può correggere un difetto dei linfociti T immunoregolatori, i quali possono così
326
ritornare a svolgere il loro compito abituale, che è quello di
tenere in ordine la loro casa. Parte di questo compito comporta l'eliminazione di virus o di particelle virali nel cervello e nel tessuto nervoso.
Il dover far fronte a centinaia di pazienti colpiti da sindrome da fatica cronica mette faccia a faccia con molte delle inadeguatezze della medicina contemporanea. Per quelli
di noi che insegnano medicina, è triste rendersi conto che
abbiamo prodotto una generazione di medici così appagati
da quello che sanno e così a loro agio nelle indagini in cui
viene utilizzata l'alta tecnologia, da non interessarsi troppo
(o per niente) alle ricerche di fisiologia e fisiopatologia
umana.
I medici moderni preferiscono, purtroppo, osservare i risultati su un foglio che esce da un computer, piuttosto che
ascoltare le osservazioni credibili, coerenti e ragionate dei
loro pazienti, i quali, in fin dei conti, convivono con il loro
corpo. Se i risultati degli esami del sangue sono tutti normali, i sintomi sono generati da una psiche alterata.
Questo atteggiamento da parte dei medici ha condotto a
una sofferenza esagerata, alla disperazione e perfino al suicidio tra le vittime della malattia. La reazione quasi universale dei miei pazienti con sindrome da fatica cronica, quando ho mostrato loro i risultati in cui erano messe in evidenza anomalie a carico dei linfociti T, è stata uno scoppiare in
un pianto di sollievo. L'essere creduti, l'avere qualche prova di non essere nevrotici, ha dato luogo istantaneamente a
un certo grado di miglioramento. «Per favore, potrei avere
una fotocopia dei risultati?» è la richiesta di quasi tutti.
L'altra conseguenza dell'arroganza intellettuale di alcuni
dei miei colleghi è stata l'aver spinto i pazienti con sindrome da fatica cronica e, a dire il vero, tutti quei pazienti colpiti da malattie incurabili o scarsamente conosciute, verso il
mondo della medicina alternativa. Qui, se uno è fortunato,
può trovare un professionista dell'arte del guarire, innovatore, dotato di intuito e con una mentalità scientifica, che
sfida in modo costruttivo l'ortodossia della scienza moder327
na. Purtroppo, però, ci sono di gran lunga maggiori possibilità di andare a finire nelle mani di un venditore - scientificamente inattendibile - di speranza ai disperati, che sono
la preda più facile dei ciarlatani e degli imbroglioni. Nessuna categoria di pazienti è stata più sfruttata di quelli con
sindrome da fatica cronica, i quali, in uno stato comprensibile e, in verità, prevedibile di disperazione, tenterebbero
qualsiasi cosa.
Vi sono pazienti che si sono recati fino in Nuova Zelanda
per farsi visitare da un uomo che sostiene di guarire la sindrome da fatica cronica esponendo il malato a una sequenza specifica di colori. Ad altri sono state somministrate dosi
massicce di vitamina C, di triptofano, di lecitina, di prodotti macrobiotici, di olio di fegato di merluzzo, e via dicendo.
Un guaritore americano sostiene che la sindrome da fatica
cronica può essere guarita dando colpetti ripetuti sul timo e
adunando, con tutta la propria energia mentale, i linfociti T
che se ne stanno in agguato all'interno della ghiandola. I
pazienti spendono anche 3000 $, o pressapoco, per recarsi
presso «unità di disintossicazione» dove vengono depurati
con clisteri, vitamine ed esercizi fisici. Una delle mie pazienti (poveretta!) ha speso di recente un'ingente somma di denaro per procurarsi cristalli dalle forme diverse, che ha posto strategicamente attorno al letto, secondo le istruzioni
che le erano state date, in modo da suscitare gli antichi e
mistici poteri delle piramidi d'Egitto, che possono esorcizzare i mali che producono la sindrome da fatica cronica.
Terapia e terapisti sopravvivono solo perché molti pazienti, nella loro disperazione, hanno un miglioramento a
breve termine, dato che il ben noto effetto placebo influisce
sulle persone ansiose di trovare una cura. Molti di coloro
che traggono vantaggio sono, in effetti, pazienti con alterazioni psicologiche, per i quali la via di uscita è la psicoterapia. Molti di questi pazienti pensano, e hanno in effetti riferito, di avere la sindrome da fatica cronica, ma in realtà
questo non è il loro caso.
A causa della natura dei sintomi, molti pazienti che visi328
to, e che sono sicuri di avere la sindrome da fatica cronica,
sono in realtà in errore. Come ho già detto, sono necessarie
sia l'arte di un medico sia la sua scienza per distinguere l'organico dal funzionale e per rendersi conto che, pur differendo il trattamento, la sofferenza con entrambi i tipi di disturbi sarà la stessa.
Concluderò tentando di chiarire alcuni dei punti controversi sui quali oggi ci sentiamo sicuri. È vero che la sindrome da fatica cronica può avere una distribuzione familiare,
ma quasi certamente per ragioni genetiche, e non infettive.
La programmazione genetica dei membri della famiglia rende costoro suscettibili al meccanismo che produce la malattia, qualunque esso sia.
È vero che la sindrome da fatica cronica raramente compare in soggetti al disopra dei cinquant'anni, ma sono stati
riscontrati casi ben definiti: può colpire individui di mezza
età e persistere fino alla vecchiaia. È certamente falso che la
sindrome risparmi i bambini; ne ho curati, infatti, parecchi
e il più giovane aveva sei anni. Può colpire anche soggetti
con un minor numero di anni.
La sindrome da fatica cronica viene spesso citata dai
mezzi di comunicazione di massa come la «malattia degli
yuppies». Questo non è soltanto crudele, ma impreciso. La
connotazione evocata dal termine è quella di un giovane dirigente o professionista di successo, che trova tutto un po'
eccessivo e che cerca una scusa per sottrarsi alla corsa sfrenata per la carriera. La sindrome colpisce gente di tutte le
categorie socio-economiche, anche se l'ostinazione e i contatti necessari per aprirsi un varco attraverso il pregiudizio e
l'ignoranza di molti medici si trovano più facilmente nelle
persone con un livello di istruzione superiore.
È vero che la sindrome da fatica cronica sembra colpire
più le donne che gli uomini, cosa che accade con la maggior
parte delle malattie immunologiche. Quando un uomo è affetto dalla sindrome, lo è in genere in una forma molto
grave.
Parecchi pazienti con sintomi corrispondenti alla sindro329
me da fatica cronica sostengono di essere molto sensibili all'ambiente e ai numerosi composti chimici che si trovano
nei cibi, nei farmaci, e via dicendo. Questa sensibilità chimica (che, qualunque ne sia la causa, è certamente non allergica nel senso immunologico) è forse un'estensione della
sindrome di base della fatica cronica? Meccanismi simili a
quelli che influiscono sui tessuti muscolare e nervoso possono interferire con gli eventi biochimici che rendono non tossiche le sostanze che entrano nell'organismo? Non conosco
le risposte a queste domande, ma ho vedute molto larghe
sull'argomento. La maggior parte della gente con sindrome
da fatica cronica non ha una sensibilità estrema alle sostanze, ma coloro che l'hanno sono ancora più disabili dei pazienti nei quali predominano la fatica e le alterazioni della
funzione mentale. Un numero molto maggiore di ricerche è
necessario prima di poter dire se si tratta di una malattia distinta o se fa parte dello spettro della sindrome da fatica
cronica.
In sintesi, molti individui in tutto il mondo, forse addirittura l'1 o l'1,5 per cento della popolazione mondiale, soffre
di una sindrome la cui caratteristica costante è una fatica
muscolare straordinaria, quasi indescrivibile, che rende difficoltoso anche il più piccolo esercizio fisico. Questa sindrome comporta anche disturbi neurologici, che sfociano, il
più delle volte, in mali di testa, stati confusionali, incapacità di concentrazione, disturbi alla memoria e labilità emotiva.
Se una tale sintomatologia compare in forma epidemica
in una comunità, è estremamente probabile che un virus
non ancora conosciuto ne sia il responsabile e molti individui che si imbatteranno in esso, certamente non tutti, ne saranno colpiti. Una variante meno grave del virus può produrre una forma endemica della malattia, che seleziona individui geneticamente predisposti in quanto portatori di un
deficit nella capacità del loro sistema immunitario di affrontare quel particolare virus. In alternativa, questa sindrome può essere innescata stimolando un sistema immuni330
tario alterato. Se questo è il caso, molti agenti non infettivi
e microrganismi diversi dai virus possono esserne responsabili. I virus o le loro singole parti possono modificare la
funzione delle cellule nei muscoli e nel sistema nervoso sia
direttamente sia indirettamente.
Dati recenti hanno confermato la natura organica della
malattia. Questa è associata a un'alterazione del sistema
immunitario e la possibilità che molti pazienti, forse la
maggior parte, siano aiutati dalla immunoterapia è stimolante. Una previsione più che ragionevole ci fa ritenere che i
misteriosi meccanismi responsabili di questa malattia saranno rivelati alla scienza medica nel prossimo futuro.
Nel frattempo, è essenziale che siano diffuse queste nuove nozioni nella comunità medica e anche all'uomo della
strada, dimodoché migliaia di sofferenti di sindrome da fatica cronica ricevano simpatia e incoraggiamento in misura
appropriata, anzi addirittura la speranza, che potrà rendere
la loro sofferenza più sopportabile, mentre noi ci avviciniamo sempre più alla cura definitiva di questa patologia disabilitante.
331
Parte V
L'ASSISTENZA AI LOTTATORI
10
Alcune armi nelle mani dell'immunologo
Attorno agli alloggi per i visitatori, all'università dove lavoravo a Dakar, nel Senegal, c'era uno dei più poveri sobborghi di una città già di per sé povera. Settecentocinquantamila persone vivevano in baracche di latta e in capanne di fango. Non c'erano fognature e acqua corrente per abitazioni
individuali. Di tanto in tanto, agli incroci di strade non pavimentate, vi erano pompe d'acqua, dalle quali il prezioso
liquido veniva raccolto e trasportato nelle abitazioni in ogni
genere di recipiente.
Un pomeriggio, passeggiavo per una di queste strade, in
mezzo alla quale stavano giocando forse dodici-quindici
bambini dell'età di circa dieci anni. Appassionati di calcio,
si divertivano correndo, con un entusiasmo senza limiti,
dietro una palla frusta, che rimbalzava con bizzarre angolature dai solchi nella strada. Non c'era alcun pericolo di essere investiti: le capre nella strada erano certamente meno
pericolose delle automobili. Una scena chiassosa, piena di
allegria... e di polvere!
Quando mi avvicinai a quei ragazzi, uno di una decina
d'anni, di nome Ibrahima, lanciò la palla agli amici e corse
verso una fontanella all'angolo della strada. Con una mano
pompava l'acqua nell'altra mano e sorseggiava quel liquido
per nulla sterile, spruzzandosene anche sul viso accaldato e
impolverato. Mentre si chinava per godere meglio di quel
refrigerio, un cane, sbucato da non si sa dove, si lanciò alle
sue spalle e lo morse sul collo senza essere stato provocato.
335
In conseguenza del morso, si formò una ferita dalla quale
sgorgò subito sangue.
Naturalmente, il fanciullo cominciò a urlare. I suoi compagni di gioco, testimoni del fatto, prima ammutolirono
esterrefatti per alcuni secondi, poi cominciarono a loro volta a strillare ad alta voce mentre si allontanavano correndo
in varie direzioni: chiaramente desideravano allontanarsi da
quel cane il più rapidamente possibile. Ibrahima, come pietrificato, si fece animo e corse fra le braccia del padre, che
era sopraggiunto con altri adulti richiamato da tanto trambusto.
Seguì un grande vociare da parte degli adulti, mentre il
padre scompariva nella sua baracca, per riuscirne alcuni secondi dopo con un asciugamano in una mano e un grosso
coltello nell'altra. Con l'asciugamano avvolto attorno alla
mano e all'avambraccio sinistro, si avvicinò al cane responsabile dell'attacco.
Il cane era naturalmente randagio, uno delle migliaia di
animali emaciati e dall'aspetto veramente compassionevole,
che vagano per le strade polverose di questi paesi. Il suo
corpo era ricoperto da un pelo sporco, color marrone, ma
numerose zone, specialmente sul dorso, erano glabre e ulcerate. Una vista penosa. Dopo aver attaccato il bambino,
non si era mosso. Stava fermo, con la testa in giù, guardando lentamente da sinistra a destra, come se non riuscisse a
decidersi a prendere quelle poche gocce d'acqua che ancora
cadevano dalla pompa.
Sollecitato dalla folla, il padre di Ibrahima si avvicinò
lentamente a quell'animale sventurato. Ricordo di aver
pensato che le intenzioni vendicative di quell'uomo erano
un po' eccessive. Non conoscevo molto gli africani allora:
se no mi sarei reso conto che un simile intendimento non sarebbe stato in sintonia col loro carattere. Non mi passò mai
per la testa che quel padre avesse perso la speranza di salvare la vita del figlio.
Quando l'uomo si precipitò su di lui, il cane non fece alcun tentativo di spostarsi: sembrava in trance. Il grosso
336
braccio nero, parzialmente protetto dall'asciugamano, gli
circondò il collo e, in un secondo, la gola venne tagliata
dal grosso coltello. Il sangue sprizzò davanti all'animale
sulla strada polverosa, mentre il padre del ragazzo si posizionava con le gambe divaricate sopra il dorso dell'animale. Il cane morì all'istante, ma dinnanzi ai miei occhi inorriditi e perplessi l'uomo continuava a tagliare la gola. In
pochi secondi staccò la testa. Poi la avvolse rapidamente
nell'asciugamano che gli aveva protetto il braccio, mentre
lasciò la carcassa nella cunetta a lato della strada, perché
un milione di mosche in agguato potesse subito prenderla
d'assalto.
Mentre il dramma si svolgeva, la strada risuonava di urla di paura, di consigli e di congratulazioni. Qualcuno, forse la madre, stava lavando il collo di Ibrahima con un pezzo - apparentemente - di sapone. Fu a questo punto che ci
si accorse di me. Il padre, che naturalmente non mi conosceva e tanto meno sapeva che fossi un medico, si precipitò
verso di me e si spiegò: «Monsieur, monsieur! Je pense que
le chien rage! Avez-vous une voiture? Il me faut porter la
téte à l'hópital».
Improvvisamente tutto fu chiaro. Il padre era convinto
che il cane fosse rabbioso, cosa del resto molto comune in
questa parte del mondo. Alla popolazione locale era stato
insegnato che gli animali che mordono devono essere uccisi
e la loro testa trasportata immédiatement all'ospedale per
esaminarne il cervello. Impaziente di dare aiuto e sedotto
da quanto era successo, portai il padre e alcuni altri uomini che lo confortavano all'ospedale, con la testa del cane
sempre avvolta nell'asciugamano ormai zuppo di sangue.
Cosa abbastanza strana, Ibrahima fu lasciato a casa con la
madre.
All'ospedale la testa fu presa in consegna assieme a
un'annotazione sui particolari dell'incidente. Al padre venne comunicato di tornare dopo due giorni per avere i risultati degli esami patologici. Borbottando che sapeva benissimo che i risultati avrebbero confermato il fatto che quel
337
cane sciagurato aveva la rabbia, si diresse verso casa, mentre chiedevo io stesso istruzioni all'ospedale.
La rabbia è una delle infezioni più letali, ma vi sono misure che si possono adottare per aiutare le persone che sono
a rischio di rimanere infettate dal morso di un animale. Il
problema è che la cura stessa della malattia presenta un certo rischio: pertanto occorre essere sicuri della diagnosi prima di iniziare la terapia.
Un milione di americani viene morsicato ogni anno da
animali. Ma questo problema è comune a tutto il mondo.
Dopo essere stato morsicato, ciascuno deve considerare se
la terapia anti-rabbia è giustificata. Della diffusione della
malattia possono essere responsabili gli skunk, i lupi, i procioni, le manguste e i pipistrelli. Nelle zone più povere del
mondo, però, i maggiori responsabili sono i cani randagi.
La rabbia è provocata da un minuscolo virus presente
nella saliva degli animali infetti. Una volta giunto sotto la
cute, per esempio, di qualcuno che sia stato morsicato, si
scava un passaggio nei nervi della cute stessa e, quindi,
marcia letteralmente lungo di essi fino a raggiungere, attraverso il midollo spinale, il cervello, dove provoca terribili
danni. Per raggiungere il cervello può impiegare dodici
giorni o dodici mesi: di conseguenza, il quadro clinico che
segue l'infezione varia in maniera considerevole.
La rabbia è letale: si ha notizia di tre uomini soltanto, che
sono riusciti a sopravvivere a un'indubbia infezione del cervello. La paralisi dei muscoli necessari alla deglutizione,
sintomo caratteristico dell'infezione, fa accumulare la saliva nella bocca e alla fine la fa fuoriuscire: da qui l'espressione «con la bava alla bocca». Mentre si hanno solo cinque
decessi l'anno per rabbia negli Stati Uniti, vi sono probabilmente quindicimila o più casi mortali di rabbia all'anno su
scala mondiale.
Nei paesi in cui la rabbia pone dei problemi, tutti i cani
domestici dovrebbero essere vaccinati contro il virus, dato
che questa norma riduce moltissimo i rischi per gli esseri
umani. I cani hanno più probabilità degli esseri umani di
338
vagare senza protezione nei boschi e di essere morsicati dagli animali selvatici. Ogni anno, migliaia di persone, orgogliose del loro cane, lo fanno vaccinare contro la rabbia e,
se queste persone fossero analogamente protette contro altre calamità, per esempio contro il cimurro, ben poche tra
loro potrebbero fare a meno di pensare agli straordinari
benefici che i vaccini hanno apportato all'umanità e al
mondo animale.
Perché non prepariamo vaccini contro tutte le malattie
infettive che affliggono l'umanità? Perché non è facile ottenere gli agenti infettivi in una forma adatta a essere presentati al sistema immunitario. Molti virus vengono coltivati con difficoltà in laboratorio e in quantità non sufficienti a produrre vaccini commerciabili. In effetti, molti virus si sono sottratti a tutti i nostri tentativi di ucciderli: tuttavia, opportunamente trattati, possono conservare la capacità di stimolare efficacemente il nostro sistema immunitario.
Si prenda come esempio la rabbia. Il virus responsabile
di questa malattia è difficile da coltivare: fino a non molto
tempo fa poteva esserlo soltanto in embrioni d'anatra. Il
virus coltivato in massa in questo modo viene quindi inattivato chimicamente. Si tratta, però, di una reazione delicata
e vi è ancora un lieve rischio che, a seguito della vaccinazione, si sviluppi una grave malattia neurologica. Un tempo la frequenza di questa complicanza era, di solito, di un
caso ogni seimila vaccinazioni. Oggi essa è dell'ordine di
un caso ogni centomila vaccinazioni, usando vaccino coltivato in embrioni d'anatra. Un vaccino ancor più recente,
prodotto con un virus coltivato in cellule umane anormali,
è ancora meno rischioso e sembra pronto a sostituire quello preparato con embrioni d'anatra. Invece, dolore nel
punto di inoculazione, febbre e nausea continuano ad essere problemi associati con il vaccino. Per una protezione
adeguata sono necessarie molteplici iniezioni. Il vaccino da
embrioni d'anatra, l'unico disponibile in Africa, non dà
l'un per cento di protezione, mentre sembra che il vaccino
339
più recente sia più efficace: finora, infatti, non sono stati
riportati insuccessi.
Tornando al povero Ibrahima, egli aspettava i risultati
dei test sul cervello del suo assalitore, curandosi il collo dolorante e odiando i cani.
All'ospedale, il patologo chiamò un collega dell'Istituto
Pasteur, istituto di ricerca e di produzione dei vaccini, con
sede a Parigi, ma con succursali in molti paesi del Terzo
Mondo. L'Istituto aveva l'attrezzatura necessaria per il
test.
Un pezzo del cervello del cane fu subito rimosso e rapidamente surgelato. Mentre si trovava in questo stato fu tagliata, con una lama estremamente sottile, una sezione dello
spessore di un'ostia, poi deposta su un vetrino portaoggetto. Il vetrino fu rivestito con un preparato che conteneva
l'anticorpo contro il virus della rabbia. Se il virus era presente, l'anticorpo l'avrebbe trovato. L'anticorpo era stato
marcato con un colorante fluorescente, che emette una luce
di colore verde brillante quando viene stimolato da radiazioni ultraviolette. La comparsa di zone verdi nel cervello
significa presenza del virus. Il tessuto cerebrale del cane
aveva infatti un bel colore verde brillante, tanto era zeppo
di virus.
Ibrahima fu condotto all'ospedale ed esaminato. Aveva
la febbre e il collo dolorante, ma per il resto sembrava a posto. Nella zona della ferita gli venne praticata un'iniezione
di siero contenente gli anticorpi contro il virus della rabbia.
Il Centre for Diseases Control, negli Stati Uniti, raccoglie
da tempo sangue da volontari che si sono fatti immunizzare
contro la rabbia. Questo sangue, naturalmente, contiene
elevati livelli di anticorpi contro il virus. Il siero che se ne ricava viene confezionato come gammaglobulina antirabbia
iperimmune e spedito in tutto il mondo. È, tuttavia, disponibile solo in piccole quantità e, quindi, prezioso. Non deve
certo essere usato se la diagnosi non è chiara.
Il preparato dà una forma di protezione istantanea: è come un regalo da una persona a un'altra. In aggiunta agli an340
ticorpi, a Ibrahima fu praticata un'iniezione di vaccino anti-rabbia. Una grande quantità di virus uccisi avrebbe rapidamente stimolato i suoi linfociti T e B a dare una risposta
vigorosa all'agente che, quasi certamente, era stato introdotto nel suo organismo dal morso del cane rabbioso.
La conclusione di questa storia è lieta, dato che Ibrahima
non si ammalò di rabbia e un giorno, grazie all'immunologia moderna, potrebbe diventare un grande campione di
calcio.
La protezione passiva
Dobbiamo esaminare un poco più a fondo il concetto di
protezione passiva, in contrapposizione alla protezione attiva indotta dalla immunizzazione.
Nel 1668, Sir Christopher Wren, impegnatissimo nella ricostruzione di Londra dopo il grande incendio, fu contattato per progettare un ago che potesse essere utilizzato in
esperimenti mirati a determinare la fattibilità o altri aspetti
del trasferimento di sangue da un animale all'altro. Progettò subito l'ago ipodermico, che è ancora in uso oggi.
Samuel Pepys riferisce nei suoi diari che una dimostrazione dell'ago ebbe luogo con successo nella casa di un medico
di Londra: venne fatto passare del sangue da un animale all'altro. (Presumibilmente l'animale in cui era stato trasfuso
il sangue non morì, non essendovi in proposito alcuna menzione, ma se non morì fu davvero fortunato, perché il sangue che aveva ricevuto doveva essere quasi certamente incompatibile con il suo.) Uno dei medici presenti alla dimostrazione, così ci racconta Pepys, disse alla folla riunita:
«Penso che questo sia l'inizio di una nuova era che vedrà il
sangue cattivo migliorato da altro sangue preso da un corpo
migliore».
Così nacque in medicina il concetto di protezione passiva, una forma di protezione da lungo tempo in uso in Natura. Gli anticorpi materni attraversano la placenta per accumularsi nel corpo del feto, difendendolo così da germi peri341
colosi con cui la madre è entrata in contatto durante la gravidanza. È questo un dono per fare superare ai bambini il
periodo in cui non producono essi stessi anticorpi. A partire
dall'ultimo decennio del secolo scorso, tale forma di protezione passiva è stata sfruttata dalla medicina.
All'inizio veniva utilizzato siero di cavallo. Questi animali venivano immunizzati con agenti che erano pericolosi per
gli esseri umani, come il batterio della difterite, e quindi,
dopo che avevano avuto tempo a sufficienza per produrre
una grande quantità di anticorpi, veniva prelevato loro il
siero, che era somministrato a pazienti a rischio nei riguardi
dell'infezione. La difterite, a quell'epoca, era una delle malattie più letali. In questo modo i pazienti erano definitivamente protetti, ma, come si può ben immaginare, la somministrazione di siero di cavallo agli esseri umani provoca tutta una serie di problemi. Il nostro sistema immunitario reagisce alla «estraneità» che riconosciamo in queste proteine
equine.
Oggi si utilizza siero umano prelevato da soggetti che o
sono guariti da una particolare infezione o sono stati immunizzati contro un particolare agente infettivo. Il siero immune di questo tipo serve a proteggerci dal tetano, dall'epatite B, dalla rabbia, dalla parotite, dalla pertosse e dalla varicella. Può sorprendervi sapere che utilizziamo ancora
qualche siero contenente anticorpi potenti, ottenuti da animali immunizzati. Gli animali ci forniscono gli anticorpi
contro il batterio della difterite, contro quei microrganismi
che provocano il botulismo, una intossicazione alimentare
letale, contro il veleno di un ragno, la vedova nera, e contro
i veleni di certi serpenti e scorpioni.
Un'altra forma di protezione passiva è necessaria per
quei pazienti che non riescono affatto a produrre anticorpi.
Viene raccolto sangue da 3000-20.000 donatori sani e poi da
esso si estrae il siero, che viene quindi concentrato in una
forma contenente immunoglobulina G quasi pura. Questa
viene somministrata per via endovenosa ai pazienti che ne
hanno bisogno. Fleboclisi mensili di questo dono «da un
342
corpo migliore», per tutto il corso dell'esistenza, permettono loro di condurre una vita pressoché normale.
La protezione attiva
Negli Stati Uniti, la maggior parte dei bambini riceve i massimi benefici dai migliori vaccini perché vigono leggi che
impediscono di essere iscritti a scuola se non si è stati vaccinati, e ciò anche per non essere fonte di infezione per i compagni. In molti paesi occidentali, dove questi vaccini sono
disponibili, triste a dirsi, l'immunizzazione non è obbligatoria. Questi paesi continuano ad avere bambini, e poi adulti,
che soffrono dei gravi effetti delle malattie infettive comuni.
In tutti i bambini, all'età di due mesi, dovrebbe essere avviata una difesa assistita del loro «sé», iniettando un vaccino polivalente, contenente gli antigeni della difterite, della
pertosse e del tetano (vaccino DPT). Inoltre, si dovrebbe
somministrare per bocca una piccola dose di vaccino antipolio. Dosi di richiamo degli stessi antigeni dovrebbero essere date a quattro e a sei mesi. A questo punto la protezione contro le quattro malattie sarà completa.
Un'altra combinazione di antigeni contenente i virus del
morbillo, della parotite e della rosolia dovrebbe essere somministrata a quindici mesi. Se la vaccinazione riesce bene, la
protezione da queste malattie dura tutta la vita. A diciotto
mesi, io raccomando un'ulteriore dose di richiamo del vaccino DPT e di quello anti-polio: quindi, a sette anni di età,
il richiamo finale. Dosi di richiamo del vaccino antitetanico
dovrebbero essere inoculate, invece, ogni dieci anni per tutta la vita.
La difterite è un'infezione causata da Corynebacterium
diphtheriae. Questi batteri penetrano nella parte posteriore
della gola e vi producono una tossina, molto tossica per i
nervi. Dalla gola la tossina può diffondersi rapidamente nel
corpo. Una cosa abbastanza interessante da sapere è che i
batteri della difterite si comportano in questo modo perché
343
sono infettati da un virus che li costringe a fare così. Pertanto, con la difterite, si è colpiti in realtà da due infezioni
alla volta. Individui di ogni età, se non sono protetti, una
volta infettati, muoiono; negli Stati Uniti si contano circa
trenta decessi l'anno. In generale, questi decessi avvengono
in comunità isolate, sfuggite all'attenzione degli immunologi.
Il tetano, in cui la morte è provocata da uno spasmo doloroso e quindi da paralisi dei muscoli, è causato dalla liberazione di una neurotossina da parte del Clostridium tetani,
organismo ubiquitario che vive nel suolo dovunque e, comunemente, negli escreti animali. Clostridium rimane quiescente nel suolo sotto forma di spore, che sono attivate
quando penetrano in una ferita. In molti paesi del Terzo
Mondo vi è ancora una poco propizia abitudine di porre
una piccola quantità di sterco di vacca attorno al moncherino del cordone ombelicale tagliato del neonato. Di conseguenza, molti neonati muoiono di tetano. In un anno qualsiasi si calcola che, negli Stati Uniti, vi siano fino a 300 casi
di tetano: di questi pazienti circa il 70 per cento muore.
Nessuna regione viene risparmiata.
Anche la pertosse può uccidere, ed effettivamente uccide,
i bambini in tenera età. Fino a un'epoca recente, negli Stati
Uniti, si registravano annualmente 10.000 casi. Con un'immunizzazione adeguata, nessun bambino dovrebbe morire
di questa malattia. Gravi complicanze e il decesso seguono,
di solito, all'infezione del cervello e dei polmoni. Poiché la
malattia esige un tributo molto pesante dai giovanissimi,
l'immunizzazione dovrebbe cominciare non appena è possibile. Le recenti epidemie tra gli adulti in Inghilterra e in Australia dimostrano chiaramente che, quando l'immunizzazione non è obbligatoria, l'agente infettivo sopravviverà
nella comunità e infetterà gli adulti immunizzati da bambini, ma la cui immunità sta ora svanendo. Per questa ragione, nei suddetti paesi, gli adulti vengono consigliati saggiamente di farsi inoculare una piccola dose di richiamo del
vaccino. D'altra parte, nei paesi in cui l'intera comunità è
344
immunizzata contro la pertosse, sopravvive una quantità
così piccola degli agenti infettanti che persino la persona eccentrica che non si è voluta lasciare vaccinare è protetta.
Oggi la paralisi infantile (poliomielite) è rara nei paesi in
cui il vaccino è liberamente disponibile. Nei paesi sottosviluppati, rimane invece una terribile sciagura. Per convincersi quanto il vaccino contro di essa sia efficace, basta ricordare che, negli anni Cinquanta, negli Stati Uniti, si avevano
annualmente 15.000 casi. Oggi, ogni anno si registrano meno di trenta casi. È vieppiù una tragedia e una vergogna
l'abbandono da parte del mondo occidentale dei paesi del
Terzo Mondo in cui migliaia di bambini sono ancora colpiti
e storpiati da questo virus. E questo perché? Semplicemente
perché i paesi sottosviluppati non hanno la disponibilità finanziaria per acquistare il vaccino.
Nel 1962, negli Stati Uniti, c'erano almeno 500.000 casi
di morbillo. Nel 1972, il numero era sceso a meno di
40.000. Nel 1974, la vaccinazione contro il morbillo si allentò, meno del 60 per cento dei bambini fu immunizzato e,
come conseguenza, un'importante epidemia esplose nel
1977. Il morbillo può essere fatale. Dal 5 al 15 per cento
delle vittime è colpito da infezioni batteriche secondarie e
un caso su mille subisce un'infezione del cervello, potenzialmente fatale. Il morbillo non dovrebbe essere preso alla leggera: nei paesi sottosviluppati rimane una delle principali
cause di decesso dei bambini al disotto dei tre anni.
La parotite (orecchioni) è causata da un virus che si moltiplica nei tessuti ghiandolari. Di solito è un'infezione lieve,
ma le complicanze sono abbastanza frequenti, tanto da rendere consigliabile la vaccinazione. Si tratta, inoltre, di un rischio grave per i maschi che hanno raggiunto la pubertà. Il
20 per cento viene colpito da un'infezione virale ai testicoli,
che può condurre alla sterilità. Infezioni del genere possono
dunque determinare complicanze dolorose e invalidanti. La
parotite è anche responsabile di meningite e di infiammazione del cervello (encefalite): il suo virus viene sospettato
di essere una possibile causa di diabete.
345
La rosolia è una malattia non grave, che colpisce i bambini e i giovani adulti. Non meriterebbe molta attenzione se
non fosse per il fatto che, durante la gravidanza, si associa
a un rischio molto elevato di far nascere un bambino anormale. Solo se tutti gli individui di una comunità sono immunizzati, la quantità dei virus in circolazione può essere
contenuta e la tragedia della rosolia congenita eliminata.
Negli Stati Uniti, dopo che nel 1964, in conseguenza di una
infezione congenita di rosolia, erano nate migliaia di bambini ciechi, sordi, affetti da ritardo mentale e/o da deficienza immunitaria, venne prodotto un vaccino. Il virus contenuto in questo vaccino, benché non pericoloso per i bambini e gli adulti, lo è per il feto e pertanto le donne in gravidanza non possono essere vaccinate.
In risposta alla domanda: «Signore, che cosa devo fare
per avere un sistema immunitario perfetto?» la risposta deve essere: «In primo luogo, scegliti i genitori con molta attenzione». Un consiglio, forse, non molto pratico, ma nondimeno vero. Se discendete da genitori che provengono da
famiglie con almeno tre generazioni di ottuagenari in cui
non si è mai manifestata alcuna allergia, né malattia autoimmune (specialmente diabete e artrite reumatoide), nessun cancro allora, se vi sono capitati genitori come questi,
amministrate con parsimonia i vostri beni, perché siete destinati a vivere a lungo.
Se non avete genitori come questi, non disperate. Si può
fare molto e le vostre imperfezioni genetiche fondamentali
possono essere riparate. Viviamo in un'epoca in cui l'ingegneria genetica, già così utile per esaminare i difetti di base
nelle malattie e per fare produrre a batteri quantità illimitate di insulina e di altre sostanze, verrà presto utilizzata in terapia. Nei cromosomi è possibile saldare informazioni genetiche diverse, aggiungendo un nuovo programma al repertorio genetico già presente, oppure correggendo un programma difettoso. Se si riescono a inserire in un cromosoma batterico le istruzioni per produrre insulina umana, saremo presto in grado di inserire nelle cellule del midollo os346
seo di bambini che producono un'emoglobina anormale i
geni che diranno a quelle cellule di produrre emoglobina
normale. Se ci sarà una nuova edizione di questo libro, l'ingegneria genetica avrà bisogno indubbiamente di un gran
numero di pagine. Per il momento, tuttavia, ci limitiamo a
questo e rivolgiamo la nostra attenzione a strategie che siano già disponibili.
Qual è il modo migliore di allungare la durata della vita,
in condizioni di buona salute, a ratti in gabbia? La risposta
è di privarli di una parte delle calorie che vorrebbero consumare, cioè di farli rimanere in uno stato di moderato digiuno. La durata della vita nei ratti può aumentare dal 30 al 60
per cento se si limita l'assunzione di calorie fin dalla nascita. Lo stesso vale per i topi, i quali, con questo regime, sembrano avere quattro mesi, mentre in realtà ne hanno sedici.
Dato che i topi vivono solo due anni, si può valutare il significato di questa osservazione.
Oltre a vivere più a lungo, gli animali degli esperimenti
appena descritti sono risultati più resistenti alle infezioni e
al cancro. L'involuzione del timo, questo sipario innato che
cala sul dramma immunitario, è molto ritardata nei soggetti
ipoalimentati. Perché ciò accade?
Mentre ammettiamo di non avere tutte le risposte a questo enigma, sono comunque emersi alcuni fatti interessanti.
I ratti non si superalimentano come fanno gli esseri umani e
i ratti obesi sono altrettanto rari dei serpenti obesi. (Vi sono
razze di polli che diventano obese e vi è un dato abbastanza
interessante: sono affette da una malattia immunologica
che colpisce la ghiandola tiroidea.) Gli animali mangiano in
modo giusto. Limitando le calorie ai ratti, essi si mantengono magri, naturalmente, ma ciò fa anche diminuire alcune
delle attività immunoregolatrici dei linfociti T. Pertanto,
questi ratti reagiscono in modo più vigoroso all'infezione e
via dicendo. Non è certo quali effetti dannosi possano essere associati a una simile «terapia», in quanto non possiamo
misurare molto bene il benessere dei ratti: certamente non si
verificano anomalie grossolane.
347
Mentre la maggior parte dei nutrizionisti pensa che l'uomo occidentale, se non altri, segua un comportamento alimentare poco bilanciato, contenente di gran lunga troppi
grassi, basta guardarsi attorno per vedere che, a parte la
dieta scarsamente bilanciata, mangiamo troppo; non è, infatti, difficile trovare persone obese. Sono stati compiuti
studi sul sistema immunitario degli obesi e ne è emerso che
la capacità dei neutrofili di fagocitare e uccidere i batteri risulta ridotta. Il potere citotossico dei linfociti T appare leso. Frequentemente si verificano carenze di zinco e di magnesio, due elementi essenziali per una normale prestazione
immunitaria. Gli obesi soffrono di un maggior numero di
infezioni, che tendono ad essere più gravi.
Vivremmo più a lungo e in modo più sano se fossimo tenuti a una dieta minima come i ratti? Probabilmente sì, ma
esperimenti controllati con esseri umani per stabilirlo risultano, come potete bene immaginare, difficili da organizzare.
D'altra parte, la disumanità del genere umano ci assicura
un abbondante materiale clinico da cui ricavare gli effetti di
una inedia reale sulla risposta immunitaria. È una situazione drammatica. Nei paesi del Terzo Mondo, la denutrizione, specialmente la mancanza di calorie e di un buon apporto proteico, fanno sì che il sistema immunitario in un primo
tempo funzioni nella norma per poi perdere drasticamente
le proprie funzioni al persistere dell'inedia.
Dapprima va perduta la capacità degli anticorpi e, con
questo, le difese contro i batteri si sgretolano. La gastroenterite diventa un modo di vita, il pus cola dagli occhi e dalla
pelle infettati. I linfociti T resistono un poco più a lungo,
quindi anch'essi vengono meno. Tutta la potenza di queste
difese magiche alla lunga svanisce. Tanto per aumentare la
tragedia, il cibo, quando e se arriva, non corregge i danni
istantaneamente; ben lungi da questo. Possono essere necessari mesi o addirittura anni per far ritornare alla norma
il funzionamento dei linfociti T.
In individui privi di cibo e quindi anche di sostegno immunologico, i parassiti che infestano il Terzo Mondo pren348
dono il sopravvento e la sofferenza umana che ne deriva è
indescrivibile.
Nell'epoca in cui viviamo, le immagini televisive mostrano in modo corretto, ma non perfetto, l'orrore degli ultimi
stadi di chi muore di fame: possiamo vedere la sofferenza e
udire i singhiozzi dei moribondi ma non possiamo sentirne
l'odore, né captarne i sentimenti. L'odore è un ben definito
odore di morte: morte compiuta e morte incombente.
I sentimenti sono di assoluta disperazione: negli occhi degli adulti e dei bambini non c'è neppure un tenue barlume
di speranza. Mani esauste non riescono neppure a scacciare
le mosche dal proprio corpo. Menti annebbiate dalla debolezza fisica non riescono più a fare attenzione a un altro
gruppo di medici dall'aspetto vigoroso che si muovono in
mezzo a loro senza un aiuto reale tra le mani.
Ho fatto la terribile esperienza di visitare in Africa alcune
tribù che si stavano estinguendo per fame. Avevo medicine
e vaccini da dispensare, ma non cibo: un inutile esercizio
nella frustrazione. Ciò che è chiaro a coloro che hanno l'occasione di lavorare in queste aree è che il mondo non può
permettersi di avere milioni di individui cronicamente denutriti e oppressi dalle malattie. Lasciando da parte, per il momento, la pietà umana, la perdita di produttività, la conseguente distruzione di suolo potenzialmente arabile e la diffusione delle malattie costeranno caro a tutti noi. È in grandissima misura nel nostro interesse chiudere il ciclo della
povertà e delle malattie che colpiscono così tanti nostri fratelli e sorelle.
Carenze vitaminiche specifiche compromettono in modo
significativo la prestazione del sistema immunitario. I pazienti con una carenza di vitamina A trovano difficoltà a
produrre l'immunoglobulina A. La capacità di legame dei
loro anticorpi è ridotta. Spesso si riscontra un numero ridotto di linfociti circolanti. Con una carenza di vitamina C,
la sintesi proteica è menomata e tutte le cellule del sistema
immunitario danno prestazioni insufficienti. Inoltre, si riduce in misura significativa il potere di cicatrizzazione delle
349
lesioni. Individui che soffrono di una carenza di vitamina B
nella dieta non possono avere buone reazioni di ipersensibilità ritardata. Non possono rigettare normalmente trapianti
di tessuti. Questa carenza, naturalmente, è un problema comune anche agli alcolisti della nostra società.
Altre carenze che deprimono in modo significativo le nostre difese immunologiche conseguono a una mancanza di
ferro, di zinco, di acido folico, di riboflavina, di niacina e
di magnesio. Le ultime tre sostanze sono molto importanti
per la normale produzione di anticorpi. Mi si lasci, tuttavia,
sottolineare fino alla noia che non vi è alcuna prova che
l'assunzione di quantità molto elevate di una qualsiasi di
queste sostanze essenziali dal punto di vista nutrizionale migliori la prestazione del sistema immunitario.
Se qualche parte del vostro corpo diventa rossa, calda, rigonfia e dolorante, si dice che essa è infiammata e il processo che ne è responsabile è l'infiammazione. Esso colpisce i
tessuti, le articolazioni e, in verità, ogni parte dell'organismo. Consegue alla liberazione di sostanze chimiche che dilatano i vasi sanguigni in una particolare zona del corpo. Il
suo scopo è permettere ad anticorpi e a cellule del sistema
immunitario di giungere nel punto infettato. Se questo è il
prezzo che dobbiamo pagare per superare un'infezione potenzialmente grave, ebbene lo sia, ma se il processo infiammatorio dovesse risultare inutile, se non addirittura dannoso (come capita in una malattia autoimmune), allora noi
medici dovremmo cercare di sopprimerlo. I farmaci antinfiammatori più potenti che possediamo sono gli steroidi e di
questi i più efficaci sono i corticosteroidi. Conoscerete probabilmente tutti l'idrocortisone e il prednisone.
I corticosteroidi vengono prodotti nella corticale (cioè
nello strato esterno) delle minuscole ghiandole surrenali, situate alla sommità dei reni. Si tratta di sostanze indispensabili: senza di esse moriremmo. Sono uno dei principali catalizzatori dell'organismo, attivando numerosi processi, dalla
sintesi proteica alla pigmentazione della cute. In sostanza,
mettono in pratica le intenzioni di una cellula e, così facen350
do, possono promuovere nell'organismo alcuni avvenimenti e sopprimerne altri. Ogni mattina il nostro cervello secerne una sostanza che ordina alle ghiandole surrenali di produrre quantità adeguate di questi ormoni preziosi.
Come probabilmente sapete, la somministrazione di forti
quantitativi di idrocortisone a pazienti può indurre una miracolosa scomparsa dei malanni causati dall'infiammazione. Sfortunatamente, però, se queste forti dosi vengono
somministrate per lungo tempo producono innumerevoli
effetti collaterali. Gli steroidi interagiscono con troppi processi del nostro organismo e, di conseguenza, gli effetti della loro somministrazione sono numerosi e importanti. Se
vengono utilizzati consapevolmente e, pertanto, in modo
appropriato, sono strumenti meravigliosi per ridurre la sofferenza: possono tenere sotto controllo l'asma, contribuire
a curare la leucemia e, cosa più importante di tutti, possono
bloccare l'infiammazione.
Alcuni medici usano irresponsabilmente questi potenti
farmaci. In Italia vi sono dottori che li somministrano ai
propri pazienti per nulla più che un'influenza e ciò è sbagliato, dato che gli steroidi possono, di fatto, ridurre la capacità di lotta dell'organismo contro il virus. Dall'altro lato, vi sono medici che si rifiutano semplicemente di usarli,
ritenendo gli effetti collaterali troppo pesanti. Entrambi
questi atteggiamenti sono errati. Se la malattia è più pericolosa e dolorosa degli effetti collaterali prodotti dai farmaci,
il giuoco vale la candela. In realtà, molti pazienti possono
condurre una vita sopportabile, se non addirittura piacevole, con dosi di corticosteroidi che producono solo effetti
collaterali minimi.
Gli steroidi in piccole dosi bloccano due azioni di altre
sostanze liberate dai neutrofili (cellule che fagocitano gli
agenti infettivi), dalle mastcellule e dai basofili, che producono l'istamina e altre sostanze vasodilatatrici. In dosi molto elevate possono essere immunosoppressori, nel senso che
danneggiano, o addirittura uccidono, i linfociti.
I principali effetti collaterali possono essere un arresto
351
della crescita, un ingrassamento, soprattutto a livello delle
guance, delle braccia e della parte alta della schiena, un indebolimento delle ossa causato da decalcificazione indotta,
una facilità nella formazione di ecchimosi, una variabilità
dell'umore, un aumento di appetito, comparsa di ulcere e di
cataratte, una pressione sanguigna superiore alla norma,
una maggiore crescita di peli sulla cute. Inoltre, quando si
assumono i corticosteroidi, l'attività delle ghiandole surrenali rallenta, in quanto non è necessario che queste ghiandole producano gli ormoni. Di conseguenza, può essere pericoloso interrompere la somministrazione di un corticosteroide dopo un lungo periodo di terapia; è raccomandabile
una riduzione lenta delle dosi.
Gli steroidi a dosi elevate possono influire sui linfociti,
cioè su quelle cellule del sistema immunitario che riconoscono l'antigene: malgrado questo, raramente li utilizziamo a
tale scopo. Quando è necessario sopprimere la funzione dei
linfociti (non è mai una bella cosa), abbiamo a disposizione
farmaci che sono in grado di svolgere esclusivamente questo
compito. Dei tre farmaci più comunemente usati, due, la ciclofosfammide e l'azatioprina, sono presi in prestito dagli
oncologi, che li utilizzano per bloccare la crescita dei tumori. Il terzo farmaco, e il più interessante, la ciclosporina A,
ha proprietà uniche.
Prima di trattare di questi farmaci, prendiamo in considerazione situazioni in cui sarebbe necessario paralizzare la
prestazione dei linfociti. La situazione più semplice con cui
cimentarsi riguarda il trapianto di organi.
Un uomo che ha in petto il cuore di un altro individuo
non può permettersi il lusso di rigettarlo. Pertanto deve essere immunodepresso, malgrado i rischi associati a una repressione non specifica delle prestazioni dei linfociti. Se
non può rigettare il cuore che gli è stato donato, non potrà
normalmente essere in grado di respingere l'attacco di quelle infezioni che potrebbero colpirlo. Noi immunologi aspettiamo ardentemente il giorno in cui potremo «rendere tollerante» un simile paziente, cioè potremo insegnargli ad ac352
cettare come «sé» gli antigeni estranei associati con il suo
nuovo cuore, istruendolo d'altro canto a continuare a rigettare qualsiasi altra cosa estranea che si trovi sul suo cammino.
I problemi connessi ai trapianti di organi vitali costituiscono uno degli scenari più drammatici della medicina moderna. Quantitativamente, comunque, solo pochissimi pazienti subiscono trapianti. Molto più diffuse sono le già
menzionate malattie autoimmuni. Consideriamo, ad esempio, l'artrite reumatoide. Perlomeno il 4 per cento dell'intera popolazione mondiale ne soffre e, di tanto in tanto, nei
casi peggiori, siamo costretti a sopprimere il sistema immunitario del paziente.
Raymond venne trasportato nella mia clinica su una sedia
a rotelle. Trentaquattro anni, sposato con un bambino, ex
insegnante. Appariva molto magro e d'aspetto miserevole
per i lunghi periodi passati nella sofferenza e nella frustrazione. Cinque anni prima, per aumentare un poco i suoi introiti, durante i fine settimana lavorava in un deposito di legname. A ventinove anni, sano, allegro e gran lavoratore,
sembrava destinato a un futuro felice.
Un mattino prese un paio di grosse pinze tagliafili per togliere una banda di metallo che avvolgeva molto strettamente un fascio di legni. Nel tagliare quella banda così tesa,
arretrò improvvisamente e violentemente, producendosi
una fortissima distorsione del polso, con una dolorosa lacerazione dei tendini. Due settimane dopo, non solo la mano
non era guarita, ma altre articolazioni nel corpo si erano
gonfiate, facevano male ed erano molto calde. Gli si era sviluppata un'artrite reumatoide, una malattia in cui le articolazioni vengono attaccate e distrutte da linfociti fuorviati
che non riconoscono tali parti del corpo come «sé». In individui predisposti geneticamente, non è raro che questi eventi vengano innescati da un episodio traumatico come quello
descritto.
Dopo cinque anni, Ray era un uomo sciancato, debole,
magro, anemico, cronicamente affaticato e, per la maggior
353
parte del tempo, inchiodato a una sedia a rotelle. Era stato
curato in modo energico da medici competenti. Aspirina,
sali d'oro, iniezioni di steroidi nelle articolazioni, penicilammina e ogni nuovo farmaco antinfiammatorio che fosse
posto in commercio erano stati tutti provati, con scarsi risultati. Discutemmo sui rischi che comportava la soppressione della risposta immunitaria con la ciclofosfammide, un
farmaco potente ma pericoloso che molti di noi, trattando
la forma più grave di questa malattia, trovano utile. Spiegai
a Ray che i suoi linfociti T e B stavano attivamente danneggiando le sue articolazioni. Era chiaro che un certo danno
permanente era già stato provocato, ma un ulteriore danno
si sarebbe aggiunto se la malattia non fosse stata tenuta sotto controllo.
La ciclofosfammide è un farmaco che uccide le cellule al
momento della divisione e la mitosi cellulare è un momento
essenziale dell'attacco immunologico. Le cellule che si dividono più rapidamente sono anche quelle che vengono maggiormente colpite. Nel sistema immunitario, le cellule che si
dividono più rapidamente sono quelle che producono gli
anticorpi, cioè i linfociti B; esse sono inibite dal farmaco
sopra citato.
Continuai a discutere con Ray sui benefici che si potevano ottenere bloccando con i farmaci l'attacco alle sue articolazioni e, naturalmente, parlammo anche degli effetti collaterali ai quali poteva andare incontro. Il più grave di tutti
era la sterilità: era molto improbabile che egli sarebbe potuto diventare padre una seconda volta dopo aver preso la ciclofosfammide per alcune settimane. Gli spermatogoni, cellule a rapida divisione che, nei testicoli, danno origine agli
spermatozoi, vengono infatti uccisi.
Mi resi conto che questo annuncio fu per lui un colpo
perché aveva un unico figlio e la famiglia desiderava vivamente averne un secondo. Oggi avrebbe raccolto il proprio
seme conservandolo per una futura fecondazione artificiale. Ma, allora, non si era in grado di fare questo. Dopo una
lunga conversazione e un'altrettanto lunga pausa di rifles354
sione, Ray scelse di prendere il farmaco. La malattia era
peggio di qualunque potenziale effetto collaterale.
Non tutti i pazienti affetti da artrite reumatoide rispondono alla ciclofosfammide, ma Ray sì. Nei primi mesi di terapia, la sua malattia sembrava in gran parte scomparsa.
Lasciò la sedia a rotelle e pianse dalla gioia di poter camminare liberamente. Non che fosse del tutto a posto. Alcuni
danni strutturali erano irreversibili. Perse i capelli per alcuni mesi, divenne sterile come previsto, ma fu in grado di
tornare alla sua professione. I benefici psicologici legati al
fatto di avere di nuovo un impiego remunerativo avrebbero
persino potuto superare la felicità di vedere l'artrite recedere. Ray continua a stare bene, anche se avrà sempre bisogno
delle più meticolose cure mediche per poter camminare
tranquillo su quella fune da equilibrista, che è sospesa tra
un nuovo divampare della malattia e un grado pericoloso di
immunosoppressione.
Di tutti i farmaci immunosoppressori il più interessante è
anche il più recente: la ciclosporina A. Esso è prodotto da
un fungo ed ha una minuscola molecola, che porta però un
enorme spuntone. Ha la capacità finora unica di impedire
ai linfociti T di secernere l'interleuchina 2 (IL-2). Forse ricorderete che l'IL-2 è il composto chiave del sistema immunitario e dà il permesso a tutte le altre cellule di attaccare.
Questo farmaco ha rivoluzionato tutto il settore dei trapianti, poiché impedisce con alta probabilità il rigetto degli
organi trapiantati e si avvicina al farmaco ideale, cioè quel
composto chimico che agisce in maniera mirata, solo sulle
cellule che desideriamo colpire, risparmiando gli altri tessuti. La ciclosporina non ha effetti sul fegato e sui reni e può
essere utilizzata per tre mesi senza rischi di effetti collaterali; a questo punto è opportuno utilizzare altri composti terapeutici. Sono in corso intense ricerche per riuscire a produrre un farmaco con effetto analogo sul sistema immunitario, ma non tossico verso altre cellule, e che si possa utilizzare in maniera prolungata.
Gli immunologi hanno a disposizione sostanze naturali e
355
potenti che servono o a favorire o ad alterare le risposte immunitarie. Il nostro repertorio terapeutico dispone oggi dell' interleuchina 2 (che viene in parte prodotta da batteri amici dopo qualche espediente di ingegneria genetica), l'interferon, gli ormoni del timo e una miriade di prodotti a basso
peso molecolare, estratti da linfociti T sani. Questi fattori
non sono specifici, e pertanto possono essere impiegati su
qualsiasi individuo per modificare le risposte immunologiche. Li utilizziamo per pazienti con immunodeficienza, con
infezioni virali croniche e affetti da cancro.
Gli immunologi clinici stanno sperimentando numerose
terapie, potenzialmente stimolanti, per aiutare i pazienti affetti da malattie immunitarie. Si considerino gli sviluppi
raggiunti con la tecnica di irradiazione linfoide totale. Sembra che, somministrando radiazioni gamma a tutti i linfonodi presenti nel corpo, siamo in grado di fare ritornare il
sistema immunitario a uno stato simile allo stato fetale, in
cui è possibile ristabilire la tolleranza verso il «sé», che è andata perduta e che dà luogo a una grave malattia. Gli antigeni, che erano stati trattati come estranei, possono di nuovo essere rispettati come «sé». Questa cura si sta dimostrando particolarmente preziosa in pazienti ai primi stadi di
sclerosi multipla, artrite reumatoide e Lupus Eritematoso
Sistemico.
Si attendono progressi anche nel campo delle allergie alimentari. Stiamo finalmente purificando gli antigeni di origine alimentare, che provocano la reazione allergica. Una
volta purificati, la nostra capacità di diagnosticare e di curare la sofferenza prodotta da questo tipo di allergia sarà di
gran lunga migliorata.
Come in qualsiasi attività umana sottesa dall'idea di progresso, la scienza necessita sia dei teorici che di ricercatori
di laboratorio capaci di verificare la bontà delle ipotesi, e se
possibile trovarne un'applicazione pratica, nel nostro caso,
clinica. L'immunologia non fa certo eccezione. Uno dei
grandi teorici del nostro tempo è stato il premio Nobel australiano MacFarlane Burnett, che ha influenzato me e cen356
tinaia di altri giovani scienziati, quando eravamo alle prime
armi. Lo conobbi che era già ufficialmente in pensione, ma
ciononostante era felicissimo di discutere i risultati sperimentali con chi di noi glielo chiedeva. L'interpretazione dei
dati osservati era per lui una grande partita a scacchi. In
quanti modi potreste far sì che il risultato significhi qualcosa? Di quanti nuovi esperimenti potreste avere bisogno per
coronare gli sforzi che avete compiuto per tutta la vita?
Burnett era un grande teorico, che capì l'autoimmunità
prima di chiunque altro. Egli si rese conto che le verità
scientifiche vanno stabilite a poco a poco, con lentezza
spesso esasperante: da A a B a C. Ma non era questo il suo
modo di procedere. Lui andava da A a L e quindi a S: che
qualcun altro venisse a dimostrare che le sue idee erano giuste e che colmavano bene i vuoti rimasti nel puzzle. Avrebbero avuto un onorevole secondo premio. Mi ripeteva di
tanto in tanto: «Non fare il taglio alle T e metti i puntini
sulle I».
Incontrai per la prima volta il suo grande amico e avversario intellettuale Niels Jerne a un party scientifico per festeggiare il settantesimo compleanno di Burnett. I due uomini erano (e Jerne continua a esserlo ancora oggi) i giganti
dell'immunologia teorica. A entrambi nulla era più gradito
di concepire una teoria che sfidasse le convinzioni dei contemporanei e di trovare quindi qualcuno che dimostrasse
che quella teoria era giusta al 100 per cento.
In questo spirito Jerne elaborò la teoria della «rete». In
sintesi, egli proponeva questo: quando produciamo un anticorpo, per esempio, contro una parte del tossoide del tetano penetrato nel nostro corpo in seguito a vaccinazione,
l'anticorpo fa tutto quello che noi oggi ci aspetteremmo che
facesse. Ma, diceva Jerne, quell'anticorpo diventa un antigene e la presenza di questo antigene nel nostro corpo fa sì
che produciamo un anticorpo contro di esso, cioè un antianticorpo!
Sicuramente questa volta Jerne era andato troppo lontano: i nostri anticorpi fanno parte del «sé» e non dovrebbero
357
promuovere una risposta da parte di alcuna delle nostre cellule. Strano o no, sosteneva Jerne, troverete che produciamo anticorpi contro gli anticorpi e che questi secondi anticorpi a loro volta provocano la comparsa di terzi anticorpi,
e così via.
Immaginate di trovarvi in una piccola imbarcazione in
mezzo a un lago e di lanciare una grossa pietra al centro di
questo corpo d'acqua. Onde d'urto correranno verso la riva
e di nuovo indietro facendo comparire alla superficie dell'acqua, là dove le onde collideranno, ben visibili increspature. A poco a poco queste diventeranno più piccole fino a
scomparire completamente. La stessa cosa accade quando
introducete un antigene nel corpo, sosteneva Jerne: onde di
anticorpi si formano le une contro le altre, e ciascuna provoca una risposta leggermente inferiore alla precedente, dimodoché il processo si smorza gradatamente, per poi scomparire.
Non vi racconterei questa storia se Jerne non avesse avuto ragione. Nel fenomeno da lui descritto, vi è qualcosa di
più affascinante da riferire che non il semplice effetto delle
increspature. Gli anti-anticorpi interagiscono con linfociti
T specifici che possono regolare la produzione, da parte dei
linfociti B, del primo anticorpo. L'essere in grado di sfruttare questa forma di reazione immunologica ci offrirà stimolanti possibilità terapeutiche. Se si hanno a disposizione
anticorpi contro anticorpi specifici, si potrebbe arrestare la
produzione da parte dell'organismo di questi anticorpi specifici. Prenderemo in esame brevemente alcuni esempi.
Nella nostra ignoranza attuale, non ci rimane che accettare il fatto, ormai ben stabilito, che il nostro sistema immunitario fa eccezione alla norma «nessuna reattività contro il
sé» quando si tratta di anticorpi. Con maggiore precisione,
reagiamo solo contro una parte dell'anticorpo quando produciamo gli anti-anticorpi. Questa parte, che è antigenica,
viene chiamata idiotipo. È la porzione della molecola che si
combina con l'antigene, cioè la porzione della configurazione tridimensionale dell'anticorpo che è perfettamente mo358
deliaca sulla forma dell'antigene: l'analogia della chiave
(l'antigene) nella serratura (l'anticorpo) di cui abbiamo già
parlato. Gli anticorpi contro questa «serratura» si chiamano anticorpi antiidiotipici.
Vediamo ora quali possono essere le applicazioni della
scoperta di Jerne. Immaginate di trovarvi nello studio di un
immunologo clinico tra qualche anno. Il problema che vi
assilla è una grave forma invalidante di allergia da ambrosia. L'immunologo vi spiega, come farebbe oggi, che avete
prodotto una quantità eccessiva di immunoglobulina E contro il polline di questa pianta. Quando antigene e anticorpo
si combinano alla superficie delle mastcellule e dei basofili,
vengono liberate istamina e altre sostanze simili ed ecco che
compaiono orticaria, febbre da fieno, asma, e via dicendo.
In futuro, l'immunologo potrà darvi buone notizie. Per
esempio, se vorrete stare meglio, dovrete bloccare la produzione di immunoglobulina E contro l'ambrosia. Per mantenere la produzione di IgE a livelli moderati, il vostro organismo non produce una quantità sufficiente di anticorpi
contro questa immunoglobulina. Vi somministreremo allora qualche anticorpo antiidiotipico, cioè un anticorpo contro quella parte della vostra IgE che riconosce il polline di
ambrosia come antigene, e in tal modo ne bloccheremo la
produzione. Otterremo così una desensibilizzazione del vostro organismo sicura, specifica e in effetti sensazionale.
Un'altra applicazione degli anticorpi antiidiotipici è già
tra noi. Se per pensare a un antigene e a un anticorpo si ricorre alla nota analogia della chiave e della serratura, si può
fare un passo in più. Se si produce un anticorpo contro la
«serratura», questo avrà lo stesso aspetto della «chiave». In
altre parole, la regione idiotipica dell'anticorpo antiidiotipico apparirà come l'antigene che ha dato inizio alla reazione
originaria. È possibile immunizzare animali ed esseri umani
con anticorpi antiidiotipici ed ottenere la stessa risposta che
otterremmo se somministrassimo l'antigene. La differenza
sta nel fatto che gli antigeni possono essere dannosi. Quando si immunizzano individui con virus vivi (per esempio, il
359
virus della poliomielite), può verificarsi sempre l'eventualità che il processo di attenuazione non sia stato soddisfacente e che si possa scatenare la malattia. Invece, la somministrazione di un anticorpo contro gli anticorpi prodotti contro il virus della poliomielite è innocua, ma efficace.
Questi sono soltanto alcuni degli strumenti che l'immunologo clinico ha attualmente a disposizione o che saranno
messi a punto tra breve. Si tratta di un settore molto stimolante, e non penso di esagerare nel dire che l'80 per cento di
tutta la sofferenza umana dovuta a malattie potrebbe essere
spazzato via se si riuscisse ad avere il controllo sulla risposta immunitaria.
360
11
I rinforzi: la mente come alleata
Martina aveva quattordici anni ed era magra. Meglio che
avere quattordici anni ed essere grassa, pensava. Ma, in
realtà, la sua magrezza preoccupava sia lei che sua madre.
Non era malata, tutt'altro. Era anzi una probabile candidata a fare parte della squadra di atletica leggera della sua
scuola. La mancanza di grasso non era neppure dovuta al
fatto che mangiasse poco. Quanto a mangiare, superava
ogni volta suo fratello di sedici anni. Tutti si prendevano
gioco del suo essere pelle e ossa ed essa odiava quel suo corpo. Pregava che la pubertà lo modificasse. Almeno le fosse
cresciuto il petto, che le avrebbe dato un poco di forma.
Martina non andava molto bene a scuola, e malgrado si
applicasse piuttosto intensamente, si era rassegnata, ritenendo (come del resto faceva chiunque altro la conoscesse)
di non essere molto intelligente. Non la interessava raggiungere un titolo accademico (o, più probabilmente, non raggiungerlo). La sua ambizione, costante da sei mesi, era di
viaggiare in tutto il mondo: la vita di una hostess di linea
faceva giusto per lei. La mamma la giudicava abbastanza
graziosa e, se Martina fosse diventata troppo alta per i
Jumbo, avrebbe sempre potuto fare la modella. I «pelle e
ossa» vanno molto bene per appendervi dei vestiti.
Dietro questa mancanza di grasso, Martina celava però
due grosse preoccupazioni. David, suo fratello, si drogava e
nessun altro nella famiglia lo sapeva. Lei lo aveva scoperto
mentre annusava una polverina bianca e, siccome non era
361
stupida, non accettava il fatto che lui sostenesse che quella
sostanza era una medicina.
Il secondo cruccio concerneva sua madre. Benché avesse
un aspetto sano e solo trentasei anni, da bambina aveva
sofferto di febbri reumatiche e, nel cuore, la valvola mitralica era rimasta danneggiata. Aveva sentito dire molte volte
che vi era qualcosa attorno che la rendeva troppo stretta: il
cuore della mamma doveva così pompare il sangue con
molto sforzo per spingerlo attraverso una valvola che era
diventata, in realtà, un minuscolo foro. Per ben due volte la
donna si era sottoposta a un intervento chirurgico che le
aprisse la valvola, ma ogni volta, dopo un miglioramento
che durava alcuni anni, il foro si restringeva di nuovo.
Martina adorava la mamma e non riusciva a sopportare il
pensiero del dolore che avrebbe provato se avesse saputo di
David. Stava per sottoporsi a un altro intervento: sarebbe
stata inserita nel suo cuore una nuova valvola artificiale.
Ed ecco che, inaspettatamente, sul tavolo operatorio, poco dopo l'inizio dell'intervento, la mamma di Martina era
morta. Un coagulo di sangue o qualcos'altro era sfrecciato
nei polmoni e l'aveva uccisa. Il padre di Martina mi raccontò in seguito che la figlia, quando lui le aveva dato la notizia, si era messa a urlare, rifiutandola; quindi si era messa a
piangere per tre interminabili giorni, afflitta da una disperazione toccante, prima che uno sfinimento totale, fisico ed
emotivo, la facesse crollare in un sonno inquieto, costellato
di singulti che le scuotevano il corpo.
Mesi dopo Martina mi confessò quanto grave fosse stato
per lei quel colpo, quanto doloroso l'acuto senso di perdita.
Si sentiva defraudata, non solo perché aveva perso la mamma e la sua migliore amica, ma anche perché non aveva
avuto alcun motivo di preoccuparsi dell'operazione e, pertanto, non aveva avuto il tempo per prepararsi a quella perdita. Di conseguenza, le prime settimane dopo la morte della mamma essa era stata tormentata dalla disperazione, dalla rabbia e da un senso di colpa.
Una storia triste, naturalmente, ma c'era molto di più di
362
quello che io vi ho raccontato per non entrare troppo nei
particolari. No, la vicenda e la sofferenza per quella ragazzina erano solo agli inizi.
Due settimane esatte dopo la morte della mamma, Martina si svegliò con le dita e la spalla destra doloranti e rigide.
A mezzogiorno entrambi i sintomi erano scomparsi, ma alla
sera il dolore era ritornato e interessava adesso anche il ginocchio destro. Due giorni dopo era una storpia relegata a
letto: ginocchia, caviglie, spalle e mani terribilmente doloranti e infuocate le avevano tolto ogni possibilità di muoversi.
I medici la esaminarono. Vennero effettuati esami sul
sangue e su un poco di liquido aspirato dal ginocchio con
un lungo ago collegato a una siringa. Venne formulata la
diagnosi: Martina era stata colpita da artrite reumatoide.
Erano bastati tre giorni per trasformarla da candidata ad
entrare nella squadra di atletica leggera della sua scuola a
una persona invalida.
Cinque giorni dopo, mentre le sue articolazioni stavano
un po' meglio grazie al riposo prolungato a letto e alle medicine somministratele, Martina notò che eliminava una
grande quantità di urina. Ogni ora ne produceva molta e la
sete che ne derivava la faceva bere in continuazione. Dopo
tre giorni, il suo già magrissimo corpo sembrava uno scheletro con articolazioni sproporzionate.
Altri esami, altri medici e una nuova diagnosi: Martina
non era affetta solo da un'artrite reumatoide, ma si era ammalata anche di diabete mellito. Questo compare quando il
pancreas non è più in grado di secernere una quantità sufficiente di insulina. L'insulina è necessaria per far giungere il
glucosio (e quindi l'energia) all'interno delle cellule e, se
questo non accade, il glucosio continua a circolare nel sangue. È compito dei reni rimuoverlo, ma ciò può essere fatto
asportando al contempo dal sangue una grande quantità
d'acqua: per questo si elimina molta urina, che è dolce.
Dolce, naturalmente, per la presenza di zucchero.
Forse la tortura psichica di Martina, muovendosi rapida363
mente per il cervello sotto forma di impulsi elettrici impazziti, sconvolse alcuni delicati meccanismi di controllo che,
in realtà, agiscono molto distanti dal cervello, in lontane articolazioni e nelle ghiandole addominali.
Dato che sia l'artrite reumatoide sia il diabete sono malattie autoimmuni, cioè malattie in cui il sistema immunitario di un organismo attacca i tessuti che fanno parte del
«sé» come se fossero tessuti estranei, potrebbe questo ritorcersi immunologico contro il «sé» essere in qualche strano
modo collegato a un ritorcersi psichico contro la propria
persona?
Molti medici competenti potrebbero raccontarvi storie simili a quella di Martina. Anch'io potrei raccontarvene molte altre. Per esempio, potrei raccontarvi di un pianista, un
concertista, che tre settimane dopo essersi rotto e permanentemente rovinato un dito, quasi morì d'infiammazione
intestinale. Potrei raccontarvi nei particolari la lotta per respirare, provocata da uno spasmo acuto delle vie respiratorie, di una madre di quarantadue anni, che aveva abortito
al sesto mese di gravidanza. Era stata quella, per lei, l'occasione in cui si era sentita più vicina alla realizzazione di un
sogno, ormai svanito per sempre, di avere un figlio. Ma, invece di continuare a raccontarvi storie, prendiamo in considerazione alcuni dati scientifici per vedere se riusciamo a
convincerci che la mente governa il corpo e, in particolare,
che mente e sistema immunitario dialogano costantemente.
Charles Darwin fu forse il primo scienziato a enunciare
chiaramente l'ipotesi che la mente, il nostro computer che
raccoglie informazioni e prende decisioni, possa istantaneamente e volontariamente fare appello a una reazione da
parte del corpo.
Darwin era affascinato dalla paura. La maggior parte
della gente, in un momento o nell'altro, ha avuto paura.
Per quanto mi riguarda, a me non piace, ma vi sono persone di parere diverso e che persino pagano per starsene un
paio d'ore al buio in preda a una tale emozione. Che piaccia
o no, tutti hanno sperimentato che la paura induce una rea364
zione, o più reazioni, nell'organismo quasi istantaneamente
al momento in cui la mente segnala una situazione di pericolo.
Una siffatta situazione viene riconosciuta dai centri cerebrali superiori. Una macchina supera l'angolo della strada
troppo in fretta, il conducente non riuscirà a frenare in corrispondenza del passaggio pedonale, siamo soltanto a metà
della carreggiata, pericolo! Ora, se la nostra mente tiene
conto di questi fatti pericolosi e ci segnala che siamo in pericolo e, malgrado questo, non risolve automaticamente il
nostro problema, saremo investiti da quella macchina. Possiamo morire sapendo quello che ci è successo e rammaricandoci per un millisecondo di non esserci tolti dalla strada.
Per fortuna, però, come riconobbe Darwin, per sopravvivere è stato necessario che fossero messi a punto meccanismi per mezzo dei quali la valutazione del pericolo produce
paura e la paura produce una reazione corporea istantanea.
I nostri muscoli si tendono e noi saltiamo, il più delle volte
con successo, verso la salvezza. Lo spavento ci prepara per
la fuga. Questo meccanismo meraviglioso esige, ovviamente, che un messaggio si sposti rapidamente dal cervello ai
muscoli e ad altri organi vitali.
I romanzieri, naturalmente, hanno descritto di continuo
queste risposte biologiche. Una maggior prontezza mentale
in qualcuno che sia stato spaventato può esserci riferita così: «Braccato e disperato, i suoi sensi erano acuti come
quelli di un gatto pronto a balzare sulla preda». L'attivazione dei nervi del sistema nervoso autonomo, che controllano i minuscoli muscoli che si trovano alla base dei follicoli
piliferi e i muscoli che fanno dilatare e retringere i vasi sanguigni, può essere descritta come segue: «Troppo tardi si
accorse del serpente che si preparava a colpire. I peli dietro
il collo gli si drizzarono e il viso gli si sbiancò».
L'effetto di quei messaggi che da una mente terrorizzata
giungono ai nervi che controllano le ghiandole sudoripare e
le contrazioni intestinali può essere descritto in questo modo: «Lo stomaco, per la paura, era come chiuso da nodi:
365
gocce di sudore gli si formarono sulla fronte quando il fucile di chi doveva eseguire la condanna fu sollevato». E così
di seguito.
La paura è positiva ed è essenziale perché pone in atto,
con incredibile velocità, le risposte corporee che possono
salvarci la vita. Ma come fa a scomparire istantaneamente il
colore dalle guance di una persona impaurita? Sappiamo
che ciò è dovuto a uno spasmo dei vasi sanguigni superficiali della cute determinato dall'adrenalina, una sostanza di
cui si tratterà un po' più avanti.
La mente invia messaggi dalla corteccia cerebrale, che è
la parte più sviluppata del cervello, ad altre parti e lo fa nell'uno o nell'altro di due differenti modi. Messaggi elettrici
possono passare lungo i miliardi di fili «telegrafici», che
connettono una parte vitale del cervello a un'altra. In alternativa, messaggi possono essere trasmessi da sostanze chimiche, come quando una parte del cervello libera una sostanza che attiverà qualche altra parte del cervello, ma quella parte e non un'altra. Sappiamo quanto rapidamente un
segnale chimico possa operare: quanto tempo impiega un
profumo conturbante a risvegliare un ricordo specifico o
una pregustazione nel vostro cervello?
Ma tutto questo si svolge all'interno della nostra testa,
mentre per toglierci dalla strada dove sta rapidamente avvicinandosi a noi un'automobile devono intervenire le gambe. Da tempo sappiamo che queste risposte periferiche
comportano non soltanto messaggi elettrici che si propagano lungo i nervi, ma la rapida liberazione di ormoni.
Gli ormoni sono sostanze prodotte dal sistema endocrino, un sistema costituito da ghiandole situate strategicamente, che producono e immagazzinano sostanze incredibilmente potenti (gli ormoni), che vengono liberate, quando
sono quelle giuste, per farci fare qualcosa di diverso. Quando si mangia, nello spazio di secondi, il pancreas libera insulina nel circolo sanguigno per agire sullo zucchero che è
stato introdotto con gli alimenti. Quando i geni di un adolescente segnalano che è tempo di far crescere del pelo sul pet366
to, i testicoli del ragazzo produrranno e libereranno testosterone e il pelo crescerà, i muscoli si rafforzeranno e molte
altre modificazioni si verificheranno nel corpo.
Non molti anni fa, è stato scoperto che la maggior parte
degli ormoni liberati nel corpo è controllata da un insieme
specifico di ormoni regolatori, prodotti dall'ipofisi. Questa
ghiandola è situata alla base del cervello. Appoggiate un dito sopra il naso e puntatelo contro il cranio: proprio al disotto (sotto l'osso, naturalmente) si trova l'ipofisi.
In un punto ben preciso del ciclo mestruale di una donna,
l'ipofisi invia un messaggio chimico alle ovaie, istruendole a
liberare nelle tube di Falloppio qualche cellula uovo, pronta
per essere fecondata. L'ipofisi aspetta quindi che una cellula uovo lo sia: in caso contrario, invia un altro messaggio
alle ovaie, istruendo nel contempo l'utero a chiudersi, staccando dalla propria parete quel rivestimento morbido, caldo e confortevole, che doveva servire a nutrire il giovane
embrione. La donna ha le mestruazioni: «Il pianto di un
utero deluso».
Ma che cosa ha tutto questo a che vedere con le articolazioni gonfie di Martina? Per favore, un poco di pazienza
ancora!
Di recente, si è scoperto che l'ipofisi è essa stessa sotto il
controllo di altri ormoni, che provengono da una parte specifica del cervello, l'ipotalamo, intimamente connesso da
legami chimici ed anatomici a molti centri cerebrali superiori.
Le ghiandole che hanno ricevuto il massimo della pubblicità scientifica, a proposito di «paura e fuga», sono i surreni, o ghiandole surrenali, poste alla sommità dei reni. Esse
producono due tipi di ormoni molto importanti: l'adrenalina, detta anche epinefrina, e gli steroidi come l'idrocortisone. Questi ormoni sono giustamente chiamati «ormoni dello stress», in quanto la loro liberazione immediata in tempi
di pericolo è molto importante. Oggi sappiamo, tuttavia,
che vi sono molte altre sostanze che hanno uguale funzione.
L'adrenalina fa sparire il colorito dal viso, non necessa367
riamente perché la Natura pensi che vi sia un vantaggio a essere pallidi. Il vantaggio che vi sia meno sangue che scorre
nella cute è che una maggiore quantità di sangue può andare
a irrorare i muscoli, i muscoli hanno bisogno di sangue per
l'ossigeno, in quanto l'ossigeno dà loro l'energia necessaria,
che, per esempio, permette di scansarsi all'arrivo di un'automobile.
Finora abbiamo trattato della paura che fa spedire messaggi deliranti in tutto il corpo, con adattamenti fisiologici
che avvengono istantaneamente, dimodoché l'organismo risponde in modo appropriato. Ma spesso i romanzieri hanno
notato che non è sempre così...
«Marie lo vide emergere dall'ombra e lo riconobbe istantaneamente quando la luce della luna bagnò quel viso fin
troppo conosciuto. Essa si raggelò, terrificata, abbacinata,
con il cuore che batteva velocemente. Voleva correre, urlare, ma tutto quello che riuscì a fare fu fissarlo in quei suoi
occhi crudeli, via via che si avvicinava.»
Che cosa non aveva funzionato? Dov'era l'ipotalamo nel
momento in cui lei ne aveva bisogno? Dov'erano quei segnali elettrici e chimici diretti alle surrenali? Non lo sapremo mai, ma è del tutto probabile che il mostro ci seppe fare
e poi strangolò quella poveretta con un sistema neuroendocrino fuori posto.
«Fatta troppo male» avrebbe detto Darwin. «Solo i più
idonei sopravvivono e trasferiscono la loro superiorità genetica alla prole.»
Alcuni di noi hanno dovuto affrontare situazioni di terrore e hanno reagito in modo appropriato, altri no.
Lo stress in ogni forma - paura, privazione, rabbia, e così
via - necessita non solo di uno stato di allerta ormonale, ma
anche di uno stato di allerta immunologico. Supponiamo,
nel momento in cui ci prepariamo a «fuggire per la paura»,
di impegnare il sistema immunologico, un altro legame vitale
nella difesa dell'uomo. Alcuni individui possono potenziare
la capacità del proprio sistema immunitario quando sono
stressati, mentre altri possono danneggiarne le funzioni.
368
Se le cose stanno in questi termini, allora si riuscirebbe
forse a spiegare che cosa è accaduto a Martina. Il suo tormento mentale ha condotto ad alterazioni non appropriate,
anzi addirittura dannose, dei suoi sistemi ormonali e immunitario.
Vi sono prove che il sistema nervoso centrale e il sistema
immunitario siano legati, con ormoni che svolgono ruoli
importanti come messaggeri, connettendo i centri superiori
del cervello al sistema immunitario.
Se chiedete a uno studente di biologia: «Dove si trovano,
nel corpo, la capacità di "conoscere se stessi", l'adattabilità
che consente di dare risposte appropriate, non riflesse, e la
capacità di memoria, il che vuol dire che si può apprendere
dall'esperienza e migliorare?», la risposta sarà, con tutta
probabilità: «Nel cervello». E il vostro interlocutore vi lancerà un'occhiata sorpresa come se si chiedesse perché gli è
stata posta una domanda così ovvia. In realtà, la risposta
dovrebbe essere: «Nel cervello e nel sistema immunitario».
La capacità di quest'ultimo di riconoscere il «sé», di adattarsi alle circostanze e di dare risposte specifiche, come pure
di utilizzare la capacità di memoria, attribuisce al sistema
immunitario stesso una certa intelligenza.
Quando qualcosa di estraneo entra nell'organismo, i geni
della risposta immunitaria, che sono stati ereditati, determineranno se si può dare o no una risposta immunitaria appropriata. Quando un individuo è sotto stress, i geni che
controllano il modo in cui egli fa fronte alle difficoltà determinano la risposta allo stress e se questa risposta è appropriata o no. In parole semplici, per ragioni genetiche alcuni
individui fronteggiano, tanto per fare un esempio, la tubercolosi meglio di altri; alla stessa stregua, per ragioni genetiche, alcuni fanno fronte alla tensione meglio di altri. Stiamo analizzando la possibilità che, nell'una e nell'altra situazione, la capacità genetica di risposta appropriata, o non
appropriata, sia in qualche modo interdipendente. Noi saremmo tentati di ipotizzare che buoni geni per far fronte alle difficoltà abbiano più probabilità di essere attivati in un
369
paziente che abbia già ereditato buoni geni che controllano
la risposta immunitaria.
Dovremmo fare marcia indietro per un minuto, onde essere certi che un paio di punti di cui abbiamo già parlato siano ben chiari. Quando gli psicologi parlano di risposta appropriata a uno stress, si riferiscono alla reazione che porta
a fronteggiare la situazione, proprio come un immunologo
pensa a una risposta immunitaria in termini di infiammazione. Dovremmo definire anche come, nel nostro contesto,
utilizziamo la parola «stress». Stress è un termine che può
trarre in inganno, perché può riferirsi sia alla causa che provoca la tensione (ad esempio, una situazione particolare) sia
alla risposta che la situazione provoca. Nel nostro contesto,
utilizziamo il termine per indicare la situazione che richiede
una risposta dalla persona che interpreta la situazione.
Oggi gli scienziati possono studiare questa situazione in
vivo negli esseri umani, e molti lo fanno, ma è spesso più
facile ricavare dati fondamentali da osservazioni ed esperimenti sugli animali. Prendiamo in considerazione il dato,
che deriva da studi sugli animali, in base al quale la mente
invia segnali al sistema immunitario e viceversa, e alcuni di
questi segnali conseguono alla percezione di una situazione
di stress.
Se avete letto qualche libro di fisiologia comportamentale, certamente avrete sentito parlare del grande dottor Pavlov e del suo altrettanto celebre cane. Pavlov sapeva di un
poveretto che, alla fine del secolo passato, era riuscito
straordinariamente a guarire da una brutta ferita allo stomaco infertagli in guerra. La guarigione lo aveva però lasciato con un pezzo di mucosa che rivestiva internamente lo
stomaco all'esterno del corpo: bizzarro, ma vero. Pavlov
aveva notato che, ogni qualvolta quell'uomo aveva fame,
anche prima di cominciare a mangiare, mentre preparava
l'atteso banchetto, il suo stomaco rovesciato secerneva ogni
tipo di succhi gastrici: al momento di mangiare, questi liquidi fluivano copiosamente. E lo stesso avveniva quando
l'uomo sentiva l'odore del cibo. In altre parole, il cervello
370
di quell'uomo faceva in qualche modo lavorare lo stomaco
prima che arrivasse il cibo.
Pavlov operò un cane in modo da lasciargli un lembo di
mucosa dello stomaco all'esterno, come in quell'uomo, ed
eseguì alcuni esperimenti di laboratorio su quel suo «beniamino», che li resero entrambi celebri. Dopo un intenso lavoro, egli trovò essenzialmente questo: che poteva condizionare il cane in modo che secernesse i succhi gastrici anche quando non aveva fame e non vedeva il cibo.
Se si prende un animale come il cane di Pavlov e si associa un suono di campanello ogni volta che gli si porge del cibo, sufficiente a fargli secernere abbondanti succhi gastrici,
gli stessi succhi vengono rapidamente secreti al semplice
suono della campana. Qualunque tipo di messaggio venga
solitamente trasmesso dal cervello allo stomaco con la fame, si propaga per le stesse vie quando suona un campanello. Questa risposta appresa è chiamata condizionamento.
Il condizionamento è così consolidato nell'anima scientifica degli studiosi di psicologia sperimentale e dei fisiologi,
che non sorprende il fatto che alcuni dei primi e più interessanti tentativi di dimostrare che la mente controlla o, perlomeno, è in grado di influenzare il sistema immunitario provengano da esperimenti effettuati su di esso. Darò qui alcuni esempi.
Se si prende un topo comune e vi si iniettano alcuni globuli rossi, per esempio di pecora, il sistema immunitario di
quel topo ovviamente si opporrà. I linfociti T riconosceranno gli invasori, lanceranno l'allarme e, tra le altre cose, attiveranno i linfociti B a produrre anticorpi contro i globuli
rossi della pecora. Tre settimane dopo, non vi sarà alcuna
difficoltà a scoprire quegli anticorpi in poche gocce di sangue del topo. Tutto perfettamente normale.
Oggi disponiamo di farmaci che possono intossicare i linfociti B. Li utilizziamo per curare malattie in cui questo tipo di linfociti è così alterato da diventare una vera e propria
minaccia, per esempio alcune forme di leucemia. Un farmaco del genere è la ciclofosfammide. Se questa sostanza (che
371
è inodore) viene aggiunta all'acqua da bere del topo e si inoculano in quest'ultimo alcuni globuli rossi di pecora, il topo
non produrrà così tanti anticorpi come quello al quale viene
data da bere acqua normale. Dopo un paio di settimane, il
topo a cui è stata somministrata la ciclofosfammide guarisce e riprende la vita normale. A questo stadio risponderebbe in modo perfettamente normale se venisse praticata una
seconda iniezione di globuli rossi di pecora.
In un modello di questo tipo si può aggiungere un artificio condizionante. Per esempio, oltre alla ciclofosfammide,
si aggiunge all'acqua un poco di saccarina e, quindi, si
iniettano i globuli rossi di pecora. Ora l'acqua è molto dolce e, naturalmente, il topo non produce anche qui molti anticorpi come un topo normale, perché la ciclofosfammide
aggiunta all'acqua ha intossicato i linfociti B.
Si lasci guarire il topo e si ripeta la sequenza. Lo si lasci
guarire per una seconda volta, ma alla terza volta si aggiunga all'acqua solo saccarina, senza farmaci. Che cosa pensate che accadrà della produzione di anticorpi? Giusto. Viene
repressa.
La saccarina lancia un segnale gustativo che si propaga
verso il cervello, dove viene tradotto così: «È tempo di sopprimere i linfociti B». Nel cervello, il messaggio induce una
catena di eventi che sopprime la risposta dei linfociti B. Eppure non vi è alcuna sostanza tossica in vista. Ovviamente gli
scienziati competenti che hanno effettuato questi esperimenti dovevano dimostrare che la saccarina, di per sé, non aveva
effetto sulla produzione di anticorpi, e lo hanno fatto.
Incoraggiati da queste straordinarie osservazioni, essi
hanno modificato questi tipi di esperimenti. C'è un ceppo
di topi, noto come NZB (New Zealand Black), che è famoso nel mondo dell'immunologia perché contrae il Lupus
Eritematoso Sistemico in forma quasi identica a quella che
contraggono gli esseri umani. Dopo pochi mesi di vita, in
questo ceppo di topi si formano gli autoanticorpi, che distruggono molti dei tessuti normali, tra cui i globuli rossi
del sangue e i tessuti renali. La malattia può essere prevenu372
ta somministrando al topo NZB della ciclofosfammide fin
dalla prima età. Sappiamo oggi che gli stessi artifici condizionanti descritti sopra permettono che la saccarina riduca
al minimo la malattia, sottoponendo nel contempo il topo a
un numero molto inferiore di effetti collaterali di quello che
si produrrebbe continuando a trattare il topo con la ciclofosfammide. È evidente il potenziale impiego di questa procedura negli esseri umani.
Questo tipo di dimostrazione non è limitato appena agli
esperimenti eseguiti su questo ceppo di topi, né all'uso della
saccarina. Se, per esempio, si prende una cavia e si trapianta sul suo fianco un piccolo frammento di cute di coniglio,
che cosa succede?
I linfociti T di una cavia sana riconoscono che la cute di
coniglio è estranea e in pochi giorni attaccano a tutta forza:
milioni di linfociti invadono il tessuto del coniglio e lo distruggono. Se questo esperimento viene realizzato, ma si
compie un'«operazione» nell'operazione, si dimostra un altro esempio di condizionamento: per esempio, si trapianta
la cute, mentre si diffonde un po' di musica nell'ambiente e
luci di differenti colori si accendono e si spengono in continuazione. Si inietta nell'animale, nella zona in cui verrà posto il tessuto trapiantato, un anestetico locale, quindi si avvolge la parte con grosse bende, che impediscono alla cavia
di camminare bene. In altre parole, l'animale apprende che
luci, musica, anestetico e bende sono tutti associati all'intervento di trapianto nel suo fianco.
Se si ripete questa operazione tre volte, ma alla terza volta non si trapianta nel fianco del topo la cute di coniglio,
che cosa succede? Naturalmente non c'è trapianto da rigettare, ma, se si effettua la biopsia della cute del topo all'incirca una settimana dopo, dove sarebbe dovuto essere il trapianto si trovano moltissimi linfociti T dall'aspetto aggressivo, che cercano dappertutto un tessuto estraneo, previsto
ma non presente. Naturalmente a questi linfociti era stato
inviato un messaggio dal cervello della cavia perché si
aspettassero delle difficoltà.
373
Come può una cavia sapere che le luci e la musica e via
dicendo significano che deve arrivare un trapianto, dimodoché dal suo cervello vengono inviati messaggi ai linfociti
T affinché stiano in allerta per qualche difficoltà che dovrà
insorgere in una determinata area? Le risposte a questo
enigma non sono state tutte date, ma come vedrete ci stiamo avvicinando.
Se la mente può influenzare il sistema immunitario, potrebbe lo stress in generale, o forse una particolare forma di
stress, danneggiare il sistema immunitario di alcuni animali
e, in questo senso, produrre un modello di ciò che può essere accaduto a Martina?
Lo studio di come una costituzione genetica possa permettere a un animale, in condizione di stress, una prestazione migliore che in altre condizioni è affascinante. Per la
maggior parte di questi tipi di esperimenti utilizziamo piccoli animali di laboratorio, che abbiamo inincrociato fino
al punto in cui tutti i discendenti sono identici. Abbiamo
cioè centinaia di animali clonati, tutti con un'identica costituzione genetica.
Se si prende un ratto o un topo e lo si blocca nella sua
gabbia, in modo che abbia poco spazio per muoversi, applicandogli poi degli elettrodi sulla coda, lo si può sottoporre a
stress per vari periodi di tempo, facendo giungere nella coda piccolissimi impulsi elettrici. Le scosse sono piccole, ma
ovviamente sgradevoli.
Numerosi studi di questo tipo hanno mostrato che ratti e
topi si ammalano fisicamente in seguito a questo trattamento, malgrado siano somministrate loro normali quantità di
cibo e di acqua. Il deterioramento fisico notato comporta
uno spettacolare calo di funzionalità nei linfociti T e un
marcato aumento della suscettibilità alle infezioni. Ma tutto
questo non è sbagliato? Lo stress non dovrebbe far diventare matto e pronto a fuggire l'animale che combatte? I linfociti T non dovrebbero essere attivati, anziché disattivati?
In alcuni animali succede il contrario. Certi ceppi di topi
perdono peso e la lucentezza del pelo, mentre i loro linfociti
374
T si deprimono per un certo periodo di tempo dopo l'inizio
dello stress, mentre in un secondo tempo recuperano spontaneamente. Il loro peso aumenta e i linfociti T diventano,
di fatto, superefficienti. Essi si sono adattati magnificamente allo stress.
Altri ceppi di topi, dato un analogo insieme di circostanze stressanti, si estinguono. Questo suggerisce, ovviamente,
che l'informazione genetica può aiutarci ad avere, sotto
stress, prestazioni migliori. Ma la cosa ancora più interessante è che studi preliminari sembrano dimostrare che,
iniettando un po' di siero di topo che non si è adattato bene
a una situazione stressante in un topo che, invece, non lo ha
fatto, quest'ultimo diventa aggressivo. Se il dato è confermato, potete immaginare quale valore avrà il sangue del
freddo, calmo ed efficiente dirigente dell'IBM che prospera
sullo stress del suo lavoro?
Il topo che «ruggiva» di fronte allo stress, come è stato
descritto sopra (non rifuggiva dalle scosse elettriche sulla
coda), è l'eccezione più che la regola e ci riporta così alla
domanda che ci siamo posti prima. Lo stress non dovrebbe
migliorare le risposte fisiche, se i concetti darwiniani di
paura e di fuga sono giusti?
Da tempo gli psicologi pensano che le risposte dannose
allo stress, che si possono trovare associate con un certo insieme di circostanze, siano sensibilmente riducibili se si ha
spazio di manovra nella situazione. Se si riesce a rispondere
alla situazione stressante in modo positivo, in altre parole
se si può fare qualcosa per essa, gli effetti dannosi dello
stress si riducono. La capacità di far fronte al pericolo o,
nel caso in questione, a una sofferenza costante, potrebbe
essere il fattore decisivo che determina l'effetto dello stress
sul sistema immunitario?
Torniamo in laboratorio e prendiamo due gruppi di ratti
identici. Fissiamo gli elettrodi sulle loro code e, a intermittenza, cioè a intervalli di dieci secondi, inviamo loro lievi
scosse per tre minuti. Entrambi i gruppi ricevono lo stesso
choc; tuttavia, un gruppo ha nella propria gabbia una pic375
cola leva e, quando i topi imparano a premerla con la zampa, le scariche si fermano. Le scariche si fermeranno anche
per l'altro gruppo, il quale però non ha modo di controllare
la situazione, cioè non è coinvolto in azioni che gli risparmiano sofferenza.
È sorprendente con quale rapidità i ratti che hanno la leva nella loro gabbia imparino a bloccare le scosse. Gli animali che agiscono in questo senso, pur essendo stressati perché le scosse sono ricominciate di nuovo a intervalli variabili, sono fiorenti. Non così i ratti che sentono le stesse scosse, ma sono indifesi. Essi perdono peso e il loro sistema immunitario è depresso.
Sembrerebbe così che, per la maggior parte di noi, lo
stress faccia avviare dal cervello una serie di risposte endocrine e immunitarie, che ci aiutano a superarlo. Far fronte
allo stress significa effettuare con successo questi interventi,
che lo vedono a poco a poco diminuire. Se capita che le circostanze impediscano di dominare la situazione, molti importanti sistemi all'interno dell'organismo possono non
funzionare normalmente e può insorgere una malattia.
In questo contesto, è importante rendersi conto che, se le
circostanze non possono davvero essere tenute sotto controllo, o anche soltanto si percepisce questa impossibilità, i
risultati possono essere gli stessi. Quale entità di stress un
essere umano sia in grado di controllare senza essere in difficoltà varia considerevolmente, come avviene nei topi.
Prima di passare a parlare degli studi e delle osservazioni
fatte sulle interazioni tra mente umana e sistema immunitario, dovremmo ricercare i possibili modi in cui si realizza
l'interdipendenza dei sistemi nervoso, endocrino e immunitario. Se la sensazione gustativa può passare dai nervi della
lingua al centro cerebrale del gusto e quindi avvia gli effetti
che bloccano i linfociti B nella milza, impedendo loro di
produrre anticorpi, allora devono esservi connessioni tra
cervello e linfociti.
Siamo tutti abituati a pensare al cervello che invia messaggi lungo i fasci nervosi riuniti nel midollo spinale; questi
376
si ramificano poi tra una vertebra e l'altra in nervi che
escono dalla colonna vertebrale e raggiungono muscoli, vasi sanguigni e altre partì del corpo, collegandoli così fisicamente al quartier generale (il cervello). È possibile seguire
questi messaggi dall'origine al momento in cui sono recepiti.
Lungo vie analoghe, corrono naturalmente altri messaggi in senso opposto, che andranno a dire al cervello che
l'effetto desiderato ha avuto, o non ha avuto, luogo. Se
proprio adesso muovete un dito del piede, vuol dire che
avete mandato un messaggio a incredibile velocità dal cervello ai muscoli del piede per far muovere quel dito. Di rimando, parte un messaggio dal piede al cervello e avrete,
così, la consapevolezza di aver realmente mosso il dito.
Questo metodo, tuttavia, non è valido per connettere il
sistema immunitario al cervello, dato che - come abbiamo
visto quando lo abbiamo descritto - esso è costituito da insiemi di cellule che pattugliano tutto il corpo e che certamente non danzano alle estremità dei nervi, come se fossero burattini attaccati a un filo.
Il cervello si compone di numerose sottosezioni, che controllano funzioni specifiche. Per esempio, l'olfatto, la parola, la visione e l'udito sono tutti controllati da differenti
aree cerebrali. Questo è il motivo per cui un individuo che
abbia avuto un ictus cerebrale (abbia cioè subito un danno
in qualche parte del cervello per un arresto della sua irrorazione sanguigna) può perdere, ad esempio, la capacità di
parlare mentre è ancora in grado di capire la parola scritta
e parlata.
Gli scienziati che stanno cercando di localizzare su una
mappa le funzioni specifiche di varie aree geografiche del
cervello sono oggi in grado di introdurre un piccolo elettrodo in certe parti di quest'organo, servendosi di un ago
estremamente sottile. Attraverso questo elettrodo essi potranno così inviare messaggi sotto forma di impulsi elettrici, che stimoleranno un gruppo di neuroni. Dagli effetti
periferici si potrà risalire alla loro funzione. Lo stesso prin377
cipio vale se al posto della stimolazione si utilizza la distruzione.
Gli studi su parti del cervello umano possono essere così
specifici che, per esempio, la stimolazione di una data area
evocherà sempre lo stesso contenuto di memoria: in questo
modo si è chiaramente localizzato un circuito di memoria
specifico.
Utilizzando queste e altre tecniche, gli scienziati hanno
studiato aree cerebrali che possono influire sulle prestazioni
del sistema immunitario. Si è già appreso molto a questo
proposito. Sappiamo, per esempio, che il timo che è localizzato nel collo e che, come ricorderete, è l'«anima» del sistema immunitario, è connesso strettamente al tronco cerebrale. La presenza di questa connessione indica che messaggi
possono essere trasmessi dal cervello al timo e viceversa.
Non si sa ancora di quale tipo di segnali si tratti, ma sicuramente esistono. I ricercatori stanno compiendo numerosi
progressi in questo importante settore.
Nell'encefalo vi è una piccola ghiandola, l'epifisi o ghiandola pineale, che è molto importante nel regolare i ritmi circadiani, come ad esempio il sonno. Un danno a suo carico
invalida la capacità dei linfociti T immunoregolatori di
svolgere il loro compito in un modo che è ancora poco compreso.
Anche un danno all'ipotalamo, che ha un'importanza così fondamentale per avviare le risposte ormonali, invalida
molti aspetti della funzione immunitaria, inibendo la capacità dei linfociti di circolare e di regolare la loro attività.
Inoltre, quando l'ipotalamo viene leso, quelle cellule «spazzine» non specifiche, che rastrellano i detriti immunologici
(batteri morti e via dicendo), non possono eseguire normalmente il loro compito a causa di alcuni meccanismi ancora
sconosciuti. Se si danneggia il lato sinistro del cervello, ma
non il lato destro, si altererà l'attività naturale delle cellule
assassine.
Per riassumere, sappiamo oggi che il cervello possiede
numerosi circuiti che sono in qualche modo legati al cuore
378
del sistema immunitario. Ci rimane, ora, il problema di sapere come avvenga una simile interazione. Per scoprirlo, gli
scienziati hanno cominciato a cercare prove in favore del
fatto che la mente, che ha la capacità di controllare la liberazione di ormoni, utilizzi questi ormoni, o un altro insieme
di sostanze chimiche, per inviare messaggi alle cellule del sistema immunitario.
Perché ciò sia possibile, avremmo bisogno di dimostrare
che la parete del linfocito, cioè la sua membrana esterna,
sia dotata dei recettori adatti per ricevere questi messaggi
chimici. Per esempio, non c'è alcuna utilità nell'avere una
grande quantità di adrenalina che giunge alla superficie del
linfocito se poi questo non può interagire.
Come avete senza dubbio immaginato, la superficie dei
linfociti è irta di antenne capaci di legare i vari ormoni e
composti chimici. Vi sono recettori per l'insulina, per gli
steroidi, per l'adrenalina e per tutta una schiera di potenti
sostanze. Ma i linfociti e altre cellule del sistema immunitario secernono a loro volta e, pertanto, potrebbero inviare
messaggi di ritorno al cervello, se il cervello avesse neuroni
in grado di leggere questi segnali (naturalmente li ha). La
scienza della psiconeuroendocrinoimmunologia è dunque
già tra noi.
Questa estensione del concetto che il pericolo, tra le altre
cose, provochi non soltanto interazioni neuroendocrine, ma
anche reazioni immunologiche neuroendocrine avrebbe,
senza dubbio, fatto la gioia di Darwin, che si preoccupava
così tanto della difesa dell'uomo. In essa vi sono, però, alcuni potenziali trabocchetti per la specie umana.
Ho il sospetto che da secoli i medici abbiano osservato
il «fenomeno dello spirito combattivo» e certamente molti
sarebbero concordi nel dire che i pazienti depressi hanno
più probabilità di essere frequentemente colpiti da infezioni. Ma sospettare e dimostrare sono due cose ben diverse.
I pazienti depressi potrebbero avere ancora più problemi
con le infezioni se la depressione agisse anche sul sistema
immunitario. Potrebbero però esservi anche spiegazioni
379
più semplici. Le persone depresse non mangiano come
quelle normali e anche il loro standard di igiene personale
può essere deteriorato, quindi questi due fattori possono
svolgere un ruolo importante nel determinare problemi di
salute.
Abbiamo oggi la certezza che, negli esseri umani, la depressione è associata a una repressione delle funzioni immunologiche. Qui ci imbattiamo nelle difficoltà che affliggono
questo tipo di ricerca: misurare in termini obiettivi un grado di depressione è molto più difficile che documentare una
diminuzione percentuale specifica della funzione dei linfociti T. Per questa ragione è forse più facile per gli scienziati
interessati alla questione studiare gli estremi emotivi per verificare se si trovano sulla pista giusta.
Forse l'emozione più potente provata dall'uomo è quel
dolore che segue a una privazione, la tristezza opprimente
derivata dalla perdita di una persona cara. Per il suo stesso
carattere, questo tipo di emozione non è di breve durata e,
pertanto, è presumibile possa indurre cambiamenti ormonali e/o immunologici. Ci si può aspettare che si verifichino
anche effetti significativi sotto il profilo clinico. Naturalmente, il panico come emozione può essere ancora più intenso della perdita di una persona cara, ma è così di breve
durata (farcela o non farcela) che può non esservi tempo
sufficiente perché abbia luogo un qualsiasi cambiamento significativo.
Anche quando si studia qualcosa di tanto forte quanto
può essere una privazione, si deve ricordare che, mentre
tutte le specie intelligenti che hanno sentimenti sono soggette a emozioni associate a quella privazione, negli esseri
umani, e probabilmente negli animali, c'è una variazione
nell'intensità di questa che è di natura sia culturale che individuale. La maggior parte delle persone rimane più o meno
sconvolta per quattro-sei settimane dopo la perdita della
persona beneamata: poi raccoglie i cocci della propria esistenza e ricomincia a marciare. Altri individui impiegano
mesi o anni per riemergere dagli abissi della loro depressio380
ne, con risultati disastrosi per la loro vita sociale e lavorativa.
Gli psicologi, naturalmente, non possono specificare un
tempo esatto di risposta normale al dolore, ma nell'analisi
del singolo caso possono decidere che, sì, la sofferenza della tal persona è al disopra del normale: essa è, allora, qualcosa di patologico.
Non tratteremo qui di tali situazioni. Quello che cercheremo di stabilire saranno gli effetti che la privazione solitamente ha sul sistema immunitario di individui per il resto
sani. Cercheremo cioè il tipo di emozioni che si possono vedere in un uomo affranto, per quattro-sei settimane, dal
dolore per la morte della moglie e che soffrirà per un periodo di mesi di una forma episodica di depressione in quanto
si trova a dover affrontare la vita da solo.
Le analisi statistiche sui valori del tasso di mortalità ci dicono che gli uomini, a qualunque età, quando perdono la
moglie hanno una probabilità quattordici volte superiore di
morire nell'arco dei successivi dodici mesi di quelli che non
sono stati colpiti da una simile perdita. Che cosa succede loro? Cercano di lavare il tostapane elettrico quando è ancora
inserito nella presa di corrente? Cadono e battono la testa
nell'area di parcheggio di un supermercato, dopo una nevicata? Non sappiamo. Le cifre che ho citato sono semplicemente dati statistici sui quali oggi si sta attentamente indagando.
Alcuni studi recenti riportano che le donne hanno una
probabilità di morire l'anno dopo la morte dei loro mariti
che è tre volte inferiore a quella che avrebbero se i loro uomini rimanessero in vita. Gli psicologi sostengono che le
donne, a livello sia conscio che inconscio, si aspettano perlopiù che i loro mariti muoiano per primi e, se di fatto questo succede, sono preparate, condizionate da anni.
Gli uomini, invece, non pensano che le loro mogli possano morire prima e, quindi, lo choc è ben peggiore, specialmente se rimangono con figli giovani da allevare. Alcuni
studi hanno dimostrato che la repressione del sistema im381
munitario dopo la perdita della moglie è direttamente proporzionale alle preoccupazioni provate nell'allevare i bambini rimasti senza la mamma.
La maggior parte degli studi che fanno parte di questo
scenario sono ricerche in retrospettiva, il che introduce nuovi problemi. Nessuno sa realmente se una persona, immunodepressa dopo una grave perdita, non abbia per caso sviluppato i suoi problemi attuali perché, già prima del lutto,
il suo sistema immunitario non era normale. In secondo
luogo, i dettagli storici, che sono spesso lacunosi, potrebbero essere sbagliati. Pertanto, sono necessarie analisi più approfondite, che in effetti sono già in corso.
Alcuni problemi connessi con gli studi di cui stiamo parlando possono essere superati analizzando la depressione
negli animali. Si può indurre sperimentalmente una privazione negli animali e studiarne gli effetti. Un modello che
ha ricevuto moltissima attenzione crea una perdita e quindi
corregge la situazione, permettendoci così di osservare non
soltanto l'effetto della privazione sul sistema immunitario,
ma anche i meccanismi di riparazione nei confronti del danno che è stato provocato.
Le scimmie sono animali con un buon grado di emotività
e da tempo è noto che subiscono cambiamenti fisici quando
vengono deprivati di qualcuno. Esperimenti, che sembrano
crudeli (e lo sono), ma di importanza vitale, analizzano la
deprivazione materna tra le scimmie. I piccoli sono sottratti
alle madri naturali in tenera età e l'effetto di questa separazione viene studiato sia sulle madri che sui figli.
Si possono stabilire varie condizioni. I piccoli sono talvolta ceduti ad altre madri, alle quali possono o no essere
stati a loro volta sottratti i piccoli, dimodoché ricevono pur
sempre un certo numero di cure materne, anche se forse
non si tratta proprio di quelle appropriate. In alternativa, i
piccoli possono essere totalmente curati da esseri umani.
Dopo un periodo di studio sui piccoli privati delle madri, i
piccoli sono riuniti alle madri naturali e si misurano gli effetti di questo evento emotivo.
382
Alcuni studi hanno dimostrato che scimmie private delle
madri sono agitate per un periodo di due settimane e quindi
diventano depresse; questo stato di depressione può essere
dedotto dall'alterazione del ritmo del sonno e da un'attività
motoria molto ridotta. Sia la madre che il figlio soffrono di
un deterioramento molto significativo nella funzione dei
linfociti T. Madri e figli che vengono riuniti fisicamente ricuperano molto in fretta e, guardando i dati, si ha poca difficoltà a individuare quali figli siano stati restituiti alle loro
madri naturali e quali no.
Come probabilmente è intuibile, qualcosa come una
grande tristezza può causare la liberazione simultanea di
molti ormoni, ma non ne consegue necessariamente che tutti gli ormoni liberati debbano influire sul sistema immunitario. Scienziati del Mt Sinai Hospital di New York si stanno
impegnando in ricerche di questo tipo con l'aiuto di genitori di prim'ordine.
Anche se il lettore non è un genitore, sono sicuro che può
capire l'amarezza particolarmente pungente che si associa
al fatto di sapere che si sta perdendo un figlio.
Come medico, per più di vent'anni ho costantemente osservato che gran parte della gente muore con un grado di
rassegnazione che garantisce loro un trapasso dignitoso ed
evidenzia quell'umanità nascosta in ognuno di noi che ci
aiuta a sopportare questo ineluttabile evento. I bambini certamente non fanno eccezione, anche se inquadrano la morte
nei limiti del loro sviluppo intellettuale.
Dopo aver spiegato la natura e l'importanza della loro ricerca ai genitori che stavano per perdere il figlio, questi medici li invitavano a collaborare con loro, chiedendo di farsi
prelevare campioni di sangue prima, durante e dopo l'incontro quasi finale con il loro bambino morente, perché
questi campioni potessero essere costantemente sottoposti a
monitoraggio. Un sottile catetere di plastica veniva introdotto loro in una vena del braccio, in modo che il sangue
potesse essere prelevato a volontà; inoltre elettrodi poco visibili venivano applicati allo scalpo per poter registrare le
383
onde cerebrali. Da questo tipo di ricerca è possibile ricavare
alcuni indizi su come sostanze presenti nel cervello e nel
corpo interagiscano con il sistema immunitario.
Mentre stiamo esaminando le connessioni tra cervello e
sistema immunitario, non dobbiamo trascurare un insieme
di interazioni importante, ma finora poco compreso, che riguarda il mancinismo. Infatti a tale situazione sono associate peculiarità mediche e fisiche.
In primo luogo, il lato buono. Tra i veri mancini (escludendo quindi gli ambidestri) vi è un numero sproporzionatamente elevato di persone che, a causa della loro maggior
capacità di concepire lo spazio, riescono molto bene nello
sport, nell'arte e in architettura. Inoltre, si nota nei mancini
veri una totale assenza di una malattia mentale comune, la
schizofrenia.
Ma non tutti i lati sono buoni. I mancini hanno dodici
volte più incapacità di apprendimento di chi usa la mano
destra e, tra loro, sono comuni la balbuzie e l'autismo.
Mentre non soffrono di schizofrenia, sembra che siano più
portati a soffrire di psicosi maniaco-depressive, una grave
sindrome che si manifesta come la più tetra delle depressioni alternantesi con un comportamento maniacale. Vi è una
componente illusoria nella malattia e pertanto il paziente,
nella fase maniacale, per esempio può sentirsi molto ricco e
correre per la città a comprare per migliaia di dollari oggetti
di cui non ha bisogno e che certamente non può permettersi.
Nel nostro contesto, invece, interessa l'associazione tra
mancinismo e la precoce comparsa di allergie nell'infanzia,
oppure tra mancinismo e numerose malattie autoimmuni
come la colite ulcerativa, la miastenia grave e il morbo celiaco.
Perché io non sia tempestato da lettere che esordiscono
così: «Sono mancino ma non sono mai stato balbuziente in
vita mia», sottolineo che la maggior parte dei mancini non
ha alcuno di questi problemi (conosco anche una grande
quantità di pessimi tennisti mancini). È chiaro che il manci384
nismo, di per sé, non è la causa di questi problemi, anche se
può essere frequentemente associato ad altre anomalie che
li causano.
Quando, nell'embrione, si sviluppa il cervello, sembra
che alcuni suoi settori dipendano per la crescita normale
dalla presenza di una maggiore o minore quantità di testosterone, l'ormone sessuale maschile. Se c'è troppo poco testosterone, allora un settore del cervello noto come planum
temporale si sviluppa eccessivamente sul lato destro e l'individuo che deriverà da quell'embrione sarà mancino.
Come è già stato riferito nel capitolo sulle malattie autoimmuni, questo tipo di problemi è molto più comune tra
le donne che non tra gli uomini e può darsi benissimo che
uno squilibrio nella concentrazione degli ormoni sessuali
durante lo sviluppo fetale provochi non soltanto il mancinismo, ma anche lo sviluppo di connessioni non proprio perfette tra il sistema nervoso centrale e il sistema immunitario. Questo può sfociare nella perdita di certi controlli regolatori, che normalmente impediscono alla autoimmunità di
instaurarsi.
Riassumendo fino a questo punto, possiamo constatare
che le difese immunologiche dell'uomo sono nelle mani dei
linfociti, cellule che possono essere influenzate dal sistema
nervoso centrale o direttamente, per esempio per innervazione nervosa del timo, o indirettamente da ormoni controllati dal cervello. I linfociti possono anche inviare messaggi
al cervello, pertanto è indubbio che si tratti di una via a due
sensi. La possibilità di un condizionamento mentale che potrebbe rafforzare i nostri meccanismi di difesa è ovviamente
un settore d'indagine stimolante, come lo è la possibilità
che sensazioni, come la depressione, generate da centri superiori, danneggino il sistema immunitario di qualcuno.
Prendiamo in considerazione entrambe le idee, ma cominciamo dalla seconda.
Immaginiamo di visitare la West Point Military Academy, nello Stato di New York, in un qualsiasi anno. Diamo un'occhiata ai giovani aspiranti ufficiali, che si sono
385
ammalati di febbre ghiandolare. Il nome esatto di questa
malattia, come abbiamo già detto, è mononucleosi infettiva. Si tratta di una penosa malattia, molto infettiva.
In un luogo come West Point è sufficiente che una o due
reclute entrino già con la malattia, dopo essere state infettate dal virus, ed ecco che l'intera accademia è in difficoltà.
Data l'esistenza di dormitori non è difficile per il virus diffondersi; ne risulta, pertanto, una miniepidemia.
Uno degli aspetti interessanti della mononucleosi infettiva è che non tutti coloro che sono stati infettati dal virus
che provoca la malattia soffrono del medesimo destino. Alcuni sono colpiti da una specie di influenza in forma molto
blanda, mentre altri possono restare confinati a letto per sei
mesi o più, se non muoiono addirittura per complicazioni.
In alcune persone, in Africa, il virus può innescare un tumore maligno del sistema immunitario, mentre in Asia può
dare origine a una crescita neoplastica nella parte posteriore
del naso e della gola. Un buon sistema immunitario è certamente necessario per far fronte a questo virus, che per alcuni aspetti è molto affine al virus dell'AIDS.
Il virus di Epstein-Barr appartiene a una famiglia diversa
da quella del retrovirus che provoca l'AIDS, ma la mononucleosi dà luogo a un'infezione che colpisce i linfociti, in
questo caso i linfociti B e non i linfociti T come nell'AIDS.
Ci rimane dunque il compito ingrato di uccidere questi linfociti B infetti e la lunghezza e gravità della malattia dipendono dal tempo che impiegano i linfociti T ad eseguire questo compito. Il fatto è che l'infezione da virus di EpsteinBarr è una grande sfida per il sistema immunitario.
Che cosa risulterebbe se si analizzassero i dati della malattia clinica e della risposta immunitaria al virus, e se si
correlassero questi dati a certi aspetti psicosociali significativi in un luogo come West Point?
Questa accademia per giovani ufficiali è colma di cadetti
i cui padri erano o essi stessi graduati o ufficiali nelle forze
armate. Sembra, a un esame attento, che molti giovani studenti siano lì soltanto perché i loro padri vogliono così. In
386
simili circostanze, molti vi trascorrono un periodo miserevole associato ad uno scarso rendimento scolastico.
Alcuni studi hanno dimostrato una netta separazione tra
coloro che danno un'ottima risposta immunologica al virus, una volta che sono stati infettati, e coloro che rispondono meno bene. Quegli studenti di West Point che non
erano contenti e che soffrivano di un notevole stress perché
avevano dubbi sulla scelta della carriera, mostravano un
maggior numero di sintomi e la loro risposta immunologica
alla malattia era scadente. Esisteva una correlazione ugualmente stretta tra il fatto di essere soddisfatti dell'istituzione
e una buona risposta all'agente infettivo.
Posso proporvi molti altri esempi, ma due basteranno.
Ricorderete che abbiamo già parlato delle cellule assassine
naturali. Si tratta di cellule che attaccano spontaneamente
le cellule maligne che possono comparire nell'organismo e
distruggerle.
La loro azione è quasi immediata e non sembra esservi alcuna ragione di pensare che queste cellule non svolgano un
ruolo importante giorno per giorno nel proteggerci dalla
comparsa di neoplasie. L'espletamento di tale ruolo dipende dalla presenza all'interno dell'organismo di una sostanza
naturale, l'interferon.
Sappiamo da tempo che numerose sostanze potenzialmente cancerogene deprimono l'attività delle cellule assassine naturali e questa attività depressa si associa a un maggior
rischio di contrarre il cancro. Più di recente, abbiamo appreso che la prestazione di tali cellule è influenzata in modo
molto marcato dallo stress. Quando esse vengono attivate
dall'interferon, diventano linfociti un po' più grossi del
normale, con un aspetto granuloso che li rende facilmente
riconoscibili. Di recente numerosi scienziati che si occupano
di immunologia comportamentale hanno cominciato a
chiamarli «linfociti da stress».
Sono stati compiuti studi anche su studenti di medicina
della Johns Hopkins University sotto stress da esami. È
emerso senza ombra di dubbio che quei candidati che erano
387
meno preparati, e che quindi conseguivano risultati poco
brillanti, erano in uno stato di profondo stress. Stress e
cattiva resa si correlavano molto bene con un'attività depressa delle cellule assassine naturali. Questo genere di indagini è particolarmente interessante, perché suggerisce ancora una volta che la natura dell'evento stressante e la capacità di un individuo di far fronte a tale situazione evidenziano la risposta più o meno adeguata del sistema immunitario.
Un ultimo esempio che ci conferma questo stato di cose
viene da studenti in odontoiatria in periodo di esami. È
stato verificato che quegli studenti sottoposti a una grave
forma di stress, in quanto poco preparati agli esami, riuscivano male, come era prevedibile. Soffrivano anche con
maggiore frequenza di infezioni alle vie respiratorie superiori. Nessuno di questi effetti, naturalmente, venne notato
in quegli studenti che stavano bene e che erano ben preparati per gli esami.
Ciò che apparve tanto affascinante a quegli osservatori
fu il fatto che l'immunoglobulina A secretoria, cioè quella
specifica immunoglobulina che protegge le nostre mucose e
pertanto le vie respiratorie superiori, era repressa in quegli
studenti che, all'epoca degli esami, apparivano notevolmente stressati. Si può certamente prospettare che la soppressione di questa forma di risposta anticorpale lasci gli
individui vulnerabili alle infezioni del tratto respiratorio
superiore.
Poco sopra ho accennato al fatto che, a parte gli effetti
potenzialmente dannosi dello stress sul sistema immunitario che i clinici dovranno affrontare in futuro, era anche
necessario contemplare la possibilità di migliorare con il
condizionamento le risposte immunitarie. Di recente sono
stati riportati alcuni risultati molto incoraggianti.
Se ricordate il nostro piccolo topo che prendeva solo la
saccarina e si dimostrava in grado di influenzare il sistema
immunitario, allora potete capire per quale motivo i clinici
desiderino utilizzare metodi di condizionamento per mi388
gliorare la risposta immunitaria di una persona contro una
qualche forma di cancro.
Alcuni scienziati negli Stati Uniti hanno utilizzato questo
procedimento su un gruppo di medici, ammalati di tumore.
Essi erano i candidati ideali per una simile forma di sperimentazione, dato che avevano scelto di non ricevere, per la
loro malattia, alcun trattamento convenzionale. Mi si lasci
subito dire che non si trattava affatto di un gruppo di medici contrari all'establishment, alla ricerca per la loro forma
tumorale di terapie di medicina alternativa; al contrario. Si
trattava piuttosto di medici che, a causa della loro lunga
esperienza professionale, sapevano che il cancro di cui soffrivano lasciava loro al massimo ancora alcuni mesi di vita,
se si fossero sottoposti a chemioterapia. Nella loro mente,
la soppressione del cancro in qualsiasi forma sarebbe stata
più che controbilanciata dalla perdita della qualità della vita, provocata dagli effetti secondari dei farmaci che essi
avrebbero dovuto prendere. Per questi medici la possibilità
di partecipare agli esercizi di condizionamento era estremamente allettante.
Essi vennero anzitutto istruiti sul sistema immunitario,
dato che molti di loro certamente non erano al corrente delle informazioni più recenti sull'immunologia riportate in
questo volume. Fu spiegato loro che possedevano cellule
immunitarie capaci di uccidere le cellule tumorali: bastava
fossero attivate a farlo. Furono loro mostrati film e diapositive in cui si vedevano cellule normali che uccidevano in
provetta cellule tumorali. Infine, fu loro chiesto di concentrarsi sull'invio di segnali dal cervello al sistema immunitario, esigendo che un'analoga perizia fosse sviluppata per la
lotta contro il loro cancro.
Quei medici avevano effettuato studi di immunologia prima dell'inizio degli esperimenti di condizionamento e, tra
gli studi compiuti sulla funzione immunitaria, vi erano
quelli per analizzare la loro capacità di uccidere le cellule
tumorali. Inutile dire che essi vennero ripetuti durante e dopo la terapia di condizionamento.
389
Mentre è troppo presto per determinare se questi particolari medici abbiano avuto la vita prolungata in misura significativa dagli esperimenti di condizionamento (i risultati definitivi non sono stati ancora riportati nella letteratura), i
resoconti preliminari hanno dimostrato chiaramente che essi erano in grado di aumentare il potere combattivo del loro
sistema immunitario.
Un collaudo più esteso per questo tipo di ricerca è in corso al M.D. Anderson Cancer Center, nel Texas. Anche qui,
non c'è nulla di definitivo, ma le impressioni iniziali dei ricercatori sono state molto favorevoli. In questo studio,
sembra vi sia una correlazione tra una maggiore attività
contro le cellule tumorali e un tempo di sopravvivenza più
lungo del previsto.
Vengono riportati anche numerosi altri pezzi del gioco di
pazienza psicoimmunologico, che richiedono di essere ulteriormente analizzati. Vi è perlomeno un'incidenza due volte
superiore del cancro tra gli esseri umani da lungo tempo
sofferenti di depressione in seguito a una perdita o a una separazione. Vi è un particolare rischio, per esempio, che gli
uomini in questa situazione sviluppino un carcinoma ai testicoli. L'artrite reumatoide giovanile, cioè un attacco immunologico alle articolazioni dei bambini, è molto più comune tra bambini adottati e tra quelli che hanno sofferto
per un divorzio traumatico dei genitori.
Altri ricercatori hanno riferito che bambini cresciuti in
una famiglia dove è facile avvertire una mancanza di intimità e affetto corrono un rischio molto maggiore di contrarre
il cancro in età più avanzata. I bambini autistici, che sembrano essersi ritirati dal mondo, hanno chiaramente linfociti T con funzione depressa. Possiamo continuare all'infinito, ma ritengo che questa rassegna vi abbia fatto intendere
qual è l'essenza di uno dei settori più stimolanti della medicina moderna.
Nel concludere, dobbiamo sottolineare che, pur essendovi una voluminosa letteratura sull'argomento, vi sono pochi
studi scientifici realmente validi, realizzati con tutte le ga390
ranzie che scienziati di prim'ordine esigerebbero. Questi
studi sono in corso e sembra che vi siano pochi dubbi che,
nei prossimi anni, disporremo di informazioni di grande valore.
Nel frattempo, è bene, probabilmente, per tutti noi pensare con attenzione alle sagge parole del cardiologo americano Robert Elliot. Nell'occuparsi delle personalità di tipo
A (che l'ansia e il ritmo di vita possono portare a un precoce attacco cardiaco), egli pensò due regole utili. La Regola 1
era: «Non prendetevela per una piccola cosa». Un ottimo
consiglio. Ma la Regola 2 è ancora più utile. Essa afferma:
«Tutto è piccola cosa».
Certamente possiamo estendere i concetti importanti nel
controllo delle malattie cardiache al controllo di quelle malattie che sono associate al funzionamento anormale dei sistemi immunitario e endocrino. Concluderemo, dunque,
l'argomento con alcune riflessioni famose sull'immunologia comportamentale, fatte da quel ben noto osservatore
della tragicommedia umana che è Woody Allen. Esprimendo tutto il suo buonsenso nel film Manhattan, egli dice queste poche parole, che dimostrano chiaramente la sua conoscenza della psiconeuroimmunologia.
«Bene, non mi arrabbio. O.K.
Voglio dire, ho una tendenza a interiorizzare.
Non riesco a esprimere rabbia.
Questo è uno dei problemi che ho.
Al contrario, io... io ho un tumore.»
391
Indice analitico
ABO, sistema, 121
Aborto, spontaneo, 97-98,
103,107, 108
Acari, 258, 259
Acetilcolina, 299
Acne, 9
Adelaide, 313
Adenoidi, 77
Adrenalina, 366, 367, 379
ghiandole dell' (surrenali),
367
Africa, 13, 14, 49, 51, 53,
115, 168, 173, 189, 192,
194-196, 208, 209, 223,
224, 231,244, 339, 386
Afta epizootica, 32
Agnello, 263
AIDS, 14, 35, 76, 126, 146,
187-245, 386
test per gli anticorpi, 225230
test per l'antigene, 230-233
Albumina, 250
Alcool, 147, 150, 153,284
Allen, Woody, 391
Allergeni, 262
Allergie, 15,86,249-282, 346
e cancro, 257
Ambrosia, allergia da, 359
American Cancer Society,
173
American Medicai Association, 264
Amianto, 166-167
Amin, Idi, 193
Amsterdam, 240
Anderson, M.D. Cancer Center, 390
Anemia, 51,53, 188,220, 257
Anemia perniciosa, 67, 300
Anfetamina, 239-241
Angola, 189,195
Anidride carbonica, 273
Ano, 46, 197, 201, 202, 233234, 236, 237
Anofele, zanzara, 50
Antibiotici, 20, 40-42, 57,
119, 132, 143,304
Anti-anticorpi, 357-358
Anticorpi, 21, 80-92, 110,
132, 249
Anticorpi antidiotipici, 359
Antigene, 24, 62-63, 68, 83,
110, 119; vedi anche Sé
Api, veleno delle, 279
Aquino, Tommaso d', 240
Argentina, 52
Artrite, 15, 268
393
Artrite reumatoide, 67, 107,
292, 302, 346, 353, 356,
363
giovanile, 390
Ascaride, 49, 55, 56
Ascesso, 38, 143
Asia, 53, 224, 231,244,386
Asma, 253, 257, 272-277,
280,351,359
Aspirina, 266-268, 354
Atlanta, 190
Atomiche, bombe, 164
Atopia, 257-258
Australia, 239, 244, 313, 344
Autismo, 384, 390
Autoanticorpi, 372
Autoimmuni, malattie, 107,
108, 110, 285, 292, 296,
324, 346, 364, 384
Autoimmunità, 66-67, 283302, 385
AZT (Azatioprina), 241-242,
352
B linfociti, 78, 80-93, 116,
123, 126, 128, 130, 157,
182-184, 260, 288, 305,
319, 322, 354
B cellule, vedi B linfociti
Bacilli, 40
Balbuzie, 384
Bamako, 13
Bambini, prematuri, 91
Barnum, circo, 25
Basofili, 351
Batteri, 23, 30, 33, 35-44, 45,
48,57,81,89, 143
Beethoven, Ludwig van, 88
Belgio, 195
Benzina, 113, 115
Bilharzia, 49
394
Boehringer Ingelheim, 6
Botulismo, 342
Bronchiale, albero, 138, 140,
142, 143, 253, 272, 274,
277
Bronchite, 138, 153
Broncospasmo, 267, 274-277,
364
Brooklyn, 215
Burnett, Macfarlane, 356,
357
Burroughs Wellcome, 241
CD4, proteina, 211
Calcio, 300
California, 127
Cancro, 23-24, 31, 93, 137186, 346, 347, 389
cura del, 176-186,389
immunologia del, 157-165
Candida albicans, 45, 46
Cani, 193, 335-338
Capo Verde, 194
Capside, 32
Caraibi, 195
Carbonio, monossido di, 156
Carcinogèni, vedi Oncogèni
Carcinoma
del collo dell'utero, 160,
171-174
intestinale, 156, 161, 167171, 181, 186
mammario, 23, 152, 160,
163-165
polmonare, 138, 156, 165167
Cardiologia, 143
Castro, 195
Cataratta, 289
Catatonia, 270
Catrame, 153, 156
Cavie, 250, 251,373
Complemento, sistema del,
C.D.C. (Centre for Diseases
88-89
Control), 190, 191, 237, Computer, 212, 322
Concepimento, 99-103
340
Condizionamento, 370-376
Cellula, 23-29
Condom, 237-239; vedi anche
crescita della, 139-142
Profilattici
differenziazione della, 139Coniglio, 373
142
divisione della, 26, 140, Connecticut, 200, 202, 215
Contraccettiva, pillola, 173
150-152
Convulsioni, 35, 40
Killer, 92, 159
Cornea,
35, 127
Killer naturali, 93, 159, 387
staminali (multipotenti), Corticosteroidi, 352
Cortisone, 111, 202, 350,
63-64, 84
351, 367
Cercopitechi verdi, 194
diphtheCerebrale, corteccia, 39, 298, Corynebacterium
riae, 343
366
Cosma e Damiano, santi, 124
Chemioterapia, 142, 165, 178
Coxsackie, virus, 294, 318,
Chlamidia, 197
319, 321
Ciclofosfammide, 352, 354,
Crescita,
ormone della, 44
355, 371-373
Croce Rossa, 126, 243
Ciclosporina, 127, 352, 355
Cromosomi, 28, 29, 117-118,
Cile, 52
177, 292
Cimici, 52-53
Cuore, 36, 39, 52, 78, 104,
Cimurro, 193, 339
121, 127
Cina, 12
malattie del, 154, 155, 362
Cioccolato, 253
Cytomegalovirus, 197
Clonale, aborto, 285
Clonazione, 27, 374
Dakar, 47, 171,335
Clorambucile, 185
Darwin, Charles, 364, 365,
Clostridium tetani, 344
368, 379
Coagulazione, 114
Decalcificazione, 352
Coca-Cola, 47
Delezione clonale, 129
Colera, 38
Denutrizione, 348-349
Colesterolo, 147, 169
Deprivazione, vedi PrivaColite ulcerativa, 170, 384
zione
Collo dell'utero, 97
Desensibilizzazione, 277-280
Colonscopia, 161
Desossiribonucleico, acido,
Colostomia, 168
vedi DNA
Colostro, 91,92
Detroit, 20
395
Diabete, 67, 133, 288, 292,
296, 298,319, 345,363
Diarrea, 38, 53, 171, 188, 197
Difillobotriasi, 55
Difterite, 86, 342, 344
Divorzio, 390
DNA, 28,31, 152,241,322
Dolore, 380-381
Donatori, d'organi, 122
DPT, vaccino polivalente,
343
Durban (Sud-Africa), 312
ECHO, virus, 318
Eczemi, 14
Egitto, piramidi, 329
Ehrlich, Paul, 72, 73
Eiaculazione, 233
Elliott, Robert, 391
Elminti, 49
Elmintiasi, 53
Emofilia, 217-220
Emofiliaci, 214, 231, 235, 239
Emoglobina, 347
Encefalite, 345
Encefalomielite mialgica,
310,313
Enfisema, 154
Enterovirus, 318
Enzimi, 69
Epatite A, 125, 126, 342
Epatite B, 31, 126, 157, 197,
198,215
Epatite, non-A non-B, 126
Epifisi, 378
Epinefrina, 367; vedi anche
Adrenalina
E p s t e i n - B a r r , virus di,
(EBV), 305, 306, 310, 319,
386
396
Eritrocita, 50; vedi anche
Globuli rossi
Eroina, 36, 214
Estrogeni, 164, 295
Eterosessuale, AIDS, 233-237
Europa, 53 194-196,239
Fabrizio, 83
borsa di, 83, 84
Falloppio, tube di, 99, 101,
367
Fatica cronica, sindrome da,
303-331
Fatica postinfettiva, sindrome da, 310-311,317
Fattore intrinseco, 300
Fattore VIII, 217-219
Fattori di coagulazione, 217
Fecondazione, 101
artificiale, 354
Fegato, 32, 63, 64, 84, 104,
121, 125, 126, 128, 179180, 301,355
Ferro, 350
Feto, 35, 63, 84, 105, 106,
110, 172, 341
Fibre, alimentari, 168
Filariasi, 48
Filippine, 244
Finlandia, 225
Flebotomi, 53
Florida, 226
Fluoruri, 169
Flussometro, 276
Folico, acido, 350
Freud, Sigmund, 272
Fumo passivo, 153, 155
Fumo, e sigarette, 153-156,
166
Funghi, 44-46, 48, 81, 197,
198
Fuoco di Sant'Antonio, 322
Gallo, Robert, 194
Gamberi, 252
Gammaglobuline, 83-92
Gatti, 258
forfora dei, 278
leucemia dei, 192
Genetica, ingegneria, 43-44,
346-347, 356
Geni, 27, 28, 43, 57, 108, 117,
146, 151
e virus, 145-158
immunoregolatori, 292,
369, 370
Germania, 194, 208
Germinali, cellule, 117; vedi
anche Ovulo; Spermatozoi
Ghiandolare, febbre, vedi
Mononucleosi infettiva
Giamaica, 210, 301
Giappone, 55, 169
Ginevra, 38, 223
Glicolpolietilene, 183
Globuli bianchi, vedi Leucociti
Globuli rossi, 50, 51, 53, 66,
130, 178, 188, 273, 300,
372
Gloucester, 9
Glucagone, 293
Glutine, 281
Gonococco, 87, 99
Gonococcus, 197
Gonorrea, 87, 198
Graminacee, 263
Granulociti, 89
Grassi, 32
insaturi, 169
Gravidanza, 97-111, 127,
154, 342
Guillotin, J.-F.,302
Guinea-Bissau, 194
Haiti, 195, 196, 236
Hansen, Dr. Gerhard, 37
HBLV, 319
Herpes, 30, 33, 173, 197, 198,
201,285,294, 305,322
simplex, 173
Hiroshima, 164
HIV, 191, 193, 195, 206, 208213, 223-237, 241-246
HIV 1, 194
HIV 2, 194
HLA, 121, 123, 126, 128,
290-296; vedi anche Leucociti
HTLVI,210
HTLV II,210
HTLV III, 209-210
Hudson, fiume, 318
Ibridoma, 184
Idiotipo, 358
IgA, 88-92, 281,349,388
IgD, 86
IgE, 86, 87, 255-263, 267,
275, 277, 281
IgG, 87, 89-91, 277, 281, 324326, 342, 359
IgG1, 87
IgG2, 87
IgG3, 87, 88
IgG4, 87, 88
IgM, 85-86, 89, 281
Illinois, 19
Immunità, vedi Sistema Immunitario
Immunodeficienza, 139, 189
Immunoglobuline, 83-92; vedi anche Anticorpi
397
Immunorepressione, 128
Immunorepressivi, farmaci,
124, 351-352, 355
Immunoterapia, 181-186, 331
Indonesia, 224, 244
Infiammazione, 100-102,
105,350, 351
Influenza, 193, 216
Inghilterra, 235, 307, 313,
344; vedi anche Regno
Unito
Insulina, 44, 151, 289, 293,
308, 363
Interferon, 93, 323, 356, 387
Interleuchina, 68-70, 180181,355,356
Intestinali, cellule, 38
Invecchiamento, 140-141
Iodio radioattivo, 185
Ipersensibilità immediata,
256, 257, 262, 282
Ipofisi, 367
Ipotalamo, 367, 368
Islanda, sindrome, 310, 313
Isotopi, 185, 186, 262
Israele, 210
Istamina, 255, 256, 270, 271,
351
Isteria, 314
Istocompatibilità, 99
antigeni di, 65, 104, 119,
120, 121, 123
Jenner, Edward, 10, 11, 14
Jerne, Niels, 357
Johns Hopkins University,
387
Kala-azar, 53
Kalahari, deserto del, 51
Kaposi, M., 188
398
Kaposi, sarcoma di, 188-192,
199
K cellule, vedi Cellule Killer
Kenya, 209
KGB, 185
Kustner, 253
Latte materno, 91-92, 221,
230, 235,281
banche di, 282
Lattuga, 263
LAV, 210
Lebbra, 37, 41
Lecitina, 328
Lehningen, professor, 150
Leishmania, 53
Leishmaniosi, 48, 53
Lesbiche, 205-206, 236
Leucemia, 129-132, 178, 351,
371
Leucemia dei linfociti pelosi,
210
Leucociti, 68, 121, 129, 178,
290
Levin, Ira, 27
Linfa, 77, 78
Linfadenopatia, 210; vedi anche LAV
Linfangite, 77
Linfatici, vasi, 77, 78
Linfociti, 29, 92, 93, 99, 106,
110, 128, 130, 143, 284,
351, 385
da stress, 387
Linfonodi, 77, 78, 84, 92,
129,210, 356
Loci, genetici, 120-121
Lombrichi, 58, 76
Londra, 9, 303,309,312
Los Angeles, 190, 313
Lupi, 338
Lupus Eritematoso sistemico
(LES), 300-302, 356, 372
Macrobiotici, prodotti, 328
Macrofagi, 69, 70
Magnesio, 348
Mahler, Gustav, 58
Malaria, 48-50, 189, 190, 257
Malaysia, 224
Mali, 13
Malignità, 145
Mammografia, 164
Mancinismo, 384, 385
Manguste, 338
Manhattan, 195, 240
Marcatori proteici, 103, 108,
119, 120
Marijuana, 120
Mastcellule, 255, 256, 260,
278,351
Medio Oriente, 12
Meduse, 58
Melanoma, 174-176, 181
Membrana cellulare, 25, 28,
33,203,211,256,295
Memoria immunologica, 123,
161
Meningite, 19, 20, 87, 345
Meningococco, 87
Menopausa, 164
Messico, 49, 52
Mestruale, ciclo, 164, 173,
205,236, 266, 367
sangue, 42, 172
Metadone, 215
Metastasi, 157
Miastenia grave, 298-300, 384
Midollo osseo, 53, 69, 84,
114-132, 177, 222, 217
Mieloma multiplo, 183
Milza, 77, 125, 129, 301
Mitogèni, 151
Monociti, 88, 130
Monoclonali, anticorpi, 181,
183, 185
Mononucleosi infettiva, 157,
197, 294, 304-306, 325, 386
Montagu, Mary Wortley, lady, 12
Morbillo, 65, 66, 176, 343,
345
Morbo celiaco, 384
Mt Sinai Hospital, 383
Mucina, 89
Mucose, 81, 88, 91, 234
Murmure cardiaco, 39
Muso di tinca, 172; vedi anche Utero
Naso, 259-260, 261
Nei, 174
Nematelminti, 49
Nematode, 55
Nervi, 38, 133, 298, 299, 322,
365
Neuromiastenia epidemica,
310
Neutrofili, 115, 348, 351
Nevrosi, 303, 309, 313, 316
New Jersey, 125, 240
Newton, sir Isaac, 105
New York, 125, 145, 190,
191, 196, 198, 200, 202,
209, 215, 269, 271, 303,
306, 385
Niacina, 350
Nicotina, 153, 154, 156
Nitrito d'amile, 202, 204
Nitrosometilurea, 152
Noci, 253
Nonoxinolnina, 238
Non-sé, 22-23, 102, 128
399
Nord America, 269
Norvegia, 37
Nosocomiali, infezioni, 91
Nucleo, cellulare, 27, 117,
212
Nuova Zelanda, 271, 328
NZB (New Zealand Black),
372, 373
Obesità, 164, 347, 348
Olio di fegato di merluzzo,
328
Ombelicale, cordone, 90, 104
Omosessuali, 192, 195-245
Oncogèni, 145-151, 152, 166,
168, 174
Oncologia, 143
Orale, sesso, 235
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 13,223
Orgasmo, 99
Ormoni, 366-367, 369, 379
Oro, sali d', 354
Orticaria, 257, 262, 263, 359
Ovaia, 101, 165, 186, 300,
367
Ovulo, 101, 108, 117
Padova, 83
Paludismo, 48; vedi anche
Malaria
Pancreas, 127, 133, 289, 293,
366
cellule beta del, 289, 293295
Papanicolau, 173
Papilloma, virus, 173
PAPP, 110
Paptest, 173, 174
Parassiti, 23, 47-56, 81, 245,
319
400
Paratiroide, ghiandola, 300
Parotite, 342, 343, 345
Pasteur, Louis, Istituto, 340
Paura, 364-369
Pavlov, Ivan Petrovic, 370371
Pechino, 59
Pecora, globuli rossi di, 131132, 371,372
Pelle, 26-27, 77, 142, 174
Pene, 42,201,233,236, 237
Penicillamina, 354
Penicillina, 252
Pepys, Samuel, 341
Pertosse, 86, 342, 345
Pesce, 253
Petri, piastra di, 38, 39
Piastrine, 114, 115, 119, 217,
231, 300
Pipistrelli, 338
Pirquet, Clemens von, 249252, 257, 261, 282
Placenta, 34, 73, 90, 107,
108, 110, 112,221,341
Planum temporale, 385
Plasma, 231
Plasmacellule, 85, 86, 183,
186
Plasmodium, 50
Platelminti, 49
Pleura, 142, 143
Pleurite, 142
Plymouth Rock, gallina, 145,
149
Pneumococchi, 21, 87
Pneumococcus, 19
Pneumocystis carinii, 190,
192
Polimorfonucleate, cellule,
89, 130; vedi anche Granulociti
Poliomielite, 310, 311, 343,
345, 360
Polipi intestinali, 170
Polli, 347
Polline, 252, 258, 260, 261,
263,278
Polmonite, 20, 33, 38, 87,
100, 220
Polvere, 258, 280
Pomodori, 253, 264-265
Portogallo, 194
Prausnitz, 253
Prednisone, 350
Privazione, 15, 381
Profilattici, 237-239
Prostaglandine, 100
Prostata, ghiandola, 147
Prostitute, 171-173, 207, 209,
227,229, 231,236
Proteine, 27, 32, 45, 66, 146,
150,317,319
Protettivi, cibi, 168-170
Protozoi, 49, 190
Providence, 98
Psiconeuroendocrinoimmunologia, 179
Psicosi maniaco-depressiva,
384
Psicosomatica, malattia, 309
Pubertà, 361
Pus, 14, 38, 44
Rabbia, 337-340, 342
Radioterapia, 142, 175, 177,
356
Ragazzi venuti dal Brasile, 27
Raggi X, 164, 171, 320
Ratti, 102, 347, 376
Recettori, dei linfociti, 379
Recettori beta, 274-277
Regno Unito, 238, 318, 321
Rene, 23, 27, 104, 121-122,
124, 127, 128, 355, 372
Rete, teoria della, 357
Retrovir, 222
Retrovirus, 192, 193
Retto, 167, 168, 197, 202, 210
Reumatica, febbre, 362
Rhode Island, 98
Rhus toxicodendron, 14
Riboflavina, 350
Ricina, 185
Rigetto, 110, 116, 123, 127,
352, 355
Rinite, allergica, 259, 261,
280
Riso, 55, 263
Risonanza magnetica, 320
Risposta immunitaria primaria, 74
Ritmi circadiani, 378
RNA, 31,211
Rockefeller Institute, 145
Rolling Stones, 88
Rosolia, 73, 343, 346
Rous, Francis, 145, 149
Royal Free, malattia del, 310314
Ruanda,209
Russia, 55
Saccarina, 372, 373
Sahara, deserto del, 51
Saliva, 27
Salivarie, ghiandole, 27, 245
San Antonio, 265
San Francisco, 196, 209, 240
Sangue, 37, 38, 78, 90, 115,
119, 129, 132, 151, 216,
227, 230, 255
banca del, 218, 233, 243,
245
401
nelle feci, 167, 170
trasfusioni di, 125, 188,
214, 220, 231, 234, 244,
341
Santiago, 98
Scandinavia, 92, 238, 282
Schistosomiasi (bilharziòsi),
49, 53-54
Schistosomitidi, 54
Schizofrenia, 384
Scimmie, 382-383
Sclerosi multipla, 292, 356
Scorpioni, veleno degli, 342
Sé, 22-25, 100, 102, 128, 139,
151,284
antigeni del, 24, 64-80,
119, 181
Secrezioni sessuali, 195, 196,
203,227,229, 233,234
Selenio, 169
Selezione naturale, 57, 286
Seminale, liquido, 100, 172,
197, 201-202, 204, 205, 233
banche di, 206, 231
Senegal, 47, 48, 335
Serpenti, veleno dei, 342
Sherman, Alan, 27
Shock tossico, sindrome da,
42,43
Sibelius, 15
Siero, 81,253,342
Sieroconversione, 225
Sifilide, 197, 198
Sistema Immunitario, 22-24,
31,35,38,44,51, 139, 250,
284
e ipoalimentazione, 347350
e Sistema Nervoso Centrale, 369-391
402
organizzazione, 57-93, 286302
umorale, 82-83, 85
Soia, 281
Sole, luce del, 174, 252
Sonno, malattia del, 51-52,
190
Spermatozoi, 99, 100, 101,
103, 108, 117,355
Spirilli, 40
Squalo, 86
Stafilococchi, 43
Stafilococcus, 40
aureus, 42, 43
Stampo, teoria dello, 73
Stati Uniti, 15, 49, 54, 190,
192, 194, 204, 207, 210,
223, 237, 239, 241, 264,
319, 338, 344, 346, 389
Sterilità, 354
Steroidi, 350-352, 367
Stitichezza, 167, 171
St Louis (Senegal), 171
Stomaco, 91,97, 365,370
Streptococchi, 19, 22
Stress, 93, 284, 293-294, 368,
369, 370, 374-375, 387-388
Sud America, 49, 51-53
Surrenali, 165, 350-351, 352,
367, 368; vedi anche Adrenalina, ghiandole dell'
Sydney, 133,244
T linfociti, 15, 63-81, 83-88,
92, 107, 116, 123, 126, 127,
129, 159, 162, 179, 182,
212-214,271,348,374
citotossici, 158-159, 179
immunoregolatori, 70-72,
105, 107, 159, 278, 287,
301, 316, 324, 327, 347,
378
induttori, 68, 72, 180, 286,
288,316
killer, 69, 73, 163, 179,
180, 378
memoria immunologica,
74, 76, 123
soppressori, 163
Tabacco, 153-155
Taenia saginata, 49
Tanzania, 189
Tartrazina, 268
Tenia, 55
Tennessee, 126
Teofillina, 277
Testicoli, 100, 300, 345, 354,
367, 390
Testosterone, 295, 296, 367,
385
Tetano, 37, 86, 317, 323, 344
tossina del, 37, 319
tossoide del, 357
Texas, 265, 390
Timo, ghiandola del, 63-65,
68, 72, 74, 84, 288, 298300, 347, 356, 378, 385
Tipizzazione tessutale, 120,
122, 290, 292
Tiroide, ghiandola, 66, 297,
302
Tiroidite, 67
Tiroxina, 297
Tolleranza, 128, 287, 352,
356
attiva, 287, 288
infettiva, 288
passiva, 287
Tonsille, 77
Topi, 182-183, 347
Tossicodipendente, 33, 35-40,
113, 198,214-216, 231, 361
Tossine, 38, 42, 43, 77, 185,
322, 343
Trachea, 272
Tragelafo striato, 52
Trapianti, 15, 65, 66, 108,
112-133,290, 350, 353,355
Trematodi, 49
Tripanosomiasi, 48, 51
Triptofano, 328
Tropico del Cancro, 54
Tropico del Capricorno, 54
Trypanosoma brucei, 51
Trypanosoma cruzi, 51
Tse-tsè, mosca, 51
Tubercolina, 250, 251
Tubercolosi, 41, 162, 230,
249-250, 369
Turchia, 12
Uganda, 187, 189, 193,209
Unione Sovietica, 53
Uretere, 122
Uretra, 237
Urina, 27, 363
Utero, 73, 98, 101, 104, 209,
367
Vaccini, 14, 30, 74, 246, 339
Vagina, 43, 45, 46, 99-101,
172, 198, 205, 237
Vaginale
secrezione, 236
sesso, 234, 236
tampone, 41, 43
Vaiolo, 11-14
Valium, 35
Valvole cardiache, 36, 39, 40
Van Leenwenhoek, A., 37 n.
Varicella, 342
Varicose, vene, 154
403
Vasi sanguigni, 296, 301, 302,
365
Vedova nera, ragno, 342
Vegetazioni batteriche, 39, 40
Vermi, 49, 54, 55, 68
Verruca, 262
Vertebrati, 55
Vescica, 122
Vibrioni, 40
Virus, 23, 30-35, 48, 68, 78,
81, 88, 93, 102, 145, 204,
245, 294, 304, 322-323,
330-331
Vitamine, 45
A, 349
B 12, 300
404
C,328,349
Vitiligine, 296
Vulva, 45, 46
West Point, Accademia Militare di, 385-387
Wren, Christopher, sir, 341
Yale, Università di, 204, 270
Yuppies, malattia degli, 329
Zaire, 189
Zanzare, 245
Zigote, 101, 103
Zinco, 348, 350
Indice
5
Introduzione
di John M. Dwyer
LE GUERRE DEL CORPO UMANO
Storia del nostro sistema immunitario
9
17
19
Prefazione
Parte I
La lotta e i lottatori
1. Perché serve un sistema immunitario
I virus, 30 - I batteri, 35 - I funghi, 44 - I parassiti, 47
57
2. L'organizzazione delle difese
Il sistema dei linfociti B, 80 - Cellule killer e non killer, 92
95
97
112
Parte II
Come domare i lottatori
3. La gravidanza, versione naturale del trapianto
4. I tentativi umani di trapianto
Parte III
135
137
La sconfitta dei lottatori
5. L'argomento cancro
Il carcinoma polmonare, 165 - Il carcinoma intestinale, 167
- Carcinoma al collo dell'utero, 171 - Il melanoma, 174 La cura del cancro, 176
187
6. Come affrontare l'AIDS
Principali problemi e controversie, 224 - Il Retrovir (AZT),
241
247
249
283
303
Parte IV
Dove sono i generali?
7. Capire le allergie
8. Il penoso argomento dell'autoimmunità
9. La sindrome da fatica cronica: una misteriosa malattia immunitaria
333
335
361
Parte V
L'assistenza ai lottatori
10. Alcune armi nelle mani dell'immunologo
La protezione passiva, 341 - La protezione attiva, 343
11. I rinforzi: la mente come alleata
393
Indice analitico
Un saggio appassionante - arricchito da disegni e da un inserto fotografico tecnologicamente tra i più avanzati, che mostra il sistema immunitario in attività - sulle lotte che il nostro sistema immunitario
combatte quotidianamente contro i milioni di microbi, minuscoli ma
potenti, che ci circondano e tentano di invadere i nostri organi e tessuti, e ci distruggerebbero se non fossimo in grado di attivare i nostri
sistemi di difesa, estremamente vigili e sofisticati. Scritto da un immunologo clinico di fama internazionale, che si è anche occupato di
malati di AIDS e riesce ad essere emotivamente coinvolgente descrivendo molti casi umani di pazienti da lui curati, questo libro è come
un viaggio alla scoperta del mondo dei batteri, dei parassiti, dei funghi e dei virus, un ambito della scienza talvolta sconosciuto e spesso
poco compreso. Dall'interazione tra il feto e il sistema immunitario
della madre, che ha dato importanti risultati per la cura della sterilità,
il racconto ci svela ciò che accade quando un sistema immunitario
non perfetto ci lascia in preda a malattie come il cancro, le allergie, le
malattie autoimmuni come la sclerosi multipla, l'artrite reumatoide, la
sindrome da affaticamento cronico, e il possibile deficit del sistema
immunitario conseguente allo stress. Si spiega inoltre come agiscono
i vaccini, e si descrivono i miracoli dei moderni trapianti di organi.
professore di medicina alla University of New South Wales, è uno
dei più esperti immunologi clinici del mondo. Consulente dell'American Space
Program, e di importanti lavori di ricerca in Africa occidentale, dal 1978 al 1985
è stato professore di medicina e pediatria, oltre che capo della Divisione di immunologia clinica, alla School of Medicine della Yale University. Ha sempre
scritto su argomenti collegati alla salute pubblica, e si è occupato personalmente della cura dell'AIDS.
JOHN DWYER,