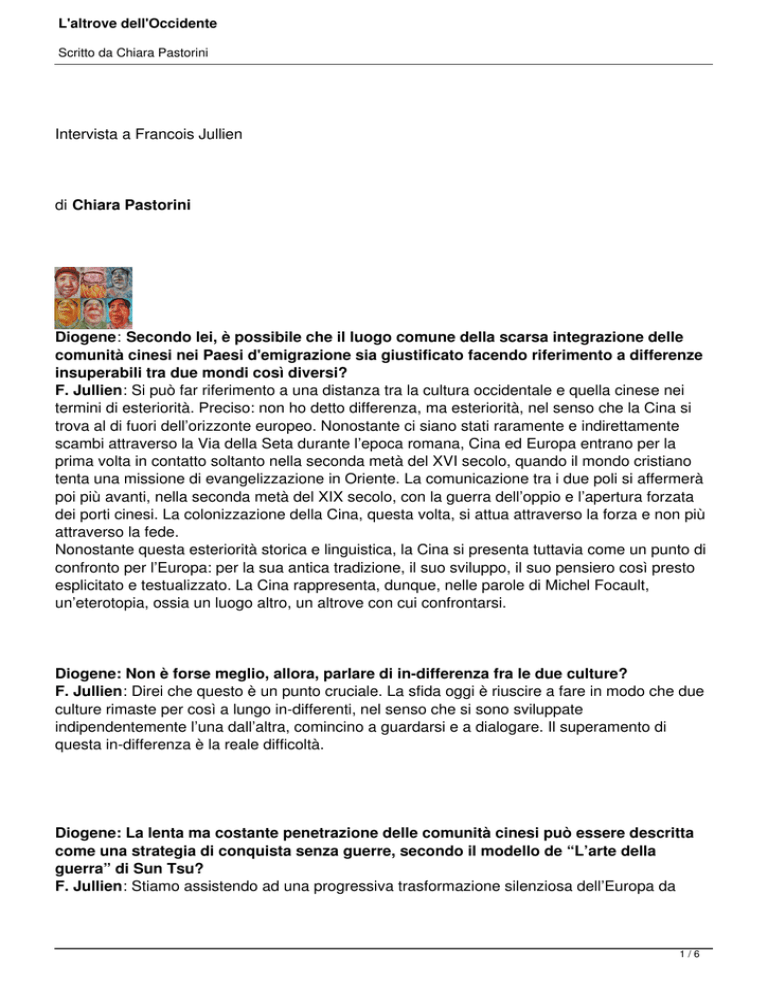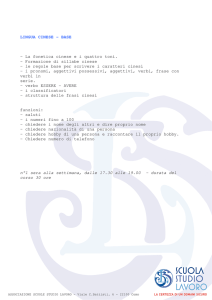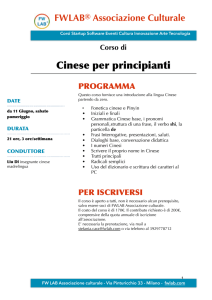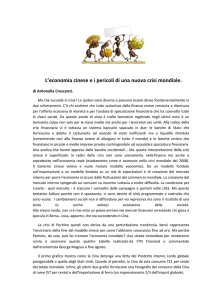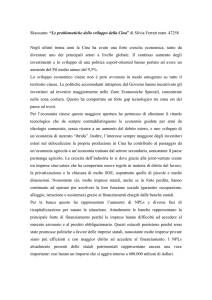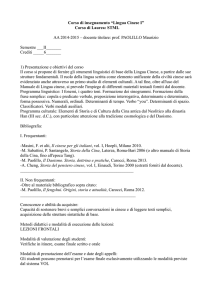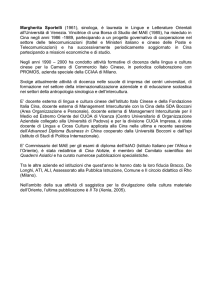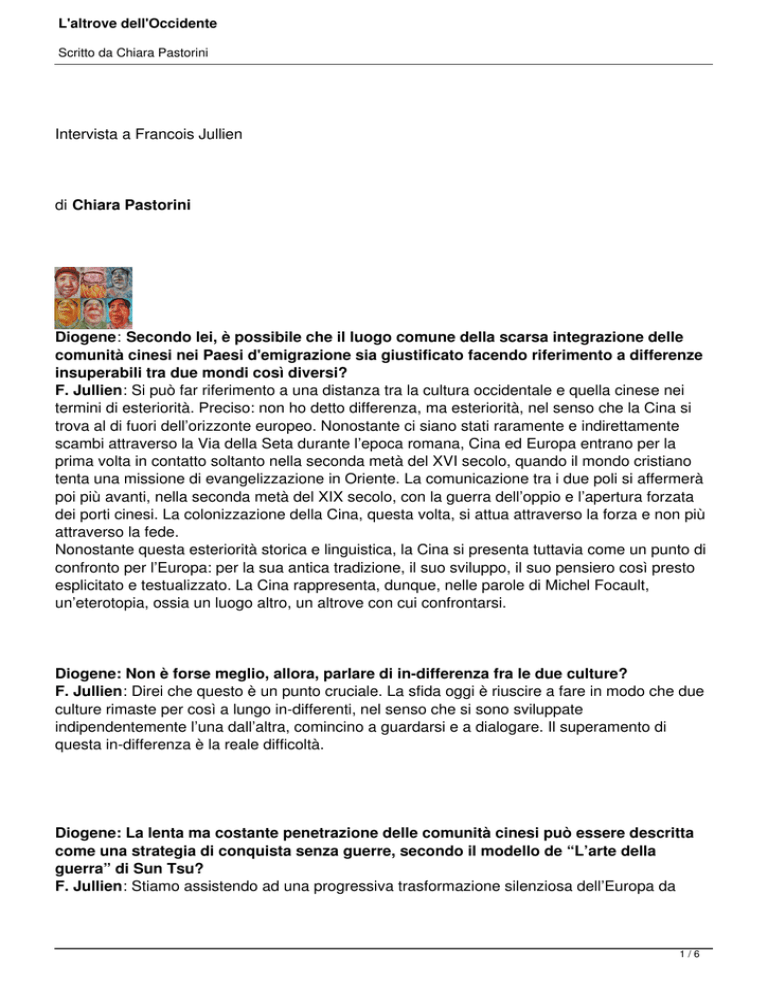
L'altrove dell'Occidente
Scritto da Chiara Pastorini
Intervista a Francois Jullien
di Chiara Pastorini
Diogene: Secondo lei, è possibile che il luogo comune della scarsa integrazione delle
comunità cinesi nei Paesi d'emigrazione sia giustificato facendo riferimento a differenze
insuperabili tra due mondi così diversi?
F. Jullien: Si può far riferimento a una distanza tra la cultura occidentale e quella cinese nei
termini di esteriorità. Preciso: non ho detto differenza, ma esteriorità, nel senso che la Cina si
trova al di fuori dell’orizzonte europeo. Nonostante ci siano stati raramente e indirettamente
scambi attraverso la Via della Seta durante l’epoca romana, Cina ed Europa entrano per la
prima volta in contatto soltanto nella seconda metà del XVI secolo, quando il mondo cristiano
tenta una missione di evangelizzazione in Oriente. La comunicazione tra i due poli si affermerà
poi più avanti, nella seconda metà del XIX secolo, con la guerra dell’oppio e l’apertura forzata
dei porti cinesi. La colonizzazione della Cina, questa volta, si attua attraverso la forza e non più
attraverso la fede.
Nonostante questa esteriorità storica e linguistica, la Cina si presenta tuttavia come un punto di
confronto per l’Europa: per la sua antica tradizione, il suo sviluppo, il suo pensiero così presto
esplicitato e testualizzato. La Cina rappresenta, dunque, nelle parole di Michel Focault,
un’eterotopia, ossia un luogo altro, un altrove con cui confrontarsi.
Diogene: Non è forse meglio, allora, parlare di in-differenza fra le due culture?
F. Jullien: Direi che questo è un punto cruciale. La sfida oggi è riuscire a fare in modo che due
culture rimaste per così a lungo in-differenti, nel senso che si sono sviluppate
indipendentemente l’una dall’altra, comincino a guardarsi e a dialogare. Il superamento di
questa in-differenza è la reale difficoltà.
Diogene: La lenta ma costante penetrazione delle comunità cinesi può essere descritta
come una strategia di conquista senza guerre, secondo il modello de “L’arte della
guerra” di Sun Tsu?
F. Jullien: Stiamo assistendo ad una progressiva trasformazione silenziosa dell’Europa da
1/6
L'altrove dell'Occidente
Scritto da Chiara Pastorini
parte dei cinesi: essi arrivano, creano una rete di relazioni, e, al contrario degli islamisti,
sembrano integrarsi meglio per l’assenza di un eventuale dogma con cui potremmo essere in
contrasto. Prendiamo l’esempio della Francia, in particolare di Parigi. Di anno in anno la
presenza di Cinesi è sempre più consistente, nelle scuole come nel lavoro, e le celebrazioni
cinesi acquistano sempre più importanza, ma la transizione progressiva è così graduale e
silenziosa che non la vediamo.
Penso dunque che si possa parlare di strategia di conquista dell’Occidente nei termini di una
trasformazione silenziosa, una nozione cinese che richiede qualche spiegazione.
Nel contesto europeo, l’eroe non si pone solamente obiettivi, ma fa dell’azione il mezzo
privilegiato del raggiungimento del risultato. Analogamente nel mondo islamico: pensiamo per
esempio alla figura degli shahid, gli uomini-bomba che si fanno esplodere per colpire un certo
obiettivo.
Uno dei temi più incisivi del pensiero cinese, e in particolare del taoismo, è invece il non-agire, il
wu wei, da non intendersi né con una forma di passività, né tantomeno con un atteggiamento di
rinuncia (vedi articolo di Margherita Sportelli in questo numero).
Se il saggio cinese o la strategia non agiscono, essi trasformano (hua), cioè fanno evolvere
gradualmente la situazione nel senso desiderato. Dissolvendo la dimensione individuale nella
globalità del processo, il saggio trasforma a vantaggio del mondo, mentre lo stratega trasforma
per un interesse particolare, essendo la differenza tra loro non di ordine logico, ma di grado di
interesse.
La trasformazione si manifesta esattamente come il contrario dell’azione. Quest’ultima è locale,
puntuale, visibile e rinvia ad un soggetto dotato di una certa volontà (si agisce hic et nunc).
La trasformazione, invece, è globale, progressiva, si incarna nel corso delle cose,
silenziosamente, e soltanto alla fine se ne apprezza il risultato. Un po’ come succede nel caso
del surriscaldamento climatico o dell’invecchiamento.
Nell’ottica cinese l’invisibilità della trasformazione, nel senso del suo non lasciarsi cogliere, è
proporzionale ai suoi effetti, cioè alla sua efficacia. La Cina ci insegna a considerare il tempo in
una durata più lenta e globale, e a prestare attenzione a ciò che non appare immediatamente,
all’indizio.
Diogene: Crede che questa lenta trasformazione possa tradursi in un processo di
progressiva integrazione?
F. Jullien: In realtà i cinesi si integrano bene nella realtà ospitante. Non essendo portatori di
dogmi o di altre verità che pretendono imporre, già alla seconda o terza generazione riescono
bene a scuola e nell’attività economica. Contemporaneamente però si organizzano in maniera
autonoma: mantengono i loro giornali, la loro cucina, una loro polizia. Quindi si tratta di
integrazione da un lato e di non integrazione dall’altro.
Per esemplificare la distanza dal modello occidentale possiamo prendere in considerazione due
giochi: quello degli scacchi e quello del go. Nel primo lo scopo è invadere il campo avversario
per dare scacco al re, nel secondo conquistare la maggior quantità di spazio possibile. La
battaglia non è più vissuta allora come un duello frontale limitato nel tempo in cui lo scopo è
l’eliminazione dell’avversario, ma come un processo più lento e ragionato in cui si acquista il
proprio spazio su un terreno comune. A un certo punto poi, l’avversario risulta sconfitto senza
2/6
L'altrove dell'Occidente
Scritto da Chiara Pastorini
che sia stato veramente attaccato.
Diogene: Pensa che ci sia comunque lo spazio per un dialogo? E quale dovrebbe essere
il ruolo degli intellettuali nel favorirlo?
F. Jullien: Penso sia necessario innanzitutto costituire le condizioni per un dialogo, cercando di
dare un senso forte a entrambe le componenti del dia e del logos. Per quanto concerne il dia
occore creare le condizioni del vis-à-vis, dell’incontro, dal momento che la storia non ce le ha
date, essendosi la cultura occidentale e quella orientale sviluppate indipendentemente,
in-differentemente l’una rispetto all’altra.
Per quanto riguarda invece il logos occorre creare un terreno comune di intellegibilità per uno
scambio reciproco. E questo al di là delle differenze linguistiche. È sulla creazione di questo
dia-logos che dovrebbe lavorare il filosofo.
In realtà, però, oggi gli europei oscillano tra due tendenze: la seduzione per questo Altro esotico
e distante (la cucina, la calligrafia etc.), e un sentimento di paura per la sua potenza in crescita.
Bisogna quindi creare le condizioni per un dialogo intelligente, cioè intellegibile, nel senso di
assimilabile.
Diogene: In che modo le differenze linguistiche possono riflettere la distanza tra la
cultura europea e quella cinese?
F. Jullien: Anche la lingua è un punto di divergenza tra le due culture. Il cinese non appartiene
al gruppo delle lingue indo-europee (a differenza per esempio del sanscrito) e si basa su
ideogrammi, è l’unica lingua ad essersi conservata tra le altre lingue ideografiche che
esistevano un tempo.
Il nostro sistema linguistico e quello cinese sono due sistemi che si sono sviluppati
indipendentemente l’uno dall’altro.
In primo luogo le lingue europee sono caratterizzate da una sintassi e da una morfologia
praticamente assenti nel cinese, in cui non esistono differenze di numero, declinazioni,
coniugazioni dei verbi secondo persone e tempi, proposizioni relative, subordinate o principali.
Ne deriva una speciale flessibilità che può essere esplicitata facendo riferimento ad una formula
di Lao Tsu, il fondatore del Taoismo, in cui troviamo la parola di, ad esempio in un frase del tipo
sembra l’antenato di. Ebbene, questo termine, di, può voler dire signore, sovrano, Dio (al
singolare e al plurale), e questo rende lo spettro delle possibilità abbastanza ampio.
Al carattere “determinante” delle lingue europee il cinese oppone quindi un forte grado di
“disponibilità” nella veicolazione dei significati.
Il cinese è, inoltre, una lingua che riflette un pensiero per polarità: per dire che cos’è questa
cosa?, ad esempio, si dice che cos’è questo est-ovest?, o ancora, per dire paesaggio si dice
montagna e acqua, shanshui o shanchuan.
Un’altra particolarità del cinese classico è la mancanza del verbo essere in senso assoluto,
esistenziale: possimo dire c’è oppure lui è grande, utilizzando il verbo essere in senso
predicativo, ma non si può dire lui è. Come è possibile verificare attraverso l’analisi del pensiero
3/6
L'altrove dell'Occidente
Scritto da Chiara Pastorini
confuciano, l’ontologia è una possibilità che non è stata esplorata: non c’è la questione del che
cos’è?, dell’essenza. Anche la nozione di verità è assente.
Diogene: Dal momento che nozioni cardine della filosofia occidentale non sono state
esplorate nel pensiero cinese possiamo parlare di filosofia, o è meglio usare il termine
saggezza?
F. Jullien: Diciamo subito che non esiste una metafisica cinese, e questo è la conseguenza
della mancanza di un piano altro (ad esempio di una dimensione ideale di stampo platonico)
rispetto all’esperienza sensibile. La riflessione cinese non ha mai sviluppato una separazione
tra sensibile e intellegibile.
Se l’assenza di metafisica è un dato certo, sulla possibilità di definire la riflessione cinese una
filosofia si può discutere. In Europa, saggezza è un termine povero, nel senso che designa
solitamente tutto ciò che non può essere considerato filosofia. Penso che all’interno della
riflessione cinese ci sia la possibilità di parlare di filosofia: quando si discute per esempio sul
carattere buono o malvagio della natura umana ritengo che ci si stia impegnando in un gioco
filosofico. Non bisogna però dimenticare che qualsiasi posizione filosofica è per definizione
parziale, e nello spirito cinese il criterio superiore della onnicomprensività impedisce di
rinchiudersi nella parzialità di una posizione. Se il grande nemico nella tradizione occidentale è
l’errore, il pensiero cinese rifugge invece la parzialità, in quanto antitetica alla comprensione di
tutti i punti di vista in una visione d’insieme unitaria.
Il saggio non è chi vede altrimenti, ma chi racchiude tutti i punti di vista, chi pensa come tutti. E
del saggio, afferma Mencio, un discepolo di Confucio, non si può dire nulla, nel senso che a
seconda delle esigenze e delle circostanze può incarnare un’attitudine piuttosto che un’altra,
per esempio l’essere accomodanti o intransigenti, il dolore come la gioia. A questo
atteggiamento si lega la nozione di giusto mezzo cinese, non nel senso di a metà strada tra una
4/6
L'altrove dell'Occidente
Scritto da Chiara Pastorini
posizione e l’altra, ma di possibilità di sposare una posizione piuttosto che l’altra.
Si può parlare quindi in ultima analisi di filosofia cinese in quanto discussione tra posizioni
diverse, ma senza sfida, cioè senza la pretesa dell’imposizione di una posizione piuttosto che
un’altra, cosa che farebbe ricadere nella parzialità. A questa chiusura in una posizione
definitoria si oppone la saggezza come apertura a tutti i punti di vista. È ora più comprensibile
anche come non si sia affermata in Cina l’idea di verità.
Diogene: Riprendiamo le nozioni di non-agire e reazione che nello spirito cinese
prevalgono sulla nozione di azione: come è possibile conciliare questa prospettiva con
concetti fondamentali della tradizione occidentale come quelli di libertà o di volontà?
F. Jullien: Questo è il cuore della questione. È a partire dalla nozione greca di azione che nella
tradizione occidentale derivano sia la nozione di libertà, sia quella di volontà nel compiere una
determinata azione piuttosto che un’altra.
Il pensiero cinese invece ha riflettuto non in termini di azione, ma di condotta, intesa spesso
come tenacia, durata. Mencio non dice “posso o voglio”, ma “posso o faccio” mettendo così in
evidenza l’assenza della categoria della volontà.
Esiste qui un piano del virtuale e uno del fattuale, ma non della volontà. Ancora una volta, la
mancanza di riflessione su un principio ultimo delle cose posto al di là di esse, è assente: si
ritorna quindi allo stesso punto: nel pensiero cinese non c’è metafisica. Se Kant pensa la
morale nella libertà, il cinese pensa la morale senza la libertà. La morale è qui pensata piuttosto
in termini di influenza, condizionamento, propensione, adattamento alle circostanze. La
condotta migliore è quella che è in accordo con il corso delle cose, nelle parole cinesi, “in
stagione” con le cose.
Diogene: Nelle sue opere parla spesso di nozioni del pensiero cinese classico, ad
esempio dell’insapore come possibilità di apertura e disponibilità, oppure dell’efficacia
come risultato di un processo. Crede che questi concetti abbiano ancora valore nella
Cina di oggi, trasformata dal capitalismo e dalla globalizzazione?
F. Jullien: Cominciando dall’insapore diciamo che questo è ancora presente innanzitutto nella
cucina cinese: si può parlare ad esempio del sapore dell’acqua. Si tratta di un (in)sapore non
ancora esclusivo, e contemporaneamente già pieno perché non parziale, completamente
disponibile. Ritorna quindi nuovamente il criterio della plenitudine evocato precedentemente e il
non interesse cinese per la costruzione della verità. Credo che questo concetto di insapore
rimanga ancora oggi nella cultura e nei comportamenti dei Cinesi.
Per quanto riguarda la nozione di efficacia bisogna fare una precisazione. I cinesi hanno
appreso, soprattutto a partire dalla seconda metà del XIX secolo, i modelli di vita occidentali:
non hanno avuto scelta. La Cina è entrata così in contatto con la scienza galileiana e
newtoniana, il pensiero politico, il modello capitalistico, etc. Questo ha permesso che oggi i
cinesi possano da una parte essere come noi, adattati ai nostri modelli occidentali, e dall’altra
parte essere distanti da noi, nel mantenimento dei loro paradigmi tradizionali.
5/6
L'altrove dell'Occidente
Scritto da Chiara Pastorini
Mao diceva: “camminare sulle proprie due gambe”, nel senso che è meglio avere la possibilità
di due risorse piuttosto che di una sola. La Cina oggi cammina quindi su una gamba occidentale
e sull’altra cinese, tradizionale. Su questo presupposto di maggior efficacia la Cina attuale
concilia il socialismo con il capitalismo.
Credo inoltre che sia più facile apprendere il modello europeo occidentale per un cinese che il
contrario. Entrare in un sistema di ragionamento in cui hanno importanza le nozioni di indizio, di
sottile, di lentezza, etc. richiede una sorta di iniziazione e molto lavoro. C’è in questo senso una
non-equivalenza tra le modalità di apprendimento dei due sistemi, occidentale e cinese, una
dissimmetria. I cinesi oggi si servono di ciò e, ritornando al gioco di go, possiamo ricordare che
la strategia consiste nel fare in modo che ad un certo punto l’avversario sia sconfitto senza
averlo attaccato.
Diogene: Quali sono le ragioni che l’hanno portata a interessarsi al pensiero cinese e in
cosa consiste il suo lavoro filosofico?
F. Jullien: Ho iniziato come filosofo ellenista e, come spesso ricordo, mi sono interessato alla
Cina per leggere meglio il greco! Sebbene sembri paradossale in realtà non è così: avevo
bisogno di prendere distanza dalla filosofia occidentale per riuscire a conoscerla meglio. La
Cina rappresenta per me questo altrove, questo punto di vista da cui è possibile ritornare, con
un altro sguardo, con un movimento contemporaneamente riflessivo al mio punto di partenza.
La filosofia in Europa non ha smesso di oscillare tra due fonti principali: la tradizione greca da
una parte e quella ebraica dall’altra. Hegel, Heiddeger, Derrida, Levinas ne sono esempi. La
scelta della Cina mi ha permesso di uscire da questa sorta di movimento oscillatorio fra Atene e
Gerusalemme, Socrate e Abramo, e di accedere ad altre parole dell’origine che non fossero
costrette fra il Logos e Yavéh.
La Cina mi ha permesso una sorta di straniamento (dépaysement) dalla filosofia occidentale in
rapporto alla lingua, alla storia, alla cultura, consentendomi così di interrogare quello che,
restando all’interno della tradizione greca, non avrei interrogato.
Solo ritornando allo sfondo di intesa implicito al nostro pensiero si possono creare le condizioni
di una riflessività filosofica. In questo consiste allora il mio lavoro: ritornare, attraverso il
pensiero cinese, all’impensato della ragione europea, cercando di cogliere secondo una
strategia obliqua le scelte implicite che hanno dato vita alla filosofia occidentale.
6/6