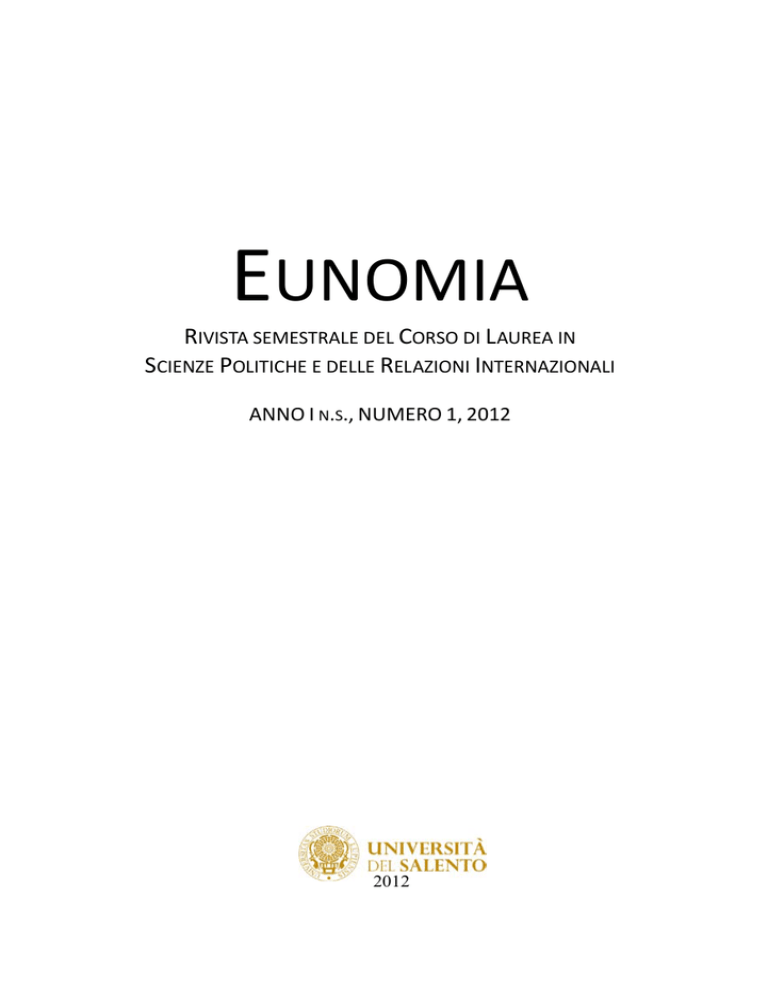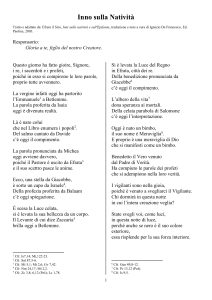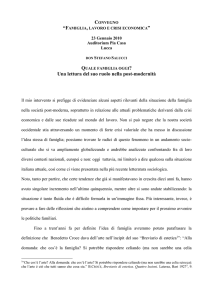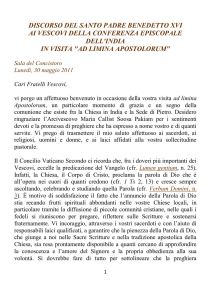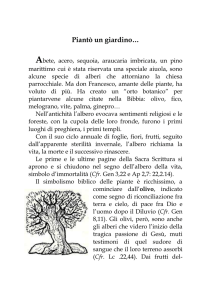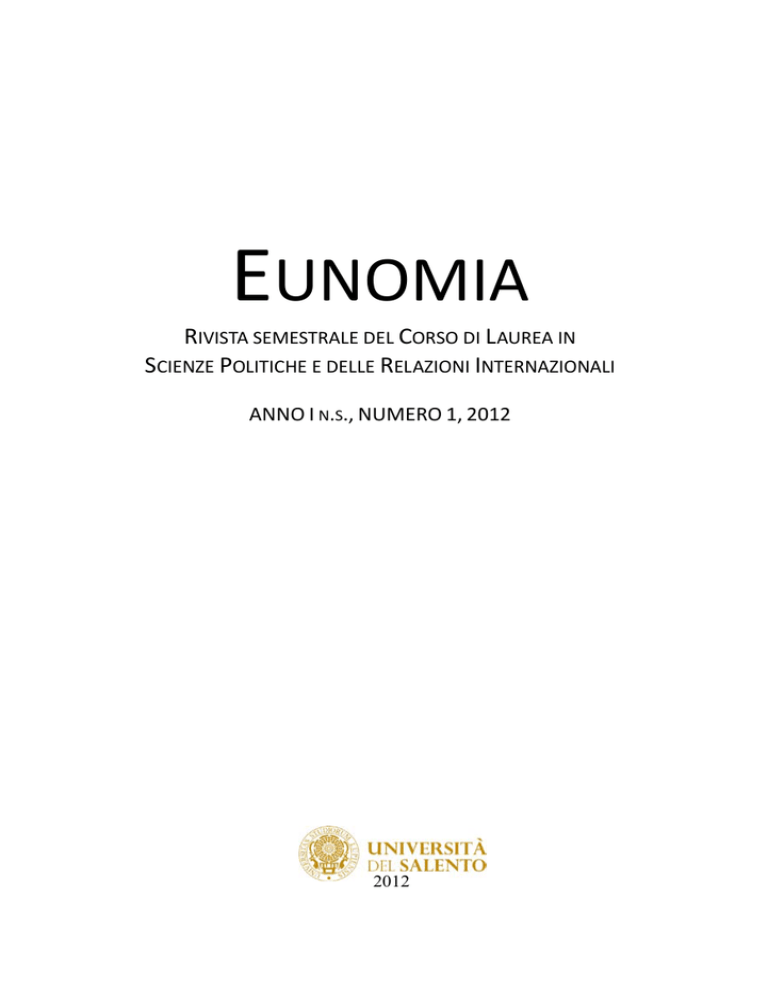
EUNOMIA
RIVISTA SEMESTRALE DEL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
ANNO I N.S., NUMERO 1, 2012
2012
Eunomia. Rivista semestrale del Corso di Laurea in Scienze
Politiche e delle Relazioni Internazionali
Università del Salento
Editor in Chief
Antonio Donno (Università del Salento, Lecce, Italia)
Scientific Board
Furio Biagini (Università del Salento), Uri Bialer (Jewish University,
Jerusalem, Israel), Ester Capuzzo (Università “La Sapienza”, Roma),
Michele Carducci (Università del Salento), Daniele De Luca (Università del
Salento), Ennio Di Nolfo (Università di Firenze), Antonio Donno (Università
del Salento), Giuseppe Gioffredi (Università del Salento), Alessandro Isoni
(Università del Salento), Giuliana Iurlano (Università del Salento), Vincenzo
Lavenia (Università di Macerata), David Lesch (Trinity University, San
Antonio, TX, USA), Amparo Lozano (Universidad S. Pablo Ceu-Madrid,
Spagna), Monica Massari (Università di Napoli Federico II), Roberto
Martucci (Università del Salento), Luigi Melica (Università del Salento),
Luke Nichter (A&M Texas University, USA), Francesco Perfetti (LUISS “G.
Carli”, Roma), Attilio Pisanò (Università del Salento), Fabio Pollice
(Università del Salento), Bernard Reich (George Washington University,
Washington, USA), Giuseppe Schiavone (Università del Salento), Teresa
Serra (Università "La Sapienza", Roma), Antonio Varsori (Università di
Padova), Manuela Williams (University of Strathclyde, U.K.)
Editorial Staff
Giuseppe Gioffredi, Giuliana Iurlano, Giuseppe Patisso, Fiorella Perrone,
Bruno Pierri, Maurizia Pierri, Attilio Pisanò, Francesca Salvatore, Claudia
Sunna, Lucio Tondo, Ughetta Vergari
Editorial Office
c/o Corso di Laurea di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Università del Salento-Lecce
Via Stampacchia, 45
73100 Lecce (Italy)
tel. 39-0832-294642
tel. 39-0832-294765
fax 39-0832-294754
e-mail: [email protected]
ISSN 2280-8949
Journal website: http://siba-ese.unisalento.it/index.php/eunomia
© 2012 Università del Salento – Coordinamento SIBA
http://siba2.unisalento.it
Sommario
ANNO I n.s., NUMERO 1, 2012
Presentazione
p.
5
ENNIO DI NOLFO
Le reazioni americane al riconoscimento italiano della Cina
p.
9
ANTONIO DONNO
La rivoluzione americana: evento locale o globale?
p. 33
NON MULTA SED MULTUM
Sezione docenti e studiosi
MAURIZIA PIERRI
Sistema fiscale e “inclinazioni” del federalismo
p. 49
GIUSEPPE PATISSO
Dall'asiento ai codes noirs: i tentativi di normativizzazione
della schiavitù (sec. XV-XVIII)
p. 65
ALESSANDRO ISONI
Farewell to the European Community: The Lisbon Treaty and
the Conceptual Shifts of a Sui Generis Public Law Experience
p. 85
FRANCESCO MARTELLONI
Geografia, economia e politica dell'Adriatico orientale:
i rapporti italo-balcanici in uno studio di Carlo Maranelli del 1907
p. 99
PAOLO MACRÌ
I quaccheri americani e le attività di soccorso in Europa
e nella Russia bolscevica, 1917-1921
p. 131
GIULIANA IURLANO
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo:
l'Amistad e il “misterioso caso della lunga e bassa goletta nera”
p. 153
GRADUS AD PARNASSUM
Sezione studenti
FRANCESCA DE PASCALIS
Piazza Tiananmen, 1989: la “rivoluzione mancata”
p. 197
KATIA SCARLINO
“Paidomazoma”: il rapimento dei bambini greci da parte
dei ribelli comunisti durante la guerra civile (1944-1949)
p. 227
FRANCESCA SALVATORE
Il ruolo della teoria dei giochi nel neorealismo strategico
di Thomas C. Schelling
p. 243
QUIS LEGET HAEC?
Recensioni
p. 269
GLI AUTORI
p. 295
Presentazione
Nell’ottobre 2007 uscì il primo numero dei quaderni editoriali di Eunomia,
una rivista fortemente voluta da Attilio Pisanò e Giuseppe Gioffredi per
ospitare alcuni fra i più meritevoli lavori finali svolti dagli iscritti al corso di
laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali dell’Università
del Salento. L’esperienza, ripetuta nel giugno 2008, confermò la validità
dell’iniziativa, il cui scopo principale era quello di avviare una collana che
potesse dare la possibilità ad ogni studente del corso “di veder riconosciuti i
propri sacrifici e la propria capacità di ricerca”. Anche la scelta della
denominazione della rivista, Eunomia, serviva a sottolineare, da un lato,
l’alveo giuridico-internazionale in cui si collocavano i lavori pubblicati;
dall’altro, ad individuare “un’immediata regola dell’agire tesa a premiare
chi nel corso degli studi ha dimostrato passione, competenza, volontà di
apprendere”.
A distanza di quattro anni, Eunomia riprende le pubblicazioni in una
nuova veste editoriale: si trasforma in un online journal, sia per facilitare e
rendere più veloce la sua distribuzione, sia per abbattere i costi di
pubblicazione, cosa che in precedenza aveva compromesso non poco
l’esperienza editoriale. Ma non è questa l’unica novità: Eunomia, infatti,
diventa la rivista del corso di studio di Scienze Politiche e delle Relazioni
Internazionali, modificando anche la sua struttura interna: oltre a mantenere
la sezione “Gradus ad Parnassum”, dedicata ai lavori degli studenti –
sezione allargata a un contesto più ampio, coincidente con tutte le aree
disciplinari previste nei curricula degli studi –, la rivista prevede anche una
parte, “Non multa sed multum”, dedicata agli studiosi, che potranno
pubblicarvi i loro autorevoli contributi. Inoltre, vi sarà una sezione “Quis
leget haec?”, che ospiterà le recensioni e le novità editoriali più interessanti
per gli studenti del corso.
Da questo punto di vista, Eunomia – concetto che, nelle intenzioni
soloniane, doveva rendere tutto ordinato e perfetto, riequilibrando le
tensioni all’interno della polis – cercherà di trascendere l’ambito puramente
giuridico-politico, per rientrare a pieno titolo anche nella sfera dell’etica,
un’etica della conoscenza oggi spesso trascurata di fronte all’idea di un
sapere solo ed esclusivamente “pratico”. “Tutti debbono ricercare non ciò
che è antico, ma ciò che è buono” (Pol. 1269a), scriveva Aristotele, anche
in polemica col suo grande maestro: l’eunomia, infatti, non poteva fondarsi
sull’immutabilità delle leggi, ma sulla continua ricerca di equilibrio e,
soprattutto, sul piacere disinteressato della scoperta, sullo stupore che
5
spinge l’uomo alla ricerca, alla conoscenza e, dunque, alla sua crescita
personale e sociale. In questo senso, Eunomia si propone di costituire una
sede qualificata per riscoprire il valore del merito e il piacere dello studio,
condizioni indispensabili per ottenere un riconoscimento reale, e non
fittizio, da parte di una società tendenzialmente sempre più orientata alla
semplificazione e alla superficialità.
La Redazione
6
Non multa sed multum
Sezione docenti e studiosi
Eunomia. Rivista semestrale del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Eunomia 1 n.s. (2012), n. 1, 9-32
e-ISSN 2280-8949
DOI 10.1285/i22808949a1n1p9
http://siba-ese.unisalento.it, © 2012 Università del Salento
Ennio Di Nolfo
Le reazioni americane
al riconoscimento italiano della Cina
Abstract: The article reconstructs the events of the Italian project, strongly backed by Nenni,
the Rumor Government’s Minister of Foreign Affairs in 1968, to recognize the People’s
Republic of China. The Italian initiative alarmed the Nixon Administration, then just in office,
thus arising for Washington the question to limit a process, which within the Western Bloc
could have caused unpredictable repercussions on the large policy Nixon intended to pursue in
light of a possible Sino-American rapprochement and of the consequent isolation of the Soviet
Union. However, the hasty Italian action threatened to frustrate the long American diplomatic
work, thus worsening the Taiwan problem, debated at length during the Italo-American talks.
On October 25, 1971, the United Nations General Assembly voted by a large majority the
replacement of Taiwan’s representative with that of Beijing. Italy abstained.
Keywords: Italian-Chinese Popular Republic Relations; Italian-American Relations; CPS's
Italian Recognition.
1. Pietro Nenni propone di riconoscere la Repubblica Popolare Cinese
Dalla nascita della Repubblica Popolare Cinese, nell’ottobre 1949, e sino
all’ottobre 1970, non esistettero relazioni diplomatiche normali tra l’Italia e
la Repubblica Popolare Cinese. Condizionato dalla natura degli
schieramenti dettati dalla Guerra Fredda e dalla risoluta scelta atlantica, il
governo italiano ritenne nel 1949 di seguire l’orientamento di molti altri
paesi europei (esclusa la Gran Bretagna), mantenendo il riconoscimento
formale al governo della Repubblica di Cina, che frattanto, sotto la guida di
Chang Kai-shek, si era rifugiato nell’isola di Taiwan, proclamando di essere
l’unico governo legittimo della Cina, animato da una forte volontà di
Ennio Di Nolfo
recupero del controllo della terraferma. 1 Questa situazione rimase immutata
per alcuni lustri, sebbene tra i due paesi si sviluppassero frattanto relazioni
commerciali e industriali di una certa intensità. 2 Nel 1964 la Repubblica
Popolare venne riconosciuta dalla Francia e questa svolta aprì la strada a un
ripensamento italiano. Da principio si pensò a un accordo commerciale ma
l’allora presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, diede ben presto a
queste discussioni il significato di preparazione per un accordo politico. Del
resto, eguale evoluzione aveva avuto luogo in Cina, proprio nella prima fase
della cosiddetta “rivoluzione culturale”, quando in virtù dell’orientamento
di Zhou Enlai, l’ambasciatore cinese a Parigi prese contatto con esponenti
del corpo diplomatico della Repubblica di San Marino, per avviare con loro
una pratica di riconoscimento che inevitabilmente sarebbe ricaduta
sull’Italia. 3
La questione uscì dal vago dopo che Pietro Nenni, alla fine del 1968,
divenne ministro degli Esteri nel governo presieduto da Mariano Rumor.
Nenni intendeva procedere con rapidità verso il riconoscimento della Cina
Popolare ma fu trattenuto dalla prudenza di Roberto Gaja, direttore degli
Affari politici del ministero, il quale rilevava che la questione era intrecciata
con il disconoscimento dei rapporti con Taiwan e che anche il Belgio e il
Canada avevano intrapreso negoziati paralleli, del cui andamento era
opportuno tenere conto. La situazione generale era profondamente
cambiata. In Cina la “rivoluzione culturale” si avviava al tramonto; in
Vietnam la guerra era ancora violenta ma i negoziati per porvi termine erano
iniziati a Parigi. Ciò che però più di tutto dominava la scena era
l’atteggiamento degli Stati Uniti, con il quale anche l’Italia avrebbe dovuto
misurarsi. Ora gli Stati Uniti, dopo l’elezione di Richard Nixon alla
presidenza, stavano elaborando una complicata revisione della loro strategia
1
Su questo tema esiste una letteratura piuttosto circoscritta. In particolare si vedano: P. OLLA
BRUNDU, Pietro Nenni, Aldo Moro e il riconoscimento della Cina comunista, in «Le Carte e la
Storia», X, 2, 2004, pp. 29-51; E. DI NOLFO, La normalizzazione delle relazioni diplomatiche
tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Cinese, in SENATO DELLA REPUBBLICAARCHIVIO STORICO, La normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica
italiana e la Repubblica popolare cinese. Atti e documenti, Soveria Mannelli, Rubbettino,
2010, pp. 1-47.
2
Cfr. a tale proposito, Tra politica e impresa. Vita di Dino Gentili, a cura di G. LUTI, con
prefazione di P. BARILE, Firenze, Passigli, 1988, pp. 30-31. Va tenuto presente il fatto che in
Cina il Gentili era accompagnato da una certa diffidenza.
3
Cfr. DI NOLFO, La normalizzazione, cit., p. 6.
10
Le reazioni americane al riconoscimento italiano della Cina
internazionale. Avevano avviato i negoziati con l’Unione Sovietica per
creare il clima poi definito come détente ma intendevano questa azione
come una delle mosse che avrebbero dovuto isolare l’Unione Sovietica,
soprattutto grazie all’instaurazione di nuovi rapporti con la Cina, che da
sempre essi avevano mostrato di voler contrastare. L’azione americana,
complessa e laboriosa, era tale da non poter accettare passivamente
iniziative parallele che potessero creare ostacoli imprevisti. Sicché
l’iniziativa che Nenni avrebbe voluto assumere doveva tener conto di tale
contesto e della netta ostilità manifestata dal segretario di Stato Rogers,
«molto contrariato» dalle velleità italiane. 4
Questa durezza non durò tuttavia a lungo e, a mano a mano che le
iniziative italiane acquistavano consistenza e precisione, a Washington si
passò dal disinteresse a uno spiccato interesse. Ciò non significava che gli
americani fossero ostili all’iniziativa italiana. Né avrebbero potuto, dato che
essi stessi si muovevano nella medesima direzione. Ciò che li preoccupava
erano le ricadute di un passo del genere, non solo per l’intreccio di processi
che sarebbero dovuti rimanere paralleli ma distaccati e remoti, quanto per le
modalità pratiche dell’azione italiana e per il grado di autonomia che la
diplomazia italiana mostrava di voler adottare come criterio ispiratore della
sua iniziativa. Questa diffidenza, che portò anche a momenti di vivace
disputa diplomatica (per usare una terminologia misurata) si manifestò in
relazione a tre aspetti diversi e successivi della situazione: la decisione
italiana di prendere l’iniziativa senza prima consultare gli Stati Uniti ma
solo informandoli; i problemi derivanti dalla situazione in cui il governo e i
diplomatici di Taiwan si sarebbero trovati; la questione della rappresentanza
cinese alle Nazioni Unite (dove sino a quel momento il delegato di Taiwan
rappresentava la Cina, come membro permanente del Consiglio di
Sicurezza, e valeva come un utile contributo al fronte guidato dagli Stati
Uniti, secondo una “finzione giuridica” che continuava a considerarlo come
rappresentante dell’intera Cina).
La questione era da tempo adombrata nel dibattito politico italiano;
Roberto Gaja, l’autorevole diplomatico italiano allora direttore dell’Ufficio
Affari politici del ministero degli Esteri, ne aveva ridiscusso, il 10 gennaio
4
E. ORTONA, Anni d’America. La cooperazione 1967-1985, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 172.
11
Ennio Di Nolfo
1969, con i colleghi americani a Roma 5 come di un’ipotesi rispetto alla
quale si nutrivano ancora esitazioni, poiché, diceva Gaja, si voleva evitare
«l’umiliazione di offrire un riconoscimento che fosse poi respinto» e si
pensava, con esagerato e forse apparente candore, che fosse anche possibile
proporre al governo di Pechino l’avvio di rapporti diplomatici regolari che
consentissero all’Italia di mantenere i suoi rapporti con la Repubblica di
Cina (cioè Taiwan). Ma Gaja parlò di questo come di un processo che
avrebbe richiesto ancora un paio di mesi e che, prima di essere avviato,
sarebbe stato oggetto di nuove consultazioni con gli alleati e in particolare
con gli americani. Viceversa, Nenni intendeva muoversi con maggiore
rapidità e il 23 gennaio (il giorno prima delle sue dichiarazioni alla Camera
dei deputati nel corso delle quali enunciò il proposito di riconoscere la Cina
popolare) ne informò l’ambasciatore americano, non per averne un parere,
ma per doverosa notizia. 6 Da Roma si informò immediatamente il
dipartimento di Stato che realisticamente ma nettamente enunciò la sua
posizione. Sebbene l’ambasciatore scrivesse che era «impossibile
dissuadere il governo italiano dal compiere quel passo», qualora la risposta
americana fosse stata troppo moderata, gli italiani l’avrebbero presa come
un’autorizzazione a comportarsi secondo criteri e tempi propri. Perciò
occorreva quanto meno influire proprio sui tempi prima che Nenni desse il
suo annuncio. 7
2. L'opposizione degli Stati Uniti
Questa interferenza fu immediata e mostrò chiaramente quanto il governo
americano volesse condizionare l’inevitabile iniziativa italiana. Dalla Casa
Bianca venne formulata la seguente dichiarazione: «L'Italia è interessata
5
Ackley to Department of State, January 13, 1969, in NATIONAL ARCHIVES, NATIONAL
SECURITY COUNCIL, busta 694, College Park, MD, Top Secret (d'ora in poi NA, NSC, seguiti
dall’indicazione di riferimento). Ringrazio la collega Liliana Saiu, dell'Università di Cagliari,
per avermi fornito copia della documentazione da lei ritrovata presso i National Archives
americani.
6
Sulla data di questa informazione, cfr. il documento allegato e segreto recante la cronologia
delle discussioni in materia e destinato presumibilmente all’ambasciatore a Roma. S.R.
Gammon of Department of State to Ambassador Martin, May 8, 1969, Secret Chronology,
National Archives, Central Files, Record Group 59 (d'ora in poi RG), box 2235.
7
Meloy to Department of State, January 23, 1969, NA, NSC, 694.
12
Le reazioni americane al riconoscimento italiano della Cina
alla pace. Anche gli Stati Uniti lo sono. Stiamo disperatamente
adoperandoci perché i negoziati di Parigi sulla pace nel Vietnam abbiano
successo. Perché l’Italia dovrebbe rendere questo problema ancora più
difficile per noi scegliendo di riconoscere la Cina prima che un accordo di
pace sul Vietnam sia raggiunto o, quanto meno, siano stati fatti progressi
sostanziali in questa direzione?». 8 Il giorno successivo al discorso di Nenni,
l’ambasciatore italiano a Washington, Egidio Ortona, incontrò il
sottosegretario di Stato Bundy per rendere esplicite le motivazioni che
avevano ispirato Nenni e dirgli della sensibilità degli italiani verso la
questione del riconoscimento e verso ciò che accadeva nel Vietnam.
Tuttavia, aggiunse la rassicurazione che «il governo italiano intendeva
aspettare la reazione del governo comunista cinese prima di definire le
procedure da adottare nella fase successiva». Bundy rispose confermando
ciò che era stato scritto il giorno precedente sulla tempistica dell’operazione
e aggiungendo che quanto si temeva era che il gesto italiano potesse
rafforzare le opinioni più intransigenti in Cina e in Vietnam in ordine ai
negoziati di Parigi. Ciò non significava, aggiunse Bundy, che da parte sua vi
fosse una richiesta di sospendere ogni iniziativa ma solo la
raccomandazione di soppesarne con grande serietà la portata e di tenere
informato il governo statunitense delle iniziative che sarebbero state prese.
Aggiunse però che le sue parole non dovevano essere overestimated mentre,
forse, sarebbe stato utile che da parte italiana si informasse il governo
giapponese, che era «assai preoccupato» dal gesto che stava per essere
compiuto. 9
Qualche giorno appresso, Gaja riprese la questione conversandone con
uno dei collaboratori dell’ambasciatore Martin. Forse con una certa
trascuratezza o forse per tenere tranquillo il suo interlocutore, Gaja
manifestò opinioni difformi da quelle di Nenni. Si mostrò infatti
«preoccupato perché il ministro Nenni aveva manifestato l’intenzione
italiana in maniera così precipitosa e senza un’accurata preparazione
preliminare» e aggiunse di essere «sorpreso da ciò che gli appariva come
una relativamente blanda reazione americana». Del resto, sperava che
l’avventatezza fosse ridimensionata dalla risposta cinese poiché era certo
che Pechino avrebbe chiesto agli italiani di rompere le relazioni con Taiwan,
8
9
Allegato al dispaccio di cui alla nota precedente, con indicazione archivistica Rome 366.
Bundy to Martin, January 25, 1969, NA, NSC, 694.
13
Ennio Di Nolfo
sebbene fosse poi sicuro che da parte italiana la richiesta sarebbe stata
accolta. Era ciò che Gaja giudicava in modo negativo, poiché un passo del
genere avrebbe aperto la strada alla successiva richiesta degli interessati,
che «l’Italia riconoscesse la Germania orientale, ciò che sarebbe equivalso a
infliggere un colpo fatale all’unità dell’Occidente». 10
Benché il comportamento diplomatico di Gaja fosse discutibile, le sue
previsioni erano tuttavia fondate poiché i Cinesi raccolsero rapidamente
l’apertura di Nenni e si mostrarono disposti a iniziare un negoziato a Parigi,
dove sia l’Italia sia la Repubblica popolare cinese erano rappresentate.
Iniziare ma a tre condizioni che corrispondono ai punti critici di tutta la
vicenda qui analizzata. Infatti, l’incaricato d’affari cinese a Parigi, Yi Su
Chich, chiese, come premessa del riconoscimento, che l’Italia riconoscesse
il governo della Repubblica popolare come «il solo governo legale» del
popolo cinese; che riconoscesse essere «la provincia di Taiwan parte
integrante del territorio cinese»; e completò il quadro con la richiesta che
l’Italia si impegnasse a sostenere la Cina popolare a ottenere il posto che
«legittimamente le spettava» in seno all’Onu, cessando di sostenere i
rappresentanti della “cricca” di Chang Kai-shek. 11 Così, sin dalle prime
battute, le questioni preliminari erano sul tappeto diplomatico. La blanda
reazione del governo degli Stati Uniti eliminava il rischio principale. Né
avrebbe potuto essere diversamente poiché in quello stesso periodo la
politica estera di Nixon si stava avviando a compiere quelle scelte politicoeconomiche che, tra il 1971 e il 1973, avrebbero poi segnato a lungo il
percorso internazionale degli Stati Uniti. In questo ambito, il ristabilimento
di un rapporto con la Cina comunista sarebbe stato, per Washington, un
formidabile passo in avanti, poiché avrebbe isolato l’Unione Sovietica e il
Vietnam dal loro potenziale (ancorché ostile) alleato e avrebbero reso
possibile agli Stati Uniti di compiere scelte più che mai ardite in tutto
l’Oceano Pacifico. Non era certo in contraddizione con tutto questo il passo
che l’Italia si avviava a compiere; non da sola, del resto, ma preceduta o
seguita dal Canada e dal Belgio, anch’essi fedeli membri dell’Alleanza
atlantica. Forse, e davvero, a Washington sarebbe piaciuto di poter
controllare più da vicino le scelte italiane, per evitare che anticipassero un
10
Meloy to Secretary of State, January 28, 1969, NA, NSC, 694.
Cfr. su questa fase e per la relativa documentazione DI NOLFO, La normalizzazione, cit., pp.
15-16.
11
14
Le reazioni americane al riconoscimento italiano della Cina
cammino che si voleva compiere in maniera più graduale, proprio per tenere
la Cina comunista sotto controllo o, comunque, nella posizione di chi
avrebbe dovuto aspettare, oltre che la ripresa dei contatti diplomatici con gli
americani, anche un pieno reintegro nella Comunità internazionale. Ma
questo era un risultato che Nixon e i suoi successori intendevano concedere
gradualmente. 12
3. L'inizio delle trattative italo-cinesi. Le perplessità americane
Le conversazioni italo-cinesi ebbero effettivamente inizio nell'aprile 1969 e
si svolsero sempre a Parigi. Tuttavia, proprio nel medesimo periodo, Nenni
ebbe l’opportunità, il 12 aprile, di incontrare il segretario di Stato Rogers,
che accompagnava il presidente in Europa. Fu, questa, l’occasione perché il
ministro italiano mettesse in chiaro gli obiettivi ai quali egli mirava. Invero,
egli teneva a precisare al collega americano, il Consiglio dei ministri
italiano non aveva ancora discusso formalmente la questione. Ma l’opinione
pubblica vicina ai partiti di maggioranza (il Partito comunista era invece
piuttosto in difficoltà a prendere una posizione precisa, non solo perché esso
era ancora condizionato dalle reazioni interne alla crisi cecoslovacca
dell’agosto 1968, ma anche e soprattutto perché la questione si poneva in un
momento di così acuta ostilità tra Cina e Unione Sovietica che una chiara
presa di posizione sarebbe stata incomprensibile per i militanti del partito)
era convinta della necessità di procedere, non appena da Parigi fossero
giunte notizie precise sulle posizioni cinesi. Posizioni rispetto alle quali
Nenni aveva una sua personale visione che, se pienamente attuata, avrebbe
portato a una rapida conclusione del negoziato. Pensava, infatti, che «l’esito
inevitabile del negoziato» avrebbe segnato la fine delle relazioni dell’Italia
con il governo di Taiwan, poiché la sua pretesa di rappresentare tutta la Cina
era solo «una finzione diplomatica che non corrispondeva alla realtà» e
aggiungeva che, una volta stipulato l’accordo con Pechino, nella successiva
sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il rappresentante
12
Su questi temi esiste una sterminata letteratura. Qui si indicano solo due opere, una di
carattere generale e una intesa a chiarire le fondamenta delle scelte di Nixon. Cfr., infatti, G.C.
HERRING, From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations since 1776, New York, Oxford
University Press, 2008, pp. 775-793; D. BASOSI, Il governo del dollaro. Interdipendenza
economica e potere statunitense negli anni di Richard Nixon (1969-1973), Firenze, Polistampa,
2006, pp. 53-182.
15
Ennio Di Nolfo
italiano, pur ammettendo che la questione rientrava nella categoria delle
“questioni importanti”, cioè tali da richiedere una maggioranza di due terzi
dei voti (art. 18 della Carta dell’Onu), avrebbe votato a favore di tale
interpretazione, come chiedevano gli Stati Uniti, ma poi avrebbe votato a
favore della proposta presentata molti anni prima dall’Albania perché il
rappresentante di Taiwan fosse sostituito da quello del governo di Pechino.
Rogers rispose allarmato. L’espulsione della Cina nazionalista da un organo
del quale aveva fatto parte sin dalla nascita delle Nazioni Unite gli pareva
così grave che egli «non trovava parole sufficientemente forti» per
disapprovarla, tanto più che in quel periodo la polemica dei comunisti cinesi
verso l’Onu mostrava il loro disprezzo verso l’organizzazione. 13
La distanza non sul principio del riconoscimento ma sui modi e sulle
conseguenze non poteva dunque essere più ampia. Né poteva colmarla ciò
che Gaja disse ad Ackley qualche giorno appresso. Si trattava, ancora una
volta, della manifesta evidenza del fatto che tra il ministro e il suo
collaboratore non esisteva una piena e consapevole identità di vedute, come
Gaja apertamente rivelava, valendosi di espressioni divergenti. Gaja, che era
stato presente all’incontro fra Nenni e Rogers del 12 aprile, affermò di
essere «sicuro che Nenni non aveva letto il testo della risoluzione albanese e
dunque non era consapevole delle implicazioni che essa aveva». Per un voto
del genere sarebbe stata necessaria l’approvazione del Consiglio dei ministri
e Gaja affermava che questa non era ancora stata concessa. Aggiunse poi
che Nenni aveva dato assicurazioni a Rogers, durante la presenza di Nixon a
Roma, che l’Italia non avrebbe riconosciuto le pretese di Pechino su
Taiwan; poi, proseguì Gaja di suo, «l’Italia non sarebbe stata così folle da
accettare una condizione che la poteva portare a uno scontro con gli Stati
Uniti nel caso, per esempio, di una richiesta cinese che gli Stati Uniti
ritirassero le loro forze da Taiwan». Piuttosto, pensava il diplomatico
italiano, era possibile che il governo di Taiwan rompesse le relazioni
diplomatiche con l’Italia. Era, quella di Gaja, una rettifica solo ufficiosa,
alla quale si aggiunse l’opinione del ministro Staderini, consigliere
diplomatico di Saragat, allora presidente della Repubblica, anche lui
nettamente avverso al riconoscimento della Cina prima di un accordo sul
Vietnam. 14
13
14
Rogers to Various Embassies, April 12, 1969, NA, NSC, 694.
Ackley to Department of State, April 24, 1969, NA, NSC, 694.
16
Le reazioni americane al riconoscimento italiano della Cina
Pareva a Washington che esistesse una buona dose di ambiguità,
accompagnata da molte oscillazioni, circa i progetti cinesi di Nenni. Si
trattava probabilmente di un gioco delle parti, poiché le affermazioni di
Gaja erano alquanto paradossali, se paragonate con ciò che Nenni aveva
detto al Segretario di Stato americano. In una memoria inviata dal
dipartimento di Stato all’ambasciata a Roma si faceva un’accurata
enumerazione delle prese di posizione italiane che apparivano «non del tutto
sincere». Il 27-28 febbraio, Nenni aveva detto a Rogers, in una sua
precedente visita a Roma, che i negoziati erano da poco stati avviati, che
sarebbe stata necessaria una certa attesa per conoscere il parere cinese, che
l’Italia intendeva appoggiare l’ammissione della Cina comunista alle
Nazioni Unite, ma che avrebbe votato a favore della tesi che inseriva la
decisione tra le “questioni importanti” da decidere con maggioranza
qualificata e avrebbe votato contro la proposta dell’Albania per
un’immediata sostituzione di Taiwan con Pechino. Ma su questo tema,
ancora Nenni si mostrava o poco informato o reticente, poiché,
discutendone ancora con Rogers, nell’aprile, come già si è visto, affermava
che l’Italia avrebbe votato a favore della stessa proposta, dopo averne
ottenuto l’approvazione del governo tutto e tenendo conto degli
orientamenti dell’opinione pubblica. Tesi, questa, che, come si è appena
visto, contraddiceva il parere di Gaja. 15
Il giorno successivo all’invio del memorandum sopra citato, Ackely ebbe
un lungo colloquio con Nenni che lo mise al corrente dello stato delle cose.
Egli non aveva notizie nuove sulle intenzioni cinesi, salvo quelle riguardanti
le tre condizioni preliminari indicate da Yi Su Chich, e restava in attesa di
quel passo cinese che tardava a arrivare forse a causa, reputava giustamente
Nenni, della tensione con i sovietici o della situazione interna cinese, dopo
la fine della “rivoluzione culturale” e in attesa del Congresso del Partito
comunista (che, tra l’altro, avrebbe visto crescere l’influenza
dell’ambasciatore a Parigi, Huang Zhen, richiamato in patria ma avviato a
entrare nel Comitato centrale del partito stesso). Nenni ribadì di aver preso
nella più seria considerazione le obiezioni mossegli da Rogers e che solo il
governo nel suo complesso avrebbe potuto prendere una decisione. Tuttavia,
15
Memorandum by Department of State to U.S. Embassy in Rome, May 8, 1969, allegato B,
NA, Central Files, RG 59, Box 2235. Nello stesso senso cfr. anche Richardson to U.S. Embassy
in Rome, May 13, 1969, NA, NSC, 694.
17
Ennio Di Nolfo
quale che fosse il suo orientamento personale, egli non aveva ancora potuto
prendere una decisione definitiva. Ottorino Borin, consigliere diplomatico
di Nenni, sapeva bene che l’aspetto critico della decisione italiana
riguardava il problema delle Nazioni Unite e del voto sulla mozione
albanese, ma confermava a Ackley che in proposito gli italiani (Nenni
compreso) non avevano ancora preso una decisione definitiva e ciò spiegava
le oscillazione e le ambiguità dei discorsi. A suo parere, l’Italia avrebbe
votato a favore della risoluzione sul concetto di “questione importante” e,
quanto alla proposta albanese, o avrebbe votato a favore o si sarebbe
astenuta, sulla base della convinzione che la tesi albanese non avrebbe
raggiunto i due terzi dei voti necessari. 16 Del resto, nemmeno il presidente
del Consiglio del tempo, Rumor, si sarebbe adoperato, come suggeriva il
suo consigliere diplomatico, ministro Catalano, per trovare una soluzione
soddisfacente a un problema che era ancora «molto aperto». 17
I primi contatti con l’incaricato d’affari cinese a Parigi ebbero luogo
all’inizio di aprile ma non portarono ad alcun esito pratico poiché, delle tre
questioni poste sul tappeto in via preliminare, l’unica effettivamente risolta
e, d’altra parte, mai messa in discussione se non per i tempi nei quali
formalizzare le decisioni, riguardava la disponibilità dell’Italia a riconoscere
la Repubblica popolare cinese come l’unico governo cinese, mentre sulle
altre la discussione restava aperta. Due motivi convergenti contribuivano al
rinvio: le difficoltà interne all’Italia, la crisi del governo Rumor, i dibattiti
nel partito della Democrazia cristiana e l’acuirsi dello scontro sociale che
avrebbe portato ai cosiddetti “anni di piombo”; e le difficoltà interne alla
Cina, dove Mao Zedong e Zou En-lai stavano adoperandosi nel
superamento dei danni provocati dalla “rivoluzione culturale”, nonché nel
problema del rinnovamento delle gerarchie di partito, per non dire
dell’inasprirsi dello scontro con l’Unione Sovietica.
4. Aldo Moro prosegue le trattative
La dilazione contribuì sia a dar corpo a una più definita posizione cinese sia
a rendere possibile che in Italia la crisi di governo fosse superata con la
formazione di un nuovo governo presieduto ancora da Mariano Rumor ma
16
17
Ackley to Department of State, May 10, 1969, NA, NSC, 694.
Ackley to Department of State, May 14, 1969, NA, NSC, 694.
18
Le reazioni americane al riconoscimento italiano della Cina
nel quale il ministero degli Esteri era affidato alla personalità divenuta
dominante nella Democrazia cristiana, cioè a Aldo Moro. A Washington,
l’ambasciatore italiano, Egidio Ortona, presentò la novità come tale da non
provocare cambiamenti 18 e, in effetti, la previsione di Ortona non era
infondata quanto alla sostanza ma piuttosto quanto ai modi. Moro non aveva
l’indole diretta e quasi aggressiva di Nenni; era invece propenso a operare
con estrema cautela, dopo matura riflessione e attenta consultazione dei suoi
collaboratori. Questi, frattanto, erano in parte cambiati, poiché Roberto Gaja
venne subito nominato Segretario generale del ministero degli Esteri,
mentre la direzione generale degli Affari politici veniva affidata a Roberto
Ducci. A Parigi era rientrato l’ambasciatore Francesco Malfatti, che seguì da
vicino il negoziato, lasciandone tuttavia la gestione pratica al suo principale
collaboratore e già incaricato d’affari, Walter Gardini, mentre all’ambasciata
cinese era prossimo a fare ritorno il titolare Huang Zhen.
Moro si rese subito conto della reticenza degli americani. Il 2 settembre
ricevette l’incaricato d’Affari americano a Roma, Wells Stabler, e con lui
ebbe una lunga e, per certi aspetti, serrata conversazione. Stabler ribadì il
punto di vista del suo governo, affermando che gli Stati Uniti erano
«vigorosamente ostili» a qualsiasi minaccia rispetto alla posizione della
Repubblica cinese (cioè di Taiwan) alle Nazioni Unite e sottolineò i rischi e
le conseguenze devastanti di un'ammissione della Cina comunista secondo i
termini che questa proponeva. Aggiunse che si aspettava che l’Italia avrebbe
continuato a seguire l’orientamento americano in relazione al problema
della “questione importante” e contro la proposta di risoluzione albanese.
Moro lo deluse, almeno in parte. L’Italia avrebbe votato a favore della tesi
di “questione importante” ma quanto alla proposta albanese, il governo, nel
suo insieme, non aveva ancora preso una decisione. Personalmente era
favorevole a un’astensione ma questa sarebbe stata presa in considerazione
solo dopo che l’accordo con Pechino fosse stato definito nella forma e nei
particolari. 19 Del resto, egli non aveva davvero nessuna intenzione di
procedere rapidamente e, diversamente da Nenni, il quale prendeva
posizione e poi disponeva che i suoi collaboratori ne tenessero conto,
costituì una commissione di studio che si riunì già il 3 settembre. Stabler
ebbe notizia dei termini della discussione da una fonte diretta, cioè,
18
19
Rogers to U.S. Embassy in Rome, August 28, 1969, NA, NSC, 694.
Stabler to Rogers, September 2, 1969, NA, NSC, 695.
19
Ennio Di Nolfo
verosimilmente, o da Gaja o da Ducci. Seppe, perciò, che Moro aveva
ribadito la volontà del governo di riconoscere la Cina popolare ma «secondo
una procedura più lenta». E seppe che il gruppo considerò accettabile la
prima delle richieste cinesi ma inaccettabili le condizioni successive, talché,
per il momento, la decisione da prendere fu quella di non fare altri passi.
L’Italia avrebbe votato a favore della “questione importante” e si sarebbe
astenuta sulla proposta albanese. Ma su questa intenzione doveva tenersi il
più completo segreto, per evitare che la decisione italiana potesse influire
sugli orientamenti di altri paesi. 20
Un passo fondamentale per il chiarimento (ma forse sarebbe più corretto
dire: per il mancato chiarimento) della maniera in cui Italia e Stati Uniti si
preparavano ad attuare una decisione già presa, almeno in linea di principio,
fu offerto dall’incontro che Moro ebbe il 9 ottobre con il presidente Nixon a
Washington, dove il ministro italiano si era recato in attesa dell’imminente
riunione annuale dell’Assemblea Generale dell’Onu. Come d’abitudine, in
questi casi, i due personaggi avrebbero compiuto una rapida rassegna delle
questioni bilaterali per affrontare poi temi di portata più generale, come per
l’appunto, il tema della rappresentanza cinese alle Nazioni Unite. A quanto
risulta dalle note di lavoro per il colloquio, Nixon ribadì la posizione degli
Stati Uniti in proposito. Aggiunse che gli Stati Uniti erano «fortemente
ostili» all’abbandono o all’espulsione del governo di Taiwan alle Nazioni
Unite, dove esso aveva svolto un «ruolo costruttivo», per lasciar posto alla
Cina comunista. Moro rispose che l’Italia avrebbe votato a favore della tesi
sulla “questione importante” ma che, per ragioni di politica interna, si
sarebbe quasi certamente astenuta sul voto della proposta albanese. 21 Erano,
questi, temi sui quali il ministro degli Esteri italiano ritornò poi a discutere,
senza cambiare linea, anche con il segretario di Stato Rogers. 22
Questa lunga fase di lentezza nel negoziato permise allo stesso Moro di
formarsi un’opinione più approfondita, anche sulla base di motivazioni
20
Stabler to Rogers, September 3, 1969, NA, NSC, 695. È interessante aggiungere che poco
appresso Stabler incontrò l’ambasciatore di Taiwan e gli menzionò sia la volontà di Moro di
agire lentamente, sia l’impressione che il voto italiano sulla risoluzione albanese si sarebbe
tradotto in un’astensione. Ciò che mostrava come il segreto sui propositi italiani avesse avuto
vita assai breve. Stabler to Rogers, September 6, 1969, NA, NSC, 695.
21
Memorandum preparatorio del dipartimento di Stato in vista del colloquio Nixon-Moro del 9
ottobre 1969, con allegati relativi ai temi in discussione, NA, Central Files, RG 59, box 2233.
22
Rogers to Various Embassies, October 10, 1969, NA, RG 59, box 2233.
20
Le reazioni americane al riconoscimento italiano della Cina
giuridiche, 23 dei termini del problema. Una serie di sintomi, e soprattutto le
conversazioni informali in corso a Parigi tra diplomatici italiani e cinesi e,
in particolare, tra l’ambasciatore Malfatti, il ministro Gardini e
l’ambasciatore cinese, Huang Zhen, accompagnato dal nuovo incaricato
d’Affari della Repubblica popolare, Song Qi-guang, lasciavano prevedere
che il momento di por fine alle sottigliezze diplomatiche per prendere
decisioni precise si avvicinava.
Malfatti ebbe, in quei giorni, la possibilità di scambiare idee con
l’ambasciatore Huang Zhen, il quale si espose con lui in dichiarazioni
piuttosto inconsuete contro l’Unione Sovietica, che definì come una potenza
imperialistica che seguiva la stessa politica degli zar. Invece, esisteva «fra il
popolo cinese e quello americano una antica e tradizionale amicizia». 24
Erano, queste, parole che sembravano destinate a placare qualsiasi
preoccupazione italiana rispetto alle reazioni americane verso il
riconoscimento. Gardini pensò che il momento fosse dunque più che mai
favorevole e sostenne subito con Moro la tesi della necessità d’agire
rapidamente. 25 Il suo ottimismo non era tuttavia condiviso da Roma, dove
Moro confidava ancora che con il trascorrere del tempo la posizione italiana
sarebbe migliorata: «Da parte nostra – scrisse a Malfatti – data la situazione,
non ci sembra conveniente dimostrare alcuna fretta di stringere i tempi». 26
La tesi di Moro era che Nenni si fosse spinto innanzi con troppa fretta,
concedendo tutto ciò che i cinesi avevano chiesto, mentre invece si
dovevano confermare le intenzioni senza accompagnarle con riconoscimenti
formali e pretese territoriali. 27
Invero, la lettura che Moro dava alle concessioni che Nenni intendeva
fare appare, alla luce di ciò che risulta dalle fonti e a meno che il ministro
non avesse altre notizie dirette, alquanto forzata. Ma in quel modo egli
prendeva tempo e si sottraeva alle difficoltà contingenti, lasciando che
l’Assemblea Generale votasse ancora una volta sulla questione cinese come
“questione importante” e istruendo la delegazione italiana perché si
23
Cfr. DI NOLFO, La normalizzazione, cit., pp. 29-30.
Malfatti a Moro, 30 settembre 1969, in ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO (d'ora in poi
ACS), Roma, Fondo Moro, Serie 5, s.serie 2, fasc. I, s.fasc. 2.
25
Cfr. DI NOLFO, La normalizzazione, cit., pp. 28-29.
26
Moro a Malfatti, 1° ottobre 1969, ACS, Fondo Moro, collocazione citata.
27
Annotazione di Moro, 8 novembre 1969, ACS, Fondo Moro, collocazione citata.
24
21
Ennio Di Nolfo
astenesse dal voto sulla risoluzione albanese, per contribuire alla sua
mancata approvazione. Così, si otteneva un anno di respiro, durante il quale,
sperava il ministro italiano, sarebbe stato possibile eliminare il divario che
separava le tesi italiane da quelle americane e, al tempo stesso, riprendere
formalmente i negoziati, che dal precedente mese di aprile non avevano
fatto alcun progresso.
5. Moro prospetta una soluzione di compromesso
Durante questa parentesi, Moro e i suoi collaboratori escogitarono una
soluzione che in linea di principio potesse apparire soddisfacente per i
cinesi. Dopo tutto, egli affermava e incaricava Malfatti di affermare, la
questione di Taiwan si poneva in due modi: come problema giuridico e
come problema geografico. Questo secondo aspetto non poteva essere
oggetto di discussione diplomatica; quanto alla questione giuridica, essa
riguardava un tema che esulava dalla competenza italiana, poiché Roma
poteva solo prendere atto del punto di vista cinese, senza necessariamente
farlo proprio. Di qui scaturiva l’idea di risolvere la situazione con un tipico
escamotage diplomatico. Secondo questa tesi, sarebbe stato opportuno che
fosse elaborato un documento generico nel quale le parti annunciassero il
reciproco riconoscimento. Questo documento sarebbe stato accompagnato
da due dichiarazione parallele ma distinte, dal tenore omogeneo. Il punto
critico restava però il caso di Taiwan poiché la tesi italiana era che i cinesi
affermassero il loro punto di vista, secondo il quale Taiwan era “parte
integrante” del loro Stato, e gli italiani esprimessero “rispetto” per questa
affermazione. Ma è evidente che il “rispetto” era una dizione troppo
evanescente per essere accettabile. Quando la proposta fu portata a
conoscenza in modo informale ai cinesi, questi chiesero che l’espressione
fosse cambiata con quella, ben più cogente e puntuale, secondo la quale gli
italiani “riconoscevano” la fondatezza dell’affermazione cinese. Dietro
l’apparenza di una sottigliezza diplomatica si celava pertanto un problema i
cui termini non erano modificati. Era il problema di fare in modo che, nel
riconoscere la Cina, anche accettando la sua ammissione all’Onu, l’Italia
non disconoscesse ufficialmente Taiwan e rendesse possibile il
conseguimento di due risultati importanti: il mantenimento di una
rappresentanza ufficiale o ufficiosa cino-nazionalista a Roma e
l’acquiescenza ai desideri della diplomazia americana, che apprezzava lo
22
Le reazioni americane al riconoscimento italiano della Cina
sviluppo economico di un'isola che negli anni era divenuta un laboratorio
industriale e un serbatoio di manodopera a basso costo per l’industria
elettronica americana.
L’ambasciata degli Stati Uniti a Roma venne costantemente informata
delle varianti in corso di preparazione. Si trattava delle formule già citate
oppure di formule come quella che immaginificamente ipotizzava la
possibilità che la clausola del riconoscimento fosse “ammorbidita”
aggiungendo l’espressione che la Repubblica popolare era riconosciuta «as
sole representative of China», un’espressione improponibile poiché tale da
non escludere la possibilità che esistesse un’altra Cina, non riconosciuta
dall’Italia ma pur sempre esistente. 28
Poche settimane dopo questa “pausa di riflessione”, i negoziati italocinesi vennero ripresi in serrate conversazioni, svolte tra il 4 e l’8 dicembre
e ben rappresentative della difficoltà di superare ostacoli immaginari o, se si
vuole, dell’abilità dei diplomatici di complicare le questioni semplici.
Quando la delegazione cinese ebbe notizia del progetto italiano di
“rispettare” il punto di vista degli interlocutori, il negoziato fu sul punto di
fallire. Nenni non aveva formulato nessuna ipotesi analoga, si osservò, e le
nuove proposte italiane erano inaccettabili. Il rischio che tutto fosse frenato
da una sola parola colpì Moro, che raccomandò a Malfatti e Gardini di
evitare questo fiasco. Moro sentì il bisogno di consultare il presidente del
Consiglio Rumor e questi raccomandò prudenza. Da parte americana si fece
notare che la questione di Taiwan era davvero importante per Washington,
ma appariva dubbio che avesse un’effettiva importanza per l’opinione
pubblica italiana. 29 Così, per qualche tempo, le diplomazie dei due paesi
valutarono la diversità ma anche l’irrilevanza dei punti di vista. 30
A quella fase di intensa consultazione seguirono alcuni mesi di silenzio. I
cinesi chiesero una dilazione, per consultare Pechino sull’ipotesi di affidare
il riconoscimento a tre documenti separati. Al tempo stesso l’Italia venne
investita dalla prima fase della lunga crisi interna, aperta dall’attentato
compiuto il 12 dicembre contro la Banca nazionale dell’Agricoltura a
Milano. Il governo Rumor dovette dimettersi ma Moro rimase ministro
28
Stabler to Rogers, November 21, 1969, NA, NSC, 695.
Martin to Rogers, December 17, 1969, NA, NSC, 695; cfr. anche Martin to Rogers,
December 19, 1969, NA, NSC, 695.
30
Martin to Rogers, December 19, 1969, NA, NSC, 695.
29
23
Ennio Di Nolfo
degli Esteri nel governo successivo, formato ancora da Rumor, così come in
quello guidato, mesi dopo, da Emilio Colombo. Perciò la direzione della
politica estera non cambiò mano. Solo nel marzo 1970 le cose ripresero a
muoversi e, nonostante le incertezze, non incontrarono più ostacoli, se non
quelli che lo stesso Moro aveva costruito con le sue formule. Lo scontro sui
termini “rispetto” e “riconoscimento” continuò per alcuni mesi. Da
principio parve che i cinesi fossero disposti a accettare formule intermedie
tali da non costringere l’Italia a una brusca rottura con Taiwan.
Gradatamente si fece però strada il concetto che Pechino non avrebbe fatto
alcuna concessione su un tema che, posto nel modo in cui lo proponevano
gli italiani, avrebbe portato a una soluzione umiliante.
Si trattò di un negoziato lungo e, per molti aspetti, estenuante. Quando
esso si avvicinò alla conclusione, il presidente del Consiglio, Colombo, che
nutriva più di Rumor interesse per le questioni di politica internazionale,
volle verificare la posizione americana. Alla fine dell’ottobre 1970,
accompagnato dal suo consigliere diplomatico, Bottai, ebbe un lungo
incontro con Stabler che gli trasmise i precisi orientamenti americani. A
Washington si auspicava che il governo italiano rinviasse le sue decisioni
sino a dopo l’imminente Assemblea Generale dell’Onu. Visto il margine
ristretto con il quale, l’anno prima, le tesi americane si erano affermate,
esisteva infatti la possibilità che un mutato atteggiamento italiano potesse
capovolgere l’esito della votazione. Ciò anche in vista dell’opportunità di
ritardare il momento in cui l’ambasciatore di Taiwan, una volta privato di
piena legittimità, decidesse precipitosamente di lasciare Roma. La risposta
di Colombo non fu del tutto soddisfacente. Per il governo italiano si trattava
di non provocare reazioni “spiacevoli” da parte dei suoi interlocutori cinesi.
Tuttavia, non vi sarebbe stato, da parte italiana, alcun gesto tale da spingere
Taiwan a decisioni frettolose e Roma avrebbe atteso che fossero i cinonazionalisti a prendere le decisioni che ritenevano corrette. Stabler opinava
che se nel testo dell’accordo italo-cinese non vi fossero state allusioni a un
impegno di rottura delle relazioni con Taiwan, non vi sarebbe stato motivo
perché l’ambasciatore del governo di Taipei si ritirasse da Roma. Tuttavia,
questa era una lettura troppo ottimistica delle stato delle cose. Una volta che
l’Italia avesse riconosciuto la Repubblica popolare cinese, quale che fosse la
24
Le reazioni americane al riconoscimento italiano della Cina
formula del documento, era ovvio che i cino-nazionalisti avrebbero
considerato interrotte le relazioni con Roma. 31
Le preoccupazioni americane erano per il momento infondate. Ancora
una volta il negoziato, che non incontrava più se non marginali ostacoli
obiettivi, salvo ciò che riguardava l’ambiguità italiana nella scelta se
“riconoscere” o “rispettare” le tesi cinesi, venne interrotto. Nella
Repubblica popolare, superata la rivoluzione culturale, era in pieno
svolgimento lo scontro tra Mao Zedong e la cosiddetta “banda dei quattro”,
capeggiata dal generale Lin Biao, il quale godeva dell’appoggio
dell’esercito. Questo conflitto interno, accompagnato dal riaccendersi della
tensione nella penisola indocinese, dopo il colpo di stato compiuto dal
primo ministro cambogiano Long Nol, il quale, appoggiato dagli Stati Uniti,
aveva detronizzato il re Norodom Sihanouk nella speranza di frenare la
neutralità cambogiana rispetto alla guerra nel Vietnam e, in particolare, nel
desiderio di impedire che il “sentiero di Ho Ci Minh”, situato in gran parte
nelle foreste e nelle montagne cambogiane, fosse utilizzato dai vietnamiti
per sostenere la guerra nel sud del paese, poneva una serie di problemi che
si riflettevano sulla capacità generale del governo cinese di prendere
decisioni rispetto ai rapporti con gli Stati Uniti e con i loro alleati. Solo
nella tarda estate del 1970 queste difficoltà interne e internazionali furono
superate con un pieno successo di Mao Zedong, appoggiato da Zhou En-lai
e da Deng Xiaoping (che da ultimo aveva recuperato la sua influenza), e
divenne dunque possibile riprendere i negoziati, che entrarono, questa volta,
nella fase conclusiva.
Non era chiaro se i cinesi fossero ancora d’accordo sull’ipotesi di
formulare tre documenti separati: un comunicato recante la notizia del
reciproco riconoscimento e due dichiarazioni parallele ma conformi, che
indicavano le rispettive interpretazioni del riconoscimento. Da parte cinese
venne infatti presentato un testo che esprimeva tre concetti ma, ancora una
volta, definiva il proprio punto di vista in maniera molto netta. Se il governo
italiano riconosceva quello cinese, esso doveva anche seguire il concetto per
cui «riconosceva che il governo della Repubblica popolare di Cina era
l’unico governo legittimo della Cina». 32 Si ripeteva, ancora una volta, il
discrimine fra le due tesi. Dato che la questione non riguardava solo un
31
32
Stabler to Rogers, October 26, 1970, NA, NSC, 695.
Cfr. DI NOLFO, La normalizzazione, cit., p. 39.
25
Ennio Di Nolfo
tema geografico ma presupponeva che l’Italia rispettasse anche «la
sovranità e l’integrità territoriale» della Cina comunista, l’assunzione di
questo principio esprimeva indirettamente che l’Italia riconosceva
l’appartenenza di Taiwan alla Repubblica popolare.
A tutto questo si rispose da parte italiana avanzando una serie di
questioni minori riguardanti i beni e gli interessi italiani in Cina. Nessuno di
questi temi toccava l’aspetto critico del negoziato. Gradualmente il
negoziato si spostò allora su un piano diverso. I cinesi avrebbero accolto la
tesi italiana dei tre documenti separati, ma di questi solo il primo avrebbe
avuto un contenuto del tutto conforme al punto di vista cinese; le
dichiarazioni separate, sull’accoglienza del principio generale del
riconoscimento, avrebbero espresso l’interesse delle parti a dirimere le
controversi minori, di carattere tecnico o patrimoniale.
In termini diversi, si deve dunque osservare che, nelle parentesi del
negoziato, Moro e i suoi collaboratori si erano gradualmente avvicinati alla
tesi di una piena acquiescenza verso i desiderata della diplomazia cinese. Il
che pone la questione di capire le motivazioni interne e internazionali di tale
svolta e di considerare come da parte degli Stati Uniti questo cambiamento
fosse accolto. A tale proposito è sufficiente osservare che da parte
dell’opinione pubblica italiana non direttamente interessata ai termini
particolareggiati dei documenti diplomatici, le diverse formulazioni non
avevano che una rilevanza marginale. Nella direzione dei partiti vi fu una
certa contrapposizione poiché il Partito repubblicano, e in particolare Ugo
La Malfa, era favorevole a un rinvio ma, visto l’orientamento del governo,
auspicava solo che la delegazione italiana votasse ancora a favore della
mozione “questione importante”, così da dilazionare l’ammissione della
Cina comunista all’Onu e mostrare solidarietà verso le tesi degli Stati
Uniti. 33 Per i socialdemocratici, Saragat, allora presidente della Repubblica,
accolse le notizie inviategli da Moro in termini aspri e polemici. A suo
parere, si doveva riconoscere la Repubblica popolare cinese (come del resto
egli aveva sostenuto sin dal 1964) ma non si doveva accettare che Taiwan
fosse espulsa dalle Nazioni Unite. 34 Tuttavia, né i repubblicani né i
33
Stabler to Rogers, October 30, 1970, NA, NSC, 695.
Lettera manoscritta di Moro a Saragat, 2 novembre 1970 e risposta di Saragat a Moro, 3
novembre 1970, ACS, Fondo Moro, collocazione citata.
34
26
Le reazioni americane al riconoscimento italiano della Cina
socialdemocratici avevano una forza politica sufficiente per affermare il
loro punto di vista.
6. L'esito del negoziato
Da parte statunitense si ebbe invece un graduale cambiamento di opinioni
che rese più facile la decisione di Moro, pur senza contribuire a spiegarne le
reali modificazioni. Un primo lievissimo sintomo del cambiamento si ebbe
alla fine del mese di ottobre quanto Stabler ammise che la diversità di
opinioni esistente in seno al governo italiano non era tale da modificare le
decisioni già prese. Perciò, le riserve americane si riducevano alla
raccomandazione che la delegazione italiana all’Onu votasse a favore della
tesi “questione importante”, e facesse poi ciò che riteneva opportuno in
relazione alla proposta albanese. Ciò significava che da parte statunitense si
sperava ancora che l’Assemblea Generale tenesse fermo l’ostacolo della
votazione a maggioranza di due terzi, così da rendere irrilevante il progetto
albanese. Un’altra raccomandazione era che la notizia del riconoscimento
fosse data al governo di Taiwan «con il minimo di informazioni necessarie»,
così da evitare una rottura precipitosa. 35 Importava agli americani che
l’ambasciata taiwanese a Roma non fosse messa nella condizione di
prendere brusche decisioni. Una tesi, questa, alla quale Gaja rispose
affermando che gli italiani si attendevano che da parte degli Stati Uniti non
vi fossero pressioni sui cino-nazionalisti perché pretendessero di mantenere
aperta la loro ambasciata a Roma, dato che ciò si sarebbe ripercosso sui
nuovi rapporti italiani con la Cina comunista. L’ambasciatore nazionalista a
Roma sarebbe stato trattato con ogni forma di cortesia, e per un certo tempo
avrebbe continuato a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche.
Tuttavia, subito dopo il riconoscimento formale della Repubblica popolare,
egli sarebbe stato considerato come privo di qualsiasi funzione di
rappresentanza. 36 Ma negli stessi giorni, l’ambasciatore italiano a
Washington, Ortona, incontrava il sottosegretario di Stato, Johnson, e
discuteva con lui anche della questione cinese. Il tenore della conversazione
fu, in proposito, tutt’altro che ostile alle decisioni che il governo italiano si
apprestava a prendere. Così Johnson, se quanto riferisce Ortona nelle sue
35
36
Stabler to Rogers, October 30, 1970, NA, NSC, 695.
Stabler to Rogers, November 2, 1970, NA, NSC, 695.
27
Ennio Di Nolfo
memorie corrisponde alle parole dette dal suo interlocutore, caldeggiò
l’iniziativa dell’Italia come promotrice di «una svolta nei rapporti con la
Cina comunista», e aggiunse persino: «La diplomazia italiana è certo capace
di tentare tanto: sarà un ponte gettato per tutti a cominciare dagli Stati
Uniti». 37 L’unica condizione era che l’iniziativa italiana non contribuisse
all’espulsione di Taiwan dalle Nazioni Unite.
Spiegare il cambiamento statunitense è, in definitiva, sufficientemente
facile, se si tien conto del fatto che da mesi tra Stati Uniti e Repubblica
popolare cinese erano ripresi quei segreti contatti che, nel 1971, avrebbero
portato al palese riavvicinamento tra le due potenze. Spiegare il
cambiamento italiano appare invece più arduo. Un certo peso poteva essere
stato esercitato dal fatto che i paralleli negoziati tra la Cina popolare e il
Canada fossero stati conclusi rapidamente, prima che, all’inizio di
novembre, fossero resi pubblici i documenti riguardanti l’Italia. Tuttavia, a
ben guardare, questo era solo un aspetto esteriore della questione, poiché al
cuore del negoziato italo-cinese vi erano problemi intrinseci, non collegati
al contesto diplomatico. Quando i documenti congiunti furono sottoscritti, il
5 novembre 1970, e resi pubblici, risultò evidente che, sul piano dei rapporti
tra l’Italia e Taiwan, l’Italia aveva ceduto alla versione cinese e aveva
accettato di “riconoscere” e non solo “rispettare” la tesi secondo la quale il
governo di Pechino rappresentava tutta la Cina, intesa in senso geografico,
cioè comprendente anche Taiwan. Era una tesi che Nenni aveva sposato sin
dall’inizio e rispetto alla quale si erano poi svolti due anni di estenuanti
trattative, ma che ora veniva pienamente rispolverata e solennemente
affermata.
Quasi ciò non bastasse, anche i problemi collaterali furono risolti in
modo difforme dai desideri americani. L’ambasciatore di Taiwan a Roma,
Hsu, sperava che gli fosse concessa la possibilità di restare a Roma ancora
per qualche tempo, fruendo del passaporto cino-nazionalista. 38 Poche ore
dopo, Stabler, l’incaricato d’affari americano, chiese a Gaja di riprendere la
tesi adombrata da Colombo, che il governo italiano non compisse «alcun
gesto» tale da costringere il rappresentante cinese a lasciare Roma. Gaja
ribatté che «it was too late to tray such a ploy»; troppo tardi perché un
atteggiamento del genere avrebbe riportato le cose al loro inizio e ciò non
37
38
ORTONA, Anni d’America. La cooperazione 1967-1985, cit., pp. 257-259.
Stabler to Rogers, November 3, 1970, NA, NSC, 695.
28
Le reazioni americane al riconoscimento italiano della Cina
era tollerabile, visti i pareri dominanti nella situazione interna italiana: «Gli
uomini politici si preoccupavano poco dei termini e delle condizioni
riguardanti la creazione di una rappresentanza italiana a Pechino. Ciò che
essi desideravano era il riconoscimento della Repubblica popolare cinese,
con tutte le conseguenze che ciò implicava». Mantenere rapporti con
Taiwan era ormai impossibile e anche il desiderio dell’ambasciatore Hsu di
restare forse a Milano, con funzioni commerciali, avrebbe suscitato subito
reazioni politiche. 39 Alla successiva Assemblea Generale dell’Onu l’Italia
avrebbe però votato sia a favore della tesi “questione importante” sia a
favore della proposta albanese.
Sebbene la svolta italiana sia in parte spiegata dalle considerazioni sin
qui svolte, resta ancora da comprenderne le motivazioni più profonde;
quelle motivazioni che avrebbero portato l’anno successivo l’Italia a
prendere ancora più esplicitamente posizione a favore delle tesi cinesi. Ma
proprio uno sguardo alle conversazioni tra Moro, l’ambasciatore
statunitense a Roma, Martin, e, poco dopo, tra Moro e Nixon consentono di
formulare ipotesi più argomentate e comunque tali da far comprendere
l’intimo significato dalla scelta italiana. Infatti, se nel 1970 gli americani
erano riusciti a salvare l’appartenenza di Taiwan alle Nazioni Unite, nel
1971 essi avrebbero subito una sonora sconfitta, alla quale non furono
estranee le scelte italiane e che da parte italiana venne spiegata con
abbondanza di argomenti.
Nel primo di questi colloqui, del 2 ottobre 1971, Moro ribadì che «come
sempre l’Italia desiderava convenire con i desiderata degli Stati Uniti,
alleato e grandissimo amico». Tuttavia, il riconoscimento della Cina come
“solo governo legittimo” di quel paese rendeva più difficile ora un’eguale
convergenza di comportamenti. Del resto, «in Italia tutti i partiti avevano
lodato la visione e il coraggio delle iniziative cinesi del presidente Nixon, il
progetto dell’imminente viaggio in Cina con tutto ciò che sarebbe venuto in
seguito, come un cambiamento della posizione americana rispetto alla
presenza della Cina comunista all’Onu». Aggiunse che «esisteva una grande
differenza tra la flessibilità e lo spazio di manovra di una grande potenza,
come gli Stati Uniti, e i confini ben più stretti imposti all’Italia per effetto
dei limiti della sua forza e della sua influenza nei rapporti di potenza
globali». Perciò, egli sperava che da parte americana si comprendessero «le
39
Stabler to Rogers, November 4, 1970, NA, NSC, 695.
29
Ennio Di Nolfo
motivazioni del comportamento che la delegazione italiana avrebbe tenuto
nella successiva Assemblea Generale delle Nazioni Unite». 40 Martin rispose
a queste flautate allusioni con una certa durezza. Gli americani capivano le
ragioni italiane ma non condividevano il proposito di un voto diverso nelle
due questioni poste alle Nazioni Unite e disse: «L’Italia, che possiede un
prestigio meritatamente conquistato, come campione delle nazioni minori
non può con leggerezza sbarazzarsi di questa posizione, conquistata così
faticosamente e così lentamente, con un voto» diverso da quello che aveva
espresso in passato. E Moro doveva capire che sebbene in Italia esistessero
questioni di consenso interno, anche negli Stati Uniti l’azione di Nixon
doveva fronteggiare reazioni interne difficili, soprattutto se queste non
fossero state appoggiate dagli alleati. Concluse con espressioni quasi
minacciose, ammonendo il ministro italiano circa la possibilità «che se
avesse scelto di votare contro il presupposto della “questione importante”,
sarebbe stato accolto [nell’imminente visita a Washington] assai
freddamente e avrebbe pregiudicato obiettivi di maggiore importanza per lui
personalmente e per l’Italia». Inoltre, Martin sentenziava che ben presto
Taiwan sarebbe ritornata a controllare tutta la Cina e comunque avrebbe
mantenuto la sua indipendenza, come anche i sovietici e i giapponesi
calorosamente desideravano. Ma furono pressioni inutili. Moro rispose che
avrebbe riflettuto su ciò che gli era stato detto ma che questa volta gli
italiani non sarebbero ritornati sui loro passi. 41
La determinazione dalla quale mostrò di essere ispirato il ministro
italiano aveva dunque motivazioni generali, che vennero chiaramente in
luce durante il lungo colloquio di quasi un’ora che egli ebbe con Nixon,
presente Kissinger, l’11 ottobre a Washington. Al centro della discussione vi
fu la questione dell’imminente votazione alle Nazioni Unite ma diversi
accenni di Moro mostrano come l’atteggiamento italiano non fosse che una
delle conseguenze della crescente tensione che, proprio tra il 1970 e il 1971,
si era sviluppata tra gli Stati Uniti e l’Europa. Si avvicinava la fine di
un’epoca. Gli europei mostravano, con le loro scelte di politica comunitaria,
monetaria e agricola, non di voler spezzare il loro rapporto con gli alleati
americani ma di volerlo allentare, scegliendo secondo criteri propri,
soprattutto quando essi non condividevano né l’azione degli Stati Uniti nel
40
41
Martin to Rogers, October 3, 1971, NA, NSC, 695.
Ibid.
30
Le reazioni americane al riconoscimento italiano della Cina
Vietnam, sul piano politico, né l’ostilità verso un dialogo globale con
l’Unione Sovietica, al quale Nixon anteponeva il dialogo bilaterale,
considerando con freddezza prima i negoziati per la preparazione della
Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa (che nel 1975
avrebbero portato all’Atto finale di Helsinki) e poi l’Ostpolitik avviata dal
cancelliere Brandt. A tutti questi motivi di dissenso più o meno palese, si era
poi aggiunta, nell’agosto 1971, la decisione con la quale Nixon paralizzava
gli accordi di Bretton Woods del 1944, adottava misure protezionistiche e
decretava la fine della libera convertibilità del dollaro secondo il tasso di
cambio con l’oro stabilito nel 1944. 42 Sin dal febbraio 1970, l’ambasciatore
americano presso la CEE aveva rilevato come e quanto lo scontento nei
confronti della CEE «stesse aumentando negli Stati Uniti, molto più di
quanto non trasparisse dalle prese di posizione ufficiali o dalle discussioni
bilaterali riservate». 43
La conversazione tra Moro e Nixon si svolse in termini bilaterali ma
avendo sullo sfondo il quadro generale appena tracciato: un quadro che
spiega le scelte del ministro degli Esteri italiano nel 1970 e la rigidità con la
quale vennero attuate nel 1971. Per Nixon, negare che la questione della
rappresentanza cinese fosse “importante” sarebbe stato «un precedente
disastroso», tale da portare potenzialmente persino alla fine
dell’organizzazione. Egli non intendeva «fare pressioni sul governo sovrano
e indipendente di un paese amico», ma semplicemente spiegare perché gli
Stati Uniti consideravano la questione come «essenziale». La risposta di
Moro rese però manifesto il genere di argomentazioni al quale egli
intendeva collegarsi. Nixon aveva alluso alla nascita di «nuovi centri di
influenza» e l’Italia apparteneva a uno di questi, cioè all’Europa nel suo
complesso, un’Europa che intendeva «trovare risposte comuni al maggior
numero possibile di questioni», come le questioni economiche e monetarie.
Il voto sulla questione cinese veniva così collegato all’insieme delle
relazioni euro-americane del momento, ma l’unico appiglio che Kissinger,
dopo aver alluso al suo viaggio in Cina, riuscì a elaborare, fu quello di una
possibile analogia con il caso del doppio voto concesso all’Unione Sovietica
e alla Bielorussia, come precedente di un’eguale soluzione per la Cina e
Taiwan. Discussero poi di altri temi ma Moro concluse l’incontro
42
43
BASOSI, Il governo del dollaro, cit., pp. 100-169.
Cit. ibid., p. 121.
31
Ennio Di Nolfo
sottolineando l’attesa di ulteriori e rapidi sforzi americani «per risolvere i
problemi economici e finanziari sul tappeto». 44 Non occorre essere un
sottile esegeta per comprendere come tale questione condizionasse come
una nube oscura il dialogo e come nessuna delle parti potesse uscirne
soddisfatta. Fu compito del presidente del Consiglio, Colombo, comunicare
al presidente americano, il 25 ottobre, che la delegazione italiana, nel voto
sulla questione procedurale, si sarebbe astenuta. 45
Nelle sue memorie, Kissinger, che notoriamente non nutriva un
particolare afflato di simpatia verso Moro, non dice nulla dell’incontro
dell’11 ottobre ma ricorda quasi con furore come, proprio il 25 ottobre,
l’Assemblea Generale avesse votato sulla questione procedurale che venne
respinta con 59 voti contro 55 e 15 astensioni. Tutti i paesi della Nato, egli
ricorda, con l’ eccezione del Lussemburgo, del Portogallo e della Grecia,
avevano votato no o si erano astenuti. Così la risoluzione albanese, che
chiedeva l’immediata sostituzione del rappresentante di Taiwan con quello
della Repubblica popolare cinese, venne approvata a grande maggioranza.
Gli sforzi compiuti per trovare una diversa via d’uscita erano stati vani. Una
volta che gli Stati Uniti avevano mostrato di aver cambiato posizione verso
la Cina comunista, gli alleati furono lieti «di compiacere i partiti di sinistra,
e ancor più di sfidare gli Stati Uniti». 46
44
Conversation between Nixon and Moro, October 11, 1971, with the partecipation of
Kissinger and Ortona, NA, NSC, 695.
45
Colombo to Nixon, October 25, 1971, NA, NSC Files–Subject Files, Presidential
Correspondence–Italy, box 756.
46
H.A. KISSINGER, White House Years, Boston-Toronto, Little, Brown and Co., 1979, pp. 784785.
32
Eunomia. Rivista semestrale del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Eunomia 1 n.s. (2012), n. 1, 33-48
e-ISSN 2280-8949
DOI 10.1285/i22808949a1n1p33
http://siba-ese.unisalento.it, © 2012 Università del Salento
Antonio Donno
La rivoluzione americana: evento locale o globale? 1
Abstract: According to Hannah Arendt, the American Revolution was a local event
without any immediate international influence, unlike the French one, which affected the
history of continental Europe. Many years later, Robert Nisbet has overturned Arendt’s
reflections, showing that the American Revolution had a non secondary impact on XIX
century European events, with a pivotal legacy for the future of democracy. The article
analyses the relative positions of both scholars, enriching them with further points of
views, which during the years have shown how the American Revolution had a wide
influence on Europe and on other parts of the world.
Keywords: American Revolution; United States-Europe Relations; American Liberalism.
In On Revolution, del 1963, Hannah Arendt scriveva: «La triste verità
sulla questione è che la rivoluzione francese, che terminò in un disastro,
è diventata storia del mondo, mentre la rivoluzione americana, che ebbe
un esito trionfante, è rimasta un evento di importanza poco più che
locale». 2 La Arendt concludeva con queste parole la sua analisi del
significato di “rivoluzione”, termine che, a suo dire, si attagliava
maggiormente alla Francia, piuttosto che al Nord America: «Fu la
rivoluzione francese, e non quella americana, che infiammò il mondo, e
di conseguenza fu dal corso della rivoluzione francese, e non dal corso
degli eventi in America o dagli atti dei Founding Fathers, che il nostro
uso attuale della parola “rivoluzione” ha ricevuto le sue connotazioni e
le sue sfumature in ogni parte del mondo, non esclusi gli stessi Stati
1
Il presente articolo è la versione rivista e ampliata della relazione letta in
occasione del Convegno Internazionale “L'età delle rivoluzioni, 1770-1870”,
svoltosi a Roma il 21 maggio 2010 presso il Consiglio Nazionale delle
Ricerche.
2
H. ARENDT, On Revolution, Harmondsworth, UK, Penguin Books, 1973
(1963), p. 56 [trad. it.: Sulla rivoluzione, con un saggio di R. ZORZI, Milano
1983].
Antonio Donno
Uniti». 3 La Arendt definiva “triste” tale esito non tanto per il risultato
immediato dei due eventi, ma perché il lascito della rivoluzione francese
è stato nefasto per la storia mondiale del Novecento, il “secolo dei
totalitarismi”. 4 Non si può, però, tralasciare il fatto che il XX secolo sia
stato anche definito, significativamente, “il secolo americano”, 5 per
l'influenza che gli Stati Uniti hanno avuto nella storia mondiale, ed
europea in particolare, un’influenza di ben altro segno se confrontata
con la terrificante eredità che l’estremismo giacobino della rivoluzione
francese ha lasciato in dote alle vicende totalitarie del continente
europeo. 6 Questa semplice constatazione, credo inoppugnabile, sarebbe
sufficiente per concludere che la rivoluzione americana fu certo, nel suo
farsi, un evento locale, soprattutto a causa della distanza che la separava
dalle vicende europee, ma ebbe un impatto ed un’influenza che nel
tempo si dimostrarono fondamentali per la storia del mondo.
Del resto, la stessa Arendt ammetteva che il messaggio della
rivoluzione americana – un messaggio che al suo tempo era impossibile
che in Europa fosse percepito in pieno nel suo impatto rivoluzionario –
3
Ibid., p. 55.
Lo intuì già nel 1800 F. VON GENTZ nel suo L’origine e i principi della
rivoluzione americana a confronto con l’origine e i principi della rivoluzione
francese, intr. di R.A. KIRK, pref. di J.Q. ADAMS, a cura di O. EBRAHIME,
Milano, Sugarcoedizioni, 2011.
5
Nel 1902 (!) il giornalista e scrittore americano W.TH. STEAD pubblicò un libro
dal titolo profetico: The Americanization of the World, or The Trend of the
Twentieth Century, New York-London, H. Markley, 1902. Qualche anno più
tardi, dopo un viaggio negli Stati Uniti, il celebre scrittore inglese H.G. WELLS
pubblicherà The Future in America: A Search after Realities, New York and
London, Harper & Brothers, 1906.
6
Sul tema, di fondamentale importanza è il libro di G. FERRERO, Le due
rivoluzioni francesi (Milano, SugarCo, 1986; I ed. francese: 1951, a cura di L.
MONNIER), in cui l'A. distingue la prima rivoluzione francese, quella liberale del
1789, da quella giacobina e totalitaria del giugno 1793, ribadita nel 1799. Tale
decisiva distinzione rappresenterà un paradigma ineludibile per la gran parte
degli studi successivi sulla rivoluzione francese. «Questo dualismo di
rivoluzioni – scrive Ferrero – lacera ancora oggi il mondo dopo
centocinquant'anni. La lotta attuale non ne è che il prolungamento. Gli
anglosassoni si battono per la rivoluzione dell'89, i regimi totalitari per quella
del '99» (p. 122). Su tali aspetti del pensiero di Ferrero, cfr. N. BERTI, Guglielmo
Ferrero e la crisi della civiltà liberale, in «MondOperaio», XI, n.s., 1, gennaiofebbraio 2006, pp. 92-108.
4
34
La rivoluzione americana: evento locale o globale?
fu quello di «[...] portare alla ribalta la nuova esperienza americana e la
nuova concezione americana del potere». 7 Ma, nei decenni successivi,
specialmente dopo le rivoluzioni liberali europee del 1948, questo
messaggio divenne sempre più chiaro ai rivoluzionari europei: la forma
repubblicana di governo, basata sul principio federale. Così, dalla metà
dell'Ottocento in poi, si diffuse la convinzione che l’esperimento
americano, che si andava ancor più consolidando dopo la guerra civile,
proiettava sul Vecchio Continente un messaggio di democrazia, fondata
su una solida base liberale, ben più convincente rispetto alle speranze
tradite della rivoluzione francese. Gli esiti della Grande Guerra, tuttavia,
ma ancora prima il diffondersi tra le masse dei lavoratori del socialismo
rivoluzionario – anti-borghese, anti-liberale, anti-capitalista, in una
parola anti-moderno – cancellarono ben presto i germi di liberalismo e
riportarono alla luce quelle forze e quegli impulsi anti-borghesi che
erano scaturiti dalla rivoluzione francese, che si erano sedimentati nel
corso di tutto l'Ottocento e che daranno vita a quel prodotto politico
tipicamente europeo che sarà il totalitarismo. Cioè, se la mentalità e la
cultura borghesi consolidavano la democrazia liberale americana, in
Europa l’odio anti-borghese generava il sistema totalitario sulla falsariga
dell’estremismo giacobino della rivoluzione francese; e mentre negli
Stati Uniti la stessa borghesia imprimeva un impulso straordinario
all’economia capitalistica, in Europa il disprezzo per la cultura borghese
tarpava le ali alla libera iniziativa ed esaltava la funzione demiurgica
dello Stato. A questo proposito scrive Luciano Pellicani: «Con la
conquista del potere da parte dei giacobini, la rivoluzione francese uscì
dai binari del liberalismo per imboccare la via della democrazia
totalitaria. […] Nelle loro mani il liberalismo divenne qualcosa di
profondamente differente da quello inglese e, alla fine, “invece di
sostenere la limitazione del potere dei governi giunse a sostenere
l’ideale dei poteri illimitati della maggioranza”». 8
Ma torniamo alla questione posta dalla Arendt. Ella, nel prosieguo
del suo libro, parlava della rivoluzione americana come di «[...] un
avvenimento di straordinaria grandezza e di enorme importanza per il
7
ARENDT, On Revolution, cit., p. 166.
L. PELLICANI, Anatomia dell’anticapitalismo, Soveria Mannelli, Rubbettino,
2010, p. 39. La citazione interna a quella di Pellicani è tratta da F.A. VON HAYEK,
Studi di filosofia, politica ed economia, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1998, p.
296.
8
35
Antonio Donno
futuro, messo in atto sotto lo stimolo dei tempi e delle circostanze, e
tuttavia pensato e valutato con la più grande cura e prudenza. [...] Non
una qualche teoria teologica o politica o filosofica, ma la loro decisione
di lasciarsi il Vecchio Mondo alle spalle [...] portò [i primi coloni] a una
sequenza di atti e avvenimenti in cui sarebbero potuti perire, se non
avessero concentrato la loro attenzione sull'evento a lungo e
intensamente da scoprire, quasi per caso, la grammatica elementare
dell'azione politica e la sua più complicata sintassi, le cui regole
determinano il sorgere e la caduta del potere umano». 9 Appare, perciò,
impossibile che la lunga riflessione su questa impresa e sui suoi esiti sia
rimasta chiusa nel ristretto gruppo dei partenti e non abbia interessato
una cerchia ben più vasta di persone, pronte a seguire l'impresa, a
ricevere notizie, seppur con il ritardo dovuto alle comunicazioni del
tempo, e a diffonderle successivamente a strati sempre più vasti di
popolazione, eventualmente pronta a seguire l'esempio.
Inoltre, la Arendt non poteva non conoscere The Age of the
Democratic Revolution, l’opera fondamentale di Robert Palmer, il cui
primo volume era stato pubblicato nel 1959, qualche anno prima di On
Revolution. Infatti, la Arendt cita più volte l’opera di Palmer, ma non le
pagine relative a tutta la seconda parte del volume, che si occupa in
specifico dell'influenza della rivoluzione americana in Europa. Si tratta
di pagine assai dettagliate che smentiscono l’affermazione della Arendt
sul carattere locale degli avvenimenti americani e che possono essere
riassunte in questo splendido passaggio di Palmer: «Gli effetti della
rivoluzione americana, in quanto rivoluzione, furono imponderabili ma
assai grandi. [...] Ispirò il senso di una nuova epoca. Dette una
dimensione completamente nuova alle idee di libertà ed eguaglianza rese
familiari dall’Illuminismo. Condusse la gente a ragionare in modo più
concreto sulle questioni politiche e a essere più facilmente critica nei
confronti del proprio governo e della propria società. [...] L’apparizione
sull’altro lato dell’Atlantico di certe idee già familiari in Europa rese tali
idee ancor più universali [...]». 10 Queste considerazioni sono poste da
Palmer alla fine di un denso capitolo, “Europe and the American
Revolution”, in cui l’autore passa in rassegna la gran parte dei paesi
9
ARENDT, Sulla rivoluzione, cit., pp. 172-173.
R.R. PALMER, The Age of the Democratic Revolution: A Political History of
Europe and America, 1760-1800, Vol. I: The Challenge, Princeton, N.J.,
Princeton University Press, 1959, p. 282.
10
36
La rivoluzione americana: evento locale o globale?
europei, sostenendo infine che il risultato della rivoluzione americana in
Europa fu «un’incredibile esplosione di discussioni, speculazioni,
entusiasmo e controversie, una sorta di autentica intossicazione di sogno
americano. [...] Il coinvolgimento dell’opinione pubblica fu
rappresentato dall’incremento fenomenale della stampa, sia di libri che
di giornali che di riviste. In precedenza i libri non erano stati mai così
numerosi, e per un crescente numero di lettori l’America fu un soggetto
gradito, che soddisfaceva il gusto popolare per l’esotico, o un interesse
filosofico per scenari internazionali». 11 Se poi si passa agli strati più
bassi della società francese, non può sfuggire la constatazione che molti
contadini francesi avevano combattuto in Nord America e che, al loro
ritorno, non poterono non confrontare le loro misere condizioni di vita
con quelle dei farmers americani, «[...] che erano proprietari delle loro
fattorie senza alcuna restrizione di tipo feudale». 12 Insomma, come ha
affermato Bernard Bailyn nella sua Atlantic History: Concept and
Contours, del 2005, Palmer «[...] inseriva la rivoluzione americana
direttamente in un quadro più ampio e le assegnava un ruolo chiave e
creativo all’interno di tutto il fenomeno atlantico». 13 Anche in Italia la
conoscenza delle vicende rivoluzionarie americane non fu assente, ma fu
meno precisa. A parte la figura di Filippo Mazzei, un gruppo di
intellettuali italiani, imbevuti dello spirito dell’Illuminismo, si aprì alla
conoscenza del fenomeno americano, anche dal punto di vista
dell'analisi politica; da qui l’esito più importante di tale apertura, «[...]
l'importazione di nuove idee riguardo ai progressi che si andavano
facendo in tutti i campi nelle colonie americane [...]». 14
A livello istituzionale le vicende americane erano ancor più note, se si
tien conto del fitto lavorio svolto da Franklin, Jefferson e John Adams
presso le corti europee. A ciò si devono aggiungere i sette
ponderosissimi volumi della Diplomatic Correspondence of the United
States of America, pubblicati nel 1833 e che coprono il periodo che va
dalla stipula del Trattato di pace, il 10 settembre 1783, all’adozione della
Costituzione, il 4 marzo 1789. Si tratta di una massa enorme di
documenti che attestano la fittissima rete di relazioni, a tutti i livelli, che
11
Ibid., pp. 242-243.
Ibid., p. 247.
13
B. BAILYN, Storia dell’Atlantico, Torino, Bollati Boringhieri, 2007, p. 31.
14
F. DURANTE, Introduzione a Italoamericana. Storia e letteratura degli italiani
negli Stati Uniti, 1776-1880, Vol. I, Milano, Mondadori, 2001, p. 13.
12
37
Antonio Donno
la repubblica americana aveva stabilito con quasi tutti i paesi europei già
da alcuni anni. Dimostrazione chiarissima della conoscenza, da parte
europea, delle vicende della rivoluzione americana e dei suoi esiti, tant’è
che nell'introduzione alla raccolta si scrive che «[essa] fornisce una
completa panoramica dei nostri primi sforzi di procurarci il
riconoscimento del nostro carattere nazionale da parte delle potenze
straniere [...]». 15 Molti anni dopo, nel 1877, appariva il libro di Benson
J. Lossing, Our Country, che faceva il punto sull'impatto della
rivoluzione americana sulla politica e sulla società inglesi e francesi ai
tempi dell'indipendenza delle colonie. 16
Un discorso a parte merita la qualità dell’accoglienza che l'Europa
riservò alle vicende della rivoluzione americana e della nascita degli
Stati Uniti d'America. Se le testimonianze europee sui fatti americani del
1776 e degli anni successivi sono abbondanti, non sempre tali
testimonianze depongono a favore della nuova nazione d'oltreatlantico.
Barry Rubin e Judith Colp Rubin, in Hating America: A History, del
2004, tracciano un acuto profilo dell’anti-americanismo della prima ora,
fondato in gran parte non solo sulla mancanza di conoscenze dirette, ma
soprattutto su un pregiudizio legato al pericolo della perdita del primato
europeo. Se il giudizio sugli americani durante l’epoca coloniale e alla
vigilia della rivoluzione era ricco di aggettivi come «[...] stupidi,
indolenti, fannulloni, ubriaconi, fisicamente deboli e perciò incapaci di
progredire», 17 nondimeno i fatti rivoluzionari del 1776 e la nascita di
una nazione così diversa dalle nazioni europee furono giudicati, stando
alle parole dei Rubin, in questi termini: «Durante i primi anni della
repubblica americana, questa potenziale minaccia fu ridicolizzata. I
critici europei descrivevano l’America come un ovvio e inevitabile
fallimento e speravano che nessuno seguisse il suo esempio e che il
pericolo fosse così evitato». 18 In sostanza, l'informazione non mancava,
anche se il giudizio era spesso sprezzante. Ma si trattava, in realtà, del
giudizio del ceto intellettuale europeo, che si riteneva depositario di una
15
Introduction to The Diplomatic Correspondence of the United States of
America from the Treaty of Peace to the Adoption of the Present Constitution, 7
vols., Washington, D.C., Printed by Francis Preston Blair, 1833, p. VIII.
16
Cfr. B.J. LOSSING, Our Country, New York, James A. Baily, 1877.
17
B. RUBIN-J. COLP RUBIN, Hating America: A History, Oxford and New York,
Oxford University Press, 2004, p. 11.
18
Ibid., p. 21.
38
La rivoluzione americana: evento locale o globale?
civiltà superiore, mentre qualche decennio dopo le masse popolari
europee cominceranno a coltivare il “sogno americano”, senza tanti
complimenti.
Molti anni dopo la pubblicazione di On Revolution, Robert Nisbet,
mentre riconosceva il valore assoluto del libro della Arendt, ne
contestava l’affermazione secondo la quale la rivoluzione americana
fosse stata un evento prevalentemente locale. Nel far questo, Nisbet si
appoggiava decisamente su molte affermazioni contenute nelle opere di
Richard Morris e soprattutto di Robert Palmer, ma aggiungeva anche
alcune pertinenti osservazioni sulla ristrettezza della visione arendtiana.
Per Nisbet, contrariamente a quanto aveva affermato la Arendt, la
rivoluzione americana ebbe un impatto anche su altri popoli del mondo;
inoltre, la rivoluzione americana fu una vera rivoluzione e la mancanza
di fanatismo e di atrocità, che si verificarono invece in Francia e poi in
Russia, non toglie nulla al suo significato autenticamente rivoluzionario.
I Founding Fathers, scriveva Nisbet, avevano la consapevolezza di
operare una rottura nella storia mondiale e consideravano universali i
principi della loro rivoluzione: «“Le fiamme accese il 4 luglio 1776 –
disse Jefferson – si sono propagate in troppa parte del mondo per poter
essere spente dalla debole energia del dispotismo”». 19 Richard Morris,
nel suo classico The Emerging Nations and the American Revolution,
che Nisbet prende come punto di riferimento nella sua critica alla
Arendt, ha sostenuto che la rivoluzione americana suscitò movimenti
antagonistici in varie parti del mondo, che, pur non giungendo a
maturazione in tempi brevi, lentamente sedimentarono un irrefrenabile
desiderio di libertà. 20 Tutto ciò smentirebbe la tesi della Arendt.
Come si è detto in precedenza, tutta la seconda parte del primo
volume di Palmer analizza gli effetti della rivoluzione americana in
Olanda, Belgio, Svizzera, Polonia, Francia, Inghilterra e Germania: un
grande affresco in cui lo storico americano dimostra quanto pervasiva
fosse stata la notizia della rivoluzione americana in Europa. «Il primo e
più grande effetto provocato dalla rivoluzione americana in Europa –
scrive Palmer – fu quello di suscitare negli europei, spesso in modo
altamente emotivo, la fede, o piuttosto il sentimento, di vivere in
19
Cit. in R. NISBET, Hannah Arendt and the American Revolution, in «Social
Research», XLIV, 1, 1977, p. 74.
20
Cfr. R.B. MORRIS, The Emerging Nations and the American Revolution, New
York, Harper & Row, 1970.
39
Antonio Donno
un'epoca speciale di importante cambiamento». 21 Ma ciò che fa riflettere
nelle pagine di Palmer è la sua affermazione che la rivoluzione
americana fu il prodotto dell’Età dell’Illuminismo e che, di
conseguenza, molti videro negli eventi straordinari d’oltreatlantico la
realizzazione pratica degli ideali liberali dello stesso: i diritti dell’uomo,
la sovranità popolare, la libertà religiosa, la libertà di pensiero e di
parola, la separazione dei poteri, le costituzioni scritte. In sintesi, un
novo ordo saeclorum. Del resto, scrive sempre Nisbet, è un fatto
accertato che «[...] molti dei Founding Fathers erano stati essi stessi
educati da dottrine che erano state partorite da intelligenze europee
[...]» 22 e quindi, da questo punto di vista, è facile pensare che il
significato dei fatti nordamericani fosse recepito più rapidamente in certi
ambienti europei. Come ha scritto Gordon Wood, «l’Illuminismo stava
diffondendosi dappertutto nel mondo occidentale, ma in America in
modo particolarmente promettente», 23 perché esso era «[...] il cuore del
repubblicanesimo». 24 Ma, al di là delle ristrette cerchie di intellettuali,
gli eventi americani erano riportati sulla stampa europea, in fase di
straordinaria crescita, discussi negli club di lettura, raccontati dai soldati
di ritorno nei numerosi paesi europei da cui erano partiti per l’avventura
americana. Come si è detto, il raffronto tra le misere condizioni di vita in
cui erano ritornati e ciò che avevano visto in America acuiva in loro il
desiderio di libertà. Quindi, conclude Nisbet, considerare la rivoluzione
americana come «un evento poco più che locale», come aveva asserito
la Arendt, «[...] significa perdere buona parte della storia internazionale
dei decenni immediatamente successivi al 1776». 25
Quest’ultima affermazione di Nisbet ha un’importanza cruciale.
Perché, se la rivoluzione americana ebbe inizialmente un impatto sul
mondo europeo non paragonabile a quello della rivoluzione francese, il
suo lascito nel corso della successiva storia europea e mondiale è stato
formidabile. Per limitarci solo al significato globale del
costituzionalismo americano, si deve dire con Bailyn che «[esso] non era
un modello che si potesse imitare meccanicamente, ma un pozzo di
21
PALMER, The Age of the Democratic Revolution, Vol. I, cit., p. 239.
NISBET, Hannah Arendt and the American Revolution, cit., p. 77.
23
G.S. WOOD, I figli della libertà. Alle radici della democrazia americana,
Firenze, Giunti, 1996, p. 255.
24
Ibid., p. 257.
25
NISBET, Hannah Arendt and the American Revolution, cit., p. 79.
22
40
La rivoluzione americana: evento locale o globale?
esperienze al quale si poteva attingere se necessario, in modo
intermittente, selettivo, con accenti differenti a seconda dei problemi
specifici delle varie società in stadi diversi di trasformazione». 26 E, se
torniamo indietro ai tempi della colonizzazione, non possiamo non
rilevare l’importanza decisiva dei tanti documenti redatti a livello locale,
tra i quali, a mo’ di esempio, spiccano le Istruzioni della città di Malden,
Massachusetts del 27 maggio 1776, poco più di mese prima del 4 luglio,
in cui gli abitanti della città davano l’addio alla Gran Bretagna e si
dichiaravano indipendenti. Essi, afferma la Arendt, «[...] conoscevano le
loro possibilità fin dall’inizio: erano consapevoli dell’enorme potenziale
di potere che scaturisce quando gli uomini “si impegnano
reciprocamente l'uno con l'altro a difendere le loro vite, le loro Fortune e
il loro sacro Onore”». 27 Sul piano commerciale, di fondamentale
importanza fu il contributo della nuova repubblica al superamento del
mercantilismo e alla liberalizzazione del commercio marittimo,
contribuendo allo sviluppo del capitalismo e del libero mercato. Più in
generale, l’impulso proveniente dagli Stati Uniti aprì una nuova fase
nelle relazioni internazionali, confermando ancor di più che gli eventi
rivoluzionari del Nord America ebbero un impatto globale. Secondo
Bailyn, il libro di Palmer «[...] inseriva la rivoluzione americana
direttamente in un quadro più ampio e le assegnava un ruolo chiave e
creativo all’interno di tutto il fenomeno atlantico». 28 Osservazione,
questa, del tutto pertinente, se si tien conto, come detto, che la presenza
nell’Atlantico della Marina commerciale americana rompeva gli schemi
sclerotizzati del commercio marittimo delle potenze europee, garantendo
la più vasta libertà di commercio e di navigazione e la progressiva
adozione del laissez-faire, elemento di novità nel panorama economico e
commerciale del tempo, ma anche nell’impostazione della prima politica
estera americana, poiché, come ha affermato appropriatamente Paul
Varg in Foreign Policies of the Founding Fathers, «il modo di pensare
intrinseco ad una società libera [è] il primo e più importante elemento
nella [sua] formulazione». 29 Del resto, John Adams, come gli altri
26
BAILYN, Storia dell'Atlantico, cit., p. 92.
ARENDT, On Revolution, cit., p. 176. La citazione interna è tratta, appunto,
dalle Istruzioni della città di Malden, Massachusetts.
28
BAILYN, Storia dell'Atlantico, cit., p. 31.
29
P.A. VARG, Foreign Policies of the Founding Fathers, East Lansing, Michigan
State University Press, 1963, p. 1.
27
41
Antonio Donno
Founding Fathers, si era mostrato ben consapevole che la nascita degli
Stati Uniti avesse prodotto «una rivoluzione nel sistema politico ed un
cambiamento nell'equilibrio di potere» 30 a livello internazionale.
Questa consapevolezza è di importanza capitale. Al di là della dura
contrapposizione tra federalisti ed anti-federalisti sull’assetto
istituzionale da conferire al paese, 31 prevalse la linea di Hamilton
sull’unità della nazione, la sola che avrebbe potuto garantire, a suo dire,
un posto di rilievo nel panorama internazionale del tempo e difendere la
nuova politica commerciale internazionale che gli Stati Uniti stavano
imponendo grazie a «[...] quell'ineguagliabile spirito di iniziativa che
caratterizza il genio dei mercanti e dei navigatori americani [...]». 32 Il
libero commercio internazionale, voluto da Washington, stava
cambiando la mentalità commerciale di quella che Bailyn definisce la
“comunità atlantica” del tempo, in cui, come sostenne Hamilton, gli
Stati fossero «[...] obbligati a competere l’uno contro l’altro per ottenere
i privilegi dei nostri mercati». 33 In sostanza, la libera competizione
commerciale prendeva progressivamente il posto dei vincoli
mercantilistici, sostituendo il “commercio passivo” con il “commercio
attivo” e imprimendo un’accelerazione enorme all’economia atlantica.
Di conseguenza, la libertà di navigazione modificò le relazioni tra le
grandi potenze, costituendo uno dei cardini delle relazioni internazionali
della giovane repubblica americana.
Se poi si considera di nuovo l’impatto internazionale della
Costituzione americana, emerge con tutta evidenza che gli eventi
rivoluzionari del Nord America furono eventi di portata globale, non
locale. A questo proposito, Bernard Bailyn ci offre uno spaccato
affascinante dell’influenza del costituzionalismo americano a livello
internazionale: «Le idee costituzionali dei nordamericani erano dibattute
ovunque: in Francia, nel primo anno dell'Assemblea nazionale; in
Inghilterra, dove crearono un ponte fra i cervellotici tentativi di riforma
30
J. Adams to the President of Congress, Paris, May 20, 1780, in The
Diplomatic Correspondence of the United States of America, cit., vol. III, p. 693.
31
Sul tema cfr. l'importante libro di L.M. BASSANI, Gli Antifederalisti. I nemici
della centralizzazione in America (1787-1788), a cura di A. Giordano, Torino,
IBL Libri, 2011.
32
PUBLIUS (Alexander Hamilton), Il Federalista n. 11, in Il Federalista,
Bologna, Il Mulino, 1997, p. 204.
33
Ibid., p. 199.
42
La rivoluzione americana: evento locale o globale?
della classe media del XVIII secolo e il radicalismo emergente della
classe operaia inglese del XIX secolo; in Brasile, dove la gioventù
rivoluzionaria, che studiava all’Università di Coimbra, cercava
segretamente in Jefferson ispirazione e consiglio; in Cile, dove la
Costituzione americana era considerata un “archetipo e un esempio” per
la propria; in Ecuador, dove Vicente Rocafuerte, che esiliato a Filadelfia
aveva tradotto i principali documenti pubblici americani, descrisse la
Dichiarazione d’Indipendenza come un decalogo politico e la
Costituzione degli Stati Uniti “come l’unica speranza per i popoli
oppressi”; in Messico, dove ispirò il federalismo della Costituzione del
1824; e infine in Francia e in Germania nel 1848 e in Argentina nel
1853». 34 Così, la Costituzione americana rappresentò un modello per
tutti i movimenti rivoluzionari della “comunità atlantica”, che siano stati
coronati dal successo o meno, lasciando un’impronta indelebile nella
storia costituzionale di una parte significativa del sistema politico
internazionale, allora come oggi. Aveva ragione Orestes Brownson,
quando nel suo trattato del 1865, American Republic, scriveva: «[...] La
Costituzione americana, considerata nel suo insieme e in tutte le sue
parti, è la meno imperfetta che mai sia esistita: i diritti individuali, la
libertà e l’indipendenza personale, così come l’autorità pubblica, sono
qui tutelati meglio che in ogni altra». 35
In sostanza, per quanto On Revolution di Hannah Arendt sia da
considerarsi un’opera di capitale importanza per comprendere il
significato delle rivoluzioni dell’età contemporanea e della loro eredità,
è impossibile condividere la sua idea sull'impatto “poco più che locale”
della rivoluzione americana. Tutto, invece, depone a favore dell’impatto
globale dell’avvenimento, per non dire del suo prezioso lascito per la
storia successiva, fino ai nostri giorni. Thomas Paine, nel suo Common
Sense del 1776, scriveva profeticamente: «La causa dell'America è in
grande misura la causa di tutta l’umanità. Si sono verificate, e si
verificheranno, molte circostanze, non di carattere locale ma dalla
portata universale, coinvolgenti i principi cari a tutti gli Amici del
Genere Umano, e nel corso delle quali tali principi sono stati e saranno
fondamentali».
34
BAILYN, Storia dell’Atlantico, cit., pp. 92-93.
O.A. BROWNSON, La repubblica americana: costituzione, tendenze e destino,
a cura di D. CARONITI, Roma, Gangemi, 2000, p. 201.
35
43
Antonio Donno
La guerra di Indipendenza fu un formidabile veicolo di democrazia
sia all'interno, che per gli europei che combatterono tra le file dei ribelli,
come ha scritto Nisbet. Essa toccò tutti gli aspetti della società
americana ed ebbe grandi conseguenze di carattere politico, diplomatico
e militare. «La guerra di indipendenza, perciò – ha scritto Francis D.
Cogliano – contribuì a democratizzare la politica americana». 36 E sul
piano strettamente diplomatico, i rappresentanti americani in Europa
introdussero immediatamente un nuovo stile, diretto, aperto, concreto,
penetrando senza timore in quello che che Daniel Boorstin ha definito
«[...] il labirinto della diplomazia europea». 37 Perciò, la diplomazia
americana facilitò la diffusione e la comprensione dei valori fondativi – i
valori liberali – della Repubblica americana, nata dalla guerra di
Indipendenza. Qui è indispensabile fare riferimento alla lezione di
Friedrich von Gentz, che nel suo magistrale libretto del 1800 comparava
la rivoluzione americana a quella francese. Gentz partiva dalla
contestazione dei due luoghi comuni più diffusi all'epoca. Il primo
sottolineava che «“ciò che era stato giusto in America non poteva essere
sbagliato in Europa”»; mentre il secondo proclamava che «“quello che
in America aveva portato un pubblico benessere presto o tardi avrebbe
portato in egual maniera un pari beneficio anche in Francia e in tutta
Europa”». 38 Gentz demolì questi luoghi comuni sulla base della
valutazione degli esiti catastrofici della rivoluzione francese; ma ciò che
interessa per il nostro discorso è che il berlinese Gentz, scrivendo nel
1800, mostrava di conoscere molto bene quali fossero le aspettative
europee relativamente al lascito universale della rivoluzione americana, i
cui principi, perciò, erano ben conosciuti nel Vecchio Continente, e non
solo, probabilmente, tra le sue élites politiche e intellettuali. Fatto che è
confermato da Russell Kirk, che, nell'introduzione al testo di Gentz, ci
informa che nel 1801 il trentatreenne John Quincy Adams, allora
ministro plenipotenziario degli Stati Uniti in Prussia, risiedendo a
Berlino, tradusse in inglese il saggio di Gentz, che era apparso su una
rivista tedesca e quindi, presumibilmente, era stato letto almeno da una
parte significativa dell'élite colta prussiana. Del resto, «Gentz era il
36
F.D. COGLIANO, Revolutionary America: A Political History, New York and
London, Routledge, 20092, p. 115.
37
D.J. BOORSTIN, The Genius of American Politics, Chicago and London, The
University of Chicago Press, 1953, p. 87.
38
GENTZ, L'origine e i principi, cit., pp. 50-51. I corsivi sono nel testo.
44
La rivoluzione americana: evento locale o globale?
fondatore, il direttore e la firma principale – scriveva Kirk – di questa
brillante rivista di idee», 39 diffusa, appunto, tra l'intellettualità tedesca.
Lo stesso discorso vale per il Regno Unito, anzi per quest'ultimo è
ancora più cogente, e per ragioni evidenti. 40 Baylin, nel suo classico The
Ideological Origins of the American Revolution, ha sostenuto che la
cospicua pamphettistica americana che precedette e accompagnò la
rivoluzione – Bland, Otis, Dickinson, gli Adams, Wilson e naturalmente
Jefferson – era ben conosciuta nel Regno Unito. 41 Grazie a tale
pamphlettistica, fu ben noto nel Regno Unito uno dei principi basilari
del pensiero rivoluzionario americano, e cioè che «[...] un popolo può
esistere come popolo prima che abbia un governo e che esso può agire
come popolo indipendentemente dal governo». 42 Sempre nel 1801,
scrive John G.A. Pocock, l'influenza del pensiero rivoluzionario
americano, già viva nella società britannica, si palesò nel momento in
cui il regno irlandese fu incorporato nel Regno Unito; ma, continua
Pocock, «[...] senza le conseguenze dirette e indirette della rivoluzione
americana, difficilmente la storia britannica avrebbe conosciuto le
riforme del 1829 e del 1832 [...]». 43 Non siamo a molti anni di distanza
dall'evento rivoluzionario americano, segno chiaro che esso ebbe
un'influenza importante sulla storia europea tra la fine del Settecento e i
primi decenni dell'Ottocento, cioè in un periodo decisivo per l'Europa.
L'esempio tedesco e britannico dimostra che, al di là degli esiti che essa
produsse sul suolo europeo, la rivoluzione americana fu un evento
39
R. KIRK, Introduzione a GENTZ, L'origine e i principi, cit., p. 33. Cfr. anche R.
KIRK, Le radici dell'ordine americano. La tradizione europea nei valori del
Nuovo Mondo, Milano, Mondadori, 1991, pp. 413-417.
40
Ancora fondamentale per la comprensione della situazione politica del tempo
in Gran Bretagna è il volume di Sir L. NAMIER, England in the Age of the
American Revolution, London, Macmillan, 1930.
41
Cfr. B. BAILYN, The Ideological Origins of American Revolution, Cambridge,
MA and London, The Belknap Press of Harvard University Press, 1992 (1967),
pp. 8-9. Sul tema della pamphlettistica americana pre-rivoluzionaria, cfr. T.
COLBOURN, The Lamp of Experience: Whig History and the Intellectual Origins
of the American Revolution, Indianapolis, IN, Liberty Fund, 1998 (1965).
42
E.S. MORGAN, The American Revolution Considered as an Intellectual
Movement, in J.P. GREENE, The Reinterpretations of the American Revolution,
1763-1789, New York, Harper & Row, 1968, p. 574.
43
J.G.A. POCOCK, La ricostruzione di un impero. Sovranità britannica e
federalismo americano, Manduria, Lacaita, 1996, p. 94.
45
Antonio Donno
globale, non locale. L'intreccio tra le due sponde dell'Atlantico fu così
fervido che Boorstin ha giustamente affermato: «Fino al momento in cui
la rivoluzione [americana] non si materializzò, gli americani parlavano
presumibilmente il linguaggio dei filosofi francesi; ma quando questi
ultimi diventarono sempre più rivoluzionari, il loro pensiero divenne
[…] sempre meno americano». 44 Al di là della tesi di Boorstin sulla
profonda differenza tra le due Rivoluzioni, 45 quel che è evidente, ancora
una volta, è la vasta diffusione del pensiero rivoluzionario americano
negli ambienti intellettuali francesi; ma quando, qualche anno dopo, si
impose l'esigenza di dare vita ad una Costituzione, il dibattito americano
si diffuse in Francia e «una parte importante dell'opinione pubblica
francese fu favorevole agli americani e al loro progetto costituzionale
[...]», 46 a dimostrazione della crescente diffusione delle idee
rivoluzionarie americane in Europa e delle sue conseguenze sul piano
politico.
Tuttavia, è indiscutibile che la rivoluzione francese e poi ancor più
quella bolscevica abbiano ben poco assimilato i principi della
rivoluzione americana, trattandosi di rivoluzioni pantoclastiche votate
fanaticamente alla sistematica distruzione dell'esistente e alla
costruzione di un “mondo nuovo”, di un “uomo nuovo”, di una “nuova
storia dell'umanità”. Siamo agli antipodi di ciò che con immenso acume
scrisse Samuel E. Morison: «[...] La rivoluzione americana differì dalla
maggior parte delle altre grandi rivoluzioni perché si fermò giusto
quando coloro che l'avevano iniziata vollero fermarla. Nel 1789 noi
avevamo gli stessi leaders del 1775». 47 Eppure, agli esordi del grande
44
BOORSTIN, The Genius of American Politics, cit., pp. 78-79.
Su questo tema, pagine importanti sono in R. KIRK, Stati Uniti e Francia: due
rivoluzioni a confronto, a cura di M. RESPINTI, Bergamo, Edizioni Centro
Grafico Stampa, 1995.
46
R. MARTUCCI, «Liberté chérie»: l'opinion française et les constitutions
américaines, in ID., sous la direction de, Constitution & Revolution aux ÉtatsUnis d'Amérique et en Europe, Macerata, Laboratorio di storia costituzionale,
1995, p. 180. Il volume contiene numerosi saggi sull'influenza del pensiero
costituzionale americano in Europa negli anni rivoluzionari e post-rivoluzionari:
Horst Dippel ed Edoardo Tortarolo (in Germania), Wyger R. Velema (in
Danimarca), Hugh Gough (in Irlanda), Alberto Gil Novales e José M. Portillo
Valdez (in Spagna), Wilhelm Brauneder (nell'Impero asburgico).
47
S.E. MORISON, The Conservative American Revolution, The Inaugural George
Rogers Clark Lecture, April 22, 1975, Washington, D.C., The Society of the
45
46
La rivoluzione americana: evento locale o globale?
evento francese, la classe colta francese era concorde nel considerare la
rivoluzione americana un fatto epocale liberatorio; essa esaltò «[...] gli
Stati Uniti e gli americani come la speranza dell'umanità, il primo
popolo che, dopo secoli di tirannia politica e religiosa, aveva combattuto
e vinto in nome dei principi etici e politici della ragione». 48 E, se da una
parte ciò significa, ancora una volta, che l'esperimento americano era
ben conosciuto e anzi osannato in certi ambienti francesi, dall'altra non
si può non riconoscere che i fatti francesi smentirono clamorosamente le
speranze iniziali. Ma c'è di più. Peter Gay ha giustamente messo in
risalto come il lungo periodo di sostanziale autogoverno delle colonie
abbia rappresentato il sostrato ideale per l'affermazione delle idee
illumistiche di matrice europea sul suolo nordamericano; e
successivamente, quando la nuova nazione divenne indipendente, essa
«[...] apparve essere il laboratorio delle idee illuministiche», 49 importate
dall'Europa. 50 Ma, nello stesso tempo, con un processo inverso, «[...] una
stampa politica ampiamente letta e la formazione di un'“opinione
pubblica” iniziarono veramente a svilupparsi in quel tempo [in Europa]
sotto l'impatto della rivoluzione americana». 51 In definitiva, ciò che i
philosophes europei avevano seminato, era stato raccolto e posto in
essere dai philosophes americani, i quali «[...] si servivano
sapientemente di idee filosofiche mentre portavano avanti una delle
grandi trasformazioni politiche della storia»: 52 un formidabile scambio
Cincinnati, 1976, pp. 27-28.
48
T. BONAZZI, Introduzione a ID., a cura di, La rivoluzione americana, Bologna,
Il Mulino, 1977, p. 10.
49
P. GAY, Enlightenment Thought and the American Revolution, in J.R. HOWE,
Jr., The Role of Ideology in the American Revolution, Huntington, N.Y., Robert
E. Krieger Publishing Co., 1976, p. 49.
50
Ma, prima di Gay, John C. Miller, nella sua classico libro sulla rivoluzione
americana, aveva così scritto su questo problema: «La rivoluzione americana e la
Dichiarazione d'Indipendenza non furono meri riflessi dell'Illuminismo europeo»,
ma si nutrirono di una varietà di motivazioni frutto della peculiare storia delle
colonie nordamericane. J.C. MILLER, Origini della rivoluzione americana, Vol. I,
Milano, Mondadori, 1965, p. 17 (I ed. americana: Boston 1943). Ma questo
argomento esula dal nostro discorso.
51
M.N. ROTHBARD, Conceived in Liberty, Vol. IV: The Revolutionary War, 17751784, Auburn, AL, Mises Institute, 1999, p. 447.
52
M. WHITE, The Philosophy of the American Revolution, Oxford and New York,
Oxford University Press, 1978, p. 4.
47
Antonio Donno
di “cultura rivoluzionaria”, che, però, in Francia dette esiti ben diversi
da quelli americani, mentre nella giovane nazione d'oltre Atlantico si
incarnò nelle storiche parole scritte da David Ramsay nel 1789: «Il
diritto del popolo di opporsi ai suoi governanti, quando essi invadono i
suoi diritti, costituisce la pietra angolare della Repubblica americana». 53
È forse a questo diritto che la Arendt si riferiva quando scriveva che, al
tempo della rivoluzione americana, era emerso «[...] un concetto
interamente nuovo di potere e di autorità, un'idea interamente nuova di
ciò che fosse di primaria importanza nella realtà politica che si era già
sviluppata nel Nuovo Mondo [...]». 54
53
D. RAMSAY, The History of the American Revolution, edited by L.H. COHEN,
Indianapolis, IN, Liberty Fund, 1990 (1789), p. 637.
54
ARENDT, On Revolution, cit., p. 166.
48
Eunomia. Rivista semestrale del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Eunomia 1 n.s. (2012), n. 1, 49-64
e-ISSN 2280-8949
DOI 10.1285/i22808949a1n1p49
http://siba-ese.unisalento.it, © 2012 Università del Salento
Maurizia Pierri
Sistema fiscale e “inclinazioni” del federalismo
Abstract: In political science federalism refers to a political system with a
constitution that guarantees some range of autonomy and power to both central and
decentralized levels of government. That is the federalism in static sense and its
principal issue refers to the distribution of sovereignty between the different levels of
government in federal states. Instead, federalism in a dynamic sense is a concept of
power and it is defined as a federalizing process, in an ongoing evolution depending
on centripetal (cooperative federalism) or centrifugal forces (dual federalism). The
transformation of the federalist system in the United States after the New Deal is a
clear example of it: the principles of welfare state had a great influence on the
centralization of fiscal frameworks (with the support of Supreme Court sentences).
This brief essay has the purpose of verifying whether the fiscal system can be an
indicator of change in federalism inclination. Does the adoption of fiscal federalism in
Italy following the Reform of the V Title of the Constitution represent a step toward
dual or cooperative federalism? The answer to this question is very complex, but the
safeguarding of the welfare in some backward areas may depend on it.
Keywords: Fiscal System; Federalism; Constitutional Problems.
1. Il collegamento tra ripartizione delle competenze in materia fiscale
ed evoluzione del processo federale
Da tempo la dottrina comparatista ha riconosciuto che l’assetto degli
ordinamenti statali, sia unitari che federali, della seconda metà del
XIX secolo ha fortemente risentito del passaggio da un modello
costituzionale “comune” di tipo liberale ad uno di tipo democraticosociale; in sostanza, ha risentito della assimilazione dei principi del
welfare state. 1 La Gran Bretagna, la Francia, la Germania, l’AustriaUngheria, l’Italia e, oltreoceano, gli Stati Uniti, nonostante le
notevoli differenze relative alla forma di governo (a monarchia
1
Al riguardo restano fondamentali le riflessioni di G. BOGNETTI, Lo spirito
del costituzionalismo americano, vol. II, La Costituzione democratica,
Torino, Giappichelli, 2000, pp. 1-27.
Maurizia Pierri
limitata, a monarchia parlamentare, a repubblica parlamentare o
presidenziale) si ispiravano ad un medesimo ideal-tipo
costituzionale. 2 Volendo riassumerne le caratteristiche essenziali,
occorre indicare da un lato la concezione del rapporto tra Statoapparato e società civile che vede il primo assumere il ruolo di tutore
della autonomia e della libertà (civile ed economica) dei cittadini;
dall’altro, la adozione di una struttura di distribuzione delle
competenze governative funzionale al ruolo statale di garante dei
diritti: la divisione classica dei poteri.
Dopo la prima, ma soprattutto dopo la seconda guerra mondiale,
pur non ripudiando completamente i principi del costituzionalismo
liberale, gli ordinamenti occidentali hanno valorizzato quelli propri
della democrazia sociale. Sull’onda delle teorie economiche
keynesiane, è cambiata la concezione dello Stato, divenuto
interventista e regolatore per sopperire ai “fallimenti del mercato” in
favore di superiori ragioni sociali, in primo luogo la garanzia delle
fasce più deboli e la tutela dei diritti sociali (o prestazionali). Il
cambiamento ha investito sia gli Stati unitari, con una
organizzazione del potere politico concentrata in un unico ente, sia
gli Stati federali, che avevano una divisione verticale dei poteri e
costituivano, al tempo, una ristretta minoranza (la Germania
imperiale, la Svizzera, gli Stati Uniti, per citare i più importanti).
L’effetto più significativo sortito dall’avvento del welfare state è
stato quello di favorire la confluenza di maggiori poteri allo Stato
centrale a discapito degli enti territoriali periferici. Da questo punto
di vista, l’esperienza degli Stati Uniti risulta esemplare. 3
La finalità di questo processo di avocazione di poteri dalla
2
In realtà, il movimento costituzionalista nasce ben prima della seconda
metà del XIX secolo, successivamente alla glorious Revolution inglese
(1688-89), alla Dichiarazione di Indipendenza delle colonie americane del
1776 ed alla rivoluzione francese del 1789. Le sue matrici storicoideologiche sono conseguentemente diversificate, tanto che il
costituzionalismo di ispirazione giacobina viene tenuto distinto da quello di
ispirazione anglosassone. Cfr. A. BARBERA, Le basi filosofiche del
costituzionalismo, Roma-Bari, Laterza, pp. 5-13.
3
Si veda in proposito, ex multis, lo stesso BOGNETTI, Lo spirito del
costituzionalismo americano, cit., pp. 203-232 e il testo di A. PIERINI,
Federalismo e welfare state nell’esperienza giuridica degli Stati Uniti,
Torino, Giappichelli, 2003.
50
Sistema fiscale ed “inclinazioni” del federalismo
periferia al centro è stata quella di «coordinare dal centro, in modo
uniforme, molti dei nuovi interventi che la politica voleva effettuare
nella società civile per fini economici e sociali e che non avrebbero
potuto realizzarsi funzionalmente attraverso decisioni scoordinate e
ad efficacia solo locale dei governi periferici». 4 Le parole di Bognetti
sono estremamente significative e suggeriscono le due fondamentali
premesse al tema oggetto di questo breve saggio. La prima. Se la
principale ragione della attrazione di poteri dagli Stati membri allo
Stato centrale è costituita dalla necessità di garantire una tutela
uniforme sul territorio nazionale in materia economico-sociale, allora
il sistema fiscale adottato da un ordinamento può essere assunto
come indicatore della sua inclinazione verso un particolare modello
federale (cfr. infra, par. 2). La seconda. La tendenza centripeta, che
ha caratterizzato la fase democratico-sociale del costituzionalismo
declinato sui sistemi federali, non è definitiva né irreversibile, per lo
meno in quegli ordinamenti che non hanno cristallizzato nel testo
costituzionale il principio della “unità economica” del paese. 5 Essa
piuttosto si inserisce in un processo, che oscilla tra una maggiore e
minore attribuzione di poteri al centro e alla periferia, in ragione dei
cambiamenti storici, sociali e culturali, conseguentemente anche
politici, di uno Stato. Si rendono al riguardo necessarie alcune
delucidazioni in ordine alla differenza semantica tra “ordinamento
federale”, inteso come struttura, e “federalismo” inteso come
concezione del potere, che si avrà modo di precisare nel paragrafo
successivo.
2. La differenza tra le formule “federalismo” e “Stato federale”
Le formule “federalismo” e “Stato federale” vengono spesso
utilizzate come sinonimi, quando in realtà esprimono entità
4
Cfr. BOGNETTI, Lo spirito del costituzionalismo americano, cit., p. 8.
Come invece è accaduto con la Legge fondamentale della Repubblica
Federale di Germania del 1949, che, all’art. 72, comma 2, dispone che «lo
Stato federale ha il diritto di legiferare se e nella misura in cui la creazione di
condizioni di vita equivalenti nel territorio federale o la tutela dell’unità
giuridica o economica nell’interesse dell’intero Stato rendano necessaria una
disciplina legislativa federale». Nella Costituzione americana non è prevista
alcuna disposizione analoga.
5
51
Maurizia Pierri
6
concettuali differenti. Lo Stato federale è una forma di
organizzazione
politica
che
comporta
un’autonomia
costituzionalmente garantita ad enti territoriali, che hanno la capacità
di concorrere anche alle funzioni statali. L’analisi storica dimostra
che esso spesso nasce per associazione o integrazione di Stati
indipendenti, già facenti parte di precedenti confederazioni (come gli
Stati Uniti nel 1787, la Svizzera nel1848, la Federazione tedesca del
Nord del 1867 e l’Impero tedesco del 1871). In altri casi, l’assetto
federale viene prescelto al momento dell’affermazione
dell'indipendenza nazionale (com'è accaduto in Canada nel 1867 ed
in Australia nel 1900). Infine, la struttura federale è l’approdo
naturale in caso di dissociazione di un precedente Stato unitario (si
pensi all’Argentina nel 1853, al Brasile nel 1891, al Messico nel
7
1917, all’Austria nel 1920 ed alla Germania nel 1949).
8
La dottrina ha enucleato una serie di elementi sintomatici
dell’esistenza di una struttura federale, che possono essere così
sintetizzati: 1) esistenza di una Costituzione scritta e rigida che
riconosca autonomia agli enti politici territoriali (variamente
denominati), collocati in posizione intermedia tra lo Stato e gli enti
locali, e dotati di costituzioni subordinate a quella dello Stato
federale; 2) previsione di un riparto di competenze tra Stato centrale
e Stati membri, relativo ai tre poteri fondamentali, modificabile solo
con revisione costituzionale; 3) esistenza di un parlamento
bicamerale articolato in modo che una camera sia rappresentativa del
corpo elettorale nazionale e la seconda degli Stati membri; 4)
composizione del governo che rispecchi la natura complessa dello
Stato; 5) partecipazione diretta o indiretta degli Stati membri al
procedimento di revisione costituzionale; 6) esistenza di un organo
federale di tipo giurisdizionale, competente a dirimere i conflitti tra
Stato federale e Stati membri.
Il federalismo, invece, prima di tradursi in categoria giuridica
sotto forma di Stato federale, è una concezione collaborativa dei
6
Cfr., per tutti, su questo tema, G. DE VERGOTTINI, Stato federale, in
Enciclopedia del diritto, vol. XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, p. 831.
7
Per i riferimenti storici si veda M. VOLPI, La classificazione delle forme di
Stato, in Diritto Pubblico comparato, Torino, Giappichelli, 2009, p. 233.
8
Cfr. DE VERGOTTINI, Stato federale, cit., pp. 838-841; VOLPI, La
classificazione delle forme di Stato, cit., pp. 833-835.
52
Sistema fiscale ed “inclinazioni” del federalismo
rapporti politici tra entità di diversa natura, sia nell’ordinamento
internazionale, che in quelli statali: si tratta, dunque, di una teoria
politico-filosofica che investe anche settori non giuridico9
istituzionali. In altri termini, il federalismo rappresenta una corrente
di pensiero che ritiene l’organizzazione federale degli Stati
un’esigenza essenziale per il governo di tutte le società complesse e,
inoltre, l’unica soluzione valida per la pacifica convivenza tra i
popoli. In questo solco, si inseriscono le varie componenti politico10
filosofiche del federalismo: quella di estrazione liberale (Kant),
11
12
quella socialista (Proudhon) e quella democratica (Friedrich).
Le ragioni della sovrapposizione dei due concetti hanno radici
storiche: anche se, nel Medioevo, il fenomeno del foedus
(alleanza/patto) non era certamente sconosciuto (Impero e Chiesa,
regni e principati, città autonome, etc.), tuttavia il federalismo
moderno è strettamente connesso con il fenomeno statale e, dunque,
può essere compreso soltanto in riferimento alle esperienze statali
federali. In primo luogo, quelle degli Stati Uniti, della Svizzera, della
13
Germania, facenti parte delle rispettive confederazioni. Per questa
ragione, i concetti di Stato federale e di federalismo sono stati letti in
sovrapposizione ed il primo è stato studiato con gli strumenti della
scienza giuridica del XIX e della prima metà del XX secolo:
utilizzando il concetto dogmatico di “sovranità”, si è tenuto distinto
dalle attigue figure della confederazione di Stati e dello Stato
regionale.
Quello della sovranità è un criterio di classificazione statico, che
mira a verificare chi sia il reale detentore del potere sovrano, ed è
proprio su questo nodo che si sono confrontate posizioni differenti e
contrapposte. La più antica è quella espressa da Hamilton, Jay e
9
Cfr. DE VERGOTTINI, Stato federale, cit., p. 831; VOLPI, La classificazione
delle forme di Stato, cit., p. 233.
10
Cfr. I. KANT, Per la pace perpetua, Milano, Feltrinelli, 1991, pp. 37-41 [I
ed. tedesca: Königsberg 1795].
11
Cfr. P.-J. PROUDHON, Del principio federativo, Pennacchi, edizione online, 2005 [I ed. francese: Parigi 1863].
12
Cfr. C.J. FRIEDRICH, Trends of Federalism in Theory and Practice, London,
Pall Mall Press, 1968, p. 177.
13
Cfr. G. BOGNETTI, Federalismo, in Digesto delle discipline pubblicistiche,
vol. VI, Torino, Utet, 1991, p. 273.
53
Maurizia Pierri
Madison che, nel Federalist, hanno sostenuto che, nello Stato
federale, la sovranità sarebbe ripartita tra Stati membri e Stato
centrale. Secondo lo statista del North Carolina, J.C. Calhoun, con
argomentazioni successivamente riprese da von Seydel, la sovranità
resterebbe agli Stati membri, e lo Stato federale sarebbe, in realtà,
una forma di confederazione. 14 Un'altra teoria, partendo dal
riconoscimento della superiorità dello Stato federale e della natura
non statuale delle entità federate, ritiene che i principi di regolazione
dei rapporti tra i diversi livelli di governo siano quelli di autonomia
costituzionale (residua) e di partecipazione. La prevalente dottrina
attribuisce la sovranità allo Stato centrale, in ragione di quanto è
scritto nelle costituzioni federali: soltanto al potere centrale spetta la
sovranità, in quanto esso è titolare della Kompetenz-Kompetenz.
Conseguentemente, lo Stato federale sarebbe una sottospecie dello
Stato unitario, ovvero una forma avanzata di Stato decentrato, in cui
15
gli Stati membri non sono sovrani, ma autonomi.
Una rappresentazione estremamente suggestiva, in quanto atta ad
evidenziare il carattere dinamico del principio federale, è quella
16
tracciata da Kelsen. Il giurista austriaco riconduce il tema del
federalismo a quello del decentramento, nel quale distingue un
aspetto statico ed uno dinamico. Il primo atterrebbe alla sfera
territoriale di validità delle norme giuridiche; il secondo, al metodo
di creazione e di esecuzione delle stesse (da parte di un solo organo o
più organi). Nello Stato federale, il decentramento sarebbe massimo
sotto entrambi i profili, in quanto «l’ordinamento giuridico, valido
solo per una comunità parziale, è creato da organi eletti
17
semplicemente dai membri di questa comunità parziale». La
14
Sul pensiero di Calhoun, cfr. M.L. SALVADORI, Potere e libertà nel mondo
moderno. John C. Calhoun: un genio imbarazzante, Roma-Bari, Laterza,
1996; L.M. BASSANI, John C. Calhoun: consenso e maggioranza semplice,
saggio introduttivo a J.C. CALHOUN, Disquisizione sul governo, Macerata,
Liberilibri, 2011, pp. IX-XCV.
15
Per una disamina dettagliata delle teorie relative alla suddivisione della
sovranità negli Stati federali, si rimanda a G. LUCATELLO, Stato federale, in
Novissimo Digesto italiano, vol. XVIII, Torino, Utet, 1971, p. 333 ss.
16
Cfr. H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, Perugia, Etas,
2000 [I ediz. inglese: Cambridge 1945], p. 310 ss.
17
Ibid., p. 315.
54
Sistema fiscale ed “inclinazioni” del federalismo
struttura dell’ordinamento federale sarebbe tripartita, in quanto
vedrebbe affiancati un ordinamento giuridico degli Stati membri, un
ordinamento giuridico dello Stato centrale e un ordinamento
giuridico globale.
Nonostante questa ricostruzione sia stata rigettata per l’eccessiva
farraginosità dello schema proposto, non può esserne sottovalutata
l’importanza con riferimento alla valorizzazione della componente
dinamica, relativa alla produzione di norme ed ai rapporti tra enti
territoriali. Proprio questi elementi, infatti, contraddistinguono le più
moderne teorie sul federalismo, che si concentrano sull’aspetto
18
empirico del federalizing process. Esse superano il concetto di
Stato e si riferiscono più in generale alla comunità politica,
sottolineando la fluidità del riparto di competenze tra Stato centrale e
Stati federali alla luce di forze centripete o centrifughe.
Come si è avuto modo di accennare, autorevole dottrina ha
osservato che il federalismo ha avuto una evoluzione nel corso del
tempo, essendo inizialmente legato alla nascita dello Stato liberale ed
ai relativi valori (libertà dei privati e del mercato, attribuzione allo
Stato federale di un numero ristretto di poteri) e poi, invece,
influenzato dalla nascita dello Stato sociale (intervento dello Stato
federale in materia economico-finanziaria, partecipazione delle
collettività locali alle scelte politiche, esistenza di una classe politica
organizzata in modo non oligarchico, prossimità delle decisioni
19
All’interno di questo
politiche alle necessità dei cittadini).
dinamismo valoriale, si sono sviluppati i vari modelli di federalismo,
da tenere distinti sia in senso cronologico, che della principiologia.
Il modello duale o anglosassone, che riflette pienamente
l’ideologia liberale, appartiene alla prima fase della storia
20
costituzionale americana fino al New Deal rooseveltiano e,
parzialmente, anche alla Germania imperiale (1871-1918), pur se, in
quest’ultima, appare più robusto l’apparato centrale della
18
Cfr. FRIEDRICH, Trends of Federalism, cit., p. 82.
Cfr. BOGNETTI, Federalismo, cit., p. 273 ss. Secondo L. MELICA
[Federalismo e libertà, Padova, Cedam, 2002, p. 1 ss.], vi sono precise
ragioni storiche, filosofiche e giuridiche che collegano il principio federalista
con le istanze liberali.
20
Come recentemente ribadisce M. COMBA, Gli Stati Uniti d’America, in
Diritto Costituzionale comparato, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 128-129.
19
55
Maurizia Pierri
federazione. Le sue caratteristiche principali possono essere così
riassunte: 1) esigenza della separazione tra Stato e società civile, con
particolare riferimento alle materie economico-sociali; 2) netta
separazione di competenze tra Stato centrale e Stati membri, con
parallelismo delle funzioni (alle competenze legislative su
determinate materie corrispondono omologhe competenze
amministrative). Il modello europeo o tedesco, invece, prevede
competenze legislative concorrenti (anche se, in Germania nel 2006,
è stata abolita la figura delle leggi-quadro) e l’assenza del
parallelismo di funzioni.
Dunque, l’emersione delle esigenze proprie dello Stato sociale ha
determinato la tendenza al rafforzamento dei poteri dello Stato
centrale, imposta da una serie di istanze eterogenee: la necessità di
garantire in modo omogeneo i diritti sociali su tutto il territorio
nazionale, di regolare in via generale i settori economico-finanziari e
di rendere maggiormente efficiente il controllo militare attraverso la
sua centralizzazione e, infine, l’intervento uniformante dei partiti
politici di massa. Il federalismo duale si è, così, evoluto in
21
federalismo cooperativo, correlato all’idea che qualunque attività
pubblica debba essere realizzata con un intervento congiunto e
coordinato dei diversi livelli di governo.
Il federalismo cooperativo implica l’affermazione di tre principi:
a) il principio di sussidiarietà verticale (l’intervento del livello
superiore di governo è giustificato solo quando non possa essere
efficacemente messo in atto dal livello inferiore) ed orizzontale (che
coinvolge il privato sociale nell’esercizio delle funzioni pubbliche);
b) il federalismo fiscale, che prevede l’autonomia finanziaria di ogni
livello di governo, attraverso l’istituzione di tributi propri e fatta
salva la possibilità di interventi perequativi da parte dello Stato; c) il
principio di collaborazione sia orizzontale che verticale,
istituzionalizzata o spontanea e, nel primo caso, facoltativa o
obbligatoria, che avvicina le decisioni ai cittadini.
Nella versione statunitense, 22 il federalismo cooperativo è stato
21
È quello che è avvenuto negli Stati Uniti dopo il New Deal. Cfr.
BOGNETTI, Lo spirito del costituzionalismo americano, cit., p. 203.
22
Per quanti hanno sostenuto che il federalismo americano aveva, sin
dall’inizio, carattere cooperativo, poiché gli organi centrali si sono sempre
avvalsi della collaborazione in fase applicativa delle autorità periferiche, si
veda D.J. ELAZAR, The American Partnership in the XIX Century, Chicago,
56
Sistema fiscale ed “inclinazioni” del federalismo
favorito dalle clausole costituzionali relative ai cosiddetti poteri
impliciti ed alla giurisprudenza della Corte Suprema in tema di
applicazione dei principi dello Stato sociale e di uguaglianza dei
diritti. Attraverso la rilettura della interstate commerce clause e dello
spending power, e l’interpretazione estensiva della necessary and
proper clause e degli implied powers del Congresso (art. I, sez. 8), la
Corte Suprema (a partire da Gibson v. Ogden del 1824) ha, infatti,
riconosciuto uno spazio sempre più ampio alla dimensione federale
del potere.
3. Evoluzione del regime fiscale e conseguenze sul processo
federalista. Prospettive del federalismo fiscale in Italia
La tendenza centripeta è stata certamente favorita dall’energica
utilizzazione 23 del XVI Emendamento (1913), che autorizza lo Stato
centrale a stabilire liberamente imposte sui redditi e sui patrimoni: lo
strumento fiscale, sempre con l’avallo della Corte Suprema (nel
1936, la sentenza United States v. Butler ha sancito il potere dello
Stato centrale di utilizzare denaro per finanziare o promuovere
qualunque iniziativa di interesse pubblico, di general welfare) è stato
usato dal Congresso per coprire le spese relative a settori
tradizionalmente di competenza degli Stati membri. 24 Le vicende
degli ultimi decenni, con particolare riguardo agli Stati Uniti, danno
atto della estrema duttilità del federalizing process: il federalismo
25
cooperativo è poi sfociato nel cosiddetto “federalismo coercitivo”
e, in reazione a questo, nel “new federalism” reaganiano o
“federalismo competitivo”, caratterizzato da una riduzione
complessiva del ruolo del potere federale, da una accentuata
competizione tra i vari livelli di governo, con l’applicazione di
logiche di mercato (analisi costi-benefici) per raggiungere livelli
University of Chicago Press, 1962. Bognetti ha ribattuto che tale obiezione
si fonda su una falsa interpretazione dei termini “cooperativo” e “duale”.
Cfr. BOGNETTI, Lo spirito del costituzionalismo americano, cit., p. 203.
23
Per utilizzare l’incisiva espressione di Bognetti. Cfr. ibid., p. 214.
24
Cfr. ibid., p. 215.
25
Cfr. J. KINCAID, Dal federalismo cooperativo al federalismo coercitivo, in
G. MIGLIO (a cura di), Federalismi falsi e degenerati, Torino, Sperling &
Kupfer, 1996, p. 110 ss.
57
Maurizia Pierri
ottimali di efficienza e, infine, dall’utilizzazione degli stock grants
(finanziamenti che obbligano al raggiungimento di obiettivi senza
fissare le modalità per ottenerli). Recentemente, poi, con
l’approvazione dell’Affordable Care Act, nel marzo 2010,
l’amministrazione di Barack Obama sembra aver impresso una
inversione di rotta al federalismo americano, incidendo sulla
garanzia di un diritto sociale rilevante come quello alla salute, non
senza conseguenze sul bilancio dello Stato e sul consenso elettorale.
Tutto ciò a riprova del fatto che, in assenza di una scelta indicata in
norme di rango costituzionale, l’evoluzione cooperativa del
federalismo non è definitiva né, appunto, irreversibile. È altresì
evidente che la ripartizione di competenze relative al prelievo fiscale
e la scelta di utilizzarne gli introiti in funzione di general welfare
sono il sintomo di una particolare inclinazione del federalismo.
È possibile che il ragionamento fin qui sviluppato possa essere
applicato anche alle trasformazioni in atto in Italia? L’ordinamento
italiano, pur non essendo compiutamente qualificabile come
federale, ha intrapreso un cammino che si colloca nel solco del
federalizing process, 26 pur trattandosi di un federalismo del tutto
particolare. 27 È una tendenza che si è compiutamente manifestata
con la riforma costituzionale del Titolo V, la quale ha radicalmente
trasformato il riparto di competenze legislative ed amministrative tra
Stato, regioni ed enti locali. Sebbene con la caduta del governo di
centro-destra (fortemente ispirato a principi federalisti e liberali) il
processo abbia subito una battuta d’arresto, le novità introdotte
hanno continuato a produrre i loro effetti, particolarmente in
relazione al regime della fiscalità regionale e locale ed alle sue
potenziali conseguenze sulle tutele sociali. Alla legge 5 maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell’art. 119 della Costituzione) hanno fatto seguito una
26
«La riforma del Titolo V […] ha avviato la trasformazione dello Stato
italiano secondo i modelli degli Stati federali». V. CERULLI IRELLI - C.
PINELLI, a cura di, Verso il federalismo, formazione e amministrazione nella
riforma del Titolo V della Costituzione, Quaderni di ASTRID, Bologna, Il
Mulino, 2004, p. 7.
27
Sia perché si tratta di un “federalismo da dissociazione”, sia per alcuni
limiti costituzionali ritenuti invalicabili, che lo rendono più simile a quello
austriaco, che a quello svizzero o tedesco. Cfr. A. D’ATENA, L’Italia verso il
“federalismo”. Taccuini di viaggio, Milano, Giuffrè, 2001, p. 98.
58
Sistema fiscale ed “inclinazioni” del federalismo
serie di decreti legislativi, 28 che hanno provocato un radicale
28
Solo per citarne alcuni: 1) del 6 settembre 2011, n. 149, Meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli
articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 2) del 28 maggio 2010,
n. 85 recante Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni
di un loro patrimonio, ai sensi dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42
– approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2010 –
pubblicato nella G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010; 3) del 17 settembre 2010,
n. 156, Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento
transitorio di Roma Capitale – approvato in via definitiva dal Consiglio dei
Ministri il 17 settembre 2010 – pubblicato nella G.U. n. 219 del 18
settembre 2010; 4) del 26 novembre 2010, n. 216, recante Disposizioni in
materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni,
città metropolitane e province – approvato in via definitiva dal Consiglio dei
Ministri il 18 novembre 2010 – pubblicato nella G. U. n. 294 del 17
dicembre 2010; 5) del 14 marzo 2011, n. 23, Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale – approvato in via definitiva dal Consiglio
dei Ministri il 3 marzo 2011 a seguito della votazione favorevole delle
Camere – pubblicato nella G.U. n. 67 del 23 marzo 2011; 6) del 6 maggio
2011, n. 68, Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a
statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario – approvato in via definitiva dal
Consiglio dei Ministri il 31 marzo 2011 – pubblicato nella G.U. n. 109 del
12 maggio 2011; 7) del 31 maggio 2011, n. 88, Disposizioni in materia di
risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri
economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 –
approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 19 maggio 2011 –
pubblicato nella G.U. n. 143 del 22 giugno 2011; 8) del 23 giugno 2011, n.
118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 – approvato in
via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 9 giugno 2011 – pubblicato nella
G.U. n. 172 del 26 luglio 11. Alle fonti menzionate si aggiungono alcuni
interventi normativi secondari ed in particolare i decreti: a) del ministero
dell’Economia e delle Finanze del 26 novembre 2010, Disposizioni in
materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 5 maggio 2009, n.42; b) del presidente del Consiglio dei Ministri del
17 giugno 2011, Disposizioni attuative degli articoli 2, comma 4 e 14,
comma 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni
in materia di federalismo fiscale municipale, in materia di attribuzione ai
comuni delle regioni a statuto ordinario della compartecipazione al gettito
dell’imposta sul valore aggiunto per l’anno 2011; c) del ministero
59
Maurizia Pierri
processo di trasformazione della finanza regionale e locale,
accendendo un dibattito che riguarda l’impatto sociale di quei
provvedimenti ed il tipo di federalismo cui l’ordinamento si va
conformando. Gli appelli alla “solidarietà” più volte espressi dalle
più alte cariche istituzionali sono un chiaro segnale della
preoccupazione per una deriva “duale” del riparto di competenze tra
Stato ed altri enti territoriali che comprometterebbe gli equilibri
sociali del paese. 29 Uno degli aspetti più spinosi della riforma
riguarda, infatti, l’impatto che tali competenze, già ridefinite dalla
modifica del Titolo V della Costituzione e soltanto “sbloccate” dalla
legge delega del 2009, 30 avranno sulla economia e sulle condizioni
di vita delle diverse regioni, nonché sui servizi di cui potranno
usufruire i cittadini residenti nelle aree geografiche 31
tradizionalmente arretrate rispetto al resto del paese. 32
Non vi è dubbio che l’applicazione del federalismo fiscale – e, in
generale, il processo di federalizzazione – inciderà sul sistema di
welfare: 33 il timore è che si possano produrre effetti differenti sulla
dell'Interno del 21 giugno 2011, Riduzione dei trasferimenti erariali (art. 2,
comma 8 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) e Fondo
sperimentale di riequilibrio (art. 2, comma 7, Decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23).
29
La possibile alternativa tra un regionalismo duale e uno cooperativo era
presente ancora prima della riforma costituzionale a causa della
“infatuazione” per il modello competitivo nonostante le evoluzioni in senso
cooperativo in atto nel continente europeo. Cfr. D’ATENA, L’Italia verso il
“federalismo”, cit., p. 237.
30
Come osserva A. D’ATENA, nell’Introduzione al volume Il sistema delle
autonomie territoriali dopo la legge sul federalismo fiscale. Atti del
convegno del 1 marzo 2010, Roma, Tipografia Artigiana, 2010, p. 10.
31
È stato rilevato come il Sud non costituisca una macro-area omogenea,
ma si presenti come un comparto dis-uniforme nelle diverse località che lo
definiscono geograficamente. Sul punto si veda M. INGROSSO, Il federalismo
demaniale e il suo impatto nel Mezzogiorno, in «Innovazione e Diritto», 4,
2010, p. 1.
32
Con performance di sviluppo inferiore rispetto ad altre regioni europee in
condizioni di ritardo economico, come sottolinea L. LETIZIA, Strumenti
innovativi di intervento pubblico per lo sviluppo del Mezzogiorno: profili
giuridici e riflessioni critiche, in www.amministrazioneincammino.it, p. 3,
con ampia bibliografia richiamata nella nota 5.
33
È quanto sostiene, tra gli altri, L. TORCHIA, a cura di, in Welfare e
60
Sistema fiscale ed “inclinazioni” del federalismo
tutela delle prestazioni sociali ai cittadini, in potenziale tensione con
quanto stabilito dall’art. 117, lett. m) della Costituzione, posto che
quella norma non (tanto) prevede una materia di competenza
esclusiva dello Stato, quanto piuttosto una clausola di salvaguardia
trasversale, in grado di incidere anche sulle materie di competenza
regionale. 34 La dottrina più ostile alla riforma ha, infatti, lamentato
che la tensione coinvolgerebbe in realtà l’art. 3 della Costituzione: la
legge di delegazione sul nuovo sistema finanziario avrebbe
completato l’opera di demolizione di un pilastro fondamentale del
nostro ordinamento (il principio di uguaglianza), già intaccato dalla
formula “livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali”,
introdotta dal novellato art. 117. 35
Le modalità di impiego degli introiti ed in generale il sistema
fiscale adottato incide certamente sul principio di uguaglianza e sulla
tutela dei diritti, in particolare di quelli cosiddetti di terza
generazione, 36 che sono espressione di un modello statale solidale e
pluralista richiamato dalla nostra Costituzione nei principi
fondamentali (art. 2, art. 3 secondo comma, art. 4 secondo comma) e
sviluppato nei Titoli II e III, dedicati ai rapporti etico-sociali ed
economici. La ripartizione di competenza relative alla fiscalità tra
centro e periferia è, dunque, anche nel caso italiano, un elemento
costitutivo ed allo stesso tempo un sintomo del modello cui il
processo di federalizzazione si ispira (cooperativo, solidale o
competitivo). 37
federalismo, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 9.
34
Come ha più volte affermato la Corte Costituzionale. Cfr., ex multis, le
sentenze n. 282/2002, 285 e 383/2005 e 87/2006.
35
Come è autorevolmente sostenuto da C. SUNSTEIN - S. HOLMES, Il costo
dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, Bologna, Il Mulino, 1999.
La dottrina prevalente ritiene che la filosofia delle prestazioni essenziali sia
strettamente connessa al principio di uguaglianza. Si veda, tra i tanti, i
contributi di C. PINELLI, Sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali (art.117, co. 2, lett. m, Cost.), in Dir. Pubbl., 2002, p.
881 e ss. Sul punto, incisivamente, G. FERRARA, A proposito del federalismo
fiscale. Sulla riforma del 2001 del Titolo V della Costituzione, in
www.costituzionalismo.it, 2 aprile 2009, p. 5.
36
Sulla scansione temporale delle generazioni dei diritti si rinvia al classico
N. BOBBIO, L'età dei diritti, Einaudi, Torino, 1990.
37
Sulle diverse declinazioni del federalismo e sulla sua componente
dinamica (federalizing process) si veda, da ultimo, A. VESPAZIANI,
61
Maurizia Pierri
A questo proposito si possono fare due considerazioni. La prima
è che le disposizioni costituzionali poc'anzi accennate ed altre
contenute nei Principi fondamentali contengono una inderogabile
(salvo radicali riforme costituzionali) indicazione di rotta: la
Repubblica è una ed indivisibile (art. 5), richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art.
2), rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del paese (art. 3 comma 2). In più, nel novellato
articolo 119, pur essendo scomparso l’esplicito riferimento al
Meridione, 38 si percepisce ancora l’esistenza di una “questione
meridionale” 39 che affiora nelle disposizioni che istituiscono un
fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per
abitante (art.119, co.3) e che prevedono la destinazione di risorse
aggiuntive, ovvero l’effettuazione di interventi speciali per
«promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l’effettivo esercizio dei diritti della persona» in favore di determinate
regioni (ed altri enti locali).
Il giudizio sulla traduzione di questi principi da parte del
legislatore del 2009 è controverso: alcuni hanno avanzato
osservazioni negative per eccesso di concessioni al Sud. Il fondo
perequativo e, soprattutto, gli interventi straordinari sono stati
interpretati come una modalità per reintrodurre surrettiziamente
forme di assistenzialismo, 40 accolte con sfavore anche perché di tipo
Federalismo, in Enciclopedia giuridica Treccani, XV, Roma, 2007.
38
Che era invece presente nella vecchia formulazione (comma 4).
Successivamente alla chiusura della Cassa per il Mezzogiorno, l’interesse per
i problemi specifici del Sud è andato scemando, riflettendo una tendenza a
negare l’esistenza della questione meridionale.
39
Quanto meno come speculare alla emersione di una antitetica “questione
settentrionale” ed alla rivolta fiscale del Nord, cfr. L. RONCHETTI,
Federalismo fiscale: il futuro della riforma e lo stato attuale della
giurisprudenza costituzionale, in www.costituzionalismo.it, 2 novembre
2009, p. 2.
40
In realtà, si tratta di valutazioni espresse da parte della corrente politica che
ha maggiormente esercitato pressioni per l’attuazione del federalismo fiscale,
fomentata da alcuni recenti scritti che hanno accentuato il ruolo “predatorio”
delle regioni meridionali rispetto a quelle settentrionali, come ad esempio il
62
Sistema fiscale ed “inclinazioni” del federalismo
orizzontale. Altri hanno manifestato perplessità sulle ricadute sul
piano della tenuta costituzionale della riforma con riferimento al
principio di uguaglianza sostanziale espresso dall’art. 3, secondo
comma: l’incoerenza dell’impianto normativo, unitamente alla
individuazione di parametri obiettivi sui quali si fonderà la finanza
regionale (capacità fiscale, principio di territorialità, fabbisogni
standard), potrebbe alimentare un abbassamento della soglia qualiquantitativa dei livelli essenziali delle prestazioni ex art. 117, lett. m)
(Lep), con gravi sperequazioni tra regioni più ricche e più povere. 41
Un giudizio in linea generale favorevole alla attuazione dei
principi costituzionali operata dalla riforma è, invece, espresso da
quanti, pur sospendendo la valutazione definitiva al completamento
della attuazione della delega legislativa, hanno posto in evidenza gli
aspetti positivi ed innovativi di quest’ultima: in primo luogo, l’aver
“sbloccato” la portata normativa dell’art. 119; 42 in secondo luogo,
l’aver agganciato le modalità di attuazione del federalismo fiscale a
parametri oggettivi come quello della territorialità, della capacità
fiscale e del costo/fabbisogno standard, distraendolo dal soggettivo e
deficitario riferimento alla spesa storica; last but not least (essendo,
invece, un aspetto visceralmente connesso all’impatto che il
federalismo fiscale potrà avere sulle regioni meridionali), l’aver
accentuato il legame tra potere impositivo e responsabilità politica, 43
espresso nel principio “no representation without taxation”, 44
l’inverso logico della massima che aveva ispirato la rivoluzione
americana.
saggio di L. RICOLFI, Il sacco del Nord. Saggio sulla giustizia territoriale,
Milano, Guerini e Associati, 2010.
41
Cfr. FERRARA, A proposito del federalismo fiscale, cit., p. 5.
42
Come si era già avuto modo di sottolineare, cfr. supra, nota 29.
43
Ad esempio F. BASSANINI, Una riforma difficile (ma necessaria): il
federalismo fiscale alla prova della sua attuazione, in «Aspenia», 49, giugno
2010, p. 5 e ss.; e R. NANIA, La questione del “federalismo fiscale tra
principi costituzionali ed avvio del percorso attuativo, in www.federalismi.it,
p. 6. Entrambi gli autori non mancano, però, di sottolineare alcuni profili di
vulnerabilità della riforma, contenuti sia nella legge di delegazione, che nei
decreti attuativi.
44
Tra i tanti che sottolineano l’importanza di questo aspetto della riforma
cfr. soltanto D’ATENA, Il sistema delle autonomie territoriali dopo la legge
sul federalismo fiscale, cit., p. 8.
63
Maurizia Pierri
Al di là di qualunque valutazione di merito sulla “bontà” della
riforma, è necessario ricordare che le disposizioni introdotte dalla
riforma del Titolo V trovano una chiave di lettura privilegiata nei
principi costituzionali poc'anzi richiamati: sempre alla luce di quei
principi, devono essere valutate le prospettive evolutive del processo
di federalizzazione intrapreso, del quale il sistema fiscale è, al tempo
stesso, uno strumento da calibrare ed un sintomo da analizzare con
attenzione e senza pregiudizi ideologici.
64
Eunomia. Rivista semestrale del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Eunomia 1 n.s. (2012), n. 1, 65-84
e-ISSN 2280-8949
DOI 10.1285/i22808949a1n1p65
http://siba-ese.unisalento.it, © 2012 Università del Salento
Giuseppe Patisso
Dall'asiento ai codes noirs. I tentativi di normativizzazione
della schiavitù (sec. XV-XVIII)
Abstract: Between the XV and XVII century in the American colonies there was an influx
of forced slave labor from Africa. Portugal, France, Spain and England were the
protagonists of this slave trade or triangular trade fueled by the cultivation of sugar cane
and due to the extinction of Amerindian populations. In these areas the need to regulate
legally the lives of slaves produced a particular legislation: the black codes. In this work
is analyzed and compared the origin of this legislation, starting from the Spanish asientos
up to the French code noir, the Americans black codes and the Caroline codigo, a
collection of rules about the slaves, but it never entered into force. The paper focuses on a
particular profile of the history of human rights in the modern age that will have its effect
until the middle of the twentieth century.
Keywords: Slavery; Black Codes; Human Rights.
Da Spartaco a Toussaint Louverture 1 (ma solo per citare alcune tra le
figure più rappresentative), la rivolta verso il sistema schiavista ha
rappresentato una costante nelle società che avevano basato la loro
economia, la loro ricchezza e il loro sviluppo su una forza lavoro senza
diritti, acquistabile su un mercato sempre più attento a soddisfare la
domanda dei grandi proprietari terrieri e delle Compagnie delle Indie
europee. I luoghi dove milioni di esseri umani venivano “importati”, a
partire dal XVI secolo, erano le grandi isole delle Antille, l’America
spagnola, inglese e francese. Erano i luoghi dove cresceva la canna da
1
Sulla rivolta degli schiavi ad Haiti, capeggiata da François-DominiqueToussaint, detto Toussaint Louverture, si vedano: C.L.R. JAMES, I giacobini
neri: la prima rivolta contro l’uomo bianco, Milano, Feltrinelli, 1968; A. FOIX,
Toussaint Louverture, Paris, Gallimard, 2007.
Giuseppe Patisso
zucchero, la cui coltivazione, raccolta e lavorazione per ottenerne il
dolce prodotto abbisognava di braccia robuste, di uomini forti, visto che
gli esili indios autoctoni, in pochi anni, si erano pressoché estinti. 2 Ma le
nuove società che si vennero a formare, con la presenza di un cospicuo
numero di neri, abbisognavano di regole certe, di un nuovo tipo di
legislazione che regolamentasse l’acquisto, la vendita, la vita (e la
morte) di un sempre crescente numero di schiavi nelle colonie
d’oltremare e, nel contempo, prevenisse e punisse ogni forma di
insubordinazione, soffocando, di fatto, sul nascere ogni tentativo di
rivolta. E la nascita di una serie di provvedimenti legislativi, come i
cosiddetti cosiddetti codes noir, risponderà a tale necessità, nella
Louisiana (dove i francesi erano presenti sin dal 1608), così come negli
altri territori della Nuova Francia.
Ma i codici neri non furono le prime forme di “regolamentazione
normativa” relativa al sistema schiavista, in quanto, già all’inizio del
XVI secolo, fu introdotto l’asiento de negro, 3 una sorta di accordo tra la
corona spagnola e un privato o un altro potere sovrano, che prevedeva il
sostanziale monopolio della fornitura di schiavi africani per le colonie
spagnole in America. L’appaltatore, chiamato asentista, accettava di
versare alla Corona una certa somma di denaro e in cambio poteva
vendere in regime di monopolio un certo numero stabilito di schiavi,
donne e uomini, nei mercati americani. 4 Già a partire dal 1501, furono
emanati i primi provvedimenti relativi agli schiavi, che venivano
deportati soprattutto nell’isola di Hispaniola, dove scoppiò una delle
prime rivolte che portò il governatore Ovando ad istituire un sistema
poliziesco che rintracciasse gli schiavi fuggiaschi. Le prime forme di
legislazione nel Nuovo Mondo, tuttavia, non erano solo rivolte agli
2
Cfr. M. LIVI BACCI, Conquista. La distruzione degli indios americani,
Bologna, Il Mulino, 2005.
3
«Los asientos, caracteristicos de los suministros alimenticios en el municipio
medieval, se extendieron a América en la Edad Moderna, alcanzando a gran
número de campos comerciales e productivos. Especial importancia revistió
elasiento de negros, que en el sigloXVIII se convirtió en pieza significativa de
las relaciones internacionale de la Monarquía». M. ARTOLA, dirigido por,
Asiento, in Enciclopedia de Historia de España, tomo V, Madrid, Espasa, 1991,
pp. 89-90.
4
Cfr. ibid., p. 90.
66
Dall'asiento ai codes noirs
schiavi africani, ma venivano estese anche a mori, ebrei, eretici, i quali
non potevano, ufficialmente, mettere piede nelle colonie spagnole in
America. Peraltro, anche nello stesso preambulo del Codice nero del
1685 è esplicitato il divieto a ebrei o protestanti di risiedere nella Nuova
Francia.
Sicuramente la coltivazione e la commercializzazione dello zucchero
furono tra le principali cause dell'aumento esponenziale degli schiavi
neri nelle coltivazioni del Nuovo Mondo. Il commercio di questo
prodotto non ebbe ripercussioni solo sugli amerindi e la popolazione
dell'Africa occidentale, ma anche sulla divisione del potere tra Spagna,
Francia ed Inghilterra, ben consapevoli che chi avesse dominato il
commercio dello zucchero sarebbe stata anche la nazione dominatrice
dei traffici nell'Oceano Atlantico. A gestire questi giochi di potere erano
i proprietari delle grandi piantagioni di zucchero ed i negrieri, che,
attraverso il loro potere economico, influenzavano quello politico per
legittimare ed ottenere migliori condizioni giuridiche per i loro traffici.
Nel Medioevo, lo zucchero di canna arrivava in Europa
direttamente dal Medio Oriente, e anche dalla Persia e dall’India, che
furono i paesi dove, con tutta probabilità, le tecniche di raffinazione
vennero inventate. Dopo la conquista araba, il bacino del Mediterraneo
rimase per diversi secoli il centro di produzione dello zucchero
consumato in Nord Africa, nel Medio Oriente ed in Europa. Mantenne
questo ruolo sino alla fine del XVI secolo, allorché lo zucchero
proveniente dalle colonie del Nuovo Mondo divenne dominante. A
quell’epoca, però, era ormai diventato una sostanza familiare in Europa.
La produzione si spostò inizialmente dal Mediterraneo alle isole
atlantiche della Spagna e del Portogallo, in particolare a Madeira, alle
Canarie e Sao Tomé; questa fu, però, una fase di breve durata che
terminò con la crescita dell’industria zuccheriera americana. 5 La
diffusione, nel bacino mediterraneo, della canna da zucchero e della
tecnologia richiesta dalla sua coltivazione e trasformazione fu ostacolata
essenzialmente dai tassi di piovosità e dalle variazioni climatiche di tale
regione. Infatti, la canna da zucchero è un frutto tropicale che ha un
ciclo di coltivazione lungo anche più di dodici mesi e richiede grandi
5
Cfr. A.H.R. DE OLIVEIRA MARQUES – M. SOARES, Histoire du Portugal et de
son empire colonial, Paris, Karthala Editions, 1998, pp. 262-271.
67
Giuseppe Patisso
quantità di acqua e lavoro. Quando lo zucchero americano incominciò
ad invadere i mercati europei, questo fu un fattore che giocò un ruolo
sfavorevole per l’industria zuccheriera mediterranea.
La produzione dello zucchero non fu soltanto una impresa difficile
dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista del reperimento e
dell’uso della forza lavoro. 6 Guerre e pestilenze, con il declino della
popolazione ad esse connesso, danneggiarono pesantemente l’industria
dello zucchero a Creta ed a Cipro nel tardo Medioevo, un'industria che
richiedeva grandi quantità di manodopera al punto che, dopo la Morte
Nera, fu proprio il bisogno di compensare, con l’uso intensivo di
schiavi, le grandi perdite demografiche dovute alla peste che diede il via
alla relazione tra zucchero e schiavitù.
La canna da zucchero fu portata nel Nuovo Mondo da Cristoforo
Colombo durante il viaggio del 1493 dalle Canarie spagnole. La prima
canna americana fu piantata nel possedimento spagnolo di Santo
Domingo e fu da lì che, all’incirca nel 1516, partì il primo carico di
zucchero diretto in Europa. L’industria saccarifera di Santo Domingo
utilizzava il lavoro di schiavi africani portati lì pochi anni dopo l’arrivo
della canna. Pertanto, fu la Spagna che introdusse per prima la canna, la
manifattura dello zucchero, gli schiavi africani e il sistema della
piantagione nelle Americhe.
Però, nonostante il sostegno della madrepatria, la dovizia degli
esperimenti (mulini ad acqua e a trazione animale, il lavoro degli
schiavi, i processi di macinatura e bollitura necessari alla manifattura di
zucchero e melassa dal succo estratto) ed i notevoli processi produttivi,
la fiorente industria ispano-americana non diede alcun risultato di rilievo
e ciò che non riuscirono ad ottenere gli spagnoli nelle Antille, lo
raggiunsero i portoghesi in Brasile. Va, però, segnalato che il
commercio degli schiavi solo per poco tempo restò appannaggio della
Corona spagnola, la quale, attraverso l'asiento, appaltò questo lucroso
commercio ad altre potenze europee. Infatti, nell’arco di un solo secolo,
francesi, olandesi e soprattutto inglesi divennero i maggiori produttori
ed esportatori di zucchero tra le due sponde dell'Atlantico. Nel XVII
secolo, l’Inghilterra fondò nel Nuovo Mondo più colonie di quanto
6
Cfr. S.W. MINTZ, Storia dello zucchero tra politica e cultura, Torino, Einaudi,
1990, pp. 34-47.
68
Dall'asiento ai codes noirs
fecero Olanda e Francia, importando un gran numero di schiavi. E fu la
potenza che con maggiore sollecitudine creò un sistema di piantagioni, il
cui prodotto più importante per diversi secoli fu lo zucchero. In un
primo tempo, gli interessi commerciali britannici mirarono tanto al
rifornimento del mercato nazionale, quanto alla ricerca di compratori
stranieri, un obiettivo perseguito in alleanza con i portoghesi. 7 In un
momento successivo, però, gli obiettivi commerciali inglesi mutarono,
in quanto il mercato interno fu privilegiato nei confronti di quello
esterno. A questo punto, le fasi finali della raffinazione venivano ormai
eseguite in impianti inglesi. Questa vicenda indica, da un lato, le tappe
dell’espansione di un impero, mentre, dall’altro, segna l’inglobamento
nella cultura inglese del consumo di zucchero, che divenne da quel
momento in poi una sorta di usanza nazionale. Insieme al tè, lo zucchero
arrivò a definire il carattere nazionale inglese.
Il depauperamento antropico provocato dalla tratta degli schiavi
non solo provocò una mutilazione delle società africane, ma anche un
notevole danno economico. Intorno al 1650, infatti, i commerci dei
mercati della costa occidentale dell'Africa avevano sostituito la
stragrande maggioranza dei beni, sia agricoli che artigianali, con gli
uomini. I mercanti africani erano pagati per gli schiavi che vendevano,
ma il loro compenso era di natura improduttiva, in quanto tutto ciò che
veniva ricavato erano cianfrusaglie ed armi da guerra, fino ad arrivare ai
cauri. Di fronte ad una richiesta di schiavi sempre più dilagante, le già
misere attività autoctone si impoverirono o caddero in rovina. 8
Esisteva, dunque, un motore, quello economico, che implementava
la tratta degli schiavi. E se lo zucchero rivestiva, almeno in un primo
momento, un’importanza fondamentale, in seguito anche altri prodotti
come il cotone e il caffé faranno sviluppare a livello globale un sistema
di produzione che in Francia sarà chiamato l’economia della schiavitù
coloniale. 9
La tratta degli schiavi neri non fu praticata solo dai francesi. In
7
Cfr. E. VILA VILAR, Hispano-América y el comercio de esclavos. Los asientos
portugueses, Siviglia, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1977.
8
Cfr. V.R. SILVÉRIO, por, História Geral da África. África do século XVI ao
XVIII, vol. V, Brasília, Bethwell Allan Ogot, Unesco 2010, pp. 124-128.
9
Cfr. F. CÉLIMÈNE – A. LEGRIS, sous la direction de, L’économie de l’esclavage
colonial, Paris, CNRS Editions, 2002.
69
Giuseppe Patisso
Africa, già in periodo pre-islamico, egiziani, romani, arabi,
«transportaient les esclaves de la vallée du Nil, et en particulier de la
Nubie, ma l'absence de données a rendu impossible de définir
l'importance de ce commerce, en particulier avant la diffusion de
l'Islam». 10 A partire dal VII secolo, il commercio di uomini assume
proporzioni sempre più vaste e articolate: gli schiavi si spostano
dall'Africa all'Asia, all'Europa, verso il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. 11
Ancor prima che portoghesi, spagnoli, inglesi, francesi e olandesi
implementassero, tra XVI e XVIII secolo, la tratta atlantica degli schiavi
neri verso le colonie europee delle Americhe, per impiegarli nelle
piantagioni di cotone e canna da zucchero, 12 gli italiani, già nel XV
secolo, si dedicarono a questo tipo di commerci. Nel momento in cui il
traffico di schiavi verso l'est del mondo si sgonfiò, ma ancora non si
affacciò prepotentemente quello verso ovest, un personaggio come
Antonio di Noli, un capitano genovese che intendeva occuparsi della
coltivazione della canna da zucchero nelle isole di Capo Verde, ottenne,
nel 1460, dal re del Portogallo, l'autorizzazione all'importazione di
schiavi neri. Ed inoltre, tra il 1489 e il 1497, il fiorentino Cesare de'
Barchi vendette sulla piazza di Siviglia circa duemila schiavi provenienti
da alcune regioni della Guinea, dove, nello scalo di Santiago, ivi
10
M.R. TURANO – F. DEGLI ATTI, Les traites négrières, in Pour une histoire de
l’Afrique (sous la direction de M.R. TURANO – P. VANDEPITTE), Lecce, Argo,
2003, p. 145.
11
Sull’argomento si vedano, tra gli altri, i lavori di A. PICCIONI, In catene:
storia della tratta degli schiavi, Scandicci, La Nuova Italia, 1991; J. READER,
Africa. Biografia di un continente, Milano, Mondadori, 2001; O.P.
GRENOUILLEAU, La tratta degli schiavi. Saggio di storia globale, Bologna, Il
Mulino, 2006; M. GORDON, Slavery in the Arab World, New York, New
Amsterdam, 1989; P. MANNING, Slavery and African Life: Occidental, Oriental
and African Slave Trades, Cambridge, Cambridge University Press, 1990; G.
PIETROSTEFANI, La tratta atlantica: genocidio e sortilegio, Milano, Jaca Book,
2000; F. RENAULT – S. DAGET, Les traites négrières en Afrique, Paris, Karthala,
1985; TURANO – DEGLI ATTI, Les traites négrières, cit., pp. 145-166; S. DAGET,
sous la direction de, De la traite a l'esclavage. Actes du Colloque international
sur la traite des Noirs, Paris-Nantes, Société française d'histoire d'outre-mer,
1989.
12
Cfr. MINTZ, Storia dello zucchero, cit.
70
Dall'asiento ai codes noirs
fondato, la famiglia Barchi deteneva una concessione. 13 Se la
storiografia internazionale ha dedicato ampio spazio al ruolo svolto da
figure come Cristoforo Colombo, Alvise Cadamosto, Amerigo Vespucci
o Antoniotto Usodimare relativamente alle esplorazioni e alle scoperte,
ben poca attenzione ha prestato al ruolo che ebbero mercanti e banchieri
italiani nel fornire tecnologia e capitali che consentirono al Portogallo di
fondare un impero commerciale dal Pacifico alle coste del Brasile e
dell'Africa.
Fu, comunque, tra il XVI e XVIII secolo che si conobbe la
massima diffusione del commercio di schiavi neri, che, dalle coste
africane, venivano ammassati sulle navi negriere per essere poi venduti
sui mercati di Haiti, Cuba, Brasile, Santo Domingo (solo per citare
alcuni dei luoghi in cui era più diffuso questo tipo di commercio).
Già dagli inizi del XVI secolo, la manodopera era fornita dagli
schiavi africani, che, seppur in numero esiguo rispetto agli anni a venire,
contribuirono a far crescere questo tipo di coltivazione. Se i risultati
ottenuti dall'industria saccarifera spagnola furono inferiori a quelli
ottenuti poi dai portoghesi, va comunque sottolineato il carattere
pionieristico di tale iniziativa, che vide l'utilizzo sempre maggiore di
schiavi neri nel momento in cui la popolazione indigena iniziò a
declinare vertiginosamente. Mentre nel corso della colonizzazione delle
Americhe, gli spagnoli (ed in parte i portoghesi) puntarono sulla ricerca
ed estrazione di metalli preziosi, i loro concorrenti nord-europei
incentrarono le loro attività sul commercio e la produzione di beni di
consumo e tra questi i prodotti delle piantagioni come zucchero, cotone,
indaco ed in seguito anche caffè. Francesi e inglesi, a partire dalla metà
del XVII secolo, divennero i maggiori esportatori e produttori di
zucchero del mondo occidentale. 14 Tali fiorenti commerci attirarono
nelle colonie francesi d'oltremare mercanti e faccendieri, che fecero
dello sfruttamento delle piantagioni la loro primaria attività economica.
D'altronde, «la production et le dévelopment des cultures tropicales dans
les colonies d'Amérique se réalisent dans l'intérêt exclusif de la France
et correspondent à des principes généraux conforme au mercantilisme,
principes qui précisent que les colonies ne sont créées que pour l'utilité
13
14
Cfr. GRENOUILLEAU, La tratta degli schiavi, cit., pp. 38-44.
Cfr. MINTZ, Storia dello zucchero, cit., pp. 52-55.
71
Giuseppe Patisso
exclusive de la métropole». 15 Con l'ampliamento delle terre coltivate,
crebbe anche la richiesta di manodopera da parte dei latifondisti,
soddisfatta in gran parte dal massiccio afflusso di schiavi assicurato
dalle navi negriere, che si rifornivano dalle piazzeforti portoghesi situate
lungo tutta la costa nord-occidentale dell'Africa, nonché nel golfo di
Guinea, conosciuto anche come "golfo degli schiavi".
Peraltro, nel XVI secolo, gli spagnoli abbandonarono le loro
iniziative nei Caraibi, preferendo impegnarsi nei territori più vasti e
ricchi dell’America centrale e meridionale, in quanto erano stati scoperti
copiosi giacimenti di metalli preziosi in Messico e in Perù. Ma anche in
questi territori il crollo demografico (e, dunque, la disponibilità di
manodopera) fu poderoso: si valuta che, dopo la sconfitta degli Aztechi
per opera di Hernan Cortès nel 1521, la popolazione messicana crollò da
oltre 15 milioni a circa 700 mila unità. Nella regione inca, la
popolazione passò da 9 milioni a 600 mila unità. La massiccia flessione
indusse i coloni spagnoli, e in seguito anche le altre potenze europee
impegnate nella colonizzazione, ad acquistare un numero crescente di
schiavi africani. Nel Messico, gli schiavi africani furono impiegati,
come in Perù, in vari tipi di lavoro: nelle fattorie, nelle case private,
nell’esercito.
Se l’argento fornì agli spagnoli le risorse necessarie a deportare gli
schiavi africani nelle Americhe, per i portoghesi in Brasile ciò avvenne
grazie alla canna da zucchero; nel 1575, i piantatori brasiliani
producevano un volume di zucchero che raggiungeva le 130 tonnellate
annue. Nel corso del primo secolo, della tratta i portoghesi conservarono
il monopolio del traffico atlantico, ma il commercio marittimo
portoghese e l’industria saccarifera brasiliana non potevano vincere la
sempre più agguerrita concorrenza da parte di inglesi, francesi e
olandesi, il cui inserimento nel mercato portò ad una enorme diffusione
l’uso degli schiavi africani, in tutti gli impieghi e le colture redditizie, ivi
comprese quelle del cotone e del tabacco.
La firma del Trattato di Utrecht, e la conseguente fine della guerra
di successione, segnò anche la ratifica di un Asiento de esclavos (Asiento
15
F. CELIMENE – A. LEGRIS, L’economie coloniale des Antilles françaises au
temps de l’ésclavage, in L’économie de l’esclavage coloniale, cit., p. 128; J.
MEYER, Des origines à 1763, in C.R. AGERON, sous la direction de, Histoire de
la France coloniale, vol. I, Des origines à 1914, Paris, Armand Colin, 1991.
72
Dall'asiento ai codes noirs
ajustado entre las dos Majestades Católica y Británica sobre
encargarse la Compañía de Inglaterra de la introducción de esclavos
negros en la América Española por tiempo de treinta años), 16 firmato,
nel marzo del 1723, da Inghilterra e Spagna, col quale tutti i privilegi,
che fino ad allora erano stati appannaggio della Spagna relativamente al
commercio degli schiavi, passavano agli inglesi per un periodo di
trent'anni. Da questo momento in poi, l'Inghilterra divenne la principale
protagonista del commercio degli schiavi, superando in questo “affare” i
francesi e gli olandesi che, sostanzialmente, iniziarono a perdere
posizioni economico-commerciali nel Nuovo Mondo. Questo avveniva
poiché il modo migliore per poter accedere al mercato ispano-americano
era sicuramente quello di contrattare un asiento con la Spagna.
A gestire il reclutamento e l’approvvigionamento degli uomini
furono diverse compagnie commerciali fino alla creazione, nel 1672 da
parte della Corona, della Royal African Company, che deteneva il
monopolio schiavile. 17 Nelle colonie americane, la schiavitù coinvolse
maggiormente il Sud, perché caratterizzato da grandi piantagioni di
tabacco: Virginia, Maryland, Carolina del Nord, mentre in Georgia e
Carolina del Sud prevaleva la coltivazione di riso. Ma anche nel Nord,
in Massachussetts e Connecticut, benché non esistesse l’economia di
piantagione, gli schiavi svolgevano perlopiù attività di servizio
domestico o erano impiegati nell’artigianato. Una forte presenza di
schiavi si registrò a New York, ex colonia olandese (New Amsterdam),
passata agli inglesi nel 1667. La presenza degli stessi schiavi crebbe
enormemente dagli anni Ottanta del Seicento e nel corso del Settecento,
seppur in maniera diversa nelle 13 colonie. Anche i francesi si
insediarono nei Caraibi e centrale in ciò fu il ruolo svolto dalla
Compagnie des Indes Occidentales (1664) ad opera del ministro
Colbert. 18 Persino la Danimarca in un breve periodo si impiantò nelle
isole di Saint Thomas e Saint Croix, per l’esportazione dello zucchero di
canna. Francesi e inglesi, dunque, soppiantarono olandesi e portoghesi e
16
Á. JARA, Fuentes para la historia del trabajo en el Reino de Chile, Santiago
de Chile, Andres Bello, 1957, pp. 28-45.
17
K. MORGAN, Slavery and the British Empire: From Africa to America,
Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 56-61.
18
Cfr. Compagnie de commerce, in F. BLUCHE, sous la direction de,
Dictionnaire du Grand Siècle, Paris, Fayard, 2005, pp. 371-372.
73
Giuseppe Patisso
la rivalità tra le due potenze fu posta in gioco proprio con tale
commercio, culminata con la guerra dei Sette Anni (1756-1763). Dal
'500 all’800 la tratta si organizzò intorno a tre itinerari che coprivano sia
il tratto che partiva dall’Europa, sia quello che dalle Americhe andava in
Africa e sia quello che partiva dall’Africa stessa, dove un gruppo di
protagonisti attivi, i négriers noirs, si occupava di reclutare schiavi tra le
proprie popolazioni. La definizione di “commercio triangolare” fa
riferimento alla tratta del Nord Atlantico, la più cospicua, ma esistevano
almeno altri due percorsi: la tratta luso-brasiliana 19 e la tratta indiana, 20
quest’ultima basata sulle relazioni con il Madagascar. I principali porti
europei negrieri erano collocati sull’Atlantico: Liverpool (il più
proficuo), Londra, Bristol, Bordeaux, Nantes, Le Havre, La Rochelle,
Amsterdam, Rotterdam. Le zone più coinvolte dell’Africa furono il
Golfo di Guinea, la Costa d’Oro, il Golfo di Benin e quello di Biafra. 21
Destinatari erano le Antille (Cuba, Santo Domingo, Giamaica) e il
Brasile, che accolse quasi l’80% degli schiavi giunti nel Nuovo Mondo.
In America del Nord, basi furono Chesapeake, Charleston e New
Orleans. Le percentuali medie di profitto oscillano tra 5-10% e non
appaiono elevate, ma, esaminando i singoli viaggi, si dimostrano
variazioni enormi: dalla perdita totale del carico a guadagni che
raggiungevano anche il 150%. Ponendo una sintesi, si può affermare che
tratta e schiavitù furono tra i fattori dello sviluppo economico
occidentale: esse contribuirono a spiegare, in termini marxisti, la fase
dell’accumulazione originaria di capitale, investito in seguito nella
rivoluzione industriale. Poi, alla tratta erano legate molteplici attività
locali come la costruzione ed armamento delle navi, il commercio dei
19
Avviata dal 1550 nel Sud Atlantico e gestita autonomamente da brasiliani
dopo l’indipendenza (1822), collegava direttamente senza passaggio il Brasile
all’Africa: i prodotti del Brasile venivano scambiati con schiavi o con avorio,
rivenduto poi ai portoghesi.
20
Le strade di questo commercio partivano spesso dal Brasile per toccare le basi
dell’Africa occidentale e raggiungere l’Africa orientale. Tra questi, non
mancavano gli schiavi emancipati, insediati in Africa da più generazioni, che
gestivano essi stessi i traffici nei circuiti interni al continente.
21
Attuali Costa d’Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Gabon, Congo, per
circa l’80%, ma anche dalle coste nord degli attuali Senegal, Gambia, GuineaBissau e Sierra Leone.
74
Dall'asiento ai codes noirs
prodotti coloniali, un sistema bancario e assicurativo organizzato. Le
variazioni nei ricavi dalla tratta dipendevano da molteplici eventi, come
i conflitti bellici, il middle passage, 22 le rivolte e le repressioni a bordo.
Nonostante queste fasi di caduta, la tratta mostra una progressiva ascesa
durante l’età moderna: si passò globalmente dai circa 19.000 trasporti
annuali del 1680 ai 90.000 del 1790 ai 33.000 del 1860. Si tratta, in ogni
caso, di uno dei più grandi spostamenti forzati di esseri umani della
storia: una vera deportazione di massa. Per concludere e verificare su
dove venissero investite le somme guadagnate attraverso la
compravendita di schiavi, non sembrerà casuale che la Gran Bretagna,
prima potenza negriera del Settecento, abbia dato vita alla rivoluzione
industriale.
Non mancarono, come vedremo, intere legislazioni volte a
istituzionalizzare la pratica: i codici neri o slaves codes, che
regolamentavano l’esistenza dei neri, schiavi e liberi, dei mulatti, degli
zambos (nati da unioni tra neri e indios), ma che imponevano norme
pure ai bianchi. Al 1667 risale il primo intervento legislativo del
parlamento londinese, che riconobbe la liceità della schiavitù africana
nelle colonie. 23 Il primo slaves code fu emanato in Virginia, nel 1705, e
rimase in vigore fino all’Ottocento. Man mano tutte le colonie
definirono, così, lo status giuridico dello schiavo, dichiarato perlopiù
chattel property, bene mobile commerciabile. Nel corso del Settecento,
dunque, la schiavitù era diventata progressivamente una istituzione
fondamentale per l’economia sudista. Si passò dai circa 600.000 schiavi
del Settecento ai 4 milioni del 1860. In Brasile e nei Caraibi, ove la
popolazione schiavile raggiunse l’85% del totale, prese piede il
fenomeno dei marronage, ossia la fuga in massa dalle piantagioni, anche
se raggiungere la frontiera non era facile a causa dell’azione dei
22
“Passaggio di mezzo”, la traversata dell’Atlantico che durava dei mesi e
comportava alti tassi di mortalità. Cause di morte per gli schiavi e per i membri
dell’equipaggio erano malattie gastrointestinali, febbri e, soprattutto, lo
scorbuto, legato alla carenza di vitamina C, contenuta in cibi freschi che non
erano disponibili lungo le traversate (a bordo c’erano solo legumi secchi, riso,
mais e manioca).
23
Si tratta dell’Act to Regulate Negroes on British Plantations, 1667. Cfr. J.P.
RODRIGUEZ, ed., Slavery in the United States: A Social, Political, and Historical
Encyclopedia, vol. II, Santa Barbara, CA, Abc-Clio, 2007, pp. 89-91.
75
Giuseppe Patisso
cacciatori di schiavi. 24 Il Code noir francese, così come il Codigo negro
carolino 25 (di Carlo III), adattati ed estesi ognuno alle proprie colonie
d’oltreoceano, regolamentavano la sfera religiosa, lo status e l’eventuale
affrancamento degli schiavi. Anche riguardo la schiavitù nell’Europa del
Settecento, si provvide a consolidare una legislazione volta a
regolamentare la loro condizione giuridica, soprattutto in Francia, dove
venne messo in crisi il principio secondo cui il suolo francese rendeva
liberi, ed anche in Inghilterra, che era stata da sempre contraria alla
schiavitù in madrepatria, ma ne era radicalmente stata pervasa. 26
Prima del Codice carolino, tra i diversi provvedimenti legislativi
che verranno adottati, o che si tenterà di adottare, per regolare l’afflusso
e la vita degli schiavi vi è anche l’Ordenanzas de la Mesta de 1574 (in
83 capitoli), la quale contiene disposizioni che stabiliscono il controllo
degli schiavi (non solo neri) nei lavori della terra e il comportamento
che dovevano osservare. Tra i vari provvedimenti era contemplato che:
«Que ningún español ni mestizo que sirviere a cualquier dueño de
estancia, ni ningún negro, ni morisco pueda tener hierro suyo con que
hierre ganado para sí [...]». 27 Oppure, che «ningún indio, ni mulato, ni
negro, ni mestizo que haya sido vaquero que esté en pueblo de indios de
los comarcanos a las dichas estancias de ganados, o alguna de ellas, no
pueda tener lanza, ni dexaterradera de ninguna suerte ni manera que sea,
so pena de veinte pesos de minas [...]». 28
Inoltre, veniva affermato che «los mayordomos y criados que
hubieren servido y cometido delitos, castíguense vendiendo el castigo
24
La Northwest Ordinance del 1787 riconobbe ai padroni il diritto di inseguire
gli schiavi anche nel Nord, per ricondurli nelle piantagioni in nome della tutela
della proprietà.
25
È il Codigo de legislacion para el gobierno moral, politico y economico de
los negros de la isla Espanola, 1783. Cfr. J.A. SACO, Historia de la esclavitud
de la raza africana en Nuevo Mundo, Barcelona, Imprenta de Jaime Jepús,
1879.
26
Lo testimoniano i moltissimi annunci di compravendita di schiavi sulla
stampa dell’epoca, sia in Inghilterra che in Francia.
27
P. MUNGUÍA – J. PATRICIA, Derecho indiano para esclavos, negros y castas.
Integración, control y estructura estamental, en «Memoria y Sociedad», VII,
15, 2003, p. 200.
28
Ibid.
76
Dall'asiento ai codes noirs
dellos y que sirvan al mismo dueño». 29 Era, ancora, regolamentata la
proprietà di alcuni particolari animali, come i cavalli, e, a tal proposito,
veniva previsto che «ningunos mestizos, indios, negros, mulatos no
tengan caballo proprio». 30
Il cosiddetto Código negro carolino è chiamato in questo modo in
quanto redatto sotto il regno Carlo III di Borbone. 31 Il Codice, non
appena emanato dal sovrano, fu inviato al Consejo de Indias per il suo
esame e la sua approvazione; esso restò, in realtà, inapplicato, anche se,
pare, ispirò la Cedola Reale del 31 maggio del 1789, relativa alla
questione degli schiavi, ma che non ebbe seguito a causa della resistenza
di coloro che volevano mantenere la condizione servile dei neri nelle
Antille e, soprattutto, a Cuba e a Puerto Rico. Il código carolino si
configura come una ricompilazione di antiche ordinanze su neri, mulatti
e liberti e risulta essere stato compilato sul modello del code noir
francese. Il testo è formato da trentasette capitoli, divisi in vari commi.
Ma, ancor prima del Codice carolino, le colonie spagnole
iniziarono a dotarsi di strumenti legislativi, che avevano come oggetto
proprio la questione degli schiavi. Il 6 gennaio del 1522, il viceré delle
Indie, Diego Colon Y Muñiz, emanò, in nome del re di Spagna Carlo I,
delle norme, denominate Ordenanzas de los Negros, che constavano di
ventitrè disposizioni rivolte non solo a regolamentare la vita degli
schiavi neri nelle colonie, ma anche quella degli altri schiavi (compresi
alcuni bianchi). 32 Nella colonia di Santo Domingo 33 furono diverse le
29
Ibid.
Ibid.
31
Si veda J. MALAGON BARCELO, Código negro carolino (1784) o código negro
español, Santo Domingo, Ediciones de Taller, 1974.
32
Cfr. ARCHIVIO GENERAL DE INDIAS [d'ora in avanti A.G.I.], Patronato 295, n.
92.
33
Cfr. “Las leyes de Indias contra los esclavos fugitivos, pronuncian la pena
del azote y de los grillos, esposas o cadenas. Los negros no pueden ausentarse
sin un permiso escrito de sus amos; si ellos golpean a un blanco, pueden ser
condenados a la pena de muerte y el porte de armas les está prohibido; pero
esas leyes están muy descuidadas en Santo Domingo; lo que no tiene lugar con
aquella que ordena que las Audiencias Reales oigan y hagan justicia a los
esclavos que reclaman la libertad, pues éstas no permiten que los amos
maltraten a los esclavos”, in M.L.E. MOREAU DE SAINT-MÉRY, Descripción de
30
77
Giuseppe Patisso
ordinanze emanate che contemplavano anche la questione degli schiavi
e ciò si verificò in un arco temporale che va dal 1528 al 1547 fino al
1768. 34 Non c’è dubbio che il Codice carolino nacque dall’Illuminismo
spagnolo e dal riformismo borbonico, ma non trovò mai applicazione a
Hispaniola. Scrive Américo Moreta Castillo: «El Código Negro
Carolino nunca fue Derecho Positivo en la Isla Española, pero sus
disposiciones se basaron en aspectos de la realidad, y con el mismo se
trataron de corregir situaciones en la convivencia de blancos, negros,
mulatos, esclavos y libertos en la colonia española más antigua del
Nuevo Mundo, pero donde hubo características muy peculiares». 35
Un Codice che, invece, fu applicato appieno nelle colonie
americane, e nella fattispecie in quelle francesi, è il cosiddetto Code
noir. Promulgato da Luigi XIV nel 1685, esso rappresenta la massima
espressione della legislazione schiavista tra XVII e XVIII secolo. È un
testo giuridico fondamentale nella regolamentazione della schiavitù dei
neri nelle terre francesi d'oltreoceano come la Guyana, le Antille e la
Louisiana, quest'ultima colonia nordamericana, avamposto chiave per
l'espansione e i rapporti commerciali verso settentrione. 36
Nel preambolo dell'editto si afferma:
«Louis, par la grace de Dieu roi de France & de Navarre: A
tous, présents & à venir, salut. Comme nous devons également
nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous
notre obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en
notre présence les mémoires qui nous ont été envoyées par nos
Officiers de nos îles de l’Amérique, par lesquels ayant été
informés du besoin qu’ils ont de notre autorité & de notre
justice pour y maintenir la discipline de l’Eglise catholique,
apostolique & romaine, pour y régler ce qui concerne l’état &
la qualité des esclaves dans nos dites îles, et désirant y pourvoir
& leur faire connaître qu’encore qu’ils habitent des climats
la Parte Española de la Isla de Santo Domingo. Barcelona, Gráficas M. Pareja,
1976, pp. 91-94.
34
Si veda C. LARRAZÁBAL BLANCO, Los negros y la esclavitud en Santo
Domingo, Santo Domingo, Julio D. Postigo y Hijos Editores, 1975, pp. 110 ss.
35
A. MORETA CASTILLO, Aspectos históricos y jurídicos del Código negro carolino, in
«Clío – Órgano de la Academia Dominicana de la Historia», LXXVII, 176, Juliodiciembre de 2008, p. 47.
36
G. HAVARD – C. VIDAL, Histoire de l’Amérique française, Paris, Flammarion, 2003, p.
477; J. PRITCHARD, In Search of Empire: The French in the Americas, 1670–1730,
Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 313-333.
78
Dall'asiento ai codes noirs
infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur
sommes toujours présent, non seulement par l’étendue de notre
puissance, mais encore par la promptitude de notre application
à les secourir dans leurs nécessités. A ces causes, de l’avis de
notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance &
autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons,
37
statuons et ordonnons, voulons & nous plaît ce qui ensuit».
La redazione del Code Noir iniziò nel 1681, quando Jean Baptiste
Colbert, segretario di Stato e della Marina francese, ordinò, previa
autorizzazione del sovrano, di redigerlo. 38 Deceduto Colbert, fu il figlio,
Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Seignelay, a portare avanti l'opera di
codificazione del padre, terminata due anni più tardi grazie anche alla
collaborazione dei redattori Charles de Courbon, conte di Blenac,
(gouverneurs et lieutenants généraux des îles d'Amériques per il re di
Francia tra il giugno del 1684 e il febbraio del 1691) e Jean-Baptiste
Patoulet, il quale, come segretario del governatore della “Nuova
Francia”, Jean Talon, 39 aveva potuto apprendere e regolamentare i
metodi del commercio triangolare nelle nuove colonie. Il Code Noir del
1685 è composto da sessanta articoli che regolamentano la vita, la
morte, l'acquisto, la vendita, l'affrancamento e la religione degli schiavi.
È sentita, da parte delle autorità francesi d'oltremare, la volontà di
diffondere presso questi ultimi la religione della Chiesa cattolica,
apostolica e romana e, allo stesso tempo, di impedire alle altre fedi di
37
Code Noir, in Requeil d’edits, declarations et arrets de sa Majeste, Paris,
Libraires Associez, 1744.
38
Cfr. R. BLACKBURN, The Making of New World Slavery: From the Baroque to
the Modern, 1492-1800, London-New York, Verso, 1997, pp. 290-292.
39
Originario di Châlons-su-Marna in Champagne, Jean Talon fa i suoi studi a
Parigi, al collegio di Clermont, diretto dai gesuiti, ed occupa poi importanti
posizioni nell’amministrazione militare fino ad essere nominato, nel 1630, dal
cardinale Richelieu a capo del Consiglio del re Luigi XIII e del suo principale
ministro. Il suo impegno è indirizzato a ristabilire e ad imporre ovunque
l’autorità del sovrano di fronte agli ultimi sussulti di un potere feudale ormai in
declino. Fu governatore nelle colonie canadesi della “Nuova Francia” e, sotto
suo diretto impulso, fu avviato il commercio triangolare tra il Canada, le Antille
e la Francia. Cfr. T. CHAPAIS, The Great Intendant: A Chronicle of Jean Talon
in Canada 1665-1672, G.M. WRONG – H.H. LANGTON, eds., Whitefish,
Kessinger Publishing, 2004, pp. 4-5.
79
Giuseppe Patisso
poter attecchire. Risulta interessante notare come fosse proibito alle fedi
riformate e non ortodosse diffondersi nelle colonie francesi d’oltremare
alla stessa stregua della religione ebraica 40 (e qui si apre un aspetto
importante che sarà oggetto delle mie ricerche). Possiamo dividere il
Code Noir in sei diverse parti.
La prima, che contempla gli articoli che vanno dal I al XIV, si
ordinava alle autorità d'oltremare di cacciare gli ebrei da quei territori in
ottemperanza alla Lettera di Patente di Luigi XIII del 23 aprile 1615; si
proibiva ogni altra fede che non fosse quella cattolica romana, alla quale
dovevano essere convertiti e battezzati gli schiavi (il battesimo risulta
essere più sistematico nei paesi dell'Illinois, soprattutto per la presenza
attiva dei gesuiti); si obbligava il rispetto della domenica e delle altre
feste religiose cattoliche attraverso la totale astensione dal lavoro. Ma è
anche affrontata le legislazione relativa ai matrimoni tra gli stessi
schiavi appartenenti ad un’unica piantagione, tra due schiavi di
piantagioni diverse o tra schiave e padroni. 41
La seconda parte di articoli (XV-XXI) regolava la vita degli
schiavi nel quotidiano, ribadendo che essi non erano in alcun modo
proprietari del loro corpo e che era proibito loro portare armi offensive o
grossi bastoni, appartenere a padroni diversi o vendere e detenere ogni
prodotto senza l'espresso consenso dei loro padroni.
Una terza parte di articoli (XXII-XXIX) regolamentavano il
sostentamento degli schiavi da parte del padrone, il quale era tenuto a
fornire ad ogni schiavo due abiti di tela l'anno, farina di manioca, e
provvedere al fabbisogno degli schiavi, concedendo loro di poter
lavorare alcuni giorni della settimana per conto proprio. Nell'art. XXVI,
40
Delle problematiche relative alla presenza degli ebrei nel Nuovo Mondo, in
parte visto come un nuova terra promessa, si veda G. IURLANO, Sion in America.
Idee, progetti, movimenti per uno Stato ebraico (1654-1917), Firenze, Le
Lettere, 2004.
41
È necessario sottolineare, inserendosi nella diversa prospettiva,
dichiaratamente razzista, del Code Noir del 1724, che vi è una modifica a
riguardo, riportata all’inizio dell’art. VI del Codice aggiornato, secondo la quale
si proibisce ai sudditi bianchi dell’uno e dell’altro sesso di contrarre matrimonio
con i neri, pena una punizione o un’ammenda comminata arbitrariamente
proibendo in maniera categorica a qualsiasi curato, sacerdote, missionario,
secolare o regolare di celebrare il matrimonio (art. XI).
80
Dall'asiento ai codes noirs
lo schiavo denutrito e maltrattato ingiustamente dal padrone aveva il
diritto di rivolgersi al procuratore coloniale per far valere i suoi “diritti”
e perseguire i padroni. Per la prima volta compariva nel Codice uno
strumento giuridico di difesa dello schiavo. La realtà, tuttavia, era ben
diversa: non sussistevano le condizioni minime affinché fosse fatta
giustizia, anche perché non venivano considerati crimini tutti quei
trattamenti che oggi definiremmo “torture”.
Una sorta di quarta parte del Codice è costituita dagli articoli che
vanno dal XXX al XXXVII. Tali articoli precludevano agli schiavi ogni
forma di ribellione: essi non potevano agire giuridicamente, né
protestare; in particolar modo, gli articoli che vanno dal XXXIII al
XXXV, contemplavano persino l'uso della pena di morte per gli schiavi
(anche in condizione di libertà) colpevoli di aver colpito il proprio
padrone o i componenti della sua famiglia, 42 le persone libere, 43 o di
aver rubato cavalli, muli, buoi, mucche. 44 Per i furti, ritenuti meno gravi,
di montoni, pollame, capre, zucchero, manioca, piselli o altri legumi era
prevista la punizione a colpi di frustate e il marchio a fuoco sulla spalla
col simbolo del giglio.
Gli articoli che vanno dal XXXVIII al XLIII delineavano la pena
per lo schiavo che non si adeguasse e che trasgredisse. Le autorità
intervenivano nel mutilare, amputare, uccidere, oppure perdonare. La
fuga di uno schiavo andava punita e la punizione era commisurata al
tempo passato dal momento in cui era fuggito. Se la “latitanza” durava
più di due mesi, gli si poteva tagliare il garretto, mentre la successiva
punizione consisteva nella pena di morte. 45 Erano previste pene in
natura nei confronti degli schiavi che avessero dato rifugio ad un
42
«L’Esclave qui aura frappé son Maître, ou la Femme de son Maître, sa
Maîtresse, ou leurs enfans, avec contusion de sang, ou au visage, sera puni de
mort». Art. XXXIII de Code Noir, in Requeil d’edits, cit., p. 92.
43
«Et quant aux excès et voies de fait, qui seront commis par les Esclaves,
contre les personnes libres, voulons qu’ils soient sévérement punis, même de
mort s’il y échet». Art. XXXIV, ibid.
44
«Les vols qualifiés, même ceux des chevaux, cavales, mulets, boeufs et
vaches qui auront été faits par les esclaves, ou par les affranchis, seront punis de
peines afflictives, même de mort si le cas le requiert». Art. XXXV, ibid., pp. 9293.
45
Cfr. ibid.
81
Giuseppe Patisso
fuggitivo: erano condannati a pagare al padrone dello schiavo 300 libbre
di zucchero per ogni giorno in cui era stato nascosto. Era, inoltre,
previsto un risarcimento in denaro al padrone che aveva denunciato il
suo schiavo, se quest'ultimo fosse stato condannato a morte.
Gli articoli che compongono l’ultima parte del Codice (la sesta)
delineano lo schiavo alla stessa stregua di un oggetto trasferibile, di cui
occorreva fissare il prezzo. Egli non era né un animale, né un persona,
ma solo merce. Fissare dei parametri precisi nella vendita ed acquisto di
tale merce avrebbe evitato ai bianchi ogni sorta di controversia in
occasione di transazioni finanziarie. Già l'articolo XLIV dichiarava gli
schiavi “beni mobili”, che potevano entrare nelle colonie senza dar
luogo ad ipoteche e ad altri diritti feudali o signorili; nell'articolo
seguente si specificava che le autorità, tuttavia, non intendevano privare
i sudditi della possibilità di precisare che gli schiavi appartenevano a
loro, ai loro familiari, nonché ai loro discendenti «ainsi qu'il se pratique
pour les sommes de deniers & autres choses mobiliaires». 46 Per
qualsiasi questione relativa al sequestro degli schiavi per omesso
pagamento dei debiti, la loro condizione andava equiparata a quella
degli altri beni mobili, prevedendo solo alcune eccezioni: «Ne pourront
être saisis et vendus séparément le Mari & la Femme & leurs enfans
impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même Maître» 47 e, per
questo, ogni sequestro o vendita, effettuati senza tener conto di quanto
sopra enunciato, andavano considerati nulli. Era proibito – in linea
generale - il sequestro per debiti degli schiavi tra i 14 ed i 60 anni,
impiegati nella lavorazione dell'indaco o negli zuccherifici, e gli articoli
che vanno dal XLVIII al LIII definivano questioni relative ai modi e ai
tempi del sequestro degli zuccherifici comprensivi degli schiavi che vi
lavoravano; dell'appartenenza dei figli degli schiavi nati durante il
periodo del sequestro; della presenza o meno su di essi di privilegi,
ipoteche, diritti feudali e signorili. Di seguito, e fino al LVII articolo, si
ingiungeva a chiunque avesse in affidamento degli schiavi di trattarli
come avrebbe fatto un buon padre di famiglia, si stabilivano le regole
per l'affrancamento e per l'esercizio dello stesso. Una sorta di
avvertimento era riservato agli schiavi affrancati, i quali, seppur
46
47
82
Art. XLV, ibid., p. 95.
Art. XLVII, ibid., p. 96.
Dall'asiento ai codes noirs
“liberi”, dovevano continuare ad avere un “particolare rispetto” nei
confronti dei loro antichi padroni, delle loro vedove e figli. Se
l'eventuale ingiuria nei loro confronti era considerata estremamente
grave – e per questo la punizione andava commisurata alla gravità del
reato – lo stesso articolo riteneva gli affrancati liberi e dispensati
«envers eux de toutes autres charges, services, & droits utiles que leurs
anciens Maîtres voudroient prétendre, tant sur leurs personnes, que sur
leurs biens, & successions, en qualité de Patrons». 48 Agli affrancati
(LIX articolo) erano accordati gli stessi diritti, immunità e privilegi
goduti dagli individui nati liberi e, inoltre, vi era un accenno di
umanitarismo nel momento in cui si voleva che la libertà acquisita dallo
schiavo producesse per loro e per i loro beni «les mêmes effets que le
bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres Sujets». 49 L'ultimo
articolo del Codice, il LX, nel primo comma contemplava la
destinazione di un terzo delle somme ricavate dalle confische e dalle
ammende all'ospedale dell'isola, mentre nel secondo comma si davano
disposizioni alle autorità della Martinica, di Guadalupe e San Cristoforo
affinchè il Code Noir fosse letto, pubblicato, registrato e rispettato nella
sua interezza, in quanto, nelle intenzioni dei legislatori, doveva
sostituire tutte le regole e le consuetudini fino ad allora in vigore. In
questi termini si chiude il Codice che riporta le indicazioni di rito,
consistenti nel luogo e nella data di presentazione, nonché nelle firme
apposte sul documento: «DONNÉ à Versailles, au mois de Mars, l'an
de grace mil six cens quatre-vingt-cinq, & de notre Règne le quarantedeuxiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roy, COLBERT. Visa, LE
TELLIER. Et scellé du Grand Sceau de Cire verte en lacs de Soye verte
& rouge». 50 Resta aperta storiograficamente una dettagliata analisi
circa le differenze tra il code del 1685 e quello del 1724. Quest’ultima
versione, aggiornata da Jean-Frederic Phelypeaux de Maurepas, 51
modificò la stessa prospettiva dalla quale si guardava al tema della
schiavitù: «Nella seconda versione del Code Noir, decretata nel 1724
48
Art. LIII, ibid., p. 98.
Ibid.
50
Le Code noir ou Edit du Roi, cit.
51
Cfr. A. CASTALDO, sous la direction de, Code Noirs. De l’esclavage aux
abolitions, Paris, Dalloz, 2006, pp. 2-3.
49
83
Giuseppe Patisso
per la Louisiana, la componente razziale della schiavitù appare in modo
più esplicito: il sintagma “schiavo negro” vi appare, infatti, nel
preambolo, ed il termine “bianco” si utilizzerà a più riprese. Dove la
distinzione operativa opponeva nel testo del 1685 gli uomini liberi agli
schiavi, si accompagna qui un'altra distinzione tra bianchi e neri». 52 In
tutte le colonie francesi, l'applicazione del Codice nero fu, tuttavia,
limitata e ciò non era raro che avvenisse, soprattutto se non
corrispondeva agli interessi economici locali: «Les planteurs, avec la
complicité passive des autorités locales et de la justice royale, ne
retinrent du Code Noir que ce qui leur convenait». 53 Nella bassa
Louisiana, l'azione congiunta tra schiavi e padroni portò ad
un'autonomia normativa che andava oltre le direttive della Corona.
52
53
84
Ibid.
HAVARD – VIDAL, Histoire de l’Amérique française, cit., p. 477.
Eunomia. Rivista semestrale del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Eunomia 1 n.s. (2012), n. 1, 85-98
e-ISSN 2280-8949
DOI 10.1285/i22808949a1n1p85
http://siba-ese.unisalento.it, © 2012 Università del Salento
Alessandro Isoni
Farewell to the European Community:
The Lisbon Treaty and the conceptual shifts
of a sui generis public law experience
Abstract: After a quick look at some of the new provisions introduced by the Lisbon Treaty,
the article aims to bring to light some of the legal and ideological implications related to the
decision of erasing all references to the term “Community” from the Lisbon Treaty. Starting
from an etymological analysis of the term “Community”, the research explores how the
decision to give such a name to the first successful experiments of European integration in
1951 and in 1957 was, on the one hand, a cultural legacy of the Thirties and Forties and, on
the other hand, necessary in order to achieve some political goals. In line with this, it will be
possible to understand how the term «Community», quite unusual in the context of
international organizations, allowed for more opportunities than the term “Union”, which
seems, prima facie, to embody the old federalist dream of the United States of Europe.
Keywords European Community; European Union; Lisbon Treaty.
1. From European Community to European Union. An inconsequential
shift?
On 29 October 2004, the Treaty establishing a Constitution for Europe was
signed in Rome. It was considered by all the observers as the most
important step towards the accomplishment of the European integration.
Issued after an original constituent process, the new European Constitution
contained a lot of new measures, like the juridical personality of the
European Union and the introduction of identity symbols, like the European
flag and anthem. 1 Among a wide set of institutional changes, in the new
1
On this point see, ex multis, C.H. CHURCH – D. PHINNEMORE, Understanding the
European Constitution: An Introduction to the EU Constitutional Treaty, London,
Alessandro Isoni
Constitution for the first time in over fifty years didn’t appear the term
“Community”, substituted with the term European Union.
It was a considerable novelty that was unanimously evaluated as a great
stride forward in the process that had begun in Maastricht in 1992.
Unfortunately, we know that the Constitution for the Europe was overruled
by the French and Dutch referenda, blocking the European integration
process in a subsidiary track. 2 It was only three years after, the 13th of
December 2007, that in Lisbon was signed a new Treaty, less advanced in
regard to the previous one, but the best result that was possible to obtain
after the Euroshock of the Constitution failure. 3
However, the Lisbon Treaty, that among other things contains a lot of
concessions in favour of the so-called Eurosceptical opinions, conserved the
decision to abandon the term “Community” in favour of “European Union”,
maybe because everybody considered that the term Union allows more
significant advantages. 4 For a first, it eliminated the double expression
“European Community/European Union”, with the result of more cohesion
and intelligibility of the institutional architecture of the European building,
that before was possible to explain only addressing to quite bizarre images,
i.e. the Greek temple. 5 Second, the term “Union” is apparently closer to the
old federalist dream aiming to create the United States of Europe, following
Routledge, 2006; J. ZILLER, The European Constitution, The Hague, Kluwer Law
International, 2005.
2
The rough path that eventually led to the failed ratification of the European
Constitution is reproduced by A. DUFF, The Struggle for Europe’s Constitution,
London, The Federal Trust for Education and Research, 2006 and by D. CURTIN –
ALFRED E. KELLERMANN – S. BLOCKMANS, eds., The EU Constitution: The Best Way
Forward?, The Hague, TMC Asser Press, 2005.
3
The main novelties of the new European Treaty are examined by S. GRILLER – J.
ZILLER, eds., The Lisbon Treaty: EU Constitutionalism without a Constitutional
Treaty, Wien, Springer-Verlag, 2008.
4
As a matter of fact, there is only one point in the preamble of the Treaty where is
possible to find the term “community”, with the new European constituents pay
tribute to the European integration started by the Communities in the Fifties of the
Twentieth century.
5
On the Maastricht Treaty see, among the others, R. CORBETT, The Treaty of
Maastricht: From Conception to Ratification, London, Longman, 1995; A. DUFF – J.
PINDER – R. PRICE, Maastricht and Beyond: Building the European Union, London,
Routledge, 1994.
86
Farewell to the European Community
the example of the United States of America, where is used the term
“Union” as synonym to define themselves. 6
So, it seems that the term "Union" is more adapt to our times, while the
term “Community” represents an old world, that was characterised both by
an international imprinting of the Treaty and by a cryptic functioning of the
European institutions, considered remote by the citizens. 7 In this line, we
would thank the High Contracting Parties for this decision, because with the
term “Union” they are also going to solve the «democratic deficit» of
Europe. 8
Notwithstanding, an apparent neutral linguistic operation, conceived in
order to achieve a greater attractiveness of the European integration process,
in our opinion hides a more important meaning. In the next paragraphs,
we’ll search for explaining the etymological origin of the term
“Community”, and then we’ll see as the decision to erase this term from the
Lisbon Treaty represents, in a certain way, a regress in the integration
process. 9
2. Communitas
In the last century, the studies around the “Community” as political and
sociological concept have been very successful. Since the seminal Max
Weber’s masterpiece Economy and Society, with a part precisely entitled
Community, the political science has meditated for long on this
simultaneously old and modern way to organize human societies. 10
6
On the federalist ideology about Europe, see W. LIPGENS, ed., A History of
European Integration, vol. I, The Formation of the European Unity Movement,
Oxford, Clarendon Press, 1982, and S. PISTONE, ed., I movimenti per l’Unità
europea 1945-1954, Milano, Jaca Book, 1992.
7
On this point see, among others, M.T. BITSCH – W. LOTH – R. POIDEVIN, eds.,
Institutions européennes et identités européennes, Brussels, Bruylant, 1998.
8
On the main features emerged during the European constituent process, see M.
KRZYZANOWSKI – F. OBERHUBER, (Un)Doing Europe: Discourses and Practices of
Negotiating the EU Constitution, Brussels, Peter Lang, 2007.
9
On the meaning of symbols – like flags and anthems – in the construction of a
European identity, see the book edited by L. PASSERINI, Figures of Europe: Images
and Myths of Europe, Brussels, Peter Lang, 2003.
10
The reference is to the famous works by M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft:
die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und die Mächte. Nachlaß, t. 1,
Gemeinschaften, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 2001, and F. TÖNNIES,
87
Alessandro Isoni
Obviously, in this occasion we won’t dwell long on this point, while our
attention will be devoted to the semantic meaning of the term
“Community”. As often happens, also this term has a Latin root: in fact,
from the term “Communitas” derive the English “community”, the French
“communauté”, the Italian “comunità”, the Spanish “comunidad”, while
from the common Indo-European root of the Greek “koinos” derives the
German adjective “gemein” and the substantive “Gemeinschaft”. 11
In this line, we can immediately appreciate that the term “Community”
and its adjective “common” and “communitarian” refers to an important
cleavage in the human society, i.e. mine/ours, public/private;
common/individual and so on. So, we can say that “common” is everything
that it’s not owned by anybody or, better, is owned by everybody.
Nonetheless, in our hypothesis it’s not really important the semantic root
of “Community”, but we should be very interested in the etymological
analysis of the Latin “Communitas”. According to the mainstream of
thought, we can say that “Communitas” is a complex term originated from
the union of two other terms, i.e. “cum” and “munus”. While we know that
“cum” means “with”, it’s very difficult to try to give a meaning to the term
“munus”, that had a strong social characterization, and which pushes
towards an idea of “must”, as it’s demonstrated by three terms strictly
related to it, like “onus”, “officium” and “donum”. 12 For the first two terms
it’s quite clear the meaning of “must”, while it’s very strange that this
meaning is related to the last one. Why a “gift” should be a "duty"?
According to the magisterial studies of Marcel Mauss on the concept of
“gift”, it’s implicit that every gift needs to be repaid: once somebody has
accepted a gift (a munus) is obliged (onus) to reciprocate with some good
or service (officium), in an uninterrupted chain, as indicate very well the
English form of the verb “to take to”. 13 In other terms, it’s a matter of a gift
that you must give and that you can’t refuse to give. In this line, the gift is
Gemeinschaft und Gesellschaft, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
2005.
11
On this point, see E. BENVENISTE, Le vocabulaire des institutions indoeuropéenne, Paris, Minuit, 1969, vol. I, pp. 47-90.
12
See N. ZAGAGI, A Note on ‘Munus’, ‘Munus Fungi’ in Early Latin, in «Glotta»,
LX, 3-4, 1982, pp. 280-281.
13
On the double meaning of the term “gift”, see M. MAUSS, Essai sur le don. Forme
et raison de l’échange dans les societiès archaïques, in «Année sociologique», 1,
1923-1924, pp. 30-186 and, most recently, J. STAROBINSKI, Largesse, Paris, Réunion
des Musées Nationaux, 1994.
88
Farewell to the European Community
only the gift that you give, and not the one that you receive. Interrupting this
biuniqueness, the munus don’t imply the stability of the ownership, but, on
the contrary, is a loss, a pledge, or a tribute that we are obliged to pay.
So, people that live together in a community have in common a duty, not
an advantage; they are united not by a property, but by a duty or, better, a
debt. In other words, the members of a community live in absence of
something, in a way that we can calmly say that the void is the element that
characterizes the essence of the community itself, obliging all subjects to
search outside themselves for their identity. 14 Because of this bond shortcircuit, that forbids the repayment of the debt, is created a communitarian
tie that unite people. In this way, the community would create an
indissoluble link among States, or – why not? –, people going beyond the
same federal (lat. foedus, agreement) scale of a pact.
3. The cultural and political roots of the concept of “European
Community”
After this short etymological analysis, apparently irrelevant to our common
interest in the European history of the second half of the Twentieth century,
a natural question comes to our mind: why, in 1951, was adopted the term
“Community” to indicate the first successful experience in the European
integration process?
Actually, the analysis of the term “Community” has been often
considered as something of not very important, while studies on European
history have concentrated on the diplomatic relationships among States, on
the institutional structure of the Community and on the economic and
juridical integration. 15 Seldom there has been a deep reflection on the origin
of the term “Community” and, above all, on the persons who decided to
adopt this denomination for the coal and steel pool. We could have the
impression that is a pointless question, but we are strongly convinced that
the oblivion in which has fallen the origin of the term “Community” has
14
On the philosophical meaning of the term “communitas”, see the reflection of R.
ESPOSITO, Communitas: The Origin and Destiny of Community, Stanford, Stanford
University Press, 2010.
15
In order to have a complete state of the art about European integration history, see
the work edited by W. KAISER - A. VARSORI, European Union History. Themes and
Debates, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010.
89
Alessandro Isoni
political and cultural reasons, and derives from the will to hide some
unavowable original sin of the European integration process. 16 In this line,
we can ask for why people who participate to the Paris Conference didn’t
adopt the term “Organization” or “Union”, frequently utilised in the
international law jargon.
To give an answer to these questions we must go back to the reflections
on the search of a “third way”, that widespread along Europe and United
States of America during the Thirties and the Forties of the Twentieth
century. 17 In particular, the most important conceptual elaborations took
place in France, where there was a paroxysmal research of an answer to the
problems issued from the Great Depression. 18 It would be only a matter of
an expression issued from that nebula of intellectuals and experts that, in a
famous book of 1969, J.-L.- Loubet Del Bayle defined as the “nonconformistes groupes”, engaged during the years immediately before and
during the Second World War in a painstaking research of a middle path
between bolshevism and capitalism, in order to lead to unity and harmony
the European societies, torn apart by conflicts between capital and labour. 19
In this sense, the concept of “communauté de travail” became very
important, like a French declination of the Italian Fascist corporatism, with
a market ruled by the State through planning measures. 20
One of the most important exponents of this variegated movement was
François Perroux, whose intellectual route is perfect to explain the destiny
of a lot of people that, for different reasons, devoted themselves to this
16
On this point, see M. MAZOWER, Dark Continent: Europe’s Twentieth Century,
London, Allen Lane, 1998.
17
See R. FRANK, ed., Les identités européennes au XXe siècle, Paris, Publications de
la Sorbonne, 2004.
18
On this point, see A. SALSANO, Ingegneri e politici. Dalla razionalizzazione alla
«rivoluzione manageriale», Torino, Einaudi, 1987.
19
See J.-L. LOUBET DEL BAYLE, Les non-conformistes des années ’30, Paris,
Editions du Seuil, 1969, and P.H. BAUCHARD, Les technocrates et le pouvoir, Paris,
Arthaud, 1966.
20
There is a large bibliography about corporativism in Italy during the Fascist
regime. On this point see, among others, A. GAGLIARDI, Il corporativismo fascista,
Roma-Bari, Laterza, 2010, and L. FRANCK, Il corporativismo e l’economia
dell’Italia fascista, Torino, Bollati Boringhieri, 1990. The close relationships
between France and Italy in experiencing corporativism are demonstrated by the
works by A. SALSANO, L’altro corporativismo. Tecnocrazia e managerialismo tra le
due guerre, Torino, Il Segnalibro, 2003.
90
Farewell to the European Community
search. In 1938, Perroux wrote a first book, Capitalisme et communauté de
travail, and, during the Vichy regime, another work entitled Communauté,
where he made an innovative synthesis of German and Austrian corporatist
ideas and Mounier’s personalism. In his opinion, the main goal of the
community should be the collaboration between capital and labour, by
means of the community itself, that he defined as a public or semi public
group where are equally represented employers and workers, and with
conflicts solved by the State intervention, which has also the power to fix
goods and services prices instead of the free market. In this line, the State,
or the Community would change its relationships with the economy,
becoming an arbiter of the economic life, through the creation of a regime
of “organized market”. 21
These reflections were at their height during the Vichy regime, when
“Community” became a password, a concept able to mobilize people in
order to realize the “National Revolution” wished by Petain. Some of the
places chosen for developing these reflections were the Ecole des cadres
d’Uriage and the Mont-Dore Days. 22 In particular, at Uriage were
developed many reflections on the term “Community”, analyzing the
subject under manifold points of view, as demonstrates the title of lessons
held there. One of these seminars was held by another exponent of the
“communitarian” movement, Paul Reuter, who afterwards should be one of
the hidden inspirers of the Schuman plan. Reuter, like Perroux, thought that
State were not able to afford the challenges of modern economy,
characterized by the presence of transnational trusts and oligopolies. In this
context, the only prescription for winning economic depression was to
equip States with new tools, like a modern bureaucratic apparatus and a
greater territorial dimension. 23
21
On the influence of these reflections in the postwar Europe, see the book edited by
O. DARD – E. DESCHAMPS, Les relèves en Europe d’un après-guerre à l’autre.
Racines, réseaux, projets et postérité, Brussels, Peter Lang, 2008.
22
On this point, see A. DELESTRE, Uriage, une communauté et une école dans la
tormente (1940-1945), Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1989, and R. JOSSE,
L’École des cadres d’Uriage (1940-1942), in «Revue d’histoire de la deuxième
guerre mondiale», LXI, 1, 1966, pp. 49-74. On the Mont-Dore Days, see P.
NICOLLE, Cinquante mois d’armistice. Vichy, 2 juillet 1940-26 août 1944; journal
d’un témoin, 2 vols., Paris, André Bonne, 1947, vol. 1, pp. 148-149.
23
On this point, see A. ISONI, Planisme and “Third Way” Ideologies in the ECSC
High Authority, in D. PREDA – D. PASQUINUCCI, eds., The Road Europe Travelled
91
Alessandro Isoni
In this line, the reflections on the economic problems resulted in an
integration conception, where each State were almost obliged to cooperate
with other States, giving place to a new institutional structure, that were
composed by the multiplicity of the national communities. The final goal of
this communitarian and third way conceptions was the creation of a
“European community”, with its federal institutions and its mutual
obligations, with a delegation of some fields of sovereignty and the ultimate
goal of peace among European nations. We can perfectly see how this
vision, quoted by one of the report presented during the Mont-Dore Days,
are the same of the Schuman plan and of the ECSC Treaty. 24
In fact, the irenic factor is always present in this description of the new
“communitarian order”, conceived as a way to solve two terrible cleavages
in the European societies: on one hand, the international conflicts, from
which derived three wars between France and Germany in less than seventy
years and, on the other hand, the class struggle, with strives between capital
and labour as disruptive elements in national communities. 25 In this line, the
Second World War represented the synthesis of these two cleavages,
leading the European civilisation to destruction.
In 1945, these reflections, issued from milieus more or less
compromised with Fascism, were reverted by the Christian-Democrat
political parties all over the Europe, thanks to the Mounier personalist
imprinting, very close to the Church social doctrine. 26 Moreover, this switch
along: The Evolution of the EEC/EU Institutions and Policies, Brussels, Peter Lang,
2010, pp. 267-279.
24
See A. COHEN, Le Plan Schuman de Paul Reuter entre Communauté nationale et
Fédération européenne, in «Revue française de science politique», XLVIII, 5, 1998,
pp. 645-663.
25
The long-lasting fight in order to solve the problem of European crisis in the
Twentieth century is well described by CH.S. MAIER, In Search of Stability:
Explorations in Historical Political Economy, Cambridge, Cambridge University
Press, 1987.
26
On the other hand, Emmanuel Mounier had participated to the Italian-French
Workshop on Corporativism held in Rome in 1935, how is demonstrated by the
work of G. PARLATO, Il convegno italo-francese di studi corporativi (Roma 1935).
Con il testo integrale degli atti, Roma, Fondazione Ugo Spirito, 1990. At the end of
the Second World War, many of the ideas developed by Mounier were used to
conceive a new organic social order. On the influence of the Christian doctrines in
the European integration see, among others, PH. CHENEAUX, Une Europe Vaticane?
Entre le Plan Marshall et les Traités de Rome, Bruxelles, Ciaco, 1990 and E.
92
Farewell to the European Community
of corporatist themes in democratic was favoured by the spread of
Keynesianism, an economic theory which was inclined to the creation of
public organisation in order to expedite industrial rebuilding. Brought in
Europe by the American technocrats of the Marshall plan, Keynesianism
allowed both Perroux and Reuter to work without problems in the new
French Fourth Republic, and Reuter managed to find the way to collaborate
with Monnet before on the project of the Commissariat au Plan and, then,
on the Schuman plan. 27
4. From supranationality to subsidiarity: the end of an era?
In 1951, when was signed the Paris Treaty, six years were passed away
since the end of the war. In this short time, we have seen as many of the
ideas conceived and developed in France during the German occupation,
and all oriented to find out a third way in order to eliminate the Bolshevik
threat and the ghost of an economic crisis, become the pillars on which was
built the new Western Europe. At the moment of the launch of the Schuman
plan, a new concept comes out, so to explain the new dimension of the
future European organisation: supranationality. 28
Supranationality, like community, in our opinion seems to own a
particular and more advanced ethos with respect to federal, a term that was
utilised as password by all the European movements. Issued from the
reflections developed before and during the war in the Fascist prisons, and
strictly linked to the American history, the term “federal” refers anyway to a
LAMBERTS, ed., Christian Democracy in the European Union (1945-1995),
Proceedings of the Leuven Colloquium, 15-18 November 1995, Leuven, Leuven
University Press, 1997.
27
On the close relationships between America and Europe in the postwar period, see
M.J. HOGAN, The Marshall Plan: America, Britain and the Reconstruction of
Western Europe, 1947-1952, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
28
On this point, see E.B. HAAS, Beyond the Nation State, Stanford, Stanford
University Press, 1964; N. HEATHCOTE, The Crisis of European Supranationality, in
«Journal of Common Market Studies», V, 2, 1966, pp. 140-171; and J.H.H. WEILER,
The Community System: The Dual Character of Supranationalism, in «Yearbook of
European Law», 1, 1981, pp. 267-306. For an historical interpretation, see the book
edited by W. KAISER – B. LEUCHT – M. RASMUSSEN, The History of the European
Union: Origins of a Trans- and Supranational Polity 1950-1972, London,
Routledge, 2009.
93
Alessandro Isoni
pact (a foedus) among States, always keeping the real power to States; on
the contrary, supranational is an innovative and quite peculiar way to
indicate a new phenomenon in the international relations. 29 Coming back to
the previous pages, in our opinion “supranational” simply seems indicate
the right and only territorial dimension to face the new challenges issued by
the modern capitalism, founded on oligopolies and transnational groups. 30
In other words, “supranational” is an original word to indicate a new
model of integration, where the States have lost their leadership and, on the
contrary, have become the real beneficiary of the international or, better, sui
generis organisation, thanks overall to the irenic and supranational
dimension of the Community. 31 In this line, we can say that "supranational"
and “community” are two Siamese twins, since, even if unconsciously, in
the meaning of “supranational” there would be the original meaning of
communitas, where all the European States are debtors with each other and,
at a rate of these mutual debts, are obliged to find out a dimension able to
fill a “sovereignty void” through the creation of a “Community”. The
“European Community”, a new constitutional space (cum-sto, i.e. I live
with), where to test a new modus vivendi in the international relations,
characterized by economic cooperation and peace. 32 A concept of peace
that, according to the Catholic Church organicistic visions, should avoid
struggles, both between capital and labour and among States, just as during
the Thirties had postulated people who searched for a third way.
29
On the supremacy of the States in the European integration process, see the works
of A.S. MILWARD, The Reconstruction of Western Europe, 1945-51, London,
Routledge, 1984, and ID., The European Rescue of the Nation-State, London,
Routledge, 1992.
30
See P. LINDSETH, Democratic Legitimacy and the Administrative Character of
Supranationalism: The Example of European Community, in «Columbia Law
Review», IC, 3, 1999, pp. 628-738 and P. CRAIG, The Nature of the Community:
Integration, Democracy and Legitimacy, in P. CRAIG – G. DE BURCA, eds., The
Evolution of EU Law, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 27-50.
31
On the novelty represented by this concept, see the reflections developed by G.
THIEMEYER, Supranationalität als Novum in der Geschichte der internationalen
Politik der fünfziger Jahre, in «Journal of European Integration History», IV, 2,
1998, pp. 5-21.
32
An European constitutional space is imagined by P. HÄBERLE, Per una dottrina
della Costituzione come scienza della cultura, Roma, Carocci, 2001, specifically pp.
113-150.
94
Farewell to the European Community
If we consider right the previous reflections on the term “Community”,
we can also see how are misleading all the conceptual reconstruction of the
European Communities issued by international law scholars, who say that
the Community is a kind of “quality” added to States, which remain the real
subjects of the international law, on the philosophical basis that a
Community is a “property” of Member States or is a “substance” produced
by their union. 33 But, as a matter of fact, this is a Union. 34
A Community, on the contrary, is based on the idea that we need a new
representation of the reality, filling the political-institutional void created by
the Second World War, when was impossible to come back to old political
conception based on the predominance of States. Maybe, this was the only
positive heritage of the war, with States and nationalism brought back to the
right dimension. 35
As often happens, the philosophical figure of the paradox is useful to
understand this strange phenomenon. “Common” is used to be identified
with its contrary: it’s common everything group together the properties of
everyone. People have in common their things, they are the owner of their
common. Passing to the international law, we listen very often that States
are the masters of the Treaties: but in this case we are out of the concept of
Community issued in the Thirties and Forties. It was the direct opposite:
33
Theorists of intergovernmentalism affirm that States continue to be the centre of
the European integration. For a wide range of these theories, see A. MORAVCSIK,
Preference and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist
Approach, in S. BULMER – A. SCOTT, eds., Economic and Political Integration in
Europe: Internal Dynamics and Global Context, Cambridge, MA, Blackwell, 1994
and, of the same author, Why the European Community Strengthens the State:
Domestic Politics and International Cooperation, in «Harvard University CES
Working Paper Series», 52, 1994.
34
For a critical approach to the Maastricht Treaty, see J.H.H. WEILER, The
Constitution of Europe: “Do the New Clothes Have an Emperor?” and Other
Essays on European Integration, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp.
238-263.
35
Jean Monnet was one of the first persons to understand the end of nationalism and
the necessity to proceed to integration among States. On the pivotal role played by
Monnet in the European integration, see F. DUCHÊNE, Jean Monnet: The First
International Statesman of Interdependence, New York–London, W. W. Norton and
Company, 1994, and, for his relationships with US Administrations, see J.
GILLINGHAM, American Monnetism and the European Coal-Steel Community in the
Fifties, in «Journal of European Integration History», I, 1, 1995, pp. 21-36.
95
Alessandro Isoni
States, at the end of Second World War, didn’t own anything, having lost
war and demonstrated that they were a real menace for civilisation. 36
In this line, we can say that States themselves shouldn’t exist without the
new European Communities, which produced inside them a lot of changes –
political, economical, juridical and so on – so much as to change them out
of all recognition after their membership in the Communities. 37
What is left of this? With the shift from the term “Community” to the
term “Union” we can say that a world came to an end. But, what has been
the reason of this shift? In our opinion, it’s very important to analyse when
this shift has taken place. The first time that we have ever heard the term
“Union” has been in 1992, when was signed the Maastricht Treaty. 38 This
was no coincidence that the Maastricht Treaty was signed only three years
after the Berlin Wall fall, ushering in a restless constituent process that has
seen five Treaties signed in only fifteen years, at the average of a Treaty
every three years. 39
The main reason of this unaccomplished constitutional revision is the
end of the Cold War, which has fooled European States to have regained a
new centrality in the world. The political defeat of the Soviet Union and the
German reunification have been two signals that convinced States to start a
deep power transfer from supranational to national level, with the
introduction of a set of measures all referred to strengthen the role of States
to Community’s disadvantage. 40 The introduction of the term “Union”,
together with the subsidiarity principle and the narrow enumeration of
Union competences, have ended an half-century experience that have been
36
On the reconstruction of National identities after the Second World War, see the
work edited by B. STRÅTH, Myth and Memory in the Construction of Community:
Historical Patterns in Europe and Beyond, Brussels, Peter Lang, 2000.
37
The main issues related to this theme are studied by J.H.H. WEILER, The External
Legal Relations of Non-Unitary Actors: Mixity and the Federal Principle, in H.G.
SCHERMERS – D. O’KEEFFE, eds., Mixed Agreements, Deventer, Kluwer, 1983, pp.
35-83.
38
Oppositely, the same year is utilized as a milestone by A.S. MILWARD - V.
SØRENSEN, eds., The Frontier of National Sovereignty: History and Theory 19451992, London, Routledge, 1993.
39
About the European integration process from a juridical point of view, see J.H.H.
WEILER, The Transformation of Europe, in ID., The Constitution of Europe, cit., pp.
10-101.
40
In this line, see A. MORAVCSIK, The Choice for Europe: Social Purpose and State
Power from Messina to Maastricht, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1998.
96
Farewell to the European Community
centred on two fundamental pillars: the Implied Powers theory and the
functional way of integration, with its most important corollary, the spillover effect. 41
The new European Union come out from the Lisbon Treaty is inspired
by the opposite concepts: the Union powers and competences are strictly
listed, while has been strongly weakened the European Court of Justice’s
powers to implement Implicit Powers, if these are not yet contained in the
Treaty. 42
We can another time go back to the paradox figure: a Treaty born in
order to rationalize the European institutional and legal structure, to deepen
the European integration, also thanks to a change of name, actually “freeze”
forever the integration process, unless the Member States decide to change
the Treaties, with all problems that we managed to see in the last years. 43
Finally, we can calmly say that, if it is true that things correspond to
names, then the shift from European Community to European Union is the
most important signal that teaches us how a glorious chapter of the
European integration history has ended forever. Our last consideration is
that we don’t know if future will be better than past.
41
On the principle of “implied powers” see, ex multis, the essays by A. TIZZANO,
Les compétences de la Communauté, in EUROPEAN COMMISSION, Trente ans de droit
communautaire, in «Perspective Européennes», I, 45, 1982, pp. 49-52; CH. SASSE –
H. CH. YOUROW, The Growth of Legislative Power of the European Communities, in
T. SANDALOW – E. STEIN, eds., Courts and Free Markets: Perspectives from the
United States and Europe, vol. II, Oxford, Oxford University Press, 1982 and, lastly,
J.A. USHER, The Gradual Widening of European Community Policy on the Basis of
Article 100 and 235 of the EEC Treaty, in J. SCHWARZE – H.G. SCHERMERS, eds.,
Structure and Dimensions of European Community Policy, Baden Baden, Nomos,
1988, pp. 25-36.
42
See P.D. MARQUARDT, Subsidiarity and Sovereignty in the European Union, in
«Fordham International Law Journal», XVIII, 2, 1994, pp. 616-640 and F. RONGE,
Legitimität durch Subsidiarität, Baden-Baden, Nomos, 1998.
43
To draw a balance of the European constitutional experience, see J.H.H. WEILER,
Federalism without Constitutionalism: Europe’s Sonderweg, in K. NICOLAIDIS – R.
HOWSE, eds., The Federal Vision: Legitimacy and Levels of Governance in the
United States and the European Union, Oxford, Oxford University Press, 2001, Ch.
2.
97
Eunomia. Rivista semestrale del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Eunomia 1 n.s. (2012), n. 1, 99-130
e-ISSN 2280-8949
DOI 10.1285/i22808949a1n1p99
http://siba-ese.unisalento.it, © 2012 Università del Salento
Francesco Martelloni
Geografia, economia e politica dell'Adriatico orientale:
i rapporti italo-balcanici in uno studio di Carlo Maranelli del 1907
Abstract: The 1907 VI Italian Geographical Congress took place at the eve of the AustroHungarian annexation of Bosnia and Herzegovina. The Balkans were a potential area of
economic, political and strategic expansion – then only at the beginning – of the Kingdom of
Italy, which in those times was allied and competitor of the Hapsburg Empire. The Geographer
Carlo Maranelli’s (radical-democrat and soon collaborator of Salvemini) interesting report
analysed the geographico-economic situation of the Eastern Adriatic seacoast and also the
Italo-Austrian competition. It caught limits and potentialities of the Italian penetration into
those areas, thus wishing a pacific Italo-Balkanic collaboration. But the analyses and
descriptions of territories and communications, of coasts and harbours, were certainly useful
also for Italian politicians and military by then involved – such as the Austrian ones – in
strategic considerations and war studies in the Adriatic. The various military institutes’
involvement in the congress showed, in fact, how geography, military art and Italian
expansionism were getting more and more interconnected.
Keywords: Eastern Adriatic; Italian-Balkans Relations; Carlo Maranelli's study.
Introduzione
Il VI Congresso geografico italiano, tenutosi a Venezia alla fine del maggio
1907, vedeva, tra altre d'ampio spettro tematico, la relazione di Carlo
1
Maranelli – allora insegnava presso la Regia Scuola Superiore di
1
Carlo Maranelli (Campobasso 1876 - Napoli 1939), professore di geografia economica a Bari
dal 1904 e poi, dal 1921, all'Università di Napoli, dove fondò e diresse l’Istituto di studi
superiori di scienze commerciali fino al 1925, quando fu rimosso per la sua manifesta
opposizione al fascismo. Formatosi alla scuola di Giuseppe Dalla Vedova, si occupò delle
relazioni tra l’Italia e l’altra sponda adriatica e, soprattutto, di geografia del Mezzogiorno, con
particolare riguardo alla distribuzione della popolazione. Con Gaetano Salvemini, nel 1916,
scrisse il puntuale saggio La questione dell'Adriatico [cfr. G. SALVEMINI, Dalla guerra
mondiale alla dittatura, 1916-1925, a cura di C. PISCHEDDA, Milano, Feltrinelli, 1973, pp. 285473], con cui gli autori smontavano, con rigore filologico e documentario, le tesi nazionalimperialiste italiane che auspicavano la conquista di territori adriatico-balcanici su presunte
Francesco Martelloni
Commercio di Bari – dal titolo: Sui rapporti economici con l’altra sponda
dell’Adriatico (Dalmazia – Bosnia – Erzegovina – Montenegro – Albania –
sponde adriatiche). 2 Questo contributo appariva allora – e in verità tuttora –
particolarmente interessante non solo dal punto di vista scientifico,
geografico-economico, ma anche, sebbene più indirettamente, politico. Né
poteva mancare l'interesse dei militari per le analisi e le considerazioni lì
esposte. Sottolineava, inoltre, l'attenzione della Forze armate e del ministero
degli Esteri per gli studi geografici l'adesione a quel congresso (tra varie
accademie, istituti, società, enti morali, riviste) anche della direzione
generale degli Affari coloniali del ministero degli Esteri, dell'Istituto
coloniale italiano, del Regio istituto geografico militare, del militare
Comitato per le Colonie, della «Rivista marittima» (mensile della Regia
Marina), della Regia scuola di guerra, della Reale Scuola macchinisti della
Reale Marina. Aderiva pure l'Associazione irredentistica “Trento e Trieste”.
D'altra parte, i rapporti tra gli studi geografici del tempo e l'arte militare
erano lì oggetto della specifica comunicazione del tenente colonnello dello
Stato maggiore, Eugenio Caputo. 3 La stessa scelta della sede veneziana – si
diceva nel Bando del 1906 con cui si promuoveva il VI Congresso –
rinviava alla «sua lunga storia gloriosa [e alle] tracce indelebili di una
millenaria vita feconda, che può ben dirsi essere stata geografia in atto, e
che noi, traendo da essa ispirazioni e auspicii, dobbiamo voler rinnovare per
la fortuna e la grandezza della nuova Italia». 4
All’epoca, quella “nuova Italia” cominciava a pensarsi “più grande”:
molto interessata a una crescita d'influenza politico-economica – per taluni
anche d'espansione coloniale – soprattutto in Africa e nel Mediterraneo a
sud, ma anche in Adriatico orientale. Appariva, infatti, già notevole e
istanze risorgimentali. Diversamente, ribadisce oggi il “risorgimentalismo” delle politiche di
Sonnino e Salandra negli anni del conflitto mondiale, C. GHISALBERTI, Adriatico e confine
orientale dal Risorgimento alla Repubblica, Napoli, ESI, 2008, p. 86. Alcuni dei lavori di
Maranelli sul Mezzogiorno sono stati ristampati e raccolti nel volume Considerazioni
geografiche sulla questione meridionale, a cura di C. BARBAGALLO, G. LUZZATTO e F.
MILONE, Bari, Laterza, 1946.
2
C. MARANELLI, Sui rapporti economici con l’altra sponda dell’Adriatico (Dalmazia –
Bosnia – Erzegovina – Montenegro – Albania – sponde adriatiche), in Atti del VI Congresso
Geografico Italiano. Adunato in Venezia dal 26 al 31 maggio 1907, Vol. I, Notizie, Documenti,
Rendiconti e Relazioni, Venezia, Premiate officine grafiche C. Ferrari, 1908, pp. 145-209.
3
Cfr. E. CAPUTO, L'arte militare e l'odierno indirizzo degli studi geografici, in Atti, cit., Vol. II,
pp. 183-189.
4
Bando del VI Congresso geografico italiano, Venezia 25 novembre 1906, in Atti, cit., Vol. I,
p. XXXI.
100
Geografia, economia e politica dell'Adriatico orientale
crescente l’interesse italiano per l’instabile situazione geo-politica dei
Balcani: per gli equilibri economici, militari e strategici del Golfo di
5
Venezia e del suo retroterra orientale. In verità, tale questione – è noto –
era sensibilmente più datata: in qualche modo si era posta già in tempi
preunitari quando, esplicitamente, Cesare Balbo, nel celebre Delle speranze
6
d'Italia del 1844, aveva legato la prospettiva di una confederazione italiana
indipendente e di un ampliamento, auspicabilmente pacifico, del regno
piemontese nel Lombardo-Veneto, come conseguenza del crollo dell'impero
turco e dell'“inorientamento” (nei Balcani, appunto) dell'impero austroungarico. Il tutto all'interno del processo di allargamento planetario di una
“cristianità” a primato cattolico. Poi, il Risorgimento e l'unificazione
nazionale avevano seguito un altro corso e altre modalità. Dal 1882 la
Triplice Alleanza aveva stabilizzato e poi consolidato i rapporti italoaustriaci. Ma tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, dal punto di
vista italiano si dinamizzavano tanto lo scacchiere mediterraneo, quanto
quello balcanico. L'“interesse nazionale” per le aree adriatico-orientali,
però, aveva una duplice, a volte contraddittoria, motivazione: una, “neorisorgimentale”, consisteva nella prospettiva del definitivo compimento del
processo di unificazione nazionale (con Trento, Trieste e Gorizia); l'altra,
declinava ormai “l'interesse nazionale” in termini espansionistici e
imperialistici, forte dell'accelerata industrializzazione del paese verificatasi
5
Cfr. F. CATALUCCIO, Antonio di San Giuliano e la politica estera italiana dal 1900 al 1914,
Firenze, Le Monnier, 1935. Per una efficace sintesi della politica estera italiana fino al primo
conflitto mondiale e del relativo dibattito storiografico, cfr. E. DECLEVA, L'Italia e la politica
internazionale dal 1870 al 1914: l'ultima fra le grandi potenze, Milano, Mursia, 1974. Per più
ampie ricerche sul nesso tra politica estera e interna, cfr. ID., L’incerto alleato. Ricerche sugli
orientamenti internazionali dell’Italia unita, Milano, Franco Angeli, 1987; B. VIGEZZI,
L’Italia unita e le sfide della politica estera. Dal Risorgimento alla Repubblica, Milano,
Unicopoli, 2001; G. MAMMARELLA – P. CACACE, La politica estera dell'Italia. Dallo Stato
unitario ai giorni nostri, Roma-Bari, Laterza, 2006. Si vedano pure i recenti saggi di O.
TAMBURINI, “Oltre la foschia”. Orientalizzazione dell’Italia e percezione dell’Adriatico nel
primo ventennio del Novecento; G. FERRAIOLI, La visione politica dell’Adriatico dalla fine
dell’Ottocento agli esordi del fascismo, in S. TRINCHESE – F. CACCAMO, a cura di, Adriatico
contemporaneo. Rotte e percezioni del mare comune tra Ottocento e Novecento, Milano,
Franco Angeli, 2008.
6
Cfr. C. BALBO, Delle speranze d'Italia, Capolago, Tipografia elvetica, 1844 (si veda
soprattutto il capitolo X). Ma queste tesi erano già state abbozzate nel suo scritto del 1821,
Considération sur le soulèvement des Grecs (inedito fino al 1913) e poi ampiamente formulate
nel 1841, nei Pensieri sulla storia d'Italia, pubblicati postumi nel 1858 (cfr. G.B. SCAGLIA,
Cesare Balbo. Il Risorgimento nella prospettiva storica del «progresso cristiano», Città di
Castello, Studium, 1975, capitoli VII, XI, XII, XIII).
101
Francesco Martelloni
tra la fine dell’Ottocento e la crisi del 1907, della positiva situazione della
finanza pubblica, delle sue più complessive trasformazioni sociali e
culturali.
Ma per i Balcani, forse ancor più che per le “terre irredente”, Austria e
Italia erano condannate – come si diceva al tempo – a essere «o alleate o
nemiche». Tuttavia, la loro ormai trentennale alleanza non escludeva il
manifestarsi di tensioni politiche e culturali (l’irredentismo e la reazione
7
austriaca avevano portato ai sanguinosi scontri di Innsbruck del 1903-4),
di concorrenzialità economiche e marittimo-mercantili – tra i porti di
Trieste, Fiume, Ragusa e Sebenico da un a parte, e Venezia, Ancona, Bari e
Brindisi dall’altra. Si ravvivavano, inoltre, antagonismi, più o meno
manifesti, in Montenegro e Albania; occhiute vigilanze militari per il
dominio dell’Adriatico – dalle basi navali di Pola, Fiume e Cattaro o da
8
Venezia e, secondariamente, da Ancona e Brindisi. Si rafforzavano le
rispettive flotte mentre, soprattutto gli austriaci, fortificavano le frontiere
terrestri del Trentino o dell’Isonzo e le corredavano di una efficiente rete
ferroviaria.
L’Italia giolittiana, insomma, ormai più forte politicamente ed
9
economicamente all’interno, e più attiva sullo scenario internazionale
grazie ai nuovi rapporti multilaterali progressivamente realizzati da Visconti
Venosta, Prinetti, Tittoni e di San Giuliano, restava alleata degli imperi
centrali, ma ballando quel valzer della sua politica estera – poco tollerato
dal principe di Bülow – sul ponte delle moderne e armatissime corazzate
dreadnoughts. E molto attenta ai destini dell'antico “Golfo di Venezia”: del
“lago italiano”, come affermava una retorica propaganda variamente
7
Si vedano gli equilibrati rapporti del console italiano a Innsbruck, Caccia Dominioni, inviati
al ministro Tittoni tra l'ottobre e il dicembre 1904, in I documenti diplomatici italiani, S. III:
1896-1907, v. VIII, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2007.
8
La Marina italiana invidiava le basi navali e le migliori condizioni strategiche dell'impero:
«L’Austria-Ungheria gode nell’Adriatico di una posizione privilegiata rispetto all’Italia. Infatti,
mentre questa non ha in quel mare che una debole base navale, Venezia, situata all’estremo
nord del lungo litorale indifeso, e che può facilmente essere bombardata dal mare, l’Austria
con Pola facilmente difendibile [...] con l’arcipelago della Dalmazia, con Cattaro [...]
inespugnabile, possiede basi navali di superiorità strategica incontestabile». Confronto fra la
flotta italiana e quella austro-ungarica, gennaio 1904, Archivio Ufficio Storico della Marina –
Roma – c. 185, f. 3.
9
Cfr. G. SPADOLINI, Il mondo di Giolitti, Firenze, Le Monnier, 1970; E. GENTILE, L'Italia
giolittiana 1899-1914, Bologna, Il Mulino, 1990 (1977).
102
Geografia, economia e politica dell'Adriatico orientale
10
nazionalista.
Infatti, più delle colonie d’Eritrea e Somalia e accanto agli “interessi
nazionali” tripolini – che l’Italia aveva cercato di tutelare, da una parte, con
le intese mediterranee con Francia e Gran Bretagna tra il 1900 e il 1902, e,
dall’altra, attraverso patti con gli alleati austro-tedeschi, stretti in occasione
dei rinnovi della Triplice Alleanza – ormai prioritari apparivano gli interessi
italiani adriatico-balcanici. Ciò valeva per le élites liberali del regno e,
variamente, anche per le forze politiche d’opposizione. Interessava gli
operatori economici, la diplomazia e le forze armate – soprattutto la Regia
Marina che lamentava la scarsa difendibilità delle basse e continue coste
adriatico-occidentali per l'assenza di buoni porti, a fronte di una evidente
superiorità orografica, logistico-strategica, austriaca. In particolare, gli
interessi nazionali adriatici, se apparivano in qualche modo formalmente
tutelati dalle clausole del trattato triplicista (difesa dello status quo
balcanico o compensi in caso di modifiche, anche temporanee, in favore di
una delle due alleate) fin dal primo rinnovo del 1887, e poi dalle specifiche
intese austro-italiane sull’Albania (strette tra Visconti Venosta e
Goluchowski nel 1898 e ribadite dai loro successori), tuttavia risultavano
poi esposti all’effettivo espansionismo dell’Austria-Ungheria, al suo Drang
nach Osten proiettato verso Salonicco, e che doveva procedere lungo la
11
ferrovia
longitudinale
balcanica
in
via
di
realizzazione.
Contemporaneamente, si andava riproponendo con più forza, dopo la
sconfitta col Giappone del 1905, il tradizionale interesse russo – in intesa
concorrenziale con la stessa Austria-Ungheria (Muerzsteg 1904) – per gli
10
Cfr. R. NASSIGH, La Marina italiana e l'Adriatico. Il potere marittimo in un teatro ristretto,
Roma, Ufficio Storico della Marina Militare, 1998; M. GABRIELE – G. FRIZ, La politica navale
italiana dal 1885 al 1915, Roma, Ufficio Storico della Marina Militare, 1982; F. MARTELLONI,
La Triplice Alleanza e l'Adriatico. Dalla convenzione navale ai piani di guerra (1900-1909), in
«Ricerche Storiche», XL, 2, 2010, pp. 299-347.
11
«La Triplice Alleanza del 1882 – sintetizzerà, nel 1923, Salvemini – era un sistema
rudimentale, che permetteva all’Italia appena appena di vivere senza essere aggredita e
schiacciata dai suoi alleati. La Triplice Alleanza e la Intesa anglo-italiana del 1887 formavano
un sistema più complesso, che assicurava all’Italia non solamente la vita, ma lo statu quo
nell’Africa settentrionale e nella penisola balcanica. Nel 1902 il sistema dell’87 diventò anche
più complesso, per l’intrecciarsi della nuova intesa italo-francese con la Triplice Alleanza e con
la Intesa anglo-italiana. In questo sistema, la garanzia dello statu quo nella penisola balcanica è
sempre mantenuta. Invece, per la Tripolitania la garanzia dello statu quo è sostituita dalla
prelazione dell’Italia». G. SALVEMINI, La politica estera italiana dal 1871 al 1915, a cura di A.
TORRE, Milano, Feltrinelli, 1970, p. 357. Per un’analoga recente interpretazione del «sistema
Prinetti del 1902», cfr. MAMMARELLA – CACACE, La politica estera dell'Italia, cit., pp. 48-52.
103
Francesco Martelloni
assetti balcanici, per gli Stretti del Mar di Marmara e per i popoli slavi del
Sud, che ormai ostentavano con forza crescente un variegato, conflittuale,
protagonismo nazionale. Né il “grande malato” turco sembrava poter
12
garantire ancora a lungo lo status quo nei suoi possedimenti europei. La
grave crisi macedone del 1903-4 l’aveva nuovamente dimostrato, alimentata
com’era dai conflitti religiosi (tra cattolici, ortodossi e musulmani), dai
conflitti sociali-rurali e tra clan, dagli ideali patriottici o dalle diverse
ambizioni nazionalistiche, fino alle provocazioni armate di bulgari, greci e
serbi. Crescevano, inoltre, anche se contraddittoriamente, le pretese
autonomistiche o indipendentistiche albanesi, variamente appoggiate o
strumentalizzate da italiani e austriaci con l’attivismo dei rispettivi
consolati, agenti, preti e associazioni politico-culturali. I montenegrini, a
loro volta, volevano accrescere il loro territorio e ambivano al porto di
Durazzo. Ma a questo ambiva anche la Serbia (il “Piemonte dei Balcani”),
che mirava ad un’espansione verso sud ed a un suo sbocco adriatico, se non,
addirittura, ad una confederazione jugoslava. A loro volta, i rumeni
avanzavano rivendicazioni territoriali tanto nei confronti dell’Ungheria (per
la Transilvania), quanto dell’autonomo principato bulgaro (per Dobrugia e
Silistra). La duplice monarchia asburgica, con l'instabile equilibrio tra le sue
principali nazionalità (tedeschi e magiari), e tra queste e le altre componenti
13
del suo multietnico impero, in Istria e a Trieste adottava una politica filoslava e anti-italiana. Insomma, l’ampia area balcanica si prospettava
nuovamente come pericoloso terreno di concorrenzialità e conflitti etnici,
sociali, nazionali e internazionali. Tanto più che dietro l’Austria incombeva
l'Impero guglielmino, nuova potenza industriale-militare ben presente
finanziariamente e con infrastrutture nell’Impero turco. Con la ferrovia per
Baghdad arrivava a minacciare, dal Golfo Persico, l’impero inglese.
Contemporaneamente, cresceva l’antagonismo tedesco con la Francia
repubblicana per le colonie, e, soprattutto per gli armamenti navali, con
12
Cfr. E. HOSCH, Storia dei paesi balcanici. Dalle origini ai nostri giorni, Torino, Einaudi,
2005 (1998); F. GEOGEON, L’ultimo sussulto (1878-1908) e P. DUMONT – F. GEORGEON, La
morte di un impero (1908-1923), in R. MANTRAN, a cura di, Storia dell’Impero ottomano,
Lecce, Argo, 1999 [1989]. Sempre preziosi: L. SALVATORELLI, Storia del Novecento, Milano,
Mondadori, 1980 [1964] e P. RENOUVIN, Il secolo XIX, 1871-1914. L'Europa al vertice della
potenza, Firenze, Vallecchi, 1961.
13
Cfr. F. FEJTÖ, Requiem per un impero defunto. La dissoluzione del mondo austro-ungarico,
Milano, Arnoldo Mondadori, 1996 [1988].
104
Geografia, economia e politica dell'Adriatico orientale
14
l’Inghilterra di Edoardo VII. Non casualmente, proprio dal 1907 si avviava
quell’intesa anglo-russa per la Persia e l’Afghanistan che, insieme
all’Entente Cordiale, concorreva a distruggere definitivamente la politica di
equilibrio europeo realizzata da Bismarck. Aumentavano così sensibilmente
– nonostante le rassicurazioni formali del nuovo pacifismo europeo – le
occasioni ed i pericoli di un grande conflitto tra le potenze dei due
schieramenti internazionali. Se in Africa era il Marocco a costituire il pomo
della discordia (appena sopita ad Algeciras) tra le potenze europee, in
Europa lo erano i Balcani.
In tale scenario, il convegno dei geografi italiani del 1907, in sintonia
con il più generale interesse politico e culturale del regno, dava il proprio
contributo di conoscenza scientifica della situazione adriatico-balcanica,
con una attenzione particolare ai rapporti economici con quei paesi. Tanto
più che la Società geografica vedeva tra i suoi soci anche alte personalità
politiche e istituzionali. Già ne era stato presidente l’importante ed attivo
ex-ministro degli Affari Esteri, il marchese di San Giuliano, allora
ambasciatore a Londra. Tra gli altri soci c'erano leaders quali Sonnino e
Salandra. Geografia e diplomazia, infatti, da tempo interloquivano e
finivano, pur nella necessaria distinzione di ruoli e competenze, con
l'interagire, col muoversi spesso in sinergia.
Nel suo studio, basato sulle scarse statistiche del tempo, ma arricchito da
una corposa bibliografia – pubblicata lì in appendice –, Maranelli
considerava rapidamente la situazione geografica delle regioni costiere
centro-meridionali dell'Adriatico orientale e del loro retroterra. Si
soffermava, invece, sulle differenti realtà produttive e commerciali di quei
paesi, analizzando soprattutto i rapporti con l’Italia. Il geografo
radiografava la situazione con obiettività, senza la boria espansionista,
proto-nazionalista, che già caratterizzava buona parte della pubblicistica
“adriatica” del tempo. Analizzava tanto le regioni appartenenti direttamente
all’impero austro-ungarico (Dalmazia), quanto quelle controllate dalla
duplice monarchia solo amministrativamente e militarmente (Bosnia ed
Erzegovina). Queste ultime verranno annesse presto, nel 1908, aprendo una
15
grave crisi tra le potenze europee e negli stessi rapporti italo-austriaci. Ma
14
Cfr. W.S. CHURCHILL, Crisi mondiale e Grande Guerra 1911-1922, Vol I: 1911-1914,
Milano, Il Saggiatore, 1968 [1929]; F. FISCHER, Assalto al potere mondiale. La Germania
nella grande guerra, Torino, Einaudi, 1965.
15
Cfr. L. MONZALI, Italiani di Dalmazia. Dal Risorgimento alla Grande Guerra, Firenze, Le
Lettere, 2004.
105
Francesco Martelloni
la sua analisi si proiettava soprattutto sui paesi ritenuti più interessanti e
promettenti dal punto di vista commerciale e politico, e da poco oggetto
dell'iniziativa italiana: il Montenegro e le terre albanesi. Il primo era
indipendente, ma subiva le ingerenze austriache stabilite al Congresso di
Berlino del 1878; 16 le seconde sarebbero rimaste sotto sovranità turca sino
17
al 1913, al termine della seconda guerra balcanica.
La Dalmazia
La Dalmazia, ambita dal proto-nazionalismo italiano, ma appartenente
all'impero degli Asburgo, è grande poco più del Lazio – scriveva Maranelli
– e occupava kmq 12.844. Aveva allora circa 600.000 abitanti (100.000 più
della Basilicata del tempo) con una densità di 46 ab. per kmq. Limitata a
nord-est dalle Alpi Dinariche, ha una costa contornata di isole, distesa da
Arbe a Spizza, a sud, vicino al montenegrino porto di Antivari (porto,
vedremo, allora oggetto dell'interesse strategico e di interventi economici
italiani). È una lunga striscia montuosa con buon clima – continuava
Maranelli. Aveva avuto una bella vegetazione arborea, prima che fosse
impoverita dall’uomo e sostituita, ma solo in poche zone, da una
piantagione commerciale: mandorli, viti, ulivi, crisantemi. Da pochi anni
poche e mediocri ferrovie la collegavano alla Bosnia-Erzegovina
attraversando i confini montuosi. Ma «Zara, la capitale, non ha ancora udito
18
il fischio della vaporiera». Se Gravosa e Castelnuovo, a sud, erano
collegate per ferrovia alla Bosnia, Spalato e Sebenico, invece, attendevano
ancora analoghi collegamenti. «Le comunicazioni col resto dell’Austria e
dell’Europa perciò si svolgono per mare, a mezzo dei piroscafi rapidi,
comodi e numerosi del Lloyd, dell’Ungaro-Croata, della Ragusea, ecc. che
partono quotidianamente da Trieste e da Fiume per Zara e per gli altri porti
19
dalmati». Anche grazie al proficuo interessamento del governo austriaco
erano sorti numerosi centri balneari e climatici che, «insieme con le
numerose guarnigioni e le squadre navali stanziate lungo la costa dalmata,
16
Cfr. V. MANTEGAZZA, Storia della guerra mondiale. Con note militari di E. Barone,
Milano, Istituto editoriale italiano, 1915; P.G. CELOZZI BALDELLI, L'Italia e la crisi balcanica
(1876-79), Galatina (Le), Congedo, 2000.
17
Cfr. E. MASERATI, Momenti della questione adriatica (1896-1914). Albania e Montenegro
tra Austria ed Italia, S. Martino B.A. (Verona), Del Bianco, 1981.
18
MARANELLI, Sui rapporti economici con l’altra sponda dell’Adriatico, cit., p. 146.
19
Ibid.
106
Geografia, economia e politica dell'Adriatico orientale
forniscono la più importante clientela alle nostre importazioni [esportazioni
20
italiane]». Quanto all’assetto produttivo del territorio, dei 1.400 kmq resi
produttivi la metà era tenuta a pascolo: prevalentemente per gli ovini. Al
netto delle foreste, soltanto 210 kmq risultavano veramente coltivati: nelle
piccole valli e lungo le pianure costiere, alle foci dei fiumi. Secondo
Maranelli, le industrie avrebbero potuto svilupparsi facilmente in presenza
di migliori collegamenti ferroviari: «Ma pelli, lane, preferiscono ancor
prender la via del mare prima di essere lavorati: i minerali metalliferi della
Bosnia di N.-O. rimangono ancora non sfruttati; [...] perciò le industrie
21
dalmate si riducono a ben piccola cosa e di importanza locale». Fanno
eccezione la produzione tradizionale del maraschino, a Zara, e quella della
polvere di crisantemo a Sebenico. Gli italiani non partecipavano
all’esportazione dalla Dalmazia, ma capitali romani erano investiti nella
società elettrica per la fabbricazione del carburo, una produzione che
utilizzava la forza del fiume Kerba. «Purtroppo, però, una ditta italiana che
possedeva la più ricca miniera d’antracite di Sevreic (Dernis) l’ha ceduta
nel 1901 ad una ditta tedesca; mentre è in parte italiana la fabbrica di
cementi di Spalato, esercitata dalla ditta “Zamboni, Stock e C.”». 22 Per tale
scarsa capacità produttiva, commerci e pesca costituivano le principali
attività economiche della Dalmazia. I pesci – puntualizzava Maranelli –
risalgono da Corfù la costa orientale, per depositare le uova, fino al
Quarnaro e poi ridiscendono lungo la costa adriatico-occidentale. Il pescato
dalmata è di ottima qualità per la bontà delle acque; pertanto, oltre ad
un’intensa attività peschereccia si è sviluppata una correlata industria
alimentare-conserviera. Gli stessi pescatori italiani, tra le insistenti proteste
dei locali, ma tutelati dagli accordi internazionali (del 1878, 1883 e 1906),
si spingono fino ad un miglio dalle coste dalmate: «Gli italiani, infatti,
esercitano la pesca con reti a strascico tirate da due barche a vela (coccia e
paranza), al di qua del miglio marino e a profondità non minore di 8 metri
[...], mentre i pescatori dalmato-istriani esercitano quasi esclusivamente la
pesca litoranea con reti a strascico tirate da terra e con altri sistemi, perché
23
mancano di barche adatte e di personale per la pesca d’alto mare». Per
Maranelli, il forte incremento dei pescherecci italiani in acque austriache
20
Ibid., p. 147.
Ibid.
22
Ibid.
23
Ibid., p. 148.
21
107
Francesco Martelloni
era dovuto all’innovativa introduzione di una rudimentale ghiacciaia per la
conservazione del pescato. Grazie alle ghiacciaie, i pescatori potevano
regolare l’offerta del pesce, i cui prezzi in continua crescita stimolavano
l’armamento di altri pescherecci. A questo, però, si aggiungeva la proficua
attività della scuola di pesca e acquicoltura della “Società Regionale
Veneta”, che migliorava la professionalità degli operatori ittici italiani.
La città di Zara, coi suoi nuclei irredentistici, vedeva la maggiore
presenza di cittadini italiani: un migliaio di regnicoli, dei quali circa 350
esercitavano commerci e piccole industrie. Anche a Spalato i cinquecento
regnicoli erano per lo più commercianti e marinai. Una certa presenza
commerciale e industriale italiana lambiva anche Sebenico; mentre «a
Ragusa i soli commercianti di erbaggi, frutta ecc. ascendono ad una ventina
24
e son tutti [pugliesi] di Giovinazzo e di Bisceglie». Però, tanto per
l’analogia tra i prodotti agricoli italiani e quelli dalmati, quanto per la
protezione doganale austriaca, non apparivano allora possibili grandi
miglioramenti negli scambi commerciali con italo-dalmati.
La Bosnia e l’Erzegovina
La Dalmazia, invece, costituiva lo sbocco delle produzioni dell’entroterra
della Bosnia e dell’Erzegovina allora amministrate, ma non ancora
formalmente annesse, alla duplice monarchia. La sovranità apparteneva
ancora al sultano ottomano. Gli austriaci, intanto, apparivano determinanti a
mantenere pacifici e civili gli assetti di quelle regioni, e impegnati per il
loro sviluppo economico: «Bosnia-Erzegovina, infatti, sono ormai solo di
nome una provincia turca; e mediante l’occupazione austriaca che via via ha
garantito l’ordine, la sicurezza e la legalità, mercé le somme ingenti spese
per la messa in valore delle ricchezze naturali, con strade, ferrovie ecc.,
25
sono diventate in pochi anni un paese molto progredito». L’unificazione
doganale austriaca, però, rendeva quasi impossibile distinguere quanto, nei
flussi commerciali, apparteneva propriamente alla Bosnia-Erzegovina.
Questa regione montuosa – continuava il geografo – come tutto il retroterra
della cimosa litoranea carsica dei Balcani, possiede ricche riserve di foreste
24
Ibid., p. 149.
Ibid., p. 150. Sullo sviluppo economico balcanico, cfr. G. CASTELLAN, Storia dei Balcani
(XIV-XX secolo), Lecce, Argo, 1999 [1991]. Mantegazza, in Storia della guerra mondiale, cit.,
p. 12, sottolineava la permanenza, in Bosnia-Erzegovina, del primato socio-economico dei
proprietari terrieri musulmani sui contadini cristiani.
25
108
Geografia, economia e politica dell'Adriatico orientale
di querce, di faggi e di abeti, rimaste intatte sino all’occupazione austriaca
del 1878 per la mancanza di vie di trasporto. Le foreste, nel 1906,
ricoprivano i 2/5 di un paese grande poco più della somma di Lombardia e
Veneto (kmq 51.000), ma avente una popolazione di circa 7 volte inferiore,
pari a circa 1.740.000 abitanti. Bestiame e foreste costituivano le maggiori
attività economiche e d’esportazione. Sui circa 96,6 milioni di corone
dell’intera esportazione bosniaca – precisa Maranelli – più di 27 milioni
spettano a legname, carbone e torba. Mentre assommava a 18 milioni di
corone l’importo per gli animali da macello e da tiro esportati. Il maggior
prodotto industriale, quello chimico, non raggiunge i 9 milioni. La presenza
economica italiana appariva assolutamente irrisoria: «Lo sfruttamento delle
foreste è quasi tutto in mano di capitalisti austro-ungarici e l’unica ditta
26
italiana che vi partecipi è quella del Feltrinelli di Milano». La maggior
parte del legname bosniaco si dirigeva a Fiume, ma anche, lungo il corso
della Narenta, a Mectovic, divenuto un nuovo emporio raggiunto da vapori
marittimi e collegato a Gravosa per ferrovia: «L’Austria, con una spesa di
7-8 milioni, ha infatti reso navigabile la Narenta fino a 20 km dalla foce per
vapori di 3 metri di pescante e di moderato tonnellaggio, e vapori italiani e
austriaci salgono fino a Mectovic per tornare indietro carichi di legnami, o
trascinando anche rimorchiati barconi [...]. I velieri risalgono il fiume più
stentatamente, perché scarseggiano i rimorchiatori [...] mentre al ritorno, per
la rapidità della corrente, sono costretti a far strisciare l’ancora nel fondo del
fiume». 27 Per il trasporto del legname verso l’Ungheria si stava allora
studiando il modo di rendere navigabile la Bosna. Trieste, intanto, mediava
il commercio dei legnami lavorati per le botti: «Il commercio delle doghe da
botti è quasi tutto in mano di triestini, e l’Italia acquista di tale articolo
28
quantità minori che la Francia e la Germania».
Se in Dalmazia gli ovini ascendevano a 888.000 capi e i bovini a
108.200, in Bosnia-Erzegovina salivano rispettivamente a 3.231.000 capi e
a 1.416.000. I dati delle esportazioni dalmato-bosniache di animali
apparivano significativi: nel 1905 si esportavano circa 18.000 cavalli;
104.000 bovini; 89.000 ovini; quasi 57.000 caprini e 40.000 suini vivi o
macellati. Le industrie dei prodotti animali progredivano continuamente e
avevano raggiunto il sesto posto (circa 6 milioni di corone) nel paniere dei
beni esportati. Si esportavano, inoltre, 2.000.000 di chili di lana e 300.000
26
MARANELLI, Sui rapporti economici con l’altra sponda dell’Adriatico, cit., p. 151.
Ibid.
28
Ibid.
27
109
Francesco Martelloni
pezzi di pellame.
Sebbene non molto estese, progredivano anche le colture. Nel 1906, i
cereali occupavano circa 650.500 ettari di cui quasi 288.000 erano destinati
a granturco. Gli orti, e soprattutto i prugneti, occupavano un’area di 500
kmq. La tipica produzione di prugne, nel decennio 1894-1904, aveva
raggiunto una media annuale di circa 1,8 milioni di quintali, costituendo
uno dei maggiori mercati europei per le prugne secche. Ma la loro
esportazione veniva ancora mediata da Vienna o da Budapest.
L’amministrazione asburgica aveva ottenuto tali risultati seguendo, nelle
terre del demanio bosniaco, una politica di colonizzazione. Aveva fatto
insediare molte famiglie di agricoltori stranieri: 1.299 fino al 1900,
soprattutto tedeschi e ungheresi, ma non mancavano italiani, olandesi e
polacchi.
Per la Bosnia, Maranelli prevedeva un possibile futuro industriale per la
presenza di discrete risorse minerarie (giacimenti di lignite a Zenica e Tuzla
e di ferro nel Nord-Ovest) e di abbondanti corsi d’acqua. L’export minerario
principale della Bosnia – scriveva il geografo – era così composto: materie
chimiche per circa 8,7 milioni di corone; ferro e ferracce per 7,6 milioni;
olii minerali, carbone, catrame per 2,3 milioni; altri minerali per 1,3 milioni
di corone. Ma si dovevano importare i prodotti industriali della metallurgia,
i tessuti di lana e le pelli conciate. Dopo i cereali (importati per 18,45
milioni di corone) entravano nel paese tessuti vari, coloniali, ferro bevande,
pelli, e anche animali da macello e da tiro. Nel 1905, a conferma dell'avvio
di un qualche sviluppo economico, l’export complessivo bosniaco, con circa
97 milioni di corone, aveva superato l’import, pari a quasi 93 milioni,
ribaltando significativamente il rapporto dei dati del commercio estero del
1889: «Non si deve negare – ribadiva il professore – che il merito principale
di questo poderoso progresso spetta all’amministrazione austriaca
specialmente per i sacrifici fatti per munire la Bosnia di buone vie di
comunicazione [...], oggi una linea da Slav Brod a Mectovic attraversa nel
29
bel mezzo tutta la Bosnia dal confine ungherese all’Adriatico». Ma ancora
molto doveva esser fatto per articolare capillarmente i rami laterali di questo
asse ferroviario, soprattutto nel ricco Nord-Ovest. Sappiamo oggi che,
anche con quegli investimenti, l'Austria-Ungheria cercava di legare a sé,
sempre più stabilmente, la Bosnia e l'Erzegovina prima di annetterle,
volendo contrastare ogni ipotesi di panslavismo balcanico o di “Grande
Serbia”.
29
Ibid., p. 153.
110
Geografia, economia e politica dell'Adriatico orientale
I traffici italiani con i porti dalmati
Nel 1906 – ammetteva lapidario Maranelli – l’Italia ha avuto con la
30
Dalmazia un «ben meschino commercio»: ha importato dalla Dalmazia
per poco più di 2 milioni di lire, pari a 2,2 milioni di quintali di merci e 827
capi di bestiame. Ha esportato in Dalmazia soltanto per 1,7 milioni di lire
per circa 360.000 quintali di beni. Il maggior acquisto fatto dall’Italia è
quello del legname bosniaco: oltre 1,5 milioni di quintali. Ma importa (a
Venezia e Chioggia, Ravenna, Rimini e Pesaro, Ortona e Molfetta) anche
lignite e carbon fossile (circa q. 602.000) dei monti Promina. La sansa (q.
16.125) e le pietre da cemento (q. 12.600) vengono acquistate dal
Meridione, soprattutto da Bari. Molto minori risultano gli altri generi
importati: dal pesce secco al maraschino. Pochi anche i cavalli (792 nel
1906), le pelli e la lana. Ma i conciatori italiani, preminentemente
piemontesi e napoletani, li acquistano a Trieste. Le esportazioni italiane, a
causa del nuovo trattato di commercio, si erano ulteriormente ridotte,
passando dagli oltre 3 milioni del 1901 a 1,8 milioni del 1906. Erano
costituite prevalentemente da materiali da costruzione (mattoni, tegole
pozzolane ecc.) richiesti dall’industria alberghiero-turistica e per le opere
pubbliche austriache. Nel 1906, Marche e Veneto hanno esportato 257.000
quintali di tali materiali. Ma, in valore, «certamente il primo posto è
occupato dai prodotti vegetali (ortaggi e frutta fresche, frutta secche, aranci,
ecc.), per la maggior parte spediti dai porti meridionali italiani [...] a Zara,
31
Spalato Ragusa, ecc., per circa 27.000 quintali». Seguono poi gli zolfi (q.
24.500); la crusca (q. 23.000); le vinacce (q.11.000) e infine il fieno e la
paglia (q. 5.700). Secondo Maranelli, il futuro, per i laterizi italiani, si
annunciava preoccupante qualora fosse terminata la fase delle costruzioni
pubbliche e private, mentre le maggiori speranze venivano riposte nei
prodotti agricoli, e tra questi il “vino di lusso” che avrebbe potuto sostituire
il bianco da taglio.
La penetrazione economica italiana nei Balcani
L’Italia cominciava a muoversi nel vicino e vicinissimo Oriente con una sua
più articolata, sebbene non facile e talvolta contraddittoria, attività
diplomatica, accompagnata da un complesso di iniziative economiche e
30
31
Ibid., p. 154.
Ibid., p. 155.
111
Francesco Martelloni
finanziarie. Naturalmente lo faceva come poteva farlo la “più piccola delle
grandi potenze”, e impegnando nel suo “imperialismo minore” le sue non
ridondanti risorse.
«Una serie successiva di imprese italiane, o con prevalenza di capitali
italiani – osservava appunto Maranelli –, hanno fatto sviluppare gl’interessi
nazionali in tutta la Balcania, dal Montenegro all’Albania, alla Macedonia,
alla Serbia e alla Bulgaria, a Costantinopoli ed anche nell’Asia turca,
assorbendovi un complesso di capitali di circa 30 milioni. Questi anche
sommati con gli altri capitali italiani impegnati da epoca più antica nella
Turchia, specialmente a Costantinopoli e a Salonicco, son sempre una ben
piccola cifra di fronte ai 522 milioni di lire impegnate dai tedeschi nelle
ferrovie e nelle banche e in imprese industriali e ai 766 milioni francesi
impegnati in eguali imprese e nei beni immobili; ma sono l’indizio del
32
nostro risveglio, la caparra del nostro progresso avvenire». Vediamo,
dunque, come il geografo riassumeva le principali attività italiane fuori dal
Montenegro, delle quali era principale protagonista l'imprenditorefinanziere semi-diplomatico Giuseppe Volpi di Misurata. 33 «In Macedonia la
Società delle miniere d’Oriente, composta tutta da capitalisti veneziani, ha
studiato ben 80 giacimenti minerari, e i suoi ingegneri conoscono perciò il
paese palmo a palmo. In Serbia fin da 10 anni indietro, il comm. Volpi,
anima di tutte queste imprese apriva a Nisch la prima casa d’esportazione
italiana che ancora funziona. A Vranja fu aperto uno stabilimento per la
trattazione del minerale di zinco e di piombo fornito dalla miniera di
Mossul, presso Blagodat in Bulgaria, cui fu congiunta da una strada
eseguita dalla stessa impresa, di nome bulgara, ma di capitali italiani.
32
Ibid., pp. 157-158.
Cfr. S. ROMANO, Giuseppe Volpi. Industria e finanza tra Giolitti e Mussolini, Milano,
Bompiani, 1979. Sulle iniziative estere di Volpi e del veneto conte Foscari (in Italia aveva
operato attraverso la SADE, una compagnia per l’elettrificazione, in società con Breda e
Orlando), che si avviarono in Montenegro nel 1903, col redditizio monopolio, per Volpi e per
la casa regnante locale, della produzione e della distribuzione del tabacco, scrive diffusamente
anche il Webster. Su Volpi e i suoi soci così sintetizza: «Di fatto nel Levante operavano tre
principali gruppi con interessi politici e capitalistici. Gli ‘amici’ veneziani della Banca
Commerciale erano di gran lunga il nucleo più importante, giacché la loro attività
comprendeva ogni genere d’impresa e si manifestava ovunque essa avesse la possibilità di una
minima entratura. Il gruppo “Ansaldo” agiva solo a Costantinopoli e faceva molto affidamento
sulla propria influenza nei circoli diplomatici e governativi». R.A. WEBSTER, L'imperialismo
industriale italiano, 1908-1915. Studio sul prefascismo, Torino, Einaudi, 1974, p. 376. Volpi
sarà destinato a svolgere un crescente ruolo finanziario e anche politico-diplomatico
soprattutto dalla pace italo-turca di Losanna del 1912, e poi sotto il regime mussoliniano col
breve governatorato di Tripolitania. Su Volpi in Montenegro vedi infra.
33
112
Geografia, economia e politica dell'Adriatico orientale
Italiane anche, ma genovesi, sono le iniziative di Varna e di Rustciuk. Di
recente poi è sorta, anch’essa per iniziativa del Volpi, la “Società
commerciale d’Oriente”, che è forse la più importante di tutte, come quella
che non solo ha assorbito la “Società delle miniere d’Oriente” e dirige, o
controlla le altre; ma si propone di esercitare il servizio di banca nella
capitale dell’impero turco, con agenzie nei principali centri dove più attivi
34
sono divenuti i traffici italiani».
Il Montenegro
Il piccolo Stato montenegrino, patria della regina Elena, moglie di Vittorio
Emanuele III, costituiva per l’Italia un’eccezione interessante rispetto al
restante panorama balcanico. Qui si era infatti concentrata l’attività di
penetrazione economica e d’influenza politica del regno sabaudo, nonché la
stessa riflessione logistico-strategica della Regia Marina, che, da sempre
alla ricerca di una sua buona base sulla costa adriatica orientale, ipotizzava
la costituzione di un suo futuro punto d'appoggio nel porto di Antivari. Ma
per il momento si trattava solo dell'intervento di un consorzio industrialefinanziario d'imprese private (la “Compagnia di Antivari”), perché le
clausole degli accordi di Berlino (art. 29) 35 vietavano l'accesso nei porti
montenegrini ad ogni nave da guerra europea, affidando a piccoli scafi
austriaci il solo controllo di quelle coste. Questi vincoli, però, verranno
meno in seguito all'annessione della Bosnia-Erzegovina, consentendo una
più ampia effettiva discrezionalità al Montenegro e ai suoi interlocutori.
Maranelli, per parte sua, alieno da ogni espansionismo imperialistico e
militare, così prospettava i rapporti italo-montenegrini: «Nella muraglia
difficilmente attaccabile da ogni nostra iniziativa economica sull’altra
sponda dell’Adriatico, costituita a nord [dai] possessi diretti e indiretti
dell’Austria, e a sud dall’inerte dominio turco, unica soluzione di continuità
presenta il piccolo Montenegro (kmq 9.080 e 250.000 abitanti). Grande
poco meno della Basilicata, montuoso come questa ne ha una popolazione
pari quasi alla metà. [...] Presenta un particolare interesse per l’Italia,
appunto come remora all’invadente Drang nach Osten dei teutoni, e come
paese simpatizzante con noi per somiglianza di tradizioni e per recenti
legami dinastici. Attrasse perciò più d’ogni altro paese balcanico
l’attenzione degli studiosi italiani in questi ultimi tempi, e divenne il campo
34
35
MARANELLI, Sui rapporti economici con l’altra sponda dell’Adriatico, cit., p. 157.
Cit. in MANTEGAZZA, Storia della guerra mondiale, cit., pp. 39-40.
113
Francesco Martelloni
36
dove più si svolse la nostra azione economica». Per ovvie ragioni si taceva
lì dell'azione politico-diplomatica. Dal confronto fatto da Maranelli tra i dati
1901 e 1905 dell’import-export italo-montenegrino, risultava come l’Italia,
nel 1901, avesse importato dal Montenegro per un totale di L. 116.000,
balzato a L. 941.000 nel 1905, dopo un triennio di lievi incrementi, in virtù
di una modifica della legislazione italiana per l’importazione della carne.
Nel 1905, i cavalli costituivano l’importazione maggiore (L. 643.000),
seguiti dalle vacche (L. 165.000), dalle lane lavate (L. 21.000), dagli ovini
(L. 19.000), dal pesce in salamoia (L. 17.000), da legna e canne di vimini
(L. 16.000), da caprini e bovi (rispettivamente L.14.000 e L. 11.000); altri
animali per minori importi. Le esportazioni italiane, però, erano di gran
lunga inferiori rispetto alle importazioni sebbene fossero cresciute da un
totale di L. 11.000 del 1901 a L. 24.000 nel 1902, e a L. 54.000 nel 1903.
Un relativo boom si era verificato nel 1904, raggiungendo L. 238.000,
quando si erano iniziati i lavori per gli impianti della Compagnia di
Antivari, creata da Volpi. Ma erano presto diminuite a L. 149.000 nel 1905.
La voce “metalli e macchine ecc.” – spiega il geografo – è balzata, appunto,
da L. 3.000 del 1901 a L. 33.000 del 1905, costituendo qui la maggior voce
dell’export. Seguono con L. 32.000 i tessuti di seta e con L. 23.000 i vini e
gli spiriti. La carta e i libri, con L.19.000, superano la voce “riso, farine e
paste” (L. 14.000) e quella “lavori di legno, vetture, ecc.” (L. 13.000). La
voce “cera” e quella “confetti, conserve e dolci” raggiungono entrambe L.
3.000, mentre a L. 2.000 si fermano “ombrelli e mercerie” e “sapone
comune”.
A fronte di tali dati sul commercio italo-montenegrino, l’intero import
del Montenegro, nel 1905, aveva raggiunto i 4,6 milioni di lire, mentre il
suo export complessivo aveva appena superato 1,7 milioni di lire.
L’Austria, dunque, continuava ad essere il suo partner commerciale
principale, anche se ormai si delineava una maggiore presenza economica e
commerciale italiana in Montenegro.
In Montenegro, inoltre, l’Italia, con le stazioni radio-telegrafiche BariAntivari aveva da poco emancipato quel paese dal vincolo austriaco del
cavo telegrafico Trieste-Cattaro. Ma ben più importante appariva l’attività
del sindacato veneziano per liberare i commerci italiani dai pedaggi
doganali che le nostre merci dovevano pagare alla dogana austriaca del
porto di Cattaro, da dove raggiungevano il Montenegro. Una naturale via
alternativa di penetrazione – osserva Maranelli – è costituita dalla Bojana,
36
MARANELLI, Sui rapporti economici con l’altra sponda dell’Adriatico, cit., p. 156.
114
Geografia, economia e politica dell'Adriatico orientale
fiume che ad una delle sue foci vede il porticciolo di San Giovanni di
Medua. La Bojana era aperta alla libera navigazione internazionale per il
primo tratto, fino a Oboti; mentre da lì e fin dentro il lago di Scutari solo
alla navigazione turca e montenegrina. Ma il porto e il fiume avevano
cattive condizioni idrografiche e presentavano forti difficoltà d'attracco;
inoltre, mancavano le strade sufficienti ai collegamenti con le cittadine
dell’interno. Ma proprio questa situazione geografica – secondo Maranelli –
aveva finito col facilitare l’iniziativa di Volpi: «Il governo del Montenegro
[...] preferì attuare il progetto della costruzione d’un porto ad Antivari,
ricongiunto con una ferrovia al lago di Scutari, a Vir Bazar. Ed ecco sorgere
la Compagnia del porto di Antivari, interamente con capitali italiani, con
personale tecnico italiano, che domanda e ottiene la costruzione del porto di
Antivari e della ferrovia Antivari-Vir e la concessione della navigazione sul
lago di Scutari. Il porto d’Antivari che è già in costruzione sorge in
posizione felice nella rada omonima, esposto solamente a greco-maestro,
per ripararlo dal quale si costruisce una diga, mentre un’altra chiuderà lo
specchio d’acqua. [...] Costruita la banchina, nell’immediato entroterra
sorgerà la nuova Antivari (la vecchia dista circa 5 chilometri) la cui vita
dipenderà non solo dal traffico del porto, ma anche dalle industrie che pensa
d’impiantare nella zona franca vastissima che il governo le ha concesso per
37
90 anni».
La Compagnia stava costruendo vari approdi su tutti gli scali principali
del lago e poi avrebbe costruito anche dei magazzini per lo stoccaggio delle
merci. Intanto, con un servizio di carri, già cominciava a collegare il lago
con l’interno. Quattro vaporetti della compagnia, ma battenti bandiera
montenegrina, garantivano l’attraversamento del lago, mentre un battello
più piccolo, nella buona stagione, discendeva la Bojana fino a San Giovanni
di Medua. Quest’ultima concessione aveva durata sessantennale. La stessa
Compagnia aveva iniziato la costruzione della ferrovia Antivari-Bar, lunga
36 chilometri, con un tunnel di m. 1.600. Però – come precisava il
professore – questa ferrovia, necessaria a collegare il Montenegro
all’Albania settentrionale non poteva certo costituire un’alternativa alla
fondamentale ferrovia longitudinale austriaca, allora in via di realizzazione:
la Saraievo-Mitrovitza-Salonicco. D'altra parte, era ormai esplicito lo
scontro politico per le ferrovie balcaniche tra Austria e Germania, da una
parte, e Francia, Italia, Russia e Serbia, dall'altra.
Per le sue iniziali politiche di modernizzazione del paese, il governo
37
Ibid., pp. 158-159.
115
Francesco Martelloni
montenegrino aveva fatto ricorso ad un prestito italiano, cosicché la società
veneziana aveva ottenuto come garanzia l’affidamento del monopolio del
tabacco, costituendo la “Regia cointeressata dei tabacchi” del Montenegro.
In tal modo, il Montenegro – sosteneva Maranelli – emancipandosi dai
vessatori incettatori turchi e albanesi, non solo garantiva nuovi proventi
all’erario, ma migliorava la qualità del tabacco coltivato, rialzando le sorti
della sua agricoltura. Non si poteva, però, negare che tale monopolio stesse
comportando l’ostilità di ampi settori della popolazione non più autorizzata
a coltivare o acquistare il tabacco liberamente: «Ma – aggiungeva Maranelli
– è innegabile che la Regia ha prodotto due grandi vantaggi. Ha fatto
sorgere a Podgoritza uno stabilimento industriale che occupa circa 340
operai montenegrini (300 donne e 40 uomini) [...]. Ha rialzato le sorti di ben
7.000 famiglie d’agricoltori, che attendono alla coltura del tabacco, le quali
dalla Società del monopolio hanno non solo appreso, per mezzo dei campi
sperimentali tenuti da coloni leccesi, il modo di coltivare razionalmente il
tabacco, ma hanno anche ottenuto uno smercio sicuro, costante e a un
38
prezzo equo, del loro prodotto». E infatti era presto migliorata la qualità
del prodotto, determinando in soli quattro anni una triplicazione del valore
dei terreni destinati alla sua coltivazione.
Non risultava, però, alcun progresso nella maggiore attività del paese:
l’allevamento del bestiame, a cui venivano destinati pascoli per 456 kmq –
mentre i terreni coltivati occupavano solo 326 kmq. Eppure, secondo
Maranelli, un più moderno metodo di allevamento, dati gli ottimi pascoli,
avrebbe potuto molto migliorarne la resa economica.
Analogo discorso valeva per lo sfruttamento delle grandi ricchezze
forestali così tanto carenti in Europa: «Sono due campi questi, il bestiame e
il legname, che potranno essere aperti all’iniziativa italiana, non appena lo
39
stato delle comunicazioni lo permetterà». Intanto, opportuni accordi
doganali avrebbero potuto da subito migliorare l’interscambio italomontenegrino: «[I] prodotti che devono costituire le basi dell’accordo
commerciale fra i due paesi non possono essere per ora che il bestiame e i
prodotti derivati per l’esportazione, il vino e i prodotti industriali,
40
specialmente i tessuti». Una diversa politica daziaria poteva incrementare
sensibilmente l'interscambio, tanto più che le regioni meridionali italiane
38
Ibid., p. 160.
Ibid., p. 162.
40
Ibid., p. 163.
39
116
Geografia, economia e politica dell'Adriatico orientale
erano povere di bestiame, mentre apparivano molto ridotti i costi del
trasporto marittimo.
L’Albania
La relazione di Maranelli considerava più analiticamente i rapporti italo41
albanesi. Dei quattro vilayet albanesi, i due propriamente tributari
dell’Adriatico erano quelli di Scutari e Jànina – questo diventerà greco dopo
la seconda guerra balcanica – mentre quelli interni (Cossovo e Monastir)
gravitano lungo l’asse ferroviario “austro-turco” Monastir-Salonico. I dati
sui commerci di Scutari, ritenuti abbastanza attendibili, si fermavano al
1902, mentre per Jànina, grazie alle informative dell’Agenzia commerciale
italiana del posto, giungevano fino al 1905. Tra 1902 e 1905, il commercio
di Jànina era cresciuto del 27%, passando da 11,3 milioni di lire a 14,2
milioni. Scutari, con un incremento analogo, saliva da 9 milioni del 1902 a
11,5 del 1905. Si poteva, dunque, stimare in circa 25,5 milioni l’intero
commercio dell’Albania adriatica. Una parte delle esportazioni skipetare (L.
2,5 milioni nel 1902) era costituita da pelli secche e salate (L. 550.000),
lane (L. 400.000), carbone e legna da ardere (L. 325.000), uova (L.
235.000), olio e granone (entrambi L. 125.000). Un’altra parte riguardava il
bestiame (L. 67.000), l’avena (L. 49.000), il pollame (L. 45.000), il tabacco
(L. 20.000). Seguivano altri generi minori, fino alle tartarughe e alle corna
d’animali, per importi di poche migliaia di lire.
Questa esportazione era destinata per il 50% all’Austria, per il 25%
all’Italia, seguite poi da Turchia, Grecia, Malta, ecc. Le pelli, come al solito,
venivano acquistate dall’Italia a Trieste, dopo che misure sanitarie ne
avevano impedito l’importazione diretta.
Indicativi risultano alcuni dati sul movimento del porto di Durazzo nel
1904. Lì, 187 vapori e 3 velieri austro-ungarici stazzavano
complessivamente t. 173.591, mentre i 104 vapori e i 34 velieri italiani
superavano di poco t. 68.500. Due vapori e 218 velieri turchi sfioravano
appena t. 20.000, mentre i 17 vapori greci e i 40 velieri non raggiungevano
le 10.000 tonnellate. Un solo vapore batteva bandiera montenegrina, ma
questa sventolava anche su ben 95 piccoli velieri, raggiungendo un totale di
41
Più in generale, per i rapporti politici e poi anche militari, si veda: A. BIAGINI, Storia
dell'Albania contemporanea, Milano, Bompiani, 2005 [1998] e ID., Momenti di storia
balcanica (1878-1914). Aspetti militari, Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore
dell’Esercito, 1981.
117
Francesco Martelloni
t. 5.000. Soltanto 3 vapori britannici, per t. 770, avevano attraccato allora in
quel porto: «Nel vilayet di Jànina la situazione è poco diversa per rispetto
alle esportazioni [di Scutari]. Queste sono ascese nel 1905 a L. 7.106.250; il
primo posto è occupato dall’Austria con 2.297.100, il secondo da noi con
2.199.150, il terzo dalla Grecia con 1.232.000». 42 Dell’intero importo, quasi
6,2 milioni erano composti dai seguenti articoli: formaggio (1,8 milioni),
pelli secche (L. 890.000), bitume (L. 790.000), lana (L. 560.000), sanse (L.
550.000), burro (L. 455.000), bestiame (L. 450.000), olio (L. 377.000),
olive salate (L. 195.000). L’Italia assorbiva quasi interamente l’esportazione
albanese di formaggi e oltre la metà di quella del bestiame, dei volatili, delle
uova e dei giunchi. Comunque, negli ultimi quattro anni l’import italiano
aveva quasi raggiunto quello austriaco che, ancora nel 1902, era invece
quasi il triplo dell’italiano.
Le importazioni albanesi nei due vilayet ammontano, nel 1905, a circa 13
milioni di lire. A Jànina superano appena i 7,1 milioni e sono costituite, in
valore, principalmente da farine (1,4 milioni), cotonami (1,6 milioni),
zucchero (L. 560.300), pelli naturali (L. 398.000), caffè (L. 286.100), filati
di cotone e sete (tra le 142.000 e le 150.000 lire). Però questi dati non erano
univoci, come riconosceva lo stesso Maranelli. Invece, risultavano sicuri
quelli relativi alle esportazioni italiane. Il Regno esportava a Jànina
cotonami (L. 690.000), superando l’Inghilterra che esportava per L.
385.000, seguita a grande distanza da Belgio, Grecia e Austria. A Scutari e
Durazzo i cotonami italiani arrivavano da Trieste e, dunque, nelle statistiche
non venivano direttamente attribuiti all’Italia. Le farine nazionali
risultavano al terzo posto dopo le turche e le francesi. Battevano, però,
decisamente quelle austriache (L. 212.500). Ciò si ripeteva anche a Durazzo
(346.800 piastre contro 108.700) e ancor più a Scutari, dove l’Italia
esportava il quadruplo delle farine austriache. Invece – affermava Maranelli
– per lo zucchero l’Italia non aveva potuto iniziare alcuna concorrenza e
l’Austria dominava sovrana sui mercati dei due vilayet, mentre
nell'esportazione del caffè era appena incominciata una debole concorrenza
dei commercianti genovesi (a Jànina per L. 49.875). Nell'export delle pelli
naturali, l’Italia aveva conquistato il primato nel vilayet meridionale (L.
224.500), seguita a grande distanza dalla Francia, dall’Austria e dalla
Grecia: «[...] Nel vilayet di Scutari, invece, nel 1901 importava [l'Italia
esportava] circa l’8% delle pelli conciate che vi entravano (circa 115 mila
lire), mentre a Jànina introduce circa 2/5 dello stesso articolo (imp.
42
MARANELLI, Sui rapporti economici con l’altra sponda dell’Adriatico, cit., p. 167.
118
Geografia, economia e politica dell'Adriatico orientale
43
[esportazione] italiana 19.500, totale 49.300)». Per le stoffe di lana, l’Italia
aveva da poco ottenuto il primato (L. 115.000) a Jànina, seguita
dall’Inghilterra. Circa Scutari, Maranelli poteva dire soltanto che un
fornitore albanese di abbigliamento militare acquistava in Italia. Per le sete,
l’Italia dominava a Jànina (L. 125.000). Nel vilayet del Nord, nel 1901,
ufficialmente non risultavano importazioni dall’Italia, perché transitavano
da Trieste. I “filati di seta per ricamo” provenivano già allora dall’Italia, per
L. 18.000.
Maranelli accennava anche a una società commerciale barese, che
operava nel nuovo settore petrolifero: «Il petrolio, che fino a poco fa
perveniva a Jànina o dalle raffinerie austriache, o dalla Russia pel tramite
dei porti turchi, ha incominciato anche a pervenirvi, pel tramite d’una casa
barese, dai depositi italiani della Società Italo-americana nel 1905, e sembra
che nel 1906 questa si sia accaparrata la maggior parte del consumo. La
44
stessa casa ha iniziato anche un discreto lavoro a Scutari».
L’Austria dominava a Jànina nell’esportazione degli spiriti, del rhum e
della birra, come nei fazzoletti colorati. Anche il vino italiano incontrava
serie difficoltà: «I nostri vini mal resistono alla concorrenza greca
nell’Albania meridionale e a quella turca nella settentrionale; ma il consumo
45
di vino è limitato». A Jànina, però, l’Italia aveva l’esclusiva nello zolfo
(L. 17.380) e nei pallini di piombo (circa L. 6.000). Manteneva il primo
posto anche nei cordami (L. 33.750), nelle flanelle di lana ( L. 12.500), nei
tappeti e canevacci (L. 21.850), per i fiammiferi (L. 26.000), le terraglie (L.
15.500), i tessuti di lino (L. 8.500), la carta da imballaggi (L. 10.350).
Vendeva anche medicine, droghe e colori (L. 37.500), riso (L. 11.900), fez
(L. 8.750), carta bianca (L. 3.400), vetrami (L. 5.250), sapone (L. 800).
Invece – lamentava Maranelli – non contava nulla nell’esportazione di
chiodi, ferro, macchine da cucire, pellicce, rame, tabacco in foglia, gioielli,
carta da sigarette. Poche erano, invece, le informazioni su Scutari: qui, gli
italiani esportavano nel 1901 agrumi, candele di cera, carta, cordami, cotoni
filati, fiammiferi, frutti secchi, liquori, paste, seta greggia, terraglie. A
Durazzo, nel 1902, si esportavano dall’Italia, per valori superiori alle lire
1.000, calce viva, fichi secchi, terraglie, vestiti. Ma il geografo si diceva
certo che nelle due cittadine del nord-ovest fossero poi aumentate
considerevolmente le nostre esportazioni. Nel commercio delle farine,
43
Ibid., p. 170.
Ibid., pp. 170-171.
45
Ibid., p. 171.
44
119
Francesco Martelloni
l’Italia aveva certamente vinto la concorrenza austriaca. Per il vilayet di
Jànina, i dati degli anni 1900-1906 chiarivano bene il ribaltamento
realizzatosi a favore dell’Italia. All’inizio del secolo, infatti, le esportazioni
austriache raggiungevano l’importo di L. 2.035.475, mentre quelle italiane
si fermavano a 438.000. Nel 1904, si era raggiunta la parità tra le due
nazioni intorno a 1,7 milioni per ciascuna. Nel 1905, l’Italia superava i 2
milioni, mentre l’Austria arretrava a 1,6 milioni, su un totale delle
importazioni di Jànina pari 7,1 milioni: insieme le due potenze fornivano
oltre il 50% delle importazioni del vilayet.
In ogni caso, considerando il commercio totale di queste due regioni
albanesi (circa 25,5 milioni di lire) in rapporto a 1,1 milioni di abitanti, la
media pro-capite appariva molto bassa: era pari a L. 23. Il dato era pertanto
indicativo delle arretrate condizioni economiche dell’Albania, e confermava
quanto altri analisti italiani considerati da Maranelli (Baldacci, Meneghelli,
Macchioro e Barbarich) avevano già bene illustrato.
Maranelli lì sottolineava soltanto i nessi intercorrenti tra gli esigui
commerci, la mancanza di industrie, la scarsa produzione agricola e
forestale, la scadente produzione di bestiame. Tutto ciò gli sembrava
discendere non dalla mancanza di risorse naturali, ma a causa di «uno stadio
46
di civiltà molto arretrato». In effetti, sosteneva, «l’unica povertà naturale
dell’Albania è forse quella mineraria se si eccettuino le miniere di bitume di
Selenitza nel distretto di Valona, le quali disgraziatamente sono sfuggite
alla iniziativa italiana, cui erano state offerte, per cadere in mani francesi». 47
Il manto forestale, invece, era estesissimo. Lungo l’intera costa a sud del
Drin e nello stesso Epiro (tra Valona e Kimara), a querce, olmi e frassini si
accompagnavano legni pregiati. Nelle zone montuose interne dell’Albania
settentrionale, ai faggi si aggiungevano, a maggiori altitudini, gli abeti.
Nelle foreste meridionali predominavano le conifere. Lo scarso
sfruttamento economico forestale riguardava soltanto le zone marittime. La
ditta genovese “Firpo e Barberis” – esemplificava il professore – ha iniziato
solo dal 1904 lo sfruttamento dei boschi durazzeschi. Ma si diceva
speranzoso che ciò sarebbe risultato di stimolo per altri italiani. Gravissimo,
però, gli appariva il problema delle comunicazioni stradali con l’interno, in
particolare quali vie occorresse utilizzare tra i numerosi fiumi (dal Drin al
Semeni), dopo le opportune opere di canalizzazione. Nelle campagne, le
fertilissime terre venivano allora destinate prevalentemente a pascolo
46
47
Ibid., p. 173.
Ibid.
120
Geografia, economia e politica dell'Adriatico orientale
naturale. Le coltivazioni principali, quelle del mais, dell’orzo, dell’avena e
del grano, davano adito soltanto a una saltuaria esportazione nei periodi di
raccolti particolarmente sovrabbondanti; invece, nei bassopiani alluvionali
interni, come in quelli acquitrinosi e lungo i corsi dei fiumi, tramite
drenaggi e irrigazioni si sarebbe potuto procedere, con successo, alla
coltivazione del riso, delle barbabietole da zucchero (come auspicava
ripetutamente il console italiano a Jànina, Millelire) e dello stesso cotone
che – lo ricordava Maranelli – veniva allora coltivato tra grandi difficoltà
nell’arida Puglia. Bisognava, poi, notevolmente modernizzare la
coltivazione dell’ulivo, ben presente nelle zone costiere – già veneziane – di
Durazzo, di Valona e di Scutari. E in questo senso, Maranelli riteneva che la
consolidata esperienza pugliese avrebbe dovuto spingere gli imprenditori
meridionali ad assicurasi una parte delle produzioni olearie albanesi. Oggi –
argomentava – «la sansa [albanese] per lo più invece prende la via della
Grecia; l’olio scadentissimo di produzione locale si dirige a Trieste per uso
industriale; e due soli industriali, il pugliese Mastrolonardo e la ditta A.
48
Berio e C. di Lucca hanno impiantato presso Valona due frantoi moderni».
Ma i più alti dazi imposti dai nuovi trattati commerciali minacciano di
vanificare quel lavoro o di renderlo inutile per l’Italia. Le colture della vite
e del gelso trovavano forti limiti nell’ignoranza agronomica di quelle
popolazioni. Invece, una sviluppata sericoltura poteva risultare di grande
interesse per gli agricoltori e i filandieri italiani.
Il giudizio complessivo sulla situazione economico-sociale skipetara,
dunque, non poteva che essere negativo, eppure Maranelli intravedeva
qualche discreta possibilità di sviluppo: «Lo stato di depressione in cui si
trova l’agricoltura albanese ha profonde cause sociali, che non
scompariranno facilmente: difetto di braccia e di capitali, gravosi sistemi di
locazione e di esazione delle imposte e soprattutto, cause di tutte le miserie
albanesi, mancanza di strade. Ma che lo straniero possa utilmente tentar
qualche iniziativa agricola in Albania, almeno in alcune parti litoranee, e
sopra tutto nel vilayet di Jànina più aperto alla civiltà occidentale, lo
dimostra il fatto che è già ben riuscito qualche tentativo come, per esempio,
quello ricordato dei frantoi a Valona, quello di alcuni coloni leccesi a
Valona stessa, e quello di colonizzazione nello stesso distretto intrapreso da
un signore ungherese, che vi trasportò macchine e uomini dal suo paese,
traendone buoni frutti. Il tentativo, però, fu troncato dalla morte del
48
Ibid., p. 175.
121
Francesco Martelloni
49
concessionario».
Primitivo appariva anche l’allevamento del bestiame, che pure costituiva
la principale ricchezza del paese. La transumanza – spiegava Maranelli –
richiede grandi spazi per i capi e li sottopone a lunghi e faticosi viaggi.
Inoltre, i foraggi sono spesso scarsi e non si provvede con i mangimi.
Cosicché le carni animali, le lane ed il latte non sono di buona qualità. Di
conseguenza, l’industria casearia risultava scarsa e concentrata al Sud. E
produceva formaggi scadenti (il mannur, importato prevalentemente
dall’Italia). La pesca nei laghi appariva discreta, però anche l’industria ittica
avrebbe dovuto progredire molto nella conservazione del pesce, per la
bottarga e per il caviale. La pesca marittima non veniva praticata dagli
indigeni, ma da pescatori pugliesi e chioggiotti, nonostante l'Albania avesse
una costa di oltre 500 chilometri, compresa tra Prevesa, a sud, ed Antivari a
nord. Un suo incremento – sosteneva Maranelli – allenterebbe la crescente
tensione tra i pescatori italiani e i dalmati: «Le fiorenti città della costa
pugliese, spesso sprovviste di sufficienti quantità di pesce, presenterebbero
ottimi mercati di consumo, quand’anche non fosse possibile instradare il
prodotto di tali pesche verso maggiori mercati interni [...]. Tentativi ben
riusciti sono già stati fatti da pescatori chioggiotti in vicinanza di Medua e
50
da pescatori pugliesi, anche lungo tutta la restante costiera».
Anche la caccia, in Albania, poteva subire un incremento, magari
consentendola anche agli stranieri tramite una significativa riduzione delle
allora forti tasse. Si sarebbero esportate beccacce, beccaccini e anitre
selvatiche. La stessa avicoltura avrebbe potuto svilupparsi meglio. In tal
caso – diceva Maranelli – i piroscafi della compagnia “Puglia” dovevano
attrezzarsi con celle frigorifere per la conservazione della cacciagione e dei
pesci.
Nei due vilayet, tranne le concerie di Jànina, l’industria era praticamente
assente. Eppure, l’utilizzo della forza motrice dei vari corsi d’acqua avrebbe
potuto consentire una fioritura delle industrie del legno, delle pelli e delle
lane. I capitali albanesi, però, restavano scarsi, nonostante i miglioramenti
dovuti alle rimesse degli emigranti dalle Americhe. E questo, tra l'altro,
ridimensionava le aspettative di successo di una possibile attività bancaria
italiana: «Temiamo, perciò, che sia ormai tardi per l’impianto della tanto
49
50
Ibid.
Ibid., p. 176.
122
Geografia, economia e politica dell'Adriatico orientale
51
invocata banca italiana a Jànina».
Le comunicazioni fluviali interne apparivano peggiori: «L’unica via
navigabile interna attualmente è quella della Bojana sino al lago di Scutari,
aperta a tutte le bandiere fino ad Oboti, al di là solo alla montenegrina ed
della ottomana. La “Puglia, la “Ragusea”, la “Compagnia del porto
d’Antivari” hanno tutte e tre dei piccoli vaporini di circa 200 tonnellate, con
poco più d’un piede di pescante, che nominalmente fanno servizio da San
Giovanni di Medua a Scutari; ma non riescono a compiere l’intero tragitto
che una dozzina di volte all’anno per una barra alla foce, e per
l’interrimento alla confluenza della Drinassa nella Bojana». 52 Più a sud, la
Voiussa (l'antica Aoò), resa navigabile in epoca romana, aveva ormai perso
ogni traccia di quelle opere.
Anche il sistema stradale appariva pessimo. La rete che collegava il
Nord-Est albanese al Montenegro e la zona di Scutari alla Vecchia Serbia,
al Cossovo, era trascuratissima. Nella provincia di Durazzo una sola strada
carrozzabile, lunga 40 chilometri, collegava quella città a Tirana. Poi
c'erano soltanto sentieri e viottoli da percorrere a cavallo e, nella cattiva
stagione, spesso impraticabili: «Valona è in pessime comunicazioni con
l’interno, con Argyrocastron, Delvino e Jànina, e solo sembrano un po’
migliori le comunicazioni con Berat per la valle dello Scombi, sulle tracce
53
d’un ramo dell’antica Egnazia». A sud di capo Linguetta – continuava
Maranelli – la costa epirota è alta e rocciosa. Di tanto in tanto si aprono
porticcioli naturali tra alte pendici. Rare e strette valli trasversali mettono in
comunicazione col mare la valle longitudinale del Drynos e la conca di
Jànina. Di qualche importanza le vie per l’interno e Jànina, da Santi
Quaranta (valle del Kalamas) e dal golfo di Arta (valle del Vyros). Queste
consentono di attraversare la catena montuosa che divide l’entroterra dal
mare: «Ma la maggior parte della regione interna si dirige, invece, seguendo
il Dyros e la Voiuza, all’Albania centrale, a Valona. In Epiro solo una strada
può dirsi carrozzabile: quella che congiunge Prevesa a Jànina, che infatti
considera la prima il suo vero porto per quanto sia più vicina a Santi
54
Quaranta».
Di grande interesse, anche politico, appariva la riflessione di Maranelli
51
Ibid., p. 177.
Ibid., pp. 178-179.
53
Ibid., p. 179.
54
Ibid., p. 180.
52
123
Francesco Martelloni
sulle ferrovie. Questi notava, infatti, che venivano allora proposte, per
ragioni geopolitiche, tre grandi linee ferroviarie. Ma diffidava del buon esito
di tali progetti, a causa dei loro grandi costi. Una linea – spiegava – è detta
“serba”: dovrebbe raggiungere i 550 chilometri e congiungere Kladova, sul
Danubio, per Nisch e Pristina, Ipek e Podgoritza, evitando così il
sangiaccato di Novi-Bazar, occupato militarmente dagli austriaci dal 1878.
Costeggiando il lago di Scutari menerebbe ad Antivari e San Giovanni di
Medua. Una seconda ripercorrerebbe la via Egnazia da Durazzo a Valona,
per Elbasan e il lago di Ocrida, fino a Monastir (oggi la macedone Bitola),
raccordando l’Adriatico a Salonicco. Questa metterebbe in contatto
Bulgaria, Romania e Serbia con le coste adriatiche albanesi. Il terzo
progetto prevede una ferrovia che, lungo la Voiussa, giunga fino al confine
greco. A questo, però – continuava – si oppone un progetto turco, ripreso
dopo la guerra greco-turca del 1897, e finalizzato a congiungere Monastir a
Jànina e poi a Prevesa, sul mare, seguendo la valle del Vyros. A parte gli
alti costi di tali progetti, a Maranelli appariva fatale che l’hinterland
albanese dovesse subire l’attrazione della ferrovia di Mitrovitza e di
Monastir per Salonicco, a causa della grande attività di questo porto, giunto
allora a registrare un movimento commerciale di 8 milioni di tonnellate
l’anno. Tanto più che questo asse ferroviario costituiva, di fatto, la via di
congiunzione tra l’Egeo e l’Europa settentrionale centro-occidentale, mentre
riteneva assolutamente fantasiosa l’ipotesi di inoltrare la Valigia delle Indie
da Brindisi a Valona per ferry-boats e poi da lì, nuovamente per ferrovia,
fino a Salonicco. Idea, questa, che era nata in Italia per il timore che
Brindisi potesse presto perdere quella prestigiosa linea internazionale.
Maranelli argomentava al proposito che non solo sarebbe stato difficoltoso,
soprattutto in inverno, sbarcare merci, posta e passeggeri a Valona, ma che
la tradizionale via Londra-Brindisi sarebbe rimasta comunque più breve
(622 chilometri) rispetto alla Londra-Salonicco. Né la traversata marittima
Salonicco-Alessandria, sebbene di 15 ore più breve rispetto a quella da
Brindisi, avrebbe compensato le difficoltà nautiche dell’attraversamento
dell’Egeo e soprattutto quelle politiche, legate alla pericolosa situazione in
Epiro, Macedonia e Tessaglia. In definitiva – secondo il geografo – ai sogni
di penetrazione all’interno della Balcania, italiani e albanesi dovevano più
realisticamente preferire miglioramenti nelle comunicazioni marittime e
terrestri tra le due coste dell’Adriatico e tra le cittadine dei loro hinterland,
per agevolare effettivamente un possibile sviluppo economico.
Anche qui, però, l’Austria non rimaneva inattiva e già premeva per
ottenere la concessione della ferrovia tra San Giovanni di Medua e Scutari,
124
Geografia, economia e politica dell'Adriatico orientale
progettata sin dal 1873. E Maranelli pure su questo richiamava l’attenzione
dei suoi connazionali: «Gli italiani non dovrebbero mai dimenticare le
parole del grande industriale von Siemens: “Ciascuna banca o strada ferrata
stabilita in paese straniero e le cui azioni siano rimaste al nostro paese, è
nello stesso tempo un elemento del nostro sviluppo all’estero e l’origine di
relazioni durevoli con un nuovo centro economico”. I tedeschi, che han
sempre tenuta presente tale massima, oltre la ferrovia di Bagdad e le altre
ferrovie asiatiche, posseggono nella Turchia europea la linea SaloniccoMonastir (219 km.) concessa nel 1890 al von Kaula [...] ed hanno la
direzione finanziaria della Salonicco-Uskub-Mitrovitza, e della BellovaPhilippopoli-Adrianopoli-Costantinopoli».55 Per il versante adriatico, era
allora in discussione la linea Durazzo-Elbassan-Monastir, oggetto degli
studi di un consorzio di imprese internazionale tra la Deutsche Bank, la
“Società generale italiana del credito immobiliare” in unione con la ditta
Aliatini di Salonicco e Almagià di Ancona. La Turchia, invece, sembrava
preferire una linea alternativa: la Valona-Berat-Monastir-Coprülü, che
avrebbe incontrato la Mitrovitza-Salonicco. Ma nulla, al momento, era stato
concesso. L’Austria per parte sua era molto interessata alla prosecuzione
della ferrovia che da Salonicco e Mitrovitza doveva un giorno giungere sino
a Sarajevo. Tali disegni asburgici – riconosceva Maranelli – preoccupavano
l’opinione pubblica italiana che voleva contrapporre agli austriaci una linea
adriatico-danubiana, che, però, gli appariva assolutamente irrealistica.
Anche le comunicazioni fluviali andavano molto migliorate, ma
sarebbero occorsi ingenti investimenti. Secondo il professore, soltanto la
Bojana avrebbe potuto attrarre capitali privati per le opere idrauliche,
perché, con soli trenta chilometri di via d’acqua, il Lago di Scutari sarebbe
stato messo in comunicazione col mare. Gli altri lavori principali dovevano
riguardare l’inalveamento delle acque del Drin, che, biforcandosi, attraverso
la Drinassa (il “Grande Drin”) portava i detriti che poi sbarravano la Bojana
alla sua foce. Insomma, la situazione delle vie di comunicazione albanesi gli
appariva tanto decisiva, quanto di non facile e rapida soluzione: «Nel
complesso, dunque, in Albania tutto ciò che si riferisce alle comunicazioni,
porti, strade carrozzabili, navigazione interna, ferrovie è tutto ancora
56
completamente da farsi e in gran parte da studiarsi».
Le comunicazioni postali – già oggetto di contenziosi italo-turchi e di
55
56
Ibid., p. 182.
Ibid., p. 184.
125
Francesco Martelloni
concorrenzialità austro-italiane – si avvalevano degli uffici turchi, dalle città
costiere all’interno; di quelli austriaci di Scutari, S. Giovanni, Durazzo,
Valona e Prevesa; e ormai anche di quelli italiani di Jànina, Scutari e
Durazzo. Il telegrafo collegava quasi tutti gli uffici principali e si
congiungeva con i cavi sottomarini Valona-Otranto e Santi QuarantaTrieste. I servizi bancari, invece, erano quasi inesistenti: operava solo una
banca agricola ottomana con finalità, appunto, molto limitate. Di fatto il
credito era affidato a speculatori privati, soprattutto greci, molti dei quali
erano concentrati a Jànina. Il nord-albanese ne era praticamente privo e si
affidava alla rudimentale mediazione finanziaria del Montenegro. Per
Maranelli, però, l’Italia, in questo campo, poteva riporre le sue speranze
nella “Società commerciale d’Oriente” e nell’apertura di sue agenzie in
Albania.
Come già accennato, lo stato delle comunicazioni sembrava costituire il
principale ostacolo allo sviluppo economico albanese: «Le difficoltà
naturali cominciano già lungo la linea d’approdo, nelle coste. Nella regione
a nord del capo Linguetta [promontorio meridionale della baia di Valona],
queste sono poco favorevoli alla navigazione per i materiali di deposito
trasportati dai numerosi corsi d’acqua a carattere torrenziale e disposti [...] a
cordoni litoranei, rendendo incostanti i fondali». 57 Tuttavia, erano proprio i
fiumi a costituire le migliori vie di comunicazione interna: «A nord le valli
della Bojana, del Drin e del Matja segnano vie di facilitazione per il bacino
di Scutari, per il paese montuoso dell’estremo N-E, e per i monti dei Mirditi
58
e dei Ducagini». Al sud, i rilievi sono poco importanti e risultavano molto
facilitate le comunicazioni tra le valli dei fiumi Arzen, Scombi, Semeni, e le
valli superiori del Drin Nero e della Voiussa: «In questa zona, infatti, si
sviluppava l’unica rete di comunicazioni costruita dai romani in Albania,
che faceva capo a Durazzo e a Valona e con la via Egnazia, per la valle
dello Scombi, per il lago di Ocrida e per quello di Presba, metteva a
Monastir e lungo la valle del Vardar a Salonicco, congiungendo l’Adriatico
59
con l’Egeo».
Considerazione notevole, questa del professore, che ci spiega il valore
strategico della regione di Valona, anche quale base per la penetrazione
nell’interno albanese e verso l’Egeo, e non solo per la celebre baia, da cui si
controlla – si “domina”, diceva la Regia Marina nei suoi studi strategici – il
57
Ibid.
Ibid., p. 178.
59
Ibid.
58
126
Geografia, economia e politica dell'Adriatico orientale
Canale d’Otranto. Quanto al porto e alla baia di Valona, da tempo oggetto
delle attenzioni, dei desideri, delle più o meno velate pretese di italiani,
austriaci e greci, Maranelli affermava che i porti albanesi, tranne quello di
Valona – pure da bene attrezzare – non erano certo dei migliori: «Allo stato
attuale, San Giovanni di Medua, protetto a settentrione e a oriente da
colline, e quindi discreto ancoraggio, a causa dei bassifondi non può essere
raggiunto dai piroscafi, che debbono ancorarsi a più di un chilometro dalla
costa, e durante l’inverno debbono attendere per due o tre settimane il buon
tempo che permetta i trasbordi sui vaporini della Bojana; Durazzo ha
anch’essa un buon porto naturale, ma infestato da bassifondi; e Valona,
situata in una rada mirabile, capace di riparare in ogni tempo un’intera
flotta, per la mancanza di banchine, durante il cattivo tempo e quando spira
maestrale, vede i piroscafi attendere oziosi senza poter compiere operazioni
commerciali; solo da pochi anni la società delle miniere di Selemitza ne ha
preso in appalto il ponte di approdo, pagando un canone annuo al comune e
percependo le tasse portuali. È questa un’altra impresa che, con le miniere
di bitume, è sfuggita agli italiani». 60
Conclusioni
Maranelli, si è detto, era non solo uomo di scienza, ma anche “buon
italiano”, in senso risorgimentalista democratico e non nazionalista. Il suo
rimpianto, allora, riguardava le occasioni mancate di una maggiore crescita
economica e civile delle regioni italiane, soprattutto di quelle meridionali e
di quelle balcaniche. Entrambe, sia pur con profonde differenze e diversi
stadi di sviluppo economico e culturale, mostravano i segni dell'arretratezza
rispetto alle aree italiane ed europee più progredite. E tali istanze
“progressiste” rimarranno nel pensiero e negli scritti di Maranelli anche allo
scoppio del primo conflitto mondiale.
Invece – con Salandra e Sonnino al governo, e con la Regia Marina in
combattimento – quell'occasione mancata, relativa alla baia di Valona,
sarebbe stata presto, dopo sette anni, riacciuffata, però in un contesto
internazionale e nazionale, da ogni punto di vista, radicalmente cambiato e
infinitamente più drammatico. A Natale del 1914, a guerra iniziata, ma con
l'Italia ancora neutrale, simulando una missione sanitaria e umanitaria, di
60
Ibid.
127
Francesco Martelloni
pacificazione, la Regia Marina e poi l’Esercito italiano avrebbero occupato
stabilmente, fino al 1920, il porto, la baia e un ampio hinterland di
Valona. 61 Con la guerra mondiale, l'occupazione si sarebbe allargata ancora
all'interno.
Quella relazione di Maranelli del 1907 non doveva essere passata
inosservata negli ambienti militari di terra e di mare, proprio a causa degli
specifici studi di guerra in Adriatico e nei Balcani che si andavano facendo
ai vertici delle forze armate italiane – come d'altra parte in quelli austroungarici. E l'interesse dei militari per un moderno studio geografico,
geologico, idrografico, economico del territorio come presupposto
dell'azione di guerra era già stato chiarito – se ce ne fosse stato ancor
bisogno – in quello stesso congresso geografico, grazie alla comunicazione
del tenente colonnello, professore di geografia generale e militare alla
Scuola di guerra, cavalier Eugenio Caputo: «Com'è noto – aveva detto –
l'importanza delle conoscenze geografiche nella preparazione e nella
condotta delle operazioni militari terrestri e marittime è venuta aumentando
di pari passo con gli eserciti moderni e, ancor più, con le tendenze
colonizzatrici dei maggiori Stati, le quali hanno esteso a dismisura i
possibili teatri di guerra [...] Oggi, più che per il passato, può dirsi che i
rapporti fra l'arte bellica operativa e la geografia siano permanenti; tanto più
stretti ed importanti, quanto più vasti e complessi sono gli obiettivi militari.
[...] E ciò è specialmente vero per quanto concerne l'elemento terreno, che,
generalmente, più degli altri influisce sull'impiego della forza organizzata.
Non paia esagerato il dire che soltanto con l'aiuto di una carta geologica [...]
assumeranno carattere di certezza, o quasi, parecchie induzioni». 62 E
lamentava i limiti della ordinaria cartografia, che non poteva dare «notizie
più concrete così in paese ostile, o non prima visitato. Per limitarmi a poche
cose: la possibilità di scavare rapidamente trincee; di improvvisare più
estese fortificazioni di terra, oggidì tanto necessarie; di disporre di pietrame;
di trovare acque sorgive o facilmente estrarne dal sottosuolo, di giudicare
61
Cfr. M. BORGOGNI, Tra continuità e incertezza. Italia e Albania, 1914-1919. La strategia
politico-militare dell’Italia in Albania fino all’Operazione «Oltre Mare Tirana», Milano,
Franco Angeli, 2007, pp. 19-23; F. MARTELLONI, Giochi di prestigio: la “chiave
dell’Adriatico” nel 1914, in «Ricerche Storiche», XXXVII, 3, 2007, pp. 481-532. L’isolotto di
Saseno, a ovest della stessa insenatura, sarebbe rimasto all’Italia, senza interruzione, sino alla
fine della seconda guerra mondiale. Recentemente, in condizioni storico-politiche
assolutamente diverse, un accordo col nuovo Stato albanese post-comunista ha garantito lì una
presenza militare italiana, per il controllo del contrabbando e del traffico di clandestini.
62
CAPUTO, L'arte militare e l'odierno indirizzo degli studi geografici, cit., p. 183.
128
Geografia, economia e politica dell'Adriatico orientale
dell'entità della copertura del suolo, dello stato ordinario delle strade a
fondo naturale, ecc., sono notizie queste che, quasi sempre, invano si
chieggono ad una carta comune, specialmente su piccola scala. [...] Eppure
son tutti dati e fatti codesti che hanno grande influenza sull'apprezzamento
militare del paese, in quanto ne dipendano la maggior o minor facilità di
rafforzare celermente e con pochi mezzi le posizioni, di far muovere la
truppa a piedi e carreggi attraverso la campagna, di far sostare le colonne, di
accamparle, di fornirle d'acqua [...]». 63
Proprio questo complesso genere d'informazioni geografiche – accanto
ad altre particolarmente utili agli operatori commerciali – stava allora
fornendo la relazione del nostro Maranelli. Ma anche politici e diplomatici
– ed oggi gli storici – avevano da imparare qualcosa.
63
Ibid., p. 186.
129
Eunomia. Rivista semestrale del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Eunomia 1 n.s. (2012), n. 1, 131-152
e-ISSN 2280-8949
DOI 10.1285/i22808949a1n1p131
http://siba-ese.unisalento.it, © 2012 Università del Salento
Paolo Macrì
I quaccheri americani e le attività di soccorso
in Europa e nella Russia bolscevica, 1917-1921
Abstract: The article provides an analysis of some American humanitarian rescue activities
between the first world war and the period following the Russian civil war. The point of view is
that of the American Friends Service Committee (Afsc), an American Quaker association
which, starting from 1917, managed to set up a dialogue with Washington with the purpose to
find a solution to the question of conscientious objectors. The Afsc activities deal with the
assistance to the French population during the last phase of the conflict, to German children in
the immediate post-war period, and to Russian refugees during the troubled events of the war
and the Bolshevik Revolution. Particularly interesting is the relationship the Afsc established
with the American Relief Administration (Ara), an assistance quasi-governmental
organisation. Although American historiography has attended several times to ARA activities
and its protagonist, Herbert Hoover, there is lack of recent, impartial and exhaustive studies
on the Quaker contribute to the model of humanitarian rescue set up in those years.
Keywords: American
Administrations.
Quakers; Quakers' Assistance in Europe,
1917-1921;
U.S.
Il 1917 fu, per gli Stati Uniti, l’anno dell’ingresso nella guerra europea e,
per i suoi cittadini, rappresentò l’inizio della sperimentazione delle
conseguenze di un conflitto tecnologico moderno, combattuto da eserciti di
massa. Già nella seconda metà del XIX secolo, la guerra civile aveva
anticipato agli americani molti dei sacrifici necessari al raggiungimento
degli obiettivi strategici degli Stati maggiori e, fra tutti, quello più avversato
e ritenuto più iniquo era stato quello della coscrizione. In seguito, gli Stati
Uniti, per quanto coinvolti in campagne militari oltremare, non avrebbero
più fatto ricorso alla leva, che, invece, alle soglie dell’intervento nella
guerra mondiale, appariva inevitabile. Infatti, per quanto l’arruolamento di
volontari fosse preferibile alla coscrizione, sia per l’opinione pubblica che
per il governo, il corpo di spedizione statunitense doveva essere allestito
rapidamente e le politiche britanniche di reclutamento volontario avevano
incontrato limiti insuperabili. Le risorse necessarie alle operazioni militari
sul fronte occidentale avevano richiesto un impiego di risorse umane mai
conosciuto prima e, già durante il primo anno di guerra, il governo inglese
Paolo Macrì
aveva constatato, drammaticamente, che le vittime dei combattimenti erano
molto più numerose dei volontari, che pure accorrevano per combattere i
tedeschi. Per questo motivo, nel marzo 1916, la Gran Bretagna aveva
introdotto il reclutamento obbligatorio per tutti gli uomini celibi,
estendendolo, successivamente, anche ai padri famiglia. Negli Stati Uniti
questa prospettiva aggregò la protesta di molti attivisti; si trattava di politici
di sinistra, religiosi pacifisti, attiviste per i diritti civili femminili e studenti
universitari, che si articolarono in un vasto movimento che trovò spazio
sulla stampa e si rese protagonista di numerose iniziative antimilitariste. Tra
le molteplici realtà di questo movimento, che rifiutava, per differenti e
molteplici ragioni, l’intervento degli Stati Uniti in Europa e, soprattutto, la
prospettiva della coscrizione, assunsero una posizione particolare i
quaccheri, che avevano contribuito alla nascita di molte associazioni
pacifiste dell’epoca e che costituivano una delle minoranze religiose più
note e antiche degli Stati Uniti.
1. La nascita dell’American Friends Service Committee nel 1917 e gli
interventi umanitari in Europa durante il primo conflitto mondiale
Nel 1917, l’incombere della leva obbligatoria sui giovani quaccheri metteva
a rischio l’eredità di George Fox, il fondatore del quaccherismo. La libertà
di cui godevano i fedeli avrebbe potuto portare molti di loro ad accettare la
chiamata alle armi, sacrificando il principio più importante del
quaccherismo, quello del rifiuto della violenza. Questo problema determinò
l’impegno politico delle comunità più antiche e ricche degli Stati Uniti, in
particolare quelle della Pennsylvania e di Filadelfia, che ritennero di dover
scongiurare il coinvolgimento dei propri membri nel conflitto armato come
combattenti. I rappresentanti di queste comunità condussero una laboriosa
mediazione con il governo statunitense, al fine di evitare l’arruolamento dei
correligionari, che si dichiaravano obiettori di coscienza, predisponendo, in
collaborazione con la Croce Rossa statunitense, il loro impegno in attività di
soccorso umanitario in Europa, in sostituzione del servizio armato. Le
comunità quacchere, infatti, a differenza di altre realtà politiche e pacifiste
dell’epoca, non intendevano criticare le scelte del governo, né volevano
indurre i propri giovani a voltare le spalle al paese; più semplicemente,
intendevano permettere ai coscritti di rimanere fedeli ai propri valori,
servendo, sotto altra forma, gli Stati Uniti.
132
I quaccheri americani e le attività di soccorso
L’intervento di uno dei più eminenti quaccheri americani fu
provvidenziale. Rufus Matthew Jones, infatti, fu in grado di porgere ai
propri correligionari la chiave di volta per edificare una struttura, che
sarebbe servita a interloquire con il governo e con i giovani obiettori,
raccogliendoli in un’unica forza, capace di riaffermare con efficacia il
rifiuto della non violenza, senza tradire la patria. Questa struttura, inoltre,
sarebbe potuta diventare lo strumento che avrebbe garantito continuità
all’assistenza delle vittime della guerra europea. Nasceva così, il 30 aprile
1917, l’American Friends Service Committee (AFSC), che riconosceva
nell’aiuto del prossimo l’attività militante più importante del movimento. 1 Il
documento di fondazione dell’AFSC stabiliva che le attività da svolgere
sarebbero state incorporate a quelle già sviluppate dai correligionari inglesi
in Russia e in Francia e che, per quest’ultima, i quaccheri americani
avrebbero collaborato direttamente con la Croce Rossa statunitense:
[…] Le articolazioni delle attività svolte sono state: la
ricostruzione e i soccorsi alle regioni devastate dalla
guerra in Russia e in Francia. Il nostro lavoro è stato
portato avanti unitamente alle attività degli Amici
inglesi, che sono impegnati in questo lavoro da tre anni.
In Francia il nostro lavoro è stato organizzato come
quello di un dipartimento della Croce Rossa americana
[…]. 2
L’AFSC raccoglieva il testimone di due secoli di attività di soccorso
umanitario quacchero, che, soprattutto in Europa, aveva contraddistinto le
1
A partecipare alla fondazione dell’AFSC furono tutte le anime del quaccherismo americano:
il Philadelphia Early Meeting (i cosiddetti ortodossi), la Friends General Conference (organo
rappresentativo del seven yearly meetings, i cosiddetti hicksite) e il Five Years’ Meeting. Negli
archivi dell’AFSC, a Filadelfia, è consultabile una copia del verbale della prima riunione dei
fondatori. Cfr. AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE ARCHIVES PHILADELPHIA [d'ora in
avanti AFSC] , April 30, 1917, Box: General Administration 1917 (GA 1917 Admin to Comm
Hees and Org), Folder: Administration General. Al proposito, cfr. L.M. JONES, Quakers in
Action: Recent Humanitarian and Reform Activities of the American Quakers, New York, The
Macmillan Company, 1929, p. 18 e M.H. JONES, Swords into Ploughshares: An Account of the
American Friends Service Committee, 1917-1937, New York, The Macmillan Company, 1937,
p. 13.
2
Cfr. verbale, p. 1, in AFSC, April 30, 1917, Box: General Administration 1917 (GA 1917
Admin to Comm Hees and Org), Folder: Administration General.
133
Paolo Macrì
attività delle adunanze più importanti delle isole britanniche, in particolare
di quella di Londra. Lo Yearly Meeting londinese, infatti, aveva fondato e
sostenuto comitati di soccorso internazionali già durante le guerre
napoleoniche, 3 portando aiuti in diversi paesi, e aveva fornito aiuti
materiali, fondi e volontari durante le maggiori crisi europee del XIX
secolo. 4 Sino alla guerra mondiale, la prova più importante affrontata dai
quaccheri britannici era stata la seconda guerra anglo-boera, conclusasi nel
1902, che aveva messo a dura prova la fede pacifista di molti fedeli e la
tenuta complessiva della comunità, per i molteplici dilemmi etici e le
innumerevoli questioni politiche poste dalle attività di soccorso umanitario.
I quaccheri inglesi, infatti, erano stati attaccati per gli aiuti portati ai nemici
dell’impero britannico. In particolare, erano state osteggiate le iniziative in
soccorso ai boeri internati nei campi di concentramento britannici, che
avevano sollevato dibattiti e contrasti sulla stampa e tra le forze
parlamentari.
Date queste premesse, i quaccheri britannici erano in possesso
dell’esperienza più vasta e articolata nel soccorso umanitario e avevano il
necessario vigore morale per imporre la propria presenza sui fronti di guerra
e assistere anche i civili nemici. Nel 1914 gli inglesi anticiparono i
correligionari americani nel portare aiuti ai profughi e ai civili affamati sul
continente europeo, sperimentando la prima struttura quacchera di
coordinamento e distribuzione di soccorsi umanitari del conflitto europeo. I
quaccheri britannici, con l’istituzione del Friends War Victims Relief
Committee, 5 iniziarono a coordinare le attività di soccorso per i profughi
belgi e favorirono l’attività della Friends Ambulance Unit (FAU), che allestì
il soccorso e il trasporto dei feriti con veicoli a motore. Dopo le prime
iniziative in Belgio, i quaccheri britannici organizzarono, in Francia,
l’assistenza ai profughi e ai senzatetto, costruendo e gestendo campi e
strutture d’accoglienza, e facendosi carico del vitto, del vestiario e delle
3
Cfr. J.O. GREENWOOD, Quaker Encounters, Vol. I, Friends and Relief, York, William
Sessions Limited, 1975, pp. 11-17.
4
I quaccheri britannici portarono soccorso alle popolazioni balcaniche e greche tra il 1822 e il
1870, a quelle irlandesi tra il 1822 e il 1900, alle popolazioni finlandesi durante la guerra di
Crimea tra il 1856 e il 1868 e a quelle russe per tutto il XIX secolo. Lo Yearly Meeting
londinese strutturò, inoltre, una serie di attività di soccorso umanitario, piuttosto articolate,
durante la guerra franco-prussiana del 1870, dove venne utilizzato il simbolo della croce rossonera, che avrebbe distinto i quaccheri in tutti gli interventi umanitari successivi. Cfr. ibid., pp.
41-46, 18-24, 95-148.
5
Ibid., pp. 194-205.
134
I quaccheri americani e le attività di soccorso
cure degli assistiti. Gli americani, in questa fase delle attività, si limitarono a
fornire aiuti materiali e somme di denaro, 6 non potendo contare su un
organismo unitario per il coordinamento e l’invio di eventuali soccorsi in
Europa. Figura di riferimento del comitato britannico fu Ruth Fry, che
aveva maturato una straordinaria esperienza nel soccorso umanitario durante
la guerra anglo-boera e vantava studi in ambito di arbitrato e mediazione
internazionali. 7 La vocazione cosmopolita del Friends War Victims Relief
Committee sarebbe stata ulteriormente confermata, nel 1916, quando
volontari britannici furono inviati, nei distretti del Volga, per valutare i
bisogni delle popolazioni russe.
Negli Stati Uniti, così come era stato ampiamente previsto, il 18 maggio
1917 venne reintrodotta la coscrizione. Il piano di reclutamento, ratificato
dal Congresso, prevedeva la registrazione di tutti gli uomini in età compresa
tra i ventuno e i trentuno anni, sia celibi che coniugati con figli, mentre
parziali esenzioni erano state previste per alcune categorie di lavoratori
specializzati e di pubblici ufficiali. L’adozione del provvedimento sollevò le
veementi proteste delle associazioni pacifiste e antimilitariste, tanto che per
contrastare le loro campagne di boicottaggio, nel giugno 1917, il governo
statunitense emanò l’Espionage Act. 8
I quaccheri dell’AFSC si mantennero distanti dalle proteste e cercarono
ostinatamente una soluzione di compromesso, che consentisse agli obiettori
di sottrarsi, in maniera legittima, al servizio di leva. Le norme sulla
6
Cfr. A.R. FRY, A Quaker Adventure: The Story of Nine Years’ Relief and Reconstruction,
London, Nisbet & Co., 1927, pp. 5-99.
7
Sulla formazione pacifista e sulla coscienza religiosa di Ruth Fry, cfr. B. BIANCHI, Una
grande pericolosa avventura. Anna Ruth Fry, il Relief Work e la riconciliazione
internazionale (1914-1926), in «DEP Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica sulla
memoria femminile», 9, 2008, pp. 25-28, consultabile sul sito internet dell’Università Ca’
Foscari di Venezia alla pagina web http://admin.unive.it/nqcontent.cmf?a_id=54023.
8
Questo provvedimento considerava reato ogni manifestazione volta a osteggiare il
reclutamento militare e anche il generico incoraggiamento a comportamenti, giudicati sleali dal
governo. Conseguenze di queste restrizioni alle libertà costituzionali furono il divieto di
distribuire periodici politici e sindacali e la repressione di tutte le attività che, a giudizio dei
tutori della legge, potevano influenzare negativamente l’opinione pubblica sulle azioni di
governo. L’Espionage Act fu approvato dal Congresso degli Stati Uniti il 15 giugno 1917 e fu
emendato nel 1918 con l’adozione dell’ancora più repressivo Sediction Act. Queste norme,
ulteriormente integrate, sono ancora in vigore. Per un approfondimento del dibattito politico
dell’epoca sulle conseguenze delle limitazioni imposte dall’Espionage Act, cfr. H.W. TAFT,
Freedom of Speech and the Espionage Act, Plainfield, N.J., New Jersey Journal Law
Publishing Co., 1921.
135
Paolo Macrì
coscrizione, tuttavia, non escludevano gli obiettori dalla chiamata alle armi
e dall’invio nei campi di addestramento. Inoltre, molti obiettori quaccheri,
come altri mennoniti e brethren, rifiutavano ostinatamente ogni contatto con
le autorità militari, rendendo difficile la mediazione. I casi di questi
obiettori, i cosiddetti “assolutisti”, erano di difficile approccio, sia per
l’AFSC che per le autorità, in quanto l’ostinazione nel rifiuto di ogni
relazione con le gerarchie militari costringeva i comandanti dei centri di
addestramento a ricorrere alle corti marziali. Ad ogni modo, i rappresentanti
del governo ebbero diverse occasioni per incontrare, a Washington, gli
inviati dell’AFSC e si sforzarono di trovare un accordo per salvare
l’operatività generale delle norme sul reclutamento, facendo salvo
l’esercizio legittimo dell’obiezione di coscienza.
In una di queste occasioni, i rappresentanti dell’AFSC ebbero modo di
interloquire con il segretario della Difesa Newton Diehl Baker, il quale
dimostrò la volontà del governo statunitense di offrire garanzie e
opportunità ai pacifisti per motivi religiosi. Si legge, infatti, in un resoconto
dell’AFSC di una riunione tenuta a Washington il 17 agosto 1917:
[…] Il segretario è stato estremamente cordiale,
concedendoci il suo tempo liberamente, malgrado fosse
sotto pressione per molte questioni, ascoltandoci con
simpatia e interesse. Ci ha comunicato che il presidente,
il generale Cowder e lui stesso ritenevano che la
situazione fosse di inusuale difficoltà, motivo per cui non
avevano ancora raggiunto una soluzione, ma che
avrebbero continuato a lavorarci. I loro sforzi sarebbero
stati indirizzati a determinare quale tipo di servizio
sarebbe potuto essere soddisfacente per i noncombattenti […]. 9
La soluzione ai numerosi problemi posti dagli obiettori di coscienza
quaccheri, soprattutto per quanto riguarda gli assolutisti non fu facile, né
immediata. Tuttavia, dopo una serie di ulteriori riunioni e incontri, si
raggiunse un compromesso. I giovani quaccheri, regolarmente reclutati nei
centri di addestramento, una volta dichiarata la loro obiezione di coscienza,
9
Resoconto della missione dell’AFSC a Washington del 17 agosto 1917, p. 1, in AFSC, Box:
General Administration 1917 (GA 1917 Admin to Comm Hees & Org.), Folder: Committees &
Organizations: U. S. Government, War Department.
136
I quaccheri americani e le attività di soccorso
avrebbero ricevuto la dispensa dal servizio armato e sarebbero stati destinati
ad attività sostitutive. Circa trecento di essi furono inviati all’Haverford
College, in Pennsylvania, dove, nell’estate del 1917, avrebbero seguito un
serrato programma di addestramento e preparazione alle attività di soccorso
umanitario. 10 In considerazione dell’esperienza britannica, l’AFSC aveva
concordato con le autorità l’impiego dei primi trecento volontari in Francia.
Garante di questa prima Haverford Unit sarebbe stata l’American Red Cross
(ARC), che aveva stabilito la sua delegazione europea a Parigi. Durante
l’autunno del 1917 e l’inverno del 1918, l’Haverford Unit giunse in Europa
e si integrò con i volontari inglesi, collaborando alle loro attività e
realizzandone altre autonomamente. 11 In ogni caso, i volontari quaccheri
rifiutarono ogni coinvolgimento con i militari, considerando anche le
attività di assistenza alle truppe una forma di legittimazione della guerra.
Nel novembre 1918, le ostilità cessarono sul fronte occidentale e i
volontari quaccheri completarono i progetti che avevano intrapreso e, in
molti casi, furono costretti a ricostruire parte dei villaggi, che avevano già
contribuito ad assistere, travolti dall’ultima offensiva tedesca. Dopo la fine
del conflitto, l’attenzione dei governi vincitori e delle strutture umanitarie si
rivolse anche alle stremate popolazioni dei paesi nemici. Il governo
statunitense, per rendere credibili le posizioni assunte presso le commissioni
della Conferenza di Pace, diede impulso a una serie di istituzioni
governative per l’assistenza umanitaria e favorì la collaborazione tra queste
10
Di particolare interesse l’articolazione delle attività e della struttura della prima Haverford
Unit. Trecento volontari quaccheri provenienti da tutti gli Stati della Federazione statunitense
si raccolsero nella Barclay Hall del campus di Haverford dove si sottoposero a un intenso
regime addestrativo, in considerazione dei loro studi e delle loro capacità tecniche e lavorative.
Vennero create undici squadre, che furono istruite sui lavori di carpenteria, sui lavori agricoli o
di riparazioni meccaniche, seguendo anche corsi di lingua francese. Negli archivi dell’AFSC è
conservato un report di sei pagine dove sono descritte minuziosamente le attività giornaliere e
settimanali delle prime squadre in addestramento, oltre ai dati anagrafici e al livello di
istruzione dei partecipanti. Cfr. AFSC, Box: General Administration 1917 (GA 1917
Conscientious Objectors to Foreign Service-Country Canada), Folder: Haverford
Reconstruction Unit.
11
Per un approfondimento sulle attività quacchere in Francia, cfr. FRY, A Quaker Adventure,
cit., pp. 57-66 e 74-78; R.M. JONES, Service of Love in War Time: American Friends Relief
Work in Europe, 1917-1919, New York, The Macmillan Company, 1920, pp. 144-156; JONES,
Quakers in Action, cit., pp. 23-35; The First Year of American Friends’ War Relief Service,
June 1, 1917- May 31, 1918, in «American Friends Service Committee Bulletin», n. 16, pp. 19, in AFSC, AFSC Annual Reports, 1917-1947.
137
Paolo Macrì
e le associazioni, che si erano occupate di aiuti umanitari durante i difficili
anni della guerra mondiale.
2. I soccorsi umanitari in Europa dopo l’armistizio. La prima
collaborazione tra l’AFSC e l’American Relief Administration (ARA) di
Herbert Hoover
Durante gli anni del conflitto e nel periodo postbellico, la figura di
riferimento per le attività umanitarie degli Stati Uniti fu, senza dubbio,
quella di Herbert Hoover, il futuro presidente degli Stati Uniti. Nel 1914,
Hoover viveva a Londra, dove aveva diretto un comitato di assistenza per i
cittadini statunitensi, che abbandonavano il continente europeo a causa della
guerra. Dopo questa sua iniziativa, era stato coinvolto nella Commission for
Relief in Belgium (CRB), che provvide all’invio di aiuti umanitari in Belgio
sotto l’occupazione tedesca. Nei tre anni di lavoro successivi, Hoover aveva
dimostrato straordinarie capacità amministrative e organizzative, che gli
valsero la direzione della United States Food Administration, istituita dal
governo americano per coordinare il controllo delle importazioni e delle
esportazioni, combattere le speculazioni sui prezzi e pianificare la
produzione agro-alimentare statunitense. L’efficienza raggiunta dalle
politiche di controllo dei prezzi e il successo della pianificazione e
dell’impiego delle risorse destinate agli aiuti umanitari accrebbero la stima
verso Herbert Hoover negli ambienti governativi e, per questo, dopo
l’armistizio del novembre 1918, il presidente Wilson gli affidò l’incarico di
programmare un massiccio invio di aiuti alimentari verso l’Europa, che
rischiava un disastro di proporzioni simili a quello provocato dalla Guerra
dei Trent’anni, tre secoli prima. 12
Il conflitto, infatti, aveva avuto pesanti ripercussioni sulle produzioni
agricole e sui commerci internazionali e alcune nazioni, come la Germania e
gli Stati nati dal dissolvimento dell’impero austro-ungarico e dell’impero
zarista, non avevano ricevuto alcun tipo di assistenza internazionale; anzi,
avevano subito le conseguenze del blocco economico imposto dagli alleati,
che aveva tragicamente impoverito la popolazione, riducendola alla fame.
Malgrado la resistenza degli alleati, il governo statunitense era determinato
a distribuire aiuti alle popolazioni europee. Per questo, il presidente Wilson
12
Cfr. F.M. SURFACE – R.L. BLAND, American Food in the World War and Reconstruction
Period: Operations of the Organizations under the Direction of Herbert Hoover 1914 to 1924,
Stanford, Stanford University Press, 1931, p. 23.
138
I quaccheri americani e le attività di soccorso
delegò il suo consigliere Edward Mandell House di scrivere un
memorandum per il Supreme War Council a Versailles, con il quale si
propose la creazione di un ente interstatale, che avrebbe provveduto a
studiare le necessità dei singoli paesi e a distribuire gli aiuti alimentari
necessari a sconfiggere la fame e la malnutrizione. Fu istituito così il
Supreme Economic Council, con sedi in ogni paese destinatario degli aiuti.
Queste unità amministrative avrebbero fatto riferimento agli uffici della
Food Section dell’Economic Council, a Parigi, che sarebbero stati
coordinati da Herbert Hoover.
Gli Stati Uniti avrebbero elargito la maggior parte dei fondi, per la
somma complessiva di cento milioni di dollari, dei quali l’88% sarebbe
stato prelevato dai fondi del Tesoro, mentre il rimanente 12% sarebbe stato
raccolto da associazioni di soccorso americane. Queste somme sarebbero
state conferite a un ente governativo statunitense, che avrebbe gestito
l’acquisto e la destinazione di cibo, vestiario e altri generi di prima necessità
per i bambini più bisognosi. Per coordinare i contributi delle associazioni e
per amministrare questi capitali, il 24 febbraio 1919 fu istituita l’American
Relief Administration (ARA), che sarebbe stata diretta da Herbert Hoover.
Le associazioni statunitensi che parteciparono alle attività dell’ARA furono
l’AFSC, l’ARC, la CRB, l’American Jewish Joint Distribution Committee
(JDC) 13 e l’American Committee for Relief of the Near East (ACRNE). 14
Una delle situazioni più gravi del continente europeo era quella dei civili
tedeschi. La Germania, dopo aver subito gli effetti del blocco economico,
durante il periodo armistiziale – dal novembre 1918 alla firma del trattato di
Versailles, avvenuta il 28 giugno 1919 – dovette sottostare a una rigida
regolamentazione dei commerci e all’impossibilità di disporre della propria
flotta commerciale. Per questo motivo, le associazioni quacchere
anglosassoni, che avevano ancora gruppi impegnati in lavori di
ricostruzione in Francia, iniziarono a predisporre nuclei di soccorso da
inviare in Germania. I quaccheri britannici costituirono un gruppo di quattro
volontari, mentre l’AFSC cominciò con l’inviarne solo un gruppo di tre. Del
resto, la guerra era finita anche per i giovani obiettori americani e, sebbene
una parte consistente dell’Haverford Unit fosse rimasta in Europa per
13
Il JDC è un’associazione ebraica internazionale di soccorso umanitario, fondata a New York
nel 1914. È ancora attiva ai nostri giorni in più di settanta paesi. Cfr. http://www.jdc.org.
14
L’ACRNE fu fondata nel 1915 per soccorrere le popolazioni dell’impero ottomano
perseguitate. È ancora oggi attiva con il nome di Near East Foundation. Cfr.
http://www.neareast.org.
139
Paolo Macrì
completare i progetti avviati, il loro destino era quello di fare ritorno in
patria, come le truppe combattenti, che erano in via di smobilitazione.
Data l’esiguità dei nuclei quaccheri destinati alla Germania, all’inizio le
attività furono solo di sommaria ricognizione delle necessità della
popolazione. Successivamente, seguirono altre iniziative molto più ampie,
alla cui riuscita non fu estraneo Herbert Hoover. Infatti, in una lettera del 25
giugno 1919, indirizzata ai funzionari dello staff tedesco dell’ARA, Hoover
dava chiare indicazioni sulle agevolazioni che dovevano essere accordate ai
membri dell’AFSC, che, tra l’altro, era stata la prima associazione a
raccogliere donazioni negli Stati Uniti per i civili tedeschi. In questa lettera,
Hoover presentava allo staff dell’ARA in Germania tre cittadine americane,
Jane Addams, Caroline Wood e Alice Hamilton, per le quali veniva
formulata questa richiesta:
[…] Qualsiasi assistenza di cui possano avere bisogno,
venga loro garantita, sia per quanto riguarda i trasporti e
le sistemazioni, che per qualunque altro mezzo che possa
agevolare il loro viaggio […]. 15
A suggellare la collaborazione tra l’ARA e l’AFSC furono Herbert
Hoover e Rufus Jones, che si incontrarono a Filadelfia; successivamente, lo
stesso Hoover avrebbe scelto l’AFSC per dirigere le operazioni umanitarie
in Germania, affidando ai quaccheri americani la realizzazione e il
coordinamento di tutte le attività di soccorso per i bambini tedeschi. In una
lettera del 17 novembre 1919, Hoover scriveva:
[…] Sono pronto a fornire garanzie, con i fondi a mia
disposizione, per le spese d’acquisto e a pagare l’intero
importo delle spese di spedizione oltremare, dai porti
atlantici ai porti tedeschi, di qualsiasi genere alimentare
da destinare al soccorso dei bambini, per i quali la vostra
associazione dovrà solo corrispondere il prezzo […]
senza spese di spedizione o di magazzino […]. 16
15
AFSC, Box: General Administration 1919 (GA 1919 Foreign Service), Folder: German
General.
16
Una parte della lettera con la quale Hoover conferma gli accordi intervenuti è citata alla
prima pagina di un report di tre, dal titolo Hoover opens the door, privo di data e siglato
H.H.B., in AFSC, Box: General Administration 1919 (GA 1919 Foreign Service), Folder:
140
I quaccheri americani e le attività di soccorso
In quel periodo, l’ARA si stava già occupando del sostentamento di altri
due milioni di bambini europei e non avrebbe potuto articolare un’efficace
struttura di soccorso anche in Germania. Secondo gli accordi, le forniture
sarebbero state inviate dagli Stati Uniti e dagli altri paesi europei a spese
dell’ARA, ma gli oneri per l’acquisto degli aiuti sarebbero stati a carico
dell’AFSC, anche se, come lo stesso Hoover aveva suggerito, i quaccheri
americani avrebbero potuto contare sulle donazioni di molti concittadini di
ascendenze tedesche. 17
La direzione di un’iniziativa di tale entità alla sola AFSC suscitò la
perplessità di molte altre associazioni, in particolare di quelle confessionali,
ma Hoover era convinto che, soprattutto nella prima fase di assistenza alla
Germania sconfitta, avrebbe potuto fare affidamento esclusivamente
sull’AFSC. Infatti, le comprovate capacità dei suoi organizzatori e la natura
non governativa dell’associazione avrebbero mantenuto le attività
umanitarie immuni da critiche. 18 L’AFSC organizzò, quindi, un ampio
gruppo di lavoro, che non solo gestì i soccorsi all’infanzia per l’intera
Germania, ma trovò ulteriori fondi per l’acquisto di derrate alimentari. A
sancire il patto tra l’AFSC e l’ARA, oltre agli accordi intervenuti, vi fu
l’accettazione, da parte di Herbert Hoover, della presidenza onoraria della
sezione tedesca dell’AFSC, garantendo con il suo stesso nome la riuscita
delle operazioni di soccorso. 19
Nelle città e nei centri dove si era potuta insediare, l’AFSC utilizzò
strutture in cui si preparavano centinaia di pasti al giorno. Da queste grandi
cucine, gli alimenti venivano portati nei centri di distribuzione, quasi
sempre edifici scolastici, dove circa venticinquemila insegnanti tedeschi
distribuivano i pasti ai piccoli maggiormente in difficoltà. L’obiettivo era
quello di assistere il maggior numero possibile di bambini, garantendo loro
le integrazioni nutritive indispensabili e monitorandone la salute. Seguendo
questi criteri, nel primo semestre del 1920, l’AFSC aveva sfamato
Country German General. Il testo integrale della lettera è riprodotto in JONES, A Service of
Love in War Time, cit., pp. 261-262 e in JONES, Quakers in Action, cit., pp. 45-46.
17
Sino al 1922, le associazioni di cittadini statunitensi di origine tedesca raccolsero tre milioni
di dollari per i soccorsi umanitari in Germania. Cfr. SURFACE–BLAND, American Food in the
World War and Reconstruction Period, cit., p. 118.
18
Cfr. il già citato report, Hoover opens the door, cit., p. 2.
19
Cfr. Third General Report, June, 1919-September, 1920, in «American Friends Service
Committee Bulletin», n. 33, p. 4, in AFSC, AFSC Annual Reports, 1917-1947.
141
Paolo Macrì
seicentotrentamila bambini, in ottantotto città, grazie alla realizzazione di
quasi quattromila centri di distribuzione. 20 Nella seconda metà del 1920,
l’assistenza fu estesa alla Prussia orientale e alla città di Danzica e, nel
1921, fu fornito aiuto a più di un milione di bambini tedeschi in
milleseicentoquaranta centri della Germania, grazie a duemiladuecento
cucine e ottomila centri di distribuzione.
3. Il fallimento delle iniziative diplomatico-umanitarie degli Stati Uniti in
Russia
Le attività dell’ARA e delle associazioni di assistenza umanitaria coinvolte
ebbero larga eco sulla stampa e questo contribuì a mantenere vivo, sia
nell’opinione pubblica che presso il governo statunitense, l’interesse per la
situazione europea. Le previsioni sui raccolti del 1920, formulate dai
funzionari dell’ARA per alcune capitali europee, 21 lasciavano intendere che
sarebbero stati scarsi e che almeno due milioni e mezzo di bambini
avrebbero avuto bisogno di aiuti alimentari per il successivo biennio 19201921. La situazione si profilava ancora più drammatica in Russia, in
particolare nelle zone del Volga e della Siberia, dove carestie ed epidemie si
erano succedute sin dal 1916, falcidiando le centinaia di migliaia di
profughi che avevano cercato rifugio.
La gestione dei rifugiati provenienti dalle regioni baltiche russe e dalle
zone a ridosso del fronte orientale era stata disastrosamente inefficiente. Il
governo zarista, prima, e quello rivoluzionario borghese, poi, si erano
limitati a spostare migliaia di persone sempre più a oriente, sperando che le
risorse delle province asiatiche potessero sostentarle. Il risultato di queste
politiche fu quello di concentrare i profughi in zone non urbanizzate e
lontane dalle linee di comunicazione, rendendo difficili l’assistenza e i
soccorsi ed esponendoli ai rigori delle stagioni invernali, che ne fecero
strage. La rivoluzione bolscevica non agevolò i soccorsi per questi
sfortunati, ai quali si aggiunsero le vittime della guerra civile, che
conobbero la devastazione delle campagne e la nazionalizzazione dei
20
Cfr. ibid., p. 7.
Uffici dell’ARA erano stati istituiti, in Finlandia, a Helsingfors; in Estonia, a Reval; nella
Russia nord-occidentale, a Jamburg; in Lettonia, a Riga; in Lituania, a Kovno; in Polonia, a
Varsavia; in Cecoslovacchia, a Praga; in Austria, a Vienna; in Ungheria, a Budapest; in
Romania, a Bucarest; in Jugoslavia, a Belgrado. Cfr. SURFACE–BLAND, American Food in the
World War and Reconstruction Period, cit., p.73.
21
142
I quaccheri americani e le attività di soccorso
raccolti, che, interrompendo i commerci delle derrate tra le province,
aggravò la penuria di cibo. La guerra civile, infine, affamò anche le zone
sotto lo stretto controllo dei rivoluzionari.
Nel 1917, gli Stati Uniti avevano riconosciuto il primo governo
rivoluzionario e avevano inviato in Russia la Root Mission, 22 la Stevens
Railways Commission 23 e, in un periodo successivo, anche i rappresentanti
della Special Red Cross Commission. 24 Obiettivo specifico di queste
iniziative diplomatico-umanitarie era il rafforzamento dei rapporti tra i due
paesi e, per questo, il governo americano metteva a disposizione di quello
russo sia capitali finanziari, che aiuti di natura sanitaria e tecnologica.
Queste iniziative di cooperazione internazionale si presentavano come
missioni di assistenza tecnico-organizzativa, ma avevano implicazioni
strettamente diplomatiche, tanto da sovrapporsi alle attività dei funzionari
d’ambasciata, con risultati piuttosto contraddittori. Gli Stati Uniti, infatti,
non riuscirono a ottenere analisi corrette sulla situazione russa, tanto che
Elihu Root, al suo ritorno in patria, avrebbe comunicato che la democrazia
russa non era in pericolo.
Diversamente, la drammatica conflagrazione tra le pressioni interne al
sistema del governo provvisorio russo e le croniche difficoltà delle
operazioni militari sul fronte orientale impedirono la normalizzazione sia
dei rapporti politici, economici e sociali all’interno dell’esausta società
russa, sia delle relazioni internazionali. Neanche il tentativo riformista di
Alexander Kerenskij riuscì a spingere lo sforzo bellico o a riformare le
istituzioni. Altri poteri lavoravano da tempo per costruire un disegno
diverso, quello sovietico, che la politica diplomatica statunitense dimostrò
22
Questa missione, diretta dal diplomatico Elihu Root, operò in Russia tra la primavera e
l’estate del 1917. Suo compito principale fu quello di dissuadere il governo russo dal firmare
un armistizio o un trattato di pace con le potenze centrali. Per un approfondimento sulla
diplomazia russo-statunitense nel 1917, cfr. i documenti diplomatici riguardanti la Root
Mission, in Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1918, Russia, Vol. I,
Washington, Government Printing Office, 1931, pp. 107-152.
23
Per un approfondimento sulla Stevens Railway Commission, cfr. ibid., pp. 137-139 e L.J.
BACINO, Reconstructing Russia: U. S. Policy in Revolutionary Russia, 1917-1922, Kent, Kent
University Press, 1999, pp. 25-40.
24
Nel luglio 1917, Henry P. Davison, in qualità di segretario del War Council dell’ARC, inviò
in Russia una commissione speciale di esperti della Croce Rossa statunitense per studiare i
bisogni e le necessità della popolazione. Si veda H.P. DAVISON, The American Red Cross in
the Great War, New York, The Macmillan Company, 1918, p. 268 e ss.
143
Paolo Macrì
di non comprendere. Il governo russo sarebbe stato travolto dalla
rivoluzione bolscevica e, in pochi mesi, sarebbero state disattese tutte le
speranze di mantenere le truppe russe sul fronte orientale.
L’armistizio del 17 dicembre 1917 tra le truppe russe e quelle austrotedesche e, tre mesi dopo, la Pace di Brest-Litovsk avrebbero esposto le
potenze dell’Intesa ad un possibile rovescio, anche sul fronte occidentale.
Gli Stati Uniti non intesero riconoscere la legittimità del governo sovietico
e, per questo, anche le relazioni diplomatiche tra i due paesi non riuscirono
a consolidarsi. La delegazione statunitense ufficiale in Russia non aveva
autorevolezza agli occhi dei bolscevichi e gli unici diplomatici russi
accreditati negli Stati Uniti erano quelli inviati dal governo precedente. Gli
americani, quindi, dovendo trovare canali diversi da quelli ufficiali, fecero
ricorso ad alcuni soggetti, che avevano partecipato alle precedenti missioni
di cooperazione internazionale, in particolare a John Mott della YMCA e a
Raymond Robins della Special Red Cross Commission.
In questa fase del conflitto, il contributo dell’AFSC alle attività
umanitarie in Russia fu piuttosto scarso, anche se, nel 1917, sei giovani
volontarie avevano solcato il Pacifico per attraversare la Siberia ed erano
giunte nel distretto di Samara, nella zona del Volga, dove già operava una
missione quacchera inglese. 25 La situazione complessiva era, tuttavia,
disastrosa, al punto che un bollettino dell’AFSC riportava le parole di
Robert Tatlock, un quacchero inglese, che descriveva questa situazione:
[…] L’ampio numero di rifugiati, la povertà della terra
sulla quale si trovano, l’asprezza del clima, la diffusa
mancanza di vestiario, la carenza di cibo a livello locale,
la diffusione di malattie, l’alto tasso di mortalità fra i
rifugiati,
l’insufficiente
natura
delle
poche
organizzazioni di soccorso che esistono e la lunga durata
delle difficoltà contribuiscono a rendere il problema
russo, se non il più straordinario o il più intenso,
senz’altro il più vasto e, per molti versi, il più terribile
25
Si trattava di Anna J. Haines, Lydia Lewis, Esther White, Emilie Bradbury, Nancy Babb e
Amelia Farbiszzewski. Cfr. R.C. SCOTT, Quakers in Russia, London, Michael Joseph, 1964, p.
184.
144
I quaccheri americani e le attività di soccorso
fenomeno civile non solo di questa guerra, ma, può darsi,
di tutte le guerre […]. 26
A complicare ulteriormente la pianificazione dell’intervento di attività di
soccorso intervenne l’evoluzione politica e militare delle relazioni tra le
potenze alleate e la Russia. Infatti, malgrado il dialogo diplomatico con le
forze sovietiche non si fosse del tutto interrotto e fosse stato ottenuto
l’armistizio sul fronte occidentale, scongiurando la possibilità di un
intervento in Francia delle truppe tedesche smobilitate a oriente, la
situazione internazionale non consentiva agli Stati Uniti di intraprendere
una politica più risoluta nei confronti della Russia. Era stato inviato un
corpo di spedizione militare americano in Siberia; inoltre, truppe francesi,
inglesi e americane erano intervenute in Crimea e nella Russia
settentrionale, ma queste missioni non erano riuscite a stabilizzare la
situazione politica russa. Le linee ferroviarie della transiberiana erano in
mano alle truppe cecoslovacche, che scoraggiavano il movimento dei civili.
Formazioni militari russe controrivoluzionarie controllavano le province più
lontane da Mosca, impedendo l’arrivo di aiuti di cui potessero beneficiare i
bolscevichi, mentre questi ultimi combattevano contro tutti con
determinazione e ferocia, controllando i territori della Russia europea e
minacciando di sostenere le rivolte bolsceviche esplose in Ungheria e in
Germania. Nel 1919 e nel 1920, la popolazione russa, quindi, non fu
raggiunta da soccorsi e, malgrado le epidemie e la scarsità di cibo si
aggravassero, né i sovietici, né le forze controrivoluzionarie, né le potenze
dell’Intesa raggiunsero accordi per autorizzare missioni di soccorso
dall’estero.
Con l’interruzione dei rifornimenti e con il blocco delle comunicazioni,
anche i quaccheri delle missioni inglesi nelle province del Volga di Samara
e Buzuluk e le volontarie inviate presso di loro dall’AFSC, nel luglio 1917,
dovettero abbandonare i centri di assistenza che avevano realizzato, perché
non ricevevano più approvvigionamenti di alcun genere. 27 I volontari
quaccheri tornarono in patria o si spostarono in Siberia, dove erano presenti
26
The First Year of American Friends’ War Relief Service, June 1, 1917- May 31, 1918, in
«American Friends Service Committe Bulletin», n. 16, pp. 9-10, in AFSC, AFSC Annual
Reports, 1917-1947.
27
Cfr. JONES, A Service of Love in War Time, cit., p. 244.
145
Paolo Macrì
le truppe americane, mentre chi scelse di rimanere per essere accanto agli
assistiti più bisognosi restò isolato per oltre un anno. 28
L’ARA di Hoover, nel 1919 e nel 1920, fece due tentativi diplomatici
per portare aiuti alla stremata popolazione russa, ma entrambe le iniziative
non ebbero successo per il boicottaggio da parte dell’opinione pubblica
inglese e francese, che vedeva in questi aiuti un sostegno indiretto al regime
bolscevico, e per quello delle autorità sovietiche, che intendevano avere il
pieno controllo delle operazioni di soccorso e degli aiuti materiali. 29
L’AFSC, dal canto suo, non appena il dipartimento di Stato rimosse le
restrizioni al commercio e alle comunicazioni con la Russia, 30 si adoperò
per inviare lì un proprio rappresentante, che fu accreditato grazie alle
pressioni dei quaccheri inglesi. 31 Il nuovo avvio delle attività umanitarie
quacchere anglo-americane in Russia non sarebbe stato, comunque,
sufficiente a sostenere un massiccio afflusso di aiuti, né le strutture
realizzate dai quaccheri anglosassoni avrebbero potuto fronteggiare il
disastro della carestia, che era destinato a sconvolgere ulteriormente le
28
Negli archivi dell’AFSC sono conservati diversi documenti inediti del volontario inglese
Thomas Riggs, presente in Russia dal 1916. Tra questi, un dattiloscritto nel quale Riggs
descrive l’esperienza vissuta con la giovane americana Esther White. I due volontari rimasero
isolati, sino al febbraio 1919, nelle zone controllate dai sovietici per assistere due colonie di
bambini, con il sostegno dei tolstojani e il consenso delle autorità bolsceviche. Questa
ricostruzione di Riggs, risalente all’agosto 1958, si compone da trentatré pagine, con appendici
e bibliografia, e descrive in forma diaristica le attività svolte. Per la lettura integrale del
documento, vedi Mission to Moscow: The Experiences of Two Relief Workers in the First
World War by T. Rigg and E. M. White, in AFSC, Box: General Administration 1918 (Foreign
Service Country-Russia), Folder: Individuals T. Rigg & E. White Excerpts from Diaries.
29
Nell’aprile 1919, Herbert Hoover aveva ricevuto dalle quattro potenze vincitrici
l’autorizzazione a esportare aiuti in Russia, grazie alla collaborazione di Fridtjof Nansen. Il
piano, tuttavia, fu boicottato dai francesi e dai rappresentanti delle forze controrivoluzionarie
russe e respinto dalle autorità sovietiche. Cfr. H.H. FISHER, The Famine in Soviet Russia, 19191923: The Operations of the American Relief Administration, New York, The Macmillan
Company, 1927, pp. 10-27. Un ulteriore tentativo fu formulato da Hoover nell’estate del 1920,
in occasione della guerra russo-polacca, ma in questo caso gli aiuti raggiunsero solo i polacchi
e i russi che abitavano le zone occupate dalle truppe polacche. Cfr. ibid., pp. 28-48.
30
Cfr. copia del comunicato stampa del dipartimento di Stato del 7 luglio 1920, in AFSC,
Box: General Administration 1920 (Foreign Service Country-Russia), Folder: Department of
State.
31
Vedi copia del memorandum del 25 settembre 1920, nel quale il rappresentante dell’AFSC a
Berlino, Robert Yarnall, comunica al rappresentante del governo sovietico in Germania, Viktor
Kopp, di avere ricevuto notizia dal rappresentante quacchero inglese, Arthur Watts, del
possibile invio di un delegato americano in Russia, in AFSC, Box: General Administration
1920 (Foreign Service Country-Russia), Folder: General.
146
I quaccheri americani e le attività di soccorso
popolazioni dell’ex-impero zarista dopo anni di combattimenti e di scarsità
di raccolti.
4. La carestia in Russia del 1921 e la collaborazione tra l'AFSC e l'ARA
Lo sblocco degli aiuti alla Russia bolscevica intervenne nel luglio 1921 su
esplicita richiesta di uno dei più conosciuti scrittori russi, Maksim Gor’kij,
che rivolse ai popoli americani ed europei un appello per ricevere pane e
medicine per il popolo russo:
[…] La sventura della Russia offre ai filantropi una
splendida opportunità per dimostrare la vitalità
dell’umanitarismo. Io penso che una particolare calda
solidarietà, nel soccorso al popolo russo, dovrebbe
essere mostrata da quelli che durante l’infame guerra
hanno così appassionatamente ammonito l’inimicizia
fratricida […]. Io chiedo alle oneste genti europee e
americane un sollecito aiuto per il popolo russo.
Mandate pane e medicine. […]. 32
Il conflitto russo-polacco si era concluso nel marzo 1921 e le truppe
americane avevano abbandonato la Siberia nel settembre del 1920, mentre il
porto di Arcangelo era stato lasciato già nel luglio di due anni prima e le
rivolte bolsceviche in Europa sembravano essere definitivamente sedate.
Secondo Herbert Hoover, i tempi potevano essere maturi per tentare di
portare aiuti al popolo russo e sperare che il regime sovietico reagisse
positivamente, mitigando la politica repressiva instaurata. 33 Dopo una serie
di consultazioni, Hoover ebbe il parere favorevole del segretario di Stato
Hughes e fu autorizzato il 23 luglio, dal presidente degli Stati Uniti
Harding, a rispondere alla richiesta di aiuto di Gor’kij. 34 Questo primo
32
Cfr. «ARA Bulletin», n. 16, Sept. 1921, p. 4, in AFSC, Box: General Administration 1921
(Committees and Orgs-American Relief Admin to Flatblush Assoc. for Russ), Folder: ARF
Bulletin.
33
H. HOOVER, An American Epic: Famine in Forty-Five Nations. The Battle on the Front Line
1914-1923, Vol. III, Chicago, Henry Regnery Company, 1961, p. 427.
34
Per la consultazione della risposta ufficiale di Hoover all’appello pubblico di Gor’kij, cfr.
FISHER, The Famine in Soviet Russia, cit. pp. 52-54.
147
Paolo Macrì
passo dell’ARA, che si impegnava a inviare forniture ospedaliere e ad
assistere un milione di bambini russi, riaprì le consultazioni diplomatiche
tra il commissario russo degli Esteri e il dipartimento di Stato americano,
che sarebbero culminate nel cosiddetto “accordo di Riga” del 20 agosto
1921. 35 Tuttavia, questo documento non era un trattato diplomatico
bilaterale tra due Stati, ma tra l’ARA, definita organizzazione caritatevole,
volontaria e non-ufficiale, e il governo delle repubbliche socialiste
sovietiche.
In previsione di un articolato e massiccio invio di aiuti, l’ARA avrebbe
cercato la collaborazione delle associazioni umanitarie con le quali aveva
già coordinato le attività di assistenza umanitaria in Europa. In merito il
presidente Harding pose a Hoover e, di conseguenza, alle associazioni
coinvolte, due condizioni irrinunciabili. La prima era quella di non sottrarsi
ai termini dell’accordo di Riga e la seconda era quella di non tentare di
emanciparsi dall’autorità dell’ARA, che doveva essere considerato l’unico
soggetto a rappresentare la volontà del popolo americano e l’unico ad avere
il potere di concludere altri accordi con il governo sovietico. 36 Gli Stati
Uniti non intendevano riconoscere lo Stato bolscevico, ma non potevano
perdere l’occasione di tesaurizzare, sia pure indirettamente, i rapporti tra
l’ARA e le autorità sovietiche e, soprattutto, di riscuotere un eventuale
credito diplomatico per le attività americane di soccorso umanitario.
Formulate queste puntualizzazioni, furono elaborate le politiche di fundraising delle associazioni, che accettavano l’accordo di Riga e
formalizzavano il rapporto di subordinazione all’ARA, in una riunione che
si tenne a Washington il 24 agosto 1921, presso il dipartimento del
Commercio. 37 Ai termini prestabiliti da Hoover, che aprì i lavori, le
associazioni di soccorso americane non avrebbero potuto derogare in alcun
modo. Hoover indicò chiaramente ai rappresentanti dell’AFSC, dell’ARA,
dell’ARC, del Federal Council of Churches, del JDC, dei Knights of
35
Cfr. Minutes of the Meeting of the European Relief Council, held at the Department of
Commerce, Washington, D.C., Wednesday, August 24, 1921, at 9.30 a.m, Appendix A:
Agreement between A.R.A. and Soviet Authorities Re Russian Relief, pp. 3-6, in AFSC, Box:
General Administration 1921 (Committees and Orgs American Relief Admin. To Flatbush
Assoc for Russ), Folder: Minutes.
36
Per il documento integrale, cfr. HOOVER, An American Epic, cit., p. 446.
37
Cfr. Minutes of the Meeting of the European Relief Council, Held at the Department of
Commerce, Washington, D. C., Wednesday, August 24, 1921, in AFSC, Box: General
Administration 1921 (Committees and Orgs American Relief Admin. To Flatbush Assoc for
Russ), Folder: Minutes.
148
I quaccheri americani e le attività di soccorso
Columbus, del National Catholic Welfare Council, della YMCA e della
YWCA 38 che le attività di soccorso sarebbero state indirizzate soprattutto ai
bambini e che le competenze delle singole associazioni avrebbero dovuto
rispettare il trattato di Riga, in “completa cooperazione e coordinamento”
con l’ARA. Il verbale della riunione formalizzò queste condizioni:
[…] L’accordo intervenuto a Riga tra l’American Relief
Administration e le autorità sovietiche è accettato da
tutte le associazioni affiliate allo European Relief
Council e tutte le attività saranno svolte secondo i
termini dell’accordo […]. 39
Una maggiore libertà sarebbe stata concessa all’AFSC, alla quale,
invece, Hoover avrebbe consentito di mantenere le attività di soccorso nelle
missioni già avviate, in virtù della specificità degli ideali di riferimento:
[…] Il direttore dell’American Relief Administration in
Russia assegnerà all’American Friends Service
Committee, che al momento sta portando avanti attività
di soccorso in Russia, un determinato distretto o area
di distribuzione, in cui l’American Friends Service
Committee manterrà la propria identità e le proprie
attività, nel pieno rispetto dei suoi ideali, ma sempre
sotto la supervisione del direttore dell’American Relief
Administration in Russia e in stretta conformità ai
termini dell’accordo di Riga […]. 40
38
Tutte le associazioni intervenute facevano parte dello European Relief Council, che era stato
istituito dall’ARA e dalle maggiori associazioni americane di soccorso all’infanzia per operare
in Europa, dopo la fine del conflitto. Per un approfondimento, cfr. Interim Report of European
Relief Council del 31 maggio 1921, p. 3, in AFSC, Report, Box: General Administration 1921
Committees and Orgs American Relief admin to Flatbush Assoc. for Russian Famine, Folder:
Committees and Orgs-European Relief Committee.
39
Minutes of the Meeting of the European Relief Council, Held at the Department of
Commerce, Washington, D. C., Wednesday, August 24, 1921, p. 1, in AFSC, Box: General
Administration 1921 (Committees and Orgs American Relief Admin. To Flatbush Assoc for
Russ), Folder: Minutes.
40
Ibid, p. 2.
149
Paolo Macrì
L’AFSC, per il tramite Wilbur Thomas, che ne sarebbe stato il segretario
sino al 1929, prese accordi con i quaccheri inglesi, con il proposito di
coinvolgerli nelle attività. Thomas era un giovane quacchero che si era
occupato della raccolta fondi per la Russia, avvicinando molti comitati e
sindacati di sinistra, sorti negli Stati Uniti per sostenere la popolazione russa
e il governo sovietico. 41 Tale circostanza sollevò le obiezioni di Herbert
Hoover, che ebbe scambi epistolari con Rufus Jones, 42 nei quali ribadiva
che le associazioni che avrebbero lavorato in Russia sarebbero state
sottoposte all’ARA e che non sarebbero stati accettati condizionamenti da
parte di simpatizzanti dei bolscevichi, che già stavano tentando di infiltrarsi
nelle attività dell’ARA. 43 Jones, da parte sua, ribadiva di non accettare
alcuna accusa di slealtà e che il suo interesse, come quello dei componenti e
dei volontari dell’AFSC, era quello di servire la causa umanitaria al meglio
delle possibilità offerte dalle circostanze. 44 Rufus Jones cercò di difendere
ulteriormente le specificità e l’indipendenza dell’AFSC dalle clausole
governative proposte da Hoover; tuttavia, i termini dell’accordo erano
stringenti. Jones fu, comunque, confortato dal pieno appoggio espressogli
da Hoover, il quale aveva dichiarato di comprendere i timori dei quaccheri
di perdere la loro identità, ma che l’ARA aveva solo il compito di assicurare
la protezione dei volontari e di rendere efficienti gli sforzi dei soccorsi
umanitari. 45
41
Cfr. D. MCFADDEN-C. GORFINKEL, Constructive Spirit: Quakers in Revolutionary Russia,
Pasadena, Intentional Productions, 2004, p. 57.
42
Lo studioso Bertrand M. Patenaude, docente a Stanford e ricercatore presso l’Hoover
Institution, ha ricostruito in un volume straordinariamente ricco e complesso l’attività di
soccorso statunitense in Russia durante la carestia. Alla collaborazione con l’AFSC presta,
tuttavia, scarsa attenzione; infatti, ai rapporti tra Hoover e l’AFSC dedica soltanto quattro
pagine del suo corposo volume. Cfr. B.M. PATENAUDE, The Big Show in Bololand, Stanford,
Stanford University Press, 2002, pp. 139-142.
43
Cfr. lettera del 10 settembre 1921 con la quale Hoover, rassicurando ulteriormente Jones
sull’indipendenza dell’AFSC, affermava di non volere che un gruppo di persone di
orientamento comunista minasse i rapporti tra ARA e AFSC, in AFSC, Box: General
Administration 1921 (Foreign Service Country Russia-General to Letters), Folder: Country
Russia 1921 Hoover Correspondence.
44
Cfr. lettera di due pagine del 16 settembre 1921 di Jones a Hoover, in AFSC, Box: General
Administration 1921 (Foreign Service Country Russia-General to Letters), Folder: Country
Russia 1921 Hoover Correspondence.
45
Cfr. lettera già citata del 10 settembre 1921, con la quale Hoover rafforzava il contenuto
della lettera consegnata a Jones in quella stessa giornata, in AFSC, Box: General
150
I quaccheri americani e le attività di soccorso
Nelle parole di Hoover c’era un ulteriore sottinteso rivolto ai britannici. I
quaccheri inglesi, che l’AFSC intendeva coinvolgere nella raccolta fondi e
nei soccorsi, avevano avuto scambi con la Russia sin dal XIX secolo e
questo li portava a difendere una politica autonoma, sganciata dall’ARA.
Inoltre, alcuni di loro avevano maturato delle posizioni molto vicine al
bolscevismo e, questo, per Hoover non era tollerabile. L’AFSC continuò,
comunque, a mediare con Hoover per ottenere la preziosa collaborazione
degli inglesi, che, da parte loro, non erano entusiasti di essere sottoposti
all’autorità dell’ARA. La soluzione fu assicurata da un compromesso.
L’AFSC avrebbe operato in Russia sotto la responsabilità dell’ARA, ma le
unità quacchere anglo-americane avrebbero lavorato in piena autonomia in
alcune aree del paese, nel rispetto degli accordi sottoscritti e, soprattutto,
cercando di caratterizzare le loro attività esclusivamente come attività di
soccorso statunitensi. In questo senso, i rappresentanti dell’AFSC non
ebbero ulteriori difficoltà. Secondo i dirigenti dell’AFSC, i volontari
quaccheri non militavano sotto la bandiera britannica o americana, ma solo
sotto le insegne cristiane e, pertanto, non tenevano ad alcuna rivendicazione
nazionale. 46
Le attività dei quaccheri in Russia furono puntualmente programmate in
un memorandum, 47 nel quale si stabilirono i termini di collaborazione anche
con le altre associazioni presenti e, nonostante le prime difficoltà di intesa
con Hoover, andarono incontro a un notevole successo. Come ricordato
dallo stesso Hoover, malgrado i quaccheri inglesi e americani non avessero
a disposizione grandi somme, le loro capacità d’intervento impressionarono
a tal punto le altre associazioni, che, oltre i centomila dollari forniti loro
dall’ARA, la JDC elargì altri centocinquantamila dollari e l’ARC gliene
fornì ulteriori centomila. L’AFSC, in ogni caso, riuscì a raccogliere le
donazioni anche di altre associazioni americane, che rimasero estranee alle
attività dell’ARA. Tra queste, la Russian Famine Fund di New York, che
raccolse cinquantamila dollari. 48
Administration 1921 (Committees and Orgs-American Relief Admin to Flatblush Assoc. for
Russ), Folder: Minutes.
46
Cfr. FORBES, The Quaker Star under Seven Flags, cit., p. 167.
47
Cfr. il testo di quattro pagine, privo di data, Memorandum on the Future Work of the
Friends’ International Service in the Russian Socialist Federated Republic, in AFSC, Box:
General Administration 1921 (Foreign Service Country Russia – General to Letters), Folder:
Afsc Foreign Service – Russia General.
48
151
Paolo Macrì
Alle unità anglo-britanniche dell’AFSC furono affidati i territori del
distretto di Buzuluk, dove – tra il 1921 e il 1922 – ebbero modo di
impiegare e mettere a frutto la collaborazione con l’ARA, distribuendo
soprattutto capi di vestiario e fornendo assistenza medica. La collaborazione
entrò in crisi quando si inasprirono le critiche della stampa statunitense nei
confronti di alcune strutture, che sostenevano e finanziavano le attività
dell’AFSC nella Russia sovietica. 49 Questa situazione condusse alla rottura
tra l’AFSC e l’ARA, che rifletteva l’allontanamento delle posizioni di
Hoover rispetto a quelle di Wilbur Thomas in merito alla programmazione
della distribuzione e dell’impiego degli aiuti. Rufus Jones, a questo punto,
non riuscì più a mediare tra le diverse posizioni. L’esito fu la stipula di un
nuovo accordo, nell’ottobre del 1922, tra le autorità sovietiche e l’AFSC,
che rese di fatto non operativo l’accordo di Riga. 50
La Federazione russa delle repubbliche socialiste si denominò, nel
dicembre successivo, Unione Sovietica e il governo comunista non volle più
ricevere gli aiuti statunitensi. Per questo, nel novembre del 1922, le autorità
bolsceviche dichiararono cessata l’emergenza della carestia e, pur
ringraziando per gli aiuti ricevuti, invitarono le associazioni straniere a
lasciare il paese. L’ARA avrebbe dismesso le sue attività in Unione
Sovietica nel giugno 1923, ricevendo l’eterna gratitudine del governo e dei
popoli sovietici. La fame non era stata ancora effettivamente sconfitta e, per
questo motivo, malgrado l’ostilità del governo americano, le missioni
quacchere avrebbero continuato a fornire soccorso in Russia sino al 1927.
Cfr. HOOVER, An American Epic, cit., p. 501.
Alcune di queste erano apertamente filo-sovietiche, come i Friends of Soviet Russia. Cfr.
FORBES, The Quaker Star under Seven Flags, cit., p. 169.
50
Cfr. MCFADDEN-GORFINKEL, Constructive Spirit, cit., p. 77.
49
152
Eunomia. Rivista semestrale del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Eunomia 1 n.s. (2012), n. 1, 153-194
e-ISSN 2280-8949
DOI 10.1285/i22808949a1n1p153
http://siba-ese.unisalento.it, © 2012 Università del Salento
Giuliana Iurlano
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo:
l’Amistad e il “misterioso caso della lunga e bassa goletta nera”
Abstract: The schooner Amistad’s unconvincing journey from the Spanish port of Havana, Cuba, with its cargo of 53 Africans destined for slavery in the sugar plantation of
the Caribbean, form one of the most significant stories of the nineteenth century. When a
violent mutiny of the slaves happened, the Africans ordered two Spanish sailors to navigate the ship toward Africa, but they, on the contrary, subverted the route and turned
Amistad toward North America. The Federal Historical Records of the Amistad Case illuminate the complex position of the U.S. government regarding slavery and the international slave trade. Abolitionists recognized that the Amistad affair had the power to cause
an emotional debate about slavery in the United States. It sparked a series of diplomatic
manoeuvres by the Van Buren Administration, prompting the former President John
Quincy Adams to go before the Supreme Court and souring diplomatic relations between
the United States and Spain.
Keywords: Amistad Case; United States-Spain Relations; Slavery.
1. “Dalla materia spagnola non è possibile estrarre la libertà”: i controversi rapporti tra Washington e Madrid
«Catturata la presunta nave pirata. Un gentiluomo, arrivato ieri da Stonington, ci ha informati che la lunga e bassa goletta nera, che aveva provocato così tanto allarme lungo la costa, è stata catturata martedì sera al
largo del faro di Watch Hill e portata a New London. La goletta aveva
fatto la sua comparsa al largo del faro martedì mattina e aveva fatto
sbarcare una scialuppa per rifornirsi d’acqua e di vettovaglie. La notizia
fu comunicata al cutter statunitense di avanscoperta, che – partito alla
sua ricerca – l’abbordò, costringendola ad arrendersi senza opporre resistenza». 1 Con queste parole, il bostoniano «Atlas» avvertiva i suoi letto1
«Boston Daily Atlas», August 29, 1839. Il cutter è un piccolo veliero molto
veloce, utilizzato per servizi di avanscoperta, con 30-40 uomini d’equipaggio e
di solito armato con due piccoli cannoni. Cfr. anche P. WALTON, The Mysterious
Case of the Long, Low, Black Schooner, in «The New England Quarterly», VI,
2, June 1933, pp. 353-361. Sull’ammutinamento dell’Amistad, si vedano anche
Giuliana Iurlano
ri della cattura dell’Amistad, una goletta a due alberi di proprietà spagnola, utilizzata originariamente per il trasporto delle merci, ma poi adibita a nave negriera per il trasferimento illegale di schiavi dall’Africa a
Cuba, al tempo ancora dominio spagnolo.
Il 26 giugno del 1839, l’Amistad aveva imbarcato a L’Avana 56
schiavi mendi, catturati in Sierra Leone e poi acquistati da due mercanti
spagnoli, José Ruiz e Pedro Montes, perché fossero trasferiti nella città
cubana di Puerto Principe. Le durissime condizioni di prigionia in cui
erano costretti nella goletta spinse gli schiavi – capeggiati da Sengbe
Pieh (conosciuto come “Cingue”, “Cinquez” o “Cinqué”) 2 – ad ammutinarsi e a impadronirsi della nave, dopo aver ucciso il capitano e aver
indotto il suo schiavo personale, Antonio, a fare da interprete tra i due
spagnoli e il gruppo mende. Ebbe inizio, così, l’avventura dell’Amistad,
che – invece di dirigersi verso l’Africa, come pretendevano gli insorti –
navigò per lungo tempo lungo le coste americane, all’insaputa degli
schiavi ribelli, finché non fu abbordata dal cutter statunitense e costretta
all’approdo al largo di Long Island. Tutti i mende furono catturati e portati a New Haven nel Connecticut.
L’“affaire Amistad” andò a incunearsi nelle difficili relazioni tra la
Spagna di Isabella II e la giovane repubblica americana, che stava muovendo i primi passi sulla scena internazionale, tra la diffidenza e il timore delle potenze europee. Il caso dell’ammutinamento sulla goletta, tuttavia, non toccava soltanto i nervi scoperti dei complessi rapporti internazionali, ma proponeva anticipatamente – sia all’interno della società
americana, sia nelle diverse sezioni degli Stati Uniti d’America – un teR. GRAYSON, The Amistad, North Mankato, MN, ABDO, 2011; I.F. OSAGIE, The
Amistad Revolt: Memory, Slavery, and the Politics of Identity in the United
States and Sierra Leone, Athens, GA, University of Georgia Press, 2000; S.
DUDLEY GOLD, United States v. Amistad: Slave Ship Mutiny, Terrytown, NY,
Marshall Cavendish, 2007; W.A. OWENS, Black Mutiny, Baltimore, Black Classic Press, 1997; D. HULM, United States v. Amistad: The Question of Slavery in
a Free Country, New York, Rosen Publishing, 2004; A.P. BLAUSTEIN – R.L.
ZANGRANDO, eds., Civil Rights and African Americans: A Documentary History,
Evanston, IL, Simon & Schuster, 1968.
2
Cinqué era nato a Mani, in Dzhopoa, nella cosiddetta “open land” nel territorio
Mendi. La distanza da Mani a Lomboko, un’isola alla foce del fiume Gallinas,
luogo in cui gli africani furono imbarcati per L’Avana, era di “dieci giorni”. Per
altre notizie su di lui, cfr. History of the Amistad Captives: Being a Circumstantial Account of the Capture of the Spanish Schooner Amistad, by the Africans on
Board, [etc.], compiled from authentic sources by J.W. BARBER, New Haven,
CT, E.L. & J.W. Barber, 1840, p. 2.
154
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
ma “caldo” nel percorso di State-building, che avrebbe caratterizzato il
periodo pre-civil war e che sarebbe riapparso in tutta la sua dimensione
economico-politica nel momento in cui si fosse profilata concretamente
la minaccia della secessione. L’Amistad, infatti, sollevava una serie di
questioni di diritto internazionale e di diritto della navigazione, soprattutto commerciale: il trasporto degli schiavi a Cuba era avvenuto su un
battello portoghese, che aveva attraversato le acque della Sierra Leone,
protettorato britannico; di conseguenza, aveva navigato illegalmente in
acque sotto la giurisdizione inglese, che vietava la schiavitù; la restituzione, ai legittimi proprietari (gli schiavisti che avevano acquistato gli
schiavi, o la regina di Spagna che rivendicava la proprietà della nave?)
della “merce” contenuta nella goletta; la pretesa dei due ufficiali che avevano recuperato la goletta dell’applicazione dell’antica regola marinaresca del diritto di salvataggio; ma il caso dell’Amistad sollevava anche
un lacerante problema di principio (erano, gli schiavi africani, una “merce” alla pari di tutte le altre, oppure dovevano essere considerati “uomini
liberi”?), problema che già si era posto Thomas Jefferson nella stesura
della Dichiarazione d’Indipendenza americana. 3
Le relazioni tra la repubblica americana e la Corona spagnola erano
state definite con il trattato di San Lorenzo il 27 ottobre 1795, 4 con il
quale furono sanciti i rapporti di amicizia tra i due paesi, stabiliti i confini tra gli Stati Uniti e le colonie spagnole e, soprattutto, garantiti agli
americani i diritti di navigazione lungo il fiume Mississippi. L’acquisto
della Louisiana nel 1803 aveva, poi, risolto il problema del controllo
della valle percorsa dal “padre delle acque”, 5 principale via di comunicazione verso l’Ovest. L’importanza del Mississippi stava nella stretta
connessione esistente, sin dai tempi dell’indipendenza, tra sicurezza e
prosperità degli Stati Uniti e navigabilità del grande fiume, senza la quale la lealtà dei “men of western waters” sarebbe risultata notevolmente
3
Si veda il passo relativo alla schiavitù contenuto nella stesura originale della
Declaration of Independence, poi cassato dal Congresso, in M. SYLVERS, Il pensiero politico e sociale di Thomas Jefferson. Saggio introduttivo e antologia dei
testi, Manduria, Lacaita, 1993, pp. 168-169.
4
Cfr. Treaty of Friendship, Limits, and Navigation between Spain and the United States, October 27, 1795, in Treaties and Other International Acts of the
United States of America, H. MILLER, ed., Vol. 2, Documents 1-40, 1776-1818,
Washington, Government Printing Office, 1931, disponibile in
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/sp1795.asp.
5
Meschacébé, letteralmente “padre delle acque”, era il nome con cui gli indiani
Natchéz chiamavano il Mississippi, prima dell’arrivo dell’uomo bianco.
155
Giuliana Iurlano
indebolita. 6 Quel legame “vitale” per la sopravvivenza stessa degli Stati
Uniti era stato più volte ribadito, in primis dal presidente Washington e,
poi, da Jefferson e Hamilton – nella loro qualità di segretari di Stato e
del Tesoro – finché anche gli Stati del Nord, fino ad allora contrari al
“Mississippi interest”, non ebbero dato il loro consenso. Il problema,
tuttavia, era più ampio e complesso: l’espansione territoriale statunitense
dipendeva dall’accondiscendenza spagnola e questa, a sua volta, «derivava dall’isolamento della Spagna, oltre che dalla sua debolezza». 7 Ma
proprio la debolezza spagnola avrebbe potuto trasformarsi in uno svantaggio, nel momento in cui una potenza terza avesse rilevato il territorio
ambito dagli Stati Uniti e fosse stata molto meno disponibile della Spagna a trattare sulle richieste americane. Tale possibilità si realizzò puntualmente alla fine dell’anno 1800, «quando la Spagna, ormai ridotta a
satellite dell’impero napoleonico, accettò di trasferire alla Francia il cosiddetto territorio della Louisiana, un’area, questa, dai confini incerti e
indefiniti, ma che includeva senza dubbio alcuno sia il Mississippi, sia la
sua foce». 8 La questione di New Orleans – che rimetteva in gioco il trattato del 1795 – contribuì a deteriorare i rapporti tra i due paesi, soprattutto dopo l’acquisto della Louisiana dai francesi e il tentativo di ottenere le Floride, perseguito sia attraverso colloqui diplomatici con Madrid,
6
Cfr. R.W. TUCKER – D.C. HENDRICKSON, Empire of Liberty: The Statecraft of
Thomas Jefferson, Oxford, Oxford University Press, 1992, p. 95.
7
M. DEL PERO, Libertà e impero. Gli Stati Uniti e il mondo, 1776-2006, RomaBari, Laterza, 2008, p. 80.
8
Ibid., p. 81. La cessione avvenne col trattato di San Ildefonso del 1° ottobre
1800 (cfr. Preliminary and Secret Treaty between the French Republic and His
Catholic Majesty the King of Spain, Concerning the Aggrandizement of His Royal Highness the Infant Duke of Parma in Italy and the Retrocession of Louisiana, October 1, 1800, in http://avalon.law.yale.edu/19th_century/ildefens.asp),
anche se esso prevedeva un periodo di transizione, durante il quale la Spagna
sospese i diritti di deposito a New Orleans, la città in cui gli americani stoccavano a tempo indefinito le loro merci, circa il trenta per cento dei prodotti americani, che scendevano dal Mississippi e dai suoi due affluenti, l’Ohio e il Tennessee. L’importanza della città era chiara. Lo stesso presidente Jefferson – convinto che la decisione di Madrid derivasse dalla Francia – mandò un suo inviato a
Parigi con un messaggio laconico, ma molto preciso: «Se gli Stati Uniti avevano
un nemico al mondo, questi era colui che possedeva la Nouvelle Orleans». In
realtà, la Spagna aveva preso autonomamente la decisione, per mettere in difficoltà i rapporti franco-statunitensi.
156
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
sia con incursioni militari nella regione da parte dell’esercito statunitense. I due volti della politica espansionistica americana – quello diplomatico, voluto dall’allora segretario di Stato John Quincy Adams, e quello
militare, portato avanti dal generale Andrew Jackson, con una dubbia
autorizzazione da parte dell’amministrazione Monroe – s’intrecciarono
saldamente e portarono, di fatto, alla conquista delle due Floride, che la
Spagna non ebbe la forza di mantenere in suo possesso.
L’espansionismo americano non prevedeva – nella concezione di Adams
– una possibile convivenza con colonie di altre potenze europee, per il
semplice fatto che ciò avrebbe costituito una vera e propria “assurdità
fisica, politica e morale”. Di conseguenza, il suo appoggio a quella che
considerava un’azione di preemption da parte di Jackson 9 – che, nel
1818, aveva invaso la Florida spagnola, occupando Pensacola, dopo una
serie di assalti ai confini del territorio da parte dei Seminoles e dei Creeks – veniva giustificato dalla evidente incapacità della Spagna di mantenere l’ordine nella regione; se ciò non fosse accaduto, come la realtà
faceva intravedere, allora essa avrebbe dovuto «cedere agli Stati Uniti
una provincia […] che è in effetti abbandonata, aperta all’occupazione
di ogni nemico, civile o selvaggio, degli Stati Uniti e [che] non ha altro
scopo in terra che quello di creare loro fastidio». 10 L’intervento di Adams – sostiene Mario Del Pero – giunse appena in tempo a salvare politicamente Jackson e a porre anche le premesse del successivo accordo
con la Spagna, formalizzato col Trattato Adams-Onís del 1819 (noto
come il “trattato transcontinentale”), 11 con il quale le due Floride passavano agli Stati Uniti, mentre la Spagna rinunciava a qualsiasi rivendicazione sull’area del nord-ovest fino al Pacifico, pur mantenendo ancora il
controllo sul Texas. La frontiera si spingeva sempre più avanti e raggiungeva, così, il Pacifico, sublimando l’espansionismo della giovane
repubblica, ma anche frenandone la corsa verso il sud-ovest, dove il ri9
Cfr. J.L. GADDIS, Attacco a sorpresa e sicurezza: le strategie degli Stati Uniti,
Milano, Vita e Pensiero, 2005, p. 22.
10
Adams to George W. Erving, November 28, 1818, cit. in S.F. BEMIS, John
Quincy Adams and the Foundations of American Foreign Policy, New York,
Knopf, 1949, p. 327.
11
Cfr. Treaty of Amity, Settlement, and Limits Between the United States of
America and His Catholic Majesty. 1819, in The Federal and State Constitutions Colonial Charters, and Other Organic Laws of the States, Territories, and
Colonies Now or Heretofore Forming the United States of America, Compiled
and Edited Under the Act of Congress of June 30, 1906 by F.N. THORPE, Washington, DC, Government Printing Office, 1909.
157
Giuliana Iurlano
schio maggiore poteva essere quello di portare nell’Unione nuovi Stati
schiavisti, capaci di alterare i già fragili equilibri del Congresso e di rallentare quella che si riteneva l’auspicabile e inevitabile abolizione della
schiavitù.
Il tentativo di Adams di spostare la frontier line verso nord-ovest non
riuscì nemmeno con il fragile compromesso del Missouri del 1820: il
collante politico dell’espansionismo venne meno, trasformandosi in un
ulteriore fattore di divisione e di conflitto. L’indipendenza delle provincie messicane dell’impero spagnolo, dopo dieci anni di sfibrante sforzo
bellico, avallò l’insediamento dei coloni americani nel Texas e, contemporaneamente, mise in crisi ciò che restava dei già precari rapporti con
Madrid. La crisi dell’impero spagnolo – manifestatasi col suo tracollo
nell’America Latina, a seguito dei moti rivoluzionari europei che, negli
anni Venti, incendiarono le “periferie” del mondo – s’intrecciò con le
mire sul continente americano di alcuni paesi europei, desiderosi di “restaurare” monarchie e principi abbattuti dalla rivoluzione francese. La
risposta statunitense partì ancora una volta da Adams, segretario di Stato
durante la presidenza Monroe, a seguito di una proposta britannica di
partnership per sbarrare agli europei la “porta” di accesso alle Americhe: perché accettare un ruolo subalterno e restare legati alla balance of
power del Vecchio Mondo, rinunciando all’acquisizione di nuovi territori, quando gli Stati Uniti avevano già ciò che gli inglesi promettevano,
senza essere obbligati a fare significative rinunce? Il lungo messaggio
presidenziale al Congresso riprendeva l’incisiva opinione di Adams e
affermava quei principi basilari che, da quel momento in poi, sarebbero
stati conosciuti come la Monroe Doctrine e che avrebbero sostanzialmente configurato le relazioni internazionali tra i due emisferi.
2. Il “caso Amistad” e gli accordi internazionali sul commercio degli
schiavi
«Ma ciò che ora assorbe gran parte del mio tempo e tutti i miei buoni
sentimenti è il caso dei 53 negri africani presi al largo di Montauk Point
dal luogotenente Gedney sul vascello degli Stati Uniti che sorvegliava la
costa, e portati nel porto di New London». 12 Così Adams, nelle sue memorie, ricordava il “caso Amistad” e i problemi giuridici e internazionali
12
Memoirs of John Quincy Adams, Comprising Portions of His Diary from
1795-1848, CH.F. ADAMS, ed., vol. X, Philadelphia, J.B. Lippincott & Co., 1876,
p. 133.
158
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
che esso sollevava. La goletta spagnola, infatti, era l’esempio eclatante
del gap tra teoria e pratica, tra dichiarazioni di principio e realtà concreta, che, dal 1815 in poi, aveva caratterizzato il commercio degli schiavi. 13 Al Congresso di Vienna, infatti, le potenze europee – pur convenendo in linea di principio sul contrasto esistente con lo ius gentium e
con i valori condivisi nel Concerto post-rivoluzionario 14 – non avevano
affrontato adeguatamente il problema dei mezzi con cui abolire effettivamente i fenomeni della schiavitù e della tratta, che, in ogni caso, venivano inscritti nel più ampio contesto degli interessi economici dei singoli Stati, lasciando pertanto a questi ultimi la facoltà di accordarsi reciprocamente sulla questione, difficilmente inquadrabile nella cornice del
“delitto internazionale” o dell’“atto di pirateria”, come proposto dalla
Gran Bretagna nel Congresso di Verona del 1822. 15 In tale contesto, nel
1817 fu firmato un trattato anglo-spagnolo, che proibiva l’acquisto di
neri in Africa e stabiliva che, a partire dal maggio del 1820, quelli portati nelle colonie spagnole avrebbero ottenuto la libertà. Tuttavia, l’art. 7
di tale trattato presentava un importante difetto, in quanto, da una parte,
13
La questione della tratta e del commercio degli schiavi fu affrontata nel Congresso di Vienna e, in particolare, nell’Atto Finale, firmato dai plenipotenziari, il
9 giugno 1815, al punto 15, art. 118. Su tale argomento, si veda G. PIETROSTEFANI, La tratta atlantica. Genocidio e sortilegio, Milano, Jaca Book, 2000, pp.
211-214.
14
«[…] Le commerce connu sous le nom de “traite des nègres d’Afrique” a été
envisagé par les hommes justes et éclairés de tous les tems, comme répugnant
aux principes d’humanité et de morale universelle». Declaration of the Powers
Regarding the Abolition of the Slave Trade, in Final Act of the Congress of Vienna (1815), in TH. C. HANSARD, The Parliamentary Debates from the Year
1803 to the Present Time, vol. 32, 1 February to 6 March 1816, London, T.C.
Hansard, 1816, pp. 71-72.
15
Cfr. P. ROBERTS-MILLER, John Quincy Adams’s Amistad Argument: The
Problem of Outrage; Or, the Contraints of Decorum, in «Rhetoric Society Quarterly», XXXII, 2, Spring 2002, p. 6. La proposta inglese prevedeva, di conseguenza, la possibilità di visitare le navi sospette, cosa non gradita dalla Francia,
che si dissociò. In ogni modo, Inghilterra e Francia firmarono un accordo in tal
senso nel 1831, ma la vigilanza sulle navi per impedire il commercio degli
schiavi sui mari fu introdotta soltanto con il Trattato di Londra del 1841, tra Inghilterra, Austria, Prussia e Russia. In particolare, oltre all’abolizione della tratta
degli schiavi in Africa, nel trattato si prevedeva che ognuno dei contraenti concedesse agli altri il diritto reciproco di visita a bordo dei vascelli sospetti di tratta
nelle acque africane, escluso il Mediterraneo, e il diritto di giudicare i comandanti e gli equipaggi delle navi, adibite al trasporto degli schiavi e catturate dai
funzionari delle parti stesse, qualunque fosse stata la nazionalità della nave.
159
Giuliana Iurlano
assicurava la libertà definitiva agli emancipados, ma, dall’altra, prolungava in realtà la schiavitù sull’isola. 16 Infatti, i neri sfuggiti alla cattura
da parte degli schiavisti al largo della costa cubana avrebbero dovuto
ricevere un certificato di emancipazione da parte di una commissione ad
hoc, insieme a un lavoro da 5 a 7 anni come servi o lavoratori liberi, con
la garanzia di godere della libertà alla fine di quel periodo. In realtà,
proprio i funzionari governativi dell’isola “vendevano” gli emancipados
ai proprietari di piantagioni, i quali li sottoponevano a condizioni lavorative durissime, sostituendoli spesso alla manodopera schiavile deceduta
o fuggita. Come ricorda Howard Jones, «il sistema di emancipazione si
trasformò in una fiorente attività per i proprietari di piantagioni, […]
fornendo di fatto un’altra fonte di schiavi sull’isola». 17 A nulla servirono
le proteste inglesi nei confronti di Madrid, che pure richiese – in maniera blanda, però, poiché non intendeva in alcun modo rinunciare ai proventi del commercio dello zucchero cubano – l’applicazione del provvedimento contenuto nel trattato: i piantatori cubani, infatti, anziché tenere
un regolare registro degli emancipati, ne falsificavano le informazioni,
ricavando profitti maggiori proprio nella vendita degli emancipados come schiavi alla fine del loro periodo lavorativo. 18
Anche gli Stati Uniti, naturalmente, non rispettarono la legge antitratta: di conseguenza, dopo la seconda guerra contro l’Inghilterra, il
traffico schiavistico aumentò notevolmente. Del resto, agli incrociatori
inglesi non era permesso perquisire le navi americane, né gli Stati Uniti
potevano impegnare le loro navi nella sorveglianza delle coste africane
per impedire il traffico degli schiavi. A ciò s’aggiungeva il fatto che,
ogni qualvolta i controlli americani si facevano più stringenti, gli schiavisti tendevano a utilizzare i porti brasiliani e cubani, in cui la tratta non
era proibita, come mercati, 19 per trasportare, poi, la loro “merce” lungo
le coste meridionali americane o, addirittura, nella foce del Mississippi,
presso i numerosi porti e territori di frontiera dove il contrabbando di
16
Cfr. H. JONES, Mutiny on the Amistad, New York, Oxford University Press,
1997, p. 18.
17
Ibid.
18
L’accordo anglo-spagnolo fu rinnovato nel 1835, ma i mercanti di schiavi
trovarono comunque il modo per aggirare la legge, arrivando addirittura a sostituire, sulle navi, la bandiera spagnola con quella portoghese o americana; a ciò
s’aggiungeva il grave fatto che le autorità cubane accettassero illegalmente del
denaro per ignorare l’importazione di schiavi dall’Africa.
19
Il commercio internazionale continuò anche dopo che la regina Isabella di
Spagna ebbe emanato un decreto regio per proibirlo.
160
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
schiavi poteva essere agevolmente praticato. Insomma, pur “rispettando” le norme che proibivano il commercio “internazionale” di schiavi,
sia la Spagna (con le sue colonie), che gli Stati Uniti trovarono una sorta
di compromesso nel non vietare tale commercio a livello intranazionale. 20 In particolare, durante la sosta a Cuba, i mercanti spagnoli
esibivano documenti falsi da cui risultava che i neri erano schiavi nati
nell’isola, cioè negros ladinos, e non invece negros bozales, catturati in
Africa e trasferiti illegalmente sulle navi. 21 In ogni caso, la falsa identità
loro attribuita non poteva essere in alcun modo rifiutata o contestata, per
il semplice fatto che essi non parlavano affatto lo spagnolo. 22
Il governo inglese era stato informato dettagliatamente della situazione in cui versavano gli africani a Cuba da David Turnbull, un aboli20
Già i delegati alla Convenzione Costituzionale nel 1787 avevano dibattuto
l’argomento della schiavitù, ma alla fine tutti avevano concordato sul fatto che
gli Stati Uniti non si sarebbero più impegnati nel commercio transatlantico di
schiavi a partire dal 1808. Effettivamente, da allora nessun vascello americano si
recò in Africa in cerca di “merce umana”; tuttavia, continuò a esserci un commercio interno di schiavi o lungo la costa tra i vari porti americani, come si evince dai documenti federali, custoditi presso gli U.S. National Archives and
Records Administration (NARA); particolarmente utili sono i records relativi
alle carte d’imbarco sulle navi di “neri, mulatti e persone di colore”, sulle quali
veniva annotato nome, età, sesso e proprietario dello schiavo. Cfr. Slave Manifests Document the Transportation of Slaves throughout the Southern Ports, in
Documents
from
the
Southeast
Region
–
Atlanta,
in
http://www.archives.gov/northeast/education/slavery/slave-trade.html. Si veda
anche D.B. DAVIS, Inhuman Bondage: The Rise and Fall of Slavery in the New
World, Oxford, Oxford University Press, 2006.
21
Al di là della differente terminologia, il vero problema era di natura giuridica:
esisteva, infatti, una distinzione legale tra le vittime di rapimento (catturate in
Africa) e gli schiavi veri e propri (individui nati già nella condizione di schiavitù
a Cuba o negli Stati Uniti). Ora, se tutti gli schiavi erano vittime di rapimento, la
situazione cambiava rispetto al luogo della cattura: i nati schiavi potevano essere
trasportati da un luogo all’altro, perché appartenevano dalla nascita al proprietario, mentre gli africani – essendo stati rapiti nel loro luogo d’origine e resi schiavi dopo – erano soggetti alle norme internazionali, che vietavano il commercio
schiavile. Sul traffico di schiavi tra Spagna e Cuba, cfr. A.F. CORWIN, Spain and
the Abolition of Slavery in Cuba, 1817-1886, Austin, University of Texas, 1967;
D.R. MURRAY, Odious Commerce: Britain, Spain and the Abolition of the Cuban Slave Trade, Cambridge, Cambridge University Press, 1980.
22
Cfr. H. THOMAS, The Slave Trade: The Story of the Atlantic Slave Trade,
1440-1870, New York, Simon & Schuster, 1997, pp. 637-648; JONES, Mutiny on
the Amistad, cit., pp. 16-17.
161
Giuliana Iurlano
zionista britannico divenuto console a L’Avana alla fine del 1840; nel
diario dei suoi viaggi ai Caraibi, descrisse i due recinti per schiavi costruiti dagli spagnoli allo scopo di «ricevere e vendere gli africani appena importati». 23 Tali recinti – continuava Turnbull – «costituiva[no] un
virtuale monumento spagnolo al fallimento britannico di metter fine al
commercio di schiavi africani [ed erano] un “sistema di rapimento ben
organizzato”». 24
L’Amistad non fu il primo caso di avvistamento di vascelli stranieri
che trasportavano illegalmente schiavi, ma probabilmente fu uno dei pochi che impresse un segno profondo, anche a livello giuridico, al problema della schiavitù. 25 In effetti, un caso analogo si era verificato nel
1818, ma aveva riguardato il trasporto illegale di schiavi su navi americane per conto di proprietari spagnoli; infatti, da quando il dominio coloniale spagnolo era diminuito significativamente nel Nuovo Mondo,
per gli spagnoli era diventato più conveniente affidare il proprio “carico
umano” ai vascelli statunitensi nel percorso da Cuba alla Florida (divenuta un «centro di scambi commerciali di schiavi sin dall’inizio del
1810»), 26 anche perché gli Stati Uniti avevano organizzato gli squadroni
anti-pirateria nel Golfo del Messico e, dunque, erano preparati a difendere i propri mercantili, evitando che si trasformassero in bottino di azioni piratesche violente. Quando il generale Jackson conquistò Pensacola, i capitani di tre navi – la Merino, la Constitution e la Louisa – che
trasportavano schiavi ed altre merci da L’Avana alla capitale della Florida spagnola, anche se ufficialmente dirette a Mobile (la prima) e a
23
D. TURNBULL, Travels in the West: Cuba, with Notice of Porto Rico and the
Slave Trade, London, Longman-Orme-Brown-Green-Longmans, 1840, p. 57.
24
Ibid., pp. 59-61.
25
Molti casi furono portati a giudizio davanti alle Corti Distrettuali americane,
come, per esempio, U.S. vs Ship Flora, 1807; Slaves of the Syrena, 1820; Juan
Madraso vs Slaves & cargo of Isabellita, 1821 (U.S. District Court for the
Southern District of Georgia, Savannah); U.S. vs Schooner Orion, 1823; U.S. vs
W. Culler, 1821 (U.S. District Court for the Southern District of Alabama, Mobile); The Carolina (Sloop Lucy) vs Slave Sampson, 1814 (U.S. District Court
for the Eastern District of North Carolina, Elizabeth City), in NARA, SOUTHEAST
REGION, ATLANTA, The African Slave Trade: A Selection of Cases from the Records of the U.S. District Courts in the States of Alabama, Georgia, North Carolina, and South Carolina, in http://www.archives.gov/southeast/findingaids/african-slave-trade.pdf.
26
F. STAFFORD, Illegal Importations: Enforcement of the Slave Trade Laws
along the Florida Coast, 1810-1828, in «Florida Historical Quarterly», XLVI, 2,
October 1967, p. 125.
162
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
New Orleans (le altre due), “deviarono” dalla rotta prevista, certamente
in modo non casuale e che costituiva di fatto un’esplicita violazione dei
trattati internazionali e delle leggi americane. 27 Dopo che la Corte Distrettuale dell’Alabama aveva dato torto ai proprietari dei vascelli, i loro
difensori avevano fatto appello alla Suprema Corte degli Stati Uniti contro la sentenza. 28 Ad ogni modo, i giornali dell’epoca diedero parecchio
risalto alla “strana” navigazione, quasi non avesse una meta,
dell’Amistad e, poi, alla novità costituita dall’ammutinamento degli
schiavi, che si erano impadroniti con la forza della nave – uccidendo il
capitano e tre membri dell’equipaggio – che essi cercavano disperatamente di far dirigere verso l’Africa. Per questo, come si legge nella
«New London Gazette», gli schiavi avevano risparmiato la vita a un
passeggero, Pedro Montes, e al proprietario del carico, Jose Ruiz, nella
speranza che la goletta fosse da loro indirizzata verso le coste africane.
Ma Montes – contando sul fatto che gli schiavi non s’intendevano affatto di navigazione – aveva cercato più volte di cambiare direzione, finché
gli ammutinati, resisi conto della situazione, non lo avevano costretto a
seguire il corso del sole (unico punto di riferimento che conoscevano).
Lo spagnolo, tuttavia, ogni notte, aveva volutamente invertito la rotta.
Di conseguenza, chiunque, da terra, avesse avvistato quella goletta che
sembrava non avere una meta precisa, ma che zigzagava e girovagava
lungo le coste americane, avrebbe rilevato una situazione sicuramente
“strana” e sarebbe stato indotto a pensare che si trattasse di una nave pirata in attesa di una preda. 29
Una volta che la goletta fu costretta ad attraccare, i due spagnoli e gli
schiavi sopravvissuti – 39 maschi adulti e 4 bambini – furono fatti scendere a terra e il capitano Gedney li consegnò al funzionario di polizia di
New Haven, che informò immediatamente Andrew T. Judson, giudice
del tribunale di prima istanza, dell’accaduto. La prima udienza fu fissata
addirittura a bordo della Washington; in tale occasione, i due spagnoli
indicarono Cinqué come il capo della rivolta e come il principale responsabile della morte dei due uomini dell’equipaggio. Poiché non par27
Cfr. HOUSE COMMITTEE ON THE SLAVE TRADE, Letter from the Secretary of the
Treasury Transmitting the Information Required by a Resolution of the House of
Representatives of the 4th Instant, 19 th Cong., 1st sess., April 20, 1826, pp. 4646.
28
Cfr. U.S. vs Schooners Constitution, Merino, Louisa and 84 Slaves, 1818, in
NARA, SOUTHEAST REGION, ATLANTA, The African Slave Trade, cit.
29
Cfr. “The Suspicious Looking Schooner” Captured and Brought in This Port,
in «New London Gazette», August 26th, 1839.
163
Giuliana Iurlano
lava né comprendeva l’inglese e lo spagnolo, egli non ebbe alcuna possibilità di difendersi dalle accuse che gli erano state rivolte. 30 Trasferiti a
New Haven, i mende rimasero in cella per ben 18 mesi, durante i quali
potevano essere guardati da “spettatori” esterni dietro pagamento di 12,5
cents. 31
3. Il movimento abolizionista e il “caso Amistad”
Alla fine degli anni Trenta, la società americana era profondamente attraversata da un forte sentimento di revival evangelico e da un diffuso
movimento di riforma, che faceva appello ai valori cristiani e alla condotta morale del common man. Il secondo Great Awakening si coniugò
quasi naturalmente con la causa abolizionista, sostenuta all’epoca soltanto da pochi “immediatisti”, da coloro, cioè, che volevano l’immediata
emancipazione degli schiavi senza il versamento di alcun risarcimento ai
proprietari. 32 Si trattava, in genere, di gruppi cristiani, che poco valutavano le conseguenze politiche e sociali di un tale intervento, ma che insistevano soprattutto sulla violazione dei più sacri principi della civiltà
cristiana attuata dalla persistenza di quel peccato gravissimo costituito
dalla schiavitù. Molti altri gruppi, invece, tendevano a “convertire” gli
schiavisti del Sud, un percorso, questo, sicuramente molto lento e che
non avrebbe dato subito risposte risolutive al grave problema; altri ancora – pur provando sinceri sentimenti anti-schiavisti – erano convinti che
la “peculiare istituzione” sarebbe scomparsa in maniera quasi naturale
30
La causa presso la Corte Federale fu inizialmente registrata come United States v. Cinque, et al., proprio perché – a seguito della richiesta di condanna per
omicidio e pirateria, pronunciata dal pubblico ministero del Connecticut – Cinqué fu ritenuto il capo della rivolta. In seguito, le accuse penali caddero, ma il
ruolo cruciale di Cinqué nella vicenda non venne meno. Cfr. U.S. CIRCUIT
COURT, DISTRICT OF CONNECTICUT, DOCKET BOOK, 1815-1843, Records of the
U.S. District and Cicuit Courts for the District of Connecticut: Documents Relating to the Various Cases Involving the Spanish Schooner Amistad, National
Archives Microfilm Pubblication M1753, Records of District Courts of the
United States, Record Group (RG) 21, National Archives and Records Administration.
31
Cfr. D.B. DAVIS – S. MINTZ, eds., The Boisterous Sea of Liberty: A Documentary History of America from Discovery through the Civil War, New York, Oxford U.P., 1998, p. 420.
32
Cfr. G. SORIN, Abolitionism: A New Perspective, New York, Praeger, 1972, p.
17; L.J. FRIEDMAN, Gregarious Saints: Self and Community in American Abolitionism, 1830-1870, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, p. 18.
164
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
dal contesto americano. Nell’ampio ventaglio di posizioni differenti, una
cosa accomunava i vari gruppi abolizionisti: nessuno di loro era ancora
in grado di formulare un piano per il riassetto economico, sociale e politico del paese all’indomani dell’eventuale liberazione degli schiavi. In
ogni caso, alla fine dell’età jacksoniana, il movimento sembrava essere
in una fase di stallo, almeno fino a quando l’Amistad non entrò di prepotenza a ridare fiato a coloro che si battevano contro la “sordida natura
della schiavitù”. 33
L’occasione per portare il caso dell’Amistad a conoscenza di alcuni
membri del Congresso si verificò alla fine del 1840, quando John
Quincy Adams fu informato in maniera dettagliata del sistema esistente
a Cuba da un residente nell’isola, Charles Butler, il quale mise in evidenza la complicità dei funzionari e del governo cubano nell’avallare le
dichiarazioni false fornite dagli schiavisti sull’identità e la provenienza
degli africani. 34 Di fronte a una tale situazione – resa, tra l’altro, ancora
più confusa per le implicazioni di natura internazionale che il traffico
illegale di schiavi comportava nelle relazioni anglo-ispaniche 35 – gli abolizionisti sposarono la causa dell’Amistad, incoraggiati in ciò anche
dal fatto che Adams volle coinvolgere nella difesa degli africani anche
Roger Baldwin, un giovane avvocato abolizionista. Il caso dello shooner
spagnolo, infatti, avrebbe potuto riportare alla ribalta la delicata questione della schiavitù, fino a quel momento affrontata in maniera diversa nei
vari Stati americani settentrionali. 36
33
JONES, Mutiny on the Amistad, cit., p. 35.
Cfr. Butler to John Quincy Adams, December 25, 1840, in ADAMS FAMILY
PAPERS, Massachusetts Historical Society, Boston, MA, cit. in JONES, Mutiny on
the Amistad, cit., p. 22.
35
La preoccupazione spagnola era determinata dal fatto che si sospettava che la
Gran Bretagna, pur di valorizzare i propri domini asiatici, stesse tentando di interrompere il commercio delle Indie occidentali, approfittando anche della turbolenta situazione politica interna della Spagna, esacerbata dai continui movimenti di rivolta e dalle risposte repressive del governo. In questo senso, la schiavitù avrebbe potuto costituire un pretesto per l’interferenza inglese nei Caraibi.
Su tale argomento, cfr. Aaron Vail, American Minister to Spain, to Secretary of
State, January 15, 1841, in U.S. DEPARTMENT OF STATE, Dispatches from U.S.
Ministers to Spain, 1792-1906, National Archives, Washington, DC.; MURRAY,
Odious Commerce, cit., pp. 113, 286; J.M. CALLAHAN, Cuba and International
Relations: A Historical Study in American Diplomacy, Baltimore, Johns Hopkins U.P., 1899, pp. 171-172.
36
Il problema si poneva soprattutto per gli Stati a nord del Maryland: alcuni di
essi, infatti, come il Massachusetts, il Vermont e il New Hampshire, avevano
34
165
Giuliana Iurlano
In verità, il primo passo in tal senso lo aveva fatto E. W. Chester, un
giovane avvocato del Connecticut, che aveva scritto una lettera
all’«Emancipator», l’organo ufficiale dell’American Antislavery
Society, in cui sosteneva che «il colore non [poteva] alterare i diritti o le
responsabilità di un imputato». 37 Nel caso degli africani dell’Amistad,
dunque, essi avrebbero dovuto ricevere lo stesso trattamento giudiziario
di qualunque altra persona, indipendentemente dal colore della loro pelle; in tal modo, il movimento abolizionista – sostenendo che il diritto
naturale alla libertà non era collegato né alla whiteness, né alla blackness, ma alla natura stessa degli individui – avrebbe potuto sferrare un
colpo decisivo alla schiavitù e, di conseguenza, anche al pregiudizio
razziale.
Lo stesso Chester aveva dato vita all’Amistad Committee, insieme al
rev. Joshua Easton (un abolizionista nero), Joshua Leavitt (editor
dell’«Emancipator»), Roger Sherman Baldwin, Simeon S. Jocelyn (un
pastore bianco di una chiesa nera di New York) e Lewis Tappan, con lo
scopo di raccogliere fondi per la difesa degli africani e per l’eventuale
cauzione da versare per il loro rilascio, oltre che per cercare un interprete in grado di tradurre dal mende all’inglese. Il Comitato, inoltre, aveva
lanciato la campagna per la difesa degli africani dell’Amistad, pubblicato un Appello agli amici della libertà 38 e inviato una serie di lettere alle
principali personalità politiche dell’epoca, compreso il presidente Martin
Van Buren, con le quali si perorava la causa degli schiavi neri
dell’Amistad. La strategia del movimento, però, era stata opera soprattutto di Dwight P. Janes (probabilmente un funzionario dell’ufficio doadottato, tra il 1777 e il 1804, una serie di misure legali atte ad abolire abbastanza velocemente la schiavitù; altri, invece, come la Pennsylvania, il New Jersey,
il New York, il Connecticut e il Rhode Island, avevano preferito seguire una legislazione che eliminasse gradualmente l’istituzione della schiavitù. Su tale
questione, cfr. D. MENSCHEL, Abolition Without Deliverance: The Law of Connecticut Slavery, 1784-1848, in «The Yale Law Journal», CXI, 183, Sept. 24,
2001, pp. 183-222.
37
E.W. Chester to Editor, in «Emancipator», Sept. 26, 1839, p. 87. Il corsivo è
nel testo.
38
Il testo dell’Appeal to the Friends of Liberty – firmato da Jocelyn, Leavitt e
Tappan – è in The Amistad Revolt: Struggle for Freedom, una pubblicazione
dell’Amistad Committee del febbraio 1993, curata dal suo presidente Alfred L.
Marder. Il 26 settembre del 1992 era stata scoperta una statua di bronzo, creata
da Ed Hamilton, che rappresentava Cinqué e che era stata collocata di fronte alla
City Hall di New Haven, nel punto esatto in cui i mende della Sierra Leone erano stati imprigionati.
166
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
ganale), il quale – dopo aver presenziato all’udienza tenuta a bordo della
USS Washington – aveva informato gli altri abolizionisti che, per ammissione di José Ruiz, nessuno dei prigionieri era legalmente uno schiavo di proprietà dei due mercanti spagnoli, 39 né tantomeno essi potevano
essere sudditi spagnoli, in quanto non erano stati abbastanza a lungo a
L’Avana per risultarvi domiciliati e non erano nemmeno in grado di parlare lo spagnolo. Fu, dunque, proprio Janes a richiamare l’attenzione del
movimento anche sull’illegalità procedurale con cui il caso Amistad stava per essere affrontato sul piano giudiziario, e a sollecitare l’intervento
legale di Baldwin: «Probabilmente sto sopravvalutando l’importanza di
questo caso – scrisse a Leavitt – ma tutti gli abolizionisti qui la pensano
come me». 40
L’Amistad Committee, insieme al movimento abolizionista di New
York – guidato da Lewis Tappan, un importante esponente
dell’American Anti-Slavery Society 41 – si fece promotore di un acceso
dibattito nazionale sul problema della schiavitù, sul cui caso – si pensava – avrebbe dovuto pronunciarsi un tribunale federale. La costituzione
di un collegio di difesa di alto profilo – composto da Roger Baldwin,
Seth Staples e Theodore Sedgwick – fece talmente scalpore che il procuratore distrettuale lo definì un “army of counsel”. 42 Esso aveva il compito di dare sostanza giuridica all’azione del movimento, volta a rinvenire
39
Cfr. Janes to Rev. Joshua Leavitt, Aug. 30, 1839, in AMERICAN MISSIONARY
ASSOCIATION PAPERS, Box 197, “Sierra Leone” Folder, Amistad Research Center [d’ora in avanti ARC], New Orleans, LA; Janes to Roger S. Baldwin, Aug.
30, 1839, ibid.; Lewis Tappan to Baldwin, Nov. 11, 1839, in BALDWIN FAMILY
PAPERS, Box 35, Sterling Memorial Library, Yale University, New Haven, CT;
Testimony of Sullivan Haley and Dwight Janes Concerning Remarks of Ruiz,
Nov. 19, 1839, in U.S. DIST. COURT RECORDS FOR CONN., Federal Archives and
Records Center, Waltham, MA. Sulla testimonianza di Janes, cfr. anche BARBER, History of the Amistad Captives, cit., p. 20.
40
Cit. in JONES, Mutiny on the Amistad, cit., p. 35.
41
Cfr. Letter from Lewis Tappan (Sept. 9, 1839), Letters & Diary Entries, in
Famous
American
Trials,
1839-1840,
http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/amistad/amistd.htm.
42
William S. Holabird to Henry D. Gilpin, Sept. 6, 1839, in Letters Received
from U.S. District Attorneys, Marshals, and Clerks of Court, 1801-1898, Records of the Solicitor of the Treasury, RG 206, in Appellate Case File No. 2161:
United States v. Amistad, 40 U.S. 518 (15 Peters 518), Decided March 9, 1841,
and Related Lower Court and Department of Justice Records, National Archives
Microfilm Publication M2012, General Records of the Department of Justice,
RG 60, NARA.
167
Giuliana Iurlano
documenti, vecchi statuti, trattati o leggi che potessero insinuare il dubbio (“to get a peg to hang a doubt upon”) circa la legalità della richiesta
di restituzione degli schiavi avanzata dai proprietari spagnoli. 43 Si trattava, in realtà, anche di intervenire sull’opinione pubblica del tempo,
costretta spesso a leggere sulla stampa informazioni inesatte o addirittura travisate sul caso dell’Amistad, insieme alla descrizione dei negri come «grassi e pigri», dediti soltanto «a mangiare e a rubare». 44 In tale
contesto, rientrava anche l’attribuzione a Cinqué di una presunta responsabilità maggiore nell’ammutinamento, di un indiscusso ruolo da protagonista, 45 evidenziato nelle cronache giornalistiche del tempo: «Il suo
aspetto, per essere quello di un nativo africano, è particolarmente intelligente e presenta una determinazione e una freddezza non comuni, con
una compostezza propria di vero coraggio, e niente che lo indichi come
un uomo pericoloso. […] I suoi sentimenti morali e le sue facoltà intellettuali predominano considerevolmente sui suoi istinti animaleschi. Si
dice che […] abbia ucciso il capitano e i membri dell’equipaggio con le
sue stesse mani, tagliando loro la gola. Ha anche attentato parecchie volte alla vita del signor Montes, e le spalle di alcuni poveri negri sono coperte di cicatrici causate dai colpi della sua frusta per sottometterli». 46
43
Cfr. The Case of the Captured Negroes, in «New York Morning Herald»,
September 9, 1839, The Gilder Lehrman Center for the Studt of Slavery, Resistance & Abolition, Yale University.
44
Cfr. ibid. Sulla stampa comparvero anche articoli o lettere di forte critica nei
confronti del movimento abolizionista, colpevole – con i suoi ipocriti ed insidiosi appelli alle simpatie del pubblico – di aver sfavorito la causa dei neri. Cfr. The
Captured Africans, in «New York Morning Herald», September 18, 1839, p. 2.
45
In alcuni articoli, Cinqué era definito come un “African hero”. Cfr. On Cinques, in «The Colored American», October 19, 1839. Sulla sua figura esiste una
vasta e spesso romanzata letteratura; si veda, in particolare, A. ABRAHAM, Sengbe Pieh: A Neglected Hero?, in «Journal of the Historical Society of Sierra Leone», II, 2, 1978, pp. 22-30; ID., Sengbe Pieh, in Dictionary of African Biography, vol. 2, Algonac, MI, Reference Publications, 1979, pp. 141-144.
46
U.S. Brig Washington, New London, Tuesday, 12 o’clock, in «New London
Gazette», Aug. 26th, 1839. Lo stesso reporter, autore dell’articolo, avrebbe poi
descritto Cinqué come «un negro che sarebbe stato valutato, all’asta di New Orleans, almeno 1500 dollari». Ibid. Su Cinqué, dopo la liberazione e il suo ritorno
in Africa, si diffuse la voce che fosse egli stesso implicato nel traffico degli
schiavi, notizia, però, smentita con fermezza dallo storico Howard Jones. Cfr. H.
JONES, Cinqué of the Amistad a Slave Trader? Perpetuating a Myth, in «The
Journal of American History», LXXXVII, 3, December 2000, pp. 923-939; ma
168
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
Del resto, a comprovare la fama di Cinqué stava anche il fatto che,
quando il procuratore distrettuale del Connecticut chiese la condanna
degli africani per il reato di omicidio e di pirateria, il caso fu iscritto a
ruolo nella Corte federale come United States v. Cinque, et al., e sebbene l’imputazione penale venisse alla fine respinta, «l’intestazione della
causa – con cui si ribadiva il ruolo critico di Cinqué – mantenne la sua
caratteristica distintiva anche nel prosieguo del procedimento giudiziario
relativo all’Amistad e agli schiavi a bordo di essa». 47
anche P. FINKELMAN, On Cinqué and the Historians, in «The Journal of American History», LXXXVII, 3, December 2000, pp. 940-946.
47
B.A. RAGSDALE, “Incited by the Love of Liberty”. The Amistad Captives and
the Federal Courts, in «Prologue Magazine», XXXV, 1, Spring 2003, Part. 1.
169
Giuliana Iurlano
Contemporaneamente alla battaglia giornalistica, il Comitato sollecitò Baldwin a presentare – se fosse stato necessario – una richiesta di habeas corpus per i prigionieri africani, affinché fossero rilasciati prima
che l’amministrazione Van Buren, in ottemperanza a quanto previsto dal
Trattato di Pinckney del 1795, ne disponesse la restituzione al governo
spagnolo. Non si trattava di un’ipotesi peregrina, tenuto conto del fatto
che agli abolizionisti erano giunti parecchi rumors sulle intenzioni della
Corona spagnola di insistere nella richiesta di riavere gli schiavi e sulla
170
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
probabile risposta positiva della Casa Bianca. 48 Lo stesso John Quincy
Adams si rifiutava di credere alla possibilità che i mende potessero subire anche la beffa di essere giudicati da un tribunale di rapitori di schiavi. 49 Di conseguenza, la strategia del movimento abolizionista fu diretta
a spostare la decisione dalla mera discrezionalità dell’Esecutivo ai tribunali, da sempre chiamati a garantire i diritti civili. In tal senso, va letta la
lettera inviata al presidente Van Buren da Staples e Sedgwick, nella quale essi sollevavano forti obiezioni sull’interpretazione del trattato ispano-statunitense, anche alla luce della proclamazione dell’illegalità del
commercio schiavile da parte di Madrid; dunque, nessuna legge internazionale avrebbe potuto costringere il presidente americano a cedere a
una richiesta spagnola formalmente e sostanzialmente illegale, così come illegale era la pretesa di Ruiz e Montes di riavere la loro “proprietà”,
anch’essa illegalmente importata a Cuba. Insomma, la prova del fatto
che tutto aveva avuto origine dalla cattura in Africa di individui nati liberi e trasformati in schiavi stava proprio nell’esercizio, da parte di costoro, del sacrosanto diritto all’autodifesa nei confronti di chi li aveva
strappati al loro villaggio e costretti in catene. 50 Scrive Howard Jones:
48
Cfr. JONES, Mutiny on the Amistad, cit., pp. 44-45. L’art. 8 del Trattato di
Pinckney stabiliva che, se un vascello della nazione firmataria fosse entrato nel
porto di un’altra «through stress of weather, pursuit of pirates or enemies, or
any other urgent necessity, that ship should receive good treatment, help, protection, and provisions at reasonable rates. [...] It shall no ways be hindered from
returning out of the said ports». L’art. 9 dello stesso Trattato affermava che «all
ships and merchandise, [...] with shall be rescued out of the hands of any pirates
or robbers in high seas [sarebbero stati consegnati agli ufficiali portuali] to be
taken care of, and restored entire» ai proprietari. Infine, l’art. 10 dichiarava che
qualsiasi vascello «wrecked, foundered, or otherwise damaged [sulle coste o in
acque territoriali di un altro paese avrebbe dovuto ricevere] the same assistance
which would be due to the inhabitants of the country where the damage happens, and shall pay the same charges and dues only as the said inhabitants
would be subject to pay in a like case». Il testo completo del Trattato
(confermato dall’Adams-Onis Treaty del 1819) è reperibile in THE AVALON PROJECT, DOCUMENTS IN LAW, HISTORY AND DIPLOMACY, Yale Law School, Lillian
Goldman Law Library, http://avalon.law.yale.edu/18th_century/sp1795.asp. Il
corsivo è mio.
49
Cfr. John Quincy Adams to William Jay, Sept. 17, 1839, in ADAMS FAMILY
PAPERS, Massachusetts Historical Society, Boston, MA, cit. in JONES, Mutiny on
the Amistad, cit., p. 45.
50
Cfr. Staples and Sedgwick to President of U.S., Sept. 13, 1839, in H. Exec.
Doc. 185, pp. 63-64. Di diverso parere il segretario di Stato, John Forsyth. Cfr.
J. FORSYTH (SECRETARY OF STATE), However unjust...the slave trade may be, it
171
Giuliana Iurlano
«Gli abolizionisti intendevano portare il caso Amistad davanti
all’opinione pubblica. Per far ciò, avrebbero dovuto strapparlo alle trattative private del presidente con la Spagna e portarlo davanti ai tribunali,
dove – essi speravano – sarebbe divenuto parte del più ampio gioco della politica nazionale». 51
4. I primi due processi
Nella prima fase del processo penale dinanzi al Tribunale Distrettuale
presieduto dal giudice Andrew T. Judson, questi fece riferimento al Judiciary Act del 1789, che – a completamento dell’art. III della Costituzione, con cui veniva istituito il potere giudiziario 52 – precisava l’ambito
di competenza per molti reati federali, per le dispute relative a cittadini
di differenti Stati e, soprattutto, per una serie di casi minori in cui il governo federale fosse attore o convenuto. Judson, dopo aver ascoltato le
parti, 53 fissò la data per la comparizione davanti al competente Tribunale
Circoscrizionale di Hartford. Il 18 settembre 1839 ebbe inizio il processo penale, presieduto dal giudice Smith Thompson, contro gli africani
dell’Amistad, imputati di omicidio, ammutinamento e atti di pirateria. La
difesa sperava sin da subito di ribaltare l’impostazione accusatoria, portando la questione sul piano dei diritti umani e di quelli di proprietà inerenti la schiavitù. Per far ciò, era necessario separare gli interventi difensivi, presentando immediatamente un writ of habeas corpus nei confronti delle tre ragazze africane, imprigionate insieme con gli uomini mende,
in modo tale che, se fosse stata dimostrata l’inesistenza di qualunque
base giuridica a giustificazione della loro detenzione, gli avvocati avrebbero potuto estendere l’argomentazione anche agli altri prigionieri.
In sostanza, il fulcro dell’azione difensiva stava in un semplice ragio-
is not contrary to the law of nations, 1839. Africans Taken in the Amistad, U.S.
26th Cong., 1st Sess., H. Exec. Doc. 185, New York, Blair & Rives, 1840, pp.
57-62.
51
JONES, Mutiny on the Amistad, cit., p. 46.
52
Relativamente al Judiciary Act del 1789, cfr. Documentary History of the Supreme Court of the United State, 1789-1800, vol. 4, Organizing the Federal Judiciary: Legislation and Commentaries, M. MARCUS – J.R. PERRY, eds., New
York, Columbia University Press, 1992, pp. 22-107; R.R. WHEELER – C.
HARRISON, Creating the Federal Judicial System, Federal Judicial Center, 19942.
53
I principali testimoni furono Ruiz e Montes, l’interprete (il luogotenente R.W.
Meade) e Antonio, lo schiavo del capitano ucciso. Il contenuto delle
testimonianze è in History of the Amistad Captives, cit., pp. 6-8.
172
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
namento: l’habeas corpus poteva essere concesso soltanto a “persone”
(le uniche titolari di diritti) e non a “proprietà”; se le ragazze lo avessero
ottenuto, allora sarebbe stato riconosciuto il loro status di persone e,
dunque, per analogia, anche quello degli altri “presunti” schiavi
dell’Amistad. Di conseguenza, le accuse sarebbero state rivolte a “persone” ben precise, con tutte le implicazioni del caso: intanto, il riconoscimento di ciò avrebbe sancito un importante principio nella battaglia
abolizionista, un principio che, dal Connecticut, poteva essere esteso a
tutti gli Stati Uniti; inoltre, fatto ancora più importante, i funzionari che
avevano eseguito l’arresto avevano agito illegalmente, violando i fondamentali diritti dei neri; per ultimo, ma non meno importante, sarebbe
stato implicitamente riconosciuto che il rispetto dei diritti umani andava
oltre le leggi statali, perché riguardava il genere umano nel suo complesso. 54 Si trattava, indubbiamente, di una linea di difesa molto ambiziosa,
che mirava a scardinare alle fondamenta l’istituto della schiavitù 55 o,
quantomeno, a segnare un primo importante traguardo nella battaglia
abolizionista. Ma era anche molto arduo pensare di riuscire a vincere
facilmente sul piano giuridico, senza dover superare tutta una serie di
ostacoli anche di natura politico-diplomatica.
L’“affaire Amistad” si giocava tutto su piani diversi che
s’intersecavano: il piano politico-diplomatico, che riguardava sia le relazioni internazionali tra Spagna e Stati Uniti, sia la posizione
dell’amministrazione Van Buren alla vigilia del rinnovo del mandato
presidenziale; quello penale, relativo alle accuse più gravi rivolte ai
mende; quello civile, che si riferiva sia ai diritti di proprietà del carico
del vascello (in questo caso, riferiti ai due mercanti spagnoli, ma anche
alla stessa Corona di Spagna, visto che il vascello batteva bandiera spagnola), sia al capitano della U.S. Washington, che pretendeva
54
Si veda, a tal proposito, W.M. WIECEK, The Sources of Antislavery Constitutionalism in America, 1760-1848, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1977, p.
157, n. 24. Fu in particolare Lewis Tappan ad essere persuaso che, se il collegio
difensivo avesse provato che gli africani dell’Amistad erano persone, anche la
richiesta dei mercanti spagnoli di riavere indietro la loro proprietà sarebbe venuta meno. Cfr. William S. Holabird, U.S. District Attorney, to Secretary of State
John Forsyth, Sep. 21, 1839, in H. Exec. Doc. 185, cit., p. 40.
55
Lo chiarì molto bene Joshua Leavitt, nel suo intervento alla General Antislavery Convention a Londra, quando precisò che lo scopo del writ era soprattutto
quello di «testare il loro [degli africani] diritto alla personalità». Leavitt’s Address before the Convention, June 15, 1843, in Proceedings of the General AntiSlavery Convention, June 13-20, 1843, in ARC, cit.
173
Giuliana Iurlano
l’indennità di salvataggio, prevista dal diritto marittimo; 56 infine, il piano di principio, che cercava di dare risposta a una serie di domande: se
gli africani dell’Amistad fossero nati liberi (e, dunque, fossero stati rapiti
e trasformati in schiavi), o se fossero schiavi dalla nascita; se i mende
potessero essere considerati alla stregua di oggetti o se, invece, dovessero essere considerati persone a tutti gli effetti, compresa la titolarità dei
diritti innati; se, infine, i blacks in generale fossero uomini alla stregua
dei bianchi e se la “peculiare istituzione” della schiavitù non violasse la
più grande legge della natura umana. A tutto ciò s’aggiungevano i preliminari problemi relativi alla competenza del giudice (spagnolo, come
affermava la Corona, visto che il reato era avvenuto in acque internazionali e su una nave spagnola; statale, in quanto l’Amistad era stata fatta
approdare in un porto del Connecticut; federale, poiché la questione riguardava le relazioni internazionali e il rispetto dei precedenti trattati
stipulati con una nazione straniera).
Naturalmente, il piano politico-diplomatico era l’ambito più caldo del
dibattito e lo si comprese immediatamente già il 6 settembre 1839,
quando – anticipando la prima comparizione nella fase pre-trial –
l’ambasciatore spagnolo a Washington, Angel Calderón de la Barca, richiese formalmente la restituzione dell’Amistad e del suo carico al segretario di Stato John Forsyth. 57 Dietro alla richiesta spagnola, vi erano
alcuni timori molto forti, il più importante dei quali era che la Gran Bretagna utilizzasse la presunta violazione del trattato anglo-spagnolo contro il commercio degli schiavi come pretesto per intervenire a Cuba. Oltre che salvare la faccia, gli spagnoli dovevano mantenere una posizione
ferma sul piano dei rapporti internazionali, proprio a causa delle gravi
questioni interne, seguite ai moti indipendentistici, che avrebbero potuto
pregiudicare la loro credibilità nello scenario mondiale. Tuttavia, qualunque decisione il governo americano avesse preso, la Corona spagnola
56
Sul ruolo dell’Admiralty Law nel caso Amistad, si veda D.O. LINDER, Salvaging Amistad, in «The Journal of Maritime Law and Commerce», XXXI, 4, October 2000, pp. 559-581.
57
Cfr. Calderón to Forsyth, Sept. 6, 1839, in U.S. DEPARTMENT OF STATE, Notes
from the Spanish Legation in the U.S. to the DS, 1790-1906, National Archives,
Washington, DC. Il giornale spagnolo «Noticioso de Ambos Mundos» pubblicò,
con ricchezza di particolari, la posizione del governo di Madrid sulla vicenda,
insistendo soprattutto sulla questione di principio, secondo la quale i sentimenti
privati sulla schiavitù e sul commercio schiavile non dovevano interferire con la
legge e la giustizia. Il resoconto è riportato nel «New York Advertiser &
Express», Sept. 11, 1839, p. 1.
174
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
non avrebbe potuto evitare alcune situazioni imbarazzanti. In primo luogo, se gli Stati Uniti avessero restituito gli africani, questi sarebbero stati
sicuramente condannati a morte da un tribunale cubano (sempre che un
processo ci fosse stato) 58 e l’opinione pubblica americana – adeguatamente sollecitata dal movimento abolizionista – avrebbe protestato clamorosamente; in secondo luogo, l’eventuale esecuzione dei mende avrebbe rafforzato le ragioni interventiste britanniche contro la Spagna;
infine, se gli africani fossero stati giudicati negli Stati Uniti, in ogni caso
la posizione inglese si sarebbe rafforzata, sia che la giustizia americana
avesse liberato i presunti schiavi (nel qual caso, la violazione spagnola
sarebbe stata confermata), sia che li avesse restituiti ai mercanti spagnoli, mettendo così a rischio la loro vita. 59
Anche sul piano politico interno, il presidente Van Buren era propenso ad accogliere le richieste spagnole, per non rischiare di spaccare
l’Unione in un momento così delicato, ma soprattutto per non rompere,
nelle elezioni del 1840, la coalizione di Northerners e di Southerners
che aveva appoggiato il Partito democratico e che probabilmente avrebbe continuato a funzionare se solo la questione della schiavitù fosse rimasta in ombra. Anche Andrew Jackson, predecessore di Van Buren,
aveva scelto di mantenere un atteggiamento, per così dire, “neutrale”
sulla spinosa questione della schiavitù, e la stessa cosa stava tentando di
fare il presidente in carica, anche sulla base di una serie di analogie individuate tra il caso dell’Amistad e quello di ben tre vascelli americani
(il Comet, l’Encomium e l’Enterprise), adibiti al trasporto costiero di
schiavi dalla Virginia alla Louisiana e costretti, dopo una tempesta, ad
un approdo forzato in territorio inglese, dove erano stati trattenuti dai
britannici. In quei casi, in effetti, Lord Palmerston alla fine aveva accolto le richieste d’indennizzo avanzate dagli americani, ad eccezione di
quella riguardante l’Enterprise, approdata alle Bermuda dopo il 1° agosto 1834, cioè dopo l’entrata in vigore del decreto di emancipazione nelle Indie occidentali. Ma proprio su tale argomentazione gli americani
58
A Cuba, infatti, esistevano interessi molto forti contro una possibile assoluzione dei neri, che certamente avrebbe creato un importante precedente.
59
La convinzione spagnola di un probabile intervento britannico a Cuba era, in
realtà, sopravvalutata: l’Inghilterra stava vivendo una serie di difficoltà sia interne, che internazionali, in particolare per la questione dei confini canadesi
nell’America settentrionale. Tuttavia, come afferma Howard Jones, «se le percezioni degli americani e degli spagnoli fossero fondate, è poco importante; essi
credevano che i britannici fossero in grado di intervenire a Cuba». JONES, Mutiny on the Amistad, cit., p. 53. Il corsivo è nel testo.
175
Giuliana Iurlano
espressero le loro critiche più aspre, sostenendo che il commercio schiavile costiero era permesso dalla legislazione statunitense, che prevaleva
dunque su quella britannica. 60 Tale precedente – in particolare quello
della Comet, accaduto nel 1830, quando lo stesso Van Buren era segretario di Stato – sembrava avvalorare l’ipotesi che l’amministrazione americana si stesse accingendo ad accogliere la richiesta della Corona
spagnola, soprattutto per ragioni politiche, più che giuridiche. In sostanza, qui non si trattava soltanto di sostenere la tesi della legalità del trasporto costiero degli schiavi da Cuba ad altri porti spagnoli, bensì di evitare di indagare a fondo sull’ipotesi di frode e di false dichiarazioni fatte
dai due mercanti. Qualunque accertamento, infatti, avrebbe finito per
sollevare il caso e infiammare l’opinione pubblica anti-abolizionista,
proprio quello che Van Buren non voleva che accadesse. 61 John Forsyth,
nel suo ruolo di segretario di Stato, era anche fermamente contrario a
quanto suggerito dal segretario del Tesoro Levi Woodbury, vale a dire di
scaricare la risoluzione del problema alla magistratura, facendo così in
modo che l’Esecutivo non dovesse a tutti i costi compromettersi con una
60
La contro-argomentazione fu sviluppata sia dall’ambasciatore americano a
Londra, Andrew Stevenson (egli stesso proprietario di schiavi), sia dal senatore
del North Carolina, John C. Calhoun, il quale sostenne a chiare lettere che, secondo il diritto internazionale, un vascello adibito a un commercio legale (nel
caso americano, il trasporto costiero di schiavi) era sotto la giurisdizione del paese cui il vascello apparteneva, anche se esso fosse stato costretto ad approdare
in territorio straniero. Occorre considerare, tra l’altro, che, proprio nell’ottobre
del 1839, il segretario di Stato Forsyth ricevette una comunicazione
dall’ambasciatore britannico Henry S. Fox, che metteva in evidenza le pecche
delle leggi contro il commercio schiavile e chiedeva agli Stati Uniti una collaborazione formale. La risposta americana sottolineò la duplice politica praticata
dagli Stati europei e ribadì la volontà dell’amministrazione di agire in prima persona negli atti dissuasivi, senza alcuna convenzione formale con altre nazioni.
Naturalmente, in tale risposta giocò anche la volontà di non interferenza nella
“peculiare istituzione” degli Stati del Sud. Su tale argomento, cfr. A.L.
DUCKETT, John Forsyth Political Tactician, Athens, University of Georgia
Press, 2010, pp. 183-184.
61
Jones cita una lunga lettera di Van Buren pubblicata sui giornali dell’epoca,
in cui il presidente sosteneva che «la relazione tra padrone e schiavo apparteneva “esclusivamente” ai singoli Stati e che il governo di Washington non aveva
alcun diritto di violare lo “spirito del compromesso che sta alla base del patto
federale”. Gli abolizionisti – a suo parere – cercavano soltanto “di disturbare le
amichevoli relazioni esistenti tra gli Stati schiavisti e gli Stati liberi di
quest’Unione” ed egli, da “uomo pubblico”, aveva il dovere di opporsi apertamente alle loro tattiche». JONES, Mutiny on the Amistad, cit., p. 57.
176
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
decisione politically incorrected. Forsyth, invece, ribadiva con forza che
la questione dell’Amistad «era una prerogativa del presidente, il quale
era obbligato da un trattato a restituire il vascello col suo carico alle autorità spagnole». 62 Di conseguenza, gli Stati Uniti non avevano alcun
diritto di indagare sulla legalità della proprietà schiavile, ragion per cui
«il caso davanti alla corte federale costituiva un improprio contenzioso». 63
In questa direzione andavano anche i contatti preliminari tra Forsyth
e il procuratore distrettuale William S. Holabird (adeguatamente istruito
sui passi da compiere per evitare di portare il caso davanti a un tribunale) prima, e tra il segretario di Stato e il procuratore generale Felix
Grundy – il quale presentò una “opinione legale” a sostegno della tesi
della restituzione alla Spagna del vascello e del suo carico –, poi; 64 nel
caso in cui ci fosse stata una decisione contraria da parte dei giudici, il
procuratore era pronto ad appellarsi di fronte alla Corte Suprema.
L’aspetto più interessante di tutta la faccenda era la convinzione, da parte della Casa Bianca, che ci fossero tutte le prerogative per un “intervento” – o, meglio, per una “interferenza” – da parte dell’Esecutivo nel procedimento giudiziario.
Dopo tre giorni di accese battaglie legali, il giudice Thompson emise
la sentenza: la Circuit Court non era competente a giudicare per le imputazioni di omicidio e di pirateria, poiché tali reati erano stati commessi
su una nave spagnola e in acque spagnole; sulle varie richieste di restituzione della proprietà, incluse quelle di Ruiz e Montes relativamente agli
“schiavi” africani, avrebbe deciso il Tribunale Distrettuale; infine, fu
rigettato l’habeas corpus per il rilascio delle bambine mende. La sentenza del giudice Thompson risultò molto ambigua, per il semplice fatto
che non entrava nel merito dello status degli africani, ma si limitava a
circoscrivere gli ambiti giurisdizionali del presunto “reato”; in sostanza,
nulla veniva detto sui prigionieri dell’Amistad, in un certo modo equiparati a molti neri statunitensi, che non erano né schiavi, né liberi: dichiararli “liberi” in quanto dotati di diritti naturali avrebbe significato contravvenire alle leggi americane; ma anche confermare il loro stato di
schiavitù sarebbe stato in conflitto con le disposizioni internazionali finalizzate a rendere la tratta degli schiavi un commercio illegale. D’altra
parte, tutte le argomentazioni del movimento antischiavista urtavano
62
DUCKETT, John Forsyth, cit., p. 186.
Ibid.
64
Il contenuto del documento di Grundy è analizzato in particolare in JONES,
Mutiny on the Amistad, cit., pp. 57-60.
63
177
Giuliana Iurlano
contro quella che era la realtà sia del sistema legale statunitense, sia delle tradizioni americane, che avevano sancito l’esistenza della schiavitù
sin dal XVII secolo e che nessuno voleva mettere in discussione in modo improvviso, sulla base dell’affermazione di immoralità della schiavitù dei neri.
Richiesta del diritto di salvataggio da parte del luogotenente Thomas R. Gedney,
del brigantino U.S. Washington, 29 agosto1839
A quel punto, nuovamente convocata la District Court, Judson ritenne di aver bisogno di altre informazioni per decidere sulle richieste di
proprietà e, intanto, concesse agli africani la libertà su cauzione «sulla
178
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
base del loro valore stimato in qualità di schiavi sul mercato cubano», 65
cosa che fu naturalmente respinta dagli avvocati difensori, in quanto avrebbe significato una preliminare ammissione dello status schiavile dei
prigionieri. Essi, tra l’altro, si adoperarono per trovare un altro interprete, in modo tale da consentire ai mende di fornire anche la loro versione
dei fatti. 66 Quando il collegio di difesa degli africani chiese l’escussione,
tra gli altri testimoni, anche del Dr. R.R. Madden – un funzionario britannico di origine irlandese presso la Costa d’Oro (Ghana) e l’Avana
(Cuba), membro della Commissione mista per la soppressione del commercio degli schiavi –, questi denunciò apertamente e sotto giuramento
la flagrante violazione delle norme del Trattato anglo-spagnolo del
1820 67 e la complicità del console americano a Cuba, Nicholas Trist, il
quale aveva ricavato enormi benefici finanziari da tutte le operazioni
illecite che erano state compiute e da lui avallate. In particolare, però,
Madden mise in evidenza il fatto che i prigionieri dell’Amistad fossero
stati “importati” a Cuba di recente, anche se, sui documenti che li accompagnavano, erano stati dichiarati “ladinos”, una pratica, questa, alla
quale avevano fatto ricorso Ruiz e Montes, assai frequente nell’isola ma
indubbiamente illegale. 68
65
A. ABRAHAM, The Amistad Revolt: An Historical Legacy of Sierra Leone and
the United States, pamphlet commissioned by the United States Information
Service in Freetown, Sierra Leone, 1987, p. 9.
66
Di tale compito si incaricò J.W. Gibbs, un docente di Teologia e Letteratura
Sacra presso la Yale Divinity School. Dopo essere riuscito ad imparare a contare
fino a dieci nella lingua mende, si recò sulla banchina del porto di New York e lì
cominciò a contare, finché non ebbe attirato l’attenzione di un marinaio, James
Covey, un ex schiavo liberato dagli inglesi, che accettò di fare da interprete agli
africani dell’Amistad.
67
Il Trattato anglo-spagnolo del 1820, che proibiva il commercio degli schiavi,
era stato rinnovato nel 1835 e, nel 1838, riaffermato da un Reale Ordine della
regina di Spagna che imponeva al capitano generale di Cuba di applicare la legge con “grande zelo”.
68
A seguito della testimonianza di Madden, i due spagnoli furono arrestati con
l’accusa di rapimento e di illecita detenzione degli africani. La cauzione di 1000
dollari fu pagata da Montes, che ritornò immediatamente a Cuba, mentre Ruiz
scelse per un breve periodo di rimanere in prigione, forte delle proteste del nuovo ambasciatore spagnolo, Pedro Alcántara de Argaiz, che insisteva sul difetto
di giurisdizione da parte dei tribunali americani, ma alla fine – dopo aver anche
lui pagato la cauzione – tornò a Cuba. Tutti e due non furono presenti
all’udienza finale. Relativamente allo scambio di note diplomatiche tra Argaiz e
Forsyth, cfr. Pedro Alcántara de Argaiz to Sec. of State John Forsyth, Oct. 18,
179
Giuliana Iurlano
Nel lasso di tempo intercorso tra il novembre 1839 e il gennaio successivo, data di rinvio della causa, Forsyth rassicurò il governo spagnolo, impegnandosi a tener pronta una nave (la Grampus) per trasferire a
Cuba i prigionieri, se essi fossero stati riconosciuti colpevoli, prima che
gli abolizionisti potessero fare appello. 69 Alla fine, il 13 gennaio 1840, il
giudice Judson emise la sentenza: i prigionieri dell’Amistad erano stati
rapiti e venduti come schiavi in violazione della legge spagnola; pertanto, essi erano uomini liberi e, dunque, dovevano tornare nella loro terra.
Sicuramente, il giudice Judson tenne conto di molti fattori: la manovra
degli abolizionisti di “giudizializzare” la spinosa questione della schiavitù e la consapevolezza che l’opinione pubblica americana mostrava simpatia per i prigionieri del vascello spagnolo; il tentativo, da parte sua, di
sganciarsi dall’eventualità di dover dimostrare – in quanto democratico
jacksoniano – la propria lealtà nei confronti dell’amministrazione Van
Buren, così come era accaduto in precedenza nel caso Crandall; 70 infine,
1839, cit. in JONES, Mutiny on the Amistad, cit., p. 87; Argaiz to Forsyth, Oct.
22, 1839, U.S. Dept. of State, Notes from the Spanish Legation in the U.S. to the
DS, 1790-1906, National Archives, Washington, DC.
69
L’ordine di preparare la Grampus per il trasporto dei prigionieri a Cuba fu
dato da Van Buren il 7 gennaio del 1840, dopo uno scambio di corrispondenza
tra il dipartimento di Stato e quello della Marina. Cfr., in particolare, Extract
from Document No. 185, 1st Session (Executive Document, House of Representatives), 26th Congress, pp. 67-69, in Appendix to the Congressional Globe, House
of Representatives, 30th Congress, 1st Session, The Amistad Case – Mr. J.A.
Rockwell, August 8, 1848, p. 1130; ma anche Memorandum from the Department of State to the Secretary of the Navy, January 7, 1840, in cui Forsyth
specifica che «questi ordini saranno impartiti con speciali istruzioni da non
comunicare ad alcuno». Il documento è in D. LINDER, Stamped with Glory: Lewis
Tappan
and
the
Africans
of
the
Amistad,
in
http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/trialheroes/Tappanessay.html. Molto precise le direttive presidenziali a Holabird, tramite Forsyth: «Non si deve
dare per scontato che ci sarà [l’appello]. Nella improbabile ipotesi che la decisione sia diversa, lei stesso deve presentare l’appello». Forsyth to Holabird, Jan.
6 -12, 1840, House Executive Document 185, pp. 55-56.
70
Nell’agosto del 1833, Prudence Crandall, un’educatrice quacchera, che aveva
aperto una scuola a Canterbury, nel Connecticut, per “giovani signore e signorine di colore”, proprio per questo “reato” fu rinviata a giudizio. Giudice era Judson, il quale – come racconta Samuel J. May – così si espresse con lui sulla
questione della schiavitù: «Mr. May, non ci siamo semplicemente opposti alla
istituzione di quella scuola a Canterbury, ma anche ad eventuali altre scuole del
genere nel nostro Stato. Le persone di colore non possono elevarsi dalla loro
condizione servile nel nostro paese, e non dovrebbe essere permesso loro di cre-
180
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
il timore che la sua sentenza venisse ribaltata dalla Corte Suprema, cosa
che avrebbe potuto assestare un duro colpo sia alla sua carriera, che alle
sue ambizioni. Scrive Howard Jones: «Politicamente, socialmente e legalmente, Judson doveva camminare su una linea sottile tra il concedere
qualcosa a tutte le parti e l’evitare di essere biasimato per la sua decisione, qualunque fosse stata». 71 In effetti, le proteste spagnole si fecero ben
presto sentire: Argaiz, sdegnato, dichiarò che il mondo intero sapeva che
un tribunale non poteva occuparsi di «crimini o atti delinquenziali commessi in altri paesi, o in altre giurisdizioni, e sotto altre leggi» e che nessun giudice avrebbe ammesso «petizioni o accuse da parte di schiavi
contro i propri padroni». 72 Inoltre, si chiedeva l’ambasciatore spagnolo,
perché non vi era alcun potere federale pronto a «interporre la sua autorità per sanare le irregolarità di questi procedimenti?». 73 Fu a questo
punto che il presidente Van Buren ordinò al procuratore generale Holabird di fare immediatamente appello contro la sentenza di assoluzione.
5. Il caso Amistad davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti
Anche se John Quincy Adams, l’“old man eloquent”, come veniva definito, aveva affiancato – ma solo in qualità di consulente molto autorevole – il collegio difensivo degli africani, la sua partecipazione attiva al
caso fu esplicitamente richiesta da Lewis Tappan, che si recò a trovarlo
nella sua casa in Massachusetts. All’epoca, Adams aveva 74 anni ed era
membro del Congresso americano, ma – pur condividendo in linea di
principio le motivazioni dei difensori dei mende – non voleva impegnarsi in prima persona in un difficile processo sia per motivi di età e di salute, sia per il suo incarico nella House of Representatives, ma anche per
la lunga assenza dalle aule dei tribunali. Alla fine, però, Tappan lo con-
scere qui. Si tratta di una razza inferiore di esseri [...]. L'Africa è il posto per loro. Sono a favore del regime di colonizzazione. Lasciate che i negri e i loro discendenti siano rispediti in patria». S.J. MAY, Some Recollections of Our Antislavery Conflict, Boston, Fields, Osgood & Co., 1869, pp. 11-12.
71
JONES, Mutiny on the Amistad, cit., p. 100. La decisione di Judson, appellata
da parte dell’amministrazione Van Buren, fu confermata dal giudice Thompson.
Il secondo appello fu presentato alla Corte Suprema degli Stati Uniti.
72
Argaiz to Forsyth, Nov. 5, 1839, U.S. Dept. of State, Notes from the Spanish
Legation in the U.S. to the DS, 1790-1906, National Archives, Washington, DC.
73
Ibid.
181
Giuliana Iurlano
vinse ad affiancare Baldwin nella difesa davanti alla Corte Suprema. 74
Certamente, una delle ragioni che spinsero Adams ad accettare stava
nella sua convinzione che il comportamento della Casa Bianca non solo
non fosse stato per nulla etico, ma addirittura esplicitamente illegale e
incostituzionale: insomma, il procuratore generale era stato autorizzato a
trasferire i prigionieri a Cuba, prima ancora che la difesa avesse avuto
materialmente il tempo di appellarsi a un’eventuale sentenza sfavorevole
della Corte. In tal modo, Van Buren riaffermava per la seconda volta il
diritto dell’Esecutivo di interferire nel giusto processo garantito dalla
Costituzione. 75 Che le motivazioni non fossero soltanto di natura interna
(la rielezione del presidente), ma anche internazionali fu chiaro dalla
corrispondenza di Forsyth con l’incaricato americano a Madrid, Aaron
Vail: in essa si precisava a chiare lettere l’interesse americano per Cuba
e la volontà di tenere lontana dall’isola la Gran Bretagna. Vail fu istruito
affinché usasse “tatto e delicatezza” nel mettere in guardia la Corona
spagnola contro i “disegni” e i pretesti che gli inglesi avrebbero potuto
accampare per mettere piede su quell’importante avamposto commerciale, ma geograficamente vicino agli Stati Uniti, che era l’isola. Nello
stesso tempo, il segretario di Stato raccomandava a Vail di non mettere
alcunché per iscritto nelle comunicazioni al ministro spagnolo, ma di
avere con lui “conversazioni informali e confidenziali”. Nel caso in cui
74
Nel suo diario, Adams descrive l’incontro a New Haven con Roger Sherman
Baldwin per preparare la strategia difensiva dinanzi alla Corte Suprema e la decisione di incontrare i propri clienti. Cfr. J.Q. ADAMS, Diary, vol. 41, December
5, 1836 – December, 31, 1841, Entry Nov. 17, 1840, p. 160 [electronic edition].
The Diaries of John Quincy Adams: A Digital Collection, Boston, Mass., Massachusetts Historical Society, 2004, in http://www.masshist.org/jqadiaries.
75
Sul comportamento di Van Buren nel caso Amistad, solo alcuni studiosi sono
intervenuti. Samuel Flagg Bemis ha ribadito l’interesse del presidente di mantenere intatta la composizione del suo collegio elettorale [S.F. BEMIS, John Quincy
Adams and the Union, New York, Knopf, 1956, pp. 393-394]; William H.
Smith, invece, ha sottolineato la “fretta indecente” di Van Buren nel cercare di
risolvere al più presto il problema [W.H. SMITH, A Political History of Slavery, 2
voll., New York, Putnam’s, 1903, vol. I, p. 57]; John R. Spears – anche lui, come Smith, agli inizi del XX secolo – ha parlato di «un vergognoso tentativo per
ingannare il popolo degli Stati Uniti, compresi i tribunali» [J.R. SPEARS, The
American Slave-Trade: An Account of Its Origin, Growth and Suppression,
London, Bickers, 1901, p. 188]; infine, in una più recente biografia del presidente, la sua politica viene definita come «una totale e riprovevole indifferenza per i
diritti degli africani» [J. NIVEN, Martin Van Buren: The Romantic Age of American Politics, New York, Oxford University Press, 1983, p. 467].
182
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
avesse «rilevato la volontà di cedere Cuba agli inglesi o ad altre potenze
europee, temporaneamente o permanentemente, avrebbe dovuto avvertire Madrid che gli Stati Uniti si sarebbero opposti in tutti i modi, compreso il ricorso ai mezzi navali e militari. [...] Il governo spagnolo doveva
evitare di fornire all’Inghilterra un qualunque vero motivo che costituisse anche il più remoto pretesto per interferire negli affari cubani. [...]
Madrid avrebbe dovuto pertanto rispettare scrupolosamente gli obblighi
del trattato». 76 Proprio su alcuni aspetti delle relazioni trilaterali informali tra Spagna, Stati Uniti e Gran Bretagna si sarebbe appuntata
l’attenzione di Adams, desideroso di portare allo scoperto la verità e di
rendere giustizia agli africani. 77 L’ex presidente era profondamente convinto che «l’unico interesse dell’amministrazione Van Buren era di soddisfare la Spagna» 78 e, per questo motivo, era pronto a muovere alla Casa Bianca l’accusa di pregiudizio verso i neri. Il fulcro del problema stava nel dimostrare, prove alla mano, che «il procuratore generale stava
restituendo gli africani come schiavi, quando invece aveva dichiarato
che li avrebbe restituiti in quanto assassini». 79 Del resto, le richieste
spagnole del 6 settembre e del 26 novembre 1839 sembravano essere
state abbastanza chiare; in particolare nell’ultima, Argaiz si era lamentato del fatto che gli Stati Uniti non avevano rispettato il trattato del 1795,
cosicché «la pubblica vendetta non era stata soddisfatta; per questo si
ricordava che la Legazione della Spagna non richiede la consegna di
schiavi, ma di assassini». 80 In realtà, Adams avrebbe dovuto dimostrare
76
Forsyth to Vail, July 15, 1840, in W.R. MANNING, ed., The Diplomatic Correspondence of the United States: Inter-American Affairs, 1831-1860, 12 voll.,
Washington, DC, Carnegie Endowment for International Peace, 1932-1939, vol.
11, pp. 23-24. Probabilmente le preoccupazioni americane per un eventuale intervento inglese erano eccessive, anche se, effettivamente, la stampa britannica
soffiava sul fuoco del caso Amistad, contribuendo ad aumentare la pressione diplomatica sul governo spagnolo.
77
Nelle sue memorie, Adams ricorda che, inevitabilmente, la sua difesa avrebbe
colpito l’amministrazione Van Buren, ma che il principio di giustizia era più
importante di qualunque cosa, anche se non sarebbe stato facile affermarlo:
«Oh, come potrò dare giustizia a questo caso e a questi uomini?». Memoirs of
John Quincy Adams, Comprising Portions of His Diary from 1795 to 1848,
CH.F. ADAMS, ed., 12 voll., Philadelphia, Lippincott, 1874-1877, vol. 10, p. 395.
78
J.Q. ADAMS, Brief in the Amistad Case, Autograph Notes, February 24 and
March 1, 1941, Manuscript Division. Library of Congress.
79
Ibid.
80
Argaiz to Forsyth, Nov. 26, 1839, U.S. Dept. of State, Notes from the Spanish
Legation in the U.S. to the DS, 1790-1906, National Archives. Il corsivo è mio.
183
Giuliana Iurlano
l’intenzionale fraintendimento dell’amministrazione americana, cosa
non facile, visto che, a metà gennaio del 1840, il governo spagnolo si era
affrettato a chiarire che la restituzione dei neri doveva essere intesa in
entrambi i significati, unendo così i due elementi in un’unica richiesta
(vale a dire, slaves as assassins). 81 È chiaro che la Corona spagnola si
trovava in una situazione a dir poco imbarazzante: sin dall’inizio aveva
cercato di tralasciare la parola “schiavi”, per non dare ragione alle accuse britanniche di violazione dei trattati anglo-spagnoli contro la tratta
degli schiavi; nello stesso tempo, però, se avesse mantenuto soltanto la
richiesta relativa all’accusa di omicidio, avrebbe in qualche modo lasciato spazio alle argomentazioni degli abolizionisti. La Gran Bretagna, da
parte sua, seguiva attentamente il caso, e l’ambasciatore inglese a Washington, Henry S. Fox, chiese di incontrare due volte Adams, prima di
inviare una nota ufficiale al dipartimento di Stato, con la quale informava della “serietà” dell’attenzione britannica verso «gli sfortunati africani, [...] illegalmente e criminosamente ridotti in schiavitù da sudditi spagnoli» e richiamava gli Stati Uniti al rispetto dell’art. 10 del Trattato di
Ghent (24 dicembre 1814), che stabiliva lo sforzo reciproco per fermare
il commercio degli schiavi. Di conseguenza, Fox chiedeva chiarezza sulla posizione americana: «Gli Stati Uniti – si leggeva nella nota – dovranno ora decidere se i neri devono riavere la libertà che spetta loro di
diritto, o se devono essere ridotti in schiavitù, in violazione delle leggi
contro il commercio schiavile da parte della Spagna. [...] La posizione
inglese è favorevole a riconoscere i neri come persone libere e il governo britannico spera che il presidente assicurerà loro il legittimo diritto
alla libertà». 82 Van Buren, invece, ribadì con decisione che il caso Amistad non costituiva argomento delle relazioni anglo-americane e che, al
Il testo spagnolo della nota così recitava: «[...] Resultando de aqui que la vindicta publica no se halla aun satisfecha; porque es preciso no olvidar que la Legacion de Espana non pide la estradicion de esclavos, sino asesinos». Ma si veda
anche la nota precedente: Angel Calderón de la Barca to Forsyth, Sept. 6, 1839,
ibid.
81
La prima richiesta era giustificata dal trattato del 1795; la seconda dal principio di reciprocità. Argaiz chiarisce che solo un’interpretazione errata della richiesta spagnola aveva fatto intendere che la Spagna avesse preteso solo la restituzione degli assassini; in realtà – spiega – egli aveva scritto «no pide esclavos
sino asesinos», volendo intendere «no solo pide esclavos sino esclavos asesinos» («not only demands slaves, but slaves who are assassins»). Argaiz to Forsyth, Jan. 19, 1841, ibid.
82
Fox to Forsyth, Jan. 20, 1841, U.S. Congress, Sen. Doc., n. 179, “Message
from the President of U.S.”, Feb. 12, 1841, 26th Cong, 2d sess., pp. 27-28.
184
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
massimo, il contenuto della nota britannica sarebbe stato accolto come
un’espressione di “benevolenza”. Secondo l’amministrazione americana, le notizie giunte alla Gran Bretagna non corrispondevano alla verità
e l’amministrazione americana non aveva alcuna intenzione di interferire nel procedimento giudiziario; soltanto se la Corte avesse deciso di
non restituire i neri, allora la Corona inglese avrebbe potuto avanzare le
sue rimostranze sulla violazione del trattato alla Spagna, perché «gli Stati Uniti non agivano da tribunale internazionale». 83 La vicenda della nota di Fox metteva in evidenza il problema fondamentale che gli abolizionisti e il collegio di difesa avrebbero dovuto affrontare, vale a dire la
difficoltà di provare concretamente l’intenzionalità del comportamento
del presidente.
Il 22 febbraio del 1841 si tenne la prima udienza dinanzi alla Corte
Suprema degli Stati Uniti, presieduta dal giudice Roger B. Taney del
Maryland. 84 Dopo l’introduzione fatta dal procuratore generale Henry
D. Gilpin, Roger Baldwin prese la parola e sostenne che il caso riguardava non soltanto gli africani da lui rappresentati, ma anche «il carattere
nazionale dell’America agli occhi dell’intero mondo civilizzato». 85 Infatti, egli domandava, il governo degli Stati Uniti – istituito per promuovere la giustizia e fondato sui grandi principi della Dichiarazione
d’Indipendenza – fino a che punto può diventare parte in causa nel procedimento «per rendere schiavi degli esseri umani sbattuti sulle nostre
coste, ma uomini liberi all’interno dei confini del territorio di uno Stato
libero e sovrano? [...] Per quale motivo, allora, io insisto, gli Stati Uniti
83
Forsyth to Fox, Feb. 1, 1841, U.S. Dept. of State, Notes to Foreign Legations
in the U.S. from the DS, 1834-1906, Great Britain, National Archives.
84
In realtà, il procedimento fu aperto con la costituzione delle parti il 16 gennaio 1841. Cfr. Appellate Case File No. 2161, United States v. The Amistad, 40
U.S. 518, Decided March 9, 1841, and Related Lower Court and Department of
Justice Records, in NARA, RG 267, Roll 0001. Gli altri 8 giudici associati erano:
John Catron (Tennessee), John McKinley (Alabama), nominato da Van Buren,
Joseph Story (Massachusetts), Smith Thompson (New York), John McLean
(Ohio), Henry Baldwin (Pennsylvania), James M. Wayne (Georgia) e Philiph P.
Barbour (Virginia). Cinque dei nove giudici provenivano dal Sud. Il presidente
Taney e il giudice Story erano noti come difensori della supremazia nazionale,
ma anche dei diritti degli Stati e, dunque, abbastanza favorevoli a un compromesso, come quello di Filadelfia del 1787, che non pregiudicasse l’Unione.
85
Cfr. Argument of Roger S. Baldwin of New Haven, Before the Supreme Court
of the United States, in the Case of the United States, Appellants, vs. Cinque,
and Others, Africans of the Amistad, New York, S.W.Benedict, 1841, p. 4.
185
Giuliana Iurlano
compaiono in questo procedimento?». 86 Baldwin andava oltre, sostenendo che la Costituzione americana non autorizzava in alcuna maniera
il governo a “istituire o legalizzare” la schiavitù, la cui esistenza dipendeva soltanto dalle leggi statali; di conseguenza, non si trattava di un
problema nazionale, ma di un problema che riguardava i singoli Stati. 87
La questione sollevata da Baldwin, tuttavia, presentava un aspetto collaterale rischioso, le cui implicazioni sarebbero emerse qualche anno dopo: l’insistenza sul fatto che lo status dei neri americani dovesse essere
di pertinenza degli Stati andava a confliggere con la strategia abolizionista, finalizzata, invece, a aumentare i poteri del governo federale nella
protezione degli schiavi neri fuggitivi. Con il Compromesso del 1850,
infatti, non solo sarebbero stati stabiliti i criteri per l’annessione
all’Unione di Stati liberi o schiavisti, ma un nuovo e più rigido Fugitive
Slave Act avrebbe sostituito quello del 1793, permettendo ai proprietari
di schiavi di arrestare i presunti evasi senza mandato e di negar loro il
giusto processo, e imponendo gravi pene a chi li avesse aiutati nella fuga. Insomma, proprio l’argomentazione di Baldwin sarebbe stata rovesciata dai Southerners, nel loro appellarsi ai diritti degli Stati per “proteggere la peculiare istituzione” proprio dall’eccessivo potere del governo federale.
6. Il “processo a un presidente da un altro presidente”
John Quincy Adams prese la parola in un’aula piena di gente, richiamata
dalla curiosità e dal desiderio di sentire ancora una volta le sue parole.
L’agitazione e la stanchezza dei giorni precedenti – di cui parla nelle sue
Memorie 88 – erano scomparse di fronte alla consapevolezza che il caso
giudiziario dipendeva dal perseguimento costante e inflessibile di uno
dei principi fondamentali, vale a dire la giustizia: «[...] In una corte di
giustizia, dove appaiono due parti avverse, giustizia vuole che i diritti di
86
Ibid., pp. 4, 11.
Cfr. ibid., p. 15.
88
Nelle sue memorie, Adams sostiene: «Ero profondamente stressato e agitato
fino al momento in cui non mi sono alzato, rendendomi conto solo allora che il
mio spirito non mi aveva abbandonato. [...] Avevo provato umiliazione per la
debolezza che limitava le mie forze. [...] La Corte doveva proteggere i neri contro l’immenso apparato di potere, esercitato dalla parte dell’ingiustizia,
dall’Esecutivo e dall’ambasciatore spagnolo». Memoirs of JQA, cit., p. 431. Si
veda anche J. WHEELAN, Mr. Adams’s Last Crusade: John Quincy Adams’s Extraordinary Post-Presidential Life in Congress, New York, Public Affairs, 2008.
87
186
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
ogni parte siano fatti salvi, come pure vuole che ogni parte abbia dei diritti, che è cura della Corte assicurare e proteggere. Questa osservazione
è importante, dato che io sono qui per conto di trentasei individui la cui
vita e la cui libertà dipendono da questa Corte». 89 Il principio guida della sua difesa sarebbe stato, dunque, la Dichiarazione d’Indipendenza
americana, quel documento basilare che recita che ogni uomo è stato
dotato dal suo creatore di alcuni diritti inalienabili, tra cui la vita, la libertà e la ricerca della felicità: «Nel momento in cui si giunga alla Dichiarazione di Indipendenza, vale a dire ad affermare che ogni uomo ha
diritto alla vita e alla libertà, un diritto inalienabile, allora questo caso è
deciso. Io non chiedo niente di più per questi uomini che questa Dichiarazione». 90
89
Argument of John Quincy Adams Before the Supreme Court of the United
States, in the Case of the United States, Appellants, vs. Cinque, and Others, Africans, Captured in the Schooner Amistad, by Lieut. Gedney, Delivered on the
24th of February and 1st of March, 1841. With a Review of the Case of the Antelope, Reported in the 10th, 11th and 12th Volumes of Wheaton’s Reports, New
York, S.W. Benedict, 1841, p. 4.
90
Ibid., p. 89.
187
Giuliana Iurlano
Bozza della prima pagina della memoria difensiva presentata da J.Q.
Adams alla Corte Suprema degli Stati Uniti, 1839-1841.
Ma il riferimento all’atto fondativo degli Stati Uniti avrebbe dovuto costituire anche la base per una denuncia più diretta contro
l’amministrazione Van Buren, accusata di aver intenzionalmente interferito sul potere giudiziario, per favorire la Corona spagnola in una causa
che, sin dall’inizio, era stata caratterizzata da una serie di gravi errori
188
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
procedurali: «Tutta la mia argomentazione ha lo scopo di dimostrare che
l’appello è inammissibile [in quanto] la procedura seguita [...] è stata
errata sin dall’inizio. Già il primo atto, la cattura del vascello e di questi
uomini da parte di un ufficiale di Marina è stato sbagliato. Il loro arresto
forzato sul suolo di New York è stato un errore. Dopo che il vascello fu
portato all’interno della giurisdizione della Corte distrettuale del Connecticut, gli uomini furono imprigionati e sottoposti a processo penale
per omicidio e pirateria sui mari, per poi essere dichiarati dal luogotenente Gedney merce di sua proprietà in base all’indennità di ritrovamento. Nel corso di quel medesimo procedimento, essi vennero presi in consegna dall’ufficiale giudiziario. Furono infine reclamati da Ruiz e Montes come loro merce e quindi di nuovo presi in custodia dalla Corte». 91
Adams, tuttavia, precisa a chiare lettere che, nonostante sia per lui
molto penoso contestare «davanti alla [...] Corte e al mondo civilizzato il
percorso effettuato dell’attuale amministrazione in questa causa, [egli]
tuttavia dovrà farlo», 92 per il semplice motivo che essa ha sostituito puntualmente, durante tutte le fasi del procedimento, la parola “giustizia”
con il termine “simpatia”, «“simpatia” per una delle parti in causa, e
“antipatia” per l’altra. Simpatia per i bianchi, antipatia per i neri – e,
come prova della [mia] accusa, io adduco l’ammissione e le dichiarazioni dello stesso segretario di Stato». 93 Dunque, per dimostrare le pressioni operate dall’Esecutivo sui giudici, Adams legge la missiva inviata da
Forsyth ad Argaiz (in cui il segretario di Stato dichiara “fondata in fatto
e in diritto” la richiesta della Corona spagnola di restituzione della proprietà), sottolinea lo zelo della Casa Bianca nel fornire assistenza legale
agli spagnoli (negandola invece agli africani), ribadisce tutti i rapporti
poco chiari intercorsi tra il procuratore distrettuale Holabird e lo staff
presidenziale e, infine, denuncia apertamente la presenza del Grampus
nel porto di New Haven, pronto a riportare i mende all’Avana per consegnarli alla giustizia spagnola. 94 Sulla base di quale diritto – incalza
indignato l’ex presidente – l’amministrazione ha esteso la “simpatia” ai
due spagnoli che hanno perpetrato la violenza, invece che alle loro vittime? 95 Il “singular blunder” commesso dalla Casa Bianca stava, dun91
Ibid., pp. 10-11.
Ibid., p. 5.
93
Ibid., p. 6.
94
Adams fa riferimento in particolare alle lettere di Forsyth ad Argaiz del 13
dicembre 1839, e di Holabird a Forsyth del 5 settembre 1839.
95
Cfr. Argument of John Quincy Adams, cit., p. 6. In particolare il seguente passaggio: «Io chiedo con quale diritto tutta questa simpatia, dal luogotenente Ged92
189
Giuliana Iurlano
que, in tre gravi difetti presenti nell’ordine impartito all’ufficiale di polizia: mancava la firma del presidente; si trattava di una semplice disposizione acclusa alla lettera, e non di un’autorizzazione vera e propria; si
riferiva alla Corte circoscrizionale, anziché a quella distrettuale. Holabird aveva tentato di rettificare il documento, per evitare la concessione
dell’habeas corpus ai neri, ma nella copia finale di Van Buren, pervenuta alla Camera dei Rappresentanti, non vi era alcuna correzione, a riprova della grave negligenza del dipartimento di Stato in una causa che aveva a che fare con la vita stessa di alcune persone.
La condanna dell’amministrazione Van Buren – sostituita, nel frattempo, da quella del nuovo presidente, William Henry Harrison – e la
richiesta di giustizia per gli uomini dell’Amistad ebbero sicuramente un
effetto: nella sua replica, infatti, Gilpin negò perentoriamente che vi fosse stato un qualunque tipo di “executive interference” o di “executive
dictation” (come l’aveva definita Adams) nel procedimento giudiziario,
ma dichiarò che Van Buren si era attenuto al rispetto del trattato stipulato con la Spagna. 96 Scrive, a tal proposito, Howard Jones: «Gilpin era
nel giusto nell’asserire che l’Esecutivo aveva il potere di intervenire nella prima fase [...]. L’esecuzione di un trattato era responsabilità
dell’Esecutivo. Se i giudici ritenevano risolto il caso, allora
l’interposizione dell’Esecutivo avrebbe costituito ciò che Gilpin definiva
la parte specifica del procedimento giudiziario. Il problema era, però,
che Gilpin aveva descritto un’azione legale, cercando poi di farla combaciare con il comportamento del presidente. Le due azioni non erano
ney al segretario di Stato, e dal segretario di Stato automaticamente alla nazione,
fu estesa esclusivamente ai due spagnoli provenienti da Cuba e completamente
negata alle cinquantadue vittime della loro illecita violenza? Per quale diritto fu
negata agli uomini che si sono ripresi la loro libertà, ed hanno assicurato alla
giustizia gli oppressori che hanno perpetrato nei loro confronti quegli atti di violenza, e perché mai essa fu estesa proprio a costoro? Quando l’Amistad giunse
nella giurisdizione territoriale degli Stati Uniti, gli atti di violenza erano già accaduti tra le due parti, spagnoli e africani, a bordo di essa, ma da quale parte essi
fossero illegittimi, da che parte stessero gli oppressori, era una questione di diritto che andava affermata nel momento in cui sia il governo, che il popolo americano fossero intervenuti e, dunque, fossero obbligati al dovere di estendere la
loro simpatia a tutte le parti; e se fossero intervenuti tra le parti, il dovere incombente derivato da tale intervento avrebbe dovuto essere non di favore, ma di
imparzialità, non di simpatia, ma di giustizia, riconoscendo ad ogni individuo i
suoi legittimi diritti». Ibid., p. 8.
96
Cfr. Mr. Gilpin, the Attorney-General, in Reply, in U.S. v. Amistad,
http://www.law.cornell.edu/background/amistad/reply.html.
190
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
sinonimiche. Proprio come gli abolizionisti sospettavano, pur non essendo in grado di provarlo senza la documentazione del dipartimento di
Stato, l’Esecutivo era intervenuto non per portare il caso davanti ai giudici, ma per evitare il loro coinvolgimento. L’Esecutivo aveva agito
prima e senza il potere giudiziario. Solo quando la Casa Bianca non riuscì più a eludere il procedimento giudiziario, essa sostenne la posizione
per cui aveva agito nella maniera appropriata nei confronti dei giudici.
Forse Gilpin [...] non si era reso conto di ciò, ma un esame dei relativi
documenti avrebbe portato alla luce questa cronologia». 97
Sul piano più specifico della strategia difensiva, gli avvocati dei neri
si trovarono di fronte ad un serio problema: negare loro lo status di
schiavi in territorio americano avrebbe potuto complicare ulteriormente
il caso, come già da tempo aveva avvertito Theodore Sedgwick. Egli
suggeriva, infatti, di riconoscere che il termine merchandise, usato dai
diplomatici nei trattati, stava ad indicare anche gli schiavi, oltre agli oggetti inanimati; dunque, l’unico modo per avere la meglio sulla posizione del governo era di smontare la richiesta avanzata dai due spagnoli
relativamente al diritto di proprietà sui neri. 98 Adams, invece, scelse
un’altra strada in quello che è stato definito “the trial of one President
by another”: quella di riportare l’attenzione sui principi di libertà a fondamento della Dichiarazione d’Indipendenza americana – principi che la
Corte Suprema aveva la responsabilità morale di sostenere e di difendere
– e di dimostrare che l’amministrazione Van Buren li aveva intenzionalmente disattesi. Rispetto al primo tipo di argomentazione, Adams
sottolineava l’aspetto mitico-simbolico che la decisione della Corte Suprema avrebbe assunto, nel momento in cui essa fosse stata in palese
contraddizione con i principi di libertà del più importante atto fondativo
degli Stati Uniti d’America, spezzando, di conseguenza, il legame di filiazione con i padri fondatori della Costituzione. Rispetto alle accuse
rivolte all’amministrazione Van Buren, l’argomento esposto da Adams
era più propriamente “istituzionale”: se la decisione della Corte fosse
stata quella auspicata dalla Casa Bianca e dalla Corona di Spagna, allora
essa avrebbe sancito inequivocabilmente una falla nel sistema di checks
and balances, affermando la prevalenza della volontà dell’Esecutivo sul
potere giudiziario e, dunque, della stessa Corte Suprema. Scrive, a tal
proposito, Giovanni Rizzoni: «Entrambi questi argomenti rivelano che
la contesa ha cambiato piano di svolgimento. Non si tratta più di una
97
JONES, Mutiny on the Amistad, cit., pp. 183-184.
Cfr. Sedgwick to Tappan, Oct. 12, 1839, in TAPPAN PAPERS, Correspondence,
1809-1872, Library of Congress, Washington, DC.
98
191
Giuliana Iurlano
controversia giudiziaria e neppure di una battaglia d’impegno eticocivile: siamo di fronte ad una controversia costituzionale». 99
Il 9 marzo 1841, il Chief Justice Roger B. Taney lesse il dispositivo
della sentenza: «Nel caso degli Stati Uniti d’America contro gli africani
dell’Amistad, è opinione di questa Corte che il nostro trattato con la
Spagna del 1795, su cui si è principalmente fondata la tesi della pubblica
accusa, sia inapplicabile, benché preveda esplicitamente che “navi e carichi sequestrati debbano essere restituiti per intero al loro proprietario”.
Non è stato, infatti, sufficientemente dimostrato alla Corte che gli imputati rientrino in tale descrizione. Pertanto non possono essere considerati
mercanzia, ma sono piuttosto individui liberi con pieni diritti legali e
morali, compreso quello di compiere un’insurrezione contro chi vorrebbe negare loro la libertà». 100
99
G. RIZZONI, La democrazia al cinema: i dilemmi del costituzionalismo in cinque film, Roma, Meltemi Editore, 2007, p. 24.
100
Appellate Case File No. 2161, United States v. Amistad, 40 U.S. 518 (15 Peters 518), Decided Court and Department of Justice Records, NARA, M2012,
RG 267, Roll 0001. Dissenziente fu solo il giudice Baldwin, che, però, non mise
per iscritto la sua opinione.
192
Le relazioni tra Stati Uniti e Spagna nella prima metà del XIX secolo
Sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, 9 marzo 1841
La motivazione della sentenza fu scritta da Joseph Story, giudice della
Corte Suprema dal 1811. Egli – importante studioso e giurista del Massachusetts – era un conservatore e un convinto nazionalista, personalmente contrario alla “peculiare istituzione”, ma anche molto deciso a
difendere la legge, anche nel caso in cui proteggesse i diritti dei proprietari di schiavi. Il filo logico seguito da Story era abbastanza semplice e
chiaro: la richiesta di riconoscimento della proprietà degli schiavi da
parte di Ruiz e Montes non era stata provata e, dunque, risultava inapplicabile il trattato del 1795; ma non era stato provato nemmeno il loro
status di schiavi, anche perché – quando il vascello era entrato in acque
territoriali americane – essi risultavano in possesso di se stessi e reclamavano la propria libertà. Tuttavia, il punto più incisivo della sentenza
era costituito dall’affermazione che, in assenza del diritto positivo, do-
193
Giuliana Iurlano
vevano prevalere gli “eterni principi di giustizia”: ciò significava, in sostanza, che veniva implicitamente legittimato il corollario che ne derivava, vale a dire che gli stessi eterni principi di giustizia diventavano “secondari” davanti all’esistenza della legge positiva. Quindi, se la Spagna
avesse provato la condizione legale di schiavitù dei neri dell’Amistad, la
richiesta dell’amministrazione Van Buren sarebbe stata accolta, nonostante qualunque giudizio morale ciò comportasse. Inoltre, proprio perché mancava la prova della condizione di schiavitù e vi erano invece
buoni motivi per ritenere illegale tale condizione, gli africani avevano
avuto il diritto sacrosanto di ribellarsi a chi li aveva catturati e privati
della libertà. 101
101
Cfr. The Supreme Court Opinion by Justice Joseph Story on the Amistad Case, January
1841, ibid.
194
Gradus ad Parnassum
Sezione studenti
Eunomia. Rivista semestrale del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Eunomia 1 n.s. (2012), n. 1, 197-226
e-ISSN 2280-8949
DOI 10.1285//i22808949a1n1p197
http://siba-ese.unisalento.it, © 2012 Università del Salento
Francesca De Pascalis
Piazza Tiananmen, 1989: la “rivoluzione mancata”
Abstract: The events in Tiananmen Square, in June 1989, represent without any doubt a
countertendency compared with the changes of the last period of the Cold War. The new
opening up of China by Deng Xiaoping brought not only a new boost to the economy of this
country, but sowed the seeds of popular revolt against the orthodoxy and the dictatorship of
the Chinese Communist Party. It is possible to reconstruct the different phases of this
revolution thanks to US Embassy documents and to those that are not under control of party
leaders. Since “the Spring of Beijing”, these various phases have brought up the expansion of
a democratic movement whose protagonists were, in particular, Chinese students. The claims
for greater freedom, a better political participation, and more incisive radical reforms clashed
with the internal struggle among party leaders and ended up with the massacre of Tiananmen
Square, on June 4, 1989.
Keywords: Chinese Popular Republic; Chinese Communism; Tiananmen Square 1989.
Premessa
Il 1989 fu un anno cruciale in tutto il mondo, l’anno dei grandi cambiamenti
nel panorama internazionale, tranne che in Cina. La fine della Guerra
Fredda, gli accordi sul disarmo tra americani e sovietici, l’apparente
riavvicinamento dei valori occidentali a quelli riformisti del nuovo leader
sovietico, la caduta del muro di Berlino, tutto ciò mise fine ai regimi
comunisti dell’Europa orientale. Per la Cina, invece, il 1989 fu soprattutto
l’anno di Piazza Tiananmen, un evento che condusse la dirigenza cinese a
rafforzare la sua autorità all’interno del paese, ad aumentare il controllo
sulla società, ignorando completamente, nel contempo, il riconoscimento di
quei diritti civili e politici che, nel resto d’Europa, erano stati la prima
conseguenza del crollo del blocco sovietico. La storia ed il popolo cinese
alla fine avrebbero giudicato il 4 giugno come una delle più drammatiche e
significative tappe della lotta mondiale per la democrazia del XX secolo.
Certamente, si è trattato del più grande evento di questo tipo in Cina. Il 4
Francesca De Pascalis
giugno non è stato soltanto una protesta studentesca o un patriottico
movimento democratico, ma anche il culmine delle più affollate, durevoli
ed influenti dimostrazioni per la democrazia del XX secolo. Si è raggiunta,
così, una fine tragica e dolorosa, nel sangue e nella vittoria della dittatura. 1
Non bisogna tralasciare, inoltre, il fatto che, quando si parla di Cina e,
soprattutto, di libertà individuali e di diritti umani, l’intera cultura cinese è
stata ed è tuttora condizionata dall’idea socialista della società, così come
dalla tradizione confuciana. Già nel ’54, infatti, la Costituzione cinese
elencava una ampio numero di diritti e di libertà, facendo intravedere, però,
una limitazione dei diritti soggettivi, che potevano essere giuridicamente
protetti solo se esercitati in conformità con l’interesse collettivo della
comunità, anche se non vi era alcuna previsione costituzionale che
predicasse ciò. Si passò, così, all’edificazione della legalità socialista,
contrastando chi pretendeva di opporre alla volontà del Partito Comunista
Cinese (PCC) la legge e la legalità. 2
Per tale motivo, notevole fu lo sforzo della dirigenza comunista di
esercitare un controllo sempre maggiore sulla libera informazione e sui
diritti politici, fino all’emanazione della legge marziale antecedente i fatti di
Piazza Tiananmen. Il bavaglio imposto dalle autorità ha, dunque, reso più
difficile ricostruire le cause, gli eventi e le conseguenze che portarono alla
nascita del Movimento per la Democrazia fino al massacro del 4 giugno
1989. I documenti raccolti presso la George Washington University, nel
National Security Archive Electronic Briefing Book, dal titolo Tienanmen
Square 1989: The Declassified History, sono il risultato dei resoconti del
canale diplomatico di quegli anni dell’ambasciata americana a Pechino ed
un’importante fonte d’informazione sugli episodi inerenti Piazza
Tiananmen. Di non minore importanza sono state le dichiarazioni della
presidenza americana, riportate dal «Department of State’s Bulletin» e dai
documenti dei FRUS (Foreign Relations of the United States).
Ottenere informazioni dai vertici della Repubblica Popolare Cinese è
difficile, ma non impossibile. A dimostrazione di ciò, fondamentale è la
raccolta di documenti contenuta nel volume The Tiananmen Papers, che per
la prima volta descrive la storia di Tiananmen dalla prospettiva dello
1
Cfr. Z. LIANG, Reflections on June Fourth, in The Tiananmen Papers: The Chinese
Leadership’s Decision to Use Force against Their Own People – in Their Own
Words [d’ora in avanti Tiananmen], ed. by A.J. NATHAN – P. LINK – Z. LIANG,
London, Little, Brown and Co., 2001, p. XV.
2
Cfr. R. CAVALIERI, La legge e il rito. Lineamenti di storia del diritto cinese,
Milano, Angeli, 1999, pp. 127-128.
198
Piazza Tiananmen, 1989: la “rivoluzione mancata”
Zhongnanhai – l’antico parco imperiale al centro di Pechino che ospita
l’Ufficio Centrale di partito, l’Ufficio del Consiglio di Stato e le residenze
di alcuni dei massimi leaders cinesi. Allo Zhongnanhai confluiva, infatti,
tutta la documentazione raccolta dalle agenzie incaricate di sorvegliare e
controllare Pechino ed il resto del paese. Ogni giorno il Comitato Centrale
riceveva rapporti dai ministeri della Sicurezza, dagli uffici esteri ed interni,
dalle agenzie di stampa, i verbali delle riunioni formali e informali tra i
vertici del partito e i resoconti di alcune conversazioni private. Documenti
come quelli raccolti in tale volume hanno una circolazione estremamente
limitata in Cina. Il compilatore, Zhang Liang, è riuscito a ottenerli e,
insieme ai suoi compagni riformatori, si è assunto il compito di renderli
pubblici per smentire la versione ufficiale secondo la quale Tiananmen fu la
legittima soppressione di una violenta rivolta antigovernativa. 3
Tianamen ha rappresentato, per la Repubblica Popolare Cinese, l’apice
di una crisi interna, che ha rischiato di far crollare l’intero sistema
comunista. Causa di ciò è stato, in primis, il clima di maggiore libertà che si
percepiva all’interno della società civile, dovuto alla nuova apertura
economica ed internazionale della Cina negli anni ’80, che l’ha resa oggi
una delle più importanti potenze economiche al mondo. La “rivoluzione
mancata” dei giovani di Piazza Tiananmen ha segnato la storia della Cina in
termini politici, rendendola protagonista anche delle tribune internazionali
sul tema dei diritti umani, civili e politici.
1. La Cina di Deng Xiaoping
Con Deng Xiaoping a capo della Repubblica Popolare Cinese, l’intero paese
asiatico visse un periodo di radicale trasformazione, soprattutto in campo
economico. La popolarità acquisita dal nuovo leader, grazie alla
propaganda affidatagli dal partito contro la “banda dei quattro”, 4 gli
consentì di ottenere un consenso sempre più forte, sia all’interno del partito
3
Cfr. A.J. NATHAN, The Documents and Their Significance, in Tiananmen, cit., pp.
XVI-XX.
4
A capo della “banda dei quattro” (Siren Bang) vi era Jang Qing, terza moglie di
Mao, insieme a Wang Homgwen, Zhang Chunqiao e Yao Wenyuan; essa governò la
Repubblica Popolare Cinese secondo le direttive di Mao durante la rivoluzione
culturale; successivamente, i suoi membri furono processati come spie nazionaliste e
come controrivoluzionari per le atrocità e i fallimenti del “Grande Balzo” e della
rivoluzione. Cfr. L. TOMBA, Storia della Repubblica Popolare Cinese, Milano,
Mondadori, 2002, p. 142.
199
Francesca De Pascalis
che tra la popolazione civile, al suo programma di riforme. Già a partire dal
’78 furono promossi numerosi cambiamenti: il collettivismo di mercato ed il
rigido meccanicismo della pianificazione centralizzata furono gradualmente
abbandonati, a favore di una metodologia di gestione dell’economia pur
sempre dirigistica, ma decisamente più aperta di quella maoista, che negli
anni ’90 sarebbe stata, infine, definita come “socialismo di mercato”. 5 La
riforma economica, avviata da Deng e dal primo ministro Zhao Ziyang,
portò al progressivo smantellamento delle Comuni e provocò ritardi nella
produzione agricola; la liberalizzazione del mercato creò una forte pressione
inflazionistica, da cui trassero profitto solo le fasce più alte della società,
mentre aumentarono il divario e le disuguaglianze tra la popolazione. 6 A
queste riforme, Deng accompagnò sempre alcuni motti propagandistici tra
cui: «Arricchirsi non è un male!», oppure «Avete fame? Chiedete a
Zhao!». 7
La nuova apertura internazionale, fortemente voluta dal leader
riformista, introdusse anche nuove tipologie d’impresa, come le joint
ventures, costituite in Cina con la partecipazione tecnologica ed economica
estera, che violarono il tabù dello sfruttamento del lavoro salariato (cinese)
per fini di profitto privato (straniero), ma che ebbero il grande pregio di
apportare tecnologia e capitali di cui la Repubblica Popolare Cinese aveva
estremo bisogno. Nacquero pure alcune “zone economiche speciali” a
conduzione d’impresa capitalistica, favorite sotto il profilo fiscale e
doganale, con incentivi per gli investitori stranieri (la più importante fu
Shenzen, vicino ad Hong Kong). Venne attuata, anche, una nuova economia
di mercato pianificata, ovvero un sistema che vedeva il capitalismo in Cina
come “il volatile”, e la pianificazione, invece, come la sua “gabbia”, che
poteva assumere dimensioni diverse a seconda dei periodi e che, in quella
fase, tendeva ad allargarsi. 8
Dal punto di vista sociale, e soprattutto dei diritti, lo stesso Deng cercò,
seppur formalmente, di apportare alcune trasformazioni partendo proprio
dalla Costituzione. C’è da sottolineare, però, che durante tutta la rivoluzione
culturale, tanto osannata da Mao, l’illegalità era stata elogiata come un
sentimento rivoluzionario e persino il principio di uguaglianza, previsto
5
Cfr. CAVALIERI, La legge e il rito, cit., p. 159.
Sui cambiamenti politici, economici e sociali della Cina di Deng, cfr. E. CHENG,
Standoff at Tiananmen, Littleton, Sensys Corporated, 2009.
7
Cfr. A. PIAZZA, La Cina di Deng Xiaoping: un lungo cammino verso la
modernizzazione, in «Mondo Cinese», 94, gennaio-aprile 1997, p. 15.
8
Cfr. TOMBA, Storia della Repubblica Popolare Cinese, cit., p. 152.
6
200
Piazza Tiananmen, 1989: la “rivoluzione mancata”
come un cardine dell’ordinamento socialista nella Costituzione del 1954,
era stato criticato per “mancanza di un orientamento di parte”. 9 Con la fine
della rivoluzione, la Repubblica Popolare Cinese aveva approvato, nel 1975,
una nuova Costituzione, che incarnava ancora i “successi” postrivoluzionari, tant’è che l’art. 26 di essa affermava: «Sono diritti e doveri
fondamentali dei cittadini: appoggiare la guida del Partito Comunista
Cinese; sostenere la dittatura del proletariato; osservare la Costituzione e le
leggi della Repubblica Popolare Cinese». 10
Interessante è anche notare che, in questa nuova carta costituzionale, il
capitolo sui “Diritti e i doveri dei cittadini” era l’ultimo capitolo enunciato.
Per riportare lo Stato alla normalità, dopo i disordini ed i processi contro ciò
che la rivoluzione culturale aveva creato, fu approvata, nel ’78, una nuova
Costituzione, contenente solo l’onere maoista della lotta di classe.
Quest’ultima fu modificata più volte, prima nel ’79, e poi nell’80, in
concomitanza con le prime opposizioni al programma riformista della
dirigenza cinese. Lo stesso Deng, infatti, nel 1980, con lo scopo di
rafforzare la stabilità politica, indispensabile nel processo di riforma, chiese
ed ottenne l’eliminazione dalla Costituzione della libertà di parola, di
diffusione delle opinioni, di dimostrazione, di sciopero, 11 di dibattito e di
affissione di grandi dazibao, 12 mentre riaffermava i “quattro principi
cardinali” della dittatura del proletariato, del ruolo guida del partito, del
marxismo-leninismo e del pensiero di Mao. Tutto ciò fu possibile perché
l’art. 35 della Costituzione prevedeva il riconoscimento e la garanzia di tali
libertà fondamentali soltanto se in linea con i “Principi Generali”, che
vietavano ogni sabotaggio ed opposizione al sistema socialista.
9
Cfr. CAVALIERI, La legge e il rito, cit., p. 153.
Ibid., p. 154.
11
Per quanto riguarda il diritto di sciopero, anch’esso non più contemplato nella
nuova Costituzione, la sua abolizione era stata anticipata da molti giuristi cinesi, con
la giustificazione che, essendo la Cina governata dalla classe lavoratrice, l’interesse
nazionale si identificava con quello dei lavoratori stessi, e che, per combattere
eventuali soprusi, sarebbero bastati i mezzi sindacali. Cfr. P. CORRADINI, I diritti
umani nella Costituzione cinese, in «Mondo Cinese», 46, giugno 1984, pp. 1-6.
12
La Costituzione cinese garantiva il diritto di scrivere ed attaccare dazibao
personali, considerati un’importante forma di democrazia rivoluzionaria. Non si
poteva ricoprire o strappare un dazibao senza il consenso dell’autore. Il termine
deriva dall’uso cinese di appendere i giornali in speciali bacheche pubbliche per
permetterne la lettura a tutti. I dazibao si differenziano dai giornali per il fatto di
essere scritti a mano in caratteri grandi e leggibili.
10
201
Francesca De Pascalis
La Costituzione fu sottoposta, nel corso degli anni, ad una serie di
adattamenti, dovuti alle nuove esigenze nel campo dello sviluppo
economico e del commercio internazionale. Infine, nella carta costituzionale
del 1982, il capitolo dei “Diritti e dei doveri del cittadino” (tuttora in vigore)
seguì quello dei “Principi Generali”, come nelle moderne Costituzioni, ma
la sua enunciazione e collocazione rimasero una scelta puramente formale
rispetto alla sua sostanziale applicazione. 13 Relativamente alle tre
Costituzioni precedentemente emanate, il posto assegnato al capitolo dei
diritti, pur non avendo alcun significato sostanziale, assunse, comunque, un
valore formale e simbolico per la Repubblica Popolare Cinese e per la
comunità internazionale.
2. Le prime opposizioni al programma di riforma di Deng
Verso la fine del 1984 vennero accelerate ulteriormente le riforme
economiche che portarono ad un aumento dei prezzi, da cui trasse profitto
solo quella fascia di giovani imprenditori, figli di quadri di medio o alto
livello, che approfittarono dell’arrivo del capitale straniero. Ad esse
seguirono anche le prime critiche all’interno del partito, soprattutto da parte
di Hu Yaobang, allora segretario, nel quale si identificarono molti circoli
intellettuali e gruppi di giovani studenti. Per tale motivo, nella primavera
del 1985, il segretario Yaobang subì gli attacchi dell’ala più conservatrice
del partito, contraria ad una liberalizzazione borghese e ostile
all’atteggiamento troppo liberale di Hu nei confronti della stampa. 14 Ma
questo atteggiamento più liberale in campo culturale e politico non bastò a
calmare l’insoddisfazione generata dalla nuova economia. Cominciarono a
crearsi conflitti sociali legati proprio alla nuova stratificazione sociale e a
darne voce furono soprattutto gli studenti. Il 21 novembre 1985, la vittoria
dei cinesi in una partita di pallavolo con il Giappone fu il pretesto per molti
studenti per manifestare in Piazza Tiananmen contro la nuova
“colonizzazione” del capitale straniero, in particolare di quello giapponese.
Quel giorno, un aviatore anonimo distribuì volantini anti-giapponesi sui
cinquemila studenti che si erano radunati in Piazza Tiananmen, 15 che
13
Cfr. L. FENG, La storia moderna del diritto costituzionale cinese, in P. COSTA – D.
ZOLO, a cura di, Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica, Milano, Feltrinelli, 2003.
14
Cfr. TOMBA, Storia della Repubblica Popolare Cinese, cit., pp. 153-154.
15
Cfr. U.S. Embassy Beijing Cable, A Student Demonstration of Sorts in Tiananmen
Square, November 21, 1985, Secret, in Tiananmen Square 1989 (The Declassified
History), A National Security Archive Briefing Book [d’ora in avanti NSAEBB], ed.
202
Piazza Tiananmen, 1989: la “rivoluzione mancata”
condannavano anche quei principi che avevano favorito l’“uneven
development”, cioè lo sviluppo disuguale di quel periodo (con chiari
riferimenti ai membri del PCC). La manifestazione venne dispersa con
l’intervento della polizia, anche perché il partito era a conoscenza della
manifestazione grazie alle infiltrazioni governative tra gli studenti che
avevano organizzato le dimostrazioni; successivamente, fu quindi facile
arrestare i responsabili ed i capibanda. 16
Le contestazioni continuarono in Piazza Tiananmen, come all’Università
di Pechino, dove gli studenti denunciarono i problemi relativi alle
condizioni di studio e la presenza del People’s Liberation Army (PLA)
all’interno del campus; 17 una minoranza di loro si radunò in piazza per
protestare contro i test nucleari fatti nella provincia dello Xinjang. La
vicenda di Tiananmen si ricollega, infatti, ad una serie di manifestazioni
diffusesi in molte altre residenze universitarie, tra le più qualificate del
paese, tra il 1986 e l’inizio dell’87, quando gli studenti scesero in campo per
sostenere e difendere i tentativi di affiancare alle ardite riforme economiche
una riforma politica che modificasse le basi del monopolio del potere da
parte del PCC ed aprisse spazi, se non alla partecipazione ed alla
democrazia, almeno ad una maggiore “trasparenza”, ad una libertà di analisi
dei fatti e di circolazione delle idee. 18 In questo periodo, il partito e il
Consiglio di Stato ricevette almeno cinquanta rapporti sul comportamento
degli studenti dalla Commissione per l’istruzione, dall’agenzia di stampa
Xinhua, dai governi provinciali e locali. Tra i problemi menzionati dalle
autorità figuravano, soprattutto, l’insofferenza degli studenti per i vincoli
ideologici, i bassi stipendi degli intellettuali, il crescente costo della vita,
l’insoddisfazione per le politiche sullo studio all’estero e il lassismo dei
responsabili dell’educazione politica nella scuola superiore. Nel rapporto si
legge, infatti, che le discussioni tra gli studenti si concentravano spesso su
questioni del tipo: «I figli degli ufficiali di rango elevato ottengono incarichi
prestigiosi!», o ancora, «I figli di ufficiali di rango elevato fanno carriera
più facilmente!». Gli studenti erano, inoltre, frustrati, secondo le autorità,
by M.L. EVANS, 2001, doc. 1.
16
Cfr. U.S. Embassy Beijing Cable, Government Arrest Student Demonstrators,
November 25, 1985, Confidential, in NSAEBB, doc. 2.
17
Secondo le fonti dell’ambasciata, erano più di 2.000 a protestare presso
l’Università di Pechino. Cfr. U.S. Embassy Beijing Cable, More Student
Demonstration, December 23, 1985, ibid., doc. 3.
18
Sull’argomento, si veda M.A. LUSTED, Tiananmen Square Protests, Edina, MN,
Abdo Publishing Co., 2010.
203
Francesca De Pascalis
dai cambiamenti della linea di propaganda ufficiale dei media.
Anteriormente alla prima protesta studentesca del 1985, i giornali tenevano
in grande considerazione gli studenti,come se fossero “favoriti dal cielo”,
invece, dopo le proteste di quell’anno i media li accusavano di avere uno
stile di vita stravagante, con frasi tipo: «la classe operaia non è d’accordo
[sul vostro tenore di vita]» e « [siete solo] una piccola manciata». 19
Gli editoriali cinesi, perciò, continuarono a riportare la volontà del
partito di utilizzare maggiormente la forza di fronte alle continue minacce di
instabilità politica del paese da parte dei manifestanti e ancor di più se a loro
si fossero uniti i lavoratori. 20 Deng si rese presto conto che i timori
dimostrati dalla Banda dei Vecchi 21 erano sempre più tangibili e si vide
costretto ad affiancare ai suoi moti propagandistici di rilancio economico
(tra cui «Non importa se il gatto è bianco o è nero, purché acchiappi i
topi»), 22 severe misure politiche per ristabilire l’ordine anche all’interno del
partito. La carica di segretario generale, detenuta da Hu, fu affidata a Zhao
Ziyang, dopo che all’ex segretario furono attribuite le responsabilità del
diffondersi del “liberalismo borghese”, così da costringerlo a presentare al
Comitato Centrale una lettera di autocritica. 23 Hu si era sempre rifiutato di
condannare le manifestazioni, ritenendo che la svolta democratica fosse
necessaria al proseguimento del processo di riforma; il suo nome, perciò,
rimase sempre legato a quello degli studenti. In concomitanza con la
rimozione di Hu Yaobang, vennero annunciate le espulsioni dal PCC del
giornalista Wang Ruodwang, accusato di aver sostenuto la liberalizzazione
borghese nella sua attività giornalistica soprattutto negli ultimi due anni,
dell’astrofisico Fang Lizhi 24, per aver negato la funzione del marxismo ed
19
Excerpt from State Education Commission, “Report to Party Central and the
State Council on Student Protests in the 1980s and the Current Ideological State of
College Students”, July 19, 1988, in Tiananmen, cit., pp. 14-16.
20
Cfr. U.S. Embassy Beijing Cable, Student Demonstration Update, December 24,
1986, in NSAEBB, doc. 4.
21
La Banda dei Vecchi era costituita da Chen Yun, Li Xiannan e Peng Zhen e
rappresentava l’ala conservatrice del partito, più critica nei confronti dell’apertura
internazionale e sociale che stava avvenendo in Cina di pari passo con le riforme
economiche.
22
Cit. in F. RAMPINI, Il secolo cinese. Storie di uomini, città e denaro dalla fabbrica
del mondo, Milano, Mondadori, 2006, p. 124.
23
Cfr. Summary of IPAC Daily Intelligence, China: Hu Yaobang Resigns, January
17, 1987, in NSAEBB, doc. 6.
24
Cfr. M. OKSENBERG – L.R. SULLIVAN – M. LAMBERT, “Intellectual Dissent”, in
204
Piazza Tiananmen, 1989: la “rivoluzione mancata”
aver sostenuto l’omologazione della Cina ai paesi dell’Occidente
capitalistico, e del saggista Liu Biyan, giornalista del «Renmin Ribao», che
era stato il più attivo nel denunciare corruzione e reticenze e che venne
anche allontanato dal giornale. 25
Per riacquistare popolarità tra gli studenti (e non solo), e per indurre tutti
ad appoggiare le sue scelte, Deng esaltò le doti di grande economista di
Zhao Ziyang con degli slogan del tipo: «Avete fame? Rivolgetevi a
Zhao». 26 Contemporaneamente, per non perdere potere all’interno del
partito, favorì l’elezione di Li Peng (dell’ala conservatrice) al posto di
primo ministro.
Deng, ormai ottantatreenne, accompagnò tutte queste manovre con un
annuncio strategico: il suo ritiro dalla scena politica; di tutte le sue cariche
avrebbe conservato solamente quella di presidente della Commissione
Militare, ed a lui e ad altri otto membri della Commissione Centrale sarebbe
spettato il compito di dirimere tutte le questioni importanti su cui la
dirigenza del partito non avesse trovato un’intesa. 27
3. La “primavera di Pechino” e il massacro di Piazza Tiananmen
La liberalizzazione dei prezzi, voluta da Zhao Ziyang durante l’estate del
1988, scatenò accesi dibattiti tra la popolazione e nel partito, dove la
proposta trovò l’opposizione delle componenti più conservatrici, tra cui Li
Peng. Quest’ultimo, forte del consenso di Deng, contrariamente a Zhao,
riteneva fosse necessario mettere davanti a tutto la stabilità del paese,
contestando le scelte, la figura e il ruolo del segretario Ziyang nel partito.
Per Deng, intanto, continuò ad essere necessaria la realizzazione di un
contesto internazionale stabile e pacifico, in quanto per troppo tempo la
Cina era rimasta isolata dal mondo e ciò non aveva giovato alla sua
economia e al suo arricchimento; per questo motivo, l’obiettivo principale,
per Deng, era il cammino della Repubblica Popolare Cinese verso una
nuova apertura con l’estero, continuando, così, il percorso che il suo
maestro e predecessore, Zhou Enlai, aveva iniziato con l’incontro tra Nixon
Beijing Spring, 1989: Confrontation and Conflict. The Basic Documents, New York,
M.E. Sharpe, 1990, pp. 151-180.
25
Cfr. E. COLLOTTI PISCHEL, Dietro Tia an men, Milano, Angeli, 1990, p. 148.
26
Cit. in PIAZZA, La Cina di Deng Xiaoping, cit., p. 15.
27
Questa decisione, rimasta a lungo segreta, fu rivelata da Zhao Ziyang nel 1989,
durante i colloqui con Gorbačev. Cfr. TOMBA, Storia della Repubblica Popolare
Cinese, cit., p. 159.
205
Francesca De Pascalis
e Mao. 28 A tal proposito, il “piccolo timoniere” continuò ad affermare, però,
che, «senza la guida del partito, ci sarebbero stati certamente disordini
ovunque e [che] la Cina si sarebbe disgregata», 29 evidenziando che il
partito, come massima fonte del governo, avrebbe potuto, da una parte,
promuovere le riforme politiche e, dall’altra, servire da garante finale della
stabilità (politica) in caso di errori nel processo di riforma.
È in questo clima d’incertezza che, nel mese di febbraio dell’89, il
presidente degli Stati Uniti, George Bush, si recò in Cina in visita ufficiale.
Il viaggio assunse un’importanza simbolica in vista della visita di metà
maggio del presidente sovietico Mikhail Garbačev. Fondamentale fu, per
Bush e i suoi collaboratori, assicurarsi che i nuovi colloqui intrapresi dalla
Cina con l’Unione Sovietica non andassero ad intaccare la collaborazione
strategica preesistente tra i due paesi. 30 Fu proprio l’equipe del presidente
americano ad evidenziare, nei primi rapporti giunti a Washington da
Pechino, che l’instabilità interna al paese e nel partito era ormai evidente,
tanto da poter sfociare in una potenziale crisi interna alla Cina. Capro
espiatorio dell’insoddisfazione che cresceva tra studenti e lavoratori fu
Zhao, che subì una vera e propria campagna denigratoria da parte dei gruppi
più conservatori del partito. 31
Il 25 febbraio, il presidente degli Stati Uniti arrivò in Cina, con molti
argomenti all’ordine del giorno, ma già nell’organizzazione del banchetto di
benvenuto si verificò il primo incidente diplomatico. Nella lista degli ospiti
furono inseriti noti dissidenti, tra cui Fang Lizhi e sua moglie, per dare
risalto al rispetto dei diritti umani, su cui l’amministrazione americana
continuava ad insistere. 32 Naturalmente, la dirigenza cinese non accolse di
buon grado la proposta americana di invitare Fang al banchetto, anche se fu
costretta ad accettare un compromesso: il dissidente avrebbe avuto un posto
a tavola in una posizione tale da non permettergli né alcun contatto con
28
Su tale argomento, cfr. Memorandum of Conversation Nixon-Zhou Enlai,
Monday, February 21, 1972, in U.S. NATIONAL ARCHIVE [d’ora in avanti NARA],
Nixon President Material Collection [d’ora in avanti NPM], President’s Office Files,
Memoranda for President, Box 87, “Beginning February 20, 1972” .
29
PIAZZA, La Cina di Deng Xiaoping, cit., p. 15.
30
Cfr. U.S. Embassy Beijing Cable, The President’s Visit to China: Suggestion
Regarding What We and the Chinese Hope to Acomplish, February 6, 1989, in
NSAEBB, “The U.S. Tiananmen Papers” [d’ora in avanti USTP], Secret, doc. 1.
31
Cfr. CIA DIRECTORATE OF INTELLIGENCE REPORT, China: Potential for Political
Crisis, February 9, 1989, in NSAEBB, USTP, Confidential, doc. 2.
32
Cfr. TOMBA, Storia della Repubblica Popolare Cinese, cit., p 155.
206
Piazza Tiananmen, 1989: la “rivoluzione mancata”
Bush, né con i leaders cinesi. 33 Costoro, inoltre, accettando malvolentieri la
volontà dell’amministrazione americana, riuscirono anche ad impedire,
predisponendo una serie di ostacoli, l’arrivo di Fang al banchetto prima che
questo terminasse. La cosa non turbò affatto il banchetto di benvenuto, tanto
che lo stesso George Bush esordì, nel suo discorso, con un vecchio
proverbio cinese: «Una generazione pianta un albero e la prossima si
siederà sotto la sua ombra»; 34 con tale frase, il presidente intendeva
evidenziare il cambiamento dinamico e la crescita straordinaria di un paese,
che, nonostante le trasformazioni, conservava una profonda e millenaria
cultura. Bush ribadì, infatti, il ruolo determinante della Cina nel mondo,
grazie alla sua apertura internazionale ed alla sua collaborazione per una
nuova e duratura pace, prosperità e leadership mondiale. Il neo-presidente
spiegò come differenti fossero le relazioni tra i due paesi rispetto alla sua
prima visita in Cina nel 1974, 35 anno in cui i due paesi cominciarono, dopo
quasi un quarto di secolo, ad instaurare rapporti pacifici e di collaborazione
reciproca che portarono alla firma del Comunicato di Shangai, 36 ben 17 anni
prima. Alla TV cinese Bush affermò: «I nostri paesi si trovano di fronte a
molte sfide e insieme dobbiamo trovare soluzioni politiche ai conflitti
regionali […]. In quanto membri delle Nazioni Unite e potenze nucleari, i
nostri paesi hanno il dovere di preservare la pace nel mondo e la stabilità
internazionale, favorendo il disarmo e il dialogo con paesi come l’Unione
Sovietica […]». 37
Le dichiarazioni del presidente americano non servirono, però, a placare
33
Cfr. U.S. Embassy Beijing Cable, President’s Banquet – Chinese Guest List,
February 18, 1989, in NSAEBB, USTP, Limited Official Use, doc. 5.
34
Toast at the Welcoming Banquet in Beijing, February 21, 1972, in
http://beijing.usembassy-china.org/cn.
35
Il presidente Bush aveva lavorato durante la presidenza Ford, dal 1974 al 1976,
come principale funzionario di collegamento tra Stati Uniti e Repubblica Popolare
Cinese, prima della costituzione di relazioni diplomatiche ufficiali.
36
Il 27 febbraio 1972, la Cina e gli Stati Uniti rilasciarono il loro primo comunicato
congiunto, con cui entrambe le nazioni si impegnavano a lavorare verso la piena
normalizzazione delle relazioni diplomatiche. Tale comunicato è noto anche come
Shangai Communique. Cfr. Joint Communique of the United States of America and
People’s Republic of China (Shangai Communique), February 28, 1972, in
http:/www.chinaorg.cn/english/china-us/26012html.
37
We Value the New Relationship, in Press Conference by President Bush (Extract),
June 5, 1989, in U.S. DEPARTMENT OF STATE, American Foreign Policy Current
Documents, N.L. GOLDEN – S. BROWN WELLS, eds., Washington, DC, U.S.
Government Printing Office, 1990, p. 513.
207
Francesca De Pascalis
gli animi della popolazione cinese. Dopo la partenza di Bush, infatti, a
scatenare la protesta studentesca fu il diffuso senso di commozione per la
morte di Hu Yaobang, il 15 aprile 1989, che fece da detonatore per la
ripresa delle attività politiche e delle contestazioni. Dal momento della
morte di Hu fino alla mattina del 17 aprile, arrivarono al partito centrale e al
Consiglio di Stato almeno cinquanta rapporti inviati dai governi locali e dai
ministeri della Sicurezza. Negli anni Ottanta Hu si era guadagnato la
reputazione di acceso fautore di una politica che facesse uscire la Cina dalle
soffocanti costrizioni che avevano caratterizzato gli anni di Mao. Sebbene
quasi tutti i cinesi fossero soddisfatti della valutazione di Hu da parte del
Centro, alcuni lamentarono che non gli era stato riservato sufficiente
rispetto negli anni successivi al suo ritiro forzato. 38 L’analisi di più di
settecento manifesti, distici ed elogi funebri, da parte dei ministeri della
Sicurezza, evidenziarono che i contenuti riguardavano tre concetti
essenziali: normali espressioni di cordoglio (la maggior parte), proteste
contro le ingiustizie subite in vita dal Compagno Hu Yaobang e attacchi
provocatori contro l’attuale situazione sociale. 39 Il 22 aprile si svolsero i
funerali di Hu e gli studenti si riunirono in Piazza Tiananmen, prendendo
d’assedio Porta Xinhua, per salutare il feretro dell’esponente riformista.
Dopo due notti di tumulti a Porta Xinhua, Li Peng, parlando con Luo Gan,
segretario generale del Consiglio di Stato, gli confidò che la situazione stava
loro sfuggendo di mano. Ordinò, quindi, alla Commissione di insistere
perché ogni Università si adeguasse allo spirito del partito centrale,
esigendo che il governo municipale intraprendesse un’azione decisa; come
conseguenza, le autorità municipali dichiararono provvisoriamente la legge
marziale nella zona di Porta Xinhua. 40 Continuarono i disordini in tutto il
paese e folle di giovani studenti, sfidando il divieto delle autorità, 41
38
April 15-17: Initial Reaction at Home and Abroad, in Tiananmen, cit., pp. 23-24.
Excerpts from Beijing Municipal Government, “Report on Mourning Activities for
Comrade Hu Yaobang at Beijing Institutions of Higher Education”, April 18, in
Tiananmen, cit., pp. 27-28.
40
Beijing Municipal Party Committee and Beijing Municipal People’s
Governments, “Trends Worth Close Attention during the Mourning for Comrade Hu
Yaobang at Beijing Institutions of Higher Education”, April 20, in Tiananmen, cit.,
pp 33-35.
41
La notte del 18 aprile, un gruppo di studenti si radunò sotto la residenza dei
dirigenti per contestare la politica del PCC, ma esso fu allontanato dall’intervento
della polizia. Da allora, le autorità cinesi vietarono le manifestazioni in piazza
Tiananmen. Cfr. COLLOTTI PISCHEL, Dietro Tian an men, cit., p. 157.
39
208
Piazza Tiananmen, 1989: la “rivoluzione mancata”
occuparono permanentemente Piazza Tiananmen, avanzando delle richieste.
I dirigenti del partito, però, ignorarono le istanze dei dimostranti e, di
conseguenza all’Università di Pechino fu indetto lo sciopero generale da
parte della nuova Federazione Autonoma degli Studenti, la FAS. 42
All’interno del PCC si contrapposero due diverse posizioni sulla linea da
tenere con i manifestanti: da una parte, il segretario Zhao Ziyang si espresse
a favore del dialogo; dall’altra, Li Peng, favorevole ad adottare una linea più
dura, cercò una autorevole alleato nel leader Deng Xiaoping. 43 Nei giorni
seguenti, Li Peng, parlando con Deng, disse: «Compagno Xiaoping, con la
situazione che si evolve così rapidamente, i membri del Comitato
permanente sono d’accordo che la situazione a Pechino è grave […]. Alcuni
dei manifesti di protesta e degli slogan sono antipartitici e antisocialisti.
Chiedono un ribaltamento del verdetto sull’inquinamento spirituale e la
liberalizzazione borghese. Le critiche sono rivolte direttamente a te e agli
altri appartenenti alla generazione dei rivoluzionari proletari». 44
Continuando nel convincimento della natura anti-governativa del
Movimento per la Democrazia, Cheng Xitong, sindaco di Pechino e
membro del Consiglio di Stato, riferì a Deng che all’Università di Pechino
alcuni studenti avevano imitato il movimento di solidarietà polacca,
formando una loro Unione Studentesca di Solidarietà. 45 In risposta a ciò, il
26 aprile uscì un editoriale sul «Quotidiano del Popolo», che accusava gli
studenti di sedizione e cospirazione, mettendo, così, il movimento fuori
dalla legalità. 46 Ad esso seguì una tra le più importanti manifestazioni del
movimento studentesco, segnando la prima vera sfida aperta su larga scala
al governo cinese e il cui successo determinerà, poi, le dinamiche
successive del movimento fino alla repressione. 47 Nel pomeriggio del 1°
maggio, Zhao Ziyang, di ritorno dal suo viaggio in Corea, presiedette una
42
Excerpt from Beijing Municipal Party Committee and Beijing Municipal People’s
Government, “Bulletin: Peking University Students Prepare to Establish a United
Student Association”, Bulletin to Party Central and State Council Duty Officies,
April 20, in Tiananmen, cit., pp. 36-37.
43
Cfr. D. LU, Do Not Forget the Young Man Who Defied the Tanks, May 26, 2009,
in http://www.asianews.it-CHINA-Tiananmen.
44
Excerpt from Party Central Office Secretariat, “Important Meeting Minutes”, in
Tiananmen, cit., p. 71.
45
Ibid., p. 72.
46
Cit. in TOMBA, Storia della Repubblica Popolare Cinese, cit., p. 162.
47
Cfr. Z. DINGXIN, The Power of Tiananmen: State-Society Relations and the 1989
Beijing Student Movement, Chicago, The University of Chicago Press, 2001, p. 255.
209
Francesca De Pascalis
riunione del Comitato Centrale del Politburo, durante la quale espose la sua
linea evidentemente discordante con le intenzioni e le impressioni del
compagno Li Peng e degli Anziani del partito. Zhao Ziyang disse, infatti:
«Il partito deve adattarsi ai nuovi tempi e alle nuove situazioni e imparare
ad usare la democrazia e la legge per risolvere nuovi problemi […].
Dobbiamo far sentire alla gente che sotto la guida del Partito comunista e
del sistema socialista può godere pienamente e oggettivamente della
democrazia e della libertà. Il socialismo può dimostrare la propria
superiorità diventando più attraente agli occhi del popolo […]. D’ora in poi,
la funzione importante della direzione del partito dovrebbe essere quella di
guidare il popolo nella costruzione di un sistema di legalità e democrazia,
per trasformare il nostro paese socialista in un paese effettivamente
governato dalla legge». 48
Intanto, il 4 maggio, decine di migliaia di studenti di cinquantuno
università sfilarono lungo il viale di Changan e in Piazza Tiananmen ed uno
dei capi degli studenti, sotto l’insegna del FAS, lesse la Dichiarazione del 4
maggio. Essa chiariva che il movimento era una continuazione ed uno
sviluppo del grande movimento patriottico degli anni Settanta. Aveva in
comune con il governo il fine ultimo della modernizzazione della Cina e
sosteneva i valori della democrazia, della scienza, della libertà, dei diritti
umani e della legalità. 49 Ad esso seguirono nuove e più importanti
manifestazioni (con evidente riferimento al Movimento del 1919), 50 durante
le quali i manifestanti minacciarono lo sciopero della fame e Zhao,
contrariamente alla linea adottata dai vertici del partito, cercò di convincere
gli studenti a rientrare nelle scuole.
In risposta agli appelli della FAS e delle organizzazioni studentesche
autonome delle università, il pomeriggio del 10 maggio più di diecimila
studenti di Pechino percorsero in bicicletta le strade della città, distribuendo
copie della loro richiesta di dialogo e altro materiale di stampa. Gli studenti
in corteo si fermarono a gridare slogan davanti ai maggiori organi di
48
Excerpt from party Central Office Secretariat, “Minutes of Politburo Standing
Committee Meeting”, May 1, in Tiananmen, cit., pp. 102-108.
49
May 4. The “May Fourth Declaration”, in Tiananmen, cit., p. 113.
50
Il “Movimento del 4 Maggio” del 1919 nacque in conseguenza della decisione
presa dalle potenze europee, vincitrici della guerra, di assegnare i possedimenti
tedeschi in Cina al Giappone, calpestando, così, la sovranità del paese. In tal modo,
la situazione mutò radicalmente, dando nuovo slancio alle forze della Cina moderna.
Cfr. J. GUILLERMAZ, Storia del partito comunista cinese, 1921-1949, Milano,
Feltrinelli, 1973, p. 44.
210
Piazza Tiananmen, 1989: la “rivoluzione mancata”
informazione, giungendo persino alla sede centrale del «Quotidiano del
Popolo». 51 L’indifferenza delle autorità cinesi, comunque, radicalizzò
ulteriormente le loro richieste: non solo essi pretendevano un
riconoscimento di legittimità della loro protesta, ma criticavano anche la
corruzione del partito ed il ritorno al conservatorismo da parte di Deng
Xiaoping, chiedendo la concessione di riforme politiche democratiche.
In Occidente cominciò a circolare largamente un documento con cui i
dimostranti annunciavano lo sciopero della fame e dichiaravano: «[…] La
democrazia non è un affare che riguardi poche persone; la battaglia
democratica non può essere vinta da una sola generazione […]. Noi
chiediamo la riabilitazione del nostro movimento, che è solo patriottico e
democratico». 52
A differenza delle proteste del 1987, a queste ultime si unirono anche i
lavoratori, che, allarmati dalla crescente inflazione e corruzione, erano
giunti da molte città per esprimere la loro solidarietà agli studenti. I
malumori all’interno del partito divenivano sempre più evidenti e le diverse
posizioni sulle politiche da adottare più marcate. Questa situazione riaffiorò
proprio nel discorso tra Zhao e Deng a pochi giorni dalla visita del
presidente Gorbačev in Cina. Il 13 maggio, infatti, Zhao, in visita a Deng,
esordì dicendo: «Compagno Xiaoping, il movimento studentesco è nato
improvvisamente ad aprile e tutti hanno cercato di sopirlo il più in fretta
possibile. Ho notato, però, che questo movimento ha due peculiarità: primo,
gli slogan degli studenti appoggiano la Costituzione […], in linea con
quanto sostengono il partito e il governo; pertanto non possiamo respingerle
in toto. Secondo, il numero di simpatizzanti e dimostranti è enorme e di
ogni provenienza sociale». Deng rispose: «Era chiaro sin dall’inizio che una
piccola minoranza stava sobillando la maggioranza, fomentando le
inquietudini», ma Zhao continuò: «Ecco perchè dobbiamo separare la massa
degli studenti dalla piccola minoranza che cerca di creare confusione.
Dobbiamo affidarci al nostro ruolo di guida: perseguire un dialogo a più
livelli e su più canali, entrare in contatto con la gente e costruire un’intesa».
Ma il piccolo timoniere replicò: «Il dialogo va bene, ma il punto è risolvere
il problema. Non possiamo farci prendere per il naso. Questo movimento si
è trascinato troppo a lungo, ormai è quasi un mese […]. Tiananmen è il
simbolo della Repubblica Popolare Cinese. La piazza deve essere in ordine
all’arrivo di Gorbačev. Dobbiamo mantenere la nostra immagine
51
52
Beijing Bicycle Demonstration, in Tiananmen, cit., p. 139.
Cit. in COLLOTTI PISCHEL, Dietro Tian an men, cit., pp. 163-166.
211
Francesca De Pascalis
internazionale. Che figura ci faremo se la piazza è nel caos?». 53
A metà maggio, però, dopo un’apparente tregua, le manifestazioni
ripresero in occasione proprio della visita storica del segretario del PCUS,
Mikhail Gorbačev, visita che segnò la ripresa delle relazioni diplomatiche
fra i due paesi, interrotte per più di 19 anni; Gorba
čev stesso venne preso
come esempio di riformatore democratico nel suo paese. Nonostante
l’arrivo del leader sovietico, il 15 maggio a Pechino gli studenti non
mutarono atteggiamento, continuando lo sciopero della fame sulla piazza,
forti dell’appoggio crescente della popolazione e delle autorità locali. La
stampa internazionale, convenuta nella capitale per l’incontro tra i dirigenti
sovietici e quelli cinesi, considerò il movimento democratico, che ormai
aveva superato i limiti del mondo studentesco, come l’evento principale del
momento. Vennero riproposti in tutto il mondo gli slogan dei manifestanti,
tra cui «La democrazia e la legge sono garanzie di stabilità sociale», oppure
«Il popolo ha diritto di conoscere i fatti, di partecipare e di controllare gli
affari dello Stato». 54 Nella Dichiarazione della fame e nel manifesto affisso
nell'Università di Pechino si leggeva: «La nazione è in crisi: soffocata dalla
crescente inflazione, dai traffici illegali dei funzionari disonesti, da abusi di
potere, burocrati corrotti, dalla fuga di persone valide verso altri paesi e dal
decadimento della legge e dell’ordine […]. La democrazia è la più nobile
aspirazione umana, la libertà è un sacro diritto umano […], questo sciopero
della fame ci è imposto. Non abbiamo scelta […]». 55 Nella piazza venne
pure innalzata, in segno provocatorio, una gigantesca statua di cartapesta
alta quasi 10 metri, che rappresentava la “Dea della Democrazia” e che
assomigliava alla Statua della Libertà newyorkese. 56
Se, da una parte, il viaggio di Gorbačev portò alla normalizzazione delle
relazioni tra i due paesi, dall’altra la situazione tra dirigenti e manifestanti si
radicalizzò del tutto. Secondo un rapporto del ministero della Sicurezza, il
numero degli studenti in sciopero della fame continuò a crescere, a dispetto
dei continui appelli a desistere. Nella notte, gli abitanti della città vennero
ripetutamente svegliati dalle sirene delle ambulanze, che portavano via gli
studenti in preda al collasso. Buona parte della cittadinanza scese in strada e
53
Excerpt from Memoranda of Conversations Supplied by a Friend of Yang
Shangkun Who Cannot Be Further Identified, in Tiananmen, cit., pp. 147-149.
54
Ibid., pp. 150-151.
55
Original Handbills Provided by the Public Security Ministry to Party Central and
the State Council, May 13, in Tiananmen, cit., pp. 153-155.
56
Cfr. Secretary of State Morning Summary for June 2, 1989, China: Stalemate
Continues, Confidential, in NSAEBB, doc. 8.
212
Piazza Tiananmen, 1989: la “rivoluzione mancata”
si unì ai cori di richiesta di dimissioni del gruppo dirigente. Il ministero
stimò che i dimostranti in quei giorni fossero complessivamente un milione
e duecentomila. In base a tale rapporto, i manifestanti risultavano provenire
dalle scuole, dalle fabbriche, dagli uffici governativi di tutti i livelli, dai
settori della comunicazione e da altri posti. 57 Tra il 19 e il 20 maggio, subito
dopo la partenza del leader sovietico, nel pieno della crisi di fronte
all’immobilismo dei massimi dirigenti del partito, fu Deng Xiaoping a
prendere l’iniziativa, emanando un’ordinanza firmata da tutti i dirigenti, ad
eccezione di Zhao Ziyang, che proclamava l’introduzione della legge
marziale, per dare un segnale ancora più forte agli studenti. Deng consegnò
un rapporto alla Commissione Centrale Militare, la CCM, sul
dispiegamento delle truppe a Pechino; l’ordine finale, emanato a nome di
Deng, recitava così: «In conformità all’art. 89, comma 16, della
Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, il Consiglio di Stato ha
deciso di instaurare la legge marziale in alcune zone di Pechino a partire dal
giorno 21 maggio 1989. Le varie unità hanno l’ordine di prendere posizione
nelle aree designate di Pechino». 58 Questo fatto è molto importante se si
considera che la legge marziale, nella storia della Repubblica Popolare
Cinese, era stata proclamata una sola volta a Lasha, capitale del Tibet, ed
ora si trattava di dichiararla a Pechino, capitale dello Stato.
Intanto, Zhao, dopo aver fatto visita agli studenti, si recò direttamente
nel suo ufficio e stilò una lettera di dimissioni indirizzata al Comitato
permanente del Politburo e al compagno Xiaoping: «Dopo lunghe
riflessioni sono giunto alla conclusione che, dato il mio attuale livello di
consapevolezza e il mio stato d’animo, non posso acconsentire alla vostra
decisione di imporre la legge marziale a Pechino. Rimango ancora della mia
opinione. Di conseguenza, chiedo di dimettermi da segretario generale del
Partito Comunista Cinese e da primo vice-presidente della Commissione per
gli Affari Esteri». 59
Davanti a ciò, lo stesso Deng allontanò Zhao dal partito e nominò al suo
posto il tecnocrate Jang Zemin. L’ex segretario riformista, però, prima di
abbandonare il quartier generale del PCC, scese in piazza tra gli studenti
cercando di convincerli ad interrompere lo sciopero della fame e
l’occupazione della piazza e promettendo che le loro ragioni sarebbero state
57
A Million-Person Demonstration in Beijing, in Tiananmen, cit., pp. 193-194.
Excerpt from Central Military Commission Office, “Minutes of Central Military
Commission meeting”; May 18, as Excerpted in Central Party Office Secretariat,
“Daily Report” (Meiri yibao), May 19, in Tiananmen, cit., p. 212.
59
May 18: An Unsent Letter of Resignation, in Tiananmen, cit., p. 199.
58
213
Francesca De Pascalis
ascoltate. 60 Le sue parole recitavano così: «Il vostro entusiasmo per la
democrazia e la legge, per la lotta alla corruzione e per l’avanzamento della
riforma è di estremo valore. Il centro prende molto seriamente le vostre
opinioni e richieste ragionevoli, e le studierà immediatamente e con
attenzione. Vogliamo migliorare ogni settore del partito e del governo, e
speriamo che voi tutti torniate in salute […]. Quindi, vi prego di non
continuare il digiuno. Siete giovani e avete molto tempo davanti per dare il
vostro contributo alla nazione e al popolo, quindi dovreste per prima cosa
prendervi cura della vostra salute». 61 Tuttavia, egli non fu ascoltato e
l’episodio decretò anche la fine della sua carriera politica. Solo
successivamente avrebbe dichiarato che il tentativo di dialogo con gli
studenti era presente nell’agenda del partito da molti giorni, in quanto gli
stessi dirigenti temevano che, dopo una settimana di occupazione e di
sciopero della fame, sarebbe aumentato il rischio di creare dei martiri, che
avrebbero potuto destabilizzare ancora di più il regime, senza contare la
crescente simpatia di cui gli studenti erano oggetto tra la popolazione. 62
Molteplici furono le reazioni degli organi internazionali presenti a
Pechino in quei giorni; la stessa ambasciata americana sostenne che quanto
stava accadendo era una conseguenza della nuova apertura della società
cinese, un’apertura attuata per conquistare il sostegno popolare alle riforme,
ma che aveva reso più difficile, per i dirigenti cinesi, imporre la propria
volontà alla popolazione civile, e che tali iniziative avrebbero finito per
provocare uno stallo non soltanto nel processo di riforma economica, ma
anche e soprattutto in quello politico e sociale. 63
All’inizio, le autorità cinesi esclusero l’occupazione militare di scuole e
università, anche se in tali istituzioni vennero insediati direttori militari,
coadiuvati da collaboratori del governo in tutti i mass media. Furono
ampliate anche le restrizioni sulla stampa e proibita la copertura dei media
sulle dimostrazioni degli studenti, costringendo, così, i giornalisti stranieri a
richiedere l’approvazione del governo cinese
per i vari servizi
60
Quella fu l’ultima apparizione di Zhao Ziyang, che, da allora, fu costretto agli
arresti domiciliari. Su tale argomento, cfr. TOMBA, Storia della Repubblica Popolare
Cinese, cit., p. 163.
61
May 19: Zhao Ziyang’s Sorrowful Speech, in Tiananmen, cit., p. 217.
62
Cfr. G. SAMARANI, Zhao Ziyang e la Primavera di Pechino. Nuovi documenti e
testimonianze, in «Mondo Cinese», 128, luglio-settembre 2006, pp. 4-8, in
http://www.tuttocina.it/Mondo_Cinese/128.
63
Cfr. CIA INTELLIGENCE ASSESTMENT, Perspective on Growing Social Tension in
China, May 1989, Secret, in NSAEBB, USTP, doc. 9.
214
Piazza Tiananmen, 1989: la “rivoluzione mancata”
d’informazione. 64 Nonostante il divieto imposto dalle autorità, tuttavia, le
manifestazioni continuarono, sia con l’occupazione della piazza da parte
degli studenti, intellettuali e cittadini, intervenuti a sostegno del movimento
di protesta, sia con l’organizzazione di blocchi stradali generalizzati contro
l’irrompere delle truppe. Fin dal momento del loro ingresso in città, le forze
armate incontrarono una resistenza passiva di massa nei sobborghi e non
riuscirono ad entrare nel centro urbano. Gli Anziani cominciarono a
preoccuparsi quando vennero a sapere che non era possibile far rispettare
come volevano l’ordinanza di legge marziale. Ma a Yang Shangkun,
responsabile dei dettagli tecnici e pratici, la situazione non sembrava così
nera. Yang, infatti, era convinto che il solo arrivo delle truppe in città avesse
suscitato un forte effetto intimidatorio e, dato che questo era uno degli
obiettivi originali della legge marziale, si poteva ritenere soddisfatto; ma
egli si sbagliava. 65
Intanto, tutta la stampa estera focalizzava la propria attenzione sui
disordini di Pechino, tant’è che tra il 29 e il 30 maggio giunsero ventisette
rapporti sulle notizie relative alla situazione cinese come prospettata dalla
stampa estera. Per i giornalisti occidentali, la presenza delle truppe nelle
periferie di Pechino era un’occasione per la leadership cinese di verificare
l’equipaggiamento e la modernità dell’esercito. 66 In risposta a tali accuse, Li
Peng scrisse, il 1° giugno, al Politburo, un rapporto dl titolo La vera natura
dei disordini, all’interno del quale affermava l’idea che il perdurare
dell’occupazione della piazza era la strategia di coloro che avevano
organizzato e tramato per realizzare questi disordini. Un elemento
importante era, per Li Peng, il grande appoggio, sia morale sia materiale,
dato — direttamente ed indirettamente — ai cospiratori e agli organizzatori
da diverse forze reazionarie, organizzazioni e singoli individui in patria e
all’estero. Egli accusava «Voice of America» 67 di aver avuto un ruolo di
primo piano nel gettare benzina sul fuoco, avendo a disposizione
quotidianamente tre trasmissioni con un totale di dieci ore, in cui diffondere
64
Cfr. Secretary of State Morning Summary for June 2, 1989, China: Stalemate
Continues, Confidential, cit.
65
Excerpt from Central Military Commission Office, “Minutes of the [May] 20
Enlarged Meeting of the Central Military Commission”, in Tiananmen, cit., pp. 239240.
66
Foreign News Coverage, ibid., p. 323.
67
La VOA è l’unica stazione radio internazionale del governo americano che
trasmette in tutto il mondo. Secondo la dirigenza cinese, essa costituì il principale
canale d’infiltrazione politica ed ideologica nei paesi socialisti.
215
Francesca De Pascalis
notizie infondate e istigare i disordini. 68 Il 1° giugno, poi, il ministero della
Sicurezza di Stato sottopose all’attenzione del Centro un rapporto dal titolo
Infiltrazioni ideologiche e politiche nel nostro paese dagli Stati Uniti e da
altre forze politiche internazionali, in cui si leggeva: «Tutte le
amministrazioni americane, compresa l’amministrazione Bush, non hanno
mai rinunciato ai tentativi di penetrazione ideologica […]. Dopo aver fallito
con l’accerchiamento militare, l’unica arma a disposizione è puntare sul
programma di riforme e apertura della RPC per riuscire nell’infiltrazione
spirituale in Cina tramite gli scambi economici e culturali. Vogliono far leva
sulla cultura americana per spingere la Cina verso la liberalizzazione […].
Tra questi metodi [vi è] il programma Fulbright […]». 69 La convinzione che
la degenerazione e la continuazione delle manifestazioni fossero causa
dell’appoggio di forze esterne al paese portò la dirigenza cinese ad accusare
anche Taiwan di inviare in Cina missionari, sotto mentite spoglie, per la
creazione di squadre di propaganda; tra i rapporti, infatti, si legge anche che
il regime di Taiwan aveva organizzato ogni strato della società in modo che
offrisse il proprio sostegno ai disordini. Il segretario generale del Consiglio
di Sicurezza Nazionale di Taiwan, Jang Weiguo, secondo il rapporto, aveva
lanciato un progetto di solidarietà in favore di Tiananmen, inviando un
contributo di 100.000 dollari e creando anche fondazioni a sostegno del
Movimento per la Democrazia. 70
Davanti a ciò, Deng era ormai deciso a risolvere al più presto la
situazione di stallo in cui da dodici giorni versava il cuore di Pechino e le
principali città del paese. Già il 2 giugno gli Anziani del partito si
incontrarono col Comitato permanente del Politburo e durante l’incontro,
Deng, convinto, disse :«Questi disordini sono stati una dura lezione, ma
68
Excerpts from Beijing Municipal Party Committee and Beijing People’s
Government, “On the True Nature of the Turmoil”, Report to the Politburo, June 1,
in Tiananmen, cit., pp. 330-335.
69
Excerpts from State Security Ministry, “On Ideological and Political Infiltration
into Our Country from the United States and Other International Political Forces”,
Report to Party Central, June 1, in Tiananmen, cit., pp. 338-341. Con questo
programma, secondo l’accusa cinese, gli Stati Uniti dopo aver stabilito normali
relazioni diplomatiche con la Cina, avevano inviato 172 professori in 24 grandi
università cinesi, con lo scopo di influenzare la cultura cinese. La United States
Information Agency inviava ogni anno in Cina una ventina di docenti per tenere
lezioni negli istituti di ricerca del paese.
70
Per maggiori approfondimenti sui sospetti cinesi sulla partecipazione di Taiwan ai
disordini, cfr. ibid., pp. 346-348.
216
Piazza Tiananmen, 1989: la “rivoluzione mancata”
almeno ora abbiamo capito che la nostra priorità è tutelare la sovranità e la
sicurezza dello Stato. Alcuni paesi occidentali strumentalizzano quelli che
chiamano i “diritti umani” e sostengono l’illegalità o l’irrazionalità del
sistema socialista per criticarci, ma in realtà hanno un unico scopo, e cioè
dominarci […]. Dobbiamo solo sforzarci di mantenere una situazione
ottimale per il progresso e lo sviluppo del nostro paese […]. La nostra
responsabilità è nell’aver trascurato l’educazione dei nostri figli e dei nostri
studenti, l’educazione è l’unica arma che ci resta con gli studenti. I disordini
non vanno più tollerati. La stabilità deve avere la precedenza su tutto
[…]». 71 In quanto presidente della Commissione Militare, fu lui a far
pervenire alle truppe l’ordine di utilizzare qualsiasi mezzo per allontanare
chiunque avesse sfidato la legge. Nella mattina del 3 giugno, il Comando
della legge marziale iniziò le mosse mirate a uno sgombero pacifico della
piazza e la polizia cominciò a sparare gas lacrimogeno sulla folla nei pressi
di Zhongnanhai, quartier generale del PCC, vicino a Piazza Tiananmen,
mentre gli studenti reagivano scagliando pietre e rifugiandosi nei complessi
adiacenti. Il Comando della legge marziale fece il seguente annuncio :«A
partire da ora, Pechino è in stato d’allerta […]. I cittadini sono pregati di
non stare in strada e di non recarsi in Piazza Tiananmen […]». 72 Intorno alle
20:30, gli elicotteri iniziarono a sorvolare viale Changan e Piazza
Tiananmen, per controllare la situazione in vista dell’imminente arrivo delle
truppe in piazza. Alle 22:00, il Comando della legge marziale ordinò alle
unità di stanza nelle periferie di entrare in città, dove queste incontrarono la
dura resistenza di cittadini e studenti. Il 27° Corpo d’Armata, composto da
quasi 5.000 soldati, fu, infatti, costretto a tornare indietro di fronte
all’opposizione dei manifestanti. Intanto, nella notte, migliaia di studenti e
cittadini si riunirono spontaneamente a Muxidi (a circa 5 chilometri da
Piazza Tiananmen), dopo aver saputo dell’avvicinamento delle truppe. 73
Nonostante le truppe cominciassero a sparare colpi di avvertimento in aria e
con i megafoni invitassero i manifestanti a liberare il passaggio per gli
autocarri, la gente non mostrò segni di paura. Ma, a seguito di un costante
pioggia di pietre da parte dei manifestanti e dei continui cori che
71
Excerpts from Party Central Office Secretariat, “Minutes of Important Meeting,
June 2, 1989”, Document Supplied to Party Central Office Secretariat for Its
Records by the Office of Deng Xiaoping, ibid., pp. 354-362.
72
Excerpt from Martial Law Command, “Situation in Tiananmen Square and
Surrounding Districts”, in “Bulletin” (Kuaibao), June 3, ibid., p. 371.
73
Excerpt from Martial Law Command, “Situation in the Muxidi District”, in
“Bulletin” (Kuaibao), June 3, ibid., p. 372.
217
Francesca De Pascalis
inneggiavano contro i militari, urlando loro “fascisti!” o “assassini”, le
truppe decisero di puntare le armi contro la folla, di aprire il fuoco e
permettere l’avanzata delle truppe. 74 Gli studenti che si trovavano in Piazza
Tiananmen, intanto, continuarono l’occupazione, convinti che il PLA non
avrebbe mai aperto il fuoco contro di loro. Nelle strade che costeggiavano il
cuore di Pechino furono installati numerosi posti di blocco con barricate
umane e con filobus dati alle fiamme. 75
Mentre la stampa internazionale raccoglieva le prime testimonianze del
fallito sgombero della piazza, la tensione aumentò bruscamente quando
dieci o quindicimila soldati completamente equipaggiati marciarono a bordo
di autocarri verso il centro urbano. 76 Nonostante le esortazioni provenienti
dall’estero (soprattutto dall’amministrazione americana), cominciò il giro di
vite a Pechino. Le truppe che avanzarono con carri armati impiegarono
quasi sette ore per raggiungere il cuore della città a causa della resistenza
della folla di civili. 77 Alcuni studenti riuscirono ad abbandonare la piazza
prima dell’assalto militare e le truppe aprirono il fuoco sui dimostranti
rimasti a Tiananmen. Gli episodi di maggior violenza avvennero, tuttavia,
nelle zone semiperiferiche e sui grandi sovrappassi stradali, dove lo scontro
tra le truppe corazzate, che sparavano in direzione della folla, si caratterizzò
per una grande violenza. Le testimonianze oculari rivendicarono, in un
primo momento, la morte di più di 10.000 persone uccise a Tiananmen,
altre drammaticamente travolte dal passaggio degli autocarri, insieme alla
distruzione, da parte del PLA, di negozi ed edifici. 78 Mentre la stampa
internazionale riportava in prima pagina il massacro di Piazza Tiananmen,
le truppe continuarono a intervenire sporadicamente in tutto il paese. Nelle
università, il 4 giugno prevalevano sentimenti di shock, rabbia e dolore.
Quella domenica mattina i sistemi d’informazione delle FAS e delle varie
università trasmisero continuamente programmi dal titolo Bagno di sangue
74
Excerpts from State Security Ministry, “Situation at Muxidi on the Evening of the
Third”, in “Important Intelligence” (Yaoqing), 2 A.M., June 4, ibid., pp. 373-375.
75
Excerpt from State Security Ministry, “Situation in Beijing urban districts on the
fourth”, in “Important intelligence” (Yaoqing), June 4, ibid., pp. 375-377.
76
Cfr. U.S. Embassy Beijing to Department of State, Wash DC, SITREP No. 28: Ten
To Fifteen Thousand Armed Troops Stopped at City Perimeter by Human and Bus
Barricades, June 3, 1989, in NSAEBB, doc. 11.
77
Cfr. Secretary of State’s Morning Summary for June 4, 1989, China: Troops Open
Fire, Top Secret, in NSAEBB, doc. 13.
78
Cfr. U.S. Embassy Beijing to Department of State, Wash DC, The Morning of
June 4 (June 4, 1989), Confidential, in NSAEBB, SITREP, No. 32, doc. 14.
218
Piazza Tiananmen, 1989: la “rivoluzione mancata”
a piazza Tiananmen e La verità sul massacro di Pechino; in questi servizi si
disse che «il sangue era stato versato come un fiume su viale Changan» e
che la Croce Rossa di Pechino aveva fatto una prima stima di 2.600
vittime. 79 Naturalmente le autorità cinesi smentirono le notizie diffuse dai
manifestanti; anzi, ribadirono che nel corso dell’intero processo di
sgombero le truppe del PLA non avevano ucciso, né investito con i carri
armati alcun manifestante. 80 Per tutto il giorno, invece, un flusso continuo
di studenti e cittadini entrò e uscì dall’ospedale di Fuxing, dove si era
raccolta un’immensa folla per avere notizie dei propri familiari, mentre
all’ospedale della stazione si contavano già nel pomeriggio ventitré vittime
e in quello delle Poste e delle Telecomunicazioni sedici. Sulla base delle
stime, il numero di persone uccise in tutta la città già la sera del 3 giugno
ammontava a circa duecento. 81 Un’atmosfera di terrore pervase Pechino per
tutta la giornata del 4 giugno. In corrispondenza degli incroci principali vi
erano camion e autoblindati in fiamme, si sentivano colpi di arma da fuoco
e i pedoni in giro non coinvolti nelle rappresaglie erano veramente pochi.
Ma la mattina del 5 giugno la gravità dell’assalto divenne chiara. Le
truppe spararono con armi automatiche indiscriminatamente su folle di
civili disarmati, inclusi donne e bambini; gli studenti in fuga erano stati
raggiunti alla schiena dagli spari dei soldati e anche all’interno delle truppe
del PLA cominciarono i disordini tra i soldati accusati di azioni efferate. 82
La popolazione di Pechino rimase inorridita dalla violenza utilizzata contro
i sostenitori del Movimento per la Democrazia, mentre i rifugiati politici
che avevano chiesto asilo ai paesi occidentali avevano portato con sé
testimonianze delle atrocità subite. Ancora oggi le stime dei morti variano.
Il governo cinese parlò inizialmente di 200 civili e 100 soldati morti, ma poi
abbassò il numero di soldati uccisi a qualche dozzina; la CIA stimò, invece,
79
Public Security Ministry, “A Counterrevolutionary Pamphlet Signed by FAS
Appears on Beijing Campuses”, in “Public Security Bulletin” (Gongan Kuaixun),
June 4, in Tiananmen, pp. 384-386.
80
Excerpt from State Security Ministry, “Trends in Tiananmen Square”, Fourth of
Six Overnight Faxes to Party Central and State Council Duty Offices. 4:04 A.M.,
June 4, ibid., pp. 379-382.
81
Cit. in Excerpt from State Security Ministry, “Situation in Beijing Urban Districts
on the fourth”, in “Important Intelligence” (Yaoqing), June, ibid., p. 375.
82
I giornalisti americani parlarono anche di più di 1.000 arresti nelle ore successive
al massacro (cifra confermata anche da Amnesty International). Cfr. E. COLLOTTI
PISCHEL, Cina oggi. Dalla vittoria di Mao alla tragedia di Tian an men, Bari,
Laterza, 1991, pp. 178-179.
219
Francesca De Pascalis
in 800 i morti solo a Tiananmen; la Croce Rossa riferì di 2.600 morti e di
30.000 feriti; altri stranieri, invece, parlavano di circa 3.000 civili morti
durante l’assalto della piazza; le stime più alte fecero riferimento a ben
12.000 morti, mentre organizzazioni non governative, come Amnesty
International, denunciarono che, ai morti durante lo sgombero della piazza,
dovevano essere aggiunti i giustiziati per “ribellione”, “incendio di veicoli”,
ferimento o uccisione di soldati, e reati simili.
La repressione della protesta fu seguita in tutto il mondo e rimarrà nelle
menti di tutti, grazie anche ad una foto che circolò in quei giorni sulle TV
internazionali e che, più di tutte, simboleggia la fine drammatica della
rivoluzione mancata degli studenti cinesi. La foto, rinominata dal «Time»
col titolo “Il ribelle sconosciuto”, ritrae un giovane che, sul viale di
Changan, aveva cercato di fermare l’avanzata dei carri armati, forte solo
della convinzione profonda delle sue idee riformiste e “troppo” occidentali.
Di quel ragazzo non si seppe più niente. La leadership cinese, intanto,
aveva ripreso il controllo del paese, ma, da allora, quell’immagine cominciò
ad essere il simbolo del mancato rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali dell’uomo in Cina.
4. La Cina dopo Tiananmen
I giorni che seguirono al massacro di Piazza Tiananmen furono
caratterizzati da una calma “uneasy”; molti furono i dissidenti scomparsi e
molti quelli fuggiti dal paese. 83 Un’indagine nazionale condotta dall’agenzia
Xinhua alla fine di giugno scoprì che ovunque gli studenti universitari erano
in preda al terrore e ad una tacita resistenza. Le università erano pervase da
un’atmosfera di tensione, con il terrore incombente di incorrere in una
punizione o nell’arresto. Alcuni fecero dei parallelismi con gli arresti
arbitrari durante la campagna di Mao e la rivoluzione culturale. Si stimò che
in tutto il paese circa uno studente su cinque era ancora ribelle e circa uno
studente su tre manteneva un deliberato silenzio, unito alla politica dei
“quattro divieti” verso i media nazionali: divieto di ascoltare, di leggere, di
credere, di domandare. 84
83
Cfr. Secretary of State’s Morning Summary for June 9, 1989, China: Uneasy
Calm, Top Secret, in NSAEBB, doc. 23.
84
Excerpt from Xinhua News Agency, “The Ideological Condition of College
Students Nationwide”, “Proofs on Domestic Situation” (Guonei dogtai qingyang),
June 29, in Tiananmen, cit., pp. 453-455.
220
Piazza Tiananmen, 1989: la “rivoluzione mancata”
Il cuore della crisi cinese era ormai solo la lotta al potere per la
successione di Deng Xiaoping; quest’ultimo, però, dopo i fatti di
Tiananmen, nel tentativo di riacquistare un minimo di credibilità, il 10
giugno, fece la sua prima apparizione pubblica, dopo quella del 16 maggio,
ribadendo il supporto alla legge marziale ed all’azione governativa nei
confronti dei controrivoluzionari e rispolverando la formula «Un centro (lo
sviluppo economico) e due punti (il controllo del partito sulle riforme e
l’apertura verso l’estero)». 85 Evidente risultò a tutti, a sei giorni dal
massacro, il ruolo cruciale che l’organo militare aveva assunto per la
struttura interna alla Cina e quanto fosse divenuto importante il suo
appoggio per l’azione politica. 86 I militari dimostrarono a Deng, infatti, che
senza di loro era impossibile conservare il potere, la loro forza andava oltre
Deng e il partito. 87
Le sentenze di morte di Shangai e Pechino non fecero che approfondire
la ferita aperta nelle settimane precedenti; la detenzione, l’arresto e
l’uccisione degli attivisti erano chiaramente contrari al riconoscimento
internazionale dei diritti umani. Già il 9 giugno, Deng si assunse la
responsabilità dell’intervento e condannò, per l’ennesima volta, il
movimento studentesco come un tentativo controrivoluzionario di
rovesciare la RPC. Per legittimare la repressione, la propaganda ufficiale
sostenne che i manifestanti avevano attaccato l’esercito, il quale, a costo di
pesanti sacrifici, era comunque riuscito a salvare il socialismo. A livello
internazionale, la repressione di Piazza Tiananmen provocò la ferma
condanna da parte di numerosi paesi occidentali, condanna che portò
l’amministrazione americana ad imporre, tra le altre cose, un pacchetto di
sanzioni nei confronti della Repubblica Popolare Cinese, sospendendo, così,
le emissioni di licenze per l’esportazione in Cina di qualsiasi articolo per la
difesa, contenuto nella Munition List, 88 insieme all’interruzione dei rapporti
85
Cfr. Secretary of State’s Morning Summary for June 10, 1989, China: Mixed
Signal of Purge, Top Secret, in NSAEBB, doc. 25.
86
Cfr. CIA, China: Situation Report, June 10, 1989, Top Secret, RUFF/UNBRA, in
NSAEBB, USTP, doc. 10.
87
Cfr. H.E. SALISBURY, Diario di Tien an men. Testimone oculare del massacro di
Pechino, Milano, SugarCo, 1989.
88
La Munition List comprendeva armi letali e non-letali, come le attrezzature per lo
sviluppo della Marina militare cinese, o radio, radar e altre specifiche tecnologie
militari. Cfr. CHINA: Military Imports from the United States and the European
Union since the 1989 Embargoes, June 1989, National Security and International
Affaire Division, Wash DC, “United States General Accounting Office”, in
221
Francesca De Pascalis
diplomatici ad alto livello. Ad essa seguì anche, il 27 giugno 1989, la
dichiarazione del Consiglio Europeo di un embargo per la vendita di armi in
Cina. Contrariamente a queste decisioni, l’Unione Sovietica, che ignorò
volutamente la repressione, aumentò i propri scambi militari con la RPC.
L’importanza geopolitica della Cina, così come il suo enorme sviluppo
economico, condusse, però, ad uno scongelamento dei rapporti sinostatunitensi ed europei già dai primi anni Novanta, fino ad una
collaborazione ancora più serrata a partire dal 1997.
La società cinese cadde, intanto, in uno stato di assoluta anomia. Molte
persone si allontanarono dalla politica. La classe intellettuale e soprattutto i
giovani studenti, con il loro esuberante idealismo, si affacciarono negli anni
Novanta privi di quell’ammirevole impegno sociale che avevano mostrato
negli anni Ottanta. Le università erano tranquille e la Cina sembrava avvolta
in una nebbia austera che celava un vuoto spirituale. Il denaro regolava ogni
cosa, la morale scomparve, la corruzione prosperò e quando tutto ciò fu reso
noto, gli studenti universitari si allontanarono definitivamente dalla politica
e si concentrarono solo sul loro destino individuale. Qualcosa era
definitivamente scomparso.
Il 1989 segna una svolta nella storia della Cina contemporanea. Appare,
infatti, come un monito severo rivolto verso chi, in Cina ed all’estero, aveva
ritenuto il processo di riforme socio-economiche, avviato dieci anni prima,
un primo passo verso un reale processo di democratizzazione e di tolleranza
anche nei confronti delle forme più vivaci di dibattito e di critica politica. È
vero che, a partire dall’inizio degli anni Ottanta, la dirigenza post-maoista
aveva decisamente optato per un modello economico misto, aveva ammesso
il ruolo costruttivo dell’iniziativa privata e della cooperazione con l’estero,
aveva promosso una sempre più ampia autonomia delle imprese pubbliche,
ricevendo, così, una piena legittimazione politica; ma ciò non significava
affatto che potessero essere messi in discussione, o addirittura ribaltati i
“quattro principi fondamentali” su cui reggeva la Cina comunista:
socialismo, “marx-leninismo-Mao Zedong pensiero”, dittatura democratica
del proletariato e ruolo guida del partito. 89 In questo senso, nel giugno 1989,
il governo comunista di Li Peng non fece altro che confermare la
tradizionale indisponibilità del potere cinese ad un dibattito politico aperto e
pluralista, rigettando contemporaneamente, con la stessa determinazione, sia
le richieste di libertà che provenivano dalle categorie intellettuali
http://www.gao.gov., p. 3.
89
Cfr. R. CAVALIERI, Tendenze del diritto commerciale cinese dopo Tiananmen, in
«Mondo Cinese», settembre-dicembre 1994, p. 1.
222
Piazza Tiananmen, 1989: la “rivoluzione mancata”
privilegiate, che quelle di giustizia sociale provenienti dai ceti meno
favoriti. La stabilità sociale, l’unità del paese e la realizzazione del progetto
di sviluppo economico non potevano essere esposti al rischio di una
trasformazione troppo rapida e traumatica. È evidente che, di fronte
all’adozione di un’opinabile legge marziale, di fronte alla deliberata
violazione, da parte del governo, di quelle regole vagamente garantistiche
(che esso stesso si era posto con la Costituzione del ’79), di fronte agli
arresti senza mandato, ai processi segreti ed al diniego del diritto alla difesa
in giudizio, tutti concordarono sul fatto che la legalità fosse stata violata e
che le legittime aspettative di un sistema più giusto generate dalla riforma,
fossero state disattese. 90 Tiananmen, inoltre, non è solo il momento di una
tragica disillusione circa le intenzioni della dirigenza cinese in materia di
diritti e libertà individuali, ma è anche il momento in cui il passo della
modernizzazione dimostra di non voler essere in alcun modo interrotto, ed
all’opposto, assume il ritmo vertiginoso che tuttora conserva, sospinto da
una crescita economica eccezionale.
I primi anni Novanta sono caratterizzati da una sempre maggiore
importanza dell’economia di mercato e della virtuale scomparsa della
pianificazione economica, da una massiccia regolamentazione dell’intera
vita sociale, da un’apertura sempre più evidente all’estero e da una sempre
maggiore partecipazione al mercato internazionale. È difficile pensare che si
possa davvero istituire un mercato aperto e pluralista, senza che in tal modo,
primo o poi, ci si veda costretti ad accettare regole uniformi a quelle dello
standard internazionale, ed a riconoscere a tutti i soggetti sociali un grado
elevato di uguaglianza, di autonomia, di mobilità e di aspettative; né si può
prevedere se la crescita di classi nuove e la loro internazionalizzazione non
abbiano potenzialità di rischio esplosive per i dogmi del sistema socialista,
tra l’altro di fatto superati sul piano internazionale. Tre generazioni di
leaders – dopo Deng è stata la volta di Jang Zemin ed ora di Hu Jintao –
sono riuscite a condurre uno Stato demograficamente e territorialmente
immenso e una società estremamente complessa e tecnologicamente
arretrata verso un crescente benessere e un sempre più incisivo ruolo
internazionale. 91 Infatti, nel corso degli ultimi decenni, la leadership cinese
90
In realtà, non vi era contraddizione tra l’intervento dell’esercito sui dimostranti ed
il principio di legalità postulato dalla dirigenza cinese, giacché quest’ultimo era
comunque ritenuto subordinato ai principi fondamentali su cui si basava
l’ordinamento socialista. Cfr. CAVALIERI, La legge e il rito, cit., p. 256.
91
Cfr. R. ALCARO – M. COMELLI – R. MATARAZZO, La politica estera della Cina,
maggio 2005, in Documentazione per le delegazioni presso le assemblee
223
Francesca De Pascalis
è riuscita a promuovere uno sviluppo economico accelerato, a mantenere
l’ordine e la sicurezza interni ed a rafforzare l’apparato militare. Pilotando
la crescita economica su un binario completamente distinto da quello delle
riforme politiche, la dirigenza del PCC ha saputo mantenere il controllo
dello Stato e ha preservato il sistema di governo da ulteriori cambiamenti di
tipo rivoluzionario. Naturalmente, il grande sviluppo è andato a discapito
dell’intero sistema sociale cinese. Come nell’89, ancora oggi elemento
fondamentale del mantenimento della stabilità, da parte della leadership
cinese, è la repressione e la prevenzione. Per repressione, si intende non
solo quella armata di Piazza Tiananmen, ma anche quella promossa dal
governo cinese con la rieducazione nei “laogai” 92, campi voluti da Mao
Zedong, che hanno accolto non meno di cinquanta milioni di persone dalla
loro costituzione; si presume, infatti, che non esista un cinese che non
conosca almeno una persona che abbia subito tale “rieducazione”. Si tratta
di una detenzione che non prevede processo, non prevede imputazione,
tanto meno esame o riesame giudiziario o possibilità di confrontarsi con
un’autorità. Lo scopo è creare un “nuovo socialista” ed un nuovo prodotto,
tant’è che ogni laogai ha due nomi, quello del centro di detenzione e quello
della fabbrica, che può essere di scarpe, vestiti, spezie, tessuti e così via.
Questi centri sono, dunque, parte integrante dell’economia cinese e le stesse
autorità li considerano delle fonti inesauribili di mano d’opera gratuita.
Numerose rimangono, anche, le sentenze di morte, la detenzione di
dissidenti negli ospedali psichiatrici, la sparizione di quasi
cinquecentocinquantamila bambine all’anno 93, a causa, soprattutto, della
politica del figlio unico introdotta da Deng nel ’79, e migliaia sono le morti
accidentali di prigionieri che precipitano dai piani più alti dei palazzi. 94 A
internazionali, a cura dell’Istituto Affari Internazionali (IAI) del Senato della
Repubblica, XIV Legislatura, in www.XIVleg.camera.it/lavori/2005, p. 5.
92
Per maggiori informazioni, cfr. W. HONGDA HARRY, Laogai: i gulag cinesi,
Napoli, L’Ancora, 2006.
93
Sono poche le informazioni che arrivano direttamente dalla Cina e le notizie a
nostra disposizione sono per lo più riportate da varie organizzazioni internazionali,
tra cui Human Rights, Amnesty International ed altre, così come da superstiti in giro
per il mondo. Cfr. F. FACCI, Vi racconto gli orrori dei laogai, i lager cinesi, in «Il
Giornale»,
21
novembre
2005,
in
http://creativamente.splinder.com/post/6999861/laogai.
94
Lo strumento principale per la riduzione della nascita femminile è l’aborto
selettivo, praticato quando viene conosciuto il sesso della nascitura. Mancano alla
conta anche le bambine che nascono, ma che non sono registrate, e perciò
virtualmente non esistenti, facili vittime di sfruttamento. Certamente le femmine
224
Piazza Tiananmen, 1989: la “rivoluzione mancata”
conferma di ciò, è bene riportare le dichiarazioni che il governo cinese fece
in un trattato internazionale sulla “sua” definizione di diritti umani:
«L’universalità dei diritti umani e delle libertà fondamentali deve essere
rispettata ma si specifica portando avanti e sostenendo le diversità nel
mondo […]. Paesi con diversi sistemi sociali, livelli di sviluppo, valori e
contesti storico-culturali diversi hanno diritto di scegliere ciascuno il
proprio approccio e modello di promozione dei diritti umani. La
politicizzazione dei diritti umani e l’imposizione di condizioni –
relativamente al rispetto dei diritti umani – legate all’aiuto economico
devono essere combattute vigorosamente giacchè costituiscono esse stesse
una violazione dei diritti umani». 95
Evidente è, quindi, la volontà del governo cinese di portare avanti una
politica che, dal “Grande Balzo” di Mao, abbia come scopo principale
quello di fare della Cina una nazione economicamente avanzata e
politicamente rilevante, a discapito delle necessità e dei diritti individuali
del popolo cinese. A ciò si aggiungono le politiche di repressione “non
violenta”, che oggi la Cina continua ad attuare, intendendo con ciò tutte le
misure che non colpiscono direttamente l’individuo, ma la gestione della
sua crescita, della sua cultura e della sua vita all’interno della società. Una
tra le più evidenti è la censura imposta su Internet a tutti i siti web stranieri,
così come la repressione imposta alle manifestazioni in memoria, per
esempio, della strage del giungo 1989. Numerose sono, infatti, le petizioni
delle madri degli studenti di Piazza Tiananmen, che chiedono una
rivisitazione degli episodi e delle condanne comminate in occasione della
strage. Gli ambienti ufficiali cinesi continuano, quindi, a definire il
massacro come la riuscita soppressione di una “rivolta controrivoluzionaria”
che ha salvato la Cina dalla triste sorte toccata alla Russia e dall'ondata di
“rivoluzioni colorate” che in anni recenti hanno fatto crollare molti regimi
autoritari da un capo all’altro dell’Eurasia. C’è tuttavia un movimento in
crescita che spinge per una revisione di questo giudizio ufficiale. Per alcuni
intellettuali cinesi — e persino per alcuni funzionari — nonché per molti
osservatori occidentali, Tiananmen è un simbolo degli abusi dei diritti
sono le principali vittime dell’evasione scolastica infantile; ma rimane il fatto che i
ricercatori stimano un numero piuttosto alto di decessi di bambine. Molte sono date
in adozione e altre spariscono nei primi anni di vita per abbandono, vendita e
persino perché uccise. Cfr. G. CRIVELLER, Bambine cinesi cercasi, in
http://www.missionline.org/index.php?l=it&art=558.
95
Cfr. Beijng Declaration of the Forum on China-Africa Co-operation, ottobre
2000, testo integrale su www.focac.org/eng/zyzl/hywj/tl57833.htm.
225
Francesca De Pascalis
umani in Cina. Per molti giovani cinesi, Tiananmen è uno spazio vuoto, che
non fa parte della loro esperienza, un qualcosa di cui sanno che “in Cina
non si parla”. Focalizzare l’attenzione su Tiananmen e sul 1989 vorrebbe
dire, però, offrire un’immagine distorta di quella che è oggi la vita in Cina.
Nell’esperienza concreta dei cinesi, il ricordo degli studenti contestatori
e dell’uomo davanti al carro armato, è offuscato dagli eventi del 1992,
l’anno in cui il PCC si votò irrevocabilmente al “socialismo di mercato” e al
“socialismo con caratteristiche cinesi”. Il viaggio nel Sud di Deng nel marzo
del 1992 conferì alle riforme di mercato promosse dal governo autoritario il
sostegno autorevole degli ultimi veterani della “lunga marcia”. Questa
svolta fu poi codificata nel quattordicesimo Congresso del partito
nell’ottobre dello stesso anno e dall’Assemblea nazionale del popolo nel
marzo successivo. Il programma di riforme varato allora ha dominato la vita
cinese per un decennio ed è ancora operante oggi. Questo processo ha
portato la Cina, sul piano internazionale, ad essere un attivo partecipante
delle organizzazioni deputate alla tutela della sicurezza internazionale
(come l’ONU) e della cooperazione economica (come l’ASEAN e il WTO)
nonché, più in generale, ad essere coinvolta nel mercato capitalistico
globalizzato. Di fatto, è il peso specifico della Cina, dettato semplicemente
dalle sue dimensioni, dalla sua economia e dalla sua popolazione a definirne
il ruolo nel mondo. Data la sua influenza politica, le linee di condotta
preferenziali del governo cinese e gli effetti cumulativi delle scelte di vita
fatte da agricoltori, lavoratori, imprese e amministrazioni locali hanno,
ormai, un’enorme rilevanza per il resto del mondo. Dalla repressione di quel
mese di giugno, quindi, il PCC ha imparato a gestire ed a controllare ogni
momento della vita del popolo cinese. 96
96
Cfr. T. CHEEK, Living with Reform: China since 1989, New York, Zed Books,
2006.
226
Eunomia. Rivista semestrale del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Eunomia 1 n.s. (2012), n. 1, 227-242
e-ISSN 2280-8949
DOI 10.1285/i22808949a1n1p227
http://siba-ese.unisalento.it, © 2012 Università del Salento
Katia Scarlino
«Paidomazoma»: il rapimento dei bambini greci da parte dei
ribelli comunisti durante la guerra civile (1944-1949)
Abstract: At the end of World War II the Greek Communist Party purposed to seize power
soon after the withdrawal of the British forces, but it was blocked by US initiative. From 1946
to 1949, about 28,000 children were kidnapped and brought beyond the Iron Curtain by
Communist rebels and afterwards obliged to fight against their own population. This crime is
called in history as Paidomazoma. The United Nations Special Committee on the Balkans
(UNSCOB) reported the child-traffic was directed to Bulgaria, Yugoslavia and Albania. The
UN resolution no. 193, issued on 17 November 1948 by the United Nations General Assembly,
recommended that the children come back to Greece and invited all UN members to take all
necessary measures. In 1949, the UN approved the resolution no. 288 concerning the children's
return. The Communist governments asserted that their purpose was to save children and
young people from war sufferings.
Keywords: Greek Civil War, 1944-1949; Greek Childs Kidnapping; Communist Guerrilla.
1. Il contesto internazionale
La fine della seconda guerra mondiale segnò in maniera indelebile la storia
dell’umanità. Gli effetti materiali e morali non possono essere paragonati a
nessun altro evento bellico: il numero elevato delle vittime, la distruzione di
centinaia di città, di campagne e di fabbriche. Dal punto di vista economico,
la guerra fu sinonimo di catastrofe per l’Europa, per il Giappone e per la
Cina. Gli Stati Uniti, invece, ne uscirono rafforzati e diedero avvio ad un
periodo di crescita non paragonabile a nessuna altra nazione al mondo. Dal
punto di vista geopolitico, la fine della guerra rappresentò una cesura
rispetto agli anni precedenti. L’Europa non era più al centro delle relazioni
internazionali. Il nuovo sistema vedeva vittoriose due potenze antitetiche,
Katia Scarlino
ma unite dal ruolo assunto a livello mondiale: gli Stati Uniti e l’Unione
Sovietica. 1 Il mondo, alla metà degli anni Quaranta, era divenuto bipolare.
Stalin trovò nel trionfo militare il modo per consolidare il proprio potere
e lo utilizzò per rendere permanente l’ascesa dell’Unione Sovietica a
superpotenza e difenderla da ogni minaccia alla sua sicurezza. A questo
scopo, attirare quante più nazioni possibili all’interno della sua orbita era
necessità prioritaria per affermare la propria egemonia e contrastare quella
statunitense, ormai indiscutibile. L’interesse di Stalin si rivolse verso il
Mediterraneo, il continente africano e il Medio Oriente. 2 Alcuni Stati erano
considerati dalla potenza sovietica come conquiste necessarie per aprire le
porte del Mediterraneo e non solo. Infatti, se la conquista della Turchia e dei
suoi Stretti facilitava l’accesso al mare, la sovietizzazione della Grecia e,
poi, dell’Italia poteva portare la rivoluzione comunista sino in Francia e,
quindi, in tutta l’Europa occidentale.
La leadership staliniana, alla fine della seconda guerra mondiale, inoltre,
assegnava un’importanza strategica al controllo comunista del movimento
partigiano nella zona di influenza occidentale. In questo modo, ogni partito
comunista locale poteva essere finanziato e consolidato in vista di
un’insurrezione armata. Sin dal 1944, infatti, la dirigenza sovietica dovette
affrontare il problema delle organizzazioni militari dei partiti comunisti
occidentali che, come in Grecia, rappresentavano un esercito parallelo a
quello centrale sovietico. 3
2. La Grecia alla fine della seconda guerra mondiale
La Grecia entrò nella seconda guerra mondiale il 28 ottobre 1940 come
conseguenza dell’invasione italiana del suo territorio. Nonostante la
superiorità numerica e tecnica dell’esercito italiano, i greci riuscirono a far
indietreggiare gli avversari fino all’Albania. La Germania inviò rinforzi per
sostenere il suo alleato e solo nel 1944 lasciò il paese dopo una dura
occupazione, a cui seguì morte e distruzione. Inoltre, tra gli anni 1941 e
1
Cfr. E. DI NOLFO, Storia delle relazioni internazionali dal 1918 ai giorni nostri,
Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 595-603.
2
Cfr. ibid, pp. 625-626.
3
Cfr. V. ZASLAVSKY, Aprile 1948, l’insurrezione mancata. La politica mediterranea
di Stalin e i suoi riflessi sull’Italia, in «Ventunesimo Secolo», I, 1, marzo 2002, p.
17.
228
"Paidomazoma"
1942 una grave carestia contribuì alla degenerazione della vita del popolo
greco. 4
Dopo la ritirata tedesca, il principale movimento di resistenza greca era
guidato dai comunisti e la brutalità dello scontro in atto aveva favorito i
gruppi più estremisti. Essi si arroccarono nelle regioni montuose del nord
dove ottennero il sostegno aperto di Jugoslavia, Bulgaria e Albania. Furono
proprio questi i luoghi da cui partirono le forze comuniste per scatenare una
nuova guerra che provocò ulteriore disperazione e dolore. La
conformazione geografica e orografica dello Stato ellenico, costituito da
numerose catene montuose, e la quasi totale assenza di moderne vie di
comunicazione erano fattori che ben si prestavano alla guerra guerreggiata
5
e all’utilizzo di forze irregolari.
L’aspra divisione e violenza che inghiottì la Grecia negli anni Quaranta
fu il risultato della sovrapposizione dei conflitti che furono combattuti, con
varia intensità e livelli differenti, da soggetti mossi da interessi locali,
nazionali e internazionali. La violenza iniziò con l’occupazione nemica,
terminata con la liberazione di Atene ed esplose, infine, con la guerra civile.
Fu proprio la situazione greca a rendere esecutiva la dottrina Truman.
Infatti, nonostante inizialmente l’Unione Sovietica non si fosse schierata
apertamente con i ribelli comunisti greci, era chiaro ai leaders americani
che, dietro al flusso di armi provenienti dalla Jugoslavia e dall’Albania
verso i ribelli greci, ci fosse la mano dell’impero di Stalin. Così, dopo
l’annuncio del ritiro delle truppe britanniche dalla Grecia, Truman
s’impegnò a creare consenso alla possibilità di inviare aiuti militari ed
economici in questi territori. 6 Nel suo discorso al Congresso del 12 marzo
1947, il presidente affermò che «la politica degli Stati Uniti deve essere
quella di offrire sostegno ai popoli liberi che stanno resistendo a tentativi di
sottomissione da parte di minoranze armate o di pressioni esterne». 7 Gli
4
Cfr. Background Note: Greece, November 23, 2010, Boureau of European and
Eurasian Affairs, in http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3395.htm.
5
Cfr. A. ROSSELLI, Breve storia della guerra civile greca, 1944-1949, Roma,
Settimo Sigillo, 2009, p. 38. Il corsivo è mio.
6
Cfr. R. CROCKATT, Cinquant’anni di guerra fredda, Roma, Salerno, 1997, pp. 108109.
7
H.S. TRUMAN, Special Message to the Congress on Greece and Turkey: The
Truman
Doctrine,
March
12,
1947,
in
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=12846&st=&st1=#ixzz1IfnO5e4v.
229
Katia Scarlino
Stati Uniti non potevano non intervenire per due ragioni fondamentali: il
governo greco non era in grado di fronteggiare la situazione e, inoltre, la
vittoria dei comunisti in Grecia avrebbe portato l’intera penisola balcanica
nell’orbita sovietica.
3. Il Partito comunista greco e la guerra civile. L’influenza della politica
staliniana.
Per meglio capire gli avvenimenti che portarono alla guerra civile greca, è
necessario analizzare la storia del Partito comunista, causa e protagonista
principale degli stravolgimenti di quel periodo.
Il Partito comunista greco fu fondato il 4 novembre 1918 come Partito
socialista del lavoro (SEKE) da Avraam Benaroya. Al Congresso del SEKE
nell’aprile 1920, il direttivo del partito si affiliò alla Terza Internazionale,
ampliando il suo nome in SEKE-K (Partito socialista del lavoro di Grecia comunista). Al III Congresso straordinario, la compagine prese il nome di
Partito comunista greco (KKE). 8 Furono i vertici di questa formazione a
prendere le redini della rivolta, dopo la liberazione di Atene
dall’occupazione nazista. Le prime organizzazioni resistenziali greche
nacquero nel nord del paese, cioè in Macedonia e Tracia, già nel maggio
1941. Alla fine di giugno dello stesso anno, le prime due unità operative,
Athanasios Diagos e Odysseas Androutosos, composte da circa 300 uomini,
scatenarono una campagna di attentati, provocando la distruzione di ponti e
stazioni di polizia inadeguatamente difese. Il 27 settembre 1941, i comunisti
greci, insieme con cinque partiti centristi e di sinistra, formarono l’EAM
(Fronte di Liberazione Nazionale), il cui braccio armato era rappresentato
dall’ELAS (Esercito di Liberazione Nazionale Popolare). Nel febbraio
1942, l’ELAS, seguendo i suggerimenti di Mosca, si propose al popolo
greco come un movimento democratico. Questo tentativo, però, non trasse
in inganno la popolazione, tradizionalmente fedele alla monarchia. Inoltre, a
preoccupare i leaders comunisti greci era la presenza di militari inglesi,
perché temevano che, a guerra finita, il primo ministro Winston Churchill,
uomo carismatico e soprattutto riluttante a ogni forma di comunismo,
potesse aiutare a restaurare il potere monarchico. 9
Il coinvolgimento sovietico nella guerra civile greca e, quindi,
l’influenza di Stalin sul KKE non è esente da incertezze. Lo storico greco
8
9
Cfr. ROSSELLI, Breve storia della guerra civile greca, cit., pp. 20-21.
Cfr. ibid., pp. 38-43.
230
"Paidomazoma"
John Iatrides, infatti, mette in evidenza come il giudizio sul partito abbia
avuto valutazioni differenti. Per la storiografia tradizionale, l’insorgenza fu
fomentata da Mosca per portare il paese sotto l’orbita sovietica. I
revisionisti, invece, seguono la tesi secondo cui i partigiani avevano il solo
scopo di espellere i nazisti. 10 Si può affermare, però, che la posizione
sovietica circa la situazione greca è mutata nel corso degli anni del conflitto.
Infatti, il tentativo britannico di escludere i comunisti dalla formazione del
nuovo esercito regolare, subito dopo la liberazione dal giogo nazista,
provocò uno scontro armato tra le truppe comuniste e le forze governative,
da cui uscirono vittoriose queste ultime grazie all’appoggio britannico. In
quel periodo, il governo sovietico non intraprese alcuna iniziativa al fine di
rafforzare la sua influenza in Grecia ed espresse una forte disapprovazione
verso le forze comuniste greche, che avevano cercato di prendere il potere
con la forza militare. Stalin guardava alla Grecia come parte di un
programma molto più ambizioso, che mirava a stabilire il controllo di
Mosca sui Balcani. Per questo motivo, l’atteggiamento del Cremlino era
stato molto prudente, e nel 1946 era disponibile a fornire ai partigiani
ellenici i finanziamenti, il vestiario e i medicinali, ma non le armi richieste
dai rivoltosi, pur nella consapevolezza che senza un intervento militare
esterno, questi non avrebbero potuto vincere. 11
I comunisti ellenici ritenevano di dover insorgere e prendere il potere nel
momento in cui le truppe britanniche si fossero ritirate (marzo 1947). Essi
avevano interpretato il ritiro britannico come un disimpegno occidentale,
ma così non fu, data l’iniziativa del presidente Truman. La sua dottrina,
infatti, provocò una triplice reazione dell’Unione Sovietica: l’accelerazione
della sovietizzazione dell’Europa orientale, l’istituzione del Cominform e la
mobilitazione dei partiti comunisti per non far accettare gli aiuti economici
americani ai rispettivi governi. Nel 1947, Stalin diede il via libera alla
decisione del partito comunista greco di ingaggiare una lotta armata contro
il governo di Atene. Il 23 dicembre 1947 i comunisti proclamarono la
formazione del governo democratico della Grecia, guidato dal generale
Markos. Si preparava un riconoscimento da parte dei paesi dell’Europa
orientale. Ciò scatenò il governo di Washington, che avrebbe considerato la
10
Cfr. J.O. IATRIDES, Revolution or Self-Defense? Communist Goals, Strategy and
Tactics in the Greek Civil War, in «Journal of Cold War Studies», III, 7, 2005, pp. 34.
11
Cfr. ZASLAVSKY, Aprile 1948, l’insurrezione mancata, cit., pp. 20-21.
231
Katia Scarlino
partecipazione diretta della Jugoslavia come un atto di aggressione alle
Nazioni Unite. Due condizioni furono necessarie alla definitiva sconfitta del
movimento partigiano greco: la rottura tra Stalin e Tito e la chiusura dei
confini da parte della Jugoslavia. 12
Vignetta satirica sulla guerra civile greca (1947)
4. Paidomazoma: la più grande tragedia della storia greca
Durante l’ultima fase della guerra civile, i comunisti intrapresero una
campagna che prevedeva il rapimento dei bambini greci dai tre ai
quattordici anni in modo da strappare linfa vitale alle forze governative. I
bambini vennero suddivisi per sesso e poi rinchiusi nei “centri di
rieducazione socialista”. Alcuni dati testimoniano che i sequestri, alla fine
del 1948, erano 28.296. Il governo greco definì il sequestro di massa dei
12
Cfr. ibid., pp. 23-27.
232
"Paidomazoma"
fanciulli come paidomazoma, perché l’azione ricordava i tempi in cui i
turchi razziavano il popolo ellenico. 13
Il primo incontro dei capi comunisti sulla rappresaglia ai danni dei
bambini ebbe luogo a Bled, in Yugoslavia, nel 1947. Tra i partecipanti
erano presenti il generale Markos e i rappresentanti di Albania, Bulgaria,
Yugoslavia e Unione Sovietica. I negoziati avevano lo scopo di fissare le
linee guida attraverso le quali doveva avvenire il trasferimento dei bambini
dietro la cortina di ferro. I guerriglieri misero a punto le modalità con cui
rapire i bambini: si doveva aspettare che l’oscurità calasse sui villaggi della
Macedonia, dell’Epiro e della Tracia per eseguire il piano con forza e
brutalità ed entrare, quindi, nelle mura domestiche per distruggere le
famiglie greche. L'obiettivo dei ribelli comunisti greci era quello di
trasformare la Grecia in satellite sovietico.
All’inizio, la pratica dei rapimenti fu sporadica ma, alla metà del 1947,
specialmente nella Macedonia greca, nell’Epiro e in Tracia, essa divenne
14
una costante. In molte occasioni, i ribelli consideravano le loro operazioni
un divertimento. Essi, infatti, radunavano i bambini rapiti, piccoli e
affamati, nelle piazze dei villaggi, dove li deridevano, mostrando loro pane
tagliato a fette e farcito con burro e marmellata. Distribuivano, poi, un
pezzo di pane a ciascuno di loro e li spingevano a salire su vecchi camion,
affermando che quello sarebbe stato il cibo quotidiano se li avessero seguiti
senza indugio. Era, invece, l’inizio di un viaggio che li avrebbe portati in
luoghi lontani, in cui i ribelli facevano di tutto per annullare le vite dei
15
piccoli, vite che sarebbero servite a formare l’uomo nuovo.
I bambini rapiti venivano dapprima portati nei territori al nord della
Grecia. Da qui, poi, venivano trasferiti nei campi dietro la cortina di ferro. I
maggiori centri erano ubicati in Albania, Yugoslavia e Bulgaria. Altri
bambini furono deportati anche in centri minori in Cecoslovacchia, Polonia,
Romania e Ungheria. 16 Quando arrivavano nelle cosiddette "Case della
13
Cfr. ROSSELLI, Breve storia della guerra civile greca, cit., p. 79.
Cfr. N. KARAVASILIS, The Abducted Greek Children of the Communist
«PAIDOMAZOMA», Pittsburgh, PA, RoseDog Books, 2006, pp. 10-11.
15
Cfr. ibid., pp.17-18. Il corsivo è mio.
16
Alcuni dati della Croce Rossa riportano il numero esatto dei campi e della
distribuzione dei bambini rapiti: 18.500 bambini furono deportati nei “Centri di
rieducazione socialista” di Bulgaria (17 campi), Romania (11 campi), Ungheria (11
campi), Cecoslovacchia (18 campi), Polonia (3 campi), Germania Est (3 campi) e
14
233
Katia Scarlino
Gioventù" non trovavano quanto era stato loro promesso. La scena
cambiava drasticamente. Dormivano stipati tutti insieme, piangevano e
urlavano, ma nessuno prestava loro attenzione. Alcuni adolescenti
provavano a scappare ma, una volta scoperti, venivano uccisi con un colpo
alla testa davanti a tutti gli altri bambini. Così, terrorizzate, le piccole
vittime passavano gli anni della loro giovinezza nella sporcizia, affamati e
svuotati nell’anima. 17
Occorre precisare che i sequestri dei fanciulli rientravano all’interno di
una strategia geopolitica. Infatti, le bande marxiste della Grecia
settentrionale, consapevoli di poter contare sull’appoggio di Stalin e di Tito,
agirono anche al fine di separare la Macedonia greca dal resto dello Stato
ellenico, per renderla una repubblica socialista indipendente. Per questo
motivo, ai bambini macedoni residenti in Grecia che vennero rapiti fu dato
l’appellativo di Desta Begaltsi (Bambini sfollati). Anche ai bambini che non
erano di origine macedone fu fatto credere di essere macedoni. Nell’estate
del 1948, quando la rottura tra Stalin e Tito fu ufficiale, il leader iugoslavo
volle allontanarsi completamente dalla politica sovietica e, quindi, 11.600
fanciulli sequestrati e reclusi nei campi iugoslavi furono trasferiti in
18
Cecoslovacchia, Ungheria, Romania e Polonia.
I ragazzini sequestrati, considerati cellule primarie di una società
contadina corrotta e legata alla monarchia e alla religione, oltre a vivere in
misere condizioni, venivano sottoposti ad una martellante propaganda
politica, che spesso sfociava in un vero e proprio lavaggio del cervello, al
solo scopo di trasformarli in attenti servi del verbo marxista, secondo i
dettami di Lenin (“Dateci un ragazzino e nell’arco di otto anni lo
Albania (3 campi); 9.500 bambini furono detenuti nella sola Yugoslavia, dove erano
ubicati 15 campi. Dal 1° gennaio 1949, 1.561 bambini furono trasferiti dalla
Yugoslavia in Cecoslovacchia e in Polonia, nei cui campi ne arrivarono altri 153.
Tra l’aprile 1948 e il marzo 1949, i bambini greci che attraversarono il suolo
iugoslavo per essere trasferiti negli Stati dell’Europa dell’Est furono 13.500.
Su tale argomento, si vedano, tra gli altri, G. MANOUKAS, Paidomazoma:
Communist Children Abductions in the Greek Civil War, March 13, 2007,
http://history-ofin
«Modern
Macedonia
History»,
macedonia.com/wordpress/2007/03/13/paidomazoma-communist-children
abductions-in-the-greek-civil-war; O.L. SMITH, Studies in the History of the Greek
Civil War 1945-1949, Copenhagen, Museum Tusculanum Press, 1987, pp. 148-149.
17
Cfr. KARAVASILIS, The Abducted Greek Children, cit., p. 22.
18
Cfr. ROSSELLI, Breve storia della guerra civile greca, cit., p. 75.
234
"Paidomazoma"
19
rieducheremo”). Un articolo del 1950, pubblicato sul «Time Magazine
U.S.», riporta la testimonianza di una madre, la quale ricorda la presenza dei
guerriglieri comunisti nel proprio paese e gli assalti alla sua proprietà che ne
derivarono e, poi, racconta del sequestro dei suoi figli, ai quali non ebbe la
possibilità di dire addio perché, durante il rapimento, i militari del KKE
20
affermarono che le tre piccole vittime non erano più figli suoi, ma loro.
Lo scopo principale della strategia dei sequestri dei bambini era la
creazione di una Repubblica Internazionalista Macedone. Questa decisione
fu favorita da Tito (fino alla rottura con Stalin) e fu uno dei punti-cardine
della politica del Cominform che voleva distruggere tutti gli Stati nazionali
dei Balcani, sostituendoli con la creazione di Repubbliche internazionaliste
21
comuniste. Tra il 1947 e il 1949, i bambini rapiti e trasferiti oltre la cortina
di ferro erano in costante aumento. Durante i lunghi viaggi, molti bambini
morivano per dissenteria, privazioni e fame. Petros Kokkalis, il ministro
dell’Educazione, della Salute e dei Servizi Sociali del KKE, creò prigioni
istituzionalizzate, gestite da direttori definiti Ambassadors of
22
Paidomazoma.
Quando la regina greca, Federica di Hannover, venne a conoscenza dei
rapimenti dei bambini e delle campagne di distruzione a cui erano sottoposti
i villaggi greci, creò le “Città dei bambini”, chiamate anche Paidoupolis,
per sottrarre i piccoli perseguitati ai ribelli comunisti e proteggerli da ogni
violenza. La vita dei bambini in queste strutture scorreva con serenità: erano
nutriti, vestiti e andavano a scuola, nel rispetto del loro patrimonio culturale,
23
della loro lingua e della loro religione. Questa iniziativa, però, non bastò a
frenare l'azione comunista: i ribelli utilizzarono l’iniziativa della regina per
19
Cfr. ibid.
Cfr. Refugees: Innocents’ Day, January 9, 1950, in «Time Magazine U.S.», in
www.time.com/time/magazine/article/0,9171,811653-1,00.html.
21
Cfr. Tragedies of the Abducted Greek Children of 1948: The Reality of the
FYROM Claims, November 17, 2009, in «Modern Macedonian History», in
http://modern-macedonian-history.blogspot.com/2009/11/in-1948-cominform-firstofficial-forum.html.
22
Cfr. KARAVASILIS, The Abducted Greek Children, cit., pp. 28-29.
23
Cfr. ibid., p. 36.
20
235
Katia Scarlino
una falsa propaganda, che accusava il governo greco del rapimento dei
24
bambini dalle loro famiglie.
I guerriglieri comunisti, oltre alla tattica dei rapimenti, che aveva lo
scopo di terrorizzare la popolazione per ottenere un consenso estorto in caso
di vittoria, volevano distruggere il governo greco, attraverso l’assassinio di
figure politiche importanti. Il 1° maggio 1948, venne assassinato in una
chiesa il ministro della Giustizia, Christos Ladas. Una serie di omicidi
seguirono e sconvolsero il paese. Il 9 maggio dello stesso anno, poi, fu la
volta di un giornalista americano, George Polk, corrispondente della CBS
(Columbia Broadcasting System), che si occupava del coinvolgimento
25
americano nella guerra civile greca.
Famiglie distrutte dai ribelli comunisti
24
25
Cfr. ibid., p. 99.
Cfr. ibid., p. 51.
236
"Paidomazoma"
Il dolore di una mamma alla notizia della perdita del figlio
Le rotte dei trasferimenti nei campi socialisti
237
Katia Scarlino
5. Il richiamo internazionale
La questione greca fu portata davanti al Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite tre volte nel 1946. I primi due dibattiti furono inconcludenti.
Il terzo, il 3 dicembre 1946, portò alla creazione di un Comitato che doveva
26
occuparsi dei problemi relativi ai territori balcanici.
Nel 1947, infatti, fu creato il Comitato Speciale delle Nazioni Unite
(UNSCOB) per verificare la situazione in Grecia. Il suo compito principale
fu quello di indagare sulle accuse, mosse dal governo greco, circa il
sostegno di Albania, Yugoslavia e Bulgaria ai guerriglieri comunisti. Ma
tali Stati rifiutarono di collaborare e il Comitato non ebbe la possibilità di
entrare nei loro territori per osservarne i contesti. Il 1° dicembre 1947
l’UNSCOB stabilì la sua sede a Tessalonica. Si formarono sei gruppi,
costituiti ciascuno da quattro osservatori, a cui vennero assegnate delle zone
di analisi. Il rapporto del giugno 1948 del Comitato, dal titolo Rimozione e
detenzione dei bambini greci, riportava che un gran numero di bambini
greci erano stati trasferiti dai territori del nord della Grecia nei territori di
Albania, Bulgaria e Yugoslavia, e ribadiva la difficoltà di stabilirne il
numero esatto. 27
Il 17 novembre 1948, la Terza Assemblea Generale delle Nazioni Unite
votò la risoluzione n. 193, che condannava il rapimento dei fanciulli greci
da parte dei ribelli comunisti e raccomandava «il ritorno in Grecia dei
bambini che attualmente sono lontani dalle loro case […]; invita[va] tutti i
membri delle Nazioni Unite e gli altri Stati nei cui territori questi bambini si
[trovavano] a prendere tutte le misure necessarie per l’implementazione
28
della presente raccomandazione». Dopo un anno, l’ONU richiese, con la
risoluzione n. 288, agli Stati comunisti di far rientrare in Grecia tutti i
bambini sequestrati. La risposta dei governi di Praga, Budapest, Bucarest e
Varsavia fu data attraverso un comunicato congiunto, in cui si affermava
che la deportazione era un “atto umanitario”, avente il solo scopo di
26
Cfr. SMITH, Studies in the History of the Greek Civil War, cit., p. 132.
Cfr. The Creation of UNSCOB and Its Investigation into the Question of the
“Paidomazoma” (Greek Abducted Children), November 25, 2009, in «Modern
Macedonian
History»,
in
http://modern-macedonianhistory.blogspot.com/2009/11/creation-of-unscob-and-its.html.
28
ONU, United Nations Resolution (III): Threats to the Political Independence and
Territorial
Integrity
of
Greece,
November
27,
1948,
in
http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r3.htm.
27
238
"Paidomazoma"
29
sottrarre i bambini agli orrori del conflitto. I capi marxisti, infatti,
sostennero sempre che la pratica dei sequestri fosse stata adottata per
30
salvare la gioventù greca, allontanandola dai luoghi di combattimento.
La moglie di Zachariadis, il segretario generale del KKE, in un incontro
internazionale dell’Organizzazione delle Donne Comuniste, sostenne
addirittura che era il governo greco la causa principale delle sofferenze
subite dai bambini greci, a cui non si permetteva di andare nei “ricchi” Stati
31
comunisti, lontani dalle atrocità e dalla povertà della guerra.
Il presidente Truman, il 19 aprile 1950, parlando alla Camera dei
Rappresentanti definì moralmente inammissibile che considerazioni
politiche o difficoltà tecniche ostacolassero il ricongiungimento dei bambini
con i loro genitori. Il testo della risoluzione n. 514 adottata chiedeva la
collaborazione delle Nazioni Unite, dei governi degli Stati in cui i fanciulli
erano stati deportati, e di tutte le organizzazioni internazionali, affinché le
32
vittime innocenti dei comunisti greci facessero ritorno in patria.
6. Le vittime alla fine della guerra civile greca
Nell’agosto 1949 l’esercito governativo greco costrinse i partigiani alla resa
o a fuggire nei paesi comunisti confinanti. L’insorgenza provocò 100.000
33
morti, 70.000 sfollati e una catastrofe a livello economico.
Dopo la fine della guerra civile, la percentuale di bambini che fece
ritorno nelle proprie case fu esigua. Tra il 1950 e il 1952, i regimi comunisti
acconsentirono al rientro di soli 684 bambini. Occorre ricordare che, alla
fine degli anni Cinquanta, molti bambini, divenuti ormai adulti, riuscirono a
trovare la salvezza raggiungendo il confine della Germania occidentale.
Tanti altri, invece, non riuscirono a ritornare in patria: alcuni perché, dopo
29
Tali governi, tuttavia, comunicarono di essere d’accordo a far rientrare i bambini
su petizione dei loro genitori. La Croce Rossa ne presentò 8.000, ma, nonostante ciò,
nessun bambino rimpatriò. Cfr. Refugees: Innocents’ Day, cit.
30
Cfr. ROSSELLI, Breve storia della guerra civile greca, cit., p. 75.
31
Cfr. KARAVASILIS, The Abducted Greek Children, cit., p. 11.
32
Cfr. H.S. TRUMAN, Letter to the Speaker on the Plight of Greek Children
Abducted
by
Communist
Guerrilla,
April
19,
1950,
in
http://trumanlibrary.org/publicpapers/viewpapers.php?pid=713.
33
Cfr. Background note: Greece, cit.
239
Katia Scarlino
l’annientamento provocato dai comunisti, dimenticarono le proprie radici;
altri, invece, perché scomparvero misteriosamente all’interno dei campi
socialisti, come documentò la Croce Rossa greca.
Agli inizi degli anni Ottanta, alcune vittime del Paidomazoma erano
ancora presenti in Europa orientale. In Polonia, in quegli anni, ne erano
presenti più di mille, rapiti in giovane età nel 1948. La maggior parte di essi
aderì al movimento Solidarnosc, fondato nel 1980 e venne, poi, arrestata dal
regime comunista di Varsavia dopo l’introduzione della legge marziale nel
1981. Alla fine degli anni Ottanta, quando ebbe inizio la democratizzazione
34
del paese, molti profughi ellenici fecero domanda di rientro in patria.
7. Il “perdono” per i comunisti
Le conseguenze della guerra civile furono catastrofiche e le condizioni
economiche che ne seguirono furono peggiori di quelle ereditate
dall’occupazione nazista degli anni 1941-1944. Il popolo ellenico fu diviso
tra i due principali schieramenti politici e ideologici. Molti guerriglieri
comunisti passarono diversi anni in carcere o furono mandati in esilio nelle
isole di Yaros e di Makronisos. Altri dovettero chiedere rifugio in Europa
orientale, oppure emigrare in Australia, Germania, Stati Uniti e in altri
paesi.
La polarizzazione e la precarietà della politica greca negli anni Sessanta
fu un effetto diretto dei sentimenti e delle ideologie esplose durante la
battaglia civile. I conflitti tra conservatori e progressisti, infatti, furono
numerosi. Durante questo periodo, i comunisti non si arresero: gli ufficiali
dell’ASPIDA, un’organizzazione paramilitare e anti-monarchica di sinistra,
furono accusati di tramare un piano per impadronirsi del potere. Il colpo di
Stato non avvenne, ma i presunti responsabili del complotto vennero
giudicati davanti alla corte marziale.
Il 21 aprile 1967, un gruppo di ufficiali di destra riuscì, attraverso un
golpe, a salire al potere. La giunta militare durò fino al 1974, anno in cui un
governo conservatore, guidato da Konstantinos Karamanlis legalizzò il
KKE ed emanò una Costituzione per garantire libertà politiche, diritti civili
ed elezioni democratiche. Nel 1981, dalle consultazioni uscì vittorioso un
governo di centro-sinistra, che consentì ai membri dell’esercito comunista,
rifugiati nell’Europa dell’Est, di rimpatriare e di riappropriarsi dei loro beni.
34
Cfr. ROSSELLI, Breve storia della guerra civile greca, cit., p. 76.
240
"Paidomazoma"
Nel 1989, fu persino assegnato ai ribelli comunisti lo status di patrioti e,
35
inoltre, fu garantita loro una pensione di guerra.
35
Cfr. ibid., pp. 95-96.
241
Eunomia. Rivista semestrale del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Eunomia 1 n.s. (2012), n. 1, 243-266
e-ISSN 2280-8949
DOI 10.1285/i22808949a1n1p243
http://siba-ese.unisalento.it, © 2012 Università del Salento
Francesca Salvatore
Il ruolo della teoria dei giochi
nel neorealismo strategico di Thomas C. Schelling
Abstract: Nowadays in the world there are a lot of game theory fans among politicians,
economists, mathematicians and psychologists: also a “pure” economist like Thomas C.
Schelling was charmed by game theory and in 1994 his studies, shared with Robert Aumann,
led him to win the Nobel Prize for Economics. His masterpiece, The Strategy of Conflict,
published in 1960, was the first study in the world about strategic behavior and is considered
now as one of the most important books that influenced Western culture after 1945. With The
Strategy of Conflict Schelling inaugurated a new stream of international relations known as
“strategic neorealism”. In this essay, that explains the link between international relations and
maths, there is a reflection about Cold War and nuclear deterrence: the study of game theory
highlights how weapons of mass destruction (this is the paradox of the atomic age) avoided, at
the same time, the nuclear destruction of the planet.
Keyword: Game Theory; Strategic Neo-Realism; Thomas C. Schelling.
1. Thomas C. Schelling e l’avvento del neorealismo strategico
La teoria dei giochi, pur non essendo un filone scientifico “nuovo”, ha
vissuto nell’ultimo decennio una nuova primavera grazie al film A Beautiful
Mind, diretto da Ron Howard, vincitore nel 2001 di ben quattro premi
Oscar; è stato proprio con l’avvento del nuovo millennio che la comunità
scientifica internazionale sembrò aver riscoperto l’interesse per quella che
l’economista Thomas C. Schelling definì “una scienza in ritardo”, ovvero la
1
strategia internazionale. La grossa pecca di questa disciplina, secondo
Schelling, risiedeva nel fatto che, negli Stati Uniti, «chi lavora nel campo
dell'economia, della medicina, della sanità, della tutela del suolo,
dell'educazione o del diritto penale può facilmente individuare la sua
1
Cfr. TH.C. SCHELLING, The Strategy of Conflict, Cambridge, Harvard University
Press, 1960, p. 3.
Il ruolo della teoria dei giochi nel neorealismo strategico di Thomas C. Schelling
controparte accademica […], ma dov'è la controparte accademica nella
2
professione militare?».
Oggi, la game theory si configura, nel tentativo scientifico di conciliare
matematica e scienze sociali, come un insieme di modelli e strategie che,
attingendo ai principi dell’economia, della psicologia, della scienza politica
e sociale, tenta di creare analisi e previsioni circa il comportamento dei
soggetti sociali, siano essi esseri umani, economie nazionali o eserciti.
Impostasi con forza nel 1944 con la pubblicazione di Theory of Games and
Economic Behaviour di John von Neumann e Oskar Morgenstern, questa
disciplina è approdata nelle maggiori università americane come Princeton e
Stanford e, tra gli anni Quaranta e Cinquanta, è divenuta oggetto di ricerche
coperte da segreto militare negli Stati Uniti: gli anni della Guerra Fredda
sembrarono l’occasione giusta per utilizzare alcuni “giochi” allo scopo di
prevenire mosse e contromosse dei sovietici, anche se in seguito è stata
proposta più volte per l’analisi della questione arabo-israeliana e per la
divisione etnica di Gerusalemme. La teoria dei giochi, contrariamente a
quanto si potrebbe pensare, non ha costituto una semplice applicazione delle
leggi di probabilità, poiché, in un gioco, l’incertezza di ogni giocatore
deriva dal comportamento del suo avversario. “Mettersi nei panni altrui”: fu
esattamente questa la portata innovativa della teoria dei giochi rispetto alle
previsioni basate su situazioni di probabilità semplice. La teoria,
un’emanazione a stelle e strisce, ha conquistato in seguito anche il
tradizionalista mondo scientifico europeo, nonché un economista puro come
Schelling, professore per gli affari esteri, sicurezza nazionale, strategie
nucleari e controllo degli armamenti presso l’università del Maryland.
Negli anni successivi alla fine del secondo conflitto mondiale, il
baricentro delle relazioni internazionali divenne la Guerra Fredda, un
perenne stato di tensione internazionale che si prestava facilmente ad
un’interpretazione realista del mondo; eppure, su questo stato di cose i
liberali furono in grado di fondare un nuovo tentativo di creare una teoria
delle relazioni internazionali, alternativa al realismo ma, allo stesso tempo,
3
lontana dal liberalismo utopico degli anni Venti. Negli anni Settanta, tra gli
studiosi, era pressoché unanime la convinzione che tale forma di
neoliberalismo, basato sulla speranza che l’aumento del volume di scambi
2
Ibid., p. 8.
Fu Edward Carr che definì il liberalismo degli anni Venti “utopico”. Cfr. E.H.
CARR, The Twenty Years’ Crisis, New York, Harper&Row, 1964.
3
244
Francesca Salvatore
tra i due blocchi rappresentasse il segno di un disgelo progressivo, fosse sul
punto di prendere il sopravvento. Fu la nuova formulazione del realismo,
dovuta a Kenneth Waltz, a far pendere l’ago della bilancia verso il realismo:
l’equilibrio del terrore, per tutti gli anni Settanta e Ottanta, continuava a
convincere più del disgelo in un mondo in cui le difficoltà della
socialdemocrazia esprimevano la generale crisi della vita democratica in
4
tutti i paesi occidentali. Alla luce di questi cambiamenti, il realismo
sembrava nuovamente adatto a descrivere lo scenario di quegli anni:
5
Kenneth Waltz, con il suo Theory of International Politics, propose una
teoria realista sostanzialmente diversa da quelle precedenti, poiché ispirata
alle ambizioni scientifiche del behaviourismo. A differenza del realismo
classico, il neorealismo prese le mosse proponendo una soluzione al
problema della distinzione tra fattori esterni alla struttura politica
internazionale e fattori interni. Concetto base del neorealismo è la
“struttura”: essa emerge dall’interazione tra Stati sovrani ed è questa la
condizione che continuamente li scoraggia a comportarsi in un modo,
spingendoli ad intraprendere determinate azioni; la struttura internazionale,
perciò, muta quando mutano le caratteristiche e il numero delle grandi
potenze: variano, infatti, decisioni, calcoli e comportamenti degli Stati, che
vedono nel cambiamento la possibilità di imporsi o il pericolo di
tramontare. La teoria della struttura si configura come il principale punto di
rottura tra il neorealismo e il realismo classico: il neorealismo crede, infatti,
che realmente la politica internazionale possa essere un sistema dotato di
regole e caratteri ben precisi. È proprio questo aspetto che teorici come
Robert Keohane e Barry Buzan criticarono a lungo, sostenendo come la
teoria neorealista non prenda in considerazioni variabili come la densità
dinamica, la ricchezza delle informazioni, i mezzi di comunicazione, cioè
una serie di caratteristiche “in movimento” che poco collimerebbero con
6
una teoria apparentemente sistemica come quella neorealista. Il mondo
4
Sul sistema mondiale al termine della Guerra Fredda, cfr., tra gli altri, J.
MEARSHEIMER, Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War, in S.
LYNN JONES, ed., The Cold War and After: Prospects for Peace, Cambridge, MIT
Press, 1993.
5
Cfr. K. WALTZ, Theory of International Politics, New York, McGraw-Hill, 1979.
6
Cfr. R. KEOHANE, Power and Interdependence Revisited, in «International
Organization», XLI, 4, October 1987, pp. 725-753. Inoltre, sull’argomento cfr. B.
BUZAN, The Logic of Anarchy: Neorealism to Structural Realism, New York,
Columbia University Press, 1993.
245
Il ruolo della teoria dei giochi nel neorealismo strategico di Thomas C. Schelling
neorealista, del resto, è molto diverso da quello che rappresentarono i primi
realisti. Per i neorealisti, gli Stati interagenti possono essere studiati solo se
si distingue fra cause ed effetti a livello della struttura ed a livello delle
unità: esattamente l’opposto di ciò che sosteneva Hans Morgenthau, la cui
opera fu caratterizzata da una logica prevalentemente comportamentale e, di
7
conseguenza, induttivista. Sebbene Morgenthau trovasse conferma
dell’antico adagio dell’homo homini lupus di hobbesiana memoria nel
succedersi di tensioni e conflitti, il realismo classico non era ancora in grado
di spiegare meccanismi come la cooperazione, che edulcorano l’animus
8
dominandi così caro ai classici.
A partire dagli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, emersero nuovi
approcci realisti, scaturiti dalla rivoluzione behaviorista. Il più innovativo di
questi, il neorealismo strategico, appunto, concentrando l’attenzione sui
processi decisionali della politica estera, costituì uno dei tanti connubi tra
realismo moderno e approcci positivisti. Thomas C. Schelling, miniera di
idee e studioso interdisciplinare di scienze sociali, cominciò a produrre
negli anni Cinquanta durante le prime battute della Guerra Fredda. A suo
avviso, il limite fondamentale delle teorie strategiche degli anni QuarantaCinquanta risiedeva nel fatto che esse analizzavano compiutamente solo le
situazioni di conflitto puro; ma, in realtà, perfino in guerra il conflitto puro
non esiste, testimoniando come i “giochi” internazionali non sono
9
necessariamente a “somma zero”. Nemmeno la guerra, espressione
paradigmatica della forza bruta, può ritenersi un gioco a somma zero: lo
stesso Schelling, in un saggio dal titolo Experimental Games and
Bargaining Theory, pubblicato nel 1961, sostenne che «la guerra –
guerreggiata o strategica che sia – non è un gioco a somma zero. Richiede
almeno un minimo di cooperazione o di accomodamento fra le parti […].
Esse sono sia partner che avversari, sia per evitare seri danni reciproci, sia
7
Sull’argomento cfr. H. MORGENTHAU, Politics among Nations: The Struggle for
Power and Peace, New York, Knopf, 1960; e ID., Scientific Man versus Power
Politics, Chicago, Phoenix, 1965.
8
Sul confronto tra neorealismo e realismo classico, cfr. M. CESA, Le relazioni
internazionali, Bologna, Il Mulino, 2004; e R. JACKSON – G. SORENSEN, Relazioni
internazionali, Milano, Egea, 2005, pp. 41-66.
9
Un gioco a somma zero è un’interazione strategica in cui la vincita di un giocatore
è quantitativamente uguale alla perdita del suo avversario.
246
Francesca Salvatore
10
per guadagnare l'uno a spese dell'altro». Ecco perché la coordinazione
tacita è stata il fulcro delle sue teorie, ed ha ispirato generazioni di
economisti, manager, politici e diplomatici, fornendo loro nuove categorie
interpretative e affrontando in modo originale e, spesso paradossale,
problemi di economia, di strategia politica e militare, di vita quotidiana e di
sociologia.
Uno dei concetti chiave del realismo strategico è quello di “minaccia”, in
particolar modo quella di tipo nucleare; proprio Schelling affermava:
«Abbiamo concluso che l'efficacia della minaccia può dipendere da quali
alternative sono a disposizione del nemico potenziale, che, se non vogliamo
che reagisca come un leone in trappola, deve poter avere qualche via
11
d'uscita». Bisogna, quindi, chiedersi come usare in modo intelligente la
propria forza per indurre l’avversario militare a fare ciò che si vuole: ecco
perché il realismo strategico si configura come un filone a-morale, poiché
non prende in considerazione l’eticità di una scelta politica, ma la sua
possibilità di successo. La teoria dei giochi è, perciò, il modello psicomatematico che meglio aiuta a valutare queste alternative. Sebbene ogni
tipo di strategia parta dalla volontà di un individuo o di un gruppo (ad
esempio gli Stati) di vincere, la teoria della strategia non nega l’esistenza né
di interessi comuni, né di interessi divergenti fra i partecipanti: il caso in cui
gli interessi dei due antagonisti siano totalmente contrapposti (ovvero
situazioni di conflitto puro) è assolutamente eccezionale, poiché nemmeno
la guerra, come già detto, può ritenersi tale. È per questa ragione che, per
Schelling, “vincere” non vuol dire battere i propri avversari, ma piuttosto
guadagnare rispetto al proprio sistema di valori: ciò si può ottenere
contrattando ed evitando comportamenti di reciproco danno. Ergo, la
strategia nulla ha a che fare con l’applicazione della forza, se non della
forza potenziale: vale a dire, essa non si riferisce a nemici che vogliono
distruggersi, ma a partner che non si fidano gli uni degli altri. È da qui che
nasce una situazione negoziale.
Non erano ancora iniziati gli anni Cinquanta quando la deterrenza fu
chiaramente formulata come chiave di volta della strategia internazionale
10
Cfr. TH.C. SCHELLING, Experimental Games and Bargaining Theory, in «World
Politics», XIV, 1, The International System: Theoretical Essays, October 1961, p.
50. Si veda, inoltre, E.N. AYDINONAT, An Intervew with Thomas C. Schelling:
Interpretation of Game Theory and the Checkerboard Model, in «Economics
Bulletin», II, 2, October 2005, pp. 1-7.
11
Cfr. SCHELLING, The Strategy of Conflict, cit., p. 6.
247
Il ruolo della teoria dei giochi nel neorealismo strategico di Thomas C. Schelling
statunitense. Da quel momento, e a caro prezzo, gli Stati Uniti compresero
che una minaccia, per essere efficace, doveva essere credibile e che la sua
credibilità poteva dipendere dai costi e dai rischi associati alla sua messa in
atto. Da allora, la teoria della deterrenza è stata continuamente affinata,
anche se negli anni della sua formulazione, all’interno delle università,
soltanto un numero ristretto di storici e politologi si è preoccupato di
strategia militare, con un seguito abbastanza esiguo. Solo istituti di ricerca
paragovernativi, come la RAND Corporation e l’Institute for Defense
12
Analysis, per primi hanno colmato questa lacuna.
Ma come dovrebbe essere una teoria della strategia e, quindi, della
deterrenza? C’è una certa analogia, afferma Schelling, tra la minaccia della
punizione di un genitore al proprio figlio e la minaccia che una nazione
ricca e paternalistica rivolge al governo debole e disorganizzato di una
nazione povera quando, per così dire, elargisce aiuti esteri e richiede in
cambio cooperazione. Affinché la propria strategia abbia effetto, bisogna
innanzitutto definirne gli elementi essenziali: tanto più chiari saranno questi,
tanto più sarà possibile influenzare le scelte che farà la nostra controparte
attraverso una serie di informazioni che permetteranno al nostro avversario
di credere che il nostro comportamento sarà determinato dal suo. Di
conseguenza, la deterrenza non è solo teoria dei giochi, ma anche
psicologia, teoria della scelta e comunicazione. Nonostante si parli di
“strategia del conflitto”, Schelling ha precisato due punti: il primo è che la
teoria non riguarda l’effettiva applicazione della violenza; non è, insomma,
una teoria di aggressione, bensì una teoria di minaccia di aggressione. Il
baricentro della teoria schellinghiana sembra, dunque, essere il concetto di
“razionalità”: questa si basa sul presupposto che i partecipanti calcolino
freddamente e razionalmente i propri vantaggi rispetto ad un sistema di
valori. “Razionale”, dunque, per Schelling, non equivale a “buono e giusto”,
ma a quel processo strategico che, tramite costruzioni logiche, cerchi di
raggiungere l’obiettivo: l’irrazionalità razzista di Hitler, ad esempio, è
razionale, perché, infatti, tramite la strategia, egli perseguiva un obiettivo,
moralmente deprecabile certo, ma molto chiaro. La razionalità
schellinghiana parte, dunque, dal fondamento che «il sistema di
comunicazione, il processo di decisione collettiva, la probabilità di
commettere un errore, la perdita del controllo possono essere considerati un
12
La RAND Corporation (Research and Developement) e l’Institute for Defense
Analisys sono enti no profit che si occupano, negli Stati Uniti, di ricerche su
problemi di sicurezza nazionale.
248
Francesca Salvatore
tentativo di formalizzare lo studio dell'“irrazionalità”. Hitler, il parlamento
francese, il comandante di un bombardiere, gli operatori radar a Pearl
Harbour, Kriscev e l'elettorato americano possono soffrire tutti di qualche
13
forma di irrazionalità, ma senza che questa sia intesa nello stesso modo».
Eppure, afferma Schelling, troppa razionalità non sempre è un vantaggio:
essa può diventare, in alcuni casi, incapacità strategica. Un buon
negoziatore, infatti, deve essere razionale, ma deve anche possedere una
buona capacità di azzardare o lasciare qualcosa al caso, quando si rendesse
necessario.
Per Schelling, la contrattazione è la base della negoziazione: essa ha
precise caratteristiche che possono facilitare o complicare un negoziato.
Nella strategia del conflitto, egli ne individua almeno otto: 1) la
contrattazione mediante un agente. La riuscita del negoziato è, in questo
caso, nelle mani del negoziatore e del suo ampio o ristretto potere
contrattuale, affidatogli da un’autorità a lui superiore; 2) la segretezza o
pubblicità dei negoziati. La segretezza o pubblicità – lo dimostra spesso la
strada delle contrattazioni sindacali – sono fondamentali perché
determinano o meno la messa in gioco della reputazione delle parti: quando
una delle parti è cosciente di poter raggiungere un successo potrà, per
accrescere il proprio prestigio, rendere pubblica la contrattazione.
Viceversa, se una delle parti o tutte le parti temono l’influenza dell’opinione
pubblica, hanno buone probabilità di soccombere o sono convinte di poter
ricorrere a forme di negoziazione “sporca”, preferiranno tentare di applicare
accordi segreti; 3) negoziazioni incrociate. Se una delle parti che negozia è
impegnata in più contrattazioni, rischia fortemente la reputazione: un
insuccesso può, infatti, generare una reazione a catena; 4) negoziazioni
continue. Questa tecnica si verifica quando due parti negoziano qualcosa nel
presente e qualcos’altro nel futuro: in questo caso, promesse e minacce del
presente si ripercuotono in tempi futuri, rinforzando o indebolendo la
credibilità delle parti nel tempo; 5) l’ordine del giorno restrittivo. Questo
metodo sottolinea come trattare due questioni differenti nello stesso
momento possa complicare la contrattazione. Un esempio tipico è quello
sulla contrattazione delle tariffe: vale a dire, se si devono negoziare i dazi su
delle merci, una delle due parti potrebbe alterare il risultato, minacciando un
cambiamento in altre tariffe a titolo puramente sanzionatorio; 6) la
possibilità di indennizzo. Spesso la contrattazione è tanto più efficace
quanto meglio distribuiti sono costi e guadagni della negoziazione. Senza
13
Cfr. SCHELLING, The Strategy of Conflict, cit., pp. 16-17.
249
Il ruolo della teoria dei giochi nel neorealismo strategico di Thomas C. Schelling
questa compartecipazione, le parti potrebbero rinunciare all’accordo,
arroccandosi sulle proprie opinioni; 7) la meccanica della negoziazione. Il
modo in cui una negoziazione è condotta è fondamentale per la trattativa. Il
voto parlamentare ne è la dimostrazione: la presenza o meno del voto
palese, ad esempio, sortisce effetti diversi. Non è un caso che la segretezza
del voto sia una delle conquiste più importanti della modernità; 8) principi e
precedenti. Per essere convincenti, gli impegni, di solito, devono essere di
tipo qualitativo, anziché quantitativo, e devono basarsi su una logica. Un
comune tipo di impegno qualitativo è la formulazione di un principio, e i
principi sono la scala di valori che i negoziatori si impegnano a rispettare:
violare i principi, dunque, significa mandare a monte il negoziato.
Nell’analisi schellinghiana della contrattazione, alla luce di tutte le
considerazioni precedenti, il tema che ricorre maggiormente è, dunque, la
minaccia, ovvero la comunicazione delle proprie intenzioni, concepita per
far comprendere alla controparte le conseguenze automatiche della propria
azione. Ebbene, è proprio la minaccia ad essere alla base del processo
negoziale: essa non è altro che la chiara intenzione di non voler ricorrere al
comportamento minacciato, bensì di usarlo come deterrente. In La
diplomazia della violenza, altra opera di Schelling datata 1966, il concetto
di minaccia viene raffinato dallo studioso, trasformandosi così in “minaccia
compellente”: compellente, infatti, in inglese deriva dal sostantivo
“compellence”, ovvero “costrizione”, termine utilizzato proprio per
sottolineare il rapporto di connessione fra l’azione proibita e la reazione
14
minacciata. Una parte può minacciare in vari modi: bluffando, mettendo
in gioco la propria reputazione, o, addirittura, impegnandosi a stipulare un
contratto (una penale, ad esempio, che cos’è, se non una minaccia?).
Diverse sono anche le ragioni che spingono a sostenere una campagna
compellente: «In primo luogo, contribuisce ad eliminare ogni incertezza
circa i termini delle condizioni in essa poste, nonché circa i mezzi che si
intendano impegnare al fine di favorire una più rapida adesione della
controparte». Inoltre, «qualora si intenda provocare una semplice adesione
dell’avversario, e non già iniziare una spirale di azioni e reazioni, può
apparire utile chiarire esattamente i termini delle proprie richieste: tutto ciò
può meglio ottenersi, quando si conduca una campagna volta ad individuare
14
Cfr. TH.C. SCHELLING, La diplomazia della violenza, Bologna, Il Mulino, 1966, p.
87. Sull’argomento, inoltre, cfr. H. BULL, Arms and Influences, in «Bulletin of
Atomic Scientist», XXIII, 3, March 1967, p. 25.
250
Francesca Salvatore
precisamente i propri obiettivi, ed a separarli da ogni altro obiettivo
15
potenziale».
Contrattare, per Schelling, è un’azione sempre collegata ad un sistema
che vuole evitare lo scontro aperto: contrattare evita o chiude la guerra. Le
guerre richiedono limiti, ma i limiti richiedono un accordo o, almeno, una
qualche forma di riconoscimento e reciproco consenso. Lo studio della
contrattazione tacita, in relazione alla guerra limitata, consiste nello
sviluppare una modalità di negoziazione in una situazione in cui una o tutte
le parti in causa non possano o non vogliano negoziare esplicitamente, o
quando nessuna delle due parti abbia abbastanza fiducia nell’altra, anche in
presenza di un accordo esplicito. Uno degli esempi più comuni utilizzati da
Schelling è tratto dalla vita quotidiana ed è una tipica situazione di
coordinamento tacito: si verifica un coordinamento tacito quando due
giocatori, che non possono o non vogliono comunicare tra loro,
raggiungono, comunque, un accordo se hanno qualche tipo di interesse
comune. Pensiamo ad un uomo e a sua moglie che si perdono all’interno di
un supermercato: sono altissime le probabilità che riescano ad aspettarsi
l’un l’altro nello stesso luogo: questo accade perché, a vari livelli, ognuno di
noi è in grado pensare strategicamente; ovvero, le possibilità che gli
individui si comportino in maniera coordinata sono molto maggiori di
quanto una semplice logica, basata sulla probabilità casuale, suggerirebbe.
Quando, invece, esistono interessi divergenti, in assenza di comunicazione
si parla di contrattazione tacita. In questo caso, i termini “vincere” e
“perdere” potrebbero non essere abbastanza precisi: essi sono concetti
relativi rispetto alle previsioni che i giocatori hanno formulato, o rispetto
alle vincite e alle perdite che i giocatori avrebbero conseguito, se avessero
potuto o voluto comunicare. Il concetto di coordinamento nella
contrattazione tacita non è, per Schelling, applicabile alla contrattazione
esplicita: non c’è, infatti, bisogno di intuizione quando si può comunicare.
Gran parte delle situazioni di contrattazione prevedono una gamma di
possibili risultati, entro cui ciascuna parte sarebbe disposta a fare una
concessione, piuttosto che non giungere affatto ad un accordo: qualsiasi
potenziale è, quindi, un risultato che una delle due parti, volendo, avrebbe
potuto migliorare. Il risultato finale dovrà essere un punto da cui nessuna
delle due parti si aspetta che l’altra indietreggi. Fondamentale è, perciò, la
ricerca di un punto fermo reciprocamente identificabile. Se un giocatore fa
una concessione, deve fermarsi e riflettere sulle aspettative del suo
15
Ibid., p. 88.
251
Il ruolo della teoria dei giochi nel neorealismo strategico di Thomas C. Schelling
avversario; la sua concessione deve essere tale e non deve apparire come
una resa o un segno di ritirata: ad esempio, se un esercito batte in ritirata al
di là del fiume, ci si aspetta che esso si arresti in tale posizione; ma, se
dovesse ulteriormente arretrare, indurrà l’esercito nemico a pensare che
batterà in ritirata all’infinito e potrà essere messo con le spalle al muro.
Questo esempio dimostra come il coordinamento delle aspettative è sempre
una componente essenziale delle negoziazione, anche quando la
comunicazione è interrotta.
I risultati dei giochi condotti da Schelling dimostrano come – sia in
presenza, che in assenza di qualche forma di comunicazione – i giocatori, in
una strategia, tendono sempre a coordinare le proprie aspettative. Nella
contrattazione tacita ciò avviene intuitivamente appellandosi alla logica e ad
una serie di esperienze precedenti; nella contrattazione esplicita, il
coordinamento delle aspettative avviene ancora prima che le parti si
accordino e viene comunicato tramite qualche forma di comunicazione. Ciò
dimostra come contrattazione esplicita e tacita non siano concetti totalmente
separati, poiché mostrano tutti una certa dipendenza dal bisogno di
coordinare le aspettative. La contrattazione esplicita non utilizza
esclusivamente la comunicazione, ma fa anche appello a manovre nascoste,
a forme di comunicazione indiretta, a lotte e spionaggio, dimostrando che il
bisogno di aspettative convergenti e il ruolo di segnali, in grado di
coordinarle, possono essere molto potenti. Schelling sostiene che questo
meccanismo d’azione è facilmente rintracciabile in due fenomeni estremi
della vita associata: l’azione di gruppi di interesse e le rivolte di massa. Nel
caso di gruppi di interesse, si assiste, infatti, ad un coordinamento tacito tra
individui che, una volta organizzatisi, comunicano ai vertici istituzionali i
propri bisogni e le proprie intenzioni. Anche una rivolta di massa può
riflettere principi simili: quando i leaders politici possono facilmente essere
destituiti, le masse hanno bisogno di un segnale per coordinarsi (un appello,
uno slogan), un segnale che deve essere immediatamente comprensibile e
così potente, che si possa essere sicuri che esso farà agire tutti i protagonisti
nello stesso modo.
Ma in che modo una tale dissertazione politologico-matematica può
aiutare a risolvere problemi di manovre strategiche e guerra limitata? Il
lavoro schellinghiano ci suggerisce che è possibile trovare dei limiti ad un
conflitto, di qualunque tipo esso sia, anche in assenza di un’aperta
negoziazione. Questo perché gli accordi taciti, o gli accordi cui si è giunti
attraverso negoziazioni parziali o fortuite, richiedono termini
qualitativamente distinguibili, affinché possano essere misurati i progressi
252
Francesca Salvatore
della negoziazione; inoltre, quando si deve raggiungere un accordo con una
comunicazione incompleta, i partecipanti devono essere pronti a lasciare
che sia la stessa situazione ad esercitare dei vincoli sul risultato stesso: ad
esempio, una soluzione che discrimini una delle due parti o crei disagi ad
entrambe, spesso, può essere l’unica via percorribile. A sostegno di ciò si
possono fornire alcuni esempi storici, come la guerra di Corea o il conflitto
tra la Cina popolare di Mao Tse-Tung e la Cina nazionalista di Chang KaiShek. Nel primo caso, la storia dimostra come la conformazione fisica della
Corea abbia indirettamente posto dei limiti al conflitto: l’area era circondata
da acqua, e il principale confine politico settentrionale era segnato
visibilmente da un fiume. Il 38° parallelo sembra aver segnato, per fortuna,
un punto cruciale per lo stallo della situazione. Nel caso del conflitto cinese
del 1949, lo Stretto di Formosa ha permesso di consolidare un confine tra le
forze comuniste e quelle nazionaliste cinesi, non solo perché le acque
circostanti favorivano la difesa e inibivano l’attacco, ma perché un’isola è
un’unità completa e non violare i suoi confini significa accettare un certo
status quo. Questi esempi dimostrano come, in una situazione negoziale, le
regole possono essere rispettate, perché, una volta infrante, non vi è certezza
sulla possibilità di trovarne delle nuove. Violare le regole pattuite con una
rappresaglia porta alla distruzione di aspettative reciproche stabili. Da
questa analisi emerge che il problema di limitare la strategia di guerra
sottende un meccanismo portato a riconoscere differenze qualitative,
anziché quantitative, un meccanismo spiazzato dalla molteplicità delle
strategie delle parti, che spesso si accorderanno per il “male minore”.
Affinché questo accordo avvenga, è necessario, ovviamente, tenere aperti i
canali di comunicazione: identificare chi manda e riceve messaggi, con
quali mezzi, in base a quale autorità, è un elemento fondamentale; nel caso
di uno sforzo bellico per combattere una guerra nucleare contenuta,
potrebbero esserci brevi istanti in cui le parti devono decidere se sia in corso
una guerra limitata o se una guerra illimitata sia appena cominciata: un gap
anche di poche ore su come creare un contatto potrebbe compromettere il
contenimento del conflitto. Questi elementi, unitamente a decine di altri
fattori contingenti, dimostrano che, quando tutte le parti hanno un disperato
bisogno di un segnale, anche quello più piccolo o discriminatorio può
ispirare riconoscimento, in mancanza d’altro. Una volta che la contingenza
viene fondata su questi segnali, gli interessi, che originariamente
divergevano nel gioco delle minacce e dei deterrenti, potranno coincidere
nel disperato bisogno di un punto focale per l’accordo.
253
Il ruolo della teoria dei giochi nel neorealismo strategico di Thomas C. Schelling
2. I fondamenti della teoria dei giochi
Il secondo Novecento è stato la culla delle teorie della strategia, in
particolar modo delle teorie strategiche descrittive, sviluppate soprattutto
dagli studiosi di storia e sociologia militare, i quali miravano a spiegare le
effettive strategie perseguite nei conflitti bellici. L’idea, invece, oggi molto
diffusa, che la strategia possa avere un carattere normativo risale almeno a
16
Carl von Clausewitz. Tra i teorici della strategia del secondo dopoguerra,
un posto di rilievo va attribuito agli esperti di strategia atomica: fra questi,
Andrè Beaufre, padre della forza atomica francese, che si distinse per aver
17
coniato il concetto di force de frappe.
Beaufre ritiene che l’analisi dei conflitti tra potenze atomiche imponga di
superare l’antico concetto di strategia militare, vista come l’arte di
impiegare le forze militari per raggiungere i risultati determinati dalla
politica. Definizione, questa, troppo ristretta, in quanto si riferisce soltanto
alle forze militari: occorre, invece, includere nel dominio della strategia
anche l’impiego di forze materiali diverse da quelle militari – per esempio,
la forza economica – e di forze non materiali, come quelle psicologiche.
Poiché il conflitto fra Stati è un caso peculiare di dialettica della volontà,
non deve sorprendere che i mezzi utilizzabili a questo scopo possano
includere la psicologia. Infatti, nella contrapposizione fra due Stati,
ciascuno dei due cerca di ottenere dall’avversario ciò che desidera:
convincerlo che potenziare la lotta o semplicemente proseguirla è
perfettamente inutile e poco auspicabile. Il carattere limitativo della vecchia
concezione della strategia emerge chiaramente in tutti quei casi in cui gli
scopi della politica non possono essere raggiunti attraverso una guerra
aperta. In una guerra atomica, le forze armate tradizionali non sono in grado
di proteggere il territorio di uno Stato dalla distruzione fisica e dalla
contaminazione nucleare: ergo, in caso di minaccia nucleare, l’obiettivo
16
Sull’argomento si veda C. VON CLAUSEWITZ, Della guerra, a cura di G.E.
RUSCONI, Torino, Einaudi, 2000.
17
La force de frappe è il termine con il quale è conosciuto l’arsenale atomico
francese. Durante gli anni Cinquanta, due avvenimenti internazionali, come la
guerra d’Indocina e la crisi del Canale di Suez, avevano convinto il governo che, per
ottenere risultati rilevanti in politica estera, avrebbe dovuto dotarsi di una propria
forza militare abbastanza potente da poter condizionare le scelte di qualunque paese:
il deterrente nucleare fu la risposta a questa esigenza. Cfr. A. BEAUFRE, Strategy of
Action, New York, Praeger, 1967.
254
Francesca Salvatore
desiderabile non è quello di vincere la guerra, bensì quello di rendere
credibile la propria minaccia per dissuadere il proprio avversario da
qualsiasi azione. Strategie dissuasive di vario genere possono essere
utilizzate, infatti, anche nelle fasi precedenti e successive al dispiegamento
delle forze militari, vale a dire nella preparazione dello scontro e nella sua
conduzione. La prima regola da stabilire in guerra è il suo grado di intensità:
ciò implica, appunto, un problema di strategia della deterrenza. Infatti,
persino nel corso dei conflitti più violenti, i contendenti possono
tacitamente accordarsi per non superare certe soglie di intensità o, al
contrario, minacciare di farlo. La storia militare ci mostra che promesse e
minacce spesso si collocano in uno scenario di guerra limitata. Proprio con
l’intento di condurre una guerra limitata, infatti, la moderna scienza
matematica e la politologia si sono unite per dar vita alla “teoria dei giochi”.
La teoria dei giochi può essere definita come la scienza matematica che
analizza situazioni di conflitto e ne ricerca soluzioni competitive e
cooperative tramite modelli; le sue applicazioni sono molteplici: dal campo
economico e finanziario a quello strategico-militare, dalla politica alla
sociologia, dalla psicologia all’informatica, dalla biologia allo sport; viene
introdotta anche l’azione del caso, connessa con le possibili scelte che gli
individui hanno a disposizione per raggiungere determinati obiettivi,
obiettivi che possono essere comuni, comuni ma non identici, differenti,
individuali, individuali e comuni, contrastanti. Nel modello della teoria dei
giochi tutti devono essere a conoscenza delle regole del gioco ed essere
consapevoli delle conseguenze di ogni singola mossa. La mossa o l’insieme
delle mosse che un individuo intende fare è chiamata “strategia”. In
dipendenza dalle strategie adottate da tutti i giocatori (o agenti), ognuno
riceve un “pay-off” (secondo un’adeguata unità di misura), che può essere
positivo, negativo o nullo. Un gioco si dice a “somma costante” se per ogni
vincita di un giocatore v’è una corrispondente perdita per altri. In
particolare, un gioco “a somma zero” fra due giocatori rappresenta la
situazione in cui il pagamento viene corrisposto da un giocatore all’altro. La
nascita della moderna teoria dei giochi può essere fatta coincidere con la
pubblicazione del libro Theory of Games and Economic Behaviour di John
von Neumann e Oskar Morgenstern nel 1944, anche se altri autori come
Ernst Zermelo, Armand Borel e von Neumann stesso avevano scritto di
18
Il più famoso studioso ad essersi occupato
teoria dei giochi.
18
Sull’argomento, cfr. E. BOREL, Valeur Pratique et Philosophie des Probabilites,
Sceaux, Editions J. Gabay, 1991. Sul lavoro di Zermelo, si veda H.-D. EBBINGHAUS
255
Il ruolo della teoria dei giochi nel neorealismo strategico di Thomas C. Schelling
successivamente della teoria dei giochi, in particolare per quel che concerne
i “giochi non cooperativi”, fu il matematico John Forbes Nash Jr., al quale è
dedicato il film di Ron Howard. Nash – che, ricordiamo, visse tra incarichi
presso il governo americano, Princeton e gli ospedali psichiatrici – adottò
un approccio completamente nuovo al problema di predire come le due parti
coinvolte in una negoziazione avrebbero potuto interagire. Invece di
definire direttamente una soluzione, definì una serie di condizioni
ragionevoli che qualsiasi soluzione avrebbe potuto soddisfare. Nella teoria
di Nash si presuppone che le aspettative di entrambe le parti riguardo ai
comportamenti reciproci si basino sugli aspetti intrinseci della situazione
stessa della contrattazione. L’essenza di una negoziazione che dia come
risultato un patto è procurata da due “giocatori”, che hanno l’opportunità di
collaborare per un comune risultato in più di un modo. Il concetto di
equilibrio di Nash, che il giovane matematico formulò per la prima volta nel
1949 in un brevissimo articolo, è sicuramente il contributo più importante di
19
questa mente meravigliosa allo studio dei giochi non cooperativi. Quando
era ancora studente a Princeton, Nash dimostrò che, nella strategia più
razionale che un giocatore possa adottare quando compete con un
avversario anch’esso razionale, esiste sempre una situazione di equilibrio,
ottenuta quando ciascun giocatore sceglie la propria mossa strategica, in
modo da massimizzare la sua funzione di retribuzione. Tutti i giocatori,
dunque, possono operare una scelta, dalla quale tutti traggano un vantaggio
(o, quantomeno, una limitazione del proprio svantaggio). Una differenza
sostanziale, questa, rispetto ai giochi a “somma zero” studiati in precedenza
da von Neumann, in cui la vittoria di uno dei due (unici) partecipanti era
totale e necessariamente accompagnata dalla sconfitta all’altro. Il contributo
– V. PECKHAUS, Ernst Zermelo: An Approach to His Life and Work, Berlino,
Springer, 2007. Sull’opera di von Neumann cfr., invece, la raccolta di lettere a cura
di M. REDEI, John von Neumann: Selected Letters, Providence, American
Mathematical Society, 2005.
19
Sulla vita di Nash, cfr. S. NASAR, Il genio dei numeri, Milano, Rizzoli, 1999. La
trattazione dei giochi non cooperativi è stata elaborata da John Nash nella sua tesi di
dottorato dal titolo Non Cooperative Games, datata 1950, tuttora in possesso
dell’Università
di
Princeton
e
disponibile
alla
pagina
www.princeton.edu/mudd/news/faq/topics/noncooperative_games_nash.pdf. Sull’intero lavoro di Nash e sul suo apporto alla
teoria dei giochi, cfr. J. NASH, Essays on Game Theory, Cheltenham, UK, Elgar,
1996.
256
Francesca Salvatore
più importante dato da John Nash alla teoria dei giochi è la dimostrazione
matematica dell’esistenza di tale equilibrio. In particolare, egli ha
dimostrato che ogni gioco finito che ammetta strategie miste, ammette
almeno un equilibrio di Nash, dove per “gioco finito” si intende un gioco
con un numero finito di giocatori e di strategie, e per “strategia mista” si
intende un sottoinsieme di strategie, a ciascuna delle quali l’agente associa
una data probabilità, che gli consentirà una scelta ponderata. L’equilibrio di
Nash rappresenta, quindi, la situazione nella quale il gruppo si viene a
trovare se ogni componente fa ciò che è meglio per sé, cioè se mira a
massimizzare il proprio profitto a prescindere dalle scelte degli avversari. È
questa la soluzione migliore per tutti? Non è detto. Infatti, se è vero che, in
un equilibrio di Nash, il singolo giocatore non può aumentare il proprio
guadagno modificando solo la propria strategia, non è affatto detto che un
gruppo di giocatori o, al limite, tutti, non possano aumentare il proprio
guadagno allontanandosi congiuntamente dall’equilibrio. È noto, infatti, che
20
l’equilibrio di Nash può non essere un “ottimo di Pareto”, ovvero quella
condizione economico-sociale in cui non è possibile migliorare la situazione
di un individuo senza peggiorare quella di un altro. Oggi, il concetto di
equilibrio di Nash relativo ai giochi strategici è uno dei paradigmi
21
fondamentali delle scienze sociali. È grazie al suo contributo che il
mondo scientifico ha accettato la teoria dei giochi come un «metodo potente
ed elegante per affrontare una materia che era diventata sempre più barocca,
in modo molto simile a quello in cui i metodi della meccanica celeste
newtoniana avevano sostituito i metodi primitivi e sempre più ad hoc degli
22
antichi». Come spesso accade ai grandi della scienza, l’idea di Nash non
fu immediatamente condivisa, perché ritenuta troppo semplice, troppo
20
Il concetto di “ottimo paretiano” venne introdotto dall’economista italiano
Vilfredo Pareto. L’idea di “ottimo paretiano”, o meglio, la sua compatibilità con il
liberismo è oggi contestata dal premio Nobel per l’Economia Amartya Sen, che ha
tentato di dimostrare, attraverso calcoli matematici, la possibile inesistenza
dell’“ottimo paretiano” in un sistema liberista. A tal proposito, cfr. A.K. SEN, The
Impossibility of a Paretian Liberal, in «Journal of Political Economy», LXXVIII, 1,
January-February 1970, pp. 152-157.
21
Per una più chiara comprensione del concetto di equilibrio di Nash, cfr. J. NASH,
Equilibrium Points in N-Person Games, in «Proceedings of the National Academy
of the Usa», XXXVI, 1, January 1950, pp. 48-49.
22
Cfr. J. EATWELL – M. MILGATE – P. NEWMAN, The New Palgrave: Game Theory,
New York, W.W. Norton, 1989, p. 13.
257
Il ruolo della teoria dei giochi nel neorealismo strategico di Thomas C. Schelling
ristretta per trovare un'ampia applicazione e, in seguito, così ovvia da
sembrare deducibile da chiunque. Come ha affermato Reinhard Selten,
l’economista tedesco che vinse il premio Nobel nel 1994 insieme a Nash e a
John C. Harsany, «nessuno avrebbe previsto il grande impatto che
l’equilibrio di Nash ebbe sulle scienze economiche e sociali in generale.
Ancor meno ci si sarebbe aspettati che il concetto del punto di equilibrio di
Nash avrebbe mai avuto una qualsiasi importanza per la teoria biologica».
23
Schelling fece tesoro delle novità, introdotte dal contributo di Nash, per
arricchire la propria analisi del panorama internazionale con una serie di
riflessioni aventi per oggetto categorie come la minaccia, la promessa o la
dissuasione, categorie che sono andate, a loro volta, a costituire un campo di
studi interdisciplinari denominato “teoria del conflitto”. Alla pari della
teoria dei giochi, della quale condivide il carattere normativo, la teoria del
conflitto si propone di identificare i principi che governano il
comportamento di un agente razionale coinvolto in un conflitto con altri
agenti razionali. Il comune interesse ad evitare che il risultato del conflitto
sia congiuntamente indesiderabile non basta, tuttavia, a mettere d’accordo i
giocatori: potrebbe accadere, infatti, che qualche risultato rovinoso per un
giocatore sia estremamente desiderabile per un altro. Tra le più comuni
strategie dissuasive figurano le minacce, le promesse e gli avvertimenti; a
livello informale, la minaccia può venire descritta come una strategia
dissuasiva in forma condizionale, il cui tratto distintivo consiste nel fatto
che chi applica la minaccia non avrebbe alcun interesse a metterla in atto. Il
successo della minaccia consiste, quindi, nella sua non attuazione: risulta
riuscita solo se non viene applicata, poiché ciò significa che ha prodotto
l’effetto di distogliere la controparte da una certa azione. La promessa,
invece, è l’esatto contrario della minaccia: infatti, se si minaccia solo
qualcosa di congiuntamente distruttivo, l’effetto di una promessa riguarda
sempre qualcosa di congiuntamente desiderabile. Quest’ultima può essere
definita come un impegno condizionale unilaterale preso dal giocatore che
muove per secondo in un gioco dinamico, allo scopo di incentivare la
controparte a fare una scelta vantaggiosa per entrambi; lo scambio di
promesse, invece, è un impegno non condizionale bilaterale, preso da
giocatori che devono muovere simultaneamente in un gioco statico. Per
23
Cfr. R. SELTEN, “Nobel Seminar”, Le prix Nobel 1994, in
www.wikipedia.org_selten, p. 297. Inoltre, si veda anche ID., Game Theory and
Economic Behaviour: Selected Essays, Northampton, Edgar Elgar, 1999.
258
Francesca Salvatore
Schelling, la teoria dei giochi propone diverse strategie di carattere
bilaterale per vincolare a sé, nel bene o nel male, il proprio avversario: la
più importante di questi è il metodo del contratto; con questo metodo, gli
impegni vengono trasformati in contratti che prevedono il ricorso ad un
arbitro in grado di amministrare una punizione a chi violi l’impegno sancito
dal contratto stesso. Ciò significa che l’obbligatorietà degli accordi viene
garantita attraverso un sistema di punizioni, che può ridurre le funzioni dei
pay-offs dei giocatori. La seconda strategia è quella di mettere in gioco la
propria reputazione; questo tipo di impegno non prevede alcun accordo con
la controparte, che, anzi, potrebbe essere danneggiata dall’eventuale
attuazione dell’impegno preso unilateralmente da un giocatore. Questo
metodo ha, però, un punto debole: il danno subito da chi “perde la faccia” si
manifesta solo dopo la fine del gioco, quando ormai il “dado è tratto”.
Perdere la faccia, inoltre, non è per tutti qualcosa di negativo: è penalizzante
solo per quei giocatori sui quali si proietta – come affermò Robert Axelrod
24
La terza
in The Evolution of Cooperation – “l’ombra del futuro”.
strategia, infine, consiste nel bruciare i ponti alle proprie spalle: ciò
permette di distruggere interamente la libertà di attuare una condotta
alternativa. Così, per esempio, l’esercito che si brucia i ponti alle spalle, si
priva volontariamente di ogni via di fuga, rendendo in tal modo
assolutamente credibile la propria minaccia di combattere fino in fondo. Il
metodo dei “ponti bruciati” include una grande varietà di sistemi e tattiche
che operano attraverso qualche volontario, ma irreversibile, sacrificio della
libera scelta.
Poiché la teoria dei giochi è strettamente connessa a calcoli matematici
complessi, spesso può accadere che le soluzioni dei giochi stessi possano
portare a paradossi validi per la matematica, ma non di certo per la vita
reale; infatti, il mondo della strategia ha una sua logica da iperuranio, spesso
in contrasto con la nostra logica ordinaria. Tali paradossi possono
manifestarsi quando l’irrazionalità si “impossessa” dei giocatori: pensiamo
alla fermezza di John Foster Dulles, alla collera che fa battere i tacchi delle
scarpe a Nikita Kruscev, all’ostinazione fredda di De Gaulle, all’“impero
del male” annunciato da Ronald Reagan. Tutti piccoli grandi esempi del
fallimento della razionalità intesa nel senso schellinghiano del termine:
l’elemento decisivo, in tutti questi casi, riposava sulla volontà di scatenare il
cataclisma, poiché far credere che si ha questa volontà è più importante di
24
Cfr. R. AXELROD, The Evolution of Cooperation, New York, Basic Books, 1985, p.
18.
259
Il ruolo della teoria dei giochi nel neorealismo strategico di Thomas C. Schelling
tutto il resto. Diplomazia compresa, purtroppo. La tattica di simulare follia,
stupidità e altre forme di irrazionalità – in aggiunta a quella di cui si è
“naturalmente” dotati – è vecchia, infatti, quanto il pianeta.
Ma in che misura la teoria dei giochi può essere illuminante nell’analisi
degli equilibri internazionali? Come si evince dalla storia di questa
disciplina, i concetti di razionalità e strategia hanno subito un boom
scientifico intimamente correlato allo sviluppo delle armi di distruzione di
massa: i primi “giochi” studiati, infatti, furono proprio i “giochi del terrore”,
in cui il primo colpo – il cosiddetto first strike – consisteva nel lancio di un
attacco atomico volto alla completa distruzione delle forze atomiche
dell’avversario, così da lasciarlo alla mercé dell’aggressore. Come osserva
25
la strategia è governata da una dialettica particolare che,
Luttwak,
soprattutto in campo atomico, può provocare la coincidenza degli opposti.
Per esempio, inesorabilmente i pacifisti attirano la guerra, gli implacabili
espansionisti perdono potere, gli inflessibili invasori sconfiggono la loro
forza, i fautori del disarmo provocano la corsa al riarmo e quelli del riarmo
generano il disarmo. Un classico paradosso dell’età atomica sembra
costituito dal fatto che le armi nucleari siano state rese inutili dalla loro
stessa potenza distruttiva, nonché dall’efficacia delle strategie di reciproca
26
dissuasione. Il primo a parlare, infatti, di quell’“equilibrio del terrore” che
fa capolino dai manuali di storia contemporanea fu Winston Churchill. In
occasione di un discorso tenuto alla Camera dei Comuni nel novembre del
1934, egli affermò: «Resta il fatto che quando tutto è stato detto e fatto
riguardo ai sistemi difensivi, in mancanza di nuove scoperte, l’unica misura
diretta di difesa su vasta scala è la certezza di poter infliggere
immediatamente al nemico un danno altrettanto grave di quello che egli può
infliggere a noi. Non sottovalutiamo l’efficacia di un tale sistema. In pratica,
anche se non lo posso provare teoricamente, potrebbe dimostrarsi
sufficiente per fornirci una totale immunità. Se due potenze si dimostrano
ugualmente capaci di infliggere danni reciproci con alcuni particolari
strumenti bellici, in modo che nessuno tragga vantaggio dalla loro adozione
ed entrambe soffrano i danni più terribili, è non solo possibile, ma probabile
27
che nessuno impiegherà tali strumenti». Schelling, dal canto suo, non
25
Cfr. E.N. LUTTWAK, Strategia, Milano, Rizzoli, 1989, p. 181.
Cfr. L. BONANATE, La politica internazionale fra terrorismo e guerra, Bari-Roma,
Laterza, 2005, p. 106.
27
Cfr. SCHELLING, La diplomazia della violenza, cit., p. 24.
26
260
Francesca Salvatore
avendo mai smesso di occuparsi di strategia e di proliferazione nucleare, ha
recentemente allargato la cornice teorica che aveva sviluppato negli anni
della Guerra Fredda a nuove tematiche come la globalizzazione e il
terrorismo internazionale. È proprio dalle pagine della rivista on line del
«Chicago Project on Security and Terrorism» che, in un caustico articolo
pubblicato il 6 agosto del 2011, l’anziano economista ha ipotizzato
l’ennesimo effetto deterrente delle armi atomiche: «[…] I terroristi non
hanno ancora acquistato armi nucleari: sarebbe molto più che rubare solo
materiale fissile. Ma loro possono ancora farlo. […] Sicuramente avranno
speso centinaia di ore cercando di pensare strategicamente circa i possibili
usi di poche armi nucleari più di quanto un capo di governo o un consigliere
abbiano mai fatto. […] Credo che loro concluderebbero che far esplodere
un’arma su Los Angeles o Vladivostok o Brema “sprecherebbe” l’arma
stessa. Loro penseranno “siamo un potere nucleare”. Ci sono Usa, Russia,
Francia, Gran Bretagna, Cina, Israele, India, Pakistan, Nord Corea, Iran, e
28
adesso noi. Abbiamo status, potere, influenza. Usiamoli!”».
Il successo delle strategie di dissuasione, nel corso dei decenni, ha
puntato ad evitare conflitti nucleari generalizzati, consentendo il tranquillo
svolgimento di conflitti locali di enorme violenza; tali conflitti sono stati
caratterizzati da un feroce primitivismo bellico, con intere popolazioni
sterminate con armi da fuoco, pugnali, asce e bastoni: si pensi ai casi del
Rwanda, della Bosnia o del Kossovo. È, così, accaduto che, per paradossale
ironia della ragione strategica, la bomba atomica abbia condotto, proprio per
il suo carattere catastrofico, alla pace atomica, aprendo, però, nel contempo
la via al più massiccio uso bellico di pugnali e armi bianche dell’intera
storia umana. Einstein l’aveva previsto quando, dopo essere venuto a
conoscenza del progetto Manhattan, restò talmente sconvolto da affermare:
«Non so se ci sarà una terza Guerra Mondiale, ma posso dirvi che la quarta
29
sarà combattuta con le pietre!».
3. Alcune applicazioni della teoria dei giochi
La scienza del conflitto, assieme a tutti gli studi strategici, ruota attorno ad
un chiaro obiettivo: la sicurezza nazionale. Da qui due evidenze: la
28
Cfr. TH.C. SCHELLING, Whatever Happened to Nuclear Terrorism?, in «Chicago
Project on Security and Terrorism (CPOST)», August 6, 2011.
29
Cfr. A. CALAPRICE, Albert Einstein: A Biography, Westport, Greenwood
Publishing Group, 2005, p. 124.
261
Il ruolo della teoria dei giochi nel neorealismo strategico di Thomas C. Schelling
sicurezza come esigenza legata a specifici interessi e il profondo legame tra
sicurezza e potere. Attorno a quest’ultima è possibile distinguere studiosi
che vedono l’accumulo progressivo di potere come l’unico mezzo per
potersi garantire la sicurezza, e altri che, invece, ritengono che un accumulo
indefinito possa essere addirittura controproducente per la propria sicurezza.
Ma quali strategie hanno elaborato teorici e matematici per poter fornire alla
politica un ausilio reale per affrontare il problema? Le definizioni
concettuali differiscono di molto da studioso a studioso ma, in linea
generale, però, se ne possono individuare almeno tre. La prima è quella del
balancing, ovvero della politica di bilanciamento che, di per sé, è inevitabile
quanto stabilizzante. Essa assicura due funzioni fondamentali: da un lato, la
stabilità dei rapporti di forza e, dall’altro, l’autonomia degli Stati; in altre
30
parole, impedisce che uno Stato sia dominato dall’altro. Diverso è, invece,
il buckpassing (lo “scaricabarile”), grazie al quale la grande potenza
minacciata cerca di indurre un altro Stato a farsi carico dell’impegno di
intimidire o sconfiggere lo Stato che rappresenta la minaccia. Barry Posen
sostenne che le dottrine militari difensive o la percezione della superiorità
31
della difesa rispetto all’attacco facilitano il buckpassing, poiché esso
appare come la strategia migliore, dati gli alti costi dell’attacco: si
sottovaluta la probabilità di essere attaccati o che sia attaccato il “caricato”
(la persona sulla quale viene fatto il buckpassing) e, contemporaneamente si
sopravvaluta il potere deterrente della superiorità, vera o presunta, della
32
33
difesa sull’attacco. Last but not least, vi è poi il bandwagoning, tipico
di quegli attori nazionali o internazionali che si uniscono alla parte più forte
fra due coalizioni. Questa formula, secondo l’interpretazione di Robert
Schweller, non è una forma di sconfitta politica, ma si presta ad
interpretazioni sia machiavelliche, che “alla Waltz”. La ragione più comune
per scegliere il bandwagoning è la previsione di un guadagno: affinché uno
Stato adotti questa strategia, non è necessaria una minaccia per la sicurezza,
30
Cfr. Q. WRIGHT, A Study of War, Chicago, University of Chicago Press, 1964, p.
116.
31
Cfr. R. SCHWELLER, Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back
in, in «International Security», XIX, 1, October 2004, pp. 72-107.
32
Cfr. B. POSEN, The Sources of Military Doctrine: France, Britain and Germany
between the World Wars, Ithaca, Cornell University Press, pp. 63, 74 e 232.
33
Il concetto di bandwagoning può essere approssimativamente tradotto in italiano
con “effetto carrozzone” o “istinto del gregge”. Indica, in linea generale, la tendenza
sociale, economica o elettorale ad allearsi con chi ha maggiori probabilità di vittoria.
262
Francesca Salvatore
poiché è la sanzione positiva (la ricompensa) a spingere gli Stati a fare
bandwagon.
Eppure, non sempre la scelta della strategia da seguire è così “pacifica”.
Spesso, nella scienza politica e nelle relazioni internazionali, si analizzano
situazioni (come la crisi di Cuba) definite “sull’orlo della guerra”. Questa
tattica è definita brinkmanship ed indica, appunto, la pratica di spingere una
situazione pericolosa sull’orlo del disastro al fine di raggiungere il risultato
più vantaggioso possibile, costringendo la parte opposta a fare delle
concessioni. Ergo, in questi casi è necessaria una buona dose di lucida
irrazionalità per lasciare intenzionalmente che la situazione sfugga di mano,
semplicemente perché il fatto che sia fuori controllo può diventare
insopportabile per l’altra parte, costringendola così, ad un
34
accomodamento. Tra le diverse ipotesi “di gioco” che prevedono una
situazione sull’orlo del baratro, una delle formulazioni più interessanti è il
cosiddetto “MAD”, acronimo di Mutually Assured Destruction (distruzione
reciproca assicurata), relativo all’escalation nucleare, file rouge di
35
cinquant’anni di Guerra Fredda. La teoria MAD assume che ogni parte
abbia sufficiente potenziale bellico da distruggere l’altra e che ognuna delle
parti, se attaccata per qualsiasi motivo, reagirebbe con forza pari o superiore
o comunque paragonabile. Risultato? L’olocausto nucleare. Lo sperabile
atteso risultato degli assunti di questa versione della teoria dei giochi è che
tali considerazioni possano indurre alla pace, seppur “fredda”, ma resa
stabile dal mutuo deterrente. I critici della teoria della distruzione mutua
assicurata notarono che l’acronimo “MAD” condivideva qualcosa di più di
una mera assonanza con la parola inglese mad (pazzo), poiché l’equilibrio e
lo stato di quiete (almeno quella atomica) dipendevano da diverse
condizioni necessarie per la sua applicabilità, tutte inevitabilmente soggette
a rischi insostenibili o irrimediabili. Interessante, a tal proposito, fu un
pamphlet pubblicato nel novembre del 1945 da Bernard Brodie, che sarebbe
diventato uno dei più importanti strateghi nucleari al mondo
preannunciando gli effetti “equilibratori” delle armi nucleari. In The Atomic
Bomb and American Security, Brodie concluse che le armi atomiche
annunciavano un cambiamento «non meramente della distruttività della
guerra moderna, ma delle sue caratteristiche fondamentali». In primo luogo,
34
Sull’argomento, cfr. R.N. LEBOW, Soviet Incentives for Brinkmanship, in «Bulletin
of the Atomic Scientist», XXXVII, 5, May 1981, pp. 14-21.
35
Cfr. COL. A.J. PARRINGTON, Mutually Assured Destruction Revisited, Strategic
Doctrine in Question, in «Airpower Journal», XI, 4, Winter 1997, pp. 5-19.
263
Il ruolo della teoria dei giochi nel neorealismo strategico di Thomas C. Schelling
la bomba atomica non era «un altro, più distruttivo armamento che si
aggiungeva a una già lunga lista, [ma] qualcosa che rischia[va] di rendere il
resto dell’elenco relativamente inutile». Le nuove armi, infatti, annullavano
non solo la distinzione classica tra offesa e difesa, ma, secondo Brodie, «il
cambiamento essenziale introdotto dalla bomba atomica è […] che essa
concentrerà la violenza in termini di tempo. Un mondo abituato a ritenere
mostruoso che la durata delle guerre sia di quattro o cinque anni è ora
terrorizzato alla prospettiva che le future guerre possano durare non più di
36
pochi giorni». La teoria fu oggetto di un’amara satira nel film di Stanley
Kubrik, Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e
ad amare la bomba del 1964. Nel film, i sovietici dispongono di un ordigno
da fine del mondo, che individua automaticamente ogni attacco nucleare
all’URSS e, di conseguenza, distrugge tutta la vita sul pianeta. Il film
mostra anche un comandante impazzito, che (inconsapevole del dispositivo
sovietico) ordina alla sua squadriglia un attacco nucleare preventivo,
scommettendo che l’alto comando sarà costretto ad appoggiarlo, lanciando
tutto l’arsenale atomico per sopravvivere al contrattacco sovietico. Alcuni
teorici sostengono che la distruzione mutua assicurata venne abbandonata il
25 luglio del 1980, quando il presidente statunitense Jimmy Carter adottò la
37
countervalling strategy con la Direttiva Presidenziale 59: la dottrina,
anticipata da una serie di direttive risalenti al 1977, aveva per oggetto la
mobilitazione, la difesa, il comando e il controllo nel caso di un conflitto
nucleare prolungato, rappresentando, come affermò l’assistente per la
Sicurezza Nazionale Zbigniew Brzezinski, un vero scostamento rispetto al
38
MAD o, meglio, una sua evoluzione. A partire da questa data, la linea
strategica statunitense fu orientata verso l’obiettivo di riportare la vittoria in
un’eventuale guerra nucleare e non di distruggere l’URSS stessa. L’ironia
del destino, però, volle che fosse uno dei più emblematici cold warrior,
Ronald Reagan, a porre la propria firma al trattato INF (Intermediate-Range
Nuclear Forces) nel 1987, segnando una delle più grandi battute d’arresto
36
Cfr. B. BRODIE, The Atomic Bomb and American Security, in Us Nuclear Strategy:
A Reader, PH. BOBBIT – L. FREEDMAN – G.F. TREVERTON, eds., Londra, Macmillan,
1945, pp. 65-67.
37
Cfr. W. SLOCOMBE, The Countervalling Strategy, in «International Security», V, 4,
Spring 1981, pp. 18-27. Il testo della PD 59, invece, è disponibile alla pagina web
www.jimmycarterlibrary.gov/documents/pddirectives/pd59/pdf.
38
Cfr. R. CROCKATT, Cinquant’anni di Guerra Fredda, Roma, Salerno Editrice,
1997, p. 367.
264
Francesca Salvatore
all’escalation nucleare. Quello che comunemente viene indicato come
“controllo degli armamenti” rappresentò «veramente lo sforzo per compiere
un passo avanti, dopo troppe e troppo lunghe incertezze, verso una più
corretta conoscenza del ruolo che le forze armate hanno nel mondo
moderno; […] ora, con il controllo degli armamenti si viene a riconoscere
che le sanzioni, le costrizioni o i fermi atteggiamenti di una seria diplomazia
implicano posizioni di forza, e che, perciò, è precipua funzione delle forze
armate influenzare il comportamento degli Stati, non quella di essere
39
adoperate soltanto per l’altrui distruzione».
Appena due anni dopo la firma del Trattato INF, cadeva il muro di
Berlino, ultimo baluardo di un mondo che era già cambiato da un pezzo.
Sulle sue macerie si risanò una delle fratture politiche più tristi del XX
secolo: gli Stati Uniti avevano vinto, ma pagando un prezzo altissimo. Se un
tempo, infatti, le potenze nucleari erano state soltanto due, lo
smantellamento dell’arsenale nucleare sovietico coincise con la nascita
dell’incubo dell’“ennesimo paese”, che portò le potenze nucleari ad un
numero sempre maggiore (soprattutto fra i paesi governati da leadership
dispotiche e illiberali), minando, oggi più che mai, la sicurezza del sistema
politico mondiale.
39
Cfr. TH.C. SCHELLING – M. HALPERIN, Strategia e controllo degli armamenti,
Bologna, Il Mulino, 1961, p. 197.
265
Quis leget haec?
Recensioni
FRANCESCO PERFETTI – ANDREA
UNGARI – DANIELE CAVIGLIA –
DANIELE DE LUCA, a cura di,
Aldo Moro nell’Italia contemporanea, Firenze, Le Lettere, 2011,
pp. 816.
Il testo raccoglie gli interventi degli
studiosi in due convegni celebratisi a
Lecce ed a Roma. Articolato in due
sezioni, la prima, curata da Perfetti e
da Ungari (concernente il ruolo di
Moro nella politica interna italiana), la
seconda, curata da Caviglia e De Luca
(che analizza l’azione svolta dal dirigente della DC nelle relazioni internazionali dell’Italia), il volume ripercorre
tutto l’arco temporale della vicenda
politica di Moro, tendendo ad identificarla, di fatto, con quella del paese,
specie nel passaggio nodale degli anni
Sessanta e Settanta.
La prima parte scandaglia la figura di
Moro analizzandone la formazione
politica (pp. 27-48), il ruolo all’interno
della DC (pp. 49-80) e del mondo cattolico (pp. 81-104), i rapporti con i
partiti, la sua percezione del movimentismo (pp. 257-276) ed un’analisi – che
rilegge criticamente le tesi di Gotor e
Flamigni – del suo rapimento ed omicidio (pp. 277-299). Moro «aveva
un’idea della politica come luogo di
mediazione delle culture diverse e,
quindi, del partito come strumento in
grado di filtrare le esigenze complesse
della vita del paese e caratterizzarsi per
la funzione mediatrice» (p. 14). Nonostante il fallimento dell’esperimento
del centrosinistra, Moro, specie dopo il
’68, si oppose fermamente alla possibi-
lità di una convergenza tra la DC e il
MSI, ribadendo, come sostiene Ungari,
«il rifiuto dell’involuzione verso destra
della Democrazia cristiana, rivendicando la necessità di riprendere il percorso del centro-sinistra, proprio a
fronte delle richieste popolari e sociali
che provenivano dal paese» (p. 249).
Negli anni della contestazione, Moro
continuò a caratterizzarsi per «un approccio realistico ai problemi, presentandosi come il massimo interprete,
nell’Italia della “grande trasformazione”» (p. 145). Atteggiamento che,
supportato da un certo realismo, fu alla
base del suo dialogo con Berlinguer,
che Guiso libera da un’interpretazione
apologetica, tendente ad identificare
Moro come ideologo di una «democrazia “trans-ideologica” o, se si preferisce, “post-ideologica”» (p. 140). Rapporto che egli gestì «in forme tali da
non indebolire nella sostanza la posizione della DC. Dunque, tenendo conto
in primo luogo che l’anticomunismo è
stato, e resta, uno dei collanti più forti
del partito» (p. 157). Di qui, la conclusione che il rapporto con Berlinguer
non sarebbe potuto «andare oltre un
confronto per verificare se e come DC
e PCI possano dare un contributo comune alla soluzione dei problemi più
urgenti del paese […]. Pertanto è senza
ambiguità il rifiuto di Moro del “compromesso storico”» (p. 156).
La propensione al dialogo che emerge dalla prima parte del volume risulta
amplificata nella seconda sezione,
dedicata agli indirizzi di politica estera.
L’azione diplomatica che lo statista di
Maglie assegnò ai rapporti internazio-
269
nali dell’Italia è analizzato in tutti i
contesti in cui esso si esplicò:
dall’azione politica in ambito ONU, ai
rapporti con i partners europei; dalla
risoluzione delle questioni alto-atesine
e del confine orientale italiano, alla
politica monetaria, coprendo anche i
rapporti con il Corno d’Africa. La
politica nei riguardi degli Stati Uniti
emerge in gran parte dei saggi, ma
assume un carattere di rilievo se rapportata all’atlantismo, alla crisi del
Vietnam ed alla questione mediorentale.
Negli anni ’60, nella fase di passaggio dalla forte contrapposizione USAURSS alla «manifesta intenzione di
individuare percorsi di dialogo» (p.
309), la politica di Moro si caratterizzò
per la fedeltà all’atlantismo che, come
sostiene Daniele De Luca, ebbe modo
di evidenziarsi nell’adesione al progetto costitutivo di una Forza Multilaterale lanciato da Kennedy. Lo statista
pugliese difese il progetto sia in sede
interna, sia in ambito europeo, bloccato
dallo sviluppo del programma nucleare
francese, da «una Gran Bretagna riluttante e per nulla persuasa, [e da] una
Germania in cui il partito di maggioranza appariva diviso sulla strada da
prendere» (p. 418). Una propensione
alla mediazione che, come rileva Imperato, si manifestò anche nei riguardi
della guerra in Vietnam. Moro, conscio
del fatto che la crisi indocinese «[avrebbe potuto contribuire] a mettere in
crisi il rapporto già precario esistente
tra DC e PSI» (p. 424), passò «da
un’adesione iniziale, quasi acritica,
all’azione americana, […] ad un più
cauto atteggiamento di “comprensione”» (p. 425). Atteggiamento che non
si limitò ad «una passiva attesa di un
negoziato» (p. 435), ma che si tradusse
nel tentativo di Giorgio La Pira di avviare dei colloqui negoziali con Ho Chi
Minh. Come evidenzia Luca Riccardi,
le prime divergenze con Washington si
manifestarono in ambito mediorentale.
Già dal suo primo governo, Moro non
si era staccato dalle «tradizioni consolidate della politica estera italiana che
aveva fatto del mondo arabo il suo
principale punto di riferimento in Medio Oriente» (p. 553). Ciò si tradusse
in una linea diplomatica improntata al
mantenimento dell’“equidistanza” tra
le parti e sull’adesione alla Risoluzione
242 dell’ONU. Il rifiuto di Gerusalemme di accettarne i termini spinse
Moro «a manifestare una sempre maggiore “comprensione per il mondo
arabo”» (p. 567). Una linea filo-araba
che Moro amplificò durante la Guerra
dello Yom Kippur con un’«azione di
riavvicinamento anche ai paesi più
radicali […] “concepita in piena autonomia” dagli Stati Uniti» (p. 579).
Lo shock petrolifero fece emergere in
Moro «la necessità di mantenere rapporti economici privilegiati con
l’Egitto, la Libia, i paesi del Maghreb e
l’Arabia Saudita [e] portò progressivamente l’Italia verso una politica più
apertamente filo-araba» (p. 634).
Un’apertura che si estese anche a Stati
arabi radicali come Iraq e Siria, paesi
in cui il sottosegretario agli esteri Bensi fu inviato con il fine «di migliorare i
rapporti con i due Stati arabi, nella
speranza […] che ciò potesse ripagare
270
[gli italiani] nel lungo periodo» (p.
635). Un atteggiamento, questo, come
afferma Labbate, che, se da un lato
rafforzò «quella cooperazione economica multilaterale orientata al dialogo
con i paesi produttori», dall’altro, generò «delle tensioni nei rapporti con
Washington» (p. 734). Un contrasto
che si condensa nel ritratto caustico
che di lui fece Henry Kissinger nelle
proprie memorie: «Era chiaramente il
personaggio di maggior spicco. Era
taciturno quanto intelligente, possedeva una formidabile reputazione intellettuale. L'unica prova concreta che
ebbi di questo suo ingegno fu la complessità bizantina della sua sintassi. Ma
poi gli feci un effetto soporifero, durante più della metà degli incontri che
tenne con me, mi si addormentò davanti; cominciai a considerare un successo
il semplice fatto di tenerlo desto. Moro
si disinteressava chiaramente degli
affari internazionali [...]; stava preparando, indirettamente e quasi impercettibilmente, com'era suo solito, quei
cambiamenti fondamentali che avrebbero portato il partito comunista a un
passo dalle leve del potere» (H. Kissinger, Gli anni della Casa Bianca,
Milano, 1989, p. 94).
Lucio Tondo
STANLEY WOLPERT, India and
Pakistan: Continued Conflict or
Cooperation?, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 2010, pp. 126.
Nella sua più recente pubblicazione
Stanley Wolpert, considerato uno dei
più importanti autori della storia moderna, politica ed intellettuale di India
e Pakistan, entra nel cuore delle problematiche che hanno contribuito ad
acuire i rapporti tra questi due Stati,
dal crollo dell’Impero britannico in
India nell’agosto del 1947 sino ai giorni nostri. Il divario esistente tra le due
principali confessioni religiose del
subcontinente indiano, induismo e
islamismo, si accentuò sino a diventare
una spina nel fianco dell’Asia Meridionale, quando la Gran Bretagna decise di decretare la nascita di due Stati
separati, India e Pakistan, effettuando
una divisione arbitraria del territorio,
non tenendo conto delle differenti etnie
presenti in ciascuna parte e lasciando
in balia degli interessi geopolitici dei
neonati Stati la sorte di alcuni territori,
primo tra tutti il Kashmir.
Partendo da questo presupposto,
l’autore passa in rassegna tutti i principali avvenimenti storici che hanno
caratterizzato la storia di questi due
Stati a partire dall’indipendenza, illustrando i numerosi conflitti scoppiati
per la contesa dello Stato del Kashmir
e per ottenere la supremazia in Asia
Meridionale. La trattazione descrittiva
delle guerre è integrata con aspetti
altrettanto rilevanti. Il Pakistan, contra-
271
riamente all’India, non presentava una
situazione politica stabile, e durante i
primi anni dalla sua nascita vide numerosi ricambi ai vertici, con il predominio della dittatura militare. A questa
debolezza regionale si unì la presenza
di due superpotenze esterne, Stati Uniti
e Unione Sovietica, la cui “tensione”
non contribuì certo ad allentare i contrasti nel subcontinente indiano. Le
alleanze “regionali”, prima tra tutte
quella stretta tra Pakistan e Afghanistan, ormai in mano ai fondamentalisti
islamici, contribuirono a rendere ancora più incandescente il clima di
quest’area geografica.
L’attenzione dell’autore, però, sembra concentrarsi su un altro aspetto più
recente e preoccupante del contrasto
tra India e Pakistan, ossia il deterrente
nucleare. Già a partire dagli anni ’70,
entrambi i Paesi cominciavano a confrontarsi non solo a livello territoriale,
ma anche nucleare, sommando alle
vecchie discordie un elemento che
rendeva sempre più improbabile un
riavvicinamento. Testimonianza di ciò
furono i tentativi falliti di trovare un
accordo tra gli anni ’80 e ’90, il riaccendersi della disputa in Kashmir nel
1999 e il perpetuarsi dello scontro sino
a oggi. Nella parte finale del testo,
l’autore prospetta la possibilità di un
futuro pacifico in Asia Meridionale. A
suo avviso, l’India dovrebbe assumere
il ruolo di una vera democrazia, promuovendo l’autonomia del Kashmir, il
Pakistan potrebbe inaugurare un processo di evoluzione politico ed economico e, soprattutto, non sostenere più il
terrorismo, diventando più credibile
nell’ambito delle relazioni internazionali. La soluzione, dunque, starebbe in
un accordo diplomatico tra India, Pakistan e Kashmir, con le potenze esterne
a fare da supporto e accelerare il processo di riavvicinamento. Wolpert
“prevede” il miglioramento di rapporti
in un futuro indefinito e affida questo
importante compito alle nuove generazioni, ai giovani, il cui spirito prevarrà,
cercando di “mettere da parte antichi
odi religiosi o anguste antipatie nazionali” (p. 105).
Nadia Schina
PRAVEEN K. CHOUDRY – MARTA
VANDUZER-SNOW, eds., United
States and India: A History
through the Archives – The Later
Years, New Delhi–Thousand
Oaks, Sage Publications, 2011,
pp. 479.
Questo volume dà concettualmente
seguito alla serie inaugurata dagli autori Praveen K. Choudry e Marta Vonduzer-Snow (entrambi impegnati nel
progetto “Security development and
democracy” presso la New York
University) in occasione dell’uscita di
United States and India: A History
through Archives-The Formative Years, pubblicato nel 2008. Il libro si
propone di analizzare i rapporti tra
Stati Uniti e India attraverso una raccolta di documenti declassificati provenienti da diverse agenzie governative americane, includendo nell’analisi
272
anche documenti provenienti dalla
Central Intelligence Agency, dal dipartimento della Difesa, dal Federal
Bureau of Investigation, dal National
Security Council e dalla Casa Bianca.
Il periodo compreso tra la fine degli
anni Cinquanta e l’inizio degli anni
Sessanta segnò il lento passaggio verso
il processo della decolonizzazione: le
nuove nazioni furono letteralmente
catapultate in nuove situazioni politiche, senza che le popolazioni indigene
possedessero una consolidata esperienza politica e di governo. L’India era
l’eccezione a questo stato di cose,
tranne che per un aspetto: qui, come
nel resto dei paesi del Terzo Mondo, la
moltitudine di gruppi etnici, tribali e
religiosi in lotta fra loro ostacolava gli
sforzi volti a creare una solida struttura
nazionale, nonché un sentimento nazionale condiviso. A raccogliere il
fardello, che un tempo era stato britannico, furono gli Stati Uniti e la loro
esigenza
primaria:
contenere
l’avanzata comunista. La forte tensione
internazionale degli anni Sessanta,
culminata,
secondo
gli
autori,
nell’incidente dell’U2, viene rispolverata attraverso le fonti per spiegare
come quelle stesse tensioni furono
propedeutiche alla détente della decade
successiva. Focalizzando l’attenzione
generale su quegli anni che coincisero
con la prima metà della carriera politica di Indira Gandhi (1966-1972), gli
autori ricostruiscono, da un lato, quel
lento passaggio che portò gli Stati
Uniti a sconfessare progressivamente e
definitivamente la precedente alleanza
militare con il Pakistan; dall’altro, il
percorso dell’India, orfana felice della
gran Bretagna dal 1947, che scelse di
legarsi con l’“aquila” al di là del Pacifico per ragioni economiche e di sicurezza. La Guerra Fredda, dunque, si
estendeva all’Indocina e al continente
asiatico, come aveva dimostrato la
vicenda della Corea negli anni Cinquanta e come avrebbe dimostrato, poi,
il dramma del Vietnam. Due nazioni
molto diverse, di cui la più giovane,
l’India appunto, non conosceva il linguaggio liberoscambista, ma soltanto il
regime della pianificazione quinquennale e che aveva sposato, a Bandung,
la linea neutralista. Sono soprattutto i
documenti diplomatici, anche quelli
dai toni più informali, a far emergere il
rapporto problematico tra questi due
novizi alleati. A seguire, l’analisi dello
scacchiere internazionale, sul quale si
colloca un corollario di vicende assolutamente non marginali, come i rapporti
con
l’Urss,
il
problema
dell’affermazione (e dell’eventuale
riconoscimento) internazionale della
Cina comunista, la vicenda del Kashmir, nonché il delicato tema del programma nucleare indiano. Eventi che
trascinarono in un vortice senza fine
India, Cina, Pakistan, Unione Sovietica
e Stati Uniti: un intreccio inestricabile
che persiste ancora oggi, a più di
vent’anni dal tramonto della cortina di
ferro.
Francesca Salvatore
273
GLEEN J. AMES, L'età delle scoperte geografiche 1500-1700, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 200.
Il volume di Ames è un’opera che,
attraverso una scorrevole trattazione,
ripercorre le tappe che segnarono la
fondazione e lo sviluppo degli imperi
coloniali di Portogallo e Spagna, oltre
che di Olanda, Inghilterra e Francia, tra
il XVI e il XVII secolo.
L’introduzione presenta una rapida
descrizione dei presupposti sociali,
politici, economici e tecnico-scientifici
alla base delle scoperte geografiche: il
fermento sviluppatosi in Europa nel
XV secolo, animato dalla necessità di
accaparrarsi nuove ricchezze e da propositi di conversione alla fede cristiana, portò gli europei a scoperte e sperimentazioni in campo scientifico (cartografia, mezzi di navigazione, strumentazione), che si rivelarono indispensabili per raggiungere terre e civiltà lontane. Così, quell’Europa che nel
Medioevo aveva in parte dimenticato
la cultura geografica classica e aveva
perso terreno, in materia culturale,
rispetto ad altre civiltà (Islam, Cina),
ora tornava alla ribalta, pretendendo di
conquistare il mondo intero, con un
rinnovato spirito d’avventura e
d’impresa che metteva d’accordo
Chiesa, nobiltà e classe media.
Il Portogallo fu il motore propulsore
di questo fenomeno europeo. Tramite i
progressi tecnologici patrocinati da
Enrico il Navigatore e da diversi re
intraprendenti, grazie a figure di esploratori carismatici come Bartolomeu
Dias e Vasco da Gama, la monarchia
portoghese intraprese campagne di
navigazione che la condussero a creare
dapprima empori sulla costa occidentale dell’Africa e poi a raggiungere le
Indie, la terra promessa delle spezie.
Qui, nella prima metà del '500, dopo
aver combattuto e vinto un’aspra guerra contro gli arabi, i portoghesi diedero
vita ad un impero commerciale
(l’Estado da Ìndia), costituito da fortezze che, dalle coste del Mozambico a
Macao, servivano a proteggere il trasporto delle spezie verso Lisbona.
Contemporaneamente, però, il Portogallo si premurava di fondare un vero e
proprio Stato territoriale in Brasile,
dove l’attività preminente divenne la
coltivazione del tabacco e della canna
da zucchero, per la quale fu impiegata
massicciamente manodopera africana.
Tuttavia, se il vasto e potente Impero
portoghese vide una rapida ascesa nel
corso del Cinquecento, esso fu soggetto ad un profondo declino nella seconda metà del XVII secolo, allorché venne insidiato dalla nascente potenza
olandese.
Per l’impegno della Spagna nella
corsa all’espansione oceanica, il 1492
fu una data cruciale: i regni uniti di
Castiglia ed Aragona, esaltati dalla
recente conquista di Granada, finanziarono la spedizione di Colombo, che
avrebbe
portato
alla
scoperta
dell’America. In circa cinquant’anni da
quella data, la monarchia spagnola,
attraverso le imprese dei conquistadores, riuscì a sottomettere gli imperi
azteco e inca e a fondare veri e propri
Stati territoriali, che si estendevano
dalla Florida al Cile, ma anche ad im-
274
pegnarsi, sebbene in misura minore, in
Asia, dove ottenne l’importante conquista delle Filippine. Nel XVI secolo
la madrepatria organizzò e controllò i
nuovi vicereami americani: in ambito
economico, istituì strutture agricole
sostanzialmente feudali (le encomiendas) e organizzò i lavori di estrazione
dei metalli preziosi; in ambito amministrativo, venne a crearsi una sofisticata
rete di istituzioni politiche e giudiziarie
che mantenevano l’ordine e il controllo; persino in materia religiosa i re
spagnoli ebbero voce in capitolo, coordinando l’operato delle diocesi e delle
missioni nella conversione degli indios, sottomessi e sfruttati dai coloni.
Questo sforzo nell’organizzazione
dell’impero permise ai vicereami americani di non soccombere alle mire
espansionistiche delle altre potenze
europee e di autogestirsi anche quando
la madrepatria si trovava in gravi difficoltà economiche e politiche, come
avvenne per la Spagna del XVII secolo.
Tardivo e differente fu l’approccio
olandese alla formazione di un impero.
Caratterizzata da una vocazione mercantile pragmatica, la neonata repubblica delle Province Unite nella prima
metà del XVII secolo s’insediò in Indonesia e, da lì, scalzò l’ormai debole
Impero portoghese, ambendo al monopolio delle spezie nell’Oceano Indiano.
Ciò le fu possibile grazie a scelte mirate e soprattutto alla fondazione della
Compagnia delle Indie orientali
(VOC), una società per azioni a cui la
repubblica affidava totalmente le operazioni politiche, militari e commercia-
li nell’impero. Intanto, incoraggiati da
questi successi, gli olandesi si insinuarono anche nei possedimenti iberici
dell’Atlantico, colonizzando le coste
del Nord America e cercando di monopolizzare il commercio degli schiavi
dall’Africa occidentale al Brasile; tuttavia, la Compagnia delle Indie occidentali (WIC) non riuscì ad ottenere i
successi della VOC. In realtà, lo strapotere olandese cominciò a declinare
anche in Asia: l’Olanda non disponeva
di risorse adeguate per mantenere un
impero commerciale così vasto e, nella
seconda metà del XVII secolo, dovette
fare i conti con l’emergente espansionismo coloniale di nuovi rivali.
Il 1600 fu il secolo in cui ebbe inizio
il promettente imperialismo britannico,
poi divenuto imbattibile nel '700. Dopo
i primi decenni di attività corsara ed
esplorativa (basti pensare ai nomi di
Drake, Releigh e Caboto), gli inglesi si
adeguarono al sistema olandese delle
compagnie per azioni, con ottimi risultati: nell’Atlantico fondarono importanti colonie nel Nord America e, sfidando la potenza spagnola, raggiunsero
i Caraibi, instaurando un commercio
“triangolare” che faceva circolare il
pesce e il legname del New England, il
tabacco e lo zucchero delle colonie
meridionali, il rum dei Caraibi e gli
schiavi africani. Nell’Oceano Indiano,
invece,
gli
inglesi
opposero
un’accanita concorrenza all’Impero
olandese e a quello portoghese fino al
proprio definitivo insediamento in
India.
La Francia, che fino alla metà del
‘600 si limitò a incerte operazioni di
275
colonizzazione nel Canada, messe
spesso in crisi dalla rivalità degli indiani Irochesi, conobbe un vero imperialismo solo con la politica aggressiva
di Luigi XIV, grazie alla quale nacque
la colonia della Louisiana e i francesi
si guadagnarono un importante spazio
nei Caraibi e nel commercio triangolare atlantico. Meno fortunato fu
l’intervento francese nell’Oceano Indiano, dove l’estenuante guerra commerciale con i Paesi Bassi frustrò le
mire espansionistiche del Re Sole. Ad
ogni modo, gran parte di questo impero
sarebbe
stato
poi
fagocitato
dall’Inghilterra nei conflitti europei del
XVIII secolo.
Alberto Rescio
GREGORY GAUSE III, The International Relations of the Persian Gulf, Cambridge, Cambridge University Press, 2010,
pp. 258.
Il libro è un autorevole resoconto
della politica internazionale della
regione del Golfo dal 1971 al 2008,
che si distingue per completezza
delle chiavi interpretative utilizzate,
nonché prudenza e profondità storica
con cui vengono esaminati anche gli
eventi più recenti.
Gregory Gause parte dall’assunto
per cui il miglior modo per comprendere i rapporti fra gli Stati del Golfo
Persico sia quello di vedere l’area
come un “sistema di sicurezza regio-
nale” che, per quanto appartenente ad
un più ampio sistema mediorientale,
non può essere con quest’ultimo
completamente identificato, pena
l’errore di attribuire un peso eccessivo alla questione arabo-israeliana
nell’analisi della politica regionale.
Definita la struttura di tale sistema – e
posto, lo stesso, in relazione a quello
mondiale – l’autore esamina nel
dettaglio cause ed effetti dei più importanti e complessi sviluppi della
politica internazionale del Golfo degli
ultimi quattro decenni: dal ritiro degli
inglesi dall’area east of Suez, passando per la rivoluzione iraniana, la
Guerra Iran-Iraq del 1980-88 e quella
del Golfo del 1990-91, sino ad arrivare al rovesciamento di Saddam a seguito dell’invasione dell’Iraq guidata
dall’America nel 2003. A dare coerenza alla trattazione è la triplice
prospettiva sottesa all’analisi: identità
transnazionali, petrolio e coinvolgimento americano – sebbene con un
peso
diverso
–
concorrono
nell’interpretazione delle cause delle
guerre e delle rispettive alleanze.
Le classiche interpretazioni realiste
incentrate sulla teoria della balance of
power sono considerate necessarie,
ma non sufficienti per comprendere le
dinamiche della regione. Gause è del
parere, infatti, che «il fattore più importante e distintivo del sistema di
sicurezza del Golfo non è lo squilibrio
di potere, ma la rilevanza delle identità transnazionali» (p. 9) araba, curda,
musulmana, sunnita, sciita, tribale.
L’esistenza di identità e idee politiche
transnazionali aumenta tanto le possi-
276
bilità che ambiziosi leaders cerchino
di sfruttare le stesse per espandere la
propria influenza, tanto il senso di
insicurezza dei regimi che costituiscono, di volta in volta, il bersaglio
dei primi. L’autore mette in luce,
perciò, come la decisione di Saddam
di scatenare le due guerre del 1980 e
1990 fu fortemente influenzata dalla
percezione che potenze regionali ed
internazionali stessero sfruttando il
pluralismo della società irachena per
indebolire il suo potere interno. Seguendo questo ragionamento, la decisione dei regimi sunniti in Arabia
Saudita e nei piccoli Stati del Golfo di
sostenere Saddam contro l’Iran negli
anni ’80 viene spiegata alla luce della
minaccia costituita dal carattere rivoluzionario del nuovo regime sciita a
Teheran. Similmente, dopo il 2003,
gli Stati Uniti ritennero l’Iran una
minaccia alla stabilità dell’Iraq per via
della capacità iraniana di influenzare
la politica irachena attraverso i suoi
legami con i gruppi sciiti – e non – nel
paese.
«Il
riconoscimento
dell’importanza delle idee non nega le
intuizioni dei Realisti rispetto
all’anarchia, il potere e il conflitto
nelle questioni del Golfo Persico;
[piuttosto] contestualizza tali intuizioni, permettendo una comprensione più
profonda di come i capi di Stato definiscano i loro interessi e valutino le
risorse a loro disposizione» (p. 243).
Sulla base di un giudizio parimenti
equilibrato, l’autore valuta il peso del
petrolio come fattore di conflittualità
nella regione. Sebbene sostenga che la
decisione di Washington di scatenare
una guerra contro Baghdad non sia da
ricondurre primariamente alla volontà
di assicurarsi le risorse petrolifere del
paese, riconosce che, se non fosse
esistita una tale risorsa strategica, probabilmente non ci sarebbe stata
un’invasione americana dell’Iraq, né
uno sforzo militare americano per impedire l’annessione irachena del Kuwait agli inizi degli anni ’90. D’altro
canto, se il petrolio aumenta le occasioni di guerra fra gli attori regionali –
sia nella misura in cui fornisce i mezzi
per acquistare armi e finanziare eserciti, sia perché rende più desiderabile un
territorio che ne sia ricco –, non può
spiegare perché determinati conflitti
scoppino in precisi momenti della storia. Ritornando, quindi, al caso delle
guerre Iran-Iraq e del Golfo, Gause,
pur ritenendo che la chiave di lettura
primaria per comprendere il comportamento di Saddam sia quella delle
identità transnazionali, non nega che
l’ambizione di controllare ulteriori
risorse petrolifere costituisca parte
della spiegazione.
Per quanto riguarda, infine, la questione del crescente coinvolgimento
militare americano nel Golfo, particolarmente interessante è l’accento posto
da Gause sulla discontinuità della politica americana nella regione, prima e
dopo l’11 settembre; una discontinuità
resa manifesta dalla decisione americana di invadere l’Iraq e rimuovere dal
potere Saddam. Rimodellare gli equilibri regionali e favorire la diffusione
della democrazia divennero i nuovi
imperativi dell’amministrazione Bush,
dopo che per decenni gli obiettivi ame-
277
ricani si erano limitati a preservare lo
status quo e assicurare l’accesso americano al petrolio della regione, oltre
che circoscrivere l’influenza sovietica
durante la Guerra Fredda. In una lunga
disamina del processo attraverso cui si
giunge alla decisione americana di
dichiarare guerra, l’autore non manca
di sottolineare le forzature e gli errori
di
valutazione
commessi
dall’amministrazione Bush rispetto alla
minaccia posta dall’Iraq in termini di
armi di distruzione di massa, ai legami
del regime iracheno con al-Qaeda e,
soprattutto, alle previsioni ottimistiche
riguardanti i costi e le difficoltà di
stabilizzare il paese dopo il rovesciamento del dittatore.
Patrizia Carratta
ROBERT P. GEORGE, Il diritto
naturale nell’età del pluralismo,
Torino, Lindau, 2011, pp. 274.
Contrariamente a quello che spesso si
tende a pensare, l’appello al diritto
naturale non esprime un pensiero principalmente religioso, ed è anzi oggi
avvertito da più parti come una delle
forme di rinnovamento dello stesso
pensiero giuspositivista, come dimostrano i recenti dibattiti sulla riapertura
del nesso diritto-morale, sul neocostituzionalismo, sulla questione dei principi, o ancora sull’universalità dei
diritti umani. Giusnaturalismo e positivismo giuridico sono due modi diversi
di considerare il fenomeno giuridico,
che non si escludono a vicenda, anzi
sono necessariamente complementari.
La problematica della legge naturale,
proveniente dal pensiero greco e potenziata dall'influsso cristiano, fiorisce
e si sviluppa lungo un arco di tempo
che va dal Medioevo all'Età moderna,
ma ha perduto per la cultura europea
buona parte della sua capacità d'incidere nei dibattiti pubblici, giuridici e
politici, restando al più confinata
nell'ambito ecclesiale ed ecclesiastico,
nonché nei dotti studi di storia delle
idee.
Il paradosso è quello di vivere in un
contesto culturale che, pur avendo
“inventato” la teoria del diritto naturale
– per difendere l’individuo dall’ordine
impositivo del potere politico o delle
maggioranze –, ormai da moltissimi
anni l’ha ripudiata come qualcosa di
sconveniente, «quasi come si tace d’un
onta», verrebbe da dire con i versi di
Rilke. Tutto ciò è accaduto nonostante
l’abbandono della credenza nel diritto
naturale, di un diritto superiore al diritto positivo, sia innegabilmente stata
una delle cause dell’avvento degli Stati
totalitari.
La vecchia Europa divora i suoi figli.
A meno che essi non riescano ad emigrare nel Nuovo Mondo. Negli Stati
Uniti, infatti, il diritto naturale si presenta vivo e battagliero, in dialogo con
le concezioni contemporanee della vita
pratica. Nel campo della ragion pratica, infatti, non ci si può accontentare
dello sviluppo teorico delle dottrine,
ma queste devono dimostrare di essere
capaci di una presenza attiva nella vita
sociale attraverso le loro applicazioni e
la loro partecipazione ai dibattiti etici e
278
politici. Conseguentemente, il diritto
naturale è tutt’altro che estraneo al
diritto costituzionale e al costituzionalismo statunitense.
Prova di tutto ciò si ha nel recentissimo volume, curato da A. Simoncini e
con un saggio introduttivo di F. Viola,
che raccoglie le lezioni magistrali tenute nel 2007 dal prof. Robert P. George
all’Università di Macerata. George –
McCormick Professor of Jurisprudence all'Università di Princeton, dove
insegna anche “Constitutional Intepretation”, “Civil Liberties” e “Philosophy
of Law” e dirige il James Madison
Program in American Ideals and Institutions, istituto che si dedica allo studio di problematiche relative al diritto
costituzionale americano e al pensiero
politico occidentale – da anni è membro del Consiglio di Bioetica della
Presidenza degli Stati Uniti d’America
e uno degli accademici più noti e stimati d’America. È fedele seguace e
strenuo difensore della concezione
tomista
della
legge
naturale
nell’interpretazione sviluppata da un
gruppo di studiosi, in cima ai quali
svetta John Finnis, professore di Filosofia del Diritto nelle Università di
Oxford e di Notre Dame, a cui dobbiamo, tra l'altro, la migliore trattazione del diritto naturale scritta negli ultimi quattro decenni. Questa concezione – tra i cui rappresentanti si annoverano anche German Grisez, Joseph
Boyle, Patrick Lee, Christopher Tollefsen e Gerard Bradley – si è autodefinita come “nuova teoria della legge naturale” o anche come “teoria neoclassica
della legge naturale”, per prendere le
distanze da quella neoscolastica. Essa
è, di fatto, l’unica forma di giusnaturalismo, presa oggi molto sul serio anche
dai giuspositivisti non ideologici, che è
riuscita a conquistare un ruolo significativo nel dibattito contemporaneo
riguardante i rapporti tra etica, politica
e diritto e che è riconosciuta come
rilevante dai teorici del diritto, oltre
che dai filosofi.
Le lezioni del prof. George presentano
le idee centrali di tale teoria. Esse cercano di dimostrare la falsità di molti
pregiudizi diffusi nel giuspositivismo
contemporaneo a proposito della concezione del diritto di Tommaso
d’Aquino e, invece, la fecondità della
dottrina della legge naturale nella sua
applicazione a problematiche attuali
come quelle concernenti la bioetica, il
costituzionalismo, il ruolo della religione nella sfera pubblica e la filosofia
del diritto internazionale.
Nella prima (ma anche nella seconda
e nella settima) lezione, è racchiusa
una descrizione della teoria della
“nuova teoria della legge naturale” o
“teoria neoclassica della legge naturale”. Essa si definisce tale in quanto
assegna un ruolo assolutamente centrale alla ragione e alla ragionevolezza
nella sua concezione della legge naturale con il conseguente rigetto di ogni
volontarismo e di ogni naturalismo. In
ciò ardisce di rispecchiare con fedeltà
il pensiero di Tommaso, che ha ripetutamente sostenuto come contrario al
bene umano ciò che è contrario all'ordine della ragione. Conseguentemente,
rifiuta tutti i tentativi di confinare la
legge naturale nell'ordine della Rivela-
279
zione. Se così fosse, del resto, la legge
naturale varrebbe solo per i credenti e
sarebbe tagliata fuori del dibattito pubblico.
La questione è allora – e sembra di
rileggere il magistero del pontefice
Benedetto XVI – quella di recuperare o
mettere a punto una concezione adeguata della ragione e della ragionevolezza umana. La razionalità della legge
naturale, infatti, incrocia le istanze
dell’etica, della politica e del diritto del
nostro tempo, che, allontanandosi
dall’emotivismo e dallo scetticismo,
manifestano un desiderio – poi mal
realizzato – di interrogarsi con rinnovato vigore sul ruolo della ragione
nelle cose umane. Del resto, pluralismo
e multiculturalismo che connotano la
post-modernità conducono all’incomprensione, all’incomunicabilità ed alla
“dittatura del relativismo” non cognitivista, se non affrontati con fiducia
nella ragione rettamente intesa e adoperata. Ma in cos’altro consiste ogni
ricerca di “ragionevolezza” se non in
una ricerca del diritto naturale?
Nella “nuova teoria della legge naturale” questa capacità di dialogo con le
etiche contemporanee è rafforzata dalla
precisazione che la legge naturale non
è, in modo neoscolastico, un insieme di
norme già compiute aventi valore oggettivo e validità metastorica; non è un
oggetto posto di fronte alla ragione, al
modo di qualcosa da apprendere e da
subire, come suggerirebbe il riferimento alla “natura”. I precetti basilari del
diritto naturale non sono dedotti da
precedenti giudizi sulla natura: è attraverso le acquisizioni della ragion prati-
ca, ancor prima che della conoscenza
speculativa, che l’uomo formula proposizioni circa la natura umana e apprende i fini che devono guidare il suo
agire e quale sia l’azione più adeguata
per il loro conseguimento. Nel raccordo tra il guidare le azioni e il fine del
bene comune si evidenzia il rapporto
tra legge morale e legge umana positiva.
Nella terza lezione dal titolo ampiamente significativo, Kelsen e il Diritto
Naturale,
George
si
impegna
nell’obiettivo accennato di demistificare false ed erronee immagini del giusnaturalismo tomista, radicate nel pensiero giuridico contemporaneo. Egli
analizza con dovizia di particolari gli
equivoci presenti nel pensiero kelseniano a proposito della legge naturale e
confuta punto per punto – in
un’atmosfera da duello cavalleresco –
alcune affermazioni fatte da Kelsen nel
famoso The Natural-Law Doctrine
before the Tribunal of Science.
Centrale è la dimostrazione, da parte
di George, di come quasi nessuno, in
verità, tra i giusnaturalisti, e men che
mai Tommaso d’Aquino, abbia pensato
al diritto naturale come a un ordine
giuridico preesistente e neppure come
un ordine morale già compiuto. Se,
infatti, la legge positiva è obbligatoria
per la coscienza dei consociati, essa
viene in contatto con i valori morali di
cui la legge naturale è espressione. A
tanto consegue che la stessa definizione del diritto positivo non può prescindere dalla relazione tra i contenuti di
quest’ultimo e i valori fondamentali,
che si esprimono non nella forma di
280
precetti già formati al modo della legge
positiva, ma come orientamenti per
l’agire, che aspirano a coagularsi in
norme morali e giuridiche. Insomma,
siamo ben lontani da quella immagine
semplicistica della mera derivazione
logica deduttiva dei contenuti della
legge positiva dalla legge naturale,
costruiti, sulla scia del sistema statico
di norme disegnato da Kelsen, dai
seguaci del giuspositivismo per rafforzare le proprie convinzioni.
Il terzo obiettivo della nuova teoria
della legge naturale riguarda la sua
fecondità ermeneutica nei confronti dei
fenomeni principali del diritto e del
costituzionalismo
contemporaneo.
Nella quarta lezione, quindi, George
affronta il tema dello statuto giuridico
dell’embrione umano, nella quinta la
questione dell’ordine internazionale e,
nella sesta, quella della ragione pubblica con particolare riferimento al ruolo
pubblico della religione nel pensiero di
Rawls e Habermas. Tali approfondimenti tematici confermano come George e la nuova teoria del diritto naturale abbiano il merito di portare le loro
prospettive e i loro argomenti nel dibattito pubblico, senza complessi di
inferiorità nei confronti delle più diffuse teorie del liberalismo contemporaneo. Queste ultime, infatti, non riescono a risolvere mai definitivamente il
conflitto tra ragioni giustificative, né
quello derivante dalla ritenuta pretesa
inconoscibilità oggettiva di valori (che
pone tutte le concezioni sullo stesso
piano, senza alcuna possibilità di differenziazione) e, in applicazione di un
preteso principio di neutralità, elimina-
no dalla vita sociale e politica
l’esercizio della ragione, confinando
nel privato e nella mera preferenza
istanze avanzate in nome della giustizia e della dignità umana.
È indubbio: i risultati dell’applicazione della nuova teoria del diritto
naturale sono coincidenti con la dottrina e la morale cattolica. Ma questa
complessa articolazione poggia su
presupposti assolutamente laici, mette
alla prova il metodo della ragionevolezza pratica e può essere difesa con
mezzi esclusivamente razionali. Di più,
richiede una sorta di contesto dialogico
aperto: la legge naturale non è un codice prefissato di precetti scritti nei cieli,
ma una sfida alla ragione umana nel
tempo e nella storia. In ogni caso, la
teoria neoclassica non può essere accusata di fideismo.
Proprio per tali ragioni, essa lascia
prevedere di poter svolgere un ruolo
decisivo sui tanti fronti che si aprono al
giusnaturalismo evidenziando – a tutti
coloro che non si rifiutano di vederle –
le falle del giuspositivismo. Si pensi
all’ampio campo dei diritti umani,
all’evoluzione del costituzionalismo
contemporaneo, alla crisi della visione
statocentrica del diritto, al ritorno di
attenzione sul caso giuridico concreto
come guida interpretativa delle norme,
alla circolazione degli argomenti giuridici (e non) tra le corti supreme di
giustizia, al ridimensionamento del
principio di autorità. Altri aspetti potrebbero aggiungersi, ma questi sono
sufficienti a mostrare che il castello
giuspositivista è andato in frantumi e i
tentativi continui di ristrutturazione
281
sono spesso vani e deboli sul piano
teorico, segno di un giuspositivismo
abbarbicato ai dogmi della rigida separazione tra diritto e morale e del rifiuto
di qualsiasi forma di oggettivismo
morale, dunque non di rado divenuto,
esso sì, niente più che un atto di fede.
Francesco Cavallo
GUSTAVO GOZZI, Diritti e civiltà.
Storia e filosofia del diritto internazionale, Bologna, Il Mulino,
2010, pp. 400.
Il volume di Gustavo Gozzi non vuole
essere unicamente una ricostruzione
storica dell’evoluzione del diritto internazionale; non la semplice enunciazione di teorie che si susseguono durante i secoli, dalla nascita degli Stati
nazionali sino al consolidamento delle
democrazie occidentali e del loro rapporto con le altre culture. Esso è
un’attenta ricerca storico-filosofica su
come si è sviluppata la dottrina giuridica occidentale e sulla sua pretesa di
universalità all’interno del sistema
giuridico internazionale. Gozzi riprende con attenzione l’excursus storico dei
diritti umani proposto da Gerhard Oestreich nel suo Storia dei diritti umani
e delle libertà fondamentali, cogliendo
la necessità di svolgere una ricostruzione della storia delle dottrine politiche e giuridiche per meglio comprendere il ruolo odierno del diritto internazionale. Per Gozzi, è fondamentale
che si riescano a evidenziare nel modo
più chiaro possibile le varie interpretazioni dei diritti, in quanto, solo così
facendo, è possibile conservare intatte
le basi etiche e politiche dei diritti
dell’individuo.
Il diritto internazionale, per Gozzi, è
stato frutto di una disparità di visione
tra l’ordinamento occidentale e le altre
dottrine globali; pertanto, nel suo volume, cerca di osservare il diritto internazionale con gli occhi di chi non è
figlio della nostra cultura e di offrire al
lettore la possibilità di andare a ritroso
sino ad evidenziarne i problemi che
vigono a monte. La sua tesi è sempre
correlata allo studio delle più significative dottrine della tradizione filosofica
occidentale,
offrendo,
quindi,
un’ottima interdisciplinarietà nello
sviluppo della ricerca. L’autore, in
questo suo volgersi al passato, comincia la sua analisi dagli scritti di Francisco da Vitoria e dalla Seconda Scolastica, ponendo in evidenza come, dal
XVI secolo, fu riscoperto il diritto
naturale attraverso la consapevolezza
di dover riprendere le virtù etiche dello
stoicismo greco. De Vitoria è solo il
precursore di un ritorno allo stoicismo,
poiché il suo pensiero è posto al centro
tra la prospettiva giusnaturalistica, che
reinterpreta lo ius gentium, e la sua
visione cattolica. De Vitoria accetta la
concezione che ogni popolo possieda
dei diritti inviolabili, ma, dall’altra
parte, non disconosce il diritto cristiano di imporre con la forza la nuova
religione e la propria cultura alle popolazioni indigene del nuovo continente.
Il passaggio ad una piena consapevolezza
dello
stoicismo
avviene,
282
nell’evoluzione storica proposta, attraverso lo studio degli scritti di Grozio.
In una fase in cui le guerre di religione
imperversavano
in
Europa,
l’affermazione, dapprima nei Paesi
Bassi e, successivamente, in altre zone
del centro-nord Europa, dei principi
laici, fondati unicamente sui basi etiche, posero le fondamenta per il consolidamento degli Stati moderni, privi di
qualsivoglia influenza religiosa. Per
l’autore, Grozio fu il primo che mise in
evidenza il processo di colonialismo
egemonico portato avanti dalla cultura
occidentale, prettamente cattolica, nei
confronti di popolazioni considerate
all’epoca come barbare.
In questa prima parte del volume,
Gozzi è abile nell’inquadrare quelli che
sono stati i precursori di una visione
globale del diritto internazionale, inserendo il pensiero di Pufendorf e Kant
all’interno del loro contesto storico.
Pufendorf, in particolare, non viene
studiato soltanto come il filosofo che
pone al centro lo Stato assoluto, ma
soprattutto come il pensatore che guarda al rapporto tra Stati sovrani e ai loro
doveri in una prospettiva di interesse
globale. Il diritto di conservare i propri
costumi e tradizioni ha fondamenta
giusnaturalistiche, come quello di ospitalità, che pone il filosofo tedesco alla
stregua di Kant. Pufendorf difende,
dunque, i diritti dei popoli contro le
pretese degli Stati occidentali, e ciò
avvalora la tesi proposta da Gozzi.
Anche Kant è analizzato nel volume
come il filosofo della pace ed è molto
interessante il capitolo nel quale si
attualizza lo scritto Per la pace perpe-
tua attraverso la visione di Jurgen Habermas. Il filosofo di Könisberg aveva,
infatti, secondo Habermas, posto le
condizioni ideali per la creazione di un
ordine politico-giuridico sovrastatale.
Gozzi vuole offrire una visione del
diritto internazionale come prettamente
europea e la sua nascita trae radici
proprio tra i secoli XVI e XVIII.
Il legame che vige tra diritto internazionale e la cultura occidentale emerge
nella seconda parte del volume, quando si analizza il secolo XIX e il processo di positivizzazione dei principi
emersi nei secoli precedenti. Il diritto
positivo occidentale è studiato nella
sua evoluzione, partendo dal contesto
nel quale si diffonde, prima come uno
dei sistemi giuridici internazionali e,
successivamente, come sistema universalistico, frutto della cultura occidentale dominante. La tesi di un’evidente
egemonia del diritto internazionale
europeo e del suo processo di universalizzazione è portata avanti dall’autore
in modo fluido, toccando sia gli aspetti
più propriamente storici, sia quelli
filosofici. Degno di attenzione lo spazio dedicato allo studio del concetto di
“nazion civile”, che compare proprio
nell’Ottocento, e al conseguente concetto di “civiltà”, inteso come confronto tra il mondo occidentale e le altre
zone del globo. Gozzi offre un quadro
completo del cosmopolitismo attraverso lo studio del pensiero di Kelsen,
Wolff ed Hegel, affrontando il problema della crisi della sovranità degli
Stati nazionali nel lasso di tempo a
cavallo tra Otto e Novecento. L’autore
ha il merito di mantenere alto
283
l’interesse sulla costruzione dello ius
gentium, quel diritto dei popoli che,
nella sua visione, deriva dal diritto di
natura e garantisce dei principi fondamentali per il riconoscimento di un
diritto internazionale che esula dalla
volontà degli Stati nazione.
Merita, poi, particolare attenzione la
parte terza del libro, nella quale Gozzi
attualizza i problemi di un mancato
riconoscimento del diritto internazionale vigente. L’autore introduce
l’argomento attraverso il pensiero di
John Rawls nel suo scritto Diritto dei
popoli, per mettere a raffronto la visione idealistica del filosofo, che auspicava una “pace democratica”, e la cruda
realtà, che, invece, caratterizza i rapporti interculturali esistenti. Al centro
della sua analisi è posto, infatti, il rapporto tra Occidente e Mondo Islamico
e tra Occidente e Terzo Mondo, con
particolare attenzione allo studio dei
diritti dell’uomo a seguito del secondo
conflitto mondiale. La Dichiarazione
Universale dei diritti dell’uomo è, per
Gozzi, il momento culminante e fondamentale, in cui emerge la frattura tra
cultura occidentale e Islam, soprattutto
in tema di matrimonio e ruolo della
donna.
L’autore, presentando con dovizia di
particolari l’evoluzione storica di tale
diatriba, non propone alla questione
una facile soluzione, nella quale
l’Occidente sia sempre dalla parte della
ragione e in cui l’Islam venga etichettato come arretrato e invitato ad adeguarsi ai principi occidentali, ma mette
in luce, soprattutto, quelli che sono i
punti di vista islamici su tali delicate
problematiche e su come l’Occidente
abbia cercato di imporre la propria
visione delle cose. Di notevole interesse è, inoltre, lo studio analitico sul
termine “democrazia” nella cultura
islamica, che pone in evidenza quelle
limitazioni che, recentemente, hanno
spinto diverse popolazioni di Stati
arabi a ribellarsi al potere costituito.
Gozzi, nel tentativo di trovare dei punti
d’incontro, offre una possibile luce alla
fine del tunnel dove ancora arrancano
le due culture contrastanti: ritrovare
unità attraverso il Mediterraneo; ciò
può costituire la chiave per trovare una
visione comune in tema di diritto internazionale, in quanto il bacino è stato
da sempre il punto d’incontro di diverse civiltà, un incontro fatto soprattutto
di storia e di cultura, che ha accomunato e che potrebbe riaccomunare questi
popoli. Per l’autore, la Dichiarazione
di Barcellona del 1995 ha fatto emergere con evidenza quelli che dovrebbero essere i principi fondamentali per la
messa in atto di un diritto internazionale, riconosciuto da entrambi i contraenti, anche se, a distanza di tempo, i risultati non sono ancora quelli sperati.
Un altro tema centrale del volume è il
rapporto tra Occidente e Terzo Mondo,
analizzato attraverso lo studio del postcolonialismo e del neo-colonialismo
come momenti di imposizione della
cultura occidentale in tema di diritti.
Nello studio dell’attuale diritto internazionale, è fondamentale dare voce a
tesi che vedono, in tale diritto, un mezzo per favorire l’egemonia occidentale.
Dopo aver affrontato le problematiche che dividono le culture mondiali,
284
Gozzi ritorna ad occuparsi delle origini
dei diritti umani. In tale contesto, emerge chiaramente la sua visione giusnaturalistica e la necessità di garantire
all’essere umano i diritti di natura. Il
rapporto forte che vige tra diritti umani
e dignità umana è messo in evidenza
per offrire al lettore una proposta interculturale dei diritti. Per l’autore, è
fondamentale che, nella creazione di
un diritto internazionale, accettato da
tutti, valgano dei principi giusnaturalistici fondati sulla ius gentium, ed egli
stesso si interroga se tali principi siano
utopistici, rispetto alle leggi basate sul
rapporto di forza tra gli Stati. La governance globale va combattuta attraverso una “costituzionalizzazione del
diritto internazionale”. Solo un’utopia
o una reale possibilità?
Pierandrea Casto
SAVERIO DE BELLIS, a cura di,
Studi su diritti umani, Bari, Cacucci Editore, 2010, pp. 287.
Il tema della protezione internazionale
dei diritti umani non cessa di rivestire
un ruolo cruciale nell’agenda degli
Stati. Le costanti violazioni che, nonostante gli sforzi profusi, continuano a
verificarsi in diverse parti del globo
impongono
di
mantenere
alta
l’attenzione e di continuare a impegnarsi affinché il rispetto dei diritti
umani diventi sempre più un valore
diffuso e condiviso, nonché minimo
comune denominatore di ogni società
umana.
Con il volume collettaneo Studi su
diritti umani, curato da Saverio de
Bellis, gli autori – un gruppo di studiosi dell’Università del Salento – hanno
cercato di fornire approfondimenti su
alcune particolari categorie di diritti
umani fondamentali e sul ruolo che gli
Stati e le Nazioni Unite rivestono in
merito alla loro protezione e attuazione
a livello statale e sovranazionale.
Spunto per la pubblicazione di tale
interessante iniziativa editoriale è stato
il ricorrere del sessantesimo anniversario dell’adozione della Dichiarazione
universale sui diritti dell’uomo (10
dicembre 1948).
In Diritto alla vita e pena di morte in
Italia tra Costituzione e obblighi internazionali, Saverio de Bellis ha dapprima ripercorso le tappe che hanno
condotto alla definitiva abolizione
della pena di morte nel nostro paese,
avvenuta con legge costituzionale 2
ottobre 2007, n. 1, ed ha poi affrontato
la questione di una conseguente configurabilità di un vero e proprio “diritto
alla vita” di derivazione costituzionale,
giungendo ad escluderla. Il problema
su cui lo scritto si focalizza è poi quello dell’analisi del contenuto di questo
preteso “diritto alla vita” – mera esistenza biologica o raggiungimento e
mantenimento di un livello ottimale di
diritti e situazioni soggettive? – e delle
diverse circostanze in cui esso viene a
vario titolo invocato: la pretesa del
nascituro di nascere e di conservare
tale esistenza e la pretesa di rinuncia
alla vita (right to die). Cruciale è la
spinosa questione del cosiddetto “te-
285
stamento biologico”, che l’autore compiutamente analizza sia con riguardo
alla disciplina internazionale che lo
legittima di principio, sia dal punto di
vista del dibattito e degli iter normativi
in atto nel nostro paese. La conclusione
cui giunge l’autore è quella di rilevare
la “debolezza” della tutela accordata al
diritto alla vita nelle sue varie sfaccettature, pur non escludendo possibili
novità normative, almeno a livello
nazionale.
Il diritto alla vita e il problema
dell’eutanasia sono poi affrontati in
maniera specifica nel contributo di
Andrea Starace, intitolato La tutela del
diritto alla vita e della dignità umana
negli atti internazionali. Riflessioni per
una disciplina dell’eutanasia. In esso
l’autore, dapprima analizza ampiamente le disposizioni internazionali, sia
universali che a carattere regionale, in
materia di diritto alla vita e rispetto
della dignità umana, e poi si sofferma
sul rapporto tra questo diritto e la pratica dell’eutanasia, avendo come punto
di riferimento l’importante sentenza
della Corte europea dei diritti
dell’uomo del 29 aprile 2002, resa nel
caso Pretty, nella quale la Corte ha
escluso che gli artt. 2 e 3 della Convenzione (che tutelano rispettivamente
il diritto alla vita e il divieto di tortura)
possano essere invocati anche per tutelare un profilo negativo del diritto alla
vita, ossia il diritto di morire. L’autore
rileva poi come la Corte giunga ad
affermare «l’assoluta imprescindibilità
del principio della santità della vita, il
quale raccomanda che la legge si adoperi per la protezione dei soggetti più
deboli e più vulnerabili, quali sono
[…] i malati terminali» (p. 279). Nelle
conclusioni dello scritto viene, infine,
evidenziata, anche alla luce della sentenza esaminata, la necessità di individuare puntualmente il confine tra la
vita e la morte, tra ciò che debba intendersi “trattamento medico doveroso” e
quello che è invece definibile “accanimento terapeutico”. Tale intervento,
però,
dovrà
tenere
conto
dell’emergente
(e,
ad
avviso
dell’autore, allarmante) tendenza ad
invocare il diritto di ognuno di vivere
la propria esistenza dignitosamente.
In questa collettanea trovano spazio
anche scritti relativi all’importante
processo di specificazione dei diritti
umani, sia ratione personae, che ratione materiae.
Un esempio di specificazione che ha
riguardato i destinatari della tutela è
quello dei diritti oggi riconosciuti ai
fanciulli rilevato dall’interessante saggio di Giuseppe Gioffredi, intitolato Il
ruolo della Dichiarazione universale
nella protezione dell’infanzia: traguardo o premessa della tutela dei
diritti del fanciullo? Dopo aver esaminato approfonditamente le linee di
tendenza dell’evoluzione dei diritti
umani, l’autore si sofferma sul tema
della tutela internazionale dei diritti
dell’infanzia, in generale, e sull’analisi
della Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, in particolare. Cuore della
normativa internazionale in materia è il
riconoscimento del principio del “superiore interesse del fanciullo”: esso
costituisce oggi la ratio e il fondamen-
286
to di molte leggi relative ai minori. Il
testo presenta anche una descrizione
del meccanismo di controllo istituito
dalla Convenzione e uno studio
sull’interazione tra sistema convenzionale e ordinamento giuridico italiano.
Nelle sue conclusioni, l’autore evidenzia come, sebbene in Italia il livello di
protezione dell’infanzia sia elevato e in
linea con gli standard internazionali,
ciò nonostante sono invece ancora
troppe le violazioni dei diritti dei minori a livello mondiale. I maggiori
problemi messi in luce, cui è necessario trovare risposte celeri, efficaci e
concrete, sono lo sfruttamento dei
minori nei conflitti armati e lo sfruttamento del lavoro minorile. Nonostante
gli sforzi profusi dalla Comunità internazionale, viene infine rilevato come
ancora oggi si debba purtroppo parlare
di infanzia “troppo ferita”.
Nel solco dell’analisi del processo di
specificazione ratione personae dei
diritti umani si pone anche lo scritto di
Martina Cutazzo, dal titolo I diritti
umani delle donne. L’autrice mette in
evidenza come, prima di giungere
all’attuazione di politiche a tutela delle
donne a livello internazionale, si sia
prima dovuta diffondere e affermare
una vera e propria “prospettiva di genere”: è stato, dunque, necessario un
cambiamento culturale, prima che
giuridico, cambiamento che deve ancora giungere ad effettivo compimento,
in quanto le donne non sono ancora
percepite ovunque come “l’altro ‘io’
nella comune umanità”. I maggiori
sforzi in materia di protezione delle
donne si sono avuti con gli interventi
delle
Nazioni
Unite,
volti
all’eliminazione delle discriminazioni
fondate sul sesso. L’autrice ha, infine,
messo in risalto un delicatissimo problema connesso alla protezione del
genere femminile, ovvero quello della
lotta alle mutilazioni genitali, barbara
pratica che ha come vittime principali
giovanissime donne, se non addirittura
bambine. Esse, in quanto pratica propria solo di alcuni contesti socioculturali,
sono
rappresentative
dell’odierna estrema difficoltà di considerare i diritti delle donne come universali e rappresentano un motivo in
più per continuare la lotta per
l’affermazione della piena eguaglianza
giuridica e morale tra i due sessi.
Il diritto all’alimentazione, della
stessa autrice, esprime, invece, il processo di specificazione ratione materiae della tutela internazionale dei
diritti umani. Tale diritto umano fondamentale è stato espressamente riconosciuto nell’art. 11 del Patto delle
Nazioni Unite sui diritti economici,
sociali e culturali del 1966. Ad essere
destinatari di questa e altre norme in
materia di diritto al cibo sono principalmente gli Stati, che devono rispettare, proteggere e attuare tale diritto. Un
paragrafo dello scritto è poi dedicato
allo specifico aspetto del diritto
all’alimentazione delle donne e dei
bambini, soggetti, questi, che risultano
essere quelli maggiormente colpiti
dalla fame e dalla malnutrizione nel
mondo e che per questo motivo subiscono «la cristallizzazione di uno status che li porterà ad essere ai margini
della società per il resto della vita» (p.
287
84). Nonostante gli sforzi per combattere la fame nel mondo, profusi soprattutto da organizzazioni internazionali e
non governative, la freedom from hunger, rileva infine l’autrice, rimane ad
oggi purtroppo ancora lontana.
Maria Antonietta Brucoli affronta,
invece, il tema, quanto mai attuale, del
diritto d’asilo. Il suo scritto Prospettive
di tutela del diritto di asilo offre una
panoramica completa del tema sia dal
punto di vista interno, che internazionale; non manca, poi, una parte dedicata al diritto dell’Unione europea. Il
‘caso Italia’ è affrontato per la rilevanza che hanno nel nostro paese le vicende – spesso tragiche – legate al fenomeno migratorio. L’autrice mette immediatamente in rilievo la difficoltà
oggi esistente di distinguere tra i semplici migranti e i richiedenti asilo:
sebbene il motivo principale che spesso spinge a lasciare il proprio paese sia
spesso di natura economica, i continui
conflitti in atto in molte parti del mondo e, per quanto ci riguarda da vicino,
dell’Africa, spingono parte delle popolazioni colpite da queste tragedie a
emigrare per motivi umanitari. Sul
divieto di refoulement, lo strumento
internazionale rilevante è individuato
nella Convenzione relativa allo status
dei rifugiati del 28 luglio 1951. Importante è anche la giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo sul
divieto di respingimento nei casi in cui,
nel paese d’origine, l’immigrato rischi
di subire atti di tortura o trattamenti
inumani e degradanti. Quanto al diritto
dell’Unione europea, l’autrice mette in
risalto come la politica comune nel
settore dell’asilo costituisca uno degli
elementi fondamentali per la compiuta
realizzazione dello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia.
Il problema delle sparizioni forzate
in ambito internazionale è il tema affrontato da Francesca Pulimeno, la
quale analizza la sparizione forzata di
individui, fenomeno che in passato era
«circoscritto
alla
realtà
latinoamericana degli anni Settanta» ma che
è oggi «legata soprattutto al problema
della lotta al terrorismo internazionale
(trattasi dell’ormai noto fenomeno
delle extraordinary renditions –
n.d.a.)» (p. 97). Il lungo percorso iniziato in seno alle Nazioni Unite per
contrastare il fenomeno in oggetto si è
concluso con l’adozione, il 20 dicembre 2007, della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le
persone dalle sparizioni forzate. Una
norma cruciale di questo testo è quella
che impone agli Stati contraenti di
riconoscere e garantire nel proprio
ordinamento il diritto alla riparazione
per le vittime e di impegnarsi affinché
si conducano azioni volte alla ricerca
degli scomparsi. Una parte dello scritto
è dedicata alla ricostruzione delle norme internazionali che permettono di
imputare allo Stato l’illecito di sparizione forzata: l’autrice fa riferimento al
Progetto di articoli sulla responsabilità
degli Stati, approvato dalla Commissione di diritto internazionale nel 2001.
Sono, inoltre, evidenziati quelli che
devono essere gli obblighi positivi
incombenti in capo agli Stati in materia
di sparizioni forzate, ovvero l’obbligo
di prevenire siffatte violazioni e quelle
288
di predisporre misure effettive e adeguate procedure investigative, ogni
volta che vengono denunciati casi di
scomparsa forzata. Da ultimo, vengono
posti in rilievo l’obbligo di punire gli
autori delle violazioni, siano essi privati o organi statali, e il già richiamato
obbligo di riparazione per le vittime o i
loro familiari per la violazione subita.
In Responsabilità sociale delle imprese multinazionali e diritto internazionale, Giuseppe Gioffredi offre una
puntuale panoramica su una questione
che nel mondo globalizzato riveste
sempre maggiore importanza: il problema del ruolo e della responsabilità
delle multinazionali rispetto a possibili
violazioni di diritti umani fondamentali. Dopo aver spiegato che cosa giuridicamente debba intendersi per “impresa multinazionale”, l’autore individua un nesso tra il potere economico
che queste esercitano nei Paesi, spesso
in via di sviluppo, in cui operano e le
possibili violazioni dei diritti umani
che possono commettere direttamente
(ad esempio attraverso particolari modalità di reclutamento o mediante
l’impatto che i processi di produzione
possono avere sui lavoratori, le comunità locali e l’ambiente) o anche indirettamente, qualora si rivelino complici
delle politiche repressive dei governi
locali. La responsabilità sociale
d’impresa è oggi oggetto di alcuni
importanti documenti internazionali: in
primis, le Norme sulle responsabilità
delle imprese multinazionali del 13
agosto 2003 e, in ambito UE, il Libro
verde della Commissione europea del
18 luglio 2001, dal titolo Promuovere
un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese. Importantissimi sono poi i vari ‘codici di condotta’
e le ‘linee guida’ adottati in seno a
varie organizzazioni intergovernative
per «tentare di bilanciare l’accresciuto
potere delle multinazionali con un
altrettanto livello di accountability, […
che] eviti che questi nuovi ‘attori’ delle
relazioni internazionali possano godere
di una sorta di impunità» (p. 200). Il
limite di questi strumenti, rileva giustamente l’autore, è però la loro natura
non vincolante e la mancanza di sistemi efficaci di monitoraggio. Egli ricorda, poi, che già la nostra Costituzione,
all’art. 41, tutela sì la libertà di iniziativa economica privata, ma ammonisce
che questa non debba “svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana”. Particolare
risalto è dato nello scritto anche
all’attività delle Nazioni Unite in materia, in particolare al progetto Global
Compact del 2000, con il quale si è
richiesto al mondo delle imprese di
«allineare l’economia globale al riconoscimento e al rispetto di dieci principî universalmente riconosciuti nelle
aree dei diritti dell’uomo, del lavoro,
dell’ambiente e […] della lotta alla
corruzione» (p. 208). Infine, viene
evidenziato come, dal giugno 2005, sia
stata istituita l’importante figura del
rappresentante speciale del segretario
generale delle Nazioni Unite sui diritti
umani e le imprese multinazionali,
figura che, con il suo operato, potrà
contribuire a monitorare il rispetto dei
diritti umani da parte delle multinazio-
289
nali.
Il delicato tema dei rapporti tra Israele e la popolazione palestinese è affrontato nell’interessante scritto di
Lucia Russo, Il muro d’Israele
nell’ottica del diritto internazionale
umanitario e dei diritti umani: strumento di protezione o mezzo di espansione? L’autrice pone subito in risalto
gli effetti sulla popolazione civile palestinese della costruzione del muro,
iniziata ad opera di Israele nel giugno
del 2002. Centrale per la ricostruzione
della vicenda è il contenuto del parere
emanato dalla Corte internazionale di
giustizia del 9 luglio 2004 e della decisione della Corte Suprema di Israele
del 30 giugno 2004: in entrambi i fori è
stata messa in discussione la legittimità
di tale iniziativa, in quanto la barriera,
oltrepassando i limiti tracciati dalla
Green Line, arrecava ingenti danni alle
popolazioni ivi residenti e costituiva
un’annessione de facto di parti di territorio non occupate dallo Stato israeliano. A conclusioni diverse sono, però,
giunte le due istanze giurisdizionali: la
Corte Suprema ha riconosciuto la legittimità delle decisioni del governo israeliano, pur avendo ravvisato una
forte sproporzione tra le esigenze di
sicurezza ed i sacrifici patiti dai civili
palestinesi; i giudici dell’Aia hanno
invece negato la legittimità della costruzione di detta barriera e l’avvenuta
violazione del diritto del popolo palestinese ad autodeterminarsi. In maniera
molto approfondita sono poi analizzate
le varie violazioni subite dai palestinesi
a causa di questa costruzione e le norme internazionali cui tali violazioni
sono riconducibili. L’autrice conclude
affermando che, sebbene il parere della
Corte internazionale di giustizia costituisca un’importante novità perché si è
per la prima volta affrontata in quella
sede giurisdizionale una delle questioni
più spinose di diritto internazionale,
ciò nonostante non vi è stata alcuna
positiva evoluzione nei rapporti tra i
due soggetti a seguito della pronuncia.
Infine, lo scritto La sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo e
gli obblighi positivi di protezione dei
diritti umani violati di Caterina Rizzo
offre un interessante esempio di “giustiziabilità” delle violazioni di diritti
umani fondamentali, nella specie quelli
riconosciuti e tutelati nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre 1950 (meglio nota
come Convenzione europea dei diritti
dell’uomo). Il procedimento che si
instaura innanzi la Corte europea dei
diritti dell’uomo si conclude con una
sentenza vincolante per lo Stato in
causa. Quest’ultimo è obbligato a darvi
esecuzione. L’autrice analizza alcune
caratteristiche delle decisioni della
Corte, anche attraverso lo studio della
sua giurisprudenza. Importanti riflessioni sono svolte rispetto all’autorità di
res interpretata delle sentenze e ai loro
cosiddetti effetti erga omnes. Altro
obbligo incombente in capo agli Stati è
quello di non ripetizione dell’illecito,
che può essere adempiuto attraverso
misure normative di carattere generale,
revirements giurisprudenziali o in virtù
di adozione di misure materiali. Un
ulteriore
argomento
affrontato
290
dall’autrice è quello delle sentenzepilota rese dalla Corte in casi di violazioni strutturali di diritti fondamentali
ad opera di uno stesso Stato: tale nuova
tecnica è volta ad evitare i ricorsi ripetitivi causati dalla persistenza negli
ordinamenti di alcuni Stati di problemi
a carattere strutturale, che incidevano
sulle libertà di numerosi individui e
che rallentavano il lavoro dei giudici di
Strasburgo. In proposito vengono richiamati i noti casi Broniowski (2004)
e Scordino (2006). Un ultimo paragrafo è, invece, dedicato agli obblighi
positivi di protezione incombenti sugli
Stati contraenti. L’autrice mette in
evidenza come solo l’azione delle autorità statali possa concretamente
scongiurare il perpetrarsi di ripetute
violazioni di diritti fondamentali: viene, così, superata la tradizionale concezione delle libertà fondate esclusivamente su un obbligo di astensione
dello Stato, che doveva limitarsi a non
ostacolarle.
Claudia Morini
ITALO TALIA, Le tracce della città: una geografia dell’urbano.
Metamorfosi, culture, identità,
Roma, Aracne, 2011, pp. 161.
Il volume si sviluppa come un intenso
racconto sulle metamorfosi di quello
che è senza dubbio l’oggetto geografico più affascinante: la città. Talia
chiama a testimoni di questa narrazione non solo geografi, ma anche storici,
demografi, sociologi, teologi, politologi, a dimostrazione di un approccio
epistemologico all’argomento che
impone ad ogni disciplina di abbandonare qualsiasi complesso di superiorità.
In questo lavoro, che si struttura in
cinque capitoli, il ruolo della città come propulsore dei cambiamenti emerge in tutta la sua forza: dalla polis
greca
all’immagine
visionaria
dell’ecumenopoli di Doxiadis, è sempre nella città che nascono i maggiori
mutamenti economici e politici e si
producono le nuove identità.
Dal primo capitolo, “Città e spazi
globali”, prende corpo il protagonismo
di metropoli e aree urbane, che si candidano a guidare la globalizzazione
formando reti mondiali, di diverso
livello, che sembrano voler prescindere
o, addirittura, superare le forme degli
Stati nazionali. Si profila, pertanto, una
sorta di “solitudine dello Stato” di
fronte alle città, che dialogano/competono
tra
loro
senza
l’intermediazione delle nazioni, dove
sfuma e si confonde il concetto stesso
di sovranità territoriale.
Il titolo del secondo capitolo prende
a prestito la definizione di città di
Chombart de Lauwe (ripresa ed ampliata da Henri Lefebvre) come “società tracciata sul suolo”, partendo
dall’antichità per analizzare le diverse
fasi della metamorfosi nella cultura
urbana. Già in questa epoca si possono
enucleare due modelli: quello della
città greco-romana, con al centro il
forum degli scambi e degli incontri tra
cittadini, e quello orientale, che riproduce, nella cittadella centrale fortifica-
291
ta, il segno di un potere autocratico.
Con l’Impero romano, la città diviene elemento riproducibile in altri territori, ma è solo dopo il Medioevo che la
città europea diviene “articolo da esportazione” (per dirla con Sergio Romano),
ossia,
la
proiezione
dell’Occidente in altri continenti. La
città medievale (la cui aria “rende liberi”, secondo un antico detto tedesco),
la città dei diritti individuali e delle
libertà politiche, del nuovo ceto della
borghesia
cittadina,
rappresenta
l’ulteriore metamorfosi culturale ed
identitaria che produce, a parere
dell’autore, il primo discrimine tra città
sviluppate e aree sottosviluppate. La
città è lo spazio della ragione cartesiana, è la dimensione culturale dove
germinerà l’Illuminismo e la rivoluzione industriale: ciò che diverge da
questo paradigma si rassegna a sottrarsi al progresso.
Nel terzo capitolo, “La modernità”,
viene sviluppato il rapporto causale tra
urbanizzazione ed industrializzazione;
la concentrazione spaziale di funzioni
ristruttura la città in nuovi ambiti funzionali e ne frammenta la struttura
sociale in nuovi ceti: borghesia, proletariato, sottoproletariato. La città assume, in questa fase, una struttura
piramidale fortemente gerarchizzata
per funzioni che Burgess e la “scuola
ecologica di Chicago” descriveranno
con il modello delle quattro zone socioeconomiche concentriche.
Questo modello entra in crisi alla
metà del XX secolo, quando la concentrazione delle attività produttive inizia
a generare diseconomie di scala e di
agglomerazione: i costi della vita urbana diventano superiori ai benefici, sia
per i privati, che per le imprese. Tuttavia, questa crisi della città centrale
contemporanea non è irreversibile: è
anch’essa una delle fasi del mutamento
della cultura urbana.
«L’approdo delle metamorfosi urbane è rappresentato dalla città in rete
e dalle reti di città. Queste generano un
insieme di flussi e di reazioni non più
gerarchici ma orizzontali» (p. 83): il
quarto capitolo, “I nuovi nomadi”,
contiene una rassegna di “nodi globali”
e di “città globali”. I primi sono rappresentati da quelle realtà metropolitane che controllano e dirigono i grandi
flussi globali; le seconde sono quelle
aree urbane che esercitano un influsso
geoeconomico sovranazionale. Questi
flussi globali (di informazioni, di capitale finanziario, di merci, di persone)
hanno messo in movimento sia i nuovi
cosmopoliti, apolidi mondialisti occidentali che dominano il cyberspazio,
che i nuovi nomadi, migranti di tutte le
aree del pianeta, portatori di identità
diverse. La loro compresenza nello
stesso spazio urbano crea la “città duale” dove si incontrano/scontrano persone, etnie, culture e lingue diverse.
Nell’ultimo capitolo, “I cittadini
globali”, Talia si inoltra tra i temi delicatissimi dell'integrazione e della tolleranza, che sottostanno alla questione
della cittadinanza, di quel “diritto alla
città” quale tema permanente che ha
percorso l’intero volume e che appare
quanto mai attuale ed urgente. Il principio di libertà che ha alimentato la
città europea e occidentale, nutrendosi
292
del valore voltairiano della tolleranza,
oggi trova di fronte a sé una sfida
grandiosa, che mette in discussione il
destino
stesso
della
città
e
dell’Occidente.
Cosimo Alessandro Quarta
293
GLI AUTORI
Ennio Di Nolfo, professore emerito dell'Università di Firenze, dove ha insegnato Storia delle
Relazioni Internazionali per molti anni. Autore, tra le molte sue opere, della fondamentale
Storia delle relazioni internazionali dal 1919 ai nostri giorni (Laterza). Il suo lavoro più
recente: Lessico di politica internazionale contemporanea (Laterza).
Antonio Donno, professore ordinario di Storia delle Relazioni Internazionali nel Corso di
Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell'Università del Salento, Lecce.
L'opera più recente (con Giuliana Iurlano): Nixon, Kissinger e il Medio Oriente, 1969-1973, Le
Lettere, 2010.
Maurizia Pierri, ricercatrice di Diritto Pubblico Comparato, disciplina che insegna nel Corso
di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell'Università del Salento,
Lecce.
Giuseppe Patisso, ricercatore di Storia Moderna, disciplina che insegna nel Corso di Laurea in
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell'Università del Salento, Lecce.
Alessandro Isoni, ricercatore di Storia delle Istituzioni Politiche, insegna Storia
dell'Integrazione Europea nel Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni
Internazionali dell'Università del Salento, Lecce.
Francesco Martelloni, studioso di storia contemporanea, lavora nel Dipartimento di Storia
Società e Studi sull'Uomo dell'Università del Salento, Lecce.
Paolo Macrì, dottore di ricerca in Storia delle Relazioni e delle Organizzazioni Internazionali,
svolge attività di ricerca presso la cattedra di Storia delle Relazioni Internazionali
dell'Università del Salento, Lecce.
Giuliana Iurlano, ricercatrice di Storia delle Relazioni Internazionali, insegna Relazioni
Internazionali e Storia degli Stati Uniti nel Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali dell'Università del Salento, Lecce.
Francesca De Pascalis ha conseguito la laurea magistrale in Scienze della Politica. Il presente
lavoro è tratto dalla sua tesi triennale in Relazioni Internazionali.
Katia Scarlino ha conseguito la laurea magistrale in Scienze della Politica. Il presente lavoro è
frutto di uno studio svolto nell'ambito di un seminario in Storia dei Trattati e Politica
Internazionale.
Francesca Salvatore è dottoranda di ricerca in Studi Storici, Geografici e delle Relazioni
Internazionali (sezione di Relazioni Internazionali). Il lavoro è tratto dalla sua tesi triennale in
Relazioni Internazionali.
Eunomia
Rivista del Corso di Laurea in Scienze Politiche
e delle Relazioni Internazionali
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/eunomia
© 2012 Università del Salento – Coordinamento SIBA
http://siba2.unisalento.it