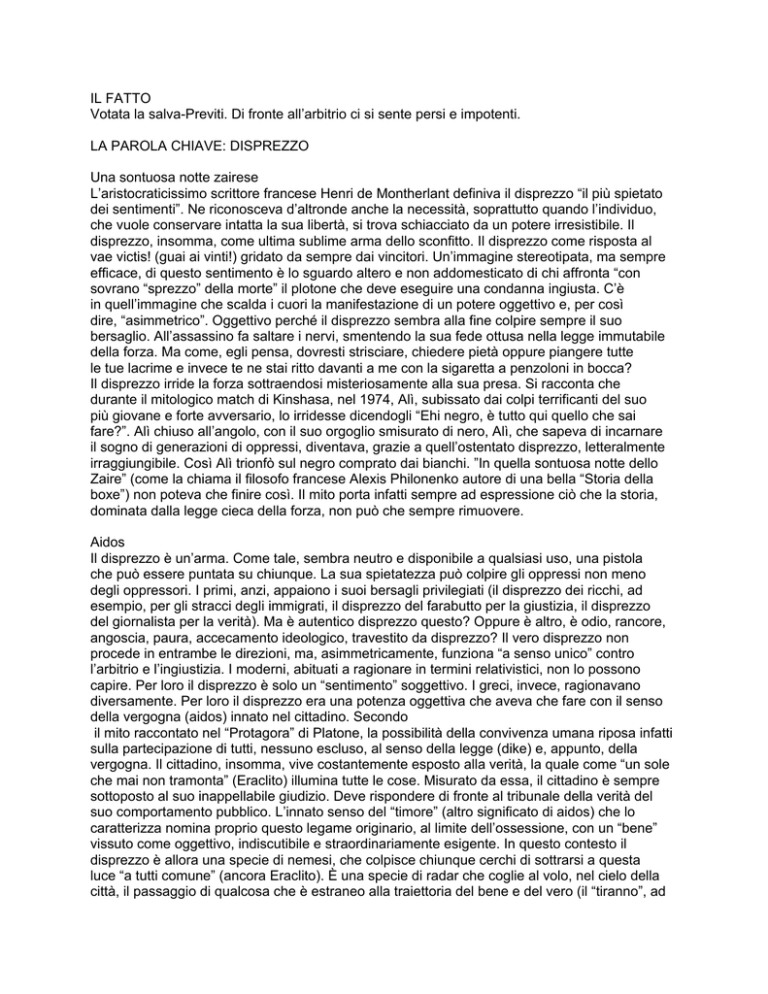
IL FATTO
Votata la salva-Previti. Di fronte all’arbitrio ci si sente persi e impotenti.
LA PAROLA CHIAVE: DISPREZZO
Una sontuosa notte zairese
L’aristocraticissimo scrittore francese Henri de Montherlant definiva il disprezzo “il più spietato
dei sentimenti”. Ne riconosceva d’altronde anche la necessità, soprattutto quando l’individuo,
che vuole conservare intatta la sua libertà, si trova schiacciato da un potere irresistibile. Il
disprezzo, insomma, come ultima sublime arma dello sconfitto. Il disprezzo come risposta al
vae victis! (guai ai vinti!) gridato da sempre dai vincitori. Un’immagine stereotipata, ma sempre
efficace, di questo sentimento è lo sguardo altero e non addomesticato di chi affronta “con
sovrano “sprezzo” della morte” il plotone che deve eseguire una condanna ingiusta. C’è
in quell’immagine che scalda i cuori la manifestazione di un potere oggettivo e, per così
dire, “asimmetrico”. Oggettivo perché il disprezzo sembra alla fine colpire sempre il suo
bersaglio. All’assassino fa saltare i nervi, smentendo la sua fede ottusa nella legge immutabile
della forza. Ma come, egli pensa, dovresti strisciare, chiedere pietà oppure piangere tutte
le tue lacrime e invece te ne stai ritto davanti a me con la sigaretta a penzoloni in bocca?
Il disprezzo irride la forza sottraendosi misteriosamente alla sua presa. Si racconta che
durante il mitologico match di Kinshasa, nel 1974, Alì, subissato dai colpi terrificanti del suo
più giovane e forte avversario, lo irridesse dicendogli “Ehi negro, è tutto qui quello che sai
fare?”. Alì chiuso all’angolo, con il suo orgoglio smisurato di nero, Alì, che sapeva di incarnare
il sogno di generazioni di oppressi, diventava, grazie a quell’ostentato disprezzo, letteralmente
irraggiungibile. Così Alì trionfò sul negro comprato dai bianchi. ”In quella sontuosa notte dello
Zaire” (come la chiama il filosofo francese Alexis Philonenko autore di una bella “Storia della
boxe”) non poteva che finire così. Il mito porta infatti sempre ad espressione ciò che la storia,
dominata dalla legge cieca della forza, non può che sempre rimuovere.
Aidos
Il disprezzo è un’arma. Come tale, sembra neutro e disponibile a qualsiasi uso, una pistola
che può essere puntata su chiunque. La sua spietatezza può colpire gli oppressi non meno
degli oppressori. I primi, anzi, appaiono i suoi bersagli privilegiati (il disprezzo dei ricchi, ad
esempio, per gli stracci degli immigrati, il disprezzo del farabutto per la giustizia, il disprezzo
del giornalista per la verità). Ma è autentico disprezzo questo? Oppure è altro, è odio, rancore,
angoscia, paura, accecamento ideologico, travestito da disprezzo? Il vero disprezzo non
procede in entrambe le direzioni, ma, asimmetricamente, funziona “a senso unico” contro
l’arbitrio e l’ingiustizia. I moderni, abituati a ragionare in termini relativistici, non lo possono
capire. Per loro il disprezzo è solo un “sentimento” soggettivo. I greci, invece, ragionavano
diversamente. Per loro il disprezzo era una potenza oggettiva che aveva che fare con il senso
della vergogna (aidos) innato nel cittadino. Secondo
il mito raccontato nel “Protagora” di Platone, la possibilità della convivenza umana riposa infatti
sulla partecipazione di tutti, nessuno escluso, al senso della legge (dike) e, appunto, della
vergogna. Il cittadino, insomma, vive costantemente esposto alla verità, la quale come “un sole
che mai non tramonta” (Eraclito) illumina tutte le cose. Misurato da essa, il cittadino è sempre
sottoposto al suo inappellabile giudizio. Deve rispondere di fronte al tribunale della verità del
suo comportamento pubblico. L’innato senso del “timore” (altro significato di aidos) che lo
caratterizza nomina proprio questo legame originario, al limite dell’ossessione, con un “bene”
vissuto come oggettivo, indiscutibile e straordinariamente esigente. In questo contesto il
disprezzo è allora una specie di nemesi, che colpisce chiunque cerchi di sottrarsi a questa
luce “a tutti comune” (ancora Eraclito). È una specie di radar che coglie al volo, nel cielo della
città, il passaggio di qualcosa che è estraneo alla traiettoria del bene e del vero (il “tiranno”, ad
esempio).
Buffone!
Infine, che altro desidera il potere se non ciò che desidera ogni desiderio, vale a dire essere
riconosciuto? La sete di potere è sete di riconoscimento. Il potere desidera essere desiderato
da chi sottomette e annaspa quando non si sente contraccambiato. Questa fragilità emotiva
del potere dovrebbe far riflettere coloro che troppo presto si rassegnano all’ingiustizia. E spiega
anche perché uno sprezzante “buffone” gridato da un omino piccolo piccolo può far tanto
incazzare chi simula un’autorità che non ha.
Rocco Ronchi
In questo numero:
Le conseguenze dell’amore
Niente vi sarà risparmiato
Il tempio indiano
IL FATTO
Tsunami
LA PAROLA CHIAVE: BENE
Le conseguenze dell’amore
”O infelici mortali! O terra degna di pietà! / O cumulo spaventoso di tutti i flagelli!
/ Successione eterna di inutili dolori! / Filosofi illusi, che gridate “Tutto è bene, /
accorrete, contemplate queste orrende rovine, / queste macerie, questi detriti,
queste ceneri miserande, / queste donne, questi bambini ammucchiati l‘uno
sull’altro, / queste membra disperse sotto i marmi infranti: / centomila sventurati
divorati dalla terra, / che terminano i loro giorni miserevoli sanguinanti, straziati e
ancora palpitanti, / sepolti sotto le loro case, senza soccorso, fra orribili tormenti!”.
Con questi versi (versi forse non belli, ma palpitanti) si apriva il poema del libero
pensatore Voltaire sul terremoto che aveva sconvolto Lisbona il giorno di Ognissanti
del 1755. L’obiettivo polemico era tutto filosofico. Nel mirino del polemista
d’eccezione era la teodicea leibniziana, ultimo esempio, a suo parere, di quel
millenario tentativo di coprire le magagne di Dio con l’esibizione di fallaci armonie
naturali. Ma si resta alla superficie della questione se si pensa che la querelle
riguardi disincantati pessimisti (Voltaire) e ottusi ottimisti al servizio del clero e
dell’ideologia “buonista” (Leibniz). Il “tutto è bene” attribuito a Leibniz esprimeva
infatti quel “principio di pienezza”, che, muovendo dalla premessa della perfezione
infinita del Principio Primo creatore di tutte le cose, sanciva “la necessità e dignità
di tutti i concepibili generi di esseri finiti, temporali, imperfetti e corporei” (Arthur
O. Lovejoy). Su questo principio avevano giurato concordi filosofi “ideologicamente”
assai eterogenei tra loro: non solo l’iper-razionalista Leibniz, ma anche l’eretico
Giordano Bruno, l’ebreo Spinoza, il cardinale cattolico Cusano, il mistico in odore
di atesimo Eckhart e innumerevoli altri, il primo dei quali era senz’altro il pagano
Platone, il quale avendo escluso dalla bontà divina ogni invidia e ogni gelosia
doveva trarre da questa premessa la terribile ma necessaria conclusione: niente di
ciò che può essere può restare escluso dall’attualità.
Niente vi sarà risparmiato
A leggerlo attentamente, il “Tutto è bene” di questi sommi filosofi diceva insomma
qualcosa di opposto a quello che, anche grazie ai versi di Voltaire, crediamo di
intendervi. Non è il “tutto è bene” del prete ipocrita odiato da François Arouet (il
vero nome di Voltaire), il prete che cerca di consolare la vittima dell’ingiustificata
violenza subita rammentandole la provvidenza divina e immaginarie colpe da
espiare in questa vita (la lettura che del terremoto portoghese aveva fatto
allora il clero è la stessa che una parte retriva del mondo religioso fa oggi per
l’Aids). No. “Tutto è bene” significa piuttosto, per questi filosofi, “niente vi sarà
risparmiato”. Tutto ciò che può essere necessariamente sarà e siccome, come
ricorda Dostoevskij, tra ciò che può essere ci sono tanto bambini seviziati quanto
solidarietà e fratellanza universale, entrambe queste cose non ci possono non
essere. E infatti ci sono, infallibilmente. Basta leggere le cronache del dopo
cataclisma dove orrore e distruzione, generosità e carità si rincorrono senza
posa. Perché se la peggiore delle due mancasse, allora, commenta con spietata
logica “parmenidea” Giovanni Scoto Eriugena, “si potrebbe pensare che Dio non è il
creatore di tutte le nature senza eccezione, di tutte le nature cioè di cui la ragione
ci mostra che possono essere create”. E siccome “possono” essere create “devono”
esserlo. Questa è, secondo i filosofi, l’onnipotenza divina. Questo, secondo
il “principio di pienezza”, è il contenuto tragico di quell’espressione, “Tutto è bene”,
eletta da Voltaire a simbolo dell”ottimismo idiota. Basta infatti capovolgerla quella
frase per ritrovarne il vero agghiacciante significato: “Il bene è il tutto”, il bene
coincide con ciò che è, qualunque cosa esso sia. Proprio come affermerà un filosofo
che si reputava, a torto, un ammiratore di Voltaire, Friedrich Nietzsche.
Il tempio indiano
Allora, nella querelle Voltaire-Leibniz, chi è il pessimista e chi è l’ottimista? Chi ha
il diritto di fregiarsi del titolo di realista e chi, invece, coltiva illusioni metafisiche e
speranze buoniste? A chi la palma del disincanto? Nel suo saggio sull’architettura
del tempio indù, Titus Burckhardt spiega la complementarità di quelle facciate
straripanti di forme ora mostruose ora incantevoli con la stanza centrale del tempio,
asciutta e vuota. Quel tempio, nella sua forma, ricorda al devoto la verità ultima
enunciata da ogni filosofia e respinta dal “moderno” Voltaire: tutto è bene, il bene è
il tutto, niente vi sarà risparmiato.
Rocco Ronchi
IL FATTO
Tutti uniti in tutto il mondo a commemorare con le stesse parole Auschwitz
Farci il callo
Tra i pochi mezzi che la natura ci ha messo a disposizione per sopportare l’assurdità
dell’ esistenza c’è l’abitudine. L’abitudine nomina infatti la facoltà di forgiarsi
con l’esercizio una “seconda natura” (così si esprimeva Aristotele nell’“Etica
nicomachea”) grazie alla quale anche quanto è originariamente in contraddizione
con la nostra esistenza viene dominato, controllato e, nei limiti del possibile,
assimilato. “Ci ho fatto il callo…”, questa è la legge sovrana dell’abitudine. Se per
certi uomini l’impossibile diventa possibile, lo straordinario ordinario, ciò si deve
a questa “cosa simile alla natura” (ancora Aristotele), a questa naturalezza di
secondo livello. Non c’è bisogno di scomodare l’orrore dei deportati. E’ sufficiente
pensare alla relativa velocità con cui il malato si abitua alla propria malattia.
Quella confidenza con il dolore, che lascia di stucco l’uomo sano, è frutto di
quell’abitudine a contrarre abitudini, che definisce la “natura” umana nella sua
differenza dalla “prima” natura. Il “carattere”, del resto, non si forgia forse nella
sventura? “Carattere” è una delle traduzioni possibili della parola greca “ethos”.
Abituarsi, se stiamo alla logica interna della parola, significa allora entrare nel
mondo adulto dell’etica. Non è il mondo dei valori ad accoglierci, non sono il bene
e il male in veste da cerimonia a darci il benvenuto. E’ piuttosto il dolore di prima,
quello che ci faceva strillare nella culla o disperare per l’abbandono notturno della
madre, che ora è diventato parte del nostro essere, legge interna delle nostre azioni
quotidiane. Abbiamo fatto il callo al buio, all’assenza della madre, al freddo della
miniera. Questo significa che ora non lo subiamo più quel buio, come si subisce
qualcosa che proviene da fuori, ma in qualche modo lo “siamo”: siamo fatti, nel
nostro “carattere”, di quel buio, di quell’assenza e di quel freddo. Altrimenti non si
spiegherebbe perché è così facile riconoscere la presenza del mare invernale, della
pesca e della sua fatica, nelle rughe di un uomo che passeggia sul porto.
Una memoria che non ricorda
L’abitudine è insomma la traduzione in termine “spirituali” di quella proprietà
che hanno gli organismi viventi di modificare funzioni e struttura in seguito a
variazioni delle condizioni ambientali. Se la “prima” natura si mantiene adattandosi,
la “seconda” lo fa abituandosi. Il nome per questo “adattamento” di secondo grado
che riguarda soggetti “spirituali” e “complessi”, e non organismi elementari, è,
secondo il filosofo Henri Bergson, “memoria”. Non la memoria che ricorda il fatto
singolo nella sua puntualità, ma la memoria automatica delle nostre membra, le
quali, con l’esercizio, hanno acquisito l’abitudine alla posizione eretta e la ripetono
in ogni occasione, senza incertezze e senza bisogno di rappresentazione e di
consapevolezza (se infatti dovessi ricordare ogni volta come si fa a camminare
sarebbe un bel guaio, un guaio purtroppo conseguente a molte patologie).
L’abitudine è insomma proprio questa memoria che agisce, una memoria
paradossale perché senza ricordo. Una memoria per altro efficace proprio grazie a
questa sua incoscienza di principio.
I bambini ci guardano
Anche la società è figlia dell’abitudine ed è solo attraverso l’abitudine che essa si
conserva. Anch’essa deve sviluppare una sua memoria-abitudine. Anch’essa deve
diventare adulta, entrare nello spazio dell’etica, “fare il callo” a tutto quanto la
minaccia nel suo essere immediato. Si comprende allora la diffidenza del testimone
(colui che ha visto) nei confronti delle ufficiali commemorazioni della sventura
massima del nostro secolo. Il testimone è colui che il callo non se lo è fatto e non se
lo vuole fare. La sua ferita è aperta e sanguina. Il dolore è immediato. In un certo
senso egli è privo di “carattere” e si arroga il diritto ad uno sguardo “infantile” sul
mondo (il testimone per eccellenza non è forse il bambino? Sono “I bambini (che)
ci guardano”, come recita il titolo di uno strepitoso film di De Sica del 1944 che
diede molto fastidio al regime fascista). Ebbene , il testimone pretende il ricordo, la
rappresentazione, la consapevolezza. Egli perciò sospetta nella memoria ufficiale la
presenza attiva dell’altra memoria, la memoria-abitudine, quella memoria adattiva
che deve assimilare l’orrore per renderlo sopportabile e gestibile. Il testimone
diffida insomma dei monumenti, anche di quelli eretti con le migliore intenzioni,
perché segni di una memoria che non ricorda.
Rocco Ronchi
IL FATTO
A chi si daranno i nostri radicali liberali, liberisti e libertari?
'Io non devo niente a nessuno'
Qual è il principio fondante della modernità? Quale immagine, quale parola d’ordine,
quale slogan, meglio definisce il 'tipo umano' occidentale? Per i giornalisti e per gli
apologeti dell’ordine esistente, non ci sono dubbi. Le parole sono quelle usate ed abusate
di 'libertà', 'diritti', 'individuo', 'autonomia' ecc. Per queste parole, lo sappiamo, l’Occidente
è disposto non solo ad uccidere ma anche, sebbene in misura ridicolmente ridotta rispetto
alle sue vittime, a morire. C’è inoltre in queste parole un contenuto di verità che trascende
il loro valore ideologico e propagandistico. Chi pensasse che sono soltanto specchietti per
allodole per giustificare l’appropriazione di risorse altrui e processi imperialistici darebbe
prova, con il suo eccesso di disincanto, di una profonda ingenuità. Vale piuttosto l’inverso:
l’imperialismo politico, economico e militare è un effetto della 'verità' indiscutibile attribuita
a queste parole, consegue da loro come una dimostrazione procede dai suoi assiomi. Ma
tutte queste sublimi e insanguinate parole sono a loro volta solo lo sviluppo di un’altra
parola d’ordine, meno roboante e più segreta. Secondo il filosofo cattolico Jean Luc Marion,
una delle menti più brillanti del pensiero francese contemporaneo, 'il modello per eccellenza
della soggettività occidentale' è dato dalla parola d’ordine: 'Io non devo niente a nessuno'.
Amerika
La vecchia storia del figliol prodigo torna allora prepotentemente d’attualità per chiarire a
noi stessi e all’altro che bussa insistentemente alla nostra porta 'chi' veramente siamo 'noi
buoni europei' (l’espressione è di Nietzsche e vale per l’Occidente in genere). Il problema
di questo benedetto ragazzo non era la prodigalità, ma il rifiuto del debito di riconoscenza
maturato in quanto figlio nei confronti del padre. Non volendo dover niente a nessuno
chiese che gli fosse dato quanto 'giuridicamente' gli spettava e se ne andò. Ciò che non
sopportava era la gratitudine. Dopodichè tutti sappiamo come andò a finire (e questo finale,
il ritorno alla casa del padre, è per noi ancora di là da venire). Quando storici e filosofi
hanno cercato di capire cosa fosse veramente la 'libertà dei moderni', una libertà così
diversa dalla libertà tutta civile e iperpolitica degli antichi (la quale era compatibile con livelli
di oppressione degli individui che la nostra sensibilità giudicherebbe senz’altro 'totalitari' –
si pensi al modello spartano elogiato da Platone), si sono imbattuti nella cosiddetta 'opzione
uscita' (A. Hirschman). La libertà dei moderni è infatti la libertà di andarsene, la libertà
del figliol prodigo di sciogliere ogni legame che lo vincola al luogo, alla comunità e alla
tradizione. E’ una libertà molto amerikana perché implica una 'frontiera' verso la quale
evadere e dove ricostruirsi una vita fondata solo sul proprio lavoro, una vita che non deve
niente a nessuno. Se eventualmente si incontra sul proprio cammino qualche 'nativo' questi
potrà essere tranquillamente liquidato in nome, appunto, del proprio sovrano diritto alla
libertà.
Delocalizzazioni
Questa libertà di andarsene è diventata la specificità del capitale nell’epoca della
globalizzazione. Esso risponde solo a se stesso (agli investitori) ed è libero da ogni obbligo
nei confronti del luogo e degli uomini che lo abitano. Come ha spiegato il sociologo Zygmunt
Bauman, il capitale, oggi, 'non deve niente a nessuno'. L’opzione uscita è la sua legge
immanente.
Clint
Questa libertà implica una solitudine e una violenza che è difficile da sopportare.
Clint Eastwood la racconta magnificamente nei suoi cupi film. Soprattutto nella scena
iniziale degli 'Spietati' e in quella conclusiva di 'Mystic River'. Questo deserto per essere
minimamente abitabile deve allora essere incessantemente popolato di fantasmi. Solo pochi,
infatti, saprebbero vivere nel silenzio come i personaggi di Clint. I più naufragherebbero
in un dolore insensato. Ecco allora che arrivano i 'neoconservatori'. Mancando una
reale comunità, un luogo abitabile, una tradizione ed un Dio viventi, se ne producono i
succedanei. Saranno la Bandiera, la Comunità intesa come fortino assediato, i Valori Morali
ed un Dio ridotto a simbolo e protettore della potenza bellica o dell’Embrione. In questo
modo l’ansia del figliol prodigo è tenuta a freno e il momento critico dell’elaborazione del
lutto rinviato.
Rocco Ronchi
IL FATTO
Si aggravano ulteriormente le condizioni del papa
L'astuzia di Mitridate
Al moribondo la filosofia non è, purtroppo, di nessuna consolazione. Non lo aiuta a morire
meglio. Morire meglio, infatti, sarebbe non dover morire. E la filosofia non può ovviamente
nulla a questo proposito. La filosofia medita, però, sulla morte. Più precisamente, s'interroga
sulla 'stranezza' (sull''atopia', come dicono i Greci) di quel fatale istante che farà combaciare
cose impossibili. S'illude chi pensa che il platonico “esercizio di morte” (è la sua definizione
della filosofia) sia un lento processo di mitridatizzazione, il quale,facendoci pensare alla
morte un pochino, ogni giorno, riesca poi a rendere meno assurdo il 'trapasso'. La morte
si fa beffe di qualsiasi propedeutica e coglie ugualmente impreparati il vecchio centenario
e il ragazzo, il saggio come lo stolto. La sua distanza dalla vita resta sempre incolmabile.
Nessun passo, nemmeno quello lento della vecchiaia, ci avvicina ad essa, nessuna
familiarità ne attenua l'estraneità assoluta. Le 'approssimazioni' alla morte sono solo una
pietosa bugia. Non ci si approssima alla morte più di quanto non ci si avvicini alla linea
dell'orizzonte marciando nella sua direzione. Nella marcia, infatti, ci portiamo sempre dietro
il nostro orizzonte la cui linea, passo dopo passo, resta sempre alla stessa distanza da noi.
Million dollar baby
Per questo il filosofo francese Maurice Blanchot scriveva che 'morire' è per noi impossibile.
A quest'impossibilità ascriveva il tormento specifico del moribondo. Morire sfugge al
nostro potere comunque esso sia declinato. Possiamo anche correrle incontro, possiamo
precipitarci tra le sue braccia, ma se non sarà lei a prendere l'iniziativa e a raggiungerci
furtivamente 'come un ladro nella notte', noi non la incontreremo mai. Perfino nell'eutanasia
la morte resta qualcosa che deve essere 'dato',qualcosa che proviene d'altrove e che sfugge
per principio alla mia iniziativa. L'eutanasia necessità della 'pietà' dell'altro. Ha bisogno,
per aver luogo, della sua libera volontà. E l'eventualità, nobilissima, del suicidio non
testimonia della possibilità di una morte liberamente scelta e consapevolmente progettata
perché il suicida non va incontro alla morte (come si può andare incontro al nulla?), quanto
piuttosto si sottrae alla vita. Nessuno, nemmeno il Kirilov dei 'Demoni' di Dostoevskij,
si uccide così, “senza ragioni”, semplicemente per provare ad estendere il dominio del
soggetto all'impossibile. Chi si uccide ha gli occhi fissi sulla sua vita, contempla come
l'angelo disegnato da Klee le rovine del proprio passato, e si affida alla morte con la stessa
incosciente leggerezza con cui una donna, in uno scatto d'indignazione, può donarsi ad uno
sconosciuto pur di farla finita con la routine asfissiante della quotidianità.
Arrendersi
L' estraneità della morte misura e rivela la nostra impotenza radicale. Non c'è prima persona
dell'indicativo presente per quel verbo. Per 'poter' morire il soggetto è costretto a deporre
la corona della propria sovranità. Per morire bisogna, ad un certo punto, lasciarsi andare,
bisogna abbandonare e abbandonarsi, proprio come avviene quando si prende sonno (la
nostra quotidiana “piccola morte”). Infatti, non sono “io” che “mi addormento”, ma è il
sonno, proprio lui, l'estraneo, che mi scova e mi trascina via da 'me'. 'Io', se il sonno arriva,
non ci sono più ed il sonno può 'arrivare' solo quando 'io' cesso finalmente di essere. Per
questo molti faticano a addormentarsi. Temono questo istante del rapimento, nel quale
saranno visitati e quasi violentati da un Altro che li esproprierà della loro libera soggettività.
Il punto in cui il sonno incontra la veglia anticipa quell'altro punto, assai più drammatico,
nel quale l'essere incrocia il nulla: l'istante “atopico”' (senza 'quando' e senza 'dove') del
mio morire. In quell'istante si toccheranno degli impossibili ed io varcherò una soglia che
restando 'io' (“io sono, io penso”) non posso per definizione varcare.
La filastrocca dell'essere
Conosciamo la filastrocca di Parmenide, il venerando padre di tutti i filosofi. Dell'essere, egli
afferma, non può dirsi altro che è e che è impossibile che non sia, del non essere che non
è e che non è possibile che sia. Più chiaro di così non è possibile. Parmenide, a scuola, è
spesso considerato dai ragazzi una specie di comico involontario che ripete con aria ispirata
ovvietà sconcertanti. Ma la contraddizione denunciata da Parmenide è proprio quel salto che
ogni mortale per morire non può che compiere, ma che, al tempo stesso, ogni mortale non
può pensare senza essere strozzato dall'assurdo.
Rocco Ronchi
In questo numero di liber opensiero
la parola chiave è MALINTESO
Si parla di:
- Critica della ragion dialettica
- La prassi cieca
- Rimbalzi e ritorni di fiamma
IL FATTO
Omicidio del coraggioso italiano e ferimento della brava giornalista. Agguato o
malinteso?
LA PAROLA CHIAVE: MALINTESO
Critica della ragion dialettica I fautori della teoria
del complotto mostrano di avere una grande fiducia nella
razionalità della storia. Ogni effetto rimanderebbe per
loro direttamente ad una causa e, in ultima analisi, ad
un’intenzione perfettamente consapevole al suo autore.
Nulla accadrebbe senza che il gran burattinaio, da
dietro le quinte, tiri le fila del gioco. Anche quando
questa visione si colora di tinte apocalittiche,
continua ad essere implicitamente ottimista perché
concepisce la prassi umana come trasparente a se stessa.
Di diverso avviso era Jean Paul Sartre quando
s’interrogava sull’intelligibilità della storia umana.
L’idea chiave della sua 'Critica della ragion
dialettica', opera prolissa, geniale e spesso involuta
fino alla totale incomprensibilità, è che 'l’autentico
momento dell’azione storica', la legge del suo processo
dialettico, sia il malinteso. L’affermazione è in primo
luogo polemica nei confronti dei dottrinari marxisti
(siamo alla fine degli anni ‘50 in piena guerra fredda,
dopo i fatti tragici di Ungheria) per i quali la storia
segue un disegno preciso e aprioristico: è cioè
determinata univocamente dalla dialettica forze
produttive - rapporti di produzione. Sartre coglie
immediatamente l’aspetto idealistico di questa tesi. Non
importa che siano ora le condizioni materiali della
produzione, invece dello spirito, a guidare
razionalmente la storia. Ciò che conta è che per gli uni
come per gli altri, della 'fatticità' dell’umano, della
sua contingenza e della sua libertà 'situata', non ne
sia più nulla. La storia risponderebbe a 'intenzioni'
perfettamente trasparenti al filosofo hegeliano e/o al
partito comunista, che della storia sono il lucido
pilota.
La prassi cieca Una sorta di cecità della prassi è
invece per Sartre il fondamento della storia. L’uomo, in
quanto essere sociale, è il principale artefice della
propria azione, e in questo consiste la sua essenziale
libertà (contro Hegel e contro i dogmatici marxisti), ma
i frutti dell’azione non gli appartengono se non in modo
precario. L’opera uscita dalle mani dell’uomo prende
immediatamente a vivere di vita propria e, come una
specie di Moloch, assume valori, intenzioni, finalità,
che non erano previste all’inizio. L’eterogenesi dei
fini, il malinteso, è la molla del divenire. Il prodotto
finito non è insomma l’attuazione dell’intenzione
originaria, ma una sua radicale modificazione, che con
il progetto di partenza mantiene solo una vaga
somiglianza. La prassi, ogni prassi, è 'storica' proprio
nella misura in cui è una durata che crea qualcosa di
inizialmente imprevedibile, qualcosa in cui il suo
autore farà fatica a riconoscersi. Anzi, alla fine non
si riconoscerà affatto nella sua opera, giudicandola,
non a caso, l’opera demoniaca o provvidenziale di un
Altro (la provvidenza, lo Spirito, la lotta di classe
oppure il complotto ebraico ecc.). Accade così che i
protagonisti della Storia perdano ogni apparenza
'umana'. Divengono concetti totem che paiono dotati di
un’assoluta autonomia. Svolgono una funzione 'oggettiva'
che spetterà allo storico del futuro decifrare. 'Stalin, si dirà, ad esempio, doveva
modernizzare la Russia e
quindi ha proceduto all’industrializzazione forzata ecc.
ecc.'. La storia diventa un sillogismo. Le azioni degli
uomini si relazionano tra loro mediante connettivi
logici come rapporti d’inferenza. La libertà si
trasforma in necessità oggettiva e gli uomini si trovano
chiusi all’interno di una gabbia di acciaio dalla quale
non possono uscire.
Rimbalzi e ritorni di fiamma 'Ogni giorno ? scrive
ancora Sartre ? (la storia) viene fatta dalle nostre
mani come altra da quella che crediamo di fare e, per un
ritorno di fiamma, ci fa altri da quello che crediamo di
essere e divenire'. Spieghiamoci con un esempio.
Probabilmente nessuno voleva intenzionalmente uccidere
la giornalista italiana e il suo accompagnatore. Le
intenzione degli autori erano altre. Tuttavia le cose
sono andate in un certo (tragico) modo. Quel modo è però
ora il significato di quell’evento. Il malinteso ha
avuto luogo e ha generato un significato del tutto
imprevisto in partenza, con il quale adesso non è
possibile non fare i conti. Questo nuovo significato,
però, 'rimbalza indietro'. La storia ha una logica
retrospettiva. Gli sparatori e i loro mandanti divengono
infatti altri rispetto a quello che erano e a quello che
credevano di essere prima. L’opera (in questo caso,
l’omicidio), frutto come qualsiasi evento storico di un
malinteso, li ha infine rivelati a loro stessi e al
mondo come degli assassini di innocenti. Quel
significato, grazie all’ironia della storia, ora essi
'lo sono e non possono non esserlo'.
Rocco Ronchi
In questo numero di liberopensiero
la parola chiave è DIFFIDENZA
Si parla di:
- Spirito scientifico
- Regola cartesiana e regola monastica
- Il buon relativismo
- Il tesoro sepolto
IL FATTO
Fassino dichiara che la sinistra deve abbandonare le posizioni relativiste
Spirito scientifico Qual è, secondo Nietzsche, l’essenza
dell’Occidente? La parola-chiave dell’Occidente è
”filosofia”, che Nietzsche traduce nella formula
”volontà di verità”. La verità è un fuoco sacro che
suscita nel suo devoto fanatica ammirazione e
inflessibile spirito di sacrificio. La verità, come e
più della fede religiosa, pretende tutto da chi a lei si
consacra. Il suo integralismo non ha pari. Dall’uomo
della verità niente può infatti essere accettato come
dato, niente può essere supposto valido in sé, se prima
non è stato sottoposto dalla critica alla prova del
dubbio metodico. Il dubbio metodico, onore e vanto dello
spirito filosofico moderno, è il più astratto e
metafisico dei dubbi, giacché non dubita quando c’è
qualcosa di effettivamente dubbio al suo orizzonte, ma
dubita anche in assenza di un dubbio reale, dubita per
dubitare, dubita perfino di quanto nella vita quotidiana
si presenta con i tratti della massima ovvietà. Se il
nome di Cartesio è quasi divenuto una metonimia dello
spirito filosofico moderno è per quella sua risoluta
decisione di non fermarsi mai nella via del dubbio,
sebbene tale ascetico esercizio rischiasse di
trascinarlo, come egli scrive, nelle “acque
profondissime” della disperazione.
Regola cartesiana e regole monastiche “Non saprei oggi
concedere troppo alla mia diffidenza”. Questa sentenza
di Cartesio è la parola d’ordine dello spirito
filosofico che caratterizza “noi, buoni europei”
(l’espressione è di Nietzsche). Andrebbero scolpite
sulla porta d’ingresso di una qualsiasi università
occidentale. La fede incondizionata nella verità
caratteristica dell’occidentale si manifesta nella
modalità del sospetto universale. Un europeo virtuoso è
un europeo che non dismette mai questo atteggiamento di
esasperata criticità, anzi lo approfondisce, lo rinnova,
lo cova, proprio come certi mistici fanno con le loro
piaghe, segno di evidente santità. La scienza è un
monastero, la sua regola è la diffidenza.
Il buon relativismo A fine corsa troviamo allora il
relativismo come espressione tipica dello spirito
europeo? Sì e No. Sì perché il sospetto eletto a metodo
e a suprema regola di una vita che si voglia
”scientifica” non poteva non investire la stessa idea di
verità oggettiva, universale e necessaria. La
”Genealogia della morale” di Nietzsche ci racconta
proprio questa storia paradossale nella quale l’amore
assoluto per la verità, alla fine, mette in questione,
per amore del vero, la stessa possibilità di un vero!
Questo relativismo è generato dal più venerando (secondo
Kant) degli interdetti veterotestamentari, quello che
comanda, senza possibilità di eccezione, la distruzione
degli idoli, con particolare riguardo a quelli che ci
sono più cari, poiché, celati dalla loro maestosa ombra,
se ne stanno invisibili i nostri più sordidi ed
egoistici interessi. Per questo genere di relativista le
cosiddette verità oggettive puzzano di sacrestia e hanno
perso l’aroma sacro della verità. Con buona pace di
Fassino, la diffidenza non si arresta alle soglie di
casa e non risparmia i “valori” dell’Occidente.
Il tesoro sepolto No, se relativismo vuol dire avere la
coscienza tranquilla nella convinzione che al mondo non
c’è nulla di vero e che, dunque, tutto, se si ha la
”forza” di farlo, è permesso (come nello “stato di
natura” di Hobbes e Spinoza, anche nel mondo del
relativista a decidere è infatti sempre la potenza di
fuoco). In quella passione squisitamente scientifica che
arriva a mettere in questione l’idea stessa di
oggettività del vero, in quella diffidenza eletta a
regola, bisogna decifrare una passione per la verità,
una domanda di assoluto, che, al pari della vivente
fede, non conosce pace di sorta. Spesso i contemporanei
non la scorgono e nell’indubbio nichilismo del pensiero
contemporaneo percepiscono soltanto la resa, il
relativismo del “niente è vero”. Ma quella diffidenza
estrema, quella diffidenza esasperata e instancabile,
contiene un tesoro. Agostino prima, Cartesio poi,
l’avevano perfettamente compreso. Chi dubita di tutto,
perfino dell’oggettività, ha infatti un rapporto
originario con la verità (se non altro come “criterio”
che gli permette di dubitare di tutto) che invece manca
a chi i conti con la verità crede di averli già fatti.
Questi ha in mano soltanto un idolo, da onorare con il
sangue di qualche sacrificale vittima, quello si
rapporta ad un assoluto la cui esigenza lo obbliga
moralmente a distruggere tutti gli idoli e i loro altari
di sangue.
Rocco Ronchi
IL FATTO
Eletto il nuovo papa. Sarà un tradizionalista?
PAROLA CHIAVE. TRADIZIONALISMO
Chi è stupido?
Jack Goody, da buon antropologo, ha speso molti anni della sua vita in Africa,
presso le popolazioni Lo Dagaa che vivono nell'attuale Ghana settentrionale. La sua
attenzione era rivolta in particolare alla recitazione del Bagre, una specie d'epopea
che raccoglieva i miti fondativi di quella lontana comunità. La sua attrezzatura
era quella "classica" dell'antropologo che lavora sul campo. Non poteva mancare
un piccolo registratore che doveva catturare sul nascere quella recitazione, la
cui origine si perdeva nella notte dei tempi. La sua legittima aspirazione era
quella di portarsi a casa una versione "autentica" del mito, e di studiare in loco
i processi della sua trasmissione e del suo apprendimento. Da buon occidentale,
Goody voleva la "verità" sul Bagre. Per un occidentale, verità vuol dire oggettività,
identità, invarianza. Vero è l'Uno. Ben presto Goody dovette arrendersi all'evidenza
che il Bagre "come tale" non esisteva. Oppure che era ovunque. C'erano, infatti,
tante versioni del Bagre, alcune assai dissimili, ma la cosa, per lui e per noi più
stupefacente, era che lo stesso "informatore" che qualche tempo addietro aveva
impresso sulla bobina una certa versione del mito, messo di fronte alla nuova
versione, appena recitata, continuasse ostinatamente a riconoscerla come la
stessa di un tempo, "in tutto e per tutto uguale", sebbene la variazione, anche
macroscopica, fosse impietosamente confermata dall'apparecchiatura meccanica
con cui si era provveduto a registrarle. Stupidità del "primitivo"? Oppure stupidità
del registratore e della "nostra" idea di verità come identità? Goody opterà per la
seconda ipotesi.
Reazionari, scettici e rivoluzionari
Vladimir Lossky (1903-1958), figlio di uno dei maggiori filosofi russi, è stato tra i
più dotti studiosi dell'ortodossia e della teologia mistica e si è prodigato più di ogni
altro per favorire il dialogo ecumenico. Niente nella nostra storia spirituale è più
codificato di quanto si raccoglie nel corpus delle Sacre Scritture, eppure, osserva
Lossky in un magistrale saggio ("La Tradizione e le tradizioni"), al di fuori della
tradizione anche la Scrittura è lettera morta. La tradizione, egli spiega, è l'opposto
di quello che, in modo unanime, tanto i suoi più ingenui apologeti
(i "tradizionalisti"), quanto i suoi avversari animati da spirito scientifico e critico,
quanto, infine, i rivoluzionari che si battono per un ritorno all'origine (Lutero, ad
esempio), reputano che essa sia. Per i reazionari, per gli scettici e per i
rivoluzionari, la tradizione è la trasmissione ("traditio" da "trado", trasmetto) di una
verità immutabile. Il reazionario "tradizionalista" difende allora a spada tratta
questa origine minacciata dal "moderno". Lo scettico denuncia nella tradizione una
costruzione ad hoc priva di valore di verità, non "originale". Il rivoluzionario nel
tradizionalismo denuncia invece il tradimento (altro significato di "trado")
dell'origine. Il reazionario, lo scettico e il rivoluzionario, hanno la stessa idea di
verità che animava il nostro antropologo culturale. A tutti loro il cristiano Lossky
ribatte che "la Tradizione, nella sua nozione prima, non è il contenuto rivelato, ma
il modo unico di ricevere la rivelazione", non è "ciò che" si trasmette, ma la "luce"
nella quale ciò che è trasmesso e raccolto ed elaborato dalla comunità, non è un
contenuto o una somma di contenuti, ma una forma. La tradizione non è
trasmissione di una moneta da mano in mano. La tradizione vivente è l'attualità
vivente della rivelazione vivente, il "qui e ora" di un origine eterna che si rinnova
costantemente e che rinasce identica e diversa ad ogni esecuzione.
Divino jazz
Tra le forme musicali quella più "tradizionale", nel senso che a quest'espressione
danno i Lo Dagaa del Dogon e l'illustre teologo russo, è allora il jazz, musica
dell'improvvisazione ma non improvvisata. La tradizione nel jazz la si fa suonando
il jazz. Ogni esecuzione permette di accedere da un punto qualsiasi alla verità
del jazz, la quale sussiste sempre uguale e sempre inaccessibile al cuore di ogni
performance riuscita. Platone aveva un'idea jazzistica della tradizione filosofica
quando denunciava i limiti della scrittura che trasforma in cosa morta ciò che è
vivo e fluente. E che altro è la predicazione, la parola che, in contesti e situazioni
sempre diversi, si fa parola di vita e di speranza, se non questo jazz dell'eterno,
questo pulsare dell'origine nel corpo (vivente) della comunità?
Rocco Ronchi
La parola chiave è DOPING
Si parla di:
- Tempeste d'acciaio
- La fabbrica assoluta
- La bellezza secondo la Riefensthal
- Stress
IL FATTO
Lo "scandalo" della flebo di Cannavaro
LA PAROLA CHIAVE: DOPING
Tempeste d'acciaio
Ernst Jünger era tornato dai campi di sterminio della prima guerra mondiale con
la stessa eccitata consapevolezza di chi, durante una prova estrema, ha avuto
una "rivelazione". La sua testimonianza non fu infatti quella del reduce, ma quella
dell'illuminato. Il registro stilistico della sua scrittura fu, da quel momento, quello
della profezia. Nelle tempeste d'acciaio del primo conflitto mondiale l'ufficiale
Jünger "aveva visto" (histor). Aveva visto l'avvento di qualcosa di inaudito, che, a
suo giudizio, avrebbe dominato l'umanità nell'epoca futura, mutando radicalmente e
irreversibilmente la natura di tutti i rapporti umani. "Con un senso di sgomento e di
ebbrezza", vale a dire con quel "piacere negativo" che, secondo Kant, caratterizza
l'esperienza del "sublime", Jünger, nelle trincee insanguinate, aveva visto "che qui
non c'è un solo un atomo che non sia al lavoro, e che questo processo delirante è,
in profondità, il nostro destino"
La fabbrica assoluta
Niente, insomma, è ormai lasciato essere se non come risorsa (Bestand) che deve
essere messa a disposizione, impiegata al massimo delle sue potenzialità e infine
consumata e abbandonata. I campi di morte del primo conflitto ne erano la prova
irrefutabile. Con i loro suoni assordanti, con le loro innaturali luci che trasformavano
la notte in giorno, con l'incomprensibilità di quei movimenti di massa, le trincee in
fiamme non "assomigliavano" alla fabbrica, erano la fabbrica moderna con la sua
organizzazione tayloristica del lavoro trasportata al fronte. L'umanità in trincea
era diventata definitivamente materia prima, risorsa disponibile da sfruttare fino
all'esaurimento, e la vittoria era assicurata a chi, tra i contendenti, avrebbe saputo
produrre industrialmente più cadaveri. La guerra moderna è "battaglia di materiali"
(Jünger). La fabbrica aveva inghiottito tutto il mondo e la guerra, per parafrasare,
la famosa sentenza di Clausewitz, non ne era che la continuazione con altri mezzi.
La bellezza secondo la Riefensthal
Il corpo mobilitato è un corpo sofferente, in pace come in guerra. Se, nel caso della
guerra, la cosa va ovviamente da sé, nel caso della pace la sofferenza del corpo è
data dall'insieme di pratiche cui esso deve comunque sottomettersi per mantenere
e incrementare la sua efficienza: nel lavoro, nella vita quotidiana, nello sport,
nelle relazioni affettive. Il corpo sotto stress da performance è il corpo moderno.
È il corpo-risorsa, il corpo usurato fino all'esaurimento delle sue possibilità. È il
corpo dell'atleta o del soldato, il corpo del fotomodello o della mannequin, un corpo
sottomesso, controllato, disciplinato, sottoposto alla prova iniziatica del dolore.
È quel corpo dolente e trionfante che Leni Riefensthal ha immortalato nel suo
cinema, sia quando ha filmato la prestanza dell'atleta che tenta il record (Olympia),
sia quando ha ripreso impavidi giovani nazisti che si lavavano nella fredda acqua
dell'accampamento comune (Il trionfo della Volontà), sia quando, infine, ha rivolto
la sua attenzione alla lotta dei guerrieri Nuba (L'ultimo dei Nuba). Anche il suo
cinema prenazista, quello che come sfondo aveva le alpi e come protagonisti
intrepidi scalatori, aveva dopotutto, come ha notato acutamente Susan Sontag, lo
stesso tema. L'idea di bellezza moderna trova infatti nel fascismo la sua compiuta
espressione. "L'estetica fascista”, scrive la Sontag, nasce e giustifica situazioni
di controllo, di comportamento sottomesso, di sforzo eccessivo, di sopportazione
del dolore: sanziona due condizioni apparentemente contraddittorie, l'egomania e
l'asservimento"
Stress
L'inglese to stress denomina l'atto del sottoporre un oggetto materiale
a sollecitazione per verificarne la resistenza. Con il suo valore "medico"
e "psicologico" (come "stato di tensione aspecifica della materia vivente") fu
introdotto nel linguaggio scientifico dal medico Hans Selye (1907-1982) in una
comunicazione apparsa in "Nature" nel 1936. Da quel momento ha definito la
situazione del corpo vivente "moderno", di quel corpo, cioè, che deve rispondere
agli imperativi del "principio di prestazione". E' un corpo che non può riposare, un
corpo che ha bisogno di continui bombardamenti di stimoli per sentirsi “vivo". Per
questo corpo il doping è una necessità naturale, come l'aria o il cibo.
Rocco Ronchi
In questo numero di liberopensiero
la parola chiave è PERSONA
Si parla di:
- Cambiare la domanda
- Il potere delle vetrine
- Gli uomini e le cose
IL FATTO
Referendum sulla fecondazione assistita. Gli embrioni sono persone?
LA PAROLA CHIAVE: PERSONA
Cambiare la domanda
Sembra del tutto ovvio che la domanda dalla quale si deve partire sia quella che
chiede se l'embrione debba o non debba essere concepito come una persona e se,
quindi, i suoi diritti siano o non siano equiparabili a quelli della persona. Ma se è
questa la domanda, allora la pratica è già chiusa prima di essere aperta. Perché,
dopotutto, vale anche in questo caso il principio universale "in dubio pro reo": se
l'embrione "può" infatti essere una persona tanto meglio una rigida legislazione
che impedisca la possibilità di quello che, a tutti gli effetti, potrebbe essere
considerato un omicidio. Come sempre, la vera questione concerne la correttezza
della domanda. Nella querelle sulla fecondazione assistita, a quasi nessuno viene in
ment di muovere dalla domanda inversa, una domanda, per altro, legittimamente
implicata nella prima: la "persona", chiediamo, è un embrione? Questa domanda ha
una risposta obbligata. Le persone non sono embrioni. Non hanno nessun rapporto
con quell'oggetto te
orico (l'embrione) che una pratica scientifica, medica e tecnologica di
straordinaria raffinatezza ha portato letteralmente alla luce (l'embrione, oggi,
lo possiamo "vedere" agitarsi sullo schermo di un computer). Che cosa sia
una "persona" noi lo sappiamo benissimo, poiché noi sempre la siamo e non
possiamo non esserlo. La "persona", direbbero i filosofi, è una "evidenza
fenomenologica" irrefutabile.
Il potere delle vetrine
Secondo l'origine di questa parola, "persona" è "maschera". "Persona" è ciò che lo
sguardo dell'Altro fa di noi. L'Altro in questione non è nessun Altro in particolare,
ma quelli Altro Generalizzato (l'espressione appartiene al filosofo G.H.Mead)
attraverso il cui severo sguardo ci giudichiamo, quando, ad esempio, gettiamo
un'occhiata alla vetrina per vedere se "siamo a posto" per l'appuntamento che
ci attende. Le scienze umane ci hanno efficacemente descritto come la persona
sia letteralmente "fabbricata" dallo sguardo dell'Altro. Non solo nelle culture
cosiddette "tradizionali", ruolo, status e riti d'iniziazione definiscono pubblicamente
la "persona" e la sua storia, ma anche in contesti altamente secolarizzati la
persona continua ad essere la maschera indossata da un attore in scena (per
Ervin Goffman la "vita quotidiana" è "rappresentazione", "teatro"). Tuttavia la
persona che noi sempre siamo non si risolve solo nel prodotto delle dinamiche
sociali e di acculturazione. La persona è anche altro, è sempre "altro" da ciò che le
condizioni fanno di noi, anzi in questa differenza trova la sua ultima e insuperabile
essenza. La persona è maschera, ma la maschera noi la siamo sempre "ad una
certa distanza". "Io" non sono quella "cosa" che vedo specchiata nella vetrina.
C'è sempre uno scarto tra ciò che le condizioni fanno di noi e ciò che noi facciamo
delle condizioni che ci fanno quali siamo. Questo scarto è la "libertà", è l'essenza
della "persona".
Gli uomini e le cose
Come una figura per essere percettibile come tale implica uno sfondo dal quale
emergere e sul quale spiccare, così la persona, per "esistere", implica un rapporto
con un passato dal quale essa dipende, ma rispetto al quale essa è sempre
anche "altra", come "in rilievo". Questa differenza impercettibile, che annulla
ogni determinismo, è la sua specifica libertà. Le persone che noi siamo subiscono
il passato, ma si aprono ad un futuro per definizione indeterminato. Senza
questo passato, che irrigidisce il nostro volto nei tratti della maschera rituale, e
senza un futuro, inteso come possibilità di sfuggire a quanto il passato fa di noi,
non c'è "persona". La persona è sempre tutta in quest'intervallo (il "presente
vivente") tra quanto è già nato e preme alle nostre spalle come una massa oscura
e quanto, non essendo ancora compiuto, si apre come imprecisata possibilità
davanti a noi (nella modalità della paura, dell'angoscia o della speranza). Al di
fuori di questa "durata creatrice" (l'espressione è di Bergson) non c'è persona.
Fuori ci sono solo le "cose", le quali, spiegava Martin Heidegger con vivo gusto
del paradosso, "sono" ma non esistono, "sono" ma non "ci" sono, vale a dire che
non se ne stanno, come noi, sospese nel vuoto della loro libertà. L'errore capitale
è allora quello di pensare la persona sul modello della cosa. Chi non percepisce
l'incolmabile differenza di natura tra una donna vivente qui e ora di fronte a noi,
con il suo passato che le pesa e con il suo futuro di speranza-timore, ed un oggetto
teorico come l'embrione, è vittima della stessa orribile cecità che da sempre affètta
l'occhio del tiranno, per il quale non ci sono mai persone alle quali rivolgersi, ma
solo "proprietà" da organizzare, dirigere e amministrare.
Rocco Ronchi
In questo numero di liberopensiero
la parola chiave è CRISTIANO
IL FATTO
L’Italia - si chiede la stampa- è un paese "clericale"?
***
I comunisti mangiano i bambini
No, non è il totalitarismo delle "teologie politiche" novecentesche quello che è profetizzato
da Dostoevskij nella leggenda del Grande Inquisitore. Il comunismo, semmai, è
rappresentato dalla nuova "tremenda torre di Babele" che uomini deboli e maldestri hanno
cercato, senza riuscirci, di erigere, per fondare una felicità collettiva su basi esclusivamente
umane. Tentativo fallimentare, che scade nell’anarchia (nell’antropofagia!), per porre
rimedio alla quale arriva proprio Lui, l’Inquisitore, il quale porta a termine la torre dando ad
essa un nuovo e sicuro triplice fondamento: il "miracolo, il mistero, l’autorità". Il quadretto
che di questa umanità finalmente pacificata e quieta fa il leggendario vecchio
corrisponde piuttosto alle aspirazioni dei nostri moderni predicatori mediatici.
La felicità di cui gli uomini allora godranno sarà infatti una "soave felicità bambinesca"
da "esseri deboli, quali costituzionalmente essi sono". "Essi, racconta l’Inquisitore, si
faranno timidi e s’avvezzeranno a girare gli occhi a noi e a stringersi a noi tutti spaventati,
come pulcini alla chioccia (...) i loro occhi diverranno facili alle lacrime (...) ma con
altrettanto facilità, ad un nostro cenno, passeranno all’allegria e al riso, alla più limpida
gioia, e alle beate canzoncine infantili. Sì, noi li obbligheremo a lavorare, ma nelle ore libere
dal lavoro daremo alla loro vita un assetto da gioco infantile, con canzoni da bambini, cosi
danze innocenti. Oh, noi permetteremo loro anche il peccato: sono così fragili e impotenti; e
loro ci vorranno bene come bambini, per il fatto che noi permetteremo loro di peccare. Noi
diremo loro che ogni peccato sarà rimesso, se compiuto con il permesso nostro".
L'alleato segreto
Che razza di assurda storia sta raccontando il disincantato Ivan Karamazov al fratellino,
in odore di santità, Alioscia? La premessa è chiara: tra i pesi che l’uomo deve sopportare
nella sua vita mortale nessuno è così intollerabile come la libertà, ergo "ama" veramente
gli uomini chi li libera da questo fardello, donando loro in cambio la spensierata felicità del
gregge. "Appunto questa esigenza di una genuflessione in comune - argomenta infatti il
terribile vecchio - è il più grande tormento di ogni uomo preso a sé e dell’umanità nel suo
insieme fin dal principio dei secoli". L’Inquisitore libera dalla libertà divenendo così,
nello stesso tempo, il benefattore di un’umanità perpetuamente minorenne e il
consapevole traditore della parola di Cristo, nel cui nome, beffardamente, dice di agire
Dostoevskij non dubita che il nome Cristo sia sinonimo di libertà illimitata, radicale, al limite
della follia. Per questo l’Inquisitore, che davanti al popolo sottomesso ha sempre in bocca il
nome del Signore, nel buio della prigione in cui l’ha rinchiuso, confessa fieramente a Cristo
che "noi non siamo con Te, siamo con Lui, ecco il nostro segreto".
Mangiare insetti
La specificità dell’Inquisitore dostoevskiano non si esaurisce però nella consapevolezza della
debolezza degli uomini, "incompiute creature sperimentali, create per beffa". I filosofi, tutto
questo, lo sanno da tempo immemorabile. Da Platone ad Agostino, da Hobbes a Kant, non
si sono stancati di ripetere che la libertà è roba per pochi e che le masse non filosofano. A
caratterizzare l’Inquisitore dostoevskiano è piuttosto il fatto che questa diabolica alleanza
con "il terribile e ingegnoso spirito, con lo spirito dell’autodistruzione e del non essere",
sia siglata nel segno del "religioso". La potenza persuasiva dell’Inquisitore discende dagli
strumenti canonici di ogni sistema religioso: miracolo, mistero, autorità. Una volta liberati
dalla libertà, agli uomini sarà insegnato "che non la libera decisione dei loro cuori
è ciò che importa, ma il mistero, al quale essi hanno l’obbligo di assoggettarsi
ciecamente". In queste pagine, il più cristiano tra gli scrittori individua così nella
dimensione "religiosa" l’ambito specifico della seduzione diabolica. Ne deriva un’immagine
del cristiano assai dissimile da quella zuccherosa e ultraconformista che è incessantemente
dispensata dai media. La "religiosità" è infatti, agli occhi di Dostoevskij, la prova più dura
che il cristiano deve sopportare, la tentazione ultima alla quale deve sottrarsi, anche a costo
di rimanere per anni abbandonato nel deserto a mangiare locuste. In questa sua solitudine
sarà però confortato dall’immagine del Cristo, che in quel deserto l’ha preceduto trionfando
sulla diabolica triplice tentazione del miracolo, del mistero e dell’autorità.
Rocco Ronchi
IL FATTO
Perché il pensiero laico sembra non avere più strumenti per leggere la contemporaneità?
LA PAROLA CHIAVE: MODERNO
Quattro secoli in dieci righe
Siccome il paese era devastato da una guerra civile, che rendeva insicura la vita di tutti,
gli uomini, resi lucidi dalla paura, fecero una scelta "radicale". Se era la pretesa alla verità
la radice del conflitto endemico - ogni setta rivendicava infatti per sé quella magica parola
- l'unica soluzione per rendere possibile una convivenza non sanguinosa poteva consistere
soltanto nel tagliare via quella radice. Nessuno avrebbe avuto più diritto di parlare
pubblicamente in nome della verità, ma ciascuno avrebbe potuto continuare ad onorarla
nel foro privato della propria coscienza. La "cosa pubblica", insomma, si faceva "laica"
e "tollerante" delle diverse opzioni religiose e filosofiche. La verità che aveva agitato e
tormentato gli animi sanguinari degli uomini del passato scadeva ora, sul piano pubblico,
ad "opinione", in regolamentato e pacifico conflitto con altre "opinioni". Sul piano privato
manteneva la stessa tirannica esigenza di un tempo, ma il suo integralismo riguarda ormai
soltanto una coscienza solitaria e silenziosa alle prese con i suoi dubbi, le sue angosce, il
suo senso individuale d'insufficienza. Laicizzazione e secolarizzazione dello spazio politico,
da un lato, misticismo ed un'ipertrofica crescita della coscienza "morale", non solo non sono
in antitesi, ma crescono e si sviluppano in modo direttamente proporzionale. Questa storia
è, in breve, la storia della "modernità". È la nostra storia. A scriverla sono stati grandi geni
del pensiero filosofico, politico e religioso, ai quali non possiamo non guardare con rispetto e
sconfinata ammirazione. Purtroppo questa storia è finita.
***
Un laico filosofo fascista
La modernità non è stata un tempo di pace. Essa, tuttavia, era persuasa di aver fornito
l'umanità degli strumenti necessari per renderla possibile (basta leggere, a questo
proposito, il Kant di "Per la pace perpetua"). Per almeno quattro secoli, l'incontestabile
assenza di pace pareva infatti doversi imputare solo ad un utilizzo difettoso o parziale
di quegli straordinari strumenti intellettuali. La guerra, si pensava, era da ascriversi
a "ricadute" nell'intolleranza e nel fanatismo. Poi è venuta l'epoca dei totalitarismi a
scuotere tanta liberale fiducia. Un filosofo sicuramente "compromesso" come Giovanni
Gentile spiegava così la genesi dell'italianissimo fascismo: una comunità, egli scriveva,
non può vivere senza un concetto dell'Assoluto; una comunità non può accontentarsi
di "opinioni" senza fondamento e di una "coscienza morale" solo individuale. L'uomo non
può spartirsi in "citoyen" e uomo privato. Fatta la diagnosi bisognava però passare alla
terapia. Se la teologia, argomentava Gentile, non è più in grado di offrire alla comunità
questo Assoluto, spetta allora allo Stato sostituirsi ad essa. Giustamente i suoi allievi
cattolici lo accusarono di "statolatria". Da figlio della migliore cultura laica italiana, quale
egli era e quale egli sempre rimase, Gentile, per trovare un succedaneo dell'Assoluto
teologico, poteva solo volgersi alla più alta creazione del pensiero laico, allo Stato appunto.
Ma ciò che venerava come divino era soltanto un idolo costruito da mano umana, era anzi
il prodotto "umano" per eccellenza. Il biblico "Leviatano" di Hobbes non era forse proprio
questo irresistibile mostro "umano" fatto dalla concorde rinuncia alla liberta di milioni di
uomini associati? Non vi erano insomma le basi perché questo idolo potesse durare più di un
ventennio. Nemmeno Gentile sopravvisse alla sua catastrofe.
***
Post-modernismo
Sopravvivrà l'umanità al fallimento della soluzione "moderna", e cioè laica e tollerante,
del conflitto? I segni per ora sono tutti negativi. Nondimeno, è assolutamente chiaro quali
siano i termini del problema che l'umanità associata deve affrontare, se non altro sul piano
speculativo, per potere sperare ancora in un futuro. Da un lato, esse deve prendere atto
della necessità per la comunità di trovare un fondamento nell'Assoluto, la verità essendo
per l'uomo una specie di elemento naturale, privato del quale questi rischia di spegnersi
dopo una lunga agonia. Le "opinioni" non saziano e la "tolleranza" è il semplice rinvio sine
die della resa dei conti finali. Dall'altro l'Assoluto richiesto non può avere la forma del
feticcio ideologico, dell'oggettività astratta, dell'imperativo etico, non può essere niente che
sia "dato" e che possa funzionare come strumento di esclusione e di controllo della l ibera
coscienza individuale (che altro è la violenta illusione teocon?). La domanda, dopotutto,
è semplice e come tutte le domande semplici è paralizzante: come abitare liberamente la
Verità?
Rocco Ronchi
IL FATTO
L'Occidente implode sotto le bombe
LA PAROLA CHIAVE: NEMICO
Il soldato ansioso e l'oracolo dispettoso
Quando il muro venne giù e il mondo fu unificato nel segno di un solo pensiero, in molti
dichiararono che era terminato il tempo dei nemici. Finito il nemico finita la storia,
perché dove viene meno il conflitto amministrazione e gestione dell'ordine pubblico (le
operazioni di "polizia internazionale") subentrano alla politica. Mai previsione si è rivelata,
ad un tempo, più azzeccata e più sbagliata. Come nel caso dell'oracolo, che al soldato
ansioso di conoscere il suo destino in guerra, rispondeva "ibis redibis non morieris"
(letteralmente "andrai, tornerai, non morirai"), anche il detto "il nemico non c'è più" si
presta infatti ad una duplice interpretazione. Nel caso del soldato è infatti sufficiente, come
permette la grammatica latina, riferire quel "non" al "redibis" perché un felice augurio si
trasformi in un terribile annuncio ("andrai, non tornerai, morirai"). Nel nostro caso, il venir
meno del nemico ha assun to un inatteso significato. Le bombe che scoppiano ovunque
(e che continueranno tranquillamente a scoppiare intorno a noi, come nel profetico film
di Terry Gillian "Brazil") ne sono una triste conferma. Detto in breve e con una formula
volutamente ad effetto: il nemico è sparito perché ha lasciato il terreno della fisica per
trasformarsi in un'idea platonica.
***
La sede del terrorismo internazionale
Un'idea per Platone è l'essere massimamente oggettivo, una realtà più reale di qualsiasi
altra realtà per la sua immaterialità, che la sottrae per principio al ciclo delle nascite e
delle morti. La sparizione del nemico è così la sua avvenuta smaterializzazione e la sua
acquisita inafferrabilità. Esso diviene illocalizzabile per principio, nello stesso modo in cui
l'idea platonica del cavallo non coincide con nessuno dei cavalli reali e nemmeno con la loro
ipotetica somma. Posso puntare il dito ovunque sulla cartina geografica, ma, dopo la fine
della politica e della storia, non troverò più "il" nemico. M'imbatterò in delle sue repliche
sbiadite, in delle copie inadeguate che "partecipano" dell'idea del nemico, ma che non
sono "il" nemico. E come posso bruciare tutti i cavalli senza in alcun modo togliere nulla
all'essenza "cavallo", che rimane identica ed immutabile, così posso bruciare, come stia
mo facendo, afgani, iracheni, palestinesi ecc. senza intaccare in nulla il mio avversario. Il
nemico, quello "vero", di questa guerra al terrore ormai se la ride perché ha preso alloggio
definitivamente nell'iperuranio.
***
L'intrattabile
In un altro profetico film ("Canadian Bacon"), il simpatico Michael Moore, s'inventava una
strampalata guerra Usa-Canada, scaturita dalla necessità per l'orco militare americano
di trovare comunque un nemico con cui combattere "fisicamente". Lo spirito empirista
dell'americano medio (non dei suoi massimi filosofi, inclini invece all'idealismo...) non riesce
infatti ad elevarsi alle altezze della metafisica. Del resto, se si ha la forza di mantenere un
poco di lucidità, appare veramente comica la sproporzione esistente tra la dismisura del
nemico e le sue identificazioni sensibili (pastori afgani, immigrati disperati, abitanti dei
campi-profughi). Lo stesso nome con cui convenzionalmente lo si indica testimonia soltanto
dell'impotenza a localizzarlo. Il "terrorista", con il quale si afferma con patetico orgoglio
di "non voler trattare", non chiede infatti nessuna "trattativa". Il suo nome è nessuno e con
nessuno non si può trattare o non trattare.
***
Land of the dead
Dovendolo rappresentare, il cinema non ha altra risorsa che lo zombie. In quella celebre
immagine c'è più comprensione della natura metafisica del nemico di quanta ve ne sia nelle
raffinate analisi politologiche degli esperti. Lo zombie infatti è già morto, quindi non lo si
può uccidere. La morte, vale a dire la minaccia estrema che si può far pendere su di un
vivente, gli è del tutto indifferente. La sua potenza nasce proprio da questa sua estraneità
di principio alla vita. Lo zombie, poi, si riproduce come un virus. Ai tortuosi e insicuri
sentieri della persuasione e dell'argomentazione sostituisce l'immediatezza del contagio
per contatto. L'epidemia è la sua retorica. Del "nemico" smaterializzato si deve allora dire
ciò che certi saggi pellerossa dicevano delle immagini di giaguari dipinte in fondo alle loro
grotte. Esse incutevano loro più timore dei giaguari reali della pianura perché quelli p
ossono essere uccisi, mentre questi sono per principio inafferrabili. I giaguari reali "ci" sono,
il giaguaro dipinto "non c'è". Ma ciò che non c'è, insegna Platone, è infinitamente più reale
di ciò che essendoci oscilla ambiguamente tra la presenza e l'assenza.
A cura di Rocco Ronchi
IL FATTO
Le cronache recenti hanno registrato, presso alcuni siti pornografici americani, un immondo
scambio di foto di prigionieri torturati con immagini oscene.
***
LA PAROLA CHIAVE: VERITA'
Il ventre di Venere
La verità non tollera veli. Il suo solo abbigliamento è la più completa nudità. Nessuno
lo discute, nemmeno la mente più bigotta. Il problema però concerne la soglia a partire
dalla quale qualcosa può darsi come una perfetta nudità. Il corpo nudo di una femmina
incantevole sdraiata lascivamente su di un lenzuolo di seta può metaforizzare la verità?
Non per un prete, certamente, che vi scorgerebbe la più mondana delle tentazioni. La vera
verità non è quell'incarnato degno di un Tiziano, ma il suo rovescio: il dedalo orribile di
viscere, sangue e umori che, invisibile all'occhio dell'amante appassionato, sarà invece reso
palese dalla putrefazione del cadavere. Ecco, grida un'indignata voce dal pulpito, che cosa
veramente tanto amano gli uomini! L'occhio del predicatore incrocia qui quello razionale
del medico. Anche per la scienza profana, quel corpo incantato è inganno. Al museo
della Specola a Firenze è possibile contemplare la più nuda delle Veneri immaginate
dall'arte occidentale. È la celebre statua policroma in cera di Clemente Susini (1781). Un
collier di perle nasconde il meccanismo che la trasforma in un'impietosa tavola anatomica
tridimensionale a disposizione dello sguardo avido degli apprendisti medici e sezionatori
di cadaveri. Gli storici ci raccontano che "per la confezione di una sola figura di cera di
questo genere, occorrevano almeno duecento cadaveri del vicino ospedale di Santa Maria
Nuova" (H.Belting). Gli organi interni che "decoravano" la venere erano infatti prodotti con
la tecnica del calco e non si disponeva allora di tecniche di conservazione adeguate.
Onan e la pittura veneziana
L'ipotesi più terribile a proposito della nudità della verità è stata formulata da Nietzsche
ed è stata messa in scena nella scena finale di Apocalypse Now di Coppola. Quella verità
che filosofi e scienziati onorano e perseguono al prezzo di inauditi sacrifici, quella verità
per cui si può anche morire (Socrate!), potrebbe essere nient'altro che il puro orrore: un
brulicare insensato di vermi. Da questa ipotesi non può allora essere tratta che una sola
conseguenza. Nietzsche, più o meno, la espone nei seguenti termini: onorate gli artisti, che
creano una realtà illusoria di bellezza (ancora l'incarnato del Tiziano, che, secondo alcune
testimonianze dell'epoca, era in grado di indurre perfino in onanistiche tentazioni) e fuggite
i filosofi. La profondità rende pazzi, la superficie invece salva (momentaneamente).
Non mettete insomma la mano in quel collier di perle stregato. Non guardate oltre il velo,
perché così facendo ripetereste l'errore di quel re greco ricco e felice che sfidò il Sileno,
funzionario del dio, perché gli rivelasse "che cosa è veramente bene per l'uomo". E la
risposta fu la "nuda verità": meglio non nascere e se nati subito morire. Giocasta non si era
espressa diversamente con il suo amato Edipo, il quale, superbamente, credeva di poter
sopportare la nuda verità circa la sua origine.
Cavalli a Torino
Ogni grande filosofo ha rischiato di diventare pazzo. Georges Bataille era solito ripeterlo
citando il caso di Hegel, che la leggenda narra assai prossimo alla catastrofe mentale
mentre scriveva la "Fenomenologia dello Spirito". Ed il caso di Nietzsche, che abbraccia
un cavallo bastonato a Torino prima di sprofondare definitivamente nel delirio, è perfino
troppo noto per essere ancora rammentato. Eppure la tenerezza disperata di quell'abbraccio
al vecchio cavallo malconcio qualcosa ancora ci dice sulla nuda verità. L'ultima parola non
è, forse, quella di Kurz moribondo. Il pullulare dei vermi è certamente la verità "obiettiva".
È la verità inaggirabile del sapere. Ma l'obiettività dello sguardo che mette a nudo, fino
all'intollerabile, non è ancora tutta la verità. C'è anche quell'abbraccio impotente. Quella
carezza va oltre l'intollerabile, che per altro vede con implacabile precisione. Non è un
illusorio velo apollineo gettato sul male. Non è arte, ma azione. Inutile, forse, se misurata
con il metro dell'efficacia storica, ma segno di un'appartenenza (momentanea) ad un
altro ordine, nel quale i cavalli sono esentati dall'umana barbarie e le donne lascivamente
sdraiate su drappi vellutati sono eternamente salve dai guasti del tempo.
Rocco Ronchi
CREUZA DE MA
CREUZA DE MÄ (1)
Umbre de muri muri de mainé
dunde ne vegnì duve l'è ch'ané
da 'n scitu duve a l'ûn-a a se mustra nûa
e a neutte a n'à puntou u cutellu ä gua
e a muntä l'àse gh'é restou Diu
u Diàu l'é in çë e u s'è gh'è faetu u nìu
ne sciurtìmmu da u mä pe sciugà e osse da u Dria
e a funtan-a di cumbi 'nta cä de pria
E 'nt'a cä de pria chi ghe saià
int'à cä du Dria che u nu l'è mainà
gente de Lûgan facce da mandillä
qui che du luassu preferiscian l'ä
figge de famiggia udù de bun
che ti peu ammiàle senza u gundun
E a 'ste panse veue cose che daià
cose da beive, cose da mangiä
frittûa de pigneu giancu de Purtufin
çervelle de bae 'nt'u meximu vin
lasagne da fiddià ai quattru tucchi
paciûgu in aegruduse de lévre de cuppi (2)
E 'nt'a barca du vin ghe naveghiemu 'nsc'i scheuggi
emigranti du rìe cu'i cioi 'nt'i euggi
finché u matin crescià da puéilu rechéugge
frè di ganeuffeni e dè figge
bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä
che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä
1) Creuza: qui impropriamente tradotto: mulattiera. In realtà la creuza è nel genovesato una strada
suburbana che scorre fra due muri che solitamente determinano i confini di proprietà.
2) Lévre de cuppi: gatto
Traduzione:
MULATTIERA DI MARE
Ombre di facce facce di marinai
da dove venite dov'è che andate
da un posto dove la luna si mostra nuda
e la notte ci ha puntato il coltello alla gola
e a montare l'asino c'è rimasto Dio
il Diavolo è in cielo e ci si è fatto il nido
usciamo dal mare per asciugare le ossa dell'Andrea
alla fontana dei colombi nella casa di pietra
E nella casa di pietra chi ci sarà
nella casa dell'Andrea che non è marinaio
gente di Lugano facce da tagliaborse
quelli che della spigola preferiscono l'ala
ragazze di famiglia, odore di buono
che puoi guardarle senza preservativo
E a queste pance vuote cosa gli darà
cose da bere, cose da mangiare
frittura di pesciolini, bianco di Portofino
cervelli di agnello nello stesso vino
lasagne da tagliare ai quattro sughi
posticcio in agrodolce di lepre di tegole
E nella barca del vino ci navigheremo sugli scogli
emigranti della risata con i chiodi negli occhi
finché il mattino crescerà da poterlo raccogliere
fratello dei garofani e delle ragazze
padrone della corda marcia d'acqua e di sale
che ci lega e ci porta in una mulattiera di mare
IL FATTO
L’industria del divertimento estivo non sembra in crisi nonostante bombe e depressione
LA PAROLA CHIAVE: DIVERTIMENTO
La ricreazione è finita
Nel sospetto con cui da sempre la filosofia guarda il divertimento non c’è puzza di sacrestia.
La condanna non ha di mira il piacere in quanto tale, ma la sua falsificazione. Siccome il
compito di ogni autentica filosofia consiste nell’introdurre ad una vita beata, il filosofo si
sente in dovere di denunciare tutti gli idoli che seducono l’anima in cammino, allontanandola
con false immagini della felicità dalla sua meta. Il divertimento, per il filosofo, è distrazione
e la distrazione, alla fine, è dolore. Nel decimo libro dell’ “Etica Nicomachea”, il filosofo per
antonomasia, Aristotele, dopo avere indicato nella felicità l’esclusiva meta della saggezza, si
preoccupa di distinguerla dalle sue immagini “umane, troppo umane”. La prima è, appunto,
la “paidía”, il “gioco”. Giocare, egli scrive, è piacevole. Chi potrebbe negarlo? Giocare è
anche raccomandabile perché non si può sempre lavorare. La prosa della vita quotidiana
ha bisogno di pause. Le ragioni di questo piacere sono poi, apparentemente, le stesse che
rendono la vita filosofica la più desiderabile. Chi gioca, se gioca veramente, non ha altro
fine che il gioco. L’attività è in se stessa desiderabile, a differenza di quello che avviene con
le altre attività “poietiche” (produttive) della vita quotidiana, che, mirando ad un risultato
esteriore (ad una “efficacia”), sono funzionali ad altro e in se stesse faticose. Questa libertà
del gioco è quanto lo rende ingannevolmente simile alla vita sovrana del filosofo, la quale, lo
sappiamo, è tutta “scolastica”, cioè “oziosa” perché non ha altro fine che se stessa. Ma per
l’adulto, osserva il filosofo, il gioco non può essere un fine assoluto. Al termine dell’intervallo
la campanella ricorda qual è il vero (non) senso della vita: l’esame, l’interrogazione, la
prova. Non si può insomma sempre godere “adesso”, mentre proprio questa è la natura
quasi divina della “vita contemplativa” (theoría): il presente senza tempo del piacere più
puro.
***
Notti in riviera
Il divertimento non è la perversione, ma il sosia della filosofia. Ne ha le stesse fattezze
esteriori, ma, come nel racconto di Dostoevskij, mira a scalzarla e a sostituirla. Come lei
ama i giovani, il piacere, l’estasi, il vino e la musica. Come la filosofia, anche l’industria
del “fun” mira a dilatare illimitatamente i confini del presente e a liberarlo dal ricatto del
futuro (l’opera, il lavoro). Come lei promette evasioni da un mondo prigione verso un
altrove non ben definito. Come lei costruisce comunità momentanee, elettive, alternative
a quelle istituzionali e tradizionali. Come lei, infine, trascende i confini angusti della legge
e della morale. Ma tutto questo, nel divertimento, avviene sotto il segno esclusivo della
finzione. Chi si diverte sa di un sapere amaro che sta solo divertendosi. Il suo godimento
è a termine. Il padrone l’aspetta. Chi si diverte non è libero dalla tirannia dell’orologio (la
clessidra, ricorda Platone nel “Teeteto”, non misura il tempo, ma soltanto la sua “scarsità”,
quanto poco tempo abbiamo per noi). E’ in libertà vigilata. Il mondo lo reclama e il
lunedì pretenderà che sia pagata la parcella. Nel film “Fuoco fatuo”, tratto dall’omonimo
racconto di Drieu La Rochelle, Louis Malle metteva in scena proprio la disperazione di un ex
bellissimo, un tempo re delle notti parigine, che non vuole rassegnarsi alla consapevolezza
di questa finzione. Sceglierà di morire piuttosto che rientrare, come tutti, in caserma.
***
Vecchi e nuovi slogan
Non si deve demonizzare il divertimento contrapponendogli un’ostentata serietà. L’ansia
che lo attraversa rendendolo così malinconico, soprattutto quando è apparentemente
spensierato (la spiaggia, il mare, la discoteca…), è infatti generata da una promessa mai
mantenuta di vera felicità. Perché, altrimenti, proveremmo tanta nostalgia per le nostre
giovanili sciocchezze? I fustigatori dei costumi dimenticano che la “scienza” e la “virtù” non
sono figlie del lavoro e della rinuncia, ma dell’inoperosità e della gaiezza. Ciò che però il
divertimento incontra solo come finzione e disperazione, il sapere lo pretende sotto il segno
della verità. Questa è la scommessa, probabilmente già perduta, della filosofia. Il famoso
slogan di sapore rimbaudiano, che comparve sui muri parigini nel maggio del ’68 – “ne
travaillez pas!” – fu scritto probabilmente da u no studente di filosofia. Oggi, in tempi di
divertimento coatto, un altro giovane apprendista filosofo potrebbe scrivere “smettete di
divertirvi!”, ma il senso sarebbe, dopotutto, lo stesso di allora.
Rocco Ronchi
IL FATTO
Grande successo di pubblico del festival della filosofia di Modena
LA PAROLA CHIAVE: FILOSOFIA
I doni della cometa
La filosofia è il mondo rovesciato. Le sue evidenze procedono in senso contrario a quelle del
senso comune. Dove per questo c’è la luce del giorno, nitidi contorni e certezze sottratte ad
ogni possibile dubbio, per lei c’è solo la notte del non sapere. Dove lei si muove a suo agio,
noi brancoliamo nel buio. Si dice che la vita sulla terra venga dallo spazio. Ebbene, tra i vari
doni che una qualche cometa lontanissima deve avere fatto al nostro pianeta deve esserci
anche la filosofia, altrimenti inspiegabile secondo le leggi di questo mondo. Platone, del
resto, rivendicava orgogliosamente una discendenza non solo regale ma semi divina…
Equazione platonica
E’ platonica l’equazione tra ciò che assolutamente è ed è perciò assolutamente conoscibile,
ciò che non è ed è assolutamente inconoscibile e ciò che oscilla tra essere e non essere
e, quindi, è conoscibile solo relativamente e fallacemente: il vero-evidente, il nienteinevidente, il relativo-opinabile. Logicamente ineccepibile ma inverso rispetto alla nostra
esperienza quotidiana. Perché a stare a questa tassonomia il più chiaro e distinto sarebbe
proprio quanto è più lontano dalla nostra esperienza reale, la quale è esperienza del relativo
e del mutevole. “Per noi” è infatti difficilissimo approdare alla “pianura della verità” e
contemplare “la cosa in sé”, la pura idea senza colore, forma, eternamente identica a se
stessa. Ci aiuta certo la geometria, la grande compagna, insieme alla musica, della filosofia,
ma nella quotidianità ciò che è primo per noi è proprio questo cavallo qui che rumina
stancamente sotto la pioggia battente e non “il cavallo” ideale che scorazza nella pianura
celeste. Ecco allora enunciato il paradosso metafisico: ciò che “per natura” è massimamente
conoscibile è “rispetto a noi” il secondo se non addirittura l’ultimo, il minimamente
conoscibile, e viceversa.
Uomini che scambiano la moglie per un cappello
La filosofia non inizia del resto proprio con la problematizzazione dell’ovvio? Lo stupore è
il nome dato a questo inizio. Questa meraviglia non ha niente di festivaliero. E’ un peso da
sopportare. Sotto questo peso si può crollare. La follia è il rischio della filosofia. Non a caso
Platone chiamava la filosofia “mania” e “delirio”. Non perché il filosofo sia romanticamente
genio e sregolatezza. Di questo armamentario kitsch la filosofia, grazie al cielo, non ha mai
saputo che farsene, preferendo apparire al mondo monotona e dimessa come le passeggiate
serali di Kant. La ragione è un'altra. Il filosofo fa riflessivamente e intenzionalmente (vale a
dire con “metodo”) quello che il folle fa irriflessivamente e involontariamente. La passività
dolente del secondo è l’attività meditata del primo. Solo un pazzo dubiterebbe di avere
due mani, un corpo oppure di sognare invece di essere sveglio. Queste ovvietà sono fuori
discussione per l’uomo sano. Non così per il filosofo. Stupore è il nome per la sospensione
di questa fede naturale nel mondo e nelle sue ovvietà. I “problemi metafisici fondamentali”
sono allora la traduzione speculativa del vissuto del folle. Viene allora spontaneo chiedersi
se il dono proveniente da quella lontana cometa non sia stato, come la mela offerta dalla
strega a Biancaneve, un dono avvelenato.
Essere minato
Il problema della filosofia è mirabilmente sintetizzato nei primi versi di una bellissima
poesia di Wislawa Szymborska: “Per motivi non chiari, / in circostanze ignote / l’Essere
Ideale smise di bastarsi”. Eterno cominciò a mutare, assolutamente conoscibile “si mise a
cercare impressioni / in cattiva compagnia della materia”, diventando opaco e impreciso.
Perché diavolo quel cavallo avrà deciso di abbandonare i verdi pascoli della pianura
della verità per riempirsi di croste quaggiù sotto questo tempo inclemente? Non è Dio il
problema della filosofia. Lui, per lo sguardo del filosofo, è l’evidenza stessa (questo è il
senso del celebre “argomento ontologico”). Lui è il massimamente conoscibile. Il problema
è questo mondo qui, la sua generazione, la sua ostinazione ad esistere, quando, a rigor
di logica, non avrebbe dovuto affatto essere. Perché questo errore? E, soprattutto, è un
errore “perdonabile”, è riconducibile in qualche modo all’eterno e al vero, oppure è un
errore senza ritorno, qualcosa che, come scrive Albert Camus, ha “minato” per sempre
d’assurdo l’essere?
Rocco Ronchi
IL FATTO
Pera, Fallaci, Ferrara. Gli atei si scoprono clericali.
LA PAROLA CHIAVE: CLERICALE
Lo spirito sotto acido
I filosofi dei lumi tenevano in gran considerazione la religione. Non perché ritenessero che
avesse un qualche contenuto di verità. La teologia per loro era solo oggetto di scherno.
Ma la religione era uno strumento di controllo delle masse analfabete al quale un despota
illuminato non poteva rinunciare a cuor leggero. Bisognava essere realisti e riconoscere
che la filosofia (come la libertà di pensiero) è roba per pochi e che la maggioranza ha
bisogno di una buona dose di superstizione per sopportare l’asprezza della vita. Platone,
del resto, non la pensava diversamente, quando selezionava attentamente i “miti” che, a
suo giudizio, dovevano essere conservati e tramandati per educare per benino i rampolli
della polis. Nemmeno lui aveva dubbi sulla loro “falsità”, ma la loro funzione era formativa
e non filosofica. Nella prima metà del secolo scorso, in un’Italia appena divenuta fascista, il
ministro-filosofo Giovanni Gentile pensò opportunamente di collocare l’educazione religiosa
nelle scuole elementari e di eliminarla, invece, nei licei. La ragione di questa scelta, che
non mancò di sollevare un vespaio di polemiche (fino ad essere di fatto cassata), era,
per certi versi, ancora platonico-illuminista: ai pochi fortunati la ragione disincantata, ai
più qualche storiella edificante e rassicurante. In Gentile agiva poi anche una convinzione
profondamente hegeliana e vichiana: la religione è una ragione balbettante che si esprime
per miti e per metafore, è lo “spirito” sotto acido, un ottimo succedaneo chimico, quindi,
della vera educazione filosofica.
***
Anarco-cristiani
L’anticlericalismo è il più genuino tra i sentimenti religiosi. Come non scorgere nella
contestazione spesso ingenua dei simboli della religiosità istituzionale un omaggio profondo
ai contenuti che quei simboli invece di tradurre tradiscono? Il prete, per l’anticlericale,
è un usurpatore e un simulatore. Parla della trascendenza, ma è interessato solo
all’immanenza. Usa il lessico della trascendenza per ottenere vantaggi pratici per la
propria mondanissima setta. Vuole il riconoscimento di questo mondo (il potere) mentre
professa la sua appartenenza ad un altro mondo. L’anticlericale non ha dubbi in merito
al contenuto di verità della fede che il funzionario dell’istituzione soltanto “recita”. Per
questo gli sputa addosso o bestemmia il “dio” di cui quello si fa portavoce: perché non
è il vero dio ma un idolo pagano. Nietzsche aveva ben colto questo gioco delle parti e
da buon filosofo sprezzante della verità religiosa smascherava i socialisti e gli anarchici
anticlericali del suo tempo chiamandoli preti mancati o preti meglio riusciti di quelli reali.
L’anticristiano Nietzsche, il pagano Nietzsche, non poteva venire a patti con quei figli spuri
del cristianesimo: “Si può stabilire una perfetta equazione – scrive nell’Anticristo – tra il
cristiano e l’anarchico…”. Ai suoi occhi aristocratici, ad aver valore era semmai la Chiesa
come istituzione “umana più che umana” creata da una lucida volontà di potenza. La
Chiesa, “macchina da guerra” transnazionale e universale, suscitava la sua ammirazione
di guerriero. La Chiesa dei preti che fingono di credere ma che in realtà sanno che non
vi è altra vita che questa vita, che non vi è altro dio che quel dio fittizio che garantisce il
potere sulle anime, questa Chiesa risolta in una pura forma senza contenuto aveva per
lui “prestigio”. Ma con ciò non si è anche data una chiara definizione di ciò che s’intende
per condotta “clericale”? Che altro è il clericalismo se non una devozione senza pietà, una
religiosità senza fede, prestigio e forza perseguiti indossando i panni dell’umiltà?
***
Nel nome del papa re
Se il clericale e il nichilista si stringono oggi cordialmente la mano, riconoscendo
onestamente di essere dalla stessa parte della barricata, questo non può stupire. La loro
alleanza, certamente non santa, non è tattica ma strategica. Non è il comune avversario
– l’Islam – ad unirli, ma la comune profonda e incrollabile convinzione che di Dio non n’è
più nulla e che, d’altra parte, il religioso fornisce, come ben sapevano gli illuministi atei, un
formidabile strumento di controllo sociale. Una dubbia etimologia fissa nel verbo “religare”,
legare strettamente, l’origine di “religio”. Se per il cristiano e per l’anarchico questa
radice significa comunicazione tra il divino e l’umano, liberazione dai falsi dei di questo
mondo grazie al ponte verticale gettato verso la trascendenza, per il clericale e per il
nichilista "religio" vuol dire invece “orizzontalmente” riunire gli uomini sotto le insegne regali
del potere sovrano.
Rocco Ronchi
In questo numero di liberopensiero
la parola chiave è Rock
IL FATTO
E se il rock fosse lento?
Musica per le ombre
Nel 1976 a Winterland, San Francisco, il gruppo rock The Band tenne il suo ultimo
concerto prima dello scioglimento. Martin Scorsese dedicò all’evento un memorabile film
documentario. Come si suole dire in queste occasioni, un’intera generazione sfilò sul palco
quasi a sancire la malinconica fine di un’epoca. Da allora il rock non ha fatto altro che
continuare a morire. Sebbene giovane anagraficamente ha cominciato ad assomigliare a
quegli anziani che, privi di un credibile futuro, vivono solo di ricordi e di patetici, quanto
ingenui e disperati, “come eravamo”. Ciò che era nato per dare una voce inconfondibile
ai “principianti assoluti” del nuovo mondo uscito dalle tenebre della seconda guerra
mondiale, nel volgere di pochi anni si era trasformato in una grande finzione che doveva
coprire con lustrini e cotillons il precoce invecchiamento di una generazione. Con il
concerto di chiusura della Band a San Francisco, il rock, secondo Martin Scorsese, diventa
definitivamente questa mesta musica di reduci con gli occhi fissi nel passato. A dispetto
delle chitarre elettriche e del loro rumore, il rock si fa musica elegiaca. Musica per i defunti,
musica per le ombre, musica che celebra un’irrimediabile assenza.
***
John Lydon e Sid Vicious
Di questo aspetto geriatrico del rock, proprio in quello stesso fatidico 1976, si rendono
perfettamente conto i punk. A differenza dei movimenti eretici che si battono per una
rivitalizzazione del sentimento religioso attraverso un ritorno alle origini, l’eresia punk
non volle affatto risuscitare il cadavere del rock’n roll. Anche le sue chitarre scordate e
bistrattate suonavano a morto, ma senza elegia, senza ombra di nostalgia, tradendo anzi
un desiderio sfrenato di affrettare la fine della creaturina. A caratterizzare il punk è un unico
ritornello, ossessivamente ripetuto, scandito con la dogmatica ottusità di un militante della
rivoluzione culturale cinese: non c’è nessun futuro e quindi il rock, che della speranza si
diceva figlio, è solo una grande truffa. Non occorre saper suonare, non servono i menestrelli
e soprattutto non c’è bisogno di assomigliare ai fiori. La nuova postura, la postura adeguata
ai tempi della fine della storia, è quella dello zombie maleodorante aggrappato al microfono,
incerto sulle gambe e con occhi sgranati che non vedono più nulla (John Lydon docet).
Il ballo, da propedeutica all’estasi dionisiaca, diventa scontro macchinico di corpi sudati
che rimbalzano l’uno contro l’altro sotto il palco come palline da flipper. Da chiavi che
dovevano “lentamente” spalancare le porte dell’immaginazione, droga e alcool diventano
la via più breve che conduce all’apatia. Alla fine del percorso c’è un ragazzetto che, in
attesa di morire, girovaga per il quartiere ebraico di Parigi con una maglietta con la croce
uncinata (Sid Vicious). Non è provocazione, ma azzeramento del valore di tutti i segni:
un’incondizionata e quasi mistica accettazione dello stato entropico verso il quale precipita
ogni esistenza nel tempo del capitalismo assoluto. Gus Van Sant ha visivamente reso questa
indifferenziazione nel suo bel film sugli ultimi giorni di Kurt Cobain (una morte che nel
tempo della morte del rock nasce già come una citazione di altre precedenti morti). Kurt
si perde nel paesaggio dove vaga, è irriconoscibile, psicologicamente non caratterizzato,
pressoché impercettibile. E’ già letteralmente nulla prima di morire. Un vero punk.
***
Il riff di Pitagora
Non dovendo rispondere ad istituzioni secolari, a tradizioni consolidate e ad accademie,
il rock, tra tutte le forme espressive, è quella che si può permettere il lusso della verità
nuda e cruda. Non ha bisogno, come le arti figurative, ad esempio, di nascondersi dietro
il dito della “cultura” per mascherare la propria natura di merce. I filosofi pitagorici
sostenevano che i cieli muovendosi secondo un impeccabile ordine matematico producevano
un’armonia sublime che il nostro orecchio era però incapace di ascoltare. Come sfondo
costante della nostra esistenza, questa armonia non prende infatti il rilievo necessario
per essere tematizzato e, quindi, inteso. Non il movimento dei cieli ma quello anonimo e
impersonale delle merci costituisce lo sfondo delle nostre esistenze. Il rock è l’eco ancora
udibile di questo incessante movimento. Quando non lo si ascolterà più vorrà dire, che com
e l’inaudita armonia celeste dei pitagorici, anche la riduzione di tutta la nostra vita a merce
sarà diventata cosa così ovvia e generalizzata da essere impercettibile.
Rocco Ronchi
IL FATTO
Periferie parigine in fiamme. Attrazione fatale del fuoco su giovani sbandati e senza futuro.
LA PAROLA CHIAVE: FUOCO
Fronimon to pur (sapiente è il fuoco)
Il pedigree filosofico del fuoco è impressionante. Nature apparentemente algide, i filosofi
hanno sempre trafficato con le fiamme. Su di loro si direbbe che si è esercitata l'ipnotica
attrazione del braciere. Perché il fuoco ha un centro, ha un cuore che chiama a sé, come
la promessa di una vita infinitamente palpitante. "Il fuoco verrà e s'impadronirà di tutte
le cose", annuncia il più enigmatico dei filosofi, Eraclito d'Efeso. Non è la triste catastrofe
dell'entropia dell'universo che qui viene salutata. L'entropia è fredda, o meglio, è tiepida.
È quella pappa omogenea nella quale si risolve e si dissolve, secondo un altro adoratore
del fuoco, lo scrittore-filosofo Dostoevskij, il dio dei bravi borghesi: un dio "tiepido, "che
non brucia più, un dio tutto moralità bigotta e famiglia patriarcale, quale è quello onorato
periodicamente dai nostri preoccupati vescovi. Il fuoco, secondo Eraclito, "è" tutte le cose,
se solo si osa guardare, destandosi dal sogno del senso comune. La "lucidità" del filosofo,
spesso scambiata con freddezza, è infatti la sua capacità di stare eretto e attento, con
gli occhi ben aperti, mentre si è investiti dalla "luce" che da quel fuoco emana. I "più",
è sempre Eraclito a parlare, distolgono invece lo sguardo. Il celebre "terzo occhio" in
dotazione al filosofo non è forse un occhio solare, una scintilla di quel grande fuoco che
è tutte le cose? Che cosa vede questo pezzo di sole, momentaneamente esiliatosi nel
mio occhio che guarda (nel mio "logos", direbbe Eraclito)? Esso non vede altro che se
stesso, "fuoco sempre vivente, che con misura divampa e con misura si spegne".
Critica dell'abbronzatura filosofica
La "VII Lettera" di Platone non è sufficientemente meditata dai filosofi professionali. E
hanno ragione ad ignorarla. Vi si legge, infatti, la più dura sconfessione della filosofia come
attività professionale che mai sia stata scritta. Chi la intende così, scrive infatti Platone,
chi la pensa come un sapere, una disciplina, una faccenda da esperti, non ha capito niente
della pratica filosofica. "Perché – scrive Platone – questa mia scienza non è come le altre:
essa non si può in alcun modo comunicare, ma come fiamma si accende da fuoco che balza:
nasce d'improvviso nell'anima dopo un lungo periodo di discussioni sull'argomento e una
vita vissuta in comune, e poi si nutre di se medesima". Ciò che si scambia con la filosofia
è la sua propedeutica. Discussioni, cultura ed erudizione, sono solo la legna che è portata
sul braciere. Lo scopo è però il fuoco. Il senso della didattica si esaurisce nella capacità da
parte del maestro di individuare un'anima ben fatta, un'anima che sia fatta di fuoco e che
si consacri al fuoco. Non dimentichiamoci che, secondo Platone, l'idea delle idee è l'idea
del bene, la cui prole sensibile è il sole che brucia (il sapere dei "professionisti" del sapere,
scrive con sferzante ironia Platone, è allora solo una "abbronzatura"). La "luce", da sempre
onorata dalla filosofia, è generata da questo incendio cosmico che si replica nell'animo
dei "buoni", i quali, a tutti gli effetti, sono i figli del sole e i nipotini del "fuoco sapiente"
di Eraclito. Gli "illuminati" non sono gli "abbronzati, ma coloro che con il loro bruciare
partecipano e alimentano quello stesso fuoco che li brucia.
Domande stupide
Ludwig Wittgenstein si sofferma perplesso sull'impalpabilità della fiamma. E' il
cosiddetto "secondo" Wittgenstein, quello che, nella sua stanzetta di Cambridge, tra
pochi e fidati allievi, si pone domande senza fine sulla natura del linguaggio e dei suoi
infiniti "giochi", domande che, per la loro apparente banalità, lasciano spesso il lettore
interdetto (con un inconfessabile dubbio: "non sarà mica stupido?"). Eppure, se lette e
rilette, quelle domande, sembrano provenire proprio dalla sterminata antichità d'Efeso.
La proposizione 125 del libro postumo "Zettel. Lo spazio segregato della psicologia"
recita: "Confronta il fenomeno del pensare con il fenomeno del bruciare! Il bruciare, la
fiamma, non possono apparirci enigmatici? E perché la fiamma più del tavolo? E come
spieghi questo enigma? Ebbene, come si deve risolvere l'enigma del pensiero? Come quello
della fiamma?"
Rocco Ronchi
Con questo numero di Liberopensiero mi congedo dai miei lettori. Vorrei ringraziarli tutti,
uno per uno, per l'attenzione, la cortesia e la pazienza, con cui mi hanno seguito. Come
dice, al momento di lasciare lo scompartimento, il viaggiatore della celebre poesia di Giorgio
Caproni, "...era bello / stare insieme. Chiacchierare".
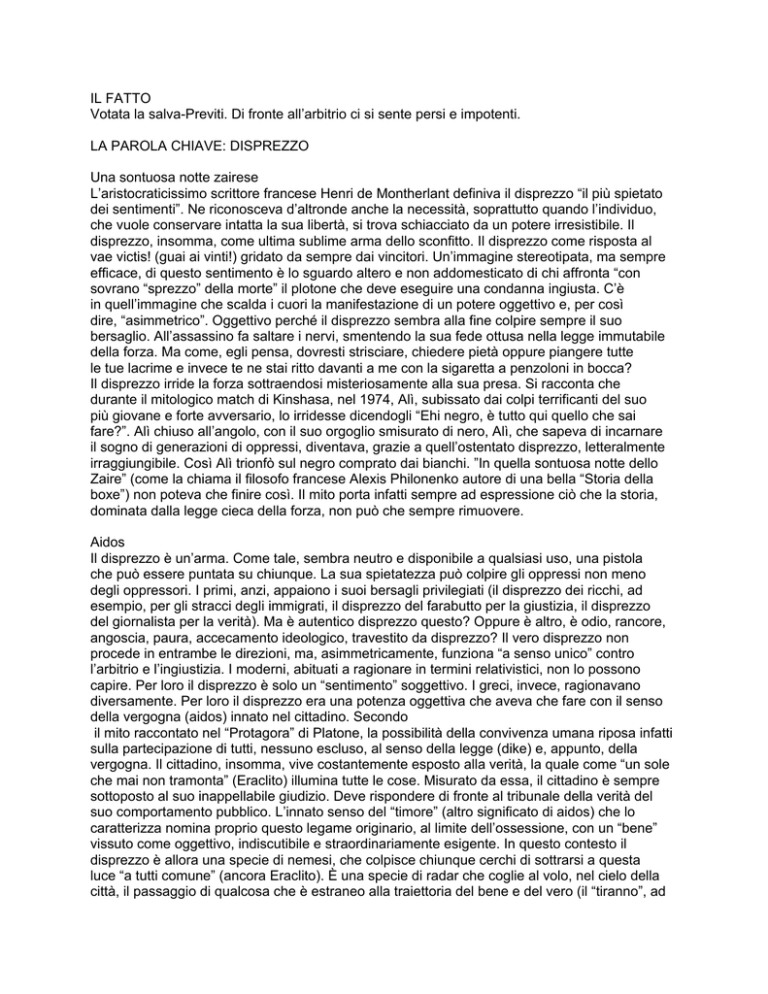






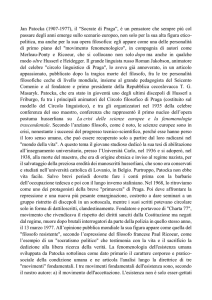
![[nazionale _ iii] lastampa_tuttoscienze_02_untitled_ ___](http://s1.studylibit.com/store/data/005745813_1-840f5eeda0f85c057daadc03dd7f45fe-300x300.png)



