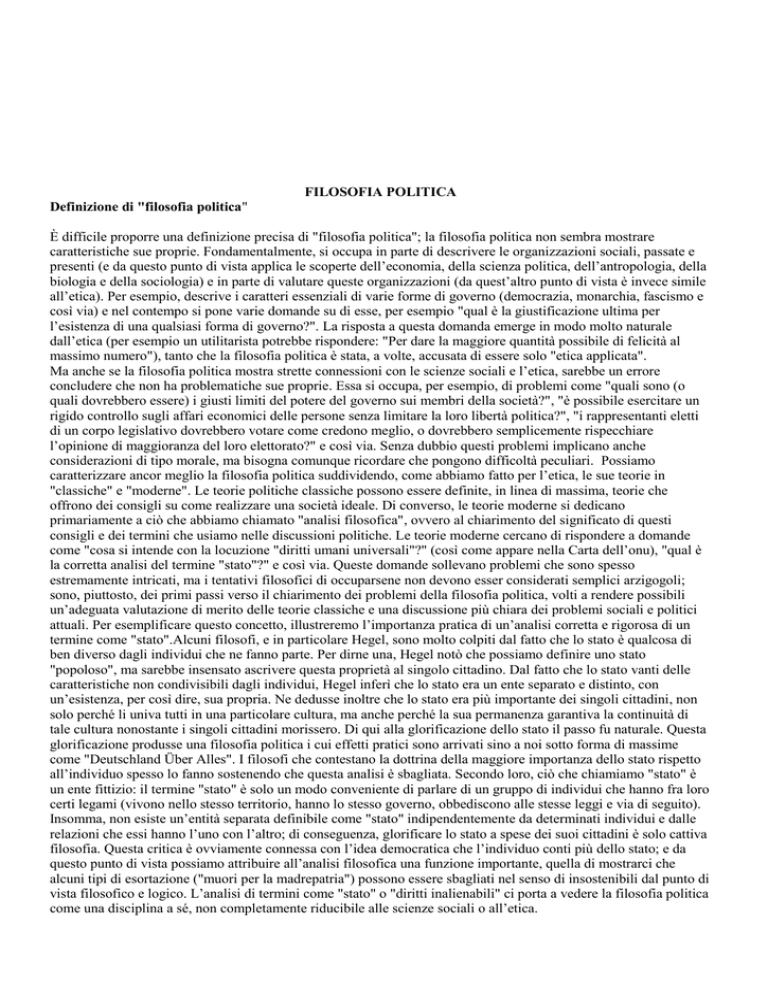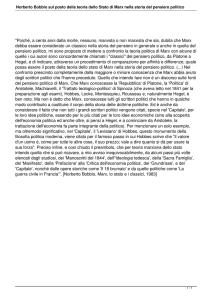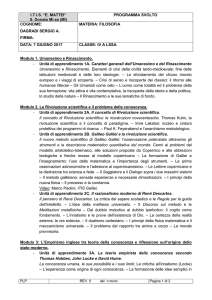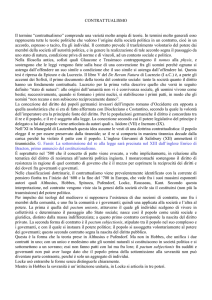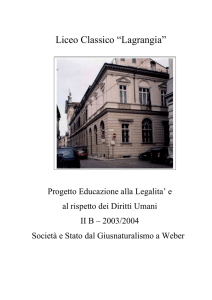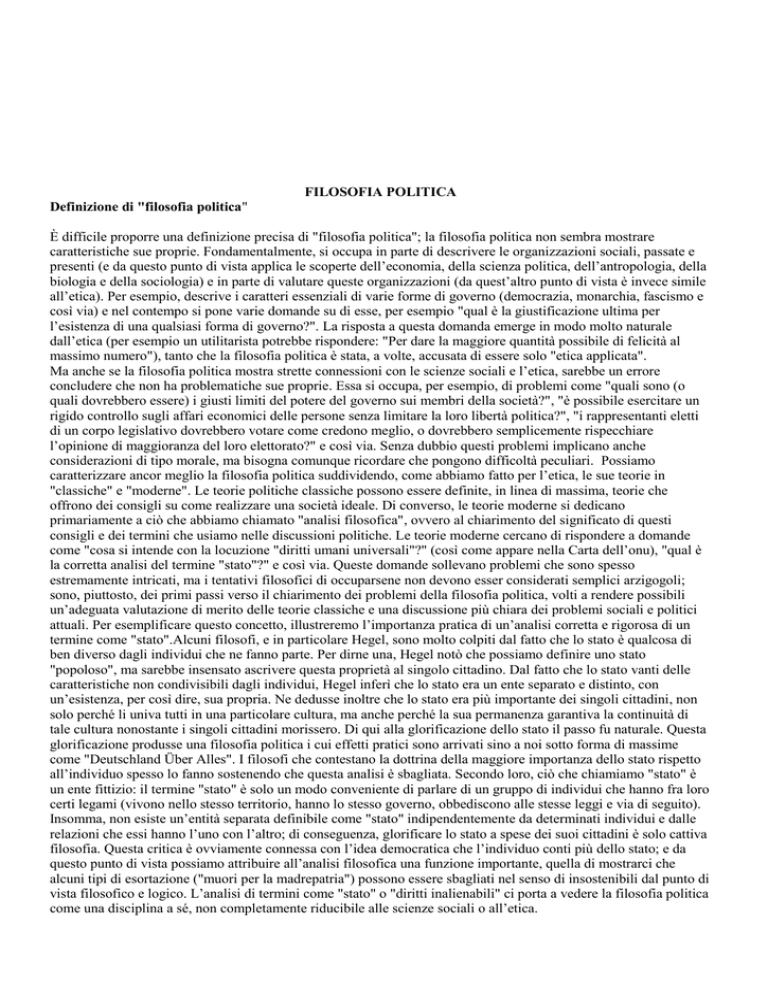
FILOSOFIA POLITICA
Definizione di "filosofia politica"
È difficile proporre una definizione precisa di "filosofia politica"; la filosofia politica non sembra mostrare
caratteristiche sue proprie. Fondamentalmente, si occupa in parte di descrivere le organizzazioni sociali, passate e
presenti (e da questo punto di vista applica le scoperte dell’economia, della scienza politica, dell’antropologia, della
biologia e della sociologia) e in parte di valutare queste organizzazioni (da quest’altro punto di vista è invece simile
all’etica). Per esempio, descrive i caratteri essenziali di varie forme di governo (democrazia, monarchia, fascismo e
così via) e nel contempo si pone varie domande su di esse, per esempio "qual è la giustificazione ultima per
l’esistenza di una qualsiasi forma di governo?". La risposta a questa domanda emerge in modo molto naturale
dall’etica (per esempio un utilitarista potrebbe rispondere: "Per dare la maggiore quantità possibile di felicità al
massimo numero"), tanto che la filosofia politica è stata, a volte, accusata di essere solo "etica applicata".
Ma anche se la filosofia politica mostra strette connessioni con le scienze sociali e l’etica, sarebbe un errore
concludere che non ha problematiche sue proprie. Essa si occupa, per esempio, di problemi come "quali sono (o
quali dovrebbero essere) i giusti limiti del potere del governo sui membri della società?", "è possibile esercitare un
rigido controllo sugli affari economici delle persone senza limitare la loro libertà politica?", "i rappresentanti eletti
di un corpo legislativo dovrebbero votare come credono meglio, o dovrebbero semplicemente rispecchiare
l’opinione di maggioranza del loro elettorato?" e così via. Senza dubbio questi problemi implicano anche
considerazioni di tipo morale, ma bisogna comunque ricordare che pongono difficoltà peculiari. Possiamo
caratterizzare ancor meglio la filosofia politica suddividendo, come abbiamo fatto per l’etica, le sue teorie in
"classiche" e "moderne". Le teorie politiche classiche possono essere definite, in linea di massima, teorie che
offrono dei consigli su come realizzare una società ideale. Di converso, le teorie moderne si dedicano
primariamente a ciò che abbiamo chiamato "analisi filosofica", ovvero al chiarimento del significato di questi
consigli e dei termini che usiamo nelle discussioni politiche. Le teorie moderne cercano di rispondere a domande
come "cosa si intende con la locuzione "diritti umani universali"?" (così come appare nella Carta dell’onu), "qual è
la corretta analisi del termine "stato"?" e così via. Queste domande sollevano problemi che sono spesso
estremamente intricati, ma i tentativi filosofici di occuparsene non devono esser considerati semplici arzigogoli;
sono, piuttosto, dei primi passi verso il chiarimento dei problemi della filosofia politica, volti a rendere possibili
un’adeguata valutazione di merito delle teorie classiche e una discussione più chiara dei problemi sociali e politici
attuali. Per esemplificare questo concetto, illustreremo l’importanza pratica di un’analisi corretta e rigorosa di un
termine come "stato".Alcuni filosofi, e in particolare Hegel, sono molto colpiti dal fatto che lo stato è qualcosa di
ben diverso dagli individui che ne fanno parte. Per dirne una, Hegel notò che possiamo definire uno stato
"popoloso", ma sarebbe insensato ascrivere questa proprietà al singolo cittadino. Dal fatto che lo stato vanti delle
caratteristiche non condivisibili dagli individui, Hegel inferì che lo stato era un ente separato e distinto, con
un’esistenza, per così dire, sua propria. Ne dedusse inoltre che lo stato era più importante dei singoli cittadini, non
solo perché li univa tutti in una particolare cultura, ma anche perché la sua permanenza garantiva la continuità di
tale cultura nonostante i singoli cittadini morissero. Di qui alla glorificazione dello stato il passo fu naturale. Questa
glorificazione produsse una filosofia politica i cui effetti pratici sono arrivati sino a noi sotto forma di massime
come "Deutschland Über Alles". I filosofi che contestano la dottrina della maggiore importanza dello stato rispetto
all’individuo spesso lo fanno sostenendo che questa analisi è sbagliata. Secondo loro, ciò che chiamiamo "stato" è
un ente fittizio: il termine "stato" è solo un modo conveniente di parlare di un gruppo di individui che hanno fra loro
certi legami (vivono nello stesso territorio, hanno lo stesso governo, obbediscono alle stesse leggi e via di seguito).
Insomma, non esiste un’entità separata definibile come "stato" indipendentemente da determinati individui e dalle
relazioni che essi hanno l’uno con l’altro; di conseguenza, glorificare lo stato a spese dei suoi cittadini è solo cattiva
filosofia. Questa critica è ovviamente connessa con l’idea democratica che l’individuo conti più dello stato; e da
questo punto di vista possiamo attribuire all’analisi filosofica una funzione importante, quella di mostrarci che
alcuni tipi di esortazione ("muori per la madrepatria") possono essere sbagliati nel senso di insostenibili dal punto di
vista filosofico e logico. L’analisi di termini come "stato" o "diritti inalienabili" ci porta a vedere la filosofia politica
come una disciplina a sé, non completamente riducibile alle scienze sociali o all’etica.
La filosofia politica di Platone
Una delle domande più difficili e imbarazzanti della filosofia politica è: "Chi deve governare?". Quasi tutte le teorie
classiche se la sono posta, e quasi tutte possono esser classificate secondo la risposta che cercano di dare. Se
qualcuno sostiene che "il popolo dovrebbe governare se stesso" sta difendendo la democrazia (John Locke); se
sostiene che dovrebbe farlo un solo uomo potrebbe essere un monarchico (Thomas Hobbes) e così via. Per Platone è
questa la domanda cruciale che ogni società deve affrontare; la sua intera filosofia politica può esser intesa come un
tentativo di fornire una risposta a tale domanda. A grandi linee, la risposta platonica è che dovrebbe governare un
gruppo di intellettuali particolarmente addestrato. Platone stesso definì "aristocratica" questa idea, perché egli
credeva che gli intellettuali fossero più adatti a governare: infatti l’unione dei termini greci "ariston" e "kratos"
significa "governo dei migliori". Ma forse caratterizziamo in modo più chiaro la teoria politica di Platone se la
definiamo "autoritaria": essa sostiene infatti che si deve concedere un’autorità assoluta a un gruppo ristretto affinché
governi la società.
Per rendersi conto della ragione per cui la domanda "Chi deve governare?" è di importanza fondamentale per
Platone sarebbe utile ricordare le condizioni prevalenti nella Grecia della sua epoca. La Grecia era composta da un
certo numero di piccole città stato, autonome dal punto di vista politico. Questi stati erano costantemente in guerra
l’uno contro l’altro, nonché contro altre nazioni grandi e potenti, come la Persia. Molti dovevano sopportare anche
gravi lotte interne. La vita del cittadino medio era precaria. Platone, insoddisfatto di questa situazione, tentò di
immaginare una società priva di questi difetti, in cui si potesse vivere insieme pacificamente e ognuno potesse
sviluppare appieno le sue potenzialità. Ciò lo condusse a chiedersi "come sarebbe una società ideale?", ammesso
che la si possa realizzare. La risposta, a suo parere, dipendeva in gran misura da chi l’avrebbe governata.
Nel suo tentativo di descrivere la società perfetta Platone venne molto influenzato dalle teorie psicologiche e
biologiche dell’epoca. Di conseguenza, egli accettò l’idea dell’esistenza di un’analogia tra l’individuo e la società in
cui viveva. L’unica differenza reale era la dimensione: una società non è null’altro se non "un individuo, scritto più
in grande". Se è così, allora il problema della natura della società ideale può essere riformulata così: "Cosa rende
ideale o perfetto l’uomo?". E la risposta di Platone venne in parte dalle teorie psicologiche e biologiche allora
correnti.
Secondo la psicologia dell’epoca ogni persona era composta da due differenti elementi: il corpo e l’anima. Quindi
ciò che rende perfetta una persona ha a che fare sia con la perfezione fisica sia con quella psicologica. In questo
contesto Platone usava il termine "perfezione" come sinonimo di "salute". Descrivere una persona perfetta significa
dunque descrivere una persona fisicamente e psicologicamente sana. Essere sani fisicamente vuol dire non essere
malati; ma determinare quando si è sani psicologicamente è questione più complessa. Platone sosteneva a questo
proposito che l’anima umana era divisa in tre parti, ovvero – per usare i suoi stessi termini – l’"elemento razionale",
l’"elemento volitivo" e l’"elemento appetitivo". L’elemento razionale è quella parte dell’anima che permette alla
persona di ragionare, di discutere e di scegliere. L’elemento "volitivo" è ciò che rende coraggiosi o codardi e che dà
forza di volontà. Le passioni e i desideri, come quello di cibo, di bevande e di sesso, costituiscono l’elemento
appetitivo. Fondandosi su questa divisione tripartita dell’anima, Platone sosteneva che una persona è
"psicologicamente sana" se le tre parti della sua anima funzionano armonicamente. La ragione dovrebbe comandare
gli appetiti, mentre l’elemento volitivo dovrebbe sostenere con la sua forza i dettami della ragione, in modo da
garantire che gli appetiti siano tenuti sotto controllo. Questi ultimi non dovrebbero essere completamente repressi:
ma dovrebbero esser soddisfatti solo quando la ragione decide che è giusto farlo. Se una persona viene controllata
dalla ragione in modo troppo esclusivo, la sua vita emotiva ne risulterà impoverita. Sembra che James Mill, se
dobbiamo fidarci dei resoconti di suo figlio John Stuart, fosse un uomo la cui vita razionale dominava quella
emotiva, a detrimento di quest’ultima. D’altro canto, gli uomini sono spesso dominati dai loro appetiti e per
soddisfare i propri desideri scelgono una condotta che danneggia sia loro stessi sia gli altri. Spesso sono dominati
dalle passioni e dai sentimenti, e in questo senso possono esser definiti "squilibrati". Nel senso comune del termine,
una persona viene considerata "sana di mente" quando non è squilibrata, ovvero quando tutte le parti della sua
anima funzionano armonicamente e ognuna di esse svolge il proprio ruolo senza dominare le altre o esserne
dominata. La risposta platonica alla domanda "Cosa rende un individuo perfetto o sano?" è dunque la seguente: "Un
individuo è sano se tutti e tre gli elementi della sua anima operano in armonia reciproca".
Dal momento che lo stato non è null’altro se non l’individuo "scritto più in grande", gli si può applicare la stessa
analisi. Uno stato ideale si compone di tre classi: i governanti che lo amministrano; i guerrieri che lo difendono; e
tutti gli altri cittadini che forniscono le cose essenziali per vivere, come il cibo e le abitazioni. Ognuna di queste tre
classi corrisponde a una divisione dell’anima individuale: la classe dei governanti è l’elemento razionale della
società; i soldati ne costituiscono l’elemento volitivo e gli altri cittadini l’elemento appetitivo. Come per l’individuo
ideale, la società ideale sarà quella in cui tutti e tre questi elementi funzioneranno armonicamente, con i guerrieri
che aiutano i governanti a controllare benevolmente, ma fermamente, il resto della cittadinanza. Non vi saranno
conflitti interni; ogni classe, facendo ciò che è meglio preparata a fare, sarà felice e soddisfatta.
Ma il fondamentale problema sollevato dalla costruzione di una società come questa è chi la governerà, dal
momento che ai governanti spetta sia decidere a quale classe apparterranno i singoli sia formulare le leggi per
mezzo delle quali la società funziona. Una dirigenza mediocre condurrà a leggi mediocri; una decisione sbagliata
nel collocare qualcuno in una classe o nell’altra produrrà infelicità, o peggio ancora, ribellione. È quindi essenziale,
se la società dev’essere perfetta, che vengano scelti governanti all’altezza della situazione.
Platone fornisce minuziose direttive sul modo di scegliere i governanti e di assicurarsi, una volta effettuata la scelta,
che essi non operino a proprio esclusivo vantaggio. Tutti i bambini, maschi e femmine, devono essere allevati in
comune – cioè dallo stato – sino a diciotto anni. A quell’età devono esser sottoposti a tre tipi di prove, con lo scopo
di dividere i governanti potenziali da chi diverrà guerriero o artigiano. Le prove dovrebbero durare due anni. In
parte sarebbero fisiche (perché l’attività di governo impone grande sforzo fisico e anche perché Platone riteneva la
salute fisica presupposto della salute mentale), in parte intellettuali, in parte morali (se una persona non riesce a
resistere alla tentazione morale potrebbe sacrificare il bene della società ai suoi interessi personali). Gli individui
che supereranno queste prove verranno rigorosamente isolati e sottoposti a ulteriore addestramento, soprattutto
intellettuale. Saranno istruiti nelle scienze astratte; per imparare a pensare per astrazioni, cosa necessaria per i loro
successivi studi filosofici, studieranno aritmetica, geometria piana, geometria dei solidi, astronomia e armonia. Lo
studio della filosofia, o della "dialettica" (termine di Platone), è il culmine della loro preparazione teorica ai compiti
di governo, perché li condurrà infine a una conoscenza compiuta del bene. Come abbiamo già visto nella
discussione della morale platonica , quando essi avranno maturato questa conoscenza, le loro azioni saranno buone:
quindi le loro decisioni saranno sempre prese nell’interesse del popolo. Essi saranno di fatto "re filosofi". La
seconda parte del loro addestramento sarà pratica; verranno loro affidate cariche amministrative minori e saranno
costantemente tenuti sotto osservazione nell’esercizio delle loro mansioni. Chiunque non riesca a dimostrarsi
competente in uno qualsiasi di questi passaggi sarà escluso dal numero dei potenziali governanti. Dopo aver passato
tutte le prove, i governanti prenderanno parte attiva all’amministrazione della società. Ma, per evitare ogni
possibilità che essi diano la precedenza al loro bene su quello pubblico, non sarà loro concesso di avere famiglia o
di possedere proprietà e ricchezze. Platone pensava che gli interessi familiari e il desiderio di ricchezza fossero i due
ostacoli maggiori a una guida politica obiettiva e imparziale. Avendo eliminato queste due motivazioni operanti
contro il bene comune, ai guardiani bisognava accordare autorità assoluta nel governo della società. A nessun
elemento delle classi "inferiori" veniva concesso di intervenire nell’attività di governo, poiché i membri di questi
ceti, al contrario dei governanti, non erano esperti nell’arte politica. Platone giustificava la concessione del potere
assoluto ai governanti sostenendo che governare era un’abilità, proprio come lo era la medicina. Governare in modo
appropriato richiedeva un addestramento adeguato, nello stesso senso in cui lo richiedeva la pratica della medicina.
Permettere a una persona non addestrata di metter bocca nell’attività di governo era secondo Platone altrettanto
stupido che permettere a una persona non addestrata di fornire consigli su come eseguire correttamente un
intervento chirurgico.
La filosofia di Platone sfocia in modo naturale in una concezione antidemocratica e autoritaria, nell’idea di un
governo per il popolo, ma non di un governo del popolo. Platone presume che i governanti sappiano meglio del
popolo stesso quali leggi e quali politiche garantiranno i suoi interessi, proprio come un medico può decidere
meglio dei profani se un paziente ha o no bisogno di un certo trattamento.
Critiche a Platone
L’argomentazione di Platone, quando viene generalizzata, è forse la più potente che sia mai stata rivolta contro la
democrazia. Formuliamola con precisione e vediamo cosa si può dire a suo favore o a suo sfavore. Essa si svolge
nel seguente modo:
Premessa 1. Governare è un’abilità.
Premessa 2. Gli uomini sono sin dalla nascita diversi per quel che riguarda le loro possibilità di acquisire ed
esercitare differenti capacità.
Premessa 3. Coloro che mostrano maggiori capacità di governo dovrebbero esser addestrati in questa loro abilità e,
a completamento dell’addestramento, dovrebbero esser messi a capo della società.
Premessa 4. Poiché costoro sono i più abili nel governare dovrebbe esser loro concessa autorità assoluta, in modo
che siano le loro leggi a essere in vigore.
È evidente che la base di tutta l’argomentazione sta nella tesi che governare è un’abilità. Platone la dimostra
appellandosi al senso comune. La gente comune non dice spesso che il governante ha fatto un errore nel promulgare
questa o quest’altra legge? Ma dire che fa degli errori equivale a dire che governare implica una conoscenza, ovvero
un’abilità che si può imparare. Se si ha la conoscenza non si commettono errori, così come il dottore che è stato
preparato in modo adeguato non pronuncerà una diagnosi sbagliata. Concessa questa premessa, il resto
dell’argomentazione di Platone sembra seguirne correttamente. Infatti, ammettere che alcuni siano più capaci di
governare di altri, non significa dire che essi dovrebbero essere addestrati a governare? Inoltre, una volta che li si è
addestrati, non saranno forse i più abili nel governare? E se così fosse, non si dovrebbe conceder loro l’autorità assoluta
di promulgare leggi? Si può presentare il nocciolo dell’argomento di Platone in modo molto semplice, riassumendolo
nella seguente domanda: volete forse che governi chi non è né adatto né correttamente addestrato al governo? Non
farebbe forse degli errori, producendo gli stessi inconvenienti che ritroviamo nelle società esistenti, e che sono dovuti al
fatto che i governanti non hanno capacità di governare? A questo punto chi si oppone alla teoria platonica si trova di
fronte a un dilemma. O devono governare gli addestrati o devono governare i non addestrati. Ma se governassero i
secondi si avrebbe un governo inadeguato; se lo facessero i primi, si avrebbe invece un governo autoritario e non
democratico. Ne consegue che si deve accettare o un governo non democratico o un governo inadeguato. C’è un
sistema per evitare questo vicolo cieco?
Ci sono molti modi di confutare l’argomentazione platonica, alcuni più potenti degli altri. Il primo è di negare che
governare sia un’abilità analoga alla medicina. L’attività di governo non è riducibile a una scienza nello stesso senso in
cui lo è la medicina. Prescrivere il da farsi ai sudditi è cosa diversa da prescrivere le cure a dei pazienti. Si potrebbe
illustrare la differenza nel seguente modo. Il medico, quando prescrive qualcosa a un suo paziente, sta dirigendo la sua
condotta; non prende direttamente in considerazione i voleri e i desideri del paziente, ma gli prescrive una linea di
condotta che questi deve adottare se vuole rimettersi in salute. Ma chi governa una società non dovrebbe avere la stessa
funzione di un medico. La sua funzione non è di dirigere gli interessi e le attività della cittadinanza, ma (almeno
secondo alcuni) è di rispecchiare questi interessi e di fare in modo che si realizzino. Questa è una delle idee proposte
dai teorici della democrazia; essa afferma, in sostanza, che gli interesssi di individui diversi sono diversi, che vi è una
grande varietà di attitudini, abilità, desideri, atteggiamenti e così via. Ciò che è bene per una persona può non esserlo
per un’altra. Una società è buona quando permette piena espressione a tutti i diversi interessi. La funzione del
governante non è di avviare su percorsi specifici la condotta o gli interessi dei cittadini, imponendo così i suoi criteri ai
membri della società, ma solo di mettere questi ultimi nella condizione di poter vivere insieme, per quanto possibile,
nel rispetto di tutti. Tuttavia, bisogna ricordare un punto essenziale della teoria morale platonica, sul quale ci siamo
soffermati nel capitolo precedente: per Platone esistono criteri assoluti – e, come abbiamo appena visto, il re filosofo sa
quali sono. Di conseguenza, governando in base a essi, egli non sta imponendo i suoi criteri personali agli altri membri
della società, ma piuttosto indirizza la loro condotta verso quei modelli che egli sa essere giusti. Una confutazione
adeguata dell’argomentazione platonica richiede che si neghi che una conoscenza di questo genere sia raggiungibile; in
tal modo si dimostrerebbe che il governo non è una scienza basata sulla conoscenza, come la medicina.
Una seconda obiezione all’argomentazione platonica, più potente della prima, tenta di dimostrare che dalle premesse
non consegue la conclusione. Per esempio, anche se si ammette che governare è un’abilità, che gli individui
differiscono naturalmente nelle loro capacità di esercitare tale abilità, e persino che alcuni di questi individui debbano
esser scelti come governanti, ancora non ne consegue che si dovrebbe loro concedere un’autorità assoluta. Essi
dovrebbero sempre render conto al popolo delle loro azioni; di conseguenza l’autorità deve risiedere nel popolo, non
nei governanti. Questa obiezione scaturisce dalla lunga esperienza delle tirannie, che il popolo ha subito per mano di
governanti assoluti. A lord Acton si attribuisce la seguente frase: "Il potere corrompe, ma il potere assoluto corrompe
assolutamente". Nonostante le misure escogitate da Platone, l’esperienza insegna che le persone intelligenti possono
sempre trovare il modo di eludere queste salvaguardie e quindi abusare della loro autorità; e il modo migliore di
impedire ai governanti di abusare del loro potere è verosimilmente quello di concedergliene il meno possibile. Qui
stiamo nuovamente rifiutando la tesi di base di Platone, cioè che la conoscenza del bene sia possibile e conduca
necessariamente a un comportamento virtuoso.
Una terza obiezione al platonismo è che una società guidata da pochi renderà impossibile il pieno sviluppo della
maggior parte dei suoi membri. Secondo Platone i governanti possono essere addestrati in modo tale da giudicare
infallibilmente cosa sia il meglio per il popolo; ma le teorie democratiche moderne sostengono che nessuno è infallibile
e che, se nessuno lo è, non ha senso che altri facciano errori al tuo posto. C’è una buona ragione per cui bisognerebbe
concedere a chiunque di commettere i propri errori: si impara dall’esperienza, e imparando si diventa persone più
mature e quindi migliori cittadini. La concezione platonica della relazione tra il governante e il cittadino è quella di una
relazione genitore-bambino; il governante è essenzialmente un genitore che dirige la vita del cittadino-bambino. Ma se
la vita di una persona è sempre diretta da altri, non crescerà mai, restando sempre in una condizione infantile. Ne
risulterebbe una società composta da individui immaturi, che non svilupperebbero mai le proprie capacità perché non
sarebbe mai concessa loro l’occasione di agire di propria iniziativa. Come abbiamo visto nella teoria morale di Platone ,
in una società di questo genere la maggior parte dei cittadini non sarebbe mai in grado di scegliere e decidere
autonomamente, e non raggiungerebbe mai quel tipo di indipendenza morale considerato, solitamente, un elemento
essenziale di una maturità responsabile. Questa obiezione sostiene insomma che l’autogoverno è essenziale per lo
sviluppo di una cittadinanza matura (ovviamente con "autogoverno" si intende qui che la responsabilità ultima risieda
nel popolo).
La filosofia politica di Thomas Hobbes
Non tutti i filosofi pensano che l’imposizione dell’autorità sia il peggiore dei mali sociali. Thomas Hobbes è un
esempio di filosofo che preferisce i mali del potere assoluto a quelli di una vita associata in cui un simile potere non sia
presente. È facile spiegarsi l’orrore hobbesiano per l’idea di vivere in un paese privo di un sovrano potente. Nato nel
1588 (una nascita prematura, si racconta, dovuta allo spavento provato dalla madre per le notizie sull’Invencible
Armada), Hobbes affrontò alcuni dei decenni più instabili della storia d’Inghilterra. Assistette alla ribellione contro
Carlo i, alla guerra civile che ne risultò nel 1642, venendo infine costretto a fuggire sul continente, dove restò in esilio
per undici anni. Ma anche là non era al sicuro. I suoi nemici politici intendevano assassinarlo; egli tornò quindi in
Inghilterra giusto in tempo per assistere alla condanna dei suoi scritti, considerati sovversivi. Nel 1662 gli fu ordinato,
pena il carcere, di astenersi dal pubblicare ancora su problemi sociali e politici. In questo panorama di estremo
disordine, è comprensibile che Hobbes temesse una società caotica più di qualsiasi altra cosa. In una società di questo
genere la vita, la proprietà o la famiglia di una persona non sono mai al sicuro. L’unico modo per garantire la pace
interna sta nel costringere le persone a obbedire alle leggi sociali e nel punirle se non lo fanno. Ma l’efficacia delle
leggi dipende solo dall’agente che le impone. Secondo Hobbes un sovrano senza un potere assoluto di far rispettare le
leggi non è in ultima analisi un sovrano: senza tale autorità non riuscirebbe a risolvere le dispute che possono nascere
tra i cittadini. Quindi, per avere una società pacifica, è necessario che chi governa eserciti su di essa un controllo
assoluto. Qualsiasi abuso sia prodotto dal suo posssesso di tale potere, la società rimarrà tuttavia pacifica: di
conseguenza gli abusi sono preferibili a una vita nel caos. Mettendo in discussione il punto di vista di Hobbes, si
potrebbe chiedere perché una società senza autorità assoluta dovrebbe necessariamente essere caotica. La risposta di
Hobbes dipende quasi esclusivamente da una teoria psicologica sulla natura umana. Secondo questa teoria l’uomo è per
natura interessato ed egoista. Egli è motivato da desideri egoistici che richiedono, come condizione della sua felicità, di
esser soddisfatti. Così, tutte le azioni di una persona possono esser spiegate come tentativi di soddisfare i propri desideri
– di sesso, di cibo, di abitazione, di fama, di ricchezza e così via. Se gli uomini vivessero da soli o in piccoli gruppi, ciò
non comporterebbe conseguenze rilevanti; ma quando si uniscono in gruppi sempre più grandi, diventa estremamente
importante per spiegare il loro comportamento reciproco. Infatti, due o più uomini possono avere tutti dei desideri da
soddisfare: ma se questi sono incompatibili tra loro, la cosa non è possibile. Due uomini possono desiderare la stessa
donna, e quindi, dando per scontato un regime monogamico, non possono ottenere entrambi soddisfazione. Ne
risulterebbe, quando gli uomini si imbrancano in grandi organizzazioni, che quando ognuno di loro cercherà di
soddisfare i propri desideri a spese degli altri, tra di essi esploderà il conflitto. La vita diventerà una battaglia in cui
vincerà il più forte ... ma solo temporaneamente: infatti anche il forte soccomberà infine nel conflitto (una persona
sconfitta potrebbe per esempio organizzare un gruppo contro il vincitore). È questo il quadro della vita dell’"uomo
naturale", o, come dice Hobbes, della "vita nello stato di natura". Hobbes riassunse gli orrori di una tale esistenza in una
frase famosa: la vita dell’uomo nello stato di natura "è solitaria, misera, ostile, animalesca e breve" (Leviatano, p.
102). Un tale stato di cose non può andare avanti all’infinito se la gente vuole sopravvivere. La nascita di ciò che
definiamo "società" è un modo di metter fine alla "guerra di tutti contro tutti". Gli uomini capiscono, finalmente, che
per sopravvivere ai conflitti dello stato di natura devono abbandonare ogni sforzo di soddisfare i propri impulsi
egoistici. La società è quindi un compromesso che gli uomini accettano: per avere la pace essi devono rinunciare al
tentativo di soddisfare i loro desideri. Nessuno vorrebbe un compromesso; ognuno preferirebbe soddisfare i propri
desideri; ma il compromesso, se si vuol sopravvivere, è necessario.Hobbes è uno dei più importanti fra i pensatori
politici che usano la teoria del "contratto sociale" per spiegare la società e le basi degli obblighi degli individui al suo
interno. Il compromesso, o "patto" (secondo la sua definizione), consiste nell’accordo stipulato dagli uomini, di
obbedire a un certo insieme di leggi, o "convenzioni". Queste costituiscono ciò che noi oggi chiamiamo "leggi della
società". Le persone convengono di obbedire a queste leggi per non essere danneggiate nei conflitti che scoppierebbero
se esse non esistessero. Ma, come sottolineò Hobbes, le leggi sono efficaci solo e soltanto se vengono fatte rispettare. E
l’agente che deve imporle lo può fare solo se gli viene concesso il potere assoluto. Se non ha questo potere, non può
impedire i conflitti. Su questa base Hobbes sostenne che l’autorità sovrana di qualsiasi nazione deve essere assoluta.
Hobbes soggiunse anche che la sovranità deve esser posta nelle mani di una singola persona: un re. Da questo punto di
vista egli è un monarchico. La ragione per cui egli preferisce la monarchia ad altre forme di governo, come l’oligarchia
o l’aristocrazia, è prima di tutto che se il sovrano fosse un gruppo, allora in questo gruppo potrebbero sorgere dei
conflitti. Quindi il potere di imporre le leggi sarebbe diviso e invece di una società pacifica avremmo nuovamente un
continuo esplodere di conflitti, mentre un monarca non può dividersi da se stesso. In secondo luogo, un singolo
governante può prendere le sue decisioni con maggiore segretezza. Nei gruppi numerosi si sviluppano
immancabilmente "fughe" di notizie; informazioni importanti possono filtrare sino al popolo e provocare dissensi.
Infine, le decisioni del monarca "non sono soggette a nessun’altra incostanza che quella della natura umana; ma, nelle
assemblee, oltre a quella propria della natura, si presenta un’altra incostanza dovuta al numero" (p. 158). Per esempio,
l’assenza o la presenza di poche persone può mutare la decisione del governo di promulgare o non promulgare una
legge, il che non potrebbe mai succedere con un monarca. Inoltre, non c’è ragione di credere che quest’ultimo agisca
per il suo proprio interesse a scapito del benessere pubblico. Come dice Hobbes, "il re è ricco solo quando lo è il suo
paese". Sebbene il potere del monarca debba essere assoluto, Hobbes intendeva anche garantire al suddito alcune libertà
(e questa è forse un’incoerenza). Egli definì queste libertà come "le cose che, sebbene comandate dal sovrano, egli può,
nondimeno, rifiutarsi di fare senza [compiere] ingiustizia". Dal momento che la sovranità è creata da un patto, o
contratto, il suddito conserva tutti quei diritti naturali che non possono essere trasmessi tramite patto. Detto in altro
modo: dal momento che il suddito ha sottoscritto un contratto per preservare e proteggere la sua vita, egli ha diritto di
rifiutarsi di obbedire al sovrano quando ciò metterebbe in pericolo, appunto, la sua sopravvivenza. Per esempio, se il
monarca comanda al suddito di uccidersi, ferirsi o mutilarsi, oppure di non resistere a chi lo assale, il suddito può
legittimamente non tenere conto di questo comando. Inoltre non è obbligato a testimoniare contro se stesso in un
processo penale (per inciso, fu in questo periodo che venne stabilito il precedente storico del quinto emendamento della
Costituzione degli Stati Uniti). Si può rifiutare di svolgere un incarico militare pericoloso se il sovrano non lo comanda
per conservare la pace (ma nessuno può legittimamente obiettare alla difesa della patria se viene assalita da un
aggressore esterno). Invece non si è liberi di difendersi dal sovrano; quindi la ribellione è sempre ingiustificabile,
secondo Hobbes. Analogamente, proteggere un criminale dai funzionari pubblici è ingiusto (anche questa idea è
arrivata sino a noi attraverso Hobbes e si è incarnata in molti codici legali). Gli individui conservano sempre la libertà
di difendere la propria vita contro il sovrano; ma, se viene offerta la grazia e rifiutano, sono ingiusti. In una controversia
con il sovrano il suddito ha il diritto di far causa (un’altra clausola che ritroviamo nel diritto americano). L’obbligo dei
sudditi nei confronti del sovrano dura solo sin tanto che il sovrano è in grado di proteggerli: "Lo scopo dell’obbedienza
è la protezione". Quindi un suddito che viene preso prigioniero dal nemico è libero di divenire suddito del nemico se il
sovrano non è in grado di proteggerlo. I poteri del sovrano sono vastissimi. Secondo Hobbes nessun suddito può
stipulare un nuovo patto o ribellarsi contro il monarca (purché quest’ultimo sia in grado di proteggerlo). Non è possibile
che il sovrano violi il patto, poiché secondo la teoria hobbesiana egli non ha stipulato alcun patto con i suoi sudditi. Essi
si sono invece accordati tra loro per rispettare alcune leggi e hanno conferito al sovrano il ruolo di agente deputato a
imporre queste leggi. Una volta nominato, egli ha autorità assoluta. Da ciò consegue che una minoranza di dissidenti
deve accettare senza rimostranze i dettami del sovrano o venire distrutta. Inoltre, in qualsiasi modo si comporti il
sovrano, egli non può, per definizione, agire in modo ingiusto verso chicchessia. La condotta "giusta" consiste, a parere
di Hobbes, nel rispetto delle leggi della comunità; ma poiché è il sovrano a fare le leggi, qualsiasi cosa egli faccia sarà
legge; quindi il sovrano è, in un senso pregnante, al di sopra della legge e non può violarla. Il sovrano ha un diritto
assoluto di controllare ogni opinione (perché spetta a lui decidere se l’espressione di una particolare opinione causerà o
no caos nello stato). Inoltre, egli deve creare il diritto civile nel suo complesso e giudicare tutti i disaccordi che
riguardano le leggi. Egli ha il potere di dichiarare la guerra e di imporre tasse per finanziarla.
Critiche a Hobbes
Poiché la dottrina hobbesiana è composta da una teoria psicologica sulla natura degli esseri umani e da una teoria
politica su chi dovrebbe governare la società, ciascuna delle sue due parti dovrebbe essere valutata separatamente.
Alcuni filosofi hanno interpretato la teoria di Hobbes come un tentativo di descrivere l’origine reale della società.
Secondo questa interpretazione Hobbes sostiene che in origine gli individui vivevano in gruppo senza leggi che
regolassero la loro condotta. Quando si resero conto che questo modello di vita dava luogo a una guerra di tutti contro
tutti, gli uomini ebbero l’idea di mettersi d’accordo per rinunciare al soddisfacimento dei loro impulsi egoistici e avere
in cambio la pace. Quando Hobbes viene interpretato in questo modo, la sua teoria può essere attaccata perché non
esistono prove storiche e antropologiche che permettano di sostenerla. Le primissime informazioni a nostra
disposizione sull’umanità delle origini provengono da epoche in cui gli individui avevano raggiunto un grado piuttosto
elevato di organizzazione sociale. Nessuno sa cosa voleva dire vivere prima della formazione delle società umane; e
quindi non vi è ragione di considerare attendibile l’immaginosa descrizione hobbesiana della "vita nello stato di
natura".
Ma questa interpretazione di Hobbes è estremamente superficiale e non coglie il senso fondamentale della sua teoria.
Hobbes non cerca di fornire un resoconto storico o antropologico veritiero dello sviluppo della società, ma una
giustificazione filosofica dell’esistenza di una particolare forma di governo. In altre parole, l’idea del contratto sociale è
un’analogia che mira a spiegare le basi dell’obbedienza politica, a spiegarci perché dovremmo osservare le leggi. La
questione se in qualche epoca passata gli uomini si siano o no comportati in questo modo è irrilevante per il senso del
discorso hobbesiano. Ciò che conta è la sua analisi della natura umana e l’idea della necessità di un’autorità assoluta
che ne tenga a freno gli eccessi. Il discorso hobbesiano può esser quindi considerato in parte psicologico, in parte
filosofico. Esaminiamo questi due aspetti separatamente, cominciando da quello psicologico.
La prospettiva hobbesiana si fonda sull’idea che gli individui siano motivati, fondamentalmente, dall’istinto di
soddisfare i loro desideri. Da ciò egli inferisce che gli uomini sono egoisti per natura. L’inferenza è giustificata?
Supponiamo di concedere che gli uomini siano motivati dal desiderio: ne consegue che tutti i loro desideri sono
egoistici? La risposta dipende, in parte, da cosa si intende con la frase "gli uomini sono motivati dal desiderio". Si
potrebbe intendere in primo luogo che gli esseri umani sono motivati dai loro impulsi non razionali, ovvero che le
emozioni, i sentimenti e gli atteggiamenti, e non la ragione, fanno sì che le persone si comportino come fanno. E quindi
si potrebbe sostenere, come hanno fatto sia Hobbes sia Hume, che nonostante la ragione possa prospettarci diverse linee
di condotta alternative, e anche qualcuna delle probabili conseguenze di ognuna di esse, non è lei a dare inizio
all’azione. Per questa posizione la scelta di una certa opzione, o di una certa linea di condotta, è una questione di
emozioni e di sentimento. Ora, se è questo che si intende con la frase citata sopra, non ne consegue che ogni desiderio
sia egoistico. Gli uomini potrebbero davvero essere motivati solo da fattori non razionali, ma questi fattori – come per
esempio il sentimento di solidarietà – potrebbero spingerli ad agire per il bene degli altri. Tuttavia, dicendo che "gli
uomini sono motivati dal desiderio" si potrebbe anche intendere che sono sempre spinti ad agire per i propri interessi e
solo per i propri interessi (indipendentemente da ciò che li motiva, che si tratti della ragione o delle emozioni). Ma se è
questo che intende Hobbes, è evidente che da un punto di vista psicologico egli è in errore. Gli uomini potrebbero
desiderare di contribuire alla felicità degli altri oltre che alla propria. Non sacrifichiamo spesso i nostri interessi a quelli
delle nostre famiglie, delle nostre mogli, dei nostri mariti, dei nostri figli, del nostro paese? Possiamo anche dire,
esprimendoci in altro modo, che alcuni dei nostri desideri sono "altruistici", invece che "egoistici". A volte desideriamo
contribuire al benessere di altri, e se è così, allora è falso dire che tutti i nostri desideri sono egoistici. Ciò che rende
attraente la teoria psicologica della natura umana proposta da Hobbes è la sua oscillazione tra queste due differenti
versioni della motivazione umana; ma se accettassimo la prima, non ne seguirebbe la tesi dell’egoismo, e se
accettassimo la seconda, tali tesi apparirebbe chiaramente falsa. Supponiamo però di accettare la seconda versione, di
ammetere cioè che tutti gli individui siano motivati da desideri egoistici (ovvero desideri che vanno a loro esclusivo
vantaggio): ne seguirebbe forse che solo la creazione di un’autorità assoluta favorirebbe una vita associata pacifica?
Qui la risposta sembra essere ancora "no".
Gli interessi sono diversificati e cambiano da momento a momento. Un governante cui viene concesso potere assoluto
in genere non esercita questo potere a favore del popolo, ma impone a quest’ultimo i suoi criteri personali. Ciò che
appare necessario per una vita associata accettabile non è l’assenza di conflitto interno, ma solo che l’entità del conflitto
non sia tale da rendere impossibile raggiungere determinate mete. Il progetto hobbesiano eliminerebbe il conflitto, ma
impedirebbe anche la soddisfazione di molti desideri fondamentali. Un potere sovrano che non abbia autorità assoluta
può tuttavia avere autorità sufficiente per eliminare la maggior parte dei conflitti, concedendo ciò nonostante ampio
spazio alla soddisfazione di molti interessi. Per questa ragione l’autorità assoluta non appare indispensabile – come
suggerisce invece Hobbes – per una società buona. Possiamo quindi rifiutare sia la parte filosofica sia quella
psicologica della teoria hobbesiana.
La filosofia politica di Hobbes è essenzialmente espressione di disfattismo: è una filosofia della "pace a ogni costo". La
mancanza di altre motivazioni la rende inaccettabile per individui di temperamento meno remissivo. Si pensi per
esempio alle altisonanti parole di Patrick Henry: "Datemi la libertà o la morte!", o a quelle di Thomas Jefferson:
"L’albero della libertà dev’essere innaffiato di tanto in tanto con il sangue dei patrioti e dei tiranni". Tentando di evitare
gli effetti negativi dei conflitti intestini, Hobbes era disposto a sottomettersi ai mali della tirannia e a cedere la libertà in
cambio della sicurezza. Per lui erano queste le uniche scelte a disposizione di un cittadino. Ma, come doveva mostrare
Locke, non si trattava delle sole alternative: è possibile avere legge e ordine anche in assenza di tiranni.
La filosofia politica di John Locke
Affermare che John Locke è l’architetto teorico della democrazia così come essa esiste oggi in Occidente è corretto. Le
sue idee, così come sono espresse nel suo famoso Secondo trattato sul governo civile, esercitarono grande influenza
sulla formazione della filosofia politica dei fondatori delle repubbliche americana e francese. Uno studio attento della
Dichiarazione d’indipendenza e della Costituzione americana svela che entrambi i documenti sono pieni di frasi come
"tutti gli uomini sono creati uguali", "la vita, la libertà, la ricerca della felicità [...] noi riteniamo queste verità evidenti
in se stesse" e così via, tutte tratte quasi alla lettera dal Secondo trattato. Nella discussione che seguirà impiegheremo il
termine "uomini" secondo l’uso di Locke e dei padri della Costituzione, che pensavano innanzitutto al sesso maschile.
Nel pensiero politico contemporaneo queste idee sono in genere intese come applicabili sia agli uomini sia alle donne.
Locke, come Hobbes, visse in un periodo di grande inquietudine sociale. Coinvolto negli intrighi contro il re, nel corso
della sua vita fu costretto per due volte a lasciare l’Inghilterra, nel 1675 e nel 1679. Ma, a differenza di Hobbes, questi
eventi non resero pessimistica la sua visione della natura umana. Sia da questo punto di vista, sia da quello della teoria
della funzione appropriata del governo egli si oppone diametralmente a Hobbes. Passiamo a esaminare la sua posizione
un po’ più in dettaglio.
Come Hobbes nel Leviatano, Locke comincia il Secondo trattato con quella che sembra una ricostruzione storica delle
origini del governo, usando, sempre come Hobbes, la nozione di contratto sociale. La ricostruzione comincia con
un’importante distinzione, diretta sicuramente contro Hobbes, tra la vita in uno "stato di natura" e la vita in uno "stato
di guerra". Nello stato di natura gli uomini vivono nel complesso pacificamente. Essi conoscono la proprietà privata,
per esempio della terra, e anche il possesso privato, per esempio di bovini e pecore. Per natura gli uomini non sono
completamente egoisti; a volte lavorano per il benessere altrui e cooperano tra loro; d’altro canto, a volte agiscono in
modo egoistico. Possono disporre come vogliono, senza chiedere il permesso a chicchessia, della loro proprietà.
L’unica legge che li governa è definita da Locke "legge di natura". Essa consiste in una sola clausola: "Nessuno deve
recar danno ad altri nella vita, nella salute, nella libertà o nei possessi" (p. 238). Ora, sebbene la vita nello stato di
natura sia in genere pacifica, gli uomini possono a volte trasgredire la legge di natura; possono tentare di uccidere
qualcuno o di rubargli le proprietà. Quando ciò accade, la parte danneggiata ha il diritto di punire il trasgressore. Non ci
sarebbe ragione alcuna che gli uomini abbandonassero lo stato di natura per formare una società, se non fosse per le
difficoltà che sorgono nel punire coloro che trasgrediscono la legge. Tali difficoltà sono tre: (a) ogni uomo, nello stato
di natura, è da se stesso giudice di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e questo lo conduce a giudizi partigiani. Una
persona può sostenere di essere stata danneggiata, un’altra può negarlo. Chi deve decidere il merito della disputa? (b)
anche quando è chiaro che qualcuno ha violato la legge, potremmo non avere una forza sufficiente a punirlo; (c) inoltre,
la misura della punizione varierà nonostante il crimine punito sia lo stesso. Un uomo che ruba una pagnotta potrebbe
essere impiccato, mentre un altro potrebbe essere semplicemente multato. Per superare questi difetti dello stato di
natura, gli uomini hanno bisogno di: (1) un ordine giudiziario che amministri imparzialmente la legge, (2) un esecutivo
che possa imporre la legge a chi la viola, e (3) un corpo legislativo che promulghi leggi coerenti e uniformi. La società
nasce dal tentativo di creare istituzioni che rimedino ai difetti di un’esistenza senza organizzazione sociale. Gli uomini
creano la società tramite l’accordo volontario di dar vita a queste istituzioni..
Tutto ciò, sostiene Locke, è completamente differente da uno stato di guerra. Lo stato di guerra è affine allo "stato di
natura" hobbesiano. È caratterizzato dall’esistenza di una persona o di un gruppo che vuole il dominio assoluto sugli
altri. In una situazione di questo genere, mancando un "giudice comune", si arriverà a uno scontro per la sopravvivenza.
Gli uomini si assalteranno e feriranno a vicenda, e la loro vita sarà appesa a un filo. Ma è un errore confondere questa
situazione con la vita nello stato di natura. Secondo Locke è questo l’errore fondamentale di Hobbes; lo stato di natura
(e, in quanto a ciò, anche la società civile) può divenire in certe condizioni uno stato di guerra, ma è sbagliato
identificarli l’uno con l’altro. La condizione perché ciò accada è che una persona, o un gruppo, tenti di conquistare un
controllo di tipo assoluto sugli altri. Quando ciò avviene, questa persona (o questo gruppo) crea uno stato di guerra tra
se stessa e quelli cui cerca di imporre il proprio dominio. L’opposizione nei suoi confronti non è solo giustificata, ma è
addirittura necessaria: infatti, se gli uomini le si sottomettessero, scambierebbero di fatto i vantaggi della vita associata
con gli inconvenienti già vissuti in precedenza, nello stato di natura. Questa sola ragione è sufficiente per rifiutare la
monarchia, sostiene Locke, poiché il sovrano che tenta di imporre un dominio assoluto ai cittadini ha dichiarato loro
guerra.
È evidente che questa teoria, convenientemente ampliata, contiene la maggior parte degli elementi della democrazia,
per come noi li conosciamo. In primo luogo, essa sottolinea che il fondamento del governo è il diritto, non la forza. Un
governo senza diritto sarebbe tirannico. L’assenza di diritti è tipica della monarchia: un re può far arrestare una persona
per decreto. Il presunto crimine poteva anche non esser regolato in alcun modo: la persona potrebbe non essersi resa
conto che la sua azione avrebbe provocato l’ira del monarca. E tuttavia il sovrano può inventare regole a volontà allo
scopo di imprigionare chi non è di suo gradimento. Un governo di questo genere funzionerebbe in base al capriccio, e la
società da esso controllata sarebbe altrettanto instabile. In un governo diretto in modo corretto (per esempio una
democrazia) un tale stato di cose sarebbe eliminato. La democrazia è il governo di leggi introdotte dopo una lunga
deliberazione da parte di rappresentanti scelti a ragion veduta dal popolo, e che vengono promulgate in modo che tutti
possano venirne a conoscenza. Tutto ciò contrasta marcatamente con il governo assoluto.
In secondo luogo, secondo Locke vi sono alcune aree dell’azione umana immuni dall’interferenza governativa. Locke
le definisce "diritti". Questa dottrina è il diretto progenitore della Dichiarazione dei diritti inserita nella Costituzione
americana. La Dichiarazione dei diritti afferma che il governo non ha il potere di limitare certi tipi di condotta dei
cittadini, come la libertà di parola, di religione e via dicendo. Il principale diritto sostenuto da Locke è tuttavia quello
alla proprietà privata. Egli pensava che nessun governo potesse privare giustamente una persona delle sue proprietà; ciò
perché la proprietà privata è molto spesso frutto del lavoro della persona interessata. La proprietà fa parte, in un senso
pregnante, della persona stessa (di fatto, Locke usa spesso il termine "proprietà" per riferirsi non solo a tutti i possessi
di una persona, ma anche alla sua vita e alla sua libertà): portargliela via equivale ad assalirla fisicamente. Sia Hobbes
sia Rousseau si opposero con forza a questa dottrina. A loro parere la proprietà era una creazione della società. Per
citare Hobbes, prima che la società venga in esistenza, non c’è "distinzione tra mio e tuo" (Leviatano, p. 103). Un uomo
possiede ciò che può tenere con la forza: non ha diritto su alcunché. Quest’idea, come abbiamo visto, è respinta con
decisione da Locke. Il suo punto di vista ha esercitato un’influenza profonda non solo su documenti come la
Dichiarazione dei diritti, ma anche sulla creazione dell’idea democratica "che tutti gli uomini sono per natura creati
uguali". Locke sostenne che tutti gli uomini sono uguali nel senso che essi hanno diritti anteriori a quelli che vengono
loro concessi dalla società; e dal momento che non vengono dati loro dalla società, quest’ultima non può neppure
portarglieli via. Ai nostri tempi questa dottrina viene interpretata come l’idea che a ogni uomo, indipendentemente dalla
sua condizione sociale, debba esser concesso eguale trattamento di fronte alla legge. Il "processo legale" ne è una delle
applicazioni.
Ma l’elemento democratico più rilevante nella teoria di Locke è il suo atteggiamento verso il governo. La società viene
creata con lo scopo di eliminare gli inconvenienti dello stato di natura. Quando gli uomini lasciano lo stato di natura per
entrare in società, con questa azione cedono il potere di punizione a un esecutivo da loro nominato. Ma il fatto cruciale
su cui Locke mette l’accento è che l’esecutivo viene nominato dal popolo ed è quindi responsabile nei suoi confronti.
Come egli scrive: "Per potere politico, dunque, intendo il diritto di far leggi con pena di morte, e per conseguenza con
ogni pena minore, per regolare e conservare la proprietà, e di impiegare la forza della comunità nell’esecuzione di tali
leggi e nella difesa della società politica da offese esterne, e tutto questo unicamente per il pubblico bene" (Secondo
trattato, pp. 234-235). Secondo la teoria di Locke il governo è, per così dire, un segretario in grande. Noi gli affidiamo
il potere di fare quelle cose che giudichiamo scomode o impossibili da fare personalmente, proprio come assumiamo un
segretario per badare ai nostri affari se siamo occupati in altro. Ma se il segretario viola il nostro mandato (diciamo, se
commette un’appropriazione indebita), noi possiamo licenziarlo; e se il governo viola il nostro mandato tentando di
usurpare la nostra legittima autorità, possiamo rimuoverlo. In ultima analisi, la sovranità risiede nel popolo che nomina
il governo. Quest’ultimo è solo uno strumento della volontà del popolo. Locke esprime questo punto dicendo che la
relazione tra il popolo e il governo è una relazione fiduciaria: il popolo affida al governo alcuni poteri, ai quali però non
rinuncia mai totalmente. Si limita a delegarli.Allo scopo di salvaguardare il popolo dalla concentrazione dei poteri,
Locke escogitò un governo diviso in tre rami, ognuno dei quali avrebbe dovuto controllare gli altri, e chiamò esecutivo,
legislativo e federativo questi tre rami. L’esecutivo e il legislativo avrebbero avuto più o meno la stessa funzione che
hanno oggi nel governo degli Stati Uniti, mentre i doveri del ramo federativo consistevano nel condurre i negoziati con
le potenze straniere.
Locke temeva molto la possibile concentrazione dell’autorità nell’esecutivo; di conseguenza ne limitò fortemente i
poteri. In primo luogo, nello stato ideale l’organo legislativo andava riconosciuto come autorità suprema. Esso e solo
esso aveva il potere di promulgare le leggi; l’esecutivo aveva soltanto il compito di applicarle. Inoltre l’esecutivo non
poteva punire chi non avesse violato una legge esplicitamente promulgata; e anche questa punizione andava demandata
a un ordine giudiziario imparziale. Inoltre, il diritto dell’esecutivo all’obbedienza proviene solo dal fatto che esso è la
persona, o il corpo, investito del potere dalla legge. Di per sé non ha autorità alcuna e non può pretendere obbedienza se
non in quanto fa rispettare la legge. Da questo punto di vista il sistema lockiano assomiglia al governo parlamentare
britannico. L’esecutivo può essere rimosso immediatamente dalla carica se il legislativo, ovvero il popolo, pensa che
abbia violato i limiti del potere concessogli.
Nel contempo, per adempiere ai propri doveri, l’esecutivo deve possedere alcuni poteri specifici. Innanzitutto, può
sciogliere e convocare l’assemblea legislativa; ma per evitare che manchi di convocarla, si dovrà porre un limite al
periodo di sospensione.
Trascorso questo limite, o l’esecutivo convoca il legislativo oppure viene esso stesso rimosso. Se l’esecutivo si rifiuta,
il popolo ha il diritto di usare la forza nei suoi confronti. Locke non riteneva necessario che il legislativo fosse
perennemente in sessione, poiché non è necessario promulgare leggi di continuo; ma l’esecutivo deve invece restare
sempre al suo posto, dal momento che è sempre necessario far rispettare la legge. Nei periodi in cui il legislativo non è
in sessione, l’esecutivo ha il potere di gestire le eventuali emergenze nazionali. Questa è la celebre dottrina della
"prerogativa". Locke definisce la prerogativa come "potere di deliberare, secondo discrezione, per il pubblico bene
senza la prescrizione della legge, e talvolta anche contro di essa" (p. 369). Locke ammise che l’uso della prerogativa da
parte dell’esecutivo avrebbe potuto rivelarsi pericoloso; ma pensava che con le contromisure previste nella sua teoria
ogni violazione grave della legalità avrebbe potuto esser contrastata dagli altri rami del governo e dal popolo.
Critiche a Locke
Nel Secondo trattato Locke tentò di mostrare come gli uomini potessero vivere insieme pacificamente senza
sottomettersi a un sovrano in possesso di autorità assoluta. Si può giungere a questo stato di cose attraverso il governo
della legge. Le leggi scelte apertamente e promulgate pubblicamente rendono stabile la società; e tuttavia esse non sono
intoccabili. Se finiscono per rivelarsi infine inadeguate, si possono cambiare. Hobbes riteneva invece che le uniche
alternative possibili fossero l’anarchia o il dispotismo. O gli uomini affrontavano una guerra di tutti contro tutti oppure
cedevano i loro diritti a un sovrano assoluto. La genialità di Locke consistette nel capire che la teoria hobbesiana era
carente da un punto di vista essenziale: cedendo i loro diritti a un sovrano assoluto gli uomini non sarebbero affatto stati
più al sicuro di quanto erano nello stato di natura, perché si sarebbero ritrovati soggetti ai capricci e alle fisime del
monarca. Sarebbero ancora vissuti nella precarietà, ma questa volta il pericolo non sarebbe venuto dai loro compagni,
bensì dal loro governante. Invece di scambiare, come pensava Hobbes, l’anarchia con la stabilità, avrebbero
semplicemente barattato una forma di caos con un’altra.
Grazie alla sua intuizione della compatibilità tra stabilità e autogoverno, Locke è divenuto la fonte di ispirazione per
quelle società democratiche che esistono, con successo, da più di due secoli a questa parte. I suoi argomenti, in una
forma o nell’altra, sono spesso stati ripresi nelle battaglie per l’autogoverno. Per esempio, Abraham Lincoln si oppose a
chi voleva conservare un suffragio il più limitato possibile con termini che sono quasi una parafrasi del Secondo
trattato:
Una maggioranza tenuta a freno da controlli e limiti costituzionali, che cambi sempre facilmente sotto l’urto dei
mutamenti meditati dei sentimenti e dell’opinione pubblica, è l’unico vero sovrano di un popolo libero. Chiunque
rifiuti questo principio cade necessariamente nell’anarchia o nel dispotismo. L’unanimità è impossibile; il governo
di una minoranza, come soluzione permanente, è completamente inammissibile; e quindi, se si rifiuta il principio
della maggioranza, tutto ciò che resta è, in qualsivoglia forma, l’anarchia o il dispotismo.
Le ragioni del rifiuto della dottrina hobbesiana da parte di Locke dipendono in parte dalla sua teoria della natura umana,
ma in parte anche dalla costruzione di una teoria delle relazioni politiche completamente nuova, che implica nozioni
come i "diritti", la "legge", lo "scopo appropriato del governo" e simili. Nel respingere la tesi hobbesiana che gli uomini
agiscono sempre egoisticamente, Locke era indubbiamente nel giusto. Ma a parte la questione psicologica, che abbiamo
già discusso, cosa si può dire pro e contro la sua teoria politica?
A questa teoria sono state rivolte due critiche principali: una contro la dottrina dei "diritti", l’altra contro l’idea del
governo della maggioranza. Entrambe queste dottrine, quando le si approfondisce, mostrano delle difficoltà.
Occupiamoci prima della questione dei diritti.
L’obiezione principale mossa alla dottrina dei diritti di Locke è che si basa sull’idea di "diritto naturale", di cui gli
uomini godono nello stato di natura, prima della nascita di una società organizzata. I critici sostengono che una tesi di
questo genere è incomprensibile, poiché è difficile capire come potessero esistere dei diritti prima dell’esistenza di un
governo e di un sistema legale che li concedesse e li imponesse. L’esame del termine rivela che esso non ha questo tipo
di significato descrittivo: esso implica una tesi prescrittiva, cioè che gli uomini dovrebbero possedere questi diritti. La
cosa fa nascere inevitabilmente qualche dubbio sulla validità dell’argomentazione di Locke, che sembra basarsi sulla
convinzione che nello stato di natura gli uomini possedessero realmente questi diritti in senso letterale. Ma anche se
accettiamo la tesi di Locke e ammettiamo che gli uomini dovrebbero possedere questi diritti, ci sono altre difficoltà da
superare. Per esempio, i diritti che noi pensiamo gli uomini debbano avere potrebbero essere incompatibili con l’idea di
"bene pubblico". Locke ha sostenuto che lo scopo del governo è di preservare alcuni diritti e nel contempo di operare
per il bene comune. Ma possono esserci casi in cui noi, se fossimo il governo, non potremmo fare entrambe le cose.
Consideriamo il caso dell’uomo che, sapendo che non c’è alcun incendio, grida "al fuoco" in un teatro affollato. Alcune
persone potrebbero essere schiacciate mentre tentano di uscire dal locale; altre potrebbero venir ferite, altre ancora
uccise. Se accettiamo la dottrina che un uomo ha diritto alla "libertà di parola", non possiamo punire il responsabile: ha
soltanto parlato liberamente. Ma in questo caso l’esercizio della libertà di parola è ovviamente incompatibile con il
bene pubblico. La persona in questione è una minaccia per il pubblico, e quando lo puniamo lo facciamo perché ha
agito contro il bene di tutti. Ma è chiaro che in questo modo noi abbandoniamo l’idea di un diritto assoluto alla libertà
di parola.
I filosofi democratici che hanno riflettuto su questo problema si sono mostrati disposti, nel complesso, ad abbandonare,
in questi casi, la dottrina dei diritti. Secondo loro gli uomini non possono rivendicare libertà assoluta contro lo stato;
ma da questo non segue che lo stato abbia un’autorità assoluta sugli uomini. È necessaria un’interpretazione più
moderata dei "diritti". Per questa interpretazione i diritti sono aree che possono essere violate solo con il consenso della
maggioranza, quando il benessere pubblico è realmente in pericolo. In caso contrario la libertà di parola può essere
conservata. Questa dottrina più moderata limita l’idea lockiana di diritto, ma non giunge ad ammettere la tirannia. Essa
sostiene che, per quel che riguarda la sostanza di un diritto, si tratta di una questione di grado: si può interferire in
alcune aree della condotta umana solo in momenti di grande crisi, altrimenti non bisogna metterci mano. In tal modo,
concede ancora agli uomini grandi spazi di libertà all’interno della società, anche se non si dà loro libertà assoluta. In
ogni caso, la libertà non può essere mai assoluta. La totale assenza di controlli non è libertà, è licenza. L’idea di libertà
è perfettamente compatibile con l’esistenza di restrizioni della nostra condotta. Il problema reale riguarda quali tipi di
restrizioni possano essere giustificati.
La seconda critica fondamentale alla teoria politica di Locke riguarda l’idea di governo della maggioranza. Nello
stabilire chi deve governare, Locke, al contrario di Platone e Hobbes, si pone dalla parte dei molti contro i pochi.
Questa dottrina ha avuto nel complesso effetti positivi. Per tradizione i pochi sono sempre stati i ricchi e i privilegiati,
che nel governare hanno servito i propri interessi, o gli interessi di una classe ristretta, in contrasto con quelli della
maggioranza. Ma ciò che Locke non giunse mai a comprendere è che la maggioranza stessa può diventare una tirannia;
essa può rivelarsi di un dispotismo tanto feroce quanto quello di un monarca nel sottomettere la minoranza. Il governo
democratico non è un mero governo di maggioranza, è anche un governo in cui i diritti delle minoranze debbono essere
ugualmente protetti. Se non si tiene fermo questo punto, il governo della maggioranza diviene dispotico e la democrazia
si trasforma in un regime che in pratica è indistinguibile da un’oligarchia. Locke insiste molto sul governo della
maggioranza, e in questo è nel giusto. Ma nel contempo nessun governo che non provveda alla protezione delle
minoranze può essere una democrazia: toccò al grande critico di Locke, John Stuart Mill, completare la teoria
democratica mettendo in rilievo quest’ultimo punto. Passiamo quindi a discutere le tesi di Mill.
La filosofia politica di John Stuart Mill
Ogni studioso di storia è stato colpito, presto o tardi, da quanto poche siano le civiltà che abbiano concesso la libertà
politica ai loro cittadini. La libertà è invero una cosa preziosa. Ebbe poco spazio nel mondo antico, nessuno nel
Medioevo, e a tutt’oggi le società che la concedono sono una minoranza. Molti attacchi contro di essa sono venuti
tradizionalmente da "destra", da società dominate da tiranni o da piccoli gruppi. Ma oggi la libertà viene minacciata
anche da "sinistra", ovvero dalle cosiddette società comuniste. Queste è una minaccia tremenda, e però ovvia. Ma
alcuni pericoli per la libertà sono più insidiosi; vengono dall’interno della democrazia stessa. Uno di questi è il potere
esercitato dalla maggioranza in uno stato democratico. Quando si concede a questo potere di espandersi, esso può
condurre a una forma di tirannia altrettanto terribile di qualsiasi dispotismo, una tirannia della maggioranza sui gruppi
minoritari. Il classico Saggio sulla libertà di Mill può essere considerato un tentativo di trovare un metodo per
eliminare questa minaccia.
Mill comincia il Saggio avvertendo che il suo argomento sarà la libertà civile (ovvero i limiti del potere della società
sull’individuo), non il libero arbitrio. La questione del contrasto tra autorità e libertà, come il problema del libero
arbitrio, è una questione antica. In origine si pensava alla "libertà" in termini negativi, come all’insieme dei modi in cui
cittadini si proteggevano dall’autorità dei loro governanti.
I teorici politici ritenevano il sovrano necessario per il benessere della società, ma nel contempo pericoloso per essa.
Era necessario per difendere la società dai nemici interni ed esterni; ma nel preservare la pace poteva oltrepassare la
propria autorità legittima e divenire un tiranno. Lo scopo dei primi libertari fu quindi quello di porre dei limiti al potere
del governante sui cittadini. Ciò andava fatto in due modi: (a) con una dottrina dei diritti (se il sovrano li violava, la
ribellione era giustificata) e (b) con una serie di controlli costituzionali sul sovrano stesso in alcune sfere importanti,
come per esempio la dichiarazione di guerra.
Tuttavia, con lo sviluppo delle società democratiche, i teorici politici giunsero a respingere la tesi che l’interesse del
governante si opponeva a quello del popolo. Dal loro punto di vista chi stava al governo era un rappresentante del
popolo, e la sua autorità era revocabile in ogni momento. Poiché i governanti sono delegati dai governati, non è
importante limitare il loro potere – anzi, farlo equivale, in verità, a limitare il potere del popolo stesso.
Mill sottolinea che, nonostante questa posizione sia teoricamente corretta, uno studio dello sviluppo reale delle
istituzioni all’interno della democrazia mostra la necessità pratica di porre alcune limitazioni ai poteri del governo. Il
termine "autogoverno" non esprime la reale natura della questione. Le persone che esercitano il potere non sono le
stesse su cui il potere viene esercitato. Esse non solo badano ai loro propri interessi, ma vengono frequentemente spinte
da gruppi di pressione (come i lobbisti) a operare contro il benessere del popolo. L’idea delle limitazioni del potere del
governante rimane quindi importante, anche se in teoria i governanti stessi sono responsabili di fronte al popolo.
La tirannia che la maggioranza del popolo può esercitare sulla minoranza è tuttavia ancora più pericolosa della
minaccia per la libertà rappresentata dai governanti. Uno degli elementi fondamentali della democrazia è che essa
concede ampi spazi per comportarsi come si vuole, per lo sviluppo di interessi distanti da quelli della maggioranza e per
la soddisfazione di tutti questi diversi interessi. Tutto ciò può essere riassunto con il termine "individualismo". Ora, la
maggioranza può imporre un tipo di tirannia che impedisca lo sviluppo di un comportamento individualistico.
Questa tirannia può funzionare in due modi: (a) attraverso una pressione sul governo (o una pressione che nasce
all’interno stesso del governo) perché adotti leggi che operino contro individui fuori dalla norma, anticonformisti o
dissidenti, anche se questi individui non sono nocivi (per esempio la "caccia alle streghe" nella Nuova Inghilterra
secentesca); (b) con la semplice pressione dell’opinione pubblica. Anche se non sono in vigore leggi specifiche, una
pubblica opinione ostile a un individuo anticonformista può essere tanto forte da privarlo dei consueti benefici della
società. Nel primo caso la dottrina dei diritti può impedire, in ampia misura, che siano promulgate leggi le quali
penetrino in aree che una persona potrebbe considerare sacre e quindi inviolabili (come la libertà di parola e così via).
Ma la minaccia viene dall’opinione pubblica. E l’opinione pubblica è notoriamente soggetta a errore: può rispecchiare
antichi pregiudizi, o essere dominata da superstizioni e tradizioni. Di conseguenza, sostiene Mill, l’opinione pubblica
non dovrebbe diventare una legge sia pure non scritta cui gli individui si debbano conformare. In una società
democratica funzionante in modo corretto, per i singoli dovrebbe essere possibile sia godere della protezione della
legge contro il modo di sentire prevalente nella società, sia agire liberamente di fronte all’opinione della maggioranza,
ove non esistano leggi, ma solo costumi. Il problema che ogni stato democratico deve affrontare può essere così
formulato: alcuni tipi di condotta individuale non possono, ovviamente, essere tollerati (per esempio un comportamento
criminale); non è tuttavia necessario reprimere ogni comportamento anticonformista; quindi il problema sta
nell’identificare il punto sino al quale la maggioranza può legittimamente spingersi nell’interferire con gli affari
individuali o di gruppi minoritari, che non si conformino alla condotta della maggioranza stessa. Scrive Mill:
Come altre tirannie, quella della maggioranza fu dapprima – e volgarmente lo è ancora – considerata, e temuta,
soprattutto in quanto conseguenza delle azioni delle pubbliche autorità. Ma le persone più riflessive compresero
che, quando la società stessa è il tiranno – la società nel suo complesso, sui singoli individui che la compongono –,
il suo esercizio della tirannia non si limita agli atti che può compiere per mano dei suoi funzionari politici. La
società può eseguire, ed esegue, i propri ordini: e se gli ordini che emana sono sbagliati, o comunque riguardano
campi in cui non dovrebbe interferire, esercita una tirannide sociale più potente di molti tipi di oppressione
politica, poiché, anche se generalmente non viene fatta rispettare con pene altrettanto severe, lascia meno vie di
scampo, penetrando più profondamente nella vita quotidiana e rendendo schiava l’anima stessa. Quindi la
protezione dalla tirannide del magistrato non è sufficiente: è necessario anche proteggersi dalla tirannia
dell’opinione e del sentimento predominanti, dalla tendenza della società a imporre come norme di condotta e con
mezzi diversi dalle pene legali, le proprie idee e usanze a chi dissente, a ostacolare lo sviluppo – e a prevenire, se
possibile, la formazione – di qualsiasi individualità discordante, e a costringere tutti i caratteri a conformarsi al suo
modello. Vi è un limite alla legittima interferenza dell’opinione collettiva sull’indipendenza individuale: e trovarlo,
e difenderlo contro ogni abuso, è altrettanto indispensabile alla buona conduzione delle cose umane quanto la
protezione dal dispotismo politico (p. 27).
Al quesito: "Quali sono i poteri legittimi che la società può esercitare sull’individuo?" Mill risponde nel seguente
modo:
Scopo di questo saggio è formulare un principio molto semplice, che determini in assoluto i rapporti di coartazione
e controllo tra società e individuo, sia che li si eserciti mediante la forma fisica, sotto forma di pene legali, sia
mediante la coazione morale dell’opinione pubblica. Il principio è che l’umanità è giustificata, individualmente o
collettivamente, a interferire sulla libertà d’azione di chiunque soltanto al fine di proteggersi: il solo scopo per cui
si può legittimamente esercitare un potere su qualunque membro di una comunità civilizzata, contro la sua volontà,
è per evitare danno agli altri. Il bene dell’individuo, sia esso fisico o morale, non è una giustificazione sufficiente.
Non lo si può costringere a fare o non fare qualcosa perché è meglio per lui, perché lo renderà più felice, perché,
nell’opinione altrui, è opportuno o perfino giusto: questi sono buoni motivi per discutere, protestare, persuaderlo o
supplicarlo, ma non per costringerlo o per punirlo in alcun modo nel caso si comporti diversamente. Perché la
costrizione o la punizione siano giustificate, l’azione da cui si desidera distoglierlo deve essere intesa a causar
danno a qualcun altro. Il solo aspetto della propria condotta di cui ciascuno deve render conto alla società è quello
riguardante gli altri: per l’aspetto che riguarda soltanto lui, la sua indipendenza è, di diritto, assoluta. Su se stesso,
sulla sua mente e sul suo corpo, l’individuo è sovrano (pp. 32-33).
Mill ha posto alcune limitazioni a questo principio. In primo luogo, egli ha dato per scontato che il principio non fosse
applicabile ai bambini. Essendo immaturi, devono essere guidati. Analogamente, per alcuni "stati arretrati" è necessario
un governo paternalistico. Questi stati, se si concedesse loro l’autogoverno, piomberebbero semplicemente nel caos.
Nell’intera sua analisi l’assunzione è che il principio vada applicato solo a persone mature e razionali; ma, a differenza
di Platone, convinto che solo pochi, particolarmente addestrati, potessero soddisfare il criterio della razionalità, Mill
dichiara esplicitamente che a suo parere tutti i cittadini delle nazioni moderne si trovano in questa condizione.
Per mostrare in che modo il principio possa funzionare nella pratica, Mill prende come caso esemplare la soppressione
dell’opinione e della discussione. Egli fornisce tre ragioni per cui sarebbe sbagliato sopprimere una qualsiasi opinione.
Prendiamole in considerazione una alla volta.
In primo luogo, è sbagliato sopprimere un’opinione non approvata dalla maggioranza perché tale opinione potrebbe
essere vera. Tutti noi sappiamo di casi in cui la maggioranza ha sostenuto credenze false; se la credenza contraria fosse
soppressa, potremmo non giungere mai alla verità, e questo a lungo termine potrebbe essere dannoso (un esempio di
credenza falsa molto diffusa è quella che il mondo fosse piatto). Un’opinione falsa viene spesso corretta per mezzo
della libera discussione. È saggio chi in una disputa ascolta tutte le parti ed esamina le prove pro e contro ognuna di
queste, prima di decidere quale parte sia nel vero. Ma se non si permette che venga espressa un’opinione contraria a
quella generalmente accettata, non si avrà mai l’occasione di scambiare la falsità con la verità.
Negare agli altri il diritto di esprimere le proprie opinioni significa presumersi infallibili. Ma nessuno è infallibile, e
quindi è sempre possibile che l’opinione che abbiamo in un dato caso sia sbagliata. Qualcuno potrebbe obiettare che
nella pratica reale è necessario presumere di non essere in errore quando si adotta una determinata linea di condotta. Se
si ritiene necessario dichiarare guerra a un aggressore, bisognerebbe forse sospendere il giudizio? Non sarebbe pratico.
La risposta di Mill a questa obiezione è una delle più famose massime della storia del liberalismo:
Vi è la massima differenza tra presumere che un’opinione sia vera perché, pur esistendo ogni opportunità di
discuterla, non è stata confutata, e presumerne la verità al fine di non permetterne la confutazione. È proprio la
completa libertà di contraddire e confutare la nostra opinione che ci giustifica quando ne presumiamo la verità ai
fini della nostra azione; e solo in questi termini chi disponga di facoltà umane può trovare una sicurezza razionale
di essere nel giusto .
Il secondo argomento di Mill contro la soppressione delle opinioni contrarie alle nostre è il seguente. Supponiamo pure
che l’opinione contraria alla nostra sia sbagliata e che siamo noi a sostenere quella giusta. Nondimeno, anche
un’opinione vera può esser sostenuta in più modi: può esser sostenuta in modo aperto da una mente sempre pronta a
cambiare il suo punto di vista in presenza di nuove prove, oppure può esser sostenuta sulla base del puro pregiudizio.
Ora, quando sosteniamo l’opinione vera, ma non siamo disposti ad ascoltare le opinioni contrarie, la stiamo sostenendo
nel modo sbagliato, come un pregiudizio. Ciò può fare danno, perché riflettendo sugli argomenti contrari, ed essendo
quindi costretti a pensare ai modi di confutarli, arriviamo in verità a comprendere meglio la nostra stessa opinione. Chi
combatte per la democrazia senza capire per cosa sta combattendo potrebbe in altre circostanze ritrovarsi a combattere
contro di essa. Una persona del genere si limita a rispecchiare il modo di sentire prevalente nella società in cui vive,
senza nemmeno tentare di giustificare la validità di tale modo di sentire. Potrebbe quindi combattere per la democrazia,
ma per le ragioni sbagliate, o, peggio ancora, per nessuna ragione in particolare, salvo il fatto che la società comanda di
comportarsi in questo modo. Tutto ciò è di ostacolo al progresso futuro: una società democratica ha bisogno di
individui illuminati, maturi e responsabili che riflettano sulle questioni che devono affrontare. Chi non prende
seriamente in considerazione le opinioni contrarie, non potrà divenire una persona di questo genere; ed è per questo che
non dobbiamo sopprimere il punto di vista opposto al nostro senza dargli la possibilità di far sentire la propria voce.
Su questo argomento Mill scrive:
Supponiamo che, per controbattere la forza di queste considerazioni, un nemico della libertà di discussione affermi
che non è necessario che tutti gli uomini conoscano e comprendano tutto ciò che filosofi e teologi possono asserire
pro e contro le reciproche opinioni. Che gli uomini normali non hanno bisogno di essere in grado di individuare
tutte le inesattezze e gli errori di un ingegnoso oppositore; basta che ci sia sempre qualcuno capace di
controbattervi in modo da confutare tutto ciò che potrebbe trarre in inganno gli incolti. Che dei semplici, cui siano
stati insegnati i fondamenti più evidenti delle verità che gli sono state inculcate, possono per il resto affidarsi
all’autorità e, consci di non possedere né le conoscenze né l’ingegno necessari a risolvere ogni possibile difficoltà,
star certi che tutte quelle già affiorate sono state, o possono essere, risolte da chi è specialmente addestrato a questo
compito.
Pur accordando a questo ragionamento tutto il valore che può avere per coloro cui non importa che si creda in una
verità senza comprenderla perfettamente, l’argomento a favore della libera discussione non ne esce in alcun modo
indebolito. Infatti persino questa dottrina ammette che gli uomini dovrebbero avere la sicurezza razionale che a
tutte le obiezioni si è risposto in modo soddisfacente; e come si risponde se la risposta adatta non viene formulata?
Oppure, come si può sapere che è soddisfacente se gli obiettori non hanno l’opportunità di dimostrare che non lo è?
Se non il pubblico, almeno i filosofi e i teologi deputati a risolvere le difficoltà devono familiarizzarsi con esse,
nelle loro forme più complesse; il che non è possibile se non vengono enunciate liberamente e nella luce a esse più
vantaggiosa. La chiesa cattolica ha un suo modo di risolvere questo imbarazzante problema: compie una netta
distinzione tra coloro cui è permesso di adottare le sue dottrine per convinzione e chi deve accettarle sulla fiducia.
In effetti, a nessuno dei due gruppi è consentito scegliere che cosa accettare: ma il clero, o almeno quella parte di
esso che è completamente fidata, può legittimamente e meritoriamente studiare gli argomenti degli oppositori per
poterli controbattere, e quindi può leggere libri eretici; invece i laici non lo possono salvo che in seguito a una
speciale dispensa, difficile da ottenere. Questa disciplina riconosce che la conoscenza degli argomenti nemici è
utile ai suoi maestri, ma trova modo, coerentemente, di negarla al resto del mondo, permettendo così all’élite una
cultura, anche se non una libertà intellettuale, superiore a quella che permette alle masse. Con questo mezzo la
chiesa riesce a conseguire il genere di superiorità intellettuale richiesto dai suoi scopi; poiché, anche se la cultura
senza libertà non ha mai formato una mente liberale e di ampie vedute, può formare un astuto avvocato del nisi
prius. Ma nei paesi che professano il protestantesimo questa soluzione è impossibile, poiché i protestanti
affermano, almeno in teoria, che ciascuno deve avere la responsabilità di scegliersi la religione, e non può
scaricarla sui suoi maestri. Inoltre, al giorno d’oggi è praticamente impossibile mantenere la popolazione incolta
all’oscuro di opere che le persone colte leggono. Perché i maestri dell’umanità possano conoscere tutto ciò che
dovrebbero vi deve essere libertà incondizionata di scrittura e pubblicazione (pp. 63-65).
La terza ragione per non sopprimere l’opinione opposta alla nostra prima di averla ascoltata è che anche se non è né
completamente vera né completamente falsa può contenere elementi di verità. Le teorie politiche sono estremamente
complesse. Una teoria politica dalla quale dissentiamo potrebbe essere in errore per le cose principali, ma contenere
elementi di vero, e se non l’ascoltassimo potremmo perdere l’occasione di scoprire anche questo poco di verità.
Critiche a Mill
Come abbiamo osservato sopra, Mill può essere considerato colui che ha completato la teoria democratica. Locke ne ha
formulato i punti principali, come il governo delle leggi, la dottrina dei "diritti naturali" e, cosa più importante, il
governo della maggioranza. A questo quadro Mill aggiunse la clausola che la minoranza deve essere protetta dalla
possibile tirannia della maggioranza. Poiché non accettava la dottrina dei diritti naturali, egli tentò di giustificare la
limitazione del potere della maggioranza su basi utilitariste, sostenendo, grosso modo, che l’interferenza nelle questioni
personali alla lunga si rivelerà dannosa per una società democratica. Se si permetterà alle simpatie e alle antipatie della
maggioranza di divenire tanto potenti da agire come leggi non scritte, si impedirà sia lo sviluppo dell’iniziativa
individuale sia la maturazione dei cittadini. Dopo la pubblicazione del Saggio sulla libertà, questa dottrina è stata
accettata dalla maggior parte dei teorici democratici, ma è stata anche attaccata perché sarebbe impossibile metterla in
pratica.
Mill sostenne che la maggioranza può interferire legittimamente nelle faccende della minoranza solo se la condotta di
quest’ultima si rivela dannosa per il tessuto della società. Ma ciò solleva un problema difficile: come facciamo a dire se
tale condotta si rivela o no dannosa? La risposta, osservano questi critici, spetterà alla fin fine alla maggioranza, che si
esprimerà attraverso una legge promulgata da un corpo legislativo eletto. Quindi le salvaguardie della minoranza sono
in ultima analisi sempre destinate a crollare sotto l’urto della maggioranza. Dal punto di vista di una politica realista, la
minoranza è al sicuro solo finché la maggioranza glielo concederà e se questo è vero, non ci sono aree della condotta
umana immuni dalle sue interferenze (né, sostiene qualcuno, dovrebbero essercene).
Se Mill fosse vissuto abbastanza a lungo da rispondere a questa obiezione, avrebbe potuto dichiararsi in parte
d’accordo. Se la maggioranza pensa che un individuo o un gruppo di individui abbia un comportamento dannoso per la
società, può votare leggi che limitino tale condotta. Mill non intende negare la legittima autorità della maggioranza
nella società democratica. Per esempio, per la protezione della maggioranza è necessario che si promulghino leggi
contro la vendita di cibo e bevande adulterate. Ma anche in questi casi, sosterrebbe Mill, tocca alla maggioranza stessa
l’onere di provare che la sua interferenza è legittima. Essa non può interferire legittimamente nella condotta di una
persona solo perché non l’approva: deve dimostrare di più, cioè che tale condotta è dannosa per la società. Se non lo
può dimostrare, alla minoranza deve essere concesso di comportarsi come preferisce. Sul piano pratico, la filosofia di
Mill si riduce a questo: in ogni questione legale tra un individuo e lo stato, l’onere di provare che il comportamento di
un singolo è indesiderabile spetta sempre allo stato, non all’individuo. Questa assunzione, una volta accettata (come è
successo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti), fornirà all’individuo una forte garanzia contro l’interferenza della
maggioranza, anche se non gli assicura un’immunità totale.
Il quesito "Chi dovrebbe governare?" suggerisce un utile modo di studiare la storia della filosofia politica. Platone,
Hobbes e, di fatto, la maggior parte dei teorici politici sino a Locke, hanno sostenuto che dovevano governare individui
o gruppi speciali. D’altro lato Locke fornisce argomenti molto potenti a favore del governo "del popolo", interpretato
come governo della maggioranza. Come Locke, Mill crede che la maggioranza debba governare perché nel complesso
essa minaccia la libertà dell’umanità meno pesantemente di quanto farebbe qualsiasi governante singolo o qualsiasi
gruppo. Ma anche all’interno della democrazia il governo della maggioranza va limitato, allo scopo di salvaguardare la
libertà personale. Passiamo ora a Karl Marx, un filosofo che, come Mill e Locke, voleva veder governare "il popolo",
ma la cui filosofia ha conseguenze pratiche antitetiche alla libertà.
La filosofia politica di Karl Marx
Karl Marx nacque a Treviri, in Prussia, nel 1818. Venne allevato in un confortevole clima da classe medio-alta,
piuttosto convenzionale, molto lontano dalle condizioni di disagio economico in cui passò la maggior parte dell’età
adulta. Fu mandato alle università di Bonn e di Berlino, dove si laureò con lode, ricevendo il titolo di dottore in
filosofia. Per come vanno di solito le cose, con questo retroterra ci si sarebbe potuti aspettare che seguisse una carriera
accademica, scomparendo dalla storia in una nuvola di riferimenti incrociati e di note a piè pagina, come succede a
molti insigni professori. Ma così non avvenne. Anche in quegli anni giovanili, Marx era considerato troppo radicale per
la vita accademica; di conseguenza scelse di lavorare alla Rheinische Zeitung, una rivista di sinistra che si opponeva
strenuamente alla politica governativa. Quando la rivista venne soppressa, Marx lasciò la Germania e si recò prima a
Parigi, poi a Bruxelles, dove restò sino alla rivoluzione del 1848, quando tornò a Colonia. Dopo il fallimento della
rivoluzione, lasciò nuovamente la Germania, sistemandosi questa volta a Londra, dove trascorse il resto della vita.
In Inghilterra Marx riallacciò la sua amicizia con Friedrich Engels, che aveva conosciuto sul continente, e che aveva
collaborato con lui alla stesura del Manifesto del partito comunista nel 1847. Il padre di Engels era un importante
industriale cotoniero di Manchester, che era anche, come spesso avviene ai padri con i figli radicali, un convinto
conservatore. Engels lavorava per lui e con parte del suo stipendio aiutava Marx, che in questo periodo viveva in
estrema povertà. Nel 1870 Engels si trasferì da Manchester a Londra, e, insieme a Marx, fondò l’Associazione
internazionale dei lavoratori (nota a volte come Prima Internazionale), un’organizzazione volta a migliorare le sorti dei
lavoratori. Marx morì nel 1883 ed Engels, lavorando sulle sue annotazioni, completò i volumi finali del Capitale, il suo
capolavoro politico. Engels morì nel 1895.
La filosofia politica di Marx è una dottrina molto complessa, che contiene almeno tre elementi distinti. Il primo è una
metafisica, ereditata da Hegel, in cui egli tenta di provare che gli eventi politici, sociali ed economici devono essere
interpretati alla luce di alcune leggi generali della storia, note come "dialettica". Il secondo è una teoria economica, in
cui Marx propone una difesa del socialismo e una critica al capitalismo; e il terzo è un’etica, che mette l’accento sui
valori umani, contrapposti ai valori associati ai beni materiali. Prendiamo in considerazione questi elementi, uno per
volta a partire da quello metafisico.
La metafisica di Marx: l’influenza di Hegel
G.W.F. Hegel è stato, da ogni punto di vista, il più importante filosofo tedesco dell’Ottocento. Come molti giovani
intellettuali del periodo, Marx venne molto influenzato dai suoi scritti, e in particolare da quelli di filosofia della storia.
Più avanti nella vita Marx avrebbe criticato severamente l’hegelismo, ma non riuscì mai a liberarsene davvero. Anzi, le
sue dottrine politiche sono comprensibili, in gran misura, solo alla luce della metafisica di Hegel, come cercheremo qui
di dimostrare. Grosso modo, l’influenza di Hegel consistette in questo: Marx era convinto che Hegel avesse trovato una
legge storica generale, nota come "dialettica", ma riteneva che ne avesse fatto un uso metafisico anziché scientifico.
Egli accettava l’esistenza della dialettica, ma tentò di renderla materialistica spiegando il processo storico in termini
economici anziché metafisici e applicandola alle classi invece che alle nazioni; cercò cioè di spiegare la storia in
termini di uno scontro di classe, e non di uno scontro tra nazioni, come aveva fatto Hegel.
Come abbiamo appena visto, l’idea essenziale dell’opera di Hegel – un’idea che Marx accettava, ma applicava in modo
diverso – era ciò che egli stesso definiva "dialettica". Hegel aveva preso a prestito il termine da Platone, ma gli aveva
dato un significato molto più ampio. In Platone si considera la dialettica come un particolare tipo di processo logico. È
un modo di argomentare, che impiega ciò che i logici moderni chiamano "il metodo del caso contrario"; viene usato
allo scopo di trarre da colui cui viene applicato delle informazioni che egli possiede, ma di cui potrebbe non essere
consapevole. Così, ponendo delle domande a un giovane schiavo che non ha mai studiato geometria, Socrate ricava
alcuni teoremi geometrici; o ancora, ponendo delle domando a Cefalo, Polemarco e altri, nella Repubblica Socrate
cerca di trarre da loro una descrizione corretta della natura della "giustizia". Il metodo funziona nel seguente modo:
qualcuno propone una tesi sulla natura della giustizia. Per esempio, la Repubblica si apre con Cefalo che suggerisce che
"giustizia" equivale a "dire la verità e ridare le cose ricevute" (p. 33). Il passo successivo dell’applicazione del metodo
consiste nel trovare un caso contrario alla tesi, ovvero un caso di cui noi diremmo in genere che implica la giustizia ma
non il dire la verità. Hegel lo definisce "antitesi". La riconciliazione di tesi e antitesi produce una "sintesi" che diviene
essa stessa una nuova tesi a un livello più avanzato. Applicando ininterrottamente questo metodo, proponendo cioè tesi
e antitesi, si giunge infine a una descrizione corretta della natura della giustizia, che comprende e riconcilia sia la tesi
che l’antitesi.
Come esempio del procedimento si veda un brano della Repubblica: Cefalo propone che "giustizia" equivalga a "dire la
verità e ridare le cose ricevute". Socrate produce allora un caso contrario. Egli fa notare che se vi siete fatti prestare
un’arma da un amico e quest’ultimo diventa matto e ve la chiede indietro, voi non ritenete corretto o giusto ridargliela.
In questo caso la giustizia richiede che voi non ridiate le cose ricevute. Se è così, allora la giustizia è a volte
incompatibile con il ridare le cose ricevute; la tesi che "giustizia" equivalga a "ridare le cose ricevute" è falsa. Siamo
così costretti a produrre una nuova definizione, che includa sia la tesi originale sia il caso contrario. Quando la si è
trovata, essa sarà una sintesi della definizione originale e dell’obiezione che era stata avanzata nei suoi confronti.
In Hegel il termine "dialettica" ha più o meno lo stesso significato che in Platone. Si tratta di un processo logico, che
procede da tesi ad antitesi, e quindi a una sintesi che le combina insieme. Ma Hegel considera la dialettica qualcosa di
più di un semplice processo logico, se con questo termine si intende solo un’argomentazione verbale. Per lui si tratta di
un processo reale, cui si conformano gli eventi del mondo. Ogni cambiamento, e in modo speciale il cambiamento
storico, ha luogo secondo la legge della dialettica: viene prodotta una tesi, si sviluppa un’opposizione (la sua antitesi),
ne risulta un conflitto, che si risolve in una sintesi in cui sono incluse sia la tesi sia l’antitesi.
Come abbiamo detto, Hegel pensava che la storia potesse essere meglio compresa osservando l’evoluzione delle
nazioni alla luce della dialettica. Si può supporre che una certa nazione occupi nella dialettica una posizione analoga a
quella che occupa la tesi in un’argomentazione, ovvero a quella che occupa l’ipotesi che l’argomentazione dovrebbe
provare. Quando la nazione si sviluppa produce un’opposizione; e una nazione avversaria potrebbe esser vista come la
sua antitesi. Infine le due entrano in conflitto e dalla lotta emerge una nuova civiltà che è di ordine superiore alle due
precedenti. Essa sintetizza gli elementi più validi di entrambe. Questa nuova nazione diventa a sua volta una nuova tesi,
che a sua volte svilupperà un’antitesi e così via, ad infinitum. Hegel è inoltre convinto che si tratti di un processo che
conduce alla perfezione. È attraverso questo processo che lo stato avanza verso la realizzazione di ciò che Hegel definì
"spirito". Il fine o scopo dello sviluppo della natura essenziale di ogni stato è ciò che egli definisce "l’idea" o "l’idea
assoluta". Per Hegel il processo dialettico è quindi un processo spirituale o metafisico.
Con la scoperta della dialettica Hegel pensava di aver trovato una legge necessaria di natura. Non si trattava solo del
fatto che qualche volta le nazioni si scontravano le une con le altre; era invece logicamente necessario che per sua
stessa natura una nazione producesse infine il suo opposto, si scontrasse con esso, e proseguisse lungo il restante
percorso della dialettica. In breve, il corso della storia è determinato dalla dialettica e nulla lo può alterare. Gli uomini
pensano di poter cambiare il corso della storia per mezzo dell’azione sociale, ma hanno semplicemente torto; non
conoscono la storia. Essi sono solo pedine della necessità storica: in verità è la dialettica a controllare il corso degli
eventi.
Marx accettò l’analisi hegeliana dell’evoluzione storica come processo prodotto da un movimento dialettico. Ma non
amava la spiegazione metafisica del processo e riteneva superficiale l’applicazione hegeliana della dialettica alle
nazioni. Preferiva una dialettica materialista; preferiva spiegare il processo dialettico della storia in termini economici
piuttosto che metafisici. La ragione per cui le nazioni cambiano è che le classi al loro interno cominciano a opporsi le
une alle altre. Non si dovrebbe pensare alla storia del mondo come a una storia di rivalità tra nazioni, ma, in senso più
pertinente, come a una storia di rivalità tra classi.
Barnett Savery ha colto molto bene questo punto:
I marxisti spiegano la dottrina degli opposti nel seguente modo: tutto contiene due principali forze opposte, la
prima chiamata tesi, la seconda antitesi. Queste due forze si distruggono l’una con l’altra, ma da ciò emerge una
nuova situazione, la sintesi. Alla fine anche questa sintesi si divide nei suoi due opposti, e noi ci ritroviamo con
una nuova tesi e una nuova antitesi. E da queste due forze opposte emerge una nuova sintesi e via di seguito. I
marxisti, come dimostreremo, usano questa idea per dimostrare che la società comunista è eticamente superiore a
tutte le società esistite in precedenza.
Le società basate sulla monarchia si sono divise, secondo i marxisti, in due opposti: da un lato i governanti re,
dall’altro i diseredati e gli schiavi. Lo scontro tra questi ha formato una sintesi, che ha dato vita alla società
feudale. Il feudalesimo si è poi diviso in due forze opposte, i signori e i servi; anche questo scontro è giunto alla
sintesi, dando vita al capitalismo moderno. E ora i marxisti sostengono che il capitalismo si è diviso nei suoi
opposti: da un lato i lavoratori e dall’altro i padroni. Secondo i marxisti la nuova società sarà il socialismo. A loro
parere ogni nuova società è superiore a quella che l’ha preceduta. Essi sostengono che il feudalesimo è superiore
allo stato regio; il capitalismo al feudalesimo; e il comunismo alla società capitalista.
Questo aspetto del marxismo ci mostra cosa si intende per scontro di classe: si tratta della dottrina degli opposti
così come si manifesta nella società. I marxisti sostengono di non creare lo scontro di classe, ma di limitarsi a
mostrarne l’esistenza, per poi usarla per contribuire all’avvento del comunismo. L’altra convinzione dei marxisti,
ovvero che ogni nuova società sia eticamente superiore alle forme sociali più antiche, è ottima propaganda per il
marxismo stesso. Senza dubbio molti abbracciano il comunismo perché credono di lavorare per un mondo migliore
di tutto ciò che l’ha preceduto.
Osserviamo più in dettaglio come Marx abbia applicato la dialettica alle classi e quali inferenze abbia tratto da tale
applicazione. Egli riteneva che ogni persona appartenesse all’uno o all’altro di certi gruppi socioeconomici, le
cosiddette "classi". Il sistema di classe di una data cultura è completamente determinato dai mezzi economici e dalle
condizioni di produzione presenti in questa cultura. Quindi a ogni epoca dello sviluppo economico corrisponde un
sistema di classe. Per esempio, durante il periodo della produzione basata sulla forza dei muscoli prevalse il sistema di
classe feudale. Quando la produzione basata sulla forza dei muscoli fu rimpiazzata dalla produzione basata sulla forza
del vapore, il capitalismo rimpiazzò il feudalesimo. Il capitalismo è un sistema economico con tre classi principali:
coloro che possiedono o controllano i mezzi di produzione, definiti da Marx "capitalisti"; coloro che dipendono
interamente per la loro sussistenza dai guadagni che ottengono lavorando per i capitalisti, ovvero la classe operaia; e
certi altri gruppi come i piccoli commercianti e i liberi professionisti (avvocati, dottori, professori e così via), che non
rientrano in nessuna delle altre due categorie: la classe media.
Secondo Marx tutte le relazioni di classe erano indipendenti dalla
volontà degli individui; di fatto, erano determinate dal sistema econo-mico dominante
Gli uomini pensano di poter scegliere la classe cui vogliono appartenere, ma questa opinione è solo autoinganno. Le
classi sono determinate in realtà dai mezzi di produzione e la classe cui una persona appartiene dipende dalla sua
posizione rispetto ai mezzi di produzione. Dal momento che gli stessi mezzi di produzione seguono il corso della storia,
ovvero la dialettica, ognuno di essi produrrà il suo opposto, portando così verso un conflitto. Il conflitto stesso produrrà
nuove relazioni tra le persone e i mezzi di produzione, provocando un mutamento nell’ordinamento di classe. Poiché le
classi sono determinate dalla loro relazione con i mezzi di produzione, anch’esse subiranno il dominio della dialettica.
Di conseguenza, si può descrivere in poche parole il corso della storia dicendo che segue il corso del conflitto di classe.
Per spiegare cosa intende Marx con conflitto di classe, prendiamo in considerazione un esempio specifico: l’ascesa del
socialismo nella società capitalistica.
Secondo Marx i progressi tecnologici della società capitalistica porteranno a un costante aumento della produttività.
Questa tendenza all’aumento della produttività significa che ci sarà un corrispondente aumento di ricchezza per la
classe che possiede i mezzi di produzione. Nel contempo le condizioni di vita della classe operaia peggioreranno;
invece di più denaro, i lavoratori ne avranno meno. Di fatto, la maggior parte del denaro esistente nella società si
concentrerà infine nelle mani dei pochi che possiedono i mezzi di produzione. Le classi intermedie saranno spazzate via
e il capitalismo presenterà un quadro con due classi opposte l’una all’altra: una classe piccola ma molto ricca ("la
borghesia") e una classe grande ma indigente ("il proletariato"). Tra le due classi si svilupperanno tensione e odio e
infine avrà luogo una rivoluzione, che porterà a una società senza classi, in cui non si avrà più sfruttamento dei
lavoratori. Questo è il socialismo così come Marx lo ha descritto. In questo quadro si distinguono facilmente i vari stadi
della dialettica. Il capitalismo presenta una tesi: bisogna lavorare per realizzare un profitto. Se si sviluppa la tesi si
giunge a una condizione in cui pochi posseggono i mezzi di produzione e tutti gli altri vengono assoggettati al controllo
di questi pochi. Ma, se si sviluppa la tesi, nasce antagonismo tra la grande classe dei lavoratori indigenti e la piccola
classe dei capitalisti. Questo è lo stadio della dialettica noto come "antitesi". Infine, scoppia un aperto conflitto e la
classe dei capitalisti viene distrutta. Sorge una nuova società senza classi (la "sintesi").
Possiamo così riassumere la metafisica di Marx: egli accetta la dottrina hegeliana secondo la quale la storia del mondo
segue un modello di forze che si scontrano, definito "dialettica". Hegel pensava che il modello si applicasse
principalmente alle nazioni, ma Marx dimostrò che si applicava alle classi. Le classi non sono determinate dalla volontà
o dalle inclinazioni degli individui, ma dai mezzi di produzione che esistono nelle varie culture. La classi producono i
loro stessi opposti, che portano a conflitti e infine al rovesciamento di un particolare sistema di classe. Nel caso del
capitalismo, il rovesciamento porterà a una società senza classi, ovvero al socialismo, in cui i mezzi di produzione
verranno controllati dagli operai (cioè, in tale società, da tutti i suoi membri).
Abbiamo definito la teoria di Marx, così come l’abbiamo abbozzata sinora, una teoria "metafisica" perché essa si fonda
sulla tesi che tutti i cambiamenti hanno luogo attraverso il conflitto, e inoltre attraverso un conflitto di una curiosa
specie logica. Ovviamente Marx pensava di aver scoperto una legge scientifica che si applicava alle classi e spiegava la
storia. Egli la riteneva scientifica perché spiegava lo sviluppo degli eventi basandosi su considerazioni materialistiche
(come i fattori economici), mentre secondo Hegel le nazioni erano motivate da ciò che egli definiva "spirito". Marx
giudicava insoddisfacente una spiegazione in termini di "spirito", e cercava invece di dare una versione "pratica" della
natura del cambiamento storico. Ma, come abbiamo mostrato, la sua visione, non diversamente da quella di Hegel, può
essere anch’essa accusata di essere metafisica, poiché deduce la natura del mutamento da considerazioni puramente
logiche. In base alla sua dottrina Marx predisse l’avvento di una società senza classi, ovvero di una società socialista.
Ma anche se la sua predizione si fonda su assunzioni metafisiche, almeno una parte dell’attacco di Marx al capitalismo
è costruito su un attento resoconto di come funzionano le società capitalistiche. In questo attacco si tenta di dimostrare
che le società capitalistiche crolleranno inevitabilmente per cause economiche piuttosto che logiche o metafisiche.
Passiamo quindi alla teoria economica di Marx, per renderci conto di come essa abbia rafforzato la motivazione
metafisica della sua previsione di un crollo inevitabile del capitalismo, che dovrà lasciare il campo all’economia
socialista.
La teoria economica di Marx: l’attacco al capitalismo
Le idee base dell’economia marxiana sono la teoria del valore-lavoro, la teoria del plusvalore, la concentrazione del
capitale e l’avvento del socialismo in quanto risultato di tale concentrazione. Cominciamo con la teoria del valorelavoro.
La teoria del valore-lavoro non è una creazione originale di Marx. Fu sostenuta da molti famosi economisti che lo
precedettero, per esempio da David Ricardo e Adam Smith. Questa teoria si impernia sulla determinazione di ciò che si
intende per "valore". La versione di Marx è più o meno la seguente: dobbiamo distinguere tra il "valore d’uso" di una
merce e il suo "valore di scambio". Una merce potrebbe esserci utile, ma potrebbe non avere valore alcuno se
tentassimo di scambiarla con altro. Per esempio, l’aria ha un valore: ne abbiamo bisogno per vivere. Ma se tentassimo
di scambiarla con un libro nessuno l’accetterebbe, perché essa è immediatamente a disposizione di chiunque la voglia.
Ciò che dà un valore di scambio a una merce è l’essere ottenibile solo a un certo costo. Marx definì "valore" tale costo.
Andando più a fondo, ciò che determina il costo di una merce è la quantità di lavoro che entra nella sua produzione. In
questo modo il "valore" viene definito nei termini del "tempo di lavoro richiesto per rappresentare un qualsiasi valore
d’uso nelle esistenti condizioni di produzione socialmente normali, e col grado sociale medio di abilità e intensità di
lavoro" (Il capitale, p. 71).
La teoria del plusvalore
Secondo Marx l’operaio comune, mancando di capitale, viene costretto a vendere la sua forza lavoro e quindi, in certo
senso, se stesso, come merce. Semplificando, la quantità di denaro che viene pagata da un imprenditore a un operaio è
una stima del valore economico del lavoratore in quanto merce che l’imprenditore deve comprare. Ma in genere il
lavoratore produce cose che hanno un valore economico molto maggiore del salario che riceve. La differenza tra la
quantità di valore economico prodotto dal lavoratore e la quantità che riceve per il suo lavoro viene definita plusvalore
da Marx. Per questo l’imprenditore non lo paga: di fatto, l’imprenditore si appropria del plusvalore della fatica del
lavoratore e lo usa in vari modi, il più importante dei quali è il profitto. Quindi sono i lavoratori, nell’ottica di Marx, a
produrre in realtà la ricchezza, attraverso la quantità di lavoro che forniscono; i capitalisti se ne prendono tuttavia una
fetta considerevole, senza ricompensare adeguatamente il lavoratore. È questa la fonte del loro profitto.
La teoria del plusvalore ci permette di identificare l’origine del conflitto tra il capitalista e l’operaio. Il capitalista vuole
accumulare il profitto maggiore possibile. Ciò potrà essere fatto solo a condizione di pagare il salario più basso
possibile e di vendere le merci al prezzo più alto possibile. D’altro canto le richieste dell’operaio sono diametralmente
opposte: ricevere lo stipendio più alto possibile e pagare le merci prodotte il meno possibile. E quindi all’interno del
capitalismo abbiamo un’incoerenza di fondo, e lo scontro tra le classi appare inevitabile.
La concentrazione del capitale e l’avvento del socialismo
Secondo Marx il capitalismo come sistema economico impone ai singoli di cercare di trarre profitti più alti possibile dai
propri investimenti. Per il capitalista questo significa impegnarsi in una competizione continua con gli altri
imprenditori, visto che il profitto dipende dalla quantità di merci vendute. Per vendere grandi quantità di merci è
necessario vendere al prezzo più basso possibile. In effetti, questo significa che bisogna costantemente cercare di
vendere sottocosto rispetto ai concorrenti. Ma dal momento che il costo di produzione per beni di qualità affine è
relativamente simile, l’unico modo in cui un imprenditore può abbassare i suoi costi nel lungo periodo consiste nell’uso
di manodopera meno costosa. Mentre cresce il potere dei capitalisti, ciò diviene sempre più importante. Infatti, dopo
aver mandato in fallimento le piccole imprese vendendo sottocosto, l’imprenditore si troverà infine in competizione con
pochi altri grandi produttori. A questo punto egli, per far fronte alla concorrenza degli avversari e per ottenere profitti
sempre più grandi, pretenderà un surplus sempre maggiore dalla produttività dell’operaio. Secondo Marx questa
tendenza produrrà, negli ultimi stadi della società capitalistica, una situazione in cui l’operaio diverrà sempre più
povero e il capitalista sempre più ricco. Quando l’operaio comprenderà di essere sfruttato (questa comprensione viene
definita "acquisizione di una coscienza di classe"), sarà inevitabile che si sviluppi una tensione nei confronti del
capitalista, che culminerà infine in un conflitto. Come conseguenza di questo conflitto, l’operaio si approprierà dei
mezzi di produzione, inaugurando una nuova tesi: l’età della società senza classi, o socialismo.
Oltre ai difetti evidenziati da questa analisi, il capitalismo ne ha uno ancora più grave. Secondo Marx esso genera
relazioni eticamente immorali tra le persone. Nei rapporti tra gli uomini scompare il senso di umanità, lasciando il posto
a un inumano istinto del profitto. Nel sostenere che il capitalismo non era un sistema funzionale Marx basava quindi la
sua accusa anche su una teoria etica, oltre che su dottrine economiche e metafisiche. Esaminiamo ora brevemente, per
concludere questo paragrafo, le sue idee morali.
Le idee etiche di Marx
Marx sostiene che l’industria e le scoperte tecnologiche si sviluppano molto più rapidamente delle tecniche per
controllarle. Ecco cosa dice in proposito:
Ai giorni nostri tutto sembra produrre il suo contrario; vediamo le macchine, dotate del meraviglioso potere di
abbreviare e far fruttare il lavoro umano, che lo rendono ancora più miserabile e gravoso. Le nuove fonti di
ricchezza sono trasformate, per qualche strana magia occulta, in fonti di bisogno. Le vittorie dell’ingegno
sembrano acquistate con la perdita di carattere. Alla stessa velocità con cui l’umanità padroneggia la natura,
l’uomo diventa schiavo di altri uomini o della sua propria infamia. Persino la luce pura della scienza sembra
incapace di brillare se non nell’oscuro paesaggio dell’ignoranza. I risultati di tutte le nostre invenzioni e il nostro
progresso sembrano consistere nel concedere forza materiale alla vita intellettuale e nel rendere ottusa la vita
umana, riducendo anch’essa a forza materiale.
Dunque l’espansione delle industrie dovrebbe mettere gli uomini nelle condizioni di vivere meglio insieme, con
sicurezza maggiore, ma sta accadendo esattamente il contrario. Il sistema capitalista, allo scopo di salvare i profitti di
chi possiede i mezzi di produzione, causa una guerra dietro l’altra; i bambini sono costretti a lavorare; il conflitto tra le
classi si intensifica. Tutto ciò secondo Marx è dovuto a due fattori: il primo è l’"autoalienazione", il secondo il
"feticismo". Il socialismo porrà rimedio a entrambi. "Autoalienazione" è un termine che Marx impiega per indicare la
difficile situazione della persona nel moderno mondo industriale. Invece di un’industria utile, che migliori le relazioni
degli individui tra loro, abbiamo esattamente il contrario. Le persone vengono isolate le une dalle altre, diventano
reciprocamente estranee, timorose e insicure. Non si tratta di semplice alienazione dal mondo, ma di autoalienazione: è
opera degli stessi interessati. Viene creato un mondo altamente tecnico, ma l’individuo non riesce a controllarlo; e
quindi si aliena da tutte quelle cose che giudica più importanti e che questa tecnologia avrebbe dovuto procurargli:
sicurezza, comodità, amicizia, tempo libero, cultura e così via. All’autoalienazione si accompagna il "feticismo",
l’adorazione dei prodotti del lavoro. Per esempio, gli individui producono automobili e dopo averle prodotte, si lasciano
dominare da queste cose inanimate. Il valore viene dato alla cosa, non alla persona che l’ha creata. Come scrive Marx:
L’oggetto che il lavoro produce, il prodotto del lavoro, si contrappone a esso come un essere estraneo, come una
potenza indipendente da colui che lo produce. [...] Quanto più l’operaio si consuma nel lavoro, tanto più potente
diventa il mondo estraneo, oggettivo, che egli si crea dinanzi, tanto più povero diventa egli stesso (Manoscritti, pp.
71-72).
L’effetto più terribile del capitalismo è stata la spersonalizzazione delle relazioni tra gli individui, l’aver reso le persone
più simili alle macchine e le macchine più simili alle persone. Questa è la tendenza contro cui si pone Marx. Egli ritiene
che il socialismo non fornirà solo i rimedi alla condizione economica del popolo, ma introdurrà anche una nuova
moralità: una moralità basata sui valori umani, non sui valori della macchina. Chiudiamo con queste considerazioni la
nostra esposizione della filosofia politica di Marx. Passiamo ora, brevemente, ad alcune annotazioni critiche.
Critiche a Marx
Come abbiamo già osservato, le filosofie politiche possono essere classificate a seconda di come rispondono alla
domanda: "Chi deve governare?". Abbiamo visto che secondo Platone e Hobbes devono governare i pochi; invece
Marx, come Mill e Locke, si schiera apertamente dalla parte dei molti. Senza distorcerla, possiamo dire che secondo la
visione politica di Marx in una società capitalista governano i pochi, ovvero quelli che possiedono i mezzi di
produzione, e che questo è fondamentalmente ingiusto. Schierandosi dalla parte della maggioranza, Marx si colloca
decisamente nella tradizione dei filosofi liberali e democratici. Inoltre, non pochi pensatori contemporanei condividono
tendenzialmente l’atteggiamento etico di Marx, che mette l’accento sulla rilevanza dei valori umani, in contrasto con il
mondo delle macchine creato dall’industria moderna.
Le principali critiche rivolte a Marx riguardano la sua filosofia della storia e la sua teoria economica. La concezione
marxiana della storia è stata attaccata su due fronti. Innanzitutto è stato detto che la pretesa di stabilire leggi storiche
generali è inammissibile. Forse per questa via si può trovare un mezzo utile a comprendere il passato, ma non a
prevedere il futuro, come tenta di fare Marx. Egli guarda allo sviluppo storico come a un processo inevitabile che
condurrà infine alla costruzione della società senza classi in tutti gli stati. Ci sono ragioni per esprimere seri dubbi sulla
validità di questo tipo di interpretazione della storia e sulla pretesa che il processo si fermi a questo punto. La seconda
critica alla sua filosofia della storia viene sollevata quando si introduce una valutazione morale degli stadi
dell’evoluzione storica. Ogni stadio, dice Marx, è eticamente superiore a quello che l’ha preceduto e quello finale, la
società senza classi, è la perfezione. In altre parole, si tratta di una teoria del progresso storico piuttosto che del
semplice cambiamento storico. Ora, per una teoria di questo genere è necessario qualche criterio; parlare in questo
modo vuol dire appellarsi a un criterio morale assoluto, cosa cui altrove lo stesso Marx, discutendo di morale, nega
qualsiasi validità. Infatti in altri passi egli ci dice che i valori morali non sono espressioni di "verità assolute", ma sono
relativi alla società in cui vengono sostenuti. Gli ideali oggettivistici della sua concezione della storia sono
incompatibili con la sua idea soggettivistica della moralità sociale. Questa incoerenza sta alla base stessa del marxismo.
La teoria economica di Marx è stata criticata dai difensori del capitalismo su basi empiriche, con un appello a fatti che
sembrano confutarla. Secondo Marx il sistema capitalistico produrrà inevitabilmente depressioni periodiche, che
culmineranno con l’accumulazione della ricchezza da parte dei proprietari dei mezzi di produzione e l’aumento della
miseria degli operai. Tutto ciò condurrà alla rivoluzione e alla nascita di una società socialista, senza classi. I difensori
del capitalismo attaccano questa tesi da due direzioni: essi sottolineano che la previsione dell’aumento della miseria
nelle società capitalistiche non si è avverata. La situazione dell’operaio è di fatto migliore che mai. Lavora per meno
ore, ha più denaro e in genere ha un tenore di vita più alto di quello degli operai del secolo scorso. Il capitalismo, invece
di abbassare la qualità di vita e di esacerbare le relazioni tra datore di lavoro e lavoratore, ha prodotto tenori di vita più
alti e ha migliorato le relazioni tra proprietario e operaio. Questi critici osservano anche che il capitalismo si è
dimostrato sorprendentemente inventivo nel risolvere le difficoltà che sono sorte al suo interno. Alcuni sviluppi, come
la formazione dei sindacati, le leggi antitrust e le misure di sicurezza sociale, hanno dato contributi positivi alla stabilità
economica delle società capitalistiche. I sindacati, per esempio, hanno contrastato la tendenza a vendere la forza lavoro
a un prezzo sempre più basso, fissando aliquote precise dell’uso del tempo lavorativo. Secondo i critici di Marx, nei
paesi capitalistici si continueranno a inventare innovazioni come queste, e quindi la previsione dell’aumento della
miseria non si avvererà.
La risposta marxista a entrambe queste accuse è la seguente: sebbene il tenore di vita in alcuni paesi capitalistici sia più
alto che in precedenza, ciò non è vero per tutti. Questa, sostengono i marxisti, è una prova che il socialismo è il sistema
preferibile e che il capitalismo sta lentamente perdendo terreno. In quanto all’idea che il capitalismo sia in grado di
risolvere i suoi problemi grazie alla propria inventiva, i marxisti sostengono che molte delle innovazioni introdotte sono
innovazioni socialiste. Per esempio, spendere a fondo perduto in tempi di crisi è un meccanismo socialista per evitare
una depressione; la formazione dei sindacati, che ha limitato il raggio d’azione del mercato del lavoro è, analogamente,
un altro esempio di intervento sullo sviluppo normale del capitalismo. I marxisti dicono che meccanismi come questi
sono necessari per salvare il sistema dall’autodistruzione.
Agli inizi degli anni novanta gli eventi politici nei cosiddetti "paesi della cortina di ferro" – la Germania dell’Est,
l’Ungheria, l’ex Unione Sovietica, ciò che una volta era la Jugoslavia, la Romania e la Cecoslovacchia – hanno
prodotto un impatto enorme sul dibattito sul marxismo. Da questi eventi sono emerse tre critiche alla teoria marxista.
Innanzitutto è stato detto che la tesi secondo la quale lo stato svanirà e sarà sostituito da una società senza classi si è
rivelata falsa. Sin dal 1917 molte società sono state organizzate sulla falsariga delle indicazioni di Marx, eppure si è
trattato invariabilmente di crudeli dittature in cui i diritti umani sono stati soppressi. Anzi, come hanno mostrato gli
eventi appena ricordati, queste cosiddette società marxiste sono divenute sempre più impopolari proprio perché non
hanno permesso che il popolo partecipasse al governo in modo democratico. Questa impopolarità ha raggiunto il punto
di rottura tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta, arrivando infine all’esplosione: il governo di queste
società è stato rovesciato e sostituito con governi non marxisti, capitalisti e orientati in senso democratico. L’Ungheria
e la Russia sono gli esempi più significativi. Ciò ha dimostrato che l’idea marxiana dell’aumento della libertà attraverso
la dittatura del proletariato è falsa: anzi, è successo esattamente il contrario. Il marxismo, in quanto programma politico
di mobilitazione della maggioranza, è fallito. L’impatto dei movimenti di opposizione che lo hanno sconfitto è da
ricercare nelle passioni nazionaliste e in quelle democratiche.
In secondo luogo, è stato detto che il marxismo, in quanto teoria, ha sempre sottovalutato la forza d’urto del
nazionalismo e delle rivalità e identità etniche. Sono state queste, e non la coscienza di classe, a trasformare i paesi
ricordati sopra. I conflitti interni nati nell’ex Jugoslavia, nell’ex Unione Sovietica e nell’ex Cecoslovacchia sono dovuti
più ad aspirazioni e tensioni nazionalistiche che agli ideali comunisti.
La terza critica è che l’economia marxista, così come è stata applicata da questi governi, non ha mai avuto successo
nella pratica. Tutti i paesi ex comunisti, dalla Germania dell’Est all’Unione Sovietica, dall’Ungheria alla Cina, sono
rimasti indietro rispetto all’Occidente. In questi paesi alla popolazione è stato imposto un tenore di vita sempre più
basso. Dopo tre quarti di secolo passati a pianificare l’economia, l’Unione Sovietica non riusciva a produrre cibo
sufficiente per sfamare la popolazione, mentre le nazioni capitalistiche e organizzate in senso democratico, come gli
Stati Uniti, il Canada, la Gran Bretagna e la maggior parte dell’Europa occidentale, riescono a produrre più cibo e merci
di alta qualità di quanto ne possano vendere.
Alcuni teorici marxisti rispondono a queste accuse sostenendo che non si possono giudicare i meriti della teoria di Marx
in base a questi eventi politici. Secondo loro i paesi comunisti si sono autodefiniti tali, ma non hanno mai seguito
realmente i precetti di Marx. Essi affermano che le esemplificazioni più significative delle teorie marxiste si ritrovano
nei paesi dove il socialismo ha preso la forma democratica auspicata da Marx: i paesi scandinavi, Israele, nazioni
occidentali come la Francia e l’Italia, dove gli ideali socialisti sono stati realmente messi in pratica.
Queste diverse valutazioni del marxismo sono state sia difese sia attaccate con vigore da vari filosofi contemporanei.
Oggi alcuni teorici affermano che il marxismo è l’idea più pericolosa che sia mai stata proposta, mentre altri lo
difendono, dicendo che non è mai stato messo alla prova nella sua forma pura. Nel mezzo ci sono molti disposti a
riconoscere che Marx è importante soprattutto per le sue intuizioni negative sul capitalismo, per averne indicato i difetti
in modo penetrante e anche per aver proposto alcuni metodi con cui eliminare o ridurre tali difetti, ma aggiungono nel
contempo che l’ideale marxista non è né attuabile né desiderabile. Da questo punto di vista la tesi marxista dello
sviluppo di un nuovo tipo di essere umano attraverso una serie di cambiamenti nella pratica economica è considerato
fantasioso utopismo. Ciò nonostante, all’aspirazione di Marx a un mondo migliore e alla sua visione ideale di questo
nuovo mondo si deve riconoscere un’innegabile serietà. Ovviamente la futura evoluzione della teoria marxista
dipenderà in gran misura da come si svilupperanno gli eventi politici al sopraggiungere del xxi secolo.
La teoria politica contemporanea
Le teorie politiche che abbiamo sin qui discusso, da Platone a Marx, hanno influenzato, in modi diversi ma importanti,
la filosofia politica del Novecento. Quasi tutte queste tradizioni hanno resistito sino a oggi e sono presenti nella
letteratura contemporanea. Abbiamo filosofi che hanno difeso la proprietà privata e un apparato statale minimo, come
Karl Popper (La società aperta e i suoi nemici, 1945), Robert Nozick (Anarchia, stato e utopia, 1974) e André
Glucksmann (I padroni del pensiero, 1977). Abbiamo opere importanti nell’ambito della tradizione neomarxista, come
L’uomo a una dimensione (1964) e il Saggio sulla liberazione (1969) di Herbert Marcuse, e difese della forma
democratica dello stato sociale, come Una teoria della giustizia (1971) di John Rawls. Non possiamo, a causa della
vasta letteratura prodotta in questo campo dall’inizio del secolo, nemmeno permetterci di iniziare una discussione di
tutte queste diverse posizioni. Limitiamoci allora al libro di Rawls, Una teoria della giustizia, che è generalmente
considerato il più importante testo di teoria politica prodotto da un americano nel Novecento.
La difesa di una forma di democrazia liberale da parte di Rawls è saldamente radicata in pensatori come Locke, Mill e
Kant. Come Locke e Mill, Rawls pensa che una delle condizioni di legittimità di qualsiasi forma di governo sia
l’accettazione del principio democratico. La legittimità implica una società che si autogoverni, una comunità in cui gli
uomini siano liberi di scegliere i loro rappresentanti e di partecipare attivamente, secondo procedure regolari, alle scelte
politiche fondamentali. Ma, a differenza di Locke, Rawls non crede che una tale società si debba impegnare nella difesa
della proprietà privata in quanto diritto. Egli ritiene che ci siano fini più importanti della conservazione della proprietà,
e pensa in particolare che una società "buona" debba distribuire il reddito in modo da ridurre al minimo la povertà. Da
questo punto di vista Rawls mostra una chiara influenza di un certo modello di socialismo democratico, tipico di alcuni
paesi scandinavi e presente anche nell’Inghilterra del dopoguerra, governata dai laburisti. Egli considera fondamentali
quelle libertà di cui aveva parlato Mill, ovvero le libertà che proteggono l’individuo dal governo, ma, a differenza di
Mill, non è un utilitarista: non tenta quindi di giustificare tali libertà sostenendo che, in quanto princìpi politici, nel
lungo periodo esse produrranno la massima felicità per il massimo numero. Rawls crede anzi che nel pensiero
utilitarista vi siano paradossi che nessuna società giusta può tollerare. Per esempio, da un punto di vista utilitarista si
potrebbe sostenere che una società può scientemente giustiziare persone innocenti se questo si dimostra un modo
efficace di scoraggiare i comportamenti fuorilegge. A suo parere si tratta di una conseguenza del principio d’utilità che
viola un principio base della giustizia, ovvero che nessuna persona innocente dovrebbe divenire vittima della politica.
Se Rawls è un difensore di una forma assistenziale di democrazia e non difende né il diritto di proprietà né
l’utilitarismo, dove trova gli antecedenti storici delle sue idee? La risposta è che li trova nella filosofia morale di
Immanuel Kant. Come abbiamo osservato nel capitolo 1 Kant difende l’oggettività e l’universalità di alcuni princìpi
morali. Tra questi c’è l’imperativo categorico, che in una delle sue forme comanda a chi agisce di trattare ogni persona
"come uno scopo, e mai come semplice mezzo". L’idea di base, che Rawls prende da Kant, dunque, è che si ha una
società giusta quando tutti gli individui, indipendentemente dalla loro posizione sociale, vengono trattati allo stesso
modo dalla legge, quando viene loro concesso un giusto processo e quando ognuno gode allo stesso modo della
protezione della società. Questa sorta di principio morale costituisce il fondamento dell’opera di Rawls. Egli è
favorevole a una società giusta in cui "giustizia" equivalga a "equità": e si tratta di una società che non può essere
giustificata con princìpi utilitaristi, ma solo su basi kantiane.Dato questo insieme di presupposti, la principale
preoccupazione di Rawls è quella di spiegare perché una società di questo genere può essere giusta dal punto di vista
economico. Dal punto di vista politico lo è, perché salvaguarda alcune libertà di fondo, ma una società potrebbe anche
essere equa politicamente, in questo senso, e tuttavia distribuire il reddito non equamente. Qui l’atteggiamento di Rawls
è ispirato da un fervore morale analogo a quello che troviamo in Marx, il quale riteneva che un capitalismo senza freni
fosse immorale per il modo in cui sfruttava gli operai, assicurando nel contempo profitti e redditi eccessivi a un piccolo
numero di persone.
A differenza di Marx, Rawls non è contrario a una società libera in cui siano presenti differenze in reddito; è contrario
però a una società in cui le differenze in reddito costringano alcuni a scendere al di sotto di un livello minimo delle
condizioni materiali di sussistenza. Uno dei princìpi fondamentali del libro di Rawls è quello che egli chiama "il
principio di differenza". In base a tale principio, le ineguaglianze in alcuni beni fondamentali sono permesse solo se la
distribuzione dei beni primari va anche a vantaggio di coloro che si trovano nelle condizioni peggiori. Quindi Rawls
potrebbe giustificare, per esempio, una società industriale avanzata che limitasse la quantità di denaro acquisibile dai
ricchi. Queste limitazioni verrebbero abolite solo se il denaro guadagnato da questi ultimi andasse anche a vantaggio
dei più poveri. L’enfasi di Rawls cade quindi sulla minimizzazione delle differenze di reddito tra i membri di una
società politicamente libera: egli sostiene quindi, riguardo alla distribuzione della ricchezza, una forma di egualitarismo
moderato e non di egualitarismo stretto. In questo senso la società buona cui pensa Rawls si fonda sulla
neutralizzazione delle ineguaglianze naturali che derivano dalla nascita, dal carattere, dal talento e dalle circostanze,
tutti elementi che favoriscono un’ingiusta distribuzione del reddito. Per lui il bene comune è misurato dai benefici di
base accordati a coloro che altrimenti sarebbero economicamente svantaggiati.
Critiche a Rawls
A Rawls sono stati rivolti due tipi di critica. Il primo, che deriva da una visione platonica della società, sostiene che gli
uomini nascono diversi per abilità, creatività e capacità realizzativa e di conseguenza contribuiscono alla società in
modo diseguale. In quest’ottica una società "giusta" non dovrebbe essere indifferente a tale diversità. Coloro che danno
i contributi più importanti e preziosi dovrebbero essere ricompensati in modo diverso: essi hanno comunque titolo a una
parte più grande dei beni primari della società, anche se ciò non favorisse i più svantaggiati. Per esempio, è questo
l’argomento sviluppato da Robert Nozick nel suo Anarchia, stato e utopia. Nozick ha, in sostanza, una concezione della
giustizia diversa da quella di Rawls.
La seconda critica rivolta a Rawls sostiene che l’idea di eguaglianza nella distribuzione del reddito e i princìpi della
libertà politica possono essere in contraddizione. Supponiamo che poche persone possiedano un’enorme ricchezza
ereditaria, compresi vasti possedimenti terrieri. In alcune circostanze potrebbe accadere che l’esistenza di proprietà
tanto grandi renda impossibile che un gran numero di cittadini viva al di sopra del livello di povertà. Il governo
potrebbe scoprire che questi grandi proprietari non controllano solo gran parte della ricchezza della società, ma anche
molti organi dello stato: la stampa, i tribunali e la magistratura, le banche e altre istituzioni. Potrebbe quindi non esserci
alcun modo democratico in cui modificare la situazione senza sospendere il libero esercizio del diritto di voto. In un
caso di questo genere uno dei princìpi fondamentali di Rawls – la libertà di voto – dovrebbe esser limitato in nome
della giustizia economica. Di conseguenza, secondo alcuni la teoria rawlsiana presenta qualche incoerenza, poiché in
certi casi porterebbe a concedere al governo poteri maggiori di quanti gliene possa concedere una società libera.
Avremmo quindi una tendenza all’accentramento, e in ultima analisi al controllo statale. Neomarxisti come Herbert
Marcuse sostengono infatti che, poiché l’intero sistema delle libertà politiche è solo una cortina fumogena che nasconde
il controllo della società da parte dei ricchi, questo è il solo modo per raggiungere la giustizia economica. Per quanto
questi argomenti siano interessanti, qui non possiamo occuparcene più a lungo; ma invitiamo i lettori ad approfondirli,
poiché vanno al cuore dei problemi attuali delle società democratiche.
Richard H. Popkin, Avrum Stroll,
Filosofia per tutti,
Il Saggiatore 1997