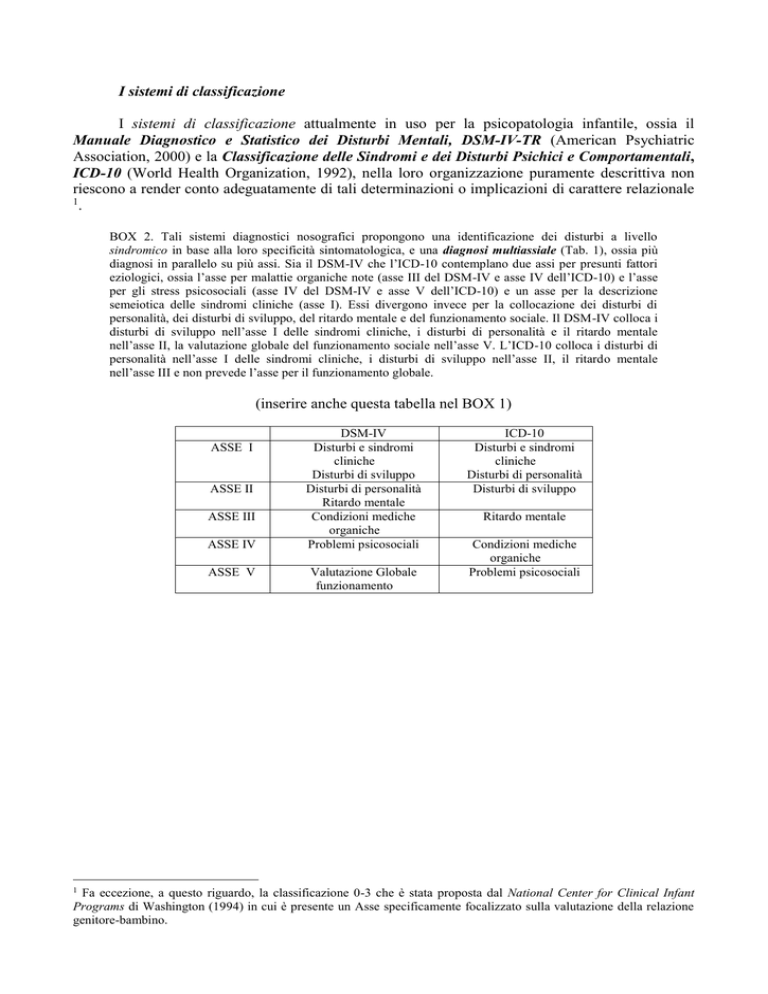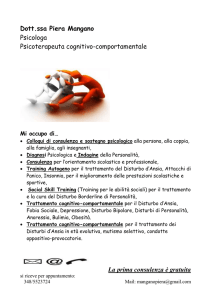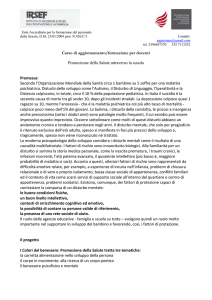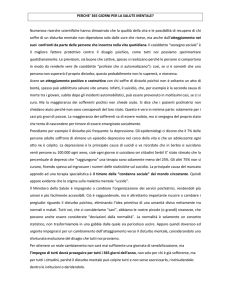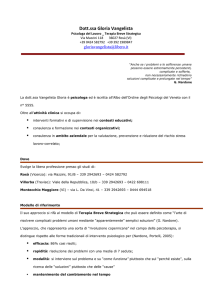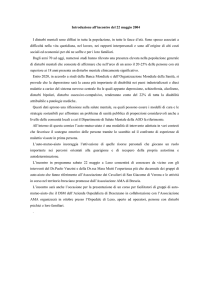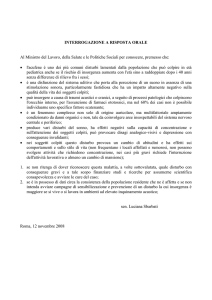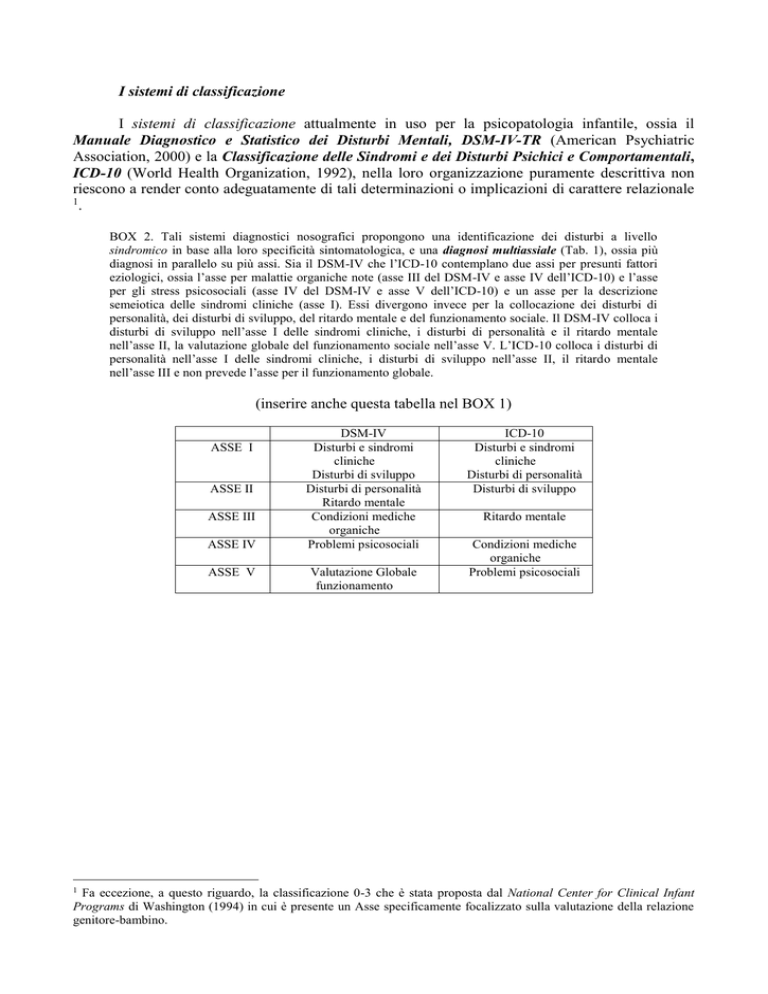
I sistemi di classificazione
I sistemi di classificazione attualmente in uso per la psicopatologia infantile, ossia il
Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, DSM-IV-TR (American Psychiatric
Association, 2000) e la Classificazione delle Sindromi e dei Disturbi Psichici e Comportamentali,
ICD-10 (World Health Organization, 1992), nella loro organizzazione puramente descrittiva non
riescono a render conto adeguatamente di tali determinazioni o implicazioni di carattere relazionale
1
.
BOX 2. Tali sistemi diagnostici nosografici propongono una identificazione dei disturbi a livello
sindromico in base alla loro specificità sintomatologica, e una diagnosi multiassiale (Tab. 1), ossia più
diagnosi in parallelo su più assi. Sia il DSM-IV che l’ICD-10 contemplano due assi per presunti fattori
eziologici, ossia l’asse per malattie organiche note (asse III del DSM-IV e asse IV dell’ICD-10) e l’asse
per gli stress psicosociali (asse IV del DSM-IV e asse V dell’ICD-10) e un asse per la descrizione
semeiotica delle sindromi cliniche (asse I). Essi divergono invece per la collocazione dei disturbi di
personalità, dei disturbi di sviluppo, del ritardo mentale e del funzionamento sociale. Il DSM-IV colloca i
disturbi di sviluppo nell’asse I delle sindromi cliniche, i disturbi di personalità e il ritardo mentale
nell’asse II, la valutazione globale del funzionamento sociale nell’asse V. L’ICD-10 colloca i disturbi di
personalità nell’asse I delle sindromi cliniche, i disturbi di sviluppo nell’asse II, il ritardo mentale
nell’asse III e non prevede l’asse per il funzionamento globale.
(inserire anche questa tabella nel BOX 1)
ASSE I
ASSE II
ASSE III
ASSE IV
ASSE V
1
DSM-IV
Disturbi e sindromi
cliniche
Disturbi di sviluppo
Disturbi di personalità
Ritardo mentale
Condizioni mediche
organiche
Problemi psicosociali
Valutazione Globale
funzionamento
ICD-10
Disturbi e sindromi
cliniche
Disturbi di personalità
Disturbi di sviluppo
Ritardo mentale
Condizioni mediche
organiche
Problemi psicosociali
Fa eccezione, a questo riguardo, la classificazione 0-3 che è stata proposta dal National Center for Clinical Infant
Programs di Washington (1994) in cui è presente un Asse specificamente focalizzato sulla valutazione della relazione
genitore-bambino.
La classificazione descrittiva delle categorie sindromiche dei due manuali fornisce solo
un’istantanea del bambino, una specie di primo piano bloccato, intorno al quale non si intravede
nessun paesaggio né alcun movimento del prima e del dopo. Ovviamente, in un tale modello
classificatorio è implicitamente pericolosa la tendenza alla reificazione, e cioè l’essere indotti a
credere che ogni categoria indichi o sia per sé una unità reale, in quanto al caso individuale ne
vengono attribuite automaticamente le proprietà discriminanti. Nell’assenza di prospettiva evolutiva
e relazionale, la valutazione descrittiva categoriale non conosce o non sa interpretare la storia
personale, familiare e sociale del bambino, né sa fare previsioni sulla possibile evoluzione di questa
storia. Ciò che le manca è una teoria esplicativa dei rapporti che connettono e disconnettono nella
storia la biografia familiare con la biografia del bambino. La prospettiva meta-teorica già
tratteggiata, coerentemente con tali assunti, può effettivamente costituirsi come una utile trama
esplicativa con la quale avvicinarsi al bambino e alla sua famiglia tentando di restituire un senso
alla loro sofferenza e di orientarli verso modalità di relazione dotate di maggiori potenzialità
evolutive. Entro tale cornice, i sintomi del bambino diventano straordinariamente trasparenti,
evidenziandosi in maniera palese la loro funzione nel mantenimento dello stato di relazione con le
proprie figure d’attaccamento (Ciotti e Lambruschi, 1995, 2004; Lambruschi et al, 2004a).
Definizione dei campi d’intervento e del setting di lavoro
Gli interventi di cui ci occuperemo nascono come risposta a problemi che si manifestano nel
corso dello sviluppo, e che sono individuati come deviazione dalla norma o come condizione che
crea sofferenza. Il riferimento più ovvio per definire i tipi di intervento è il modello medico: una
patologia o una condizione anomala creano una sofferenza o altri tipi di problema, e il clinico, una
volta definito il problema con una procedura diagnostica, è chiamato a intervenire in termini
preventivi, curativi o riabilitativi. Secondo la terminologia medica, questi tipi di intervento sono
così definiti:
A- Intervento preventivo: viene distinto in diversi tipi, prevenzione primaria, secondaria, e
addirittura terziaria (che peraltro coincide con la riabilitazione).
La prevenzione primaria è un tipo di intervento che si propone di proteggere i soggetti sani,
annullando o riducendo il rischio di malattia. Alla base di un intervento di prevenzione primaria
ci sono conoscenze riguardo alla causa di una malattia o ai fattori principali che ne influenzano
il manifestarsi; sulla base di queste conoscenze, si potranno progettare e attuare azioni volte
alla rimozione delle cause delle malattie e alla modifica dell’ambiente o delle abitudini di vita,
in modo da annullare o attenuare le cause di malattia, o di modificare l’azione di fattori
patogeni o protettivi. Gli interventi di prevenzione primaria possono essere messi in atto a
favore di intere popolazioni. Ad esempio le raccomandazioni che l’Associazione Culturale
Pediatri dà a tutte le neomamme è assimilabile ad un vero e proprio programma di prevenzione
primaria rispetto alle malattie o ai disturbi della prima infanzia: la posizione supina in culla per
prevenire la morte improvvisa, il seggiolino omologato in auto per gli incidenti, le vaccinazioni
per le malattie infettive, il non fumo per le malattie respiratorie, la lettura congiunta di libri
illustrati per la prevenzione dei disturbi del linguaggio. La conoscenza di alcuni fattori di
rischio nell’obesità (ad esempio: obesità in uno dei genitori, più rapido aumento ponderale del
bambino nel primo anno di vita rispetto alle curve normali di crescita, basso livello socio
culturale) può portare a strutturare interventi di prevenzione primaria (ad esempio, gruppi di
genitori di bambini con tali fattori di rischio) volti alla osservazione e al graduale cambiamento
del proprio stile relazionale e alimentare verso il figlio.
La prevenzione secondaria è il tipo di intervento che agisce su un processo patogeno già in
atto, in cui i soggetti sono già stati colpiti da un danno, che però non è ancora manifesto a
livello clinico. La conoscenza dei processi mediante i quali dall’azione della causa si passa allo
stato di malattia, con tempi a volte anche prolungati, apre la possibilità a interventi che, anche
se non sono volti a curare una malattia (non ancora manifestamente presente), ne riducono la
futura possibilità di insorgenza. Cruciale per l’attuazione di interventi di prevenzione
secondaria è l’individuazione di quali sono i soggetti già interessati da un processo che aumenta
le loro probabilità di andare incontro a una malattia: le indagini volte a effettuare questo tipo di
selezione dei soggetti sono dette screening. In età evolutiva sono esempi di screening sulla
popolazione infantile i bilanci di salute per il rilievo precoce di ipoacuità visiva ed uditiva,
obesità, scarsa crescita, scoliosi, oppure, come si vedrà successivamente, lo screening
attraverso la scala CHAT dell’autismo infantile.
B - Intervento terapeutico (o clinico): un soggetto affetto da una malattia clinicamente evidente
(cioè che dà sintomi o segni e che arreca sofferenza e/o danno) verrà trattato in modo da
eliminare la causa di malattia oppure bloccarne l’effetto, attenuare il processo patologico e/o i
suoi sintomi e limitare il danno da esso derivante. L’insieme di queste pratiche, effettuato su
una malattia riconosciuta e distinta da altre grazie ad un attento lavoro di tipo diagnostico,
configura l’intervento terapeutico. L’insieme delle pratiche diagnostiche e terapeutiche
definisce l’attività di tipo clinico. Ad esempio con gli esami di laboratorio si può individuare
una anemia sideropenica che richiede un trattamento col ferro mancante o una iperglicemia da
diabete mellito che richiede un trattamento con l’insulina che manca nel diabetico. Oppure,
come vedremo, a partire da un’attenta diagnosi di Disturbo d’Ansia o della Condotta, possiamo
attivare protocolli psicoterapeutici di provata efficacia.
C - Intervento riabilitativo o abilitativo: si effettua sulle situazioni in cui la malattia ha danneggiato
il soggetto, sia in seguito a un decorso acuto, sia durante un decorso cronico. I soggetti
danneggiati da un processo patologico acuto, o progressivamente limitati nelle competenze e
nell’autonomia funzionale durante un processo patologico cronico, una volta che l’intervento
terapeutico abbia arrestato il processo patologico, ne abbia ridotto l’impatto o ne abbia
rallentato il decorso, si troveranno a dover affrontare un mutato livello di adattamento al
proprio abituale contesto di vita. L’intervento volto a massimizzare il recupero delle autonomie
e dei livelli di funzionamento premorbosi viene definito intervento riabilitativo (o anche
prevenzione dell’invalidità, vale a dire prevenzione terziaria). Nella paralisi ostetrica di un
arto, ad esempio, il fisioterapista cerca di far recuperare la funzione dell’arto trascurato dal
bambino, con esercizi che ne promuovano la consapevolezza e l’uso. Nella articolazione
impropria di un suono (es. labiali o sibilanti) la logopedista cercherà di rieducare i movimenti
glossofacciali che ostacolano l’articolazione del suono.
Laddove non si possa parlare di “malattia” in senso stretto, perché la condizione del soggetto
non è contraddistinta dall’azione di una causa che trasforma un soggetto sano in un soggetto malato,
bensì il soggetto si trova in una condizione atipica statica (per esempio è portatore di un’anomalia
cromosomica, di un ritardo mentale, o di un disturbo specifico dell’apprendimento, tutte condizioni
che tendono a non modificarsi significativamente nel tempo), un intervento avente lo scopo di
massimizzare il livello di funzionamento e di autonomia del soggetto viene definito abilitativo. In
senso stretto, infatti, non si può mirare a ristabilire un livello di funzionamento che il soggetto non
ha mai mostrato. Si può invece, agendo sulle abitudini di vita e sulle caratteristiche dell’ambiente,
modificare i parametri rilevanti per il livello di abilità/inabilità del soggetto.
Un’ultima considerazione sullo spazio clinico, cosiddetto, consulenziale. Una quota
rilevante di probematiche dell’età evolutiva (o, da un altro punto di vista, di sofferenza nell’area
della genitorialità) potrebbe fruire, più che di veri e propri interventi strutturati e prolungati nel
tempo, di rigorosi ma flessibili interventi consulenziali. Nei servizi pubblici per l’età evolutiva, è in
effetti assai più ampia l'attività cosiddetta di “primo livello”, ovvero di diagnosi e di consulenza,
piuttosto che di terapia in senso stretto. Può capitare che tale attività consulenziale venga vista e
trattata come un’ operazione semplice e limitata, ponendola ad un rango inferiore rispetto ai più
prolungati, “profondi” e “faticosi” percorsi di terapia. Al contrario, per operare con attenzione,
rispetto ed efficacia in termini consulenziali è necessario possedere livelli notevoli di esperienza
terapeutica. Quello di consulenza è un atto molto complesso e particolarmente delicato, anzitutto,
perché opera in uno spazio e in un tempo limitati, veicolando un concentrato notevole di messaggi;
inoltre, muovendosi spesso su un campo “vergine”, di aree emozionali critiche emergenti nel
bambino e nel suo sistema familiare, può avere effetti considerevoli nella definizione o ridefinizione
della situazione di crisi e nella sua futura evoluzione. In questo senso, i servizi di primo livello e la
figura del counselor , che incontra i primi segnali di sofferenza, hanno un ruolo e una responsabilità
notevole nell'avviare, nella relazione con la famiglia, una co-costruzione di significati che rechino
in sé valenze generative ed evolutive piuttosto che di malattia e di sofferenza.
Qualunque tipo di intervento dovrà ovviamente essere preceduto e informato da un’attenta
fase di assessment o inquadramento diagnostico. Considerata la multifattorialità e l’intrinseca
complessità della psicopatologia dello sviluppo, di norma, diverse figure professionali si trovano a
cooperare in un lavoro di équipe allo scopo di inquadrare e gestire le varie situazioni cliniche in
tutta la loro complessità (Lambruschi e Rezzonico, 1996; Isola e Pallini, 1997). Nell'équipe ogni
figura professionale, con le differenti modalità di approccio dettate dalle diverse strumentazioni
concettuali e procedurali, concorre alla definizione dell'inquadramento dello stesso “oggetto” di
studio, il bambino, il fanciullo o l’adolescente, nella sua totalità somatica, psicologica e sociale. Un
approccio globale e integrato che comprenda (Sameroff e Emde, 1989, Zeanah, 1993; Ammaniti,
2001; Cammarella et al. , 2000; Lambruschi et al, 2004):
- un esame attento del funzionamento psicologico del bambino, del ragazzo o dell’adolescente
(delle sue caratteristiche individuali di sviluppo auto-organizzative, emotive, cognitive e
sociali);
- delle caratteristiche del sistema di accudimento-cure (il funzionamento psicologico dei
genitori e le globali risorse del sistema familiare);
- della esperienza interpersonale e dei pattern interattivi tra il bambino e il caregiver; nel loro
specifico contesto di vita.
La situazione problematica viene considerata nel suo insieme come effetto di un gioco
complesso di fattori biologici, socioeconomici e culturali, affettivo-relazionali, che assumono di
volta in volta configurazioni diverse. In tal modo, la formulazione diagnostica si presenta come
sintesi ragionata e complessa delle conoscenze acquisite sul caso dai diversi tecnici negli specifici
campi e si configura come ipotesi atta a guidare la pianificazione di un adeguato intervento
terapeutico.
In psicologia dello sviluppo, valutare gli stessi sintomi o gli stessi segni in maniera
affidabile e riproducibile non è un compito facile, perché qui i segni sono comportamenti in
trasformazione. Questi comportamenti in divenire riguardano le aree di sviluppo della motricità, del
linguaggio, dell’intelligenza, dell’apprendimento, dell’affettività. Per ogni area occorre trovare
strumenti di valutazione affidabili, capaci di distinguere i comportamenti “normali” da quelli
“devianti”, in funzione dell’età. La capacità di un bambino di raggiungere un certo livello di
prestazioni motorie a una certa età teoricamente non è per nulla diversa dalla capacità di
raggiungere un certo livello di peso o di altezza. Come la bilancia per il peso o il metro per
l’altezza, anche per una valutazione affidabile e riproducibile delle prestazioni motorie o cognitive
o linguistiche o relazionali sarebbe opportuno poter ricorrere a strumenti standardizzati di
valutazione descrittiva. Questi strumenti standardizzati di valutazione sono i test di sviluppo. La
valutazione tramite test, a differenza della valutazione intuitiva, consente di trasformare
l’osservazione soggettiva in osservazione intersoggettiva, riproducibile e controllabile, prevedendo
stimoli uguali per tutti, istruzioni standardizzate, uguale setting di somministrazione, griglie
rigorosamente definite per il punteggio e la classificazione delle risposte, verifica dell’attendibilità
dello strumento attraverso il retest e la concordanza tra n operatori.
Le aree specifiche dell’intervento clinico
Cercheremo ora di offrire alcune esemplificazioni sulle modalità di approccio clinico ai più
comuni disturbi dello sviluppo. Di quali “atipie” evolutive ci occuperemo? Seguendo lo schema
multiassiale dell’ICD-10 (molto utilizzato nell’ambito dei servizi per l’età evolutiva):
- Sull’Asse 1, dopo aver discusso della più ampia e fondamentale distinzione tra Disturbi da
internalizzazione e da esternalizzazione, ci focalizzeremo sui Disturbi d’Ansia come
esemplificazione della prima categoria e sui Disturbi Oppositivo-Provocatori e della
Condotta e sui Disturbi da Deficit d’Attenzione e Iperattività (DDAI) come
esemplificazione della seconda.
- Sull’Asse 2, appunteremo la nostra attenzione sui Disturbi dello sviluppo motorio, del
linguaggio, dell’apprendimento e sui Disturbi Generalizzati dello Sviluppo (con particolare
riguardo al disturbo Autistico).
- Sull’Asse 3, considereremo infine il Ritardo mentale.
Per ciascuna di queste aree psicopatologiche, cercheremo di descrivere in modo sintetico: le
possibilità di intervento preventivo; le necessarie procedure, strumenti e relativi problemi
diagnostici con i quali lo psicologo clinico deve confrontarsi; e infine le linee essenziali del
percorso terapeutico o riabilitativo. Dove possibile faremo anche alcuni cenni alle più probabili
evoluzioni, in fase adolescenziale e in età adulta, dei diversi quadri considerati.
ASSE I – I DISTURBI NELLO SVILUPPO EMOTIVO, AFFETTIVO E RELAZIONALE
In questa area le principali problematiche (motivo più frequente di consultazione nei servizi
dell’età evolutiva), possono essere raggruppate in due categorie fondamentali: i disturbi da
internalizzazione (ad esempio, disturbi d’ansia, disturbi ossessivo-compulsivi, disturbi dell’umore)
e i disturbi da esternalizzazione (ad esempio, disturbi della condotta, disturbi da deficit d’attenzione
e iperattività). Una delle caratteristiche distintive dei disturbi da internalizzazione è rappresentata
dall’ipercontrollo sul comportamento e dalla prevalenza di modalità rappresentative distorte e
disfunzionali, quali catastrofizzazione e autosvalutazione (distorsione cognitiva); mentre i disturbi
da esternalizzazione si manifestano usualmente con un ipocontrollo, scarsa riflessività, carenza
nelle abilità di problem-solving, e di pensiero (selezione degli obiettivi, generazione di alternative
possibili di soluzione, considerazione delle loro possibili conseguenze e successiva messa in atto) in
grado di guidare in modo funzionale il comportamento (deficit cognitivo) (Kendall, 1985, 1991,
2000).
Il modo più semplice per ottenere una immediata lettura della severità e dell’ampiezza dei
problemi in queste aree, è l’utilizzo di Questionari Comportamentali (“Behavioral Checklist”), che
consentono, in breve tempo di raccogliere informazioni relativamente ai diversi contesti in cui vive
il bambino o l’adolescente. La scala comportamentale più comunemente usata e scientificamente
validata è la Child Behavioral Checklist (CBCL, Achenbach ed Edelbrock,1983;
Achenbach,1991), di cui esistono 6 versioni: 3 per i genitori, suddivise per fasce d’età del bambino
(2-3 anni; 4-5 anni; 6-18 anni); 2 per insegnanti (2-5 anni; 6-18 anni); 1, auto-somministrato per gli
adolescenti (11-18anni). Gli items totali sono 113, riconducibili alle seguenti aree problematiche:
condotte aggressive/iperattive; comportamento deviante; disturbo di attenzione; disturbi di pensiero;
problemi di socializzazione; condizione ansioso/depressiva; disturbi psicosomatici; comportamento
introverso/passivo. Tre sono i livelli di punteggio: soggetti senza problemi evidenti; soggetti ad
eventuale rischio; soggetti con dubbio importante di patologia. La scala ci offre una immediata
possibilità di discriminare la prevalenza di aspetti internalizzanti o esternalizzanti.
Disturbi d’ansia
La diagnosi
I Disturbi d’Ansia (DA), nella classificazione proposta dall’ICD10, comprendono alcuni
principali quadri clinici:
- Sindrome d’ansia da separazione dell’infanzia: caratterizzata da ansia eccessiva
manifestata dal bambino quando si deve separare da qualcuno della famiglia a cui è
profondamente attaccato (di solito la figura materna). I soggetti affetti da questo disturbo
hanno di solito un comportamento normale finché sono in presenza della figura primaria di
attaccamento, ma manifestano un’intensa ansia non appena vengono separati da tale figura o
percepiscono come imminente la separazione. Inoltre tendono ad esprimere paure
irrealistiche e persistenti riguardo al verificarsi di eventi catastrofici che li possano separare
per sempre dai genitori.
- Sindrome fobica dell’infanzia: una serie di paure fanno parte dello sviluppo di ogni
bambino. Si parla di Sindrome fobica dell’infanzia quando la paura nei confronti di
particolari oggetti, animali o situazioni è eccessiva e persistente. Tale paura è anormale per
il grado di severità e può interferire con il normale funzionamento dell’individuo e con la
vita dei familiari.
- Sindrome di ansia sociale dell’infanzia: caratterizzata da un’eccessiva timidezza nei
confronti di situazioni e figure nuove o poco familiari. Tale timidezza è così intensa da
rendere impossibili i normali rapporti interpersonali. L’ansia degli incontri sociali è di un
grado che va oltre i limiti normali per l’età del bambino, insorge in età precoce ed è
associato a problemi significativi nel funzionamento sociale.
- Sindrome ansiosa generalizzata dell’infanzia: caratterizzata dalla presenza di uno stato di
ansia eccessiva e di preoccupazione irrealistica. L’ansia ha un carattere pervasivo e non è
possibile collegarla a particolari stimoli ambientali.
Si tende a distinguere l’ansia patologica dalle normali paure, basandosi su criteri
cronologico-statistici (il persistere di una normale paura oltre la sua età “fisiologica”) e di tipo
comportamentale, considerando disfunzionale un’attivazione emotiva eccessiva nella frequenza con
cui si verifica, nell’intensità con cui si manifesta e nella sua durata (Kendall et al, 1992).
Il tasso di prevalenza dei DA in bambini e adolescenti tra i 4 e i 20 anni di età risulta di circa
il 12% in studi di Costello e collaboratori (Costello et al., 1994); mentre altri studi (Verhulst et al.,
1997; Shaffer et al., 1995) evidenziano una prevalenza del 20-25%. Il disturbo d’ansia da
separazione, che è il disturbo d’ansia più frequente nell’infanzia e nell’adolescenza, ha una
prevalenza pari al 3-4%, con un rapporto 2:1 tra maschi e femmine (Levi, Sogos, 1999).
Particolarmente elevata risulta la comorbilità tra i diversi disturbi d’ansia, ma anche tra DA e
disturbi dell’umore (disturbo depressivo e disturbo bipolare) e tra DA e Disturbo da Deficit
d’Attenzione e Iperattività.
Nell’eziopatogenesi insieme ad alcuni aspetti di vulnerabilità neurobiologica e
temperamentale, sono implicati fattori relazionali e sociali, in interazione reciproca. Tra i bambini
con DA, in particolare con disturbo d’ansia di separazione, gli schemi cognitivi dominanti, cioè le
loro modalità di elaborazione degli stimoli esterni, possono riguardare la minaccia di perdita, un
intenso timore di danno fisico o di critica, con aspettative potenzialmente assai più pericolose e
catastrofiche di quelle riscontrabili in bambini non ansiosi. Ciò ovviamente è frutto di particolari
esperienze primarie d’attaccamento. Infatti gli itinerari di sviluppo a cui usualmente si connette tale
organizzazione cognitiva sono quelli caratterizzati da pattern ansioso-resistenti: dunque contesti
d’accudimento-cura connotati da quote più o meno importanti di instabilità e imprevedibilità
nell’esserci di una figura d’attaccamento essa stessa profondamente insicura, turbata e insoddisfatta
dei propri legami affettivi (primariamente, la propria famiglia d’origine e la relazione coniugale).
Nella maggior parte dei casi tali vissuti sono scarsamente esplicitati, ma colti tacitamente dal
bambino nella comunicazione emotiva col caregiver (Arrindell et al., 1983; Bowlby, 1973, 1980,
1988; Parker, 1979, 1983). Tipicamente si osservano comportamenti genitoriali apparentemente di
tipo iperprotettivo che mascherano, in realtà, la loro stessa difficoltà a tollerare la solitudine: essa
viene appunto gestita impedendo o limitando l’esplorazione del piccolo, connotandolo come fragile
e dipingendo costantemente la realtà esterna come pericolosa, densa di insidie e di minacce. In altri
casi il disagio, l’insicurezza e l’insoddisfazione della figura d’attaccamento si rendono più evidenti,
attraverso la manifestazione di indefiniti malesseri quotidiani, sintomi fisici, croniche
recriminazioni lamentose verso tutti i familiari e talora anche attraverso minacce esplicite di
separazione e di abbandono (“Un giorno tornerete a casa e non mi troverete più!”) o di attribuzione
al figlio del proprio stato di malessere (“Prima o poi mi farai morire!”). E’ evidente che entro un
siffatto contesto primario di relazione il bambino finisce per sperimentare una indiretta e massiccia
limitazione del comportamento esploratorio, attraverso il mantenimento stretto della prossimità
fisica al caregiver e quindi una difficoltà a riconoscere e ad articolare adeguatamente le varie
componenti di cui si sostanzia la paura di separazione, della quale non hanno potuto fare adeguata e
“fisiologica” esperienza.
Tra gli strumenti (scale di valutazione e questionari, ecc) che possono risultare di una certa
utilità per lo psicologo in questi quadri clinici, possiamo segnalare oltre alla già citata Child
Behavioral Checklist, nel cui profilo ritroveremo caratteristicamente elevati i punteggi alle scale di
internalizzazione; la Scala d’ansia per l’età evolutiva (Busnelli, Dall’Aglio e Faina, 1974) un agile
questionario utilizzabile con ragazzi tra gli 8 e i 15 anni, che fornisce indicazioni distinte rispetto ai
livelli di “ansia scolastica” e di “ansia ambientale” più genericamente intesa; il Children’s
Depression Inventory (CDI: Kovacs, 1989) o la Child Depression Scale (C.D.S.: Lang e Tisher,
1980) utili ad evidenziare le eventuali componenti depressive del quadro clinico, con particolare
riguardo al fattore “senso di colpa”; Inventari delle paure per bambini (Sanavio 1984, 1988);
Ollendick (1983), Kendall, Di Pietro (1995) utili ad esplorare e discutere insieme al bambino e ai
genitori un’ampia serie di possibili fonti di paura.
Al di là della funzione centrale comunque svolta dal colloquio clinico, nella osservazione e
valutazione della qualità dei legami d’attaccamento in atto tra il bambino e i suoi caregivers, e dello
stato mentale dei genitori (e quindi nell’analisi della funzione relazionale dei sintomi) potranno
essere utilizzati strumenti diagnostici diversi a seconda dell’età del bambino e delle caratteristiche
dei genitori (Lambruschi et al, 2004b).
L’intervento terapeutico
Diversi programmi di tipo cognitivo-comportamentale, hanno mostrato una buona efficacia
nel lavoro terapeutico con bambini e adolescenti con disturbi d’ansia (Kendall, Howard, Epps,
1988; Kendall, Kane, Howard, Siqueland, 1989; Kendall, Di Pietro, 1995; Di Pietro, Kendall, 1995;
Kendall, Treadwell, 1996; Leivin, Ashmore-Callahan, Kendall, Ichii,1996; Ronen,1997; Ollendick
e King, 1998; Kendall, et al., 2000). Tali programmi integrati di trattamento hanno come obiettivo
principale quello di aiutare il bambino a riconoscere i segnali dell’impellente arousal ansioso, e
fare in modo che questi servano come indicatori per l’utilizzo di adeguate strategie di gestione
dell’ansia.
L’intervento può essere distinto in due parti principali. La prima, più ad orientamento
pedagogico e di acquisizione delle abilità, in cui il bambino è aiutato in modo semplice ad
identificare le varie componenti della propria reazione ansiosa (somatiche, cognitive,
comportamentali) e successivamente a costruire efficaci abilità di coping riguardo a ciascuna di
queste componenti. Il bambino è guidato nella messa in pratica delle abilità apprese, attraverso una
graduale esposizione alle situazioni temute, prima immaginativa e poi in vivo. Soprattutto nei
disturbi d’ansia da separazione il clinico dovrà svolgere spesso un’opera di mediazione tra famiglia
e scuola volta a spiegare e a far accettare agli insegnanti l’utilità della strutturazione di un piano in
cui si chiede al bambino una graduale assunzione di responsabilità e di sforzo nella ripresa delle
attività scolastiche, in un contesto però non costrittivo e di rassicurante gradualità.
I dati prognostici disponibili sui disturbi d’ansia sottolineano, come elemento di criticità, il
mantenimento dei risultati nel tempo e il rischio comune di esacerbazioni e ricadute successive
(Rutter, 1995; Van Hasselt, Hersen, 1995; Elliot e Place, 2001; Celi, 2002). L’ampliamento del
lavoro terapeutico con la coppia genitoriale o comunque con la madre, quando risulta possibile,
consolidando la consapevolezza delle loro aree emozionali critiche, del loro modo di gestirle e di
comunicarle all’interno del rapporto di coppia, può consentire in alcuni casi una migliore
stabilizzazione dei risultati: più è stabile la “cornice” rappresentata dalle possibili turbolenze
emozionali che attraversano il sistema d’accudimento-cure del bambino, più i diversi tasselli del
puzzle terapeutico, le diverse abilità di coping che il bambino stesso ha interiorizzato, saranno in
grado di reggere l’impatto degli eventi critici futuri. Al di là della gestione del sintomo, dunque,
uno dei problemi terapeutici principali che si pone in tali quadri clinici, sarà quello di aiutare madre
e bambino a ripristinare un contesto di condivisione emotiva e di comunicazione sulle aree
emozionali critiche ed inespresse (connesse all’ansia di perdita del legame, piuttosto che a qualcosa
di esterno: usualmente la scuola) e sulla funzione svolta dal sintomo a livello relazionale.
Dall’autosservazione e dall’analisi dei momenti di maggiore difficoltà emotiva della propria
quotidianità e del rapporto col figlio, non è raro che il genitore possa connettersi a frammenti
significativi della propria storia di sviluppo. Offrire al genitore la possibilità di riconoscere e di
esprimere le emozioni connesse ad alcune dolorose vicende nei propri legami primari
d’attaccamento, può restituirgli la capacità di riconoscere e sintonizzarsi meglio sui bisogni emotivi
ed affettivi del proprio figlio, promovendone la sicurezza (Lambruschi et al, 2004c).
Evoluzione in età adolescenziale e adulta
Relativamente all’evoluzione dei DA, ed in particolare alla possibilità che possano essere
considerati come precursori dei DA dell’età adulta, studi longitudinali su bambini ed adolescenti
con DA evidenziano che il rischio di sviluppare un DA in età adulta è di 3-4 volte maggiore rispetto
ai bambini non affetti (Pine et al., 1998; Newman et al. 1996).
L’insorgenza precoce, che non compromette troppo l’inserimento sociale, ha una prognosi
migliore del disturbo ad insorgenza tardiva, con rifiuto della scuola e di altri contesti sociali. La
comorbilità con la depressione, di cui talora il disturbo d’ansia di separazione può essere un
precursore, rende la prognosi più negativa. Il DA può essere, infine, associato a successive difficoltà
di separazione nella vita adulta (Flakierska et al., 1988); difficoltà ad andarsene di casa o a cambiare
lavoro (Wekman, 1987); agorafobia (Gittelman e Klein, 1984).
Disturbi della Condotta e Disturbo Oppositivo-Provocatorio
La diagnosi
I Disturbi della Condotta (DC) e il Disturbo Oppositivo-Provocatorio costituiscono un
importante problema clinico nella consultazione presso gli ambulatori di neuropsichiatria infantile e
psicologia dell’età evolutiva. Si tratta di disturbi relativamente stabili, che si possono porre in
continuità con il disturbo antisociale di personalità nell’età adulta ed il cui costo sociale è tra i più
elevati. L’ottica preventiva sembra risultare la più valida nell’ostacolare l’organizzazione in
comportamenti aggressivi cronici, essendo stati ormai identificati con certezza alcuni fattori di
rischio biologico, psicosociale, familiare.
I DC si caratterizzano per una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale,
aggressiva e provocatoria, con violazione dei diritti fondamentali degli altri e/o delle principali
norme o regole societarie in relazione all’età. Tali modalità devono essere osservate per almeno sei
mesi consecutivi e devono causare una compromissione significativa del funzionamento sociale,
scolastico o lavorativo. Possono essere limitati al contesto familiare; con ridotta socializzazione (a
cui è associata la mancanza di effettiva socializzazione rispetto al gruppo dei pari); con
socializzazione normale (in cui gli atti antisociali possono o meno essere espressi insieme ai
coetanei, ma il livello delle relazioni è adeguato al livello di sviluppo); oppure ancora possono
configurarsi in termini di Disturbo oppositivo-provocatorio, che implica negativismo e oppositività
ma non un comportamento che violi le leggi e i diritti fondamentali degli altri.
I DC si riscontrano con maggior prevalenza tra i maschi sotto i 18 anni in percentuali che
variano tra il 6% e il 16 %, mentre nelle femmine tra il 2% e il 9% (Speranza, 2001). Questo
disturbo è frequentemente associato con condizioni ambientali psicosociali sfavorevoli: povertà,
disoccupazione, sovraffollamento, frequente cambiamento residenziale, frequente ricorso ai Servizi
Sociali. Un esordio precoce dei DC (<5 anni) tende ad essere predittivo di una prognosi peggiore e
di un aumentato rischio di disturbo antisociale e disturbi correlati ad abuso di sostanze in età adulta.
Le ricerche indicano l’importanza di diagnosticare precocemente i comportamenti aggressivi e i
DC dal momento che gli interventi precoci si sono dimostrati i più efficaci in questo ambito (Target,
Fonagy, 1998), mentre tali disturbi si sono rivelati estremamente resistenti al trattamento soprattutto
in adolescenza (Kazdin,1993).
Dati i problemi di comorbilità e di frequente associazione con altre condizioni
psicopatologiche (Disturbi dell’umore, Disturbi d’ansia, DDAI), nei DC diventa molto importante
non solo rilevare il cluster di comportamenti allarmanti, ma anche poter avere un quadro emotivo,
affettivo e relazionale il più possibile completo del bambino, in una prospettiva diagnostica più
ampia ed attendibile, in primo luogo attraverso scale comportamentali come la Child Behavioral
Checklist. Nei DC, si evidenzieranno, ovviamente, punteggi significativamente elevati alle scale
cosiddette “esternalizzanti”.
La psicopatologia dello sviluppo, come abbiamo visto, sottolinea il concetto di
multifattorialità nella determinazione delle problematiche comportamentali ed emotive di rilievo
clinico: ad esempio, in bambini con diagnosi accertata di disturbo oppositivo-provocatorio e di
disturbo della condotta c’è una probabilità 34 volte superiore alla norma di trovare elementi di
rischio in tutti e 4 i domini definiti dalla Greenberg (1999).
Fonagy (1998) ha proposto un modello evolutivo bidirezionale dei disturbi della condotta
che vede l’influenza reciproca tra un bambino con difficoltà temperamentali, da una parte, e una
madre la cui storia di vita e il suo attuale stato mentale le impediscono di relazionarsi in maniera
sintonica dall’altra. Il comportamento incostantemente ed imprevedibilmente responsivo o
addirittura intrusivo e spaventante della madre esacerba l’irritabilità di base del bambino, che a sua
volta aumenta la difficoltà materna a prendersene cura. Fonagy e collaboratori (Fonagy, 1991;
Fonagy, Moran, Target, 1993; Fonagy e Target, 1996) hanno fornito una chiave di lettura ancor più
ricca ed articolata dei comportamenti aggressivi, basata sulle difficoltà di mentalizzazione presenti
in questi bambini. La funzione riflessiva (v. cap 8), cioè la capacità di riflettere sui propri stati
mentali, rappresenta un’acquisizione evolutiva che consente al bambino di rispondere non solo al
comportamento di un’altra persona, ma anche all’idea che il bambino stesso è riuscito a costruirsi
dei suoi atteggiamenti, piani, intenzioni, bisogni, desideri, credenze, ecc.: gli consente, dunque, di
“leggere” la mente altrui e di coglierne i sentimenti, i pensieri e le intenzioni che sono alla base del
comportamento umano. L’attaccamento sicuro costituisce una base solida per la comprensione della
mente altrui, mentre in itinerari di sviluppo insicuri tali competenze si riducono. In particolare negli
attaccamenti di tipo disorganizzato, i livelli di invasività e di ostilità verso il bambino da parte
della figura di attaccamento diventano così massicci e pervasivi da introdurre all’interno della
relazione consistenti elementi di minaccia e paura. La comprensione del comportamento del
caregiver, l’assumere la sua prospettiva mentale, porterebbe questi bambini a confrontarsi con
rappresentazioni estremamente dolorose, cariche di odio, crudeltà o indifferenza. La difficoltà a
mentalizzare e a riconoscere gli stati interni propri e altrui, li priva, tuttavia, del principale
deterrente alla messa in atto del comportamento aggressivo, la possibilità cioè di sviluppare
empatia col dolore e con la sofferenza altrui, o semplicemente la possibilità di immaginare
l’esistenza stessa dei suoi stati mentali. Non riescono, cioè, ad inibire l’aggressività,
rappresentandosi la vittima come priva di pensieri, sentimenti e incapace di vera sofferenza.
(Fonagy e Target, 1997).
Anche qui risulta evidente, al di là di una corretta diagnosi descrittiva di tipo nosografico
tradizionale, l’importanza di un assessment clinico e di strumenti che consentano allo psicologo
clinico un inquadramento diagnostico di tipo “esplicativo”, e cioè capace di mettere in luce il valore
funzionale e relazionale dei sintomi al’interno dei legami d’attaccamento con le figure genitoriali
(Lambruschi et al., 2004b).
L’intervento terapeutico
La complessità dell’eziopatogenesi nei DC, in cui i fattori socio-familiari si connettono
saldamente a fattori biologici e temperamentali rende ragione dei fallimenti a cui spesso sono
sottoposti gli abituali trattamenti psicoterapeutici sia individuali, che di gruppo, della famiglia o
cognitivo-comportamentali. Nei DC, in effetti, è ormai indiscussa la maggior efficacia terapeutica
di interventi multimodali (Kazdin, 1987; Miller e Prinz,1990; Southam-Gerow e Kendall,1997) e
multisistemici, che tengano conto dell’origine complessa del disturbo, cercando di influire sui
diversi fattori che contribuiscono all’emergere del comportamento deviante e prevedendo un livello
di intervento individuale, familiare, extrafamiliare ed eventualmente anche un intervento
psicofarmacologico, condotti da una medesima equipe. Più che di intervento psicoterapeutico in
senso stretto, in effetti, in questi quadri psicopatologici sarebbe più opportuno parlare di necessità di
trattamento integrato.
Nei primi anni di vita, quando l’organizzazione del Sé e gli schemi interpersonali del
bambino si esprimono principalmente sul piano procedurale ed emotivo, sarà più opportuno ed
efficace centrare l’intervento terapeutico sulla relazione madre/bambino e/o sulla coppia genitoriale.
L’intervento potrà giovarsi, in questi casi, di una fase iniziale di assessment che ponga una
particolare enfasi sul processo di osservazione della relazione genitori/bambino e su un suo oculato
utilizzo ai fini di un incremento di consapevolezza nel genitore delle proprie modalità di
accudimento-cura e di responsività ai segnali d’attaccamento del figlio (Lambruschi et al, 2004d).
Un’altra area importante dell’intervento col genitore, sia in età prescolare che
successivamente, dovrà riguardare la gestione delle “regole educative” e la negoziazione dei
bisogni, tramite contrattazione delle contingenze di rinforzo. I genitori dei bambini con DC
(soprattutto se in comorbilità con un DDAI), hanno certamente bisogno di essere sostenuti sia nella
gestione delle regole educative quotidiane, sia in una maggiore comprensione delle motivazioni
neurobiologiche e relazionali del comportamento del bambino. La ristrutturazione di tali aspetti può
essere affrontata attraverso specifici percorsi “psicoeducativi” detti “Parent training” (individuali o
di gruppo): si tratta, com’è noto, di programmi strutturati, volti alla promozione nei genitori di
nuove competenze comunicative, educative, di gestione delle regole e del conflitto (WebsterStratton, 1996; Kazdin 1996; Vio, Marzocchi, Offredi, 1999). Il programma prevede diverse unità
di lavoro con lo scopo di aiutare i genitori su diversi aspetti della interazione col figlio:
comprensione della natura del problema; preparazione al cambiamento e alla complessità del
problema; imparare ad effettuare delle scelte educative che favoriscano l'autoregolazione;
individuare i comportamenti negativi del bambino e ampliare il bagaglio delle strategie educative;
ecc. Attraverso le tecniche di Parent Training, tendono a migliorare sia le abilità interpersonali del
genitore che quelle del bambino, col risultato di un comportamento sociale più efficace, soprattutto
nei disturbi di tipo oppositivo-provocatorio (Hanish, Tolan, Guerra, 1996).
L’importanza di un intervento terapeutico di tipo multimodale espletato su più livelli e più
sistemi, si rende ancor più evidente col passaggio all’età scolare. Il ragazzo, a questa età, comincia
a giocare il proprio stile interpersonale su più fronti relazionali e su contesti diversi (la scuola, il
gruppo dei pari e le amicizie extrascolastiche). Se, da un lato, è necessario continuare ad offrire il
dovuto spazio e supporto terapeutico alle figure parentali, e ora anche al bambino individualmente,
dall’altro, andranno attentamente considerati il possibile contributo terapeutico, così come le
richieste di supporto, veicolabili attraverso questi nuovi ambiti educativi e sociali, in primo luogo il
contesto scolastico.
L’approccio cognitivo-comportamentale classico, ha messo a punto un insieme di procedure
che si sono dimostrate piuttosto utili nella terapia dei DC e che hanno in sé le potenzialità per
promuovere molti di questi obiettivi. A cominciare dai diversi programmi o “training
all’autocontrollo”, nei quali i bambini vengono supportati nell’individuare le esperienze o le
sensazioni cenestesiche o fisiologiche che segnalano la comparsa di una reazione di rabbia, e
incoraggiati a graduare i livelli d’intensità dell’emozione avvertita. Inoltre, si può agire sul “dialogo
interno” aiutando il bambino ad identificare pensieri che possono aumentare o ridurre l’attivazione
emotiva della rabbia, condizionando i comportamenti. A questo riguardo, uno dei programmi
terapeutici più interessanti e completi messi a punto per il trattamento dei bambini con
comportamenti aggressivi, è rappresentato dal Anger Coping Program (Lochman et al, 2000), una
versione in qualche modo ridotta del Coping Power Program (Lochman, Wells, 1996) che si
prefigge i seguenti obiettivi: aumento della consapevolezza dei fenomeni neurovegetativi, affettivi e
cognitivi legati all’attivazione della rabbia; potenziamento delle capacità autoriflessive e di autocontrollo; incremento dei repertori comportamentali dei bambini di fronte ai conflitti sociali,
tentando di ridurre il loro deficit di abilità nel risolvere con successo i problemi interpersonali,
supportandoli nell’identificare le situazioni conflittuali come problematiche e incoraggiandoli ad
incrementare il loro repertorio di risposta a tali situazioni (Social Problem Solving Skills).
La scuola, così come altri contesti educativi (centri pomeridiani, parrocchia, ecc), possono
rappresentare per il ragazzo con DC ambiti di grande criticità e conflitto, così come,
opportunamente coinvolti e supportati, contesti di grande generatività e generalizzazione delle
abilità di regolazione emotiva e sociali che egli va, via via, acquisendo in terapia. Gli insegnanti e
gli educatori, possono essere coinvolti, direttamente o indirettamente, in alcuni obiettivi educativi
pianificati nel rapporto con i genitori e con il ragazzo, ad esempio nella organizzazione di un
eventuale contratto comportamentale. È essenziale che il ragazzo avverta comunità di intenti e un
chiaro rapporto collaborativo tra scuola e famiglia.
Evoluzione in età adolescenziale e adulta
Il disturbo oppositivo provocatorio è considerato un precursore e un fattore predisponente
all’insorgenza del DC; nell’ambito dei DDAI è stato dimostrato come i quadri sintomatologici in
cui prevale l’iperattività e l’impulsività rispetto al problema attentivo hanno una probabilità elevata
di sviluppare un DC in adolescenza. I casi in cui si associa una comorbilità tra DC e DDAI e/o
disturbo oppositivo provocatorio presentano un quadro sintomatologico più grave ed una
evoluzione più sfavorevole, talora condotte antisociali e problemi con la giustizia, o abuso di
sostanze stupefacenti (Hinshaw, 1987).
Si è osservata, in effetti, una stabilità dei DC che oscilla da moderata ad alta, a seconda delle
ricerche, dall’infanzia all’adolescenza. L’aggressività e i pattern comportamentali distruttivi
identificano in maniera attendibile e precoce i DC (Tremblay et al., 1992, 1994; White et al., 1990).
E’ inoltre improbabile che i bambini che non hanno mostrato comportamenti aggressivi nella prima
infanzia, sviluppino livelli elevati di aggressività nelle età successive (Shaw, Gilliom, Giovannelli,
2000). In particolare, è stato accertato il legame tra i disturbi della condotta nei maschi e i
comportamenti delinquenziali e criminali negli adulti, mentre nelle femmine il destino prevalente
sembra essere quello di un disturbo depressivo o ansioso. Molti studi longitudinali hanno in effetti
evidenziato come nei maschi (75%) la più frequente evoluzione naturale in età adulta sia verso
comportamenti delinquenziali, antisociali, d’abuso di sostanze stupefacenti; solo nell’11% dei casi
si sviluppa una patologia psichiatrica maggiore (schizofrenia, disturbo depressivo).
Svariati ambiti di ricerca mostrano come alcuni di questi gravi disturbi esternalizzanti
dell’infanzia, in cui il campo mentale e interpersonale è dominato dall’impulsività,
dall’aggressività, dalla disregolazione emotiva e dalla drammaticità talvolta teatrale delle reazioni
emotive e comportamentali, rappresentino i precursori di quelli che poi nell’adolescente e
nell’adulto saranno descritti come Disturbi Borderline di Personalità (v. cap. 8).
Disturbi da deficit d’Attenzione e Iperattività
Sempre nell’area dei disturbi “esternalizzanti” è doveroso accennare ai DDAI, quadri
clinici ad esordio precoce che combinano un comportamento iperattivo/impulsivo scarsamente
modulato con una mancanza di perseveranza nell'esecuzione di un compito.
La diagnosi
Il DSM-IV (che su questa area psicopatologica mostra maggiore definizione e chiarezza
dell’ICD10), prevede tre sottotipi di questo disturbo:
-
Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, Tipo con Disattenzione Predominante.
Questo sottotipo dovrebbe essere usato se 6 (o più) sintomi di disattenzione (ma meno di 6
sintomi di iperattività-impulsività) sono persistiti per almeno 6 mesi.
- Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, Tipo con Iperattività-Impulsività
Predominanti: questo sottotipo dovrebbe essere usato se 6 (o più) sintomi di iperattivitàimpulsività (ma meno di 6 sintomi di disattenzione) sono persistiti per almeno 6 mesi. Ciò
non toglie che in questi casi la disattenzione spesso possa essere una manifestazione clinica
significativa.
- Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, Tipo Combinato: questo sottotipo dovrebbe
essere usato se 6 (o più) sintomi di disattenzione e 6 (o più) sintomi di iperattivitàimpulsività hanno persistito per almeno 6 mesi.
E’ molto frequente nei DDAI la comorbidità con altri disturbi. E’ utile ricordare che la
diagnosi in comorbilità di DDAI e Disturbo Oppositivo–Provocatorio è severa anche in relazione
alla prognosi come abbiamo già notato; l’associazione invece con un Disturbo d’Ansia può
contribuire nel tempo a determinare l’insorgere di sintomi depressivi, e difficoltà nelle relazioni
interpersonali; infine, la presenza di problemi di comportamento e/o di attenzione accanto ad un
Disturbo Specifico di apprendimento, espone questi bambini a frequenti insuccessi sul piano
dell’apprendimento, a difficoltà nella relazione con l’insegnante e con i coetanei, così da rendere
difficile il loro percorso scolastico.
In merito all’eziologia del DDAI, vi è oramai un certo accordo tra clinici e ricercatori nel
ritenere assai rilevanti fattori di natura neurobiologica (Barkley, 1997; Barkley, 1998; Ross e Ross,
1982; Sieg et al. , 1995; Houk e Wise, 1995; Russel e Barkley, 1999), mentre l’ambiente sociale e/o
familiare avrebbe comunque il compito importante di modulare le problematiche primarie del
Disturbo (iperattività, disattenzione, impulsività) e quelle secondarie (ad esempio, rispetto di regole,
difficoltà nei rapporti sociali, basso livello di autostima), nel senso di riuscire in parte a contenerle
o, al contrario, se l’ambiente sociale e/o familiare è disgregato, ad enfatizzarle. E’, infatti,
clinicamente ben evidente che quando il deficit autoregolativo di base va ad incontrarsi con quote di
sensibilità sufficientemente ampie, come nei pattern d’attaccamento sicuri, le mancanze o gli
eccessi di segnalazione del bambino riescono, in qualche modo, ad essere compensati o contenuti
dal genitore, con una graduale (più o meno ampia) tendenza alla normalizzazione del quadro
comportamentale e attentivo del bambino. Si determina e si mantiene, invece, un disturbo di
evidenza clinica quando il comportamento scarsamente regolato del bambino s’incontra con
atteggiamenti genitoriali, con forme di legame, che per essere adeguatamente gestite e “curate”,
richiedono un’amplificazione del deficit stesso, che si trasforma quindi in sintomo. In un itinerario
di sviluppo ansioso-resistente, ad esempio, l'iperattività e la distraibilità finiscono per assumere una
chiara funzione coercitiva e di controllo del genitore. Paradossalmente, si potrebbe osservare che
per un bambino immerso in un funzionamento diadico di tipo ansioso-resistente, su un piano
strettamente funzionale alla gestione del legame e quindi della stabilità del proprio senso di sé,
disporre di un tale deficit autoregolativo, di una forma di “perdita di controllo” capace di ancorare
potentemente a sé il genitore, rappresenta una “risorsa” tacita di notevole valore, indipendentemente
da tutti gli “effetti collaterali” che sul piano educativo tali condotte possono procurargli.
Per quanto riguarda il percorso diagnostico, lo psicologo ad una attenta raccolta dei dati
anamnestici personali e familiari, dovrà affiancare una raccolta di informazioni dal contesto
scolastico e sui livelli di apprendimento, insieme ad un accurato esame neuropsicologico del
bambino che preveda quanto meno: le competenze di pianificazione, monitoraggio e controllo
dell’azione, della capacità di inibire la risposta anche se programmata (ad esempio, assenza di
comportamenti di perseverazione), il grado di mobilitazione delle risorse attentive (compiti di
vigilanza, mantenimento dell’attenzione sul compito) (Vio, 2004). L’osservazione dei modelli
d’attaccamento in atto, dello stato mentale dei caregivers e della relativa organizzazione del sé che
va strutturandosi nel bambino, di nuovo, vengono ad assumere un ruolo particolarmente importante.
L’intervento
I modelli di trattamento più sperimentati sui problemi di inattenzione, impulsività e
iperattività si focalizzano su tre ambiti possibili di intervento: 1) il miglioramento delle abilità
autoregolative nel bambino (training delle autoistruzioni verbali abbinato a problem solving e
tecniche di rinforzo); 2) il coinvolgimento delle figure genitoriali nel contenimento e nella gestione
educativa quotidiana del bambino (Parent Training); 3) il sostegno agli insegnanti e al contesto
scolastico, ambito entro il quale le risorse del bambino con DDAI mostrano più chiaramente i loro
limiti (Teacher Training) (Vio, 2004). In Italia sono a disposizione alcuni programmi di intervento
sperimentati (Cornoldi et al., 1996), che sviluppano il modello originario di Kendall e Braswell
(1985), con l’obiettivo di far acquisire una migliore competenza di regolazione autonoma al
bambino con DDAI. Per ovviare al limite che a miglioramenti nell’utilizzo delle risorse attentive di
questi bambini, non corrisponda una riduzione di comportamenti di iperattività e di disattenzione
nei contesti di vita quotidiana, viene particolarmente enfatizzato il lavoro Parent Training (Barkley,
1987-97, Vio, Marzocchi e Offredi, 1999). Il programma ha evidenziato cambiamenti significativi
osservati nel comportamento del figlio all’interno della vita familiare, ma anche un miglior senso di
competenza nei genitori (in particolare nelle madri); ciò favorirebbe circolarmente una maggiore
disponibilità di interazione positiva con il proprio figlio. Per quanto concerne infine le modalità di
aiuto che possono essere messe in atto dalla scuola (dalla organizzazione dell’aula, all’analisi
funzionale dei comportamenti problema, all’introduzione di tecniche metacognitive di controllo
dell’attenzione) si può fare riferimento al programma strutturato da Cornoldi et al. (2001), con
sperimentazioni per ora incoraggianti (Marzocchi, Di Pietro, Vio, Bassi, Filoramo, Salmaso, 2002).
Delle possibili evoluzioni nel tempo di questi quadri abbiamo già discusso osservando la
loro frequente comorbidità con i vari disturbi da internalizzazione e da esternalizzazione.
ASSE II – I DISTURBI SPECIFICI DELLO SVILUPPO
Questo asse comprende entità cliniche descrittivamente eterogenee: i disturbi della funzione
motoria, i disturbi della funzione linguistica, i disturbi dell’apprendimento scolare, le sindromi da
alterazione globale dello sviluppo psicologico (autismi e sindromi correlate). Tuttavia questi
disturbi di aree di sviluppo singole o multiple presentano caratteristiche biologiche ed evolutive
simili: 1) hanno un esordio precoce nell’infanzia; 2) hanno un decorso naturale che tende alla
cronicizzazione con un lieve miglioramento spontaneo al crescere dell’età; 3) sono disturbi
funzionali fortemente correlati alla maturazione biologica del SNC (sistema nervoso centrale) e
tuttavia non sono di solito correlati ad una malattia neurologica né ad alterazioni macroscopiche del
SNC; 4) presentano una base familiare ereditaria per disturbi uguali o simili; 5) sono molto più
frequenti nei maschi che nelle femmine. Come criterio dimensionale utile per distinguere il disturbo
specifico di sviluppo da un ritardo o da una variazione fisiologica della funzione considerata,
Rutter osserva che il ritardo di sviluppo della funzione è severo rispetto agli standard normativi,
anomalo sul piano qualitativo, associato sempre ad anomalie comportamentali e a disadattamento
sociale nel contesto di vita del bambino.
Pertanto, per fare diagnosi di disturbo specifico dello sviluppo, occorre disporre di strumenti
anamnestici, osservativi e testologici capaci di descrivere la severità del disturbo, la sua qualità
intrinseca e in generale la sua indipendenza da malattie del SNC. A questo scopo occorre disporre,
non solo di strumenti psicometrici standardizzati descrittivi della funzione in sviluppo (motoria,
linguistica, scolare, psicologica), ma anche di strumenti qualitativi e interpretativi che in genere
sono forniti da modelli teorici esplicativi di sviluppo di quella funzione.
Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
La diagnosi
Nei criteri diagnostici l’ICD10 precisa il criterio dimensionale del disturbo: “un punteggio
ad un test standardizzato di coordinazione motoria fine oppure di motricità grossolana almeno due
deviazioni standard al di sotto del livello atteso in base all’età cronologica del bambino”. A questo
criterio dimensionale psicometrico aggiunge un criterio sociale: “il disturbo interferisce
significativamente con il profitto scolastico e con le attività quotidiane”.
Le funzioni motorie considerate sono perciò la motricità grossolana o posturale che ha a
che vedere con la postura, la funzione statica, l’equilibrio, il cammino e la corsa e la motricità fine
che ha che vedere con la coordinazione oculomanuale e la manipolazione. O l’una o l’altra di queste
funzioni o entrambe devono essere compromesse in maniera rilevante e sul piano psicometrico e sul
piano delle conseguenze sociali perché ne risultano compromesse l’autonomia nella vita quotidiana
e l’apprendimento della lettoscrittura.
Per diagnosticare tale disturbo tuttavia, non vi deve essere una condizione neurologica
diagnosticabile e non deve coesistere un ritardo mentale con Q. I. <70. Ne consegue che sul piano
diagnostico lo psicologo deve disporre in prima battuta di strumenti psicometrici standardizzati che
descrivano lo sviluppo della motricità grossolana, della motricità fine e della autonomia personale e
sociale nelle attività quotidiane del bambino. Tali strumenti sono rappresentati dalle scale di
sviluppo psicomotorio infantile che in genere coprono la fascia di età da 0 a 6 anni: scala di
Brunet-Lèzine, scala di Griffiths, scala di Denver. Queste scale permettono di valutare lo sviluppo
del bambino nelle aree della motricità grossolana, della motricità fine e della autonomia personale e
sociale fornendo per ogni area la media di sviluppo e le deviazioni standard in difetto o in eccesso.
Per rispondere alla definizione diagnostica lo sviluppo del bambino al test deve risultare
inferiore alla -2DS nel settore motorio grossolano e/o fine e nella autonomia personale e sociale. Per
contro le funzioni cognitive non devono risultare compromesse alla -2DS e il Q. I. deve essere >70.
In realtà, giacchè la diagnosi di disturbo specifico della funzione motoria si pone nei primi anni di
vita, non esiste in tale fascia di età uno strumento affidabile per la misura del Q. I., se non a partire
dai 4 anni di età con la scala Wechsler per i bambini in età prescolare. Per escludere una
compromissione della funzione cognitiva, può essere allora sufficiente ricorrere alla
somministrazione delle prove di Piaget del periodo sensomotorio per i primi due anni di vita e del
periodo rappresentativo per la fascia 2-5 anni.
Per escludere una malattia neurologica diagnosticabile, ovviamente, il bambino con disturbo
della funzione motoria deve sempre effettuare una visita medica neuropsichiatria infantile per
escludere la presenza all’anamnesi di crisi convulsive e alla osservazione di anomalie di sviluppo
del cranio, di segni neurologici focali e di anomalie del tono muscolare.
Tab. 1 Criteri di inclusione ed esclusione per il disturbo specifico della funzione motoria
Criteri di inclusione
Criteri di esclusione
Quoziente di sviluppo psicomotorio <70
Quoziente Intellettivo<70
In Motricità grossolana e/o
Malattia neurologica (es. Paralisi cerebrale
infantile)
In Motricità fine
L’intervento
In questo campo vanno tenuti distinti gli interventi nel disturbo della funzione motoria
grossolana e della funzione motoria fine, in quanto funzioni con basi biologiche diverse e con
modelli teorici di intervento diversi. I diversi interventi sul bambino con disturbo motorio sono
praticati dal fisioterapista, che dovrà avere la capacità di reinterpretare la fisioterapia in modo che
questa diventi esperienza di vita quotidiana piuttosto che rinchiudere la vita all’interno del mero
esercizio terapeutico (Ciotti, 1999).
Le tecniche fisioterapiche più utilizzate sono chiamate tecniche di facilitazione afferenziale
perché utilizzano stimolazioni afferenti di tipo sensoriale e cenestesico per stimolare lo sviluppo dei
pattern motori corretti. Esse si distinguono in tecniche di facilitazione che agiscono
prevalentemente a livello sottocorticale, indipendenti dal controllo volontario, per lo sviluppo della
motricità grossolana e tecniche che agiscono prevalentemente a livello corticale, dipendenti dal
controllo volontario, per lo sviluppo della motricità fine.
La tecnica di facilitazione sottocorticale più utilizzata e diffusa nel disturbo della funzione
motoria grossolana è la Neurodevelopmental Therapy (NDT) dei coniugi Bobath (1985). Essa si
basa sul concetto neuroevolutivo che la funzione statica del cammino si organizza grazie alla
successione di una sequenza precisa e predeterminata dei riflessi di raddrizzamento del capo e del
tronco, dei riflessi protettivi di paracadute in basso-di lato-in avanti-in dietro e dei riflessi di
equilibrio prono-supino-seduto-quadrupede. Il fisioterapista attraverso esercizi specifici dovrebbe
indurre lo sviluppo dei riflessi mancanti. In realtà gli studi randomizzati sulla efficacia della tecnica
Bobath non sono affatto incoraggianti. In effetti l’acquisizione della funzione statica e del cammino
è un processo biologico programmato geneticamente in maniera molto vincolante e non sembra che
stimoli esterni o ambientali possano in nessun modo ostacolare o favorire i tempi di mielinizzazione
programmati geneticamente. Maggiore attenzione rivestono a questo proposito perciò gli interventi
abilitativi ed educativi, in cui il fisioterapista ad esempio consiglia i genitori su come tenere il
bambino in posture corrette quando è sdraiato, quando è seduto, quando è in piedi, evitando carichi
gravitari eccessivi capaci di provocare deformità articolari .
La tecnica corticale più utilizzata nel disturbo della motricità fine è quella di Perfetti
(Morosini, 1978), utilizzata per l’uso degli arti superiori nella manipolazione. Al contrario della
motricità grossolana sotto stretto controllo genetico, la motricità fine invece risente sensibilmente
della ricchezza o della povertà delle esperienze sensomotorie della prima infanzia. E’ nota da tempo
ad esempio la goffaggine motoria dei bambini deprivati allevati nei brefotrofi. Le recenti ricerche
sui neuroni a specchio (Rizzolati e Sinigaglia, 2006) dimostrano i meccanismi neurofunzionali che
sono alla base nei primati e nell’uomo dell’apprendimento delle sequenze motorie, specie
oculomanuali, per imitazione. L’imitazione gestuale, insieme alla nozione di permanenza
dell’oggetto e alla causalità operazionale, già per Piaget (1937) costituiva un’area fondamentale per
l’apprendimento, nel periodo esploratorio sensomotorio dei primi due anni di vita del bambino.
Utilizzando le nozioni di Piaget relative allo sviluppo del periodo sensomotorio, Uzgiris e
Hunt (1979) hanno costruito una scala che consente una valutazione analitica dello sviluppo
sensomotorio: attraverso il gioco e l’esplorazione di materiali standardizzati permette di collocare il
bambini piccolo nella fase di sviluppo piagetiana relativa alle seguenti aree: nozione di permanenza
dell’oggetto; sviluppo di mezzi per ottenere fini; sviluppo dell’imitazione gestuale e vocale;
sviluppo della causalità operazionale; costruzione di schemi relazionali fra gli oggetti. Tale scala
può essere utilizzata per diversi tipi di intervento. La scala consente di conoscere per quel bambino
in ciascuna area esaminata quale è la zona prossimale di sviluppo, ovvero quale è la performance
sensomotoria più vicina a quella già posseduta e che pertanto può essere stimolata con la
presentazione di una determinata attività. Montenegro et al. (1977), utilizzando questa metodica,
hanno dimostrato in bambini di basso ceto sociale che i soggetti, esaminati con la scala e sottoposti
agli stimoli conseguenti, all’età di due anni avevano uno sviluppo sensomotorio e abilità
oculomanuali superiori a quelli non trattati.
Parallelamente ai diversi interventi riabilitativi e abilitativi, è di importanza cruciale che nel
trattamento del bambino con disturbo motorio (così come dei disturbi sensoriali: deficit uditivo o
visivo) l’equipe curante ponga grande attenzione alle implicazioni relazionali ed emotive che tali
problematiche inevitabilmente comportano. La condizione di vulnerabilità fisica del bambino, i
limiti che determina nelle autonomie personali e sociali, l’esposizione a complessi seppur necessari
percorsi sanitari, si riflette inevitabilmente in cospicue difficoltà nella regolazione delle emozioni e
dei comportamenti. Ovviamente la qualità dei legami d’attaccamento con le figure genitoriali
rappresenta la migliore tutela a questo riguardo. Tuttavia, anche il genitore più sensibile e
responsivo, di fronte a un bambino con “bisogni speciali” come questo dovrà essere adeguatamente
supportato e contenuto nella propria funzione educativa e affettiva, così come nella elaborazione
delle aree emozionali critiche (angoscia, dolore, sentimenti depressivi) che i deficit del figlio fanno
inevitabilmente risuonare nel suo universo mentale.
Evoluzione in adolescenza e in età adulta
Riguardo alla prognosi naturale a distanza in adolescenza ed età adulta del disturbo specifico
motorio ben poco si sa dalla letteratura. A questo proposito basta forse citare il commento di Brunet
e Lèzine (1951) in occasione della pubblicazione del test omonimo coi dati longitudinali di
osservazione: “non si può assegnare un forte significato prognostico al quoziente derivato dai test
psicomotori eseguiti nei primi due anni di vita. Le misure precoci di sviluppo non danno
informazioni decisive sulla intelligenza futura ... Vediamo che è soltanto a partire dai 30 mesi che si
stabilisce una differenza stabile di livello tra i gruppi di bambini seguiti e questo in relazione
soprattutto allo sviluppo del linguaggio che si organizza fortemente in questo periodo sulla
costruzione della frase”.
Il disturbo specifico di linguaggio
Diagnosi
L’ICD10 prevede due forme di disturbo specifico del linguaggio: una forma in cui sono
compromesse sia la comprensione che l’espressione del linguaggio e una forma in cui è
compromessa la sola espressione linguistica. Poiché infatti, come dice la Bishop (1989), il
linguaggio è un edificio che ha come fondamenta le strutture di comprensione linguistica su cui poi
si costruiscono le capacità espressive, è evidente che non ci può essere disturbo della comprensione
del linguaggio senza compromissione delle abilità espressive e che il disturbo limitato alle sole
abilità espressive con capacità di comprensione normali è meno severo del precedente.
Per entrambe le forme l’ICD10 precisa il criterio dimensionale del disturbo nel seguente
modo: a) disturbo specifico del linguaggio espressivo: la capacità di esprimersi mediante il
linguaggio, valutata con test standardizzati, è più di due deviazioni standard al di sotto del livello
appropriato per l’età del bambino; la capacità di comprensione del linguaggio, valutata con test
standardizzati, è compresa entro il limite di due deviazioni standard per l’età del bambino; b)
disturbo misto della comprensione e della espressione del linguaggio: la comprensione del
linguaggio, valutata con test standardizzati, è di due deviazioni standard al di sotto del livello
appropriato per l’età del bambino.
Inoltre, per diagnosticare il disturbo specifico di linguaggio, devono mancare: alterazioni
neurologiche, sensoriali, anatomiche; una sindrome da alterazione globale dello sviluppo
psicologico; una intelligenza non verbale compromessa: ovvero se il Q. I. non verbale del soggetto
è <70 non può essere fatta diagnosi di disturbo specifico di linguaggio.
Pertanto lo psicologo, di fronte a un bambino in età prescolare che dopo i due anni non parla
o ha un linguaggio incomprensibile, in prima battuta potrà utilizzare un test di linguaggio
standardizzato per la comprensione e l’espressione verbale semantica (vocabolario) e sintattica
(frasi). I test più usati a questo scopo per la comprensione semantica e per la comprensione
sintattica sono rispettivamente il Peabody Picture Vocabulary test (in cui si richiede al soggetto di
indicare oggetti denominati dall’esaminatore su un campione di figure) e il test di ricezione
grammaticale TROG di Bishop (in cui si richiede al soggetto di indicare azioni illustrate da frasi
dell’esaminatore su un campione di figure) (Ciotti, 1996). Per l’espressione semantica e sintattica
sono rispettivamente una prova di vocabolario espressiva, come il test di Brizzolara, e una prova di
costruzione di frasi illustrative di azioni figurate, come il test Action Picture di Renfrew.
Per verificare la normalità della intelligenza non verbale, si potrà ricorrere alle prove non
verbali della scala Wechsler per l’età prescolare oltre i 4 anni di età, oppure alle prove di Piaget del
periodo rappresentativo che sono prove grafomotorie non verbali, tra i 2 e i 4 anni di età.
Per escludere un disturbo della comunicazione associato a sindrome da alterazione dello
sviluppo psicologico, lo psicologo dovrà verificare che il bambino utilizzi la comunicazione
gestuale, il gioco simbolico e l’indicazione protodichiarativa (il bambino indica un oggetto
all’interlocutore per condividere un interesse con lui e mentre sta indicando guarda il viso
dell’interlocutore per vedere se quello guarda l’oggetto indicato). Infine, per escludere alterazioni
neurologiche e sensoriali, sarà necessario un esame neurologico, della acuità visiva ed uditiva.
Tab 2 Criteri di inclusione ed esclusione per il disturbo specifico di linguaggio
Criteri di inclusione
Criteri di esclusione
Test di linguaggio
Sordità neurosensoriale
<2DS in espressione verbale e/o
Malattia Neurologica
<2DS in comprensione verbale
Ritardo mentale
Sindrome da alterazione globale dello s. psicologico
Intervento
Un importante studio di metanalisi (Scarborough et al. , 1994) ha dimostrato che leggere
libri al bambino da parte del genitore fin dai sei mesi di vita migliora significativamente il suo
sviluppo linguistico, in particolare del vocabolario e delle competenze fonologiche. Dagli anni ’90
esistono perciò in diversi paesi, come USA e Regno Unito, programmi di promozione della
lettura dei genitori ai propri figli piccoli come mezzo di prevenzione dei disturbi di linguaggio.
La promozione è fatta dai pediatri, dalle istituzioni bibliotecarie cittadine e di quartiere, dalle scuole
dell’infanzia. In Italia dal 2000 esiste un programma di questo tipo chiamato “Nati per Leggere”
(Causa, 2007).
In genere il trattamento riabilitativo del bambino con disturbo specifico del linguaggio è
affidato alla figura professionale del logopedista. I metodi riabilitativi logopedici più comunemente
usati sono tre: a) Metodo ortofonico “sintomatico”: è’ il metodo classico, più lineare e direttivo, in
cui il logopedista chiede al bambino di eseguire esercizi programmati e finalizzati a migliorare
l’articolazione dei fonemi, il vocabolario lessicale e la costruzione sintattica delle frasi. b) Metodo
logopedico (cosiddetto) “psicoterapico”: il logopedista ha come obiettivo fondamentale il
raggiungimento di una relazione terapeutica intensa col bambino in cui utilizza diversi strumenti
comunicativi ed espressivi mimici, gestuali, grafomotori e infine verbali. c) Metodo logopedico
“naturale”: il logopedista interviene indirettamente mediante una consulenza alla madre (e agli
educatori) sulle tappe linguistiche che deve stimolare nel suo bambino attraverso l’articolazione
chiara dei fonemi, l’utilizzo di frasi semplici e corrette, la lettura di immagini e storie illustrate.
Per nessuno di questi metodi esiste un controllo sperimentale rigoroso di efficacia. In
generale gli esperti raccomandano che la presa in carico logopedica per essere utile deve
presupporre: una lunga esperienza personale del logopedista con bambini che hanno disturbo di
linguaggio; una buona formazione relazionale; la definizione di obiettivi a breve e a lungo termine e
la loro verifica; il dialogo sistematico con la famiglia e con la scuola; la consapevolezza dei limiti
delle metodiche riabilitative, limiti tanto più grandi quanto più grave è il disturbo trattato.
Proprio l’incertezza sulla efficacia dell’intervento riabilitativo nel disturbo specifico di
linguaggio, oltre alla difficoltà di differenziare tra i due e i tre anni di età il disturbo specifico dal
ritardo semplice di linguaggio, non consiglia a tuttoggi di effettuare uno screening dei disturbi del
linguaggio nei primi tre anni di vita (Law, 2000). Si ricorda infatti che lo screening di un disturbo o
di una malattia è consigliabile solo quando siano soddisfate tutte queste condizioni: ci sono
conoscenze precise sulla storia naturale del disturbo; esiste un metodo per diagnosticare il disturbo
specifico (pochi falsi positivi), sensibile (pochi falsi negativi) e non costoso; esistono interventi
terapeutici capaci di minimizzare o neutralizzare gli effetti del disturbo nei trattati rispetto ai non
trattati (Ciotti et al. 1986).
Anche per le difficoltà di linguaggio, ovviamente, occorre considerare con attenzione
l’interazione con altre variabili di rischio o protettive, che, a fianco di quella logopedica, ampliano e
rendono talora essenziale la funzione psicologica. In effetti, i disturbi specifici di sviluppo del
linguaggio (unitamente ai disturbi dell’apprendimento, che tra poco analizzeremo) ben si prestano,
per la loro natura, ad un ragionamento eziologico complesso e denso di più ricchi significati alla
luce della psicopatologia dello sviluppo. Cominciano ad accumularsi prove interessanti sulla
profonda influenza che i legami affettivi primari possono esercitare sullo sviluppo e l’efficace
utilizzo delle funzioni linguistiche e cognitive, in funzione dei livelli di sensibilità materna e
dell’efficacia del suo “ruolo tutoriale” verso il bambino (Meins, 1997). Anche assumendo una
vulnerabilità di fondo nel funzionamento linguistico e neuropsicologico di questi bambini, appaiono
evidenti al clinico esperto le possibili funzioni protettive, compensative e riparative che può
comunque esercitare una relativa sicurezza nel contesto relazionale di cui il bambino si nutre. Egli
pertanto, nell’inquadramento diagnostico e nel trattamento di questi problemi, non potrà non farsi
carico in qualche modo, anche del significato relazionale che il problema assume e del modo in cui
viene gestito ed utilizzato dal bambino nelle sue relazioni significative. I processi linguistici e
d’apprendimento possono organizzarsi e svilupparsi in maniera armonica solo all’interno di una
relazione percepita come significativa, sicura e contenitiva. Viceversa, in contesti connotati da
livelli più o meno elevati di insicurezza, discontinuità, distanza affettiva o addirittura pericolo, il
deficit si inserisce inesorabilmente in un circolo vizioso di progressivo aggravamento delle
performance linguistiche o di apprendimento del bambino e di “resistenza” al trattamento
rtiabilitativo entro cui gli operatori stessi finiscono spesso per dibattersi impotenti.
Evoluzione in adolescenza e in età adulta
Riguardo alla prognosi a distanza in adolescenza e giovane età del disturbo specifico di
linguaggio, in una recensione ampia di studi Bishop (1994) prende in considerazione: la persistenza
nel tempo di un disturbo del linguaggio evidenziabile con test specifici,la presenza in tutta l’età
scolare di disturbi di apprendimento, la comparsa in comorbidità di disturbi psichiatrici (DDAI,
disturbo della condotta e comportamento antisociale, psicosi paranoide), la scarsa autonomia sociale
in età adulta rispetto al lavoro e alla vita familiare. L’autore conclude che ognuno di questi eventi
negativi evolutivi interviene con frequenza statisticamente maggiore rispetto alla popolazione
normale nei soggetti che da bambini hanno avuto un disturbo specifico del linguaggio misto, in cui
cioè era interessata anche la capacità di comprensione del linguaggio.
Disturbi specifici dell’apprendimento scolare
I Disturbi di Apprendimento costituiscono una evenienza piuttosto frequente ed un problema
al quale gli specialisti dell’infanzia devono rivolgere una parte rilevante del loro impegno. La causa
di questi disturbi è solitamente rappresentata da una alterazione, funzionale o lesionale, di una
qualche area dell’apparato neurologico, ma le conseguenze possono andare molto al di là di una
inefficienza in aree specifiche del funzionamento cognitivo. Questi disturbi possono, infatti,
incidere profondamente sulla direzione dell’itinerario di sviluppo del bambino e concorrere a
determinare, a volte, situazioni di disagio, disadattamento o addirittura di disturbo mentale.
L’ICD10 distingue il disturbo specifico di lettoscrittura e il disturbo specifico delle abilità
aritmetiche, che possono decorrere isolati, ma anche associati fra loro.
A. Il disturbo specifico di lettoscrittura
L’ICD10 precisa il criterio dimensionale di questo disturbo nel seguente modo: “un
punteggio nell’accuratezza e/o nella comprensione della lettura che è almeno due deviazioni
standard al di sotto del livello atteso sulla base dell’età cronologica e dell’intelligenza generale del
bambino; capacità di lettura e Q. I. devono essere valutati con test standardizzati somministrati
individualmente ... più un punteggio ad un test standardizzato di dettato che sia almeno due
deviazioni standard al di sotto del livello atteso in base all’età cronologica e al Q. I. del bambino”.
Inoltre, per diagnosticare il disturbo specifico, non devono essere presenti: difetto della vista;
difetto dell’udito; sindrome neurologica; gravi inadeguatezze nell’istruzione ricevuta (per assenze
da scuola, cambi di scuola, assenze o inadeguatezze gravi degli insegnanti); Q. I. < 70 con ritardo
mentale. Pertanto, di fronte ad un bambino segnalato dalla scuola o dalla famiglia per insufficiente
profitto scolastico specie in italiano e nelle materie letterarie, lo psicologo potrà ricorrere in prima
battuta a strumenti standardizzati capaci di misurare la lettura nelle abilità di accuratezza (numero di
errori nel leggere le parole) e di comprensione del testo letto, il dettato nelle abilità di accuratezza
(numero di errori di scrittura), e l’intelligenza (Q. I.) e di mettere in correlazione i valori standard
di lettura e dettato coi valori standard dell’intelligenza.
I test psicometrici disponibili in lingua italiana capaci di rispondere a queste esigenze sono
due. Il più accurato è il test di Faglioni et al. (1967) che ricorre a un test di lettura di parole con
significato (comprensione), a un test di lettura di parole senza significato (accuratezza), a un test di
dettato e a un test di intelligenza culture free (scala 2, forma A di Cattell). Il test classifica dislessico
il soggetto che ottiene risultati inferiori a quelli ottenuti dal 95% della popolazione scolare della
stessa età e dello stesso livello intellettivo in uno dei due test di lettura e nel test di dettato.
Il test di Elena Boder, adattato in italiano da Chiarenza e Cucci (1989), consta di una prova
di lettura che fornisce un Quoziente di Lettura e di una prova di dettato di parole lette globalmente e
lette sillabate dal soggetto. E’ definito dislessico il soggetto con Q. L. <80 , che scrive con errori più
del 50% delle parole dettate, e che presenta un Q. L. significativamente più basso di quello atteso in
funzione del suo Q. I.. In ogni caso qualora il Q. I. fosse inferiore a 70, si deve porre la diagnosi di
ritardo mentale e non di disturbo specifico di apprendimento. Inoltre lo psicologo attraverso una
anamnesi personale del percorso scolastico del soggetto dovrà verificare che lo stesso sia stato
esposto ad una istruzione scolastica adeguata. Infine il soggetto dovrà essere visitato dal pediatra o
dal neuropsichiatria infantile per escludere difetti di vista, di udito o una malattia neurologica.
B. Il disturbo specifico delle abilità aritmetiche
In questo disturbo il criterio dimensionale previsto dal ICD10 è “un punteggio ad un test
standardizzato per le abilità aritmetiche almeno due deviazioni standard al di sotto del livello atteso
in base all’età cronologica del bambino e al suo livello intellettivo generale”. Le abilità aritmetiche
in realtà possono riferirsi sia alla velocità e alla accuratezza del calcolo matematico sia alla abilità
ad interpretare e risolvere i problemi espressi con parole e frasi e/o con figure geometriche. I test
standardizzati in lingua italiana che misurano tali abilità sono stati elaborati dal gruppo padovano di
Cornoldi (ACMT) .
Anche in questo caso per porre la diagnosi l’istruzione scolastica deve essere stata regolare,
il Q. I. totale deve essere superiore a 70, vista-udito-esame neurologico devono essere normali.
Tab 3 Criteri di inclusione ed esclusione per il disturbo specifico di apprendimento
Criteri di inclusione
Criteri di esclusione
Test specifico di apprendimento per
Lettura e/o Scrittura e/o Calcolo
<2ds rispetto all’età e al livello atteso
in base all’intelligenza del soggetto
Esperienza scolastiche inadeguate
Malattia Neurologica
Ipoacuità Visiva o Uditiva
Ritardo mentale
L’intervento
Uno studio di metanalisi di Bus et al. (1995) ha dimostrato che leggere libri al bambino fin
dai sei mesi di vita migliora le competenze linguistiche in età prescolare e l’apprendimento della
lettura in età scolare. Pertanto, come già notato per i disturbi del linguaggio, programmi di
promozione alla lettura sin dalla più tenera età avviati in diversi paesi, tra cui l’Italia (Causa, 2007),
possono essere considerati strumento di prevenzione anche del disturbo specifico di lettoscrittura.
Secondo le ricerche epidemiologiche di Bianca Zazzo (1986) la mancata frequenza della
scuola materna e le difficoltà di apprendimento sin dalla prima classe elementare sono fattori di
rischio per gli apprendimenti scolastici e per la carriera scolastica successiva.
Schonaut e Satz (1984), prendendo in esame 24 lavori pubblicati in lingua inglese sul follow
up a distanza dei disturbi di apprendimento ne isolano solo 5 come rigorosi e affidabili sul piano
metodologico. Di questi, in 4 l’esito scolare a distanza dei bambini dislessici è sempre sfavorevole.
I lavori controllati che verifichino la validità del trattamento del disturbo di lettoscrittura sono pochi
e insufficienti, quasi assenti quelli che riguardano il disturbo delle abilità aritmetiche.
Tra i lavori pubblicati sul trattamento del disturbo di lettoscrittura, con risultati positivi
documentati, vi è quello di Sartori e La Spisa (1981), che utilizza un metodo in cui il soggetto è
sollecitato continuamente a tradurre il codice visivo in quello uditivo, ma il follow up è breve.
Curci et al. (1992) in una ricerca su 21 bambini dislessici seguiti longitudinalmente dalla 3°
elementare alla 3° media inferiore utilizzano in 4° e 5° elementare il trattamento del gruppo
padovano MT, costituito da un allenamento della capacità di lavoro seriale da sinistra a destra, dalla
percezione globale della parola scritta, dalla capacità di discriminazione uditiva. Di questi 21, a fine
5° elementare i 2/3 sembravano usciti dal criterio diagnostico del disturbo specifico di lettoscrittura,
ma riesaminati tre anni dopo alla fine della terza media inferiore soltanto 1/3 continuava a essere
libero dal disturbo. Nella casistica i soli fattori che sembravano predire l’esito favorevole a distanza
erano l’appartenere al sesso femminile e a genitori con alta scolarità.
L’incertezza della efficacia del trattamento riabilitativo rende non ancora consigliabili
programmi di screening. La stessa incertezza suggerisce l’utilità di ricorrere a strumenti abilitativi e
pedagogici, che permettano al bambino in classe di utilizzare strumenti compensativi e
dispensativi che aggirino le sue difficoltà. Ad esempio, se il bambino ha tempi di lettura lunghi ed
estenuanti, gli va consentito di apprendere la lezione per via soltanto orale direttamente o tramite
audioregistrazione. Se il bambino ha tempi di scrittura lunghi e dispendiosi rispetto agli altri, gli va
consentito di fare composizioni più sintetiche o gli va concesso un tempo di compitazione maggiore
(Luisi e Ruggerini, 1997). L’uso della calcolatrice o del computer rappresentano altri strumenti in
grado di facilitare in diversi ambiti educativi i processi di apprendimento.
Per quanto concerne più specificamente il ruolo dello psicologo, occorre ribadire che le
concezioni della Psicopatologia dello Sviluppo indicano un modello che permette di descrivere il
significato funzionale dei comportamenti del bambino e dei suoi genitori di fronte al pericolo di
fallimento costituito da particolari deficit cognitivi. Si pone come punto fermo l’idea del terapeuta
base-sicura che declina il suo ruolo in sintonia con le caratteristiche particolari del DA del bambino
e con lo stile proprio del funzionamento familiare. A volte lo psicologo può assolvere già
pienamente il suo ruolo esercitando una attenta attività diagnostica e condividendo con bambino e
genitori le basi di evidenza sulle quali si fonda uno specifico programma di Trattamento e di
Abilitazione. Altre volte realizza il suo compito tentando di attenuare e gestire le condizioni
aggiuntive di rischio familiare. Altre volte ancora il terapeuta è chiamato ad utilizzare concezioni e
tecniche pertinenti ad un ben definito setting psicoterapeutico, laddove alla vulnerabilità
neuropsicologica si sommino variabili specifiche di rischio nell’area della regolazione emozionale e
comportamentale (Ruggerini et al., 2004).
Evoluzione in adolescenza e in età adulta
Numerosi sono gli studi (Romano et al., 2008) che documentano come il disturbo specifico
di apprendimento condizioni la carriera scolastica del soggetto e indirettamente le future
opportunità lavorative e le condizioni materiali nella vita adulta creando problemi persistenti. Allo
stesso modo documentano l’alta frequenza di associazione tra dislessia e comportamento antisociale
in adolescenza e età giovane adulta.
Le sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico
La diagnosi
I disturbi generalizzati dello sviluppo sono quadri caratterizzati da anomalie qualitative delle
interazioni sociali e delle modalità di comunicazione, oltre che da un repertorio limitato e
stereotipato di interessi e di attività. Anormalità che rappresentano una caratteristica preminente del
funzionamento dell'individuo in tutte le situazioni di vita. Tra queste sindromi, l'autismo infantile è
certamente una delle più importanti e forse anche una delle più controverse sul piano eziologico,
diagnostico e del trattamento. Nei disturbi generalizzati dello sviluppo possiamo chiaramente
osservare come importanti vincoli biologici drasticamente rendano impossibile l’acquisizione di una
adeguata “teoria della mente” e quindi l’espressione delle relative competenze metacognitive e
comunicative (Baron-Cohen, Leslie, Frith, 1985; Harris, 1989) (v. cap. 8).
Nell’Autismo Tipico Infantile la compromissione qualitativa della interazione sociale
riguarda almeno due aspetti tra i seguenti: a) incapacità di utilizzare lo sguardo, la mimica facciale e
gestuale per regolare l’interazione sociale; b) incapacità di condividere coi coetanei interesi, attività,
emozioni; c) incapacità di reciprocità socioemozionale e di apprendere i comportamenti
sociali;incapacità di condividere anche con persone adulte come i genitori divertimenti ed interessi.
La compromissione qualitativa della comunicazione riguarda almeno uno dei seguenti aspetti: a)
ritardo o mancanza dello sviluppo del linguaggio verbale e assenza del linguaggio gestuale come
modalità alternativa al precedente; b) incapacità di sostenere una conversazione con risposte
reciproche e pertinenti alle comunicazioni di un altro soggetto; c) uso ripetitivo e stereotipato di
parole o frasi fuori contesto; d) assenza del gioco di imitazione e del gioco simbolico. I
comportamenti ripetitivi e stereotipati riguardano almeno uno dei seguenti aspetti: a) adesione
compulsiva a pratiche o rituali; b) manierismi motori ripetitivi e stereotipati riferiti ad esempio alle
mani o a tutto il corpo; c) preoccupazione inusuale per elementi particolari dei materiali di gioco
quali l’odore, il tatto, la vibrazione; d) interessi ripetitivi anomali per contenuto e natura come il
gioco ripetitivo ad esempio con l’acqua o con oggetti circolari.
Per accertare la compromissione delle aree di sviluppo così definite, lo psicologo dovrà
ricorrere sia all’intervista ai genitori sia all’osservazione del comportamento del bambino. Oggi in
questo ambito esistono alcuni strumenti standardizzati tra i quali: l’ADI (Lord et al.1994) per
l’intervista semistrutturata ai genitori e l’ADOS (Lord et al.1989) per l’osservazione
comportamentale del bambino.
L’autismo infantile persiste nel tempo con livelli di severità e di cronicizzazione legati alla
severità delle compromissione della comunicazione verbale e del Quoziente Intellettivo misurato
con un test non verbale come ad esempio il test di Leiter o le matrici progressive di Raven. Molti
bambini con autismo hanno un Quoziente Intellettivo <70. Tuttavia i soggetti con ritardo mentale e
senza autismo si differenziano dai bambini autistici perché sono capaci di instaurare una interazione
sociale sia coi bambini che con gli adulti, anche se possono avere ritardi nella comunicazione
verbale e non verbale e comportamenti stereotipati.
Rispetto all’autismo tipico, l’ICD10:
- descrive forme più lievi e a prognosi migliore: Autismo Atipico (i sintomi insorgono dopo i
tre anni di vita e/o perché non sono mai compromesse tutte e tre le are di sviluppo sopra
descritte), Sindrome di Asperger (non ha un ritardo significativo nello sviluppo del
linguaggio verbale e il Quoziente Intellettivo di solito è superiore a 70);
- e descrive forme più gravi e a prognosi peggiore: Sindrome di Rett (colpisce il sesso
femminile, lo sviluppo appare normale fino a 6-12 mesi con successiva perdita delle abilità
sociali, linguistiche, comunicative e motorie con comparsa di continui movimenti delle
mani), Sindrome Disintegrativa dell’Infanzia (dai due anni di età si assiste ad una perdita
clinicamente significativa delle abilità sociali, comunicative, ludiche, che colpisce anche la
motricità grossolana, la motricità fine, il controllo anale e vescicale e le funzioni cognitive);
Sindrome iperattiva associata a ritardo mentale medio-grave e movimenti stereotipati (il
bambino è capace di interazioni sociali mimiche e gestuali con bambini e con adulti, ma
manca la comunicazione verbale e dominano il quadro clinico l’iperattività e i movimenti
stereotipati).
E’ più probabile che le forme gravi siano secondarie ad una malattia organica del SNC.
Tuttavia in tutte le forme di autismo risulta essenziale il lavoro interdisciplinare di equipe ed è
consigliabile che lo psicologo richieda una consulenza specifica alla ricerca delle malattie che più
spesso possono associarsi ad autismo: sclerosi tuberosa, X fragile, sindrome di Angelmann,
encefalopatie metaboliche, malformative o degenerative. Infine non bisogna dimenticare che il
bambino sordo fin dalla nascita può sviluppare comportamenti autistici, per cui occorre sempre
valutare la acuità uditiva.
Tab 4 Criteri di inclusione per le diverse forme cliniche di sindrome da alterazione globale dello sviluppo psicologico
FORMA CLINICA
CRITERI DI INCLUSIONE
Autismo tipico
Autismo atipico
Sindrome di Asperger
Sindrome iperattiva con movimenti
stereotipati e ritardo mentale
Sindrome disintegrativa dell’infanzia
Sindrome di Rett
Anomalie qualitative di interazione, comunicazione e
attività
Ad esordio prima dei 3 anni di età
Anomalie in una o due delle tre aree sopraelencate
e/o esordio dopo i 3 anni di età
Sviluppo del linguaggio >3° centile
Q. I. >70
Anomalie qualitative di interazione e attività
Q. I. <50
Movimenti stereotipati e iperattività persistenti
Interazione sociale soddisfacente
Sviluppo normale fino ai 2 anni
Perdita delle abilità motorie, sfinteriche, cognitive, di
interazione sociale e comunicazione.
Sesso femminile
Sviluppo normale fino a 6-12 mesi
Perdita delle abilità di manipolazione e di
comunicazione
Segni neurologici (c. cranica e rigidità a. inferiori)
Anomalia genetica MEPC2 (85% dei casi)
L’intervento
Per prevenire l’autismo occorrerebbe conoscerne le cause. Ora, a parte una bassa percentuale
di casi in cui si individua una malattia neurologica o genetica, l’autismo resta ad eziologia ignota. In
questo stato delle cose infatti si parla di sindrome, e non di malattia, ovvero di un quadro
comportamentale che potrebbe avere cause biologiche oggi non note o cause psicosociali. Oggi gli
esperti concordano piuttosto sulla necessità di programmi di screening o di diagnosi precoce
dell’autismo per le seguenti ragioni. In primo luogo è disponibile uno strumento di screening assai
affidabile rappresentato dalla CHAT di Baron-Cohen et al. (1992). In secondo luogo la diagnosi
precoce consente una presa in carico precoce che è capace di migliorare la prognosi naturale del
disturbo. Infine, in caso di figlio autistico, i genitori devono saperlo onde effettuare una rapida
consulenza genetica, dato che la probabilità che i figli successivi abbiano autismo è del 3-7%, ossia
50 volte più alta del resto della popolazione.
La CHAT è uno strumento semplice ed efficace che consta di due parti: un questionario con
9 domande ai genitori e una osservazione diretta del comportamento del bambino da parte dello
psicologo che si basa su 5 item. Le domande e gli item critici per la diagnosi di sospetto autismo
sono quelli relativi all’attenzione condivisa e al gioco simbolico. Il gioco simbolico consiste nel far
finta di giocare con una tazzina a versare del the. L’attenzione condivisa si sonda chiedendo al
bambino dove si trova nella stanza un gioco assai visibile, il bambino deve indicare il gioco e deve
guardare il volto dell’esaminatore per vedere se guarda nella stessa direzione. I bambini autistici
non presentano nessuna delle due attività.
Per quanto riguarda il trattamento vero e proprio i genitori devono sapere che non esistono
cure, tanto meno farmacologiche, che guariscono l’autismo. Il trattamento dell’autismo è finalizzato
ad ottenere miglioramenti nelle aree della comunicazione, dell’interazione sociale, degli interessi
personali e degli schemi d’azione. Alcune procedure sperimentalmente hanno dimostrato di essere
sufficientemente efficaci nel migliorare la prognosi naturale dell’autismo:
- il metodo ABA (Applied Behavior Analysis): un trattamento educativo basato sui principi
della terapia del comportamento, organizzato per almeno 20 ore alla settimana in individuale
o in piccolo gruppo, con il quale si tenta di insegnare al bambino comportamenti sociali,
verbali, cognitivi e motori attraverso l’osservazione sistematica, il rinforzo positivo e
l’incentivo all’apprendimento, passo a passo, di comportamenti specifici.
- il metodo TEACCH (Treatment Education of Autistic and Related Comunication
Handicapped Children) (Shopler, 1991, 1995; Shopler e Mesibov, 1998; Coppa et al.,
1999): apprendimento altamente strutturato ed organizzato che prevede principalmente
compiti visivi e visuomotori. Si tratta di un programma complesso ed articolato, basato sui
principi della individualizzazione e della flessibilità. E’ prevista inoltre una particolare
attenzione alla strutturazione dell’ambiente in termini di “igiene sensoriale”, con un
importante e costante coinvolgimento delle figure genitoriali. Uno degli obiettivi
fondamentali del TEACCH è la comunicazione spontanea, un aspetto tipicamente debole
nei disturbi generalizzati dello sviluppo. I risultati di questo programma sembrano
particolarmente incoraggianti, ma strettamente dipendenti dalle effettive possibilità di
coinvolgimento nel programma di genitori ed educatori. Lo psicologo ha qui il compito di
orientare l’intervento dei genitori e degli insegnanti tenendo conto del livello di sviluppo
raggiunto dal bambino, del suo contesto di vita quotidiano e delle sue propensioni
- CAA (Communication Augmentative e Alternative): promozione della comunicazione con
l’ausilio di strumenti visivi e tecniche comportamentali di rinforzo.
In ogni caso, al di là della tecnica o delle tecniche prescelte, il trattamento dovrebbe
prefiggersi degli obiettivi comportamentali e comunicativi: nei contesti di vita del bambino; che
siano misurabili; che presuppongano un ambiente strutturato e routine; che prevedano tempi con un
educatore adulto in un rapporto 1/1; che siano individualizzati sulla osservazione e sulle
caratteristiche personali del bambino; che privilegino il canali visivo e visuomotorio; che prevedano
una collaborazione continua tra genitori e professionisti. La collaborazione tra professionisti e
genitori è fondamentale per l’educazione a casa, per discutere insieme obiettivi e verifiche del
trattamento, per discutere le terapie controverse o inutili di cui i genitori vengano a conoscenza, per
fornire comunque supporto e disponibilità anche quando i professionisti non condividono a pieno le
scelte fatte dalla famiglia. Il ricorso agli psicofarmaci è utile solo come sintomatico, quando siano
prevalenti i comportamenti aggressivi o autolesivi (neurolettici) o quando siano prevalenti i
comportamenti ritualistici ed ossessivi (serotoninergici) .
Dunque, pur nella consapevolezza dei cospicui deficit innati e quindi dei vincoli biologici
presenti in questi gravi quadri clinici dell’età evolutiva, dovremo porre grande attenzione alle
risorse educative e affettive presenti all’interno del sistema familiare. I bambini con autismo
infantile, pur attivando seppure in modo poco integrato una loro disposizione all’attaccamento,
mettono decisamente in scacco la sensibilità e la responsività materna, sia di fronte ai loro bisogni
evolutivi, sia nella possibilità di utilizzare in modo armonioso i diversi canali di comunicazione. Le
mamme appaiono spesso disorientate di fronte alle atipie comportamentali del bambino e possono
vivere l’isolamento che egli cerca attivamente come rifiuto o comunque come fallimento nella
funzione genitoriale. Nel tentativo di “riparare” a tali limiti, possono mettere in atto comportamenti
intrusivi o scarsamente sensibili che aggravano i cicli interpersonali disfunzionali. Un
atteggiamento non giudicante, di piena e calda condivisione empatica del loro dolore da parte
dell’equipe curante, insieme ad un supporto educativo sensibile e costante, rappresentano dunque il
presupposto fondamentale per l’implementazione di qualunque programma terapeutico.
Evoluzione in adolescenza e in età adulta
Riguardo alla prognosi a distanza in adolescenza e in età giovane-adulta Kanner (1972)
descrivendo l’evoluzione dei 96 pazienti che aveva diagnosticato come autistici durante la sua
carriera psichiatrica, riporta solo 9 casi di soggetti divenuti autosufficienti da adulti e individuava
come principale fattore prognostico favorevole la presenza di un linguaggio comunicativo entro i
primi 5 anni di vita. Rees e Taylor (1975), Etemad e Szurek (1973), Eggers (1978) concordano che
il più potente fattore correlato ad un esito terapeutico positivo è l’elevato quoziente intellettivo: ad
un Q.I.>60-70 fanno riscontro esiti a distanza rispetto all’autonomia sociale migliori rispetto ai
soggetto con Q.I. più basso. Ciotti et al.(2002) in un follow-up di 17 soggetti autistici fino all’età di
20-30 anni concludono che l’evoluzione dei soggetti a distanza rispetto in particolare ad autonomia
sociale, lavorativa e familiare è correlata positivamente ad un quadro clinico iniziale meno grave,
alla precocità e alla continuità di un trattamento terapeutico a lungo termine da parte di un
professionista competente e non è correlato al trattamento farmacologico. Secondo Koegel, Koegel
et al. (2006) i 2/3 di questi pazienti in età adulta non riescono a raggiungere una sufficiente
autonomia e richiedono pertanto un’assistenza continuativa. Anche per questi autori elementi
predittivi per una evoluzione positiva sono la presenza del linguaggio comunicativo dopo i 5 anni e
capacità cognitive più elevate. I pazienti con più elevato funzionamento possono progressivamente
migliorare le loro competenze cognitive e comunicative, ma restano generalmente più evidenti le
difficoltà nell’interazione sociale.
ASSE III - RITARDO MENTALE
La diagnosi
Il bambino con ritardo mentale è un bambino con bisogni speciali, che va riconosciuto,
valutato e trattato per migliorare il suo adattamento sociale e lavorativo in età giovanile ed adulta. A
tuttoggi i dati in nostro possesso, sia internazionali che italiani, mostrano infatti che vi è un mancato
risconoscimento dei soggetti con insufficiente capacità cognitiva, che dovrebbe interessare il 3%
della popolazione infantile, mentre la diagnosi effettiva riguarda a seconda delle casistiche il 1 o 2
% della popolazione. Il soggetto con ritardo mentale non riconosciuto è esposto a rischi evolutivi di
diversa natura. Può in primo luogo essere portatore di una malattia biologica del SNC che può
comportare danni organici e rischio genetico. In secondo luogo, qualora le aspettative familiari e
sociali non siano appropriate rispetto al livello intellettivo del soggetto, ma siano irrealisticamente
elevate e non prevedano livelli di apprendimento domestici e scolastici adeguati, ne possono
derivare per il soggetto disturbi emozionali o francamente psichiatrici.
La diagnosi di ritardo mentale è definita dal livello del Quoziente Intellettivo, misurato con
una scala psicometria standardizzata sulla popolazione di appartenenza del soggetto. In altre parole,
come per definire iposomico un soggetto dobbiamo misurarlo e osservare se si trova sotto il terzo
centile nelle curve di crescita della popolazione di appartenenza, così per definire ritardato mentale
un soggetto dobbiamo misurare la sua capacità cognitiva e osservare se si trova sotto il terzo centile
per gli standard cognitivi normativi della popolazione di appartenenza.
Le scale psicometriche Wechsler, standardizzate anche sulla popolazione italiana,
rispondono esattamente a questa esigenza. Esistono le scale normative Wechsler per l’età prescolare
(Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, WPPSI per i 4-6, 6 anni), le scale
Wechsler per l’età evolutiva (Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC per i 6-16 anni) e le
scale per l’età giovane-adulta (Wechsler Adult Intelligence Scale, WAIS). Se alla scala un soggetto
riporta un Q. I. =100, significa che rispetto alla popolazione di pari età egli si trova al 50° centile,
ossia esattamente nella media. Se riporta un Q. I. =85 si trova nella -1 DS, ossia intorno al 16°
centile. Se invece riporta un Q. I. =70, si trova nella -2DS, ossia intorno al 3° centile. Coloro che
riportano un Q. I. <70 hanno un ritardo mentale, e precisamente:
Ritardo mentale lieve
Q. I. 50-69
Ritardo mentale medio
Q. I. 35-49
Ritardo mentale grave
Q. I. 20-34
Ritardo mentale profondo Q. I. <20
Nella tab. 5 riportiamo a titolo esemplificativo il foglio di risultato alla scala WISC di un
bambino di 10 anni e 7 mesi con un ritardo mentale lieve (Q. I. Totale=55). Ciò che fa testo come
risultato finale nel foglio è il Q. I. totale e non il Q. I. parziale verbale e il Q. I. parziale
performance, che lo compongono.
Tab. 5
Foglio di risultato WISC di C. A. ,
10 anni e 7 mesi
TEST VERBALI
Informazione
Somiglianze
Aritmetica
Vocabolario
Memoria di cifre
Punteggio verbale totale
TEST PERFORMANCE
Completamento figure
Storie figurate
Disegno con cubi
Ricostruzione oggetti
Cifrario
Punteggio performance totale
Q. I. verbale
Q. I. performance
Q. I. totale
Punteggio grezzo
Punteggio ponderato
9
9
0
7
6
31
5
6
1
1
4
17
8
0
6
14
10
38
3
1
3
6
6
19
59
60
55
La definizione di ritardo mentale comporta, oltre a una ridotta prestazione cognitiva, anche
una diminuita competenza sociale, che è sia diretta conseguenza del grado del ritardo mentale sia
influenzata dall’ambiente sociale e culturale di crescita. Di solito il soggetto con ritardo mentale
lieve in età giovane-adulta raggiunge il pensiero operatorio concreto di Piaget, impara a leggere e a
scrivere, sa usare la calcolatrice, il telefono, l’orologio, e in ambito sociale sa adoperare i servizi
pubblici, acquisisce una buona autonomia nelle routine quotidiane e sul lavoro. Il soggetto con
ritardo mentale medio raggiunge il pensiero rappresentativo di Piaget, sa parlare e comunicare, è
autonomo nella igiene personale e nel pasto, può essere inserito in un lavoro protetto. Il soggetto
con ritardo mentale grave si ferma al pensiero sensomotorio di Piaget, non sa parlare, può ricorrere
alla comunicazione aumentativa alternativa non verbale, può vivere in comunità protetta con
supervisione e supporto continuativi.
Visti i criteri precedenti ne deriva che la diagnosi di ritardo mentale con le scale
psicometriche di Wechsler può essere posta solo dopo i 4 anni di età. Sotto i 4 anni non abbiamo
scale psicometriche affidabili per misurare le abilità cognitive, ma solo scale di sviluppo
psicomotorio come le scale di Brunet-Lèzine o di Griffiths che forniscono un Quoziente di
Sviluppo Psicomotorio (Q. D.), non sempre correlabile al Q. I. successivo ai 4 anni di età.
In caso di ritardo mentale riconosciuto con Q. I. <55, ci si dovrà poi occupare della
eventuale eziopatogenesi organica del ritardo. Infatti, mentre nei casi di Q. I. di 55-69 le cause
biologiche sono rintracciabili in un basso numero di casi, nei casi di Q. I. <55 il ritardo mentale
rivela una causa biologica nell’80% dei casi. Le cause più frequenti sono le anomalie
cromosomiche e genetiche, seguite dalle malattie cerebrali e neurodegenerative, infezioni e ipossie
pre, peri e postnatali completano il quadro (tab. 6). Nel caso del ritardo mentale medio-grave
l’indagine eziologica è d’obbligo e prevede alcune valutazioni da effettuare sempre: Anamnesi
familiare e personale; Esame obiettivo e neurologico; Potenziali visivi ed uditivi; Cariotipo e ricerca
X fragile, e altre da eseguire selettivamente in base ai segni neurologici e ai dimorfismi rilevati.
Tab. 6 Le cause del ritardo mentale medio-grave
ESEMPI
Trisomie 21, 18, 13, Klinefelter
Xfragile, Prader-Willi
Idrocefalo/meningomielocele
Lissencefalia
Infezioni congenite
HIV, Toxoplasmosi, Rosolia, Herpes
simplex, Citomegalovirus
Errori
metabolici/m. Tay-Sachs
neurodegenerative
Fenilchetonuria
Cause perinatali
Meningite,
Sindrome
fetoalcolica,
CAUSE
Cromosomopatie
S. genetiche
Anomalie cerebrali
%
22
21
9
4
8
4
Cause postnatali
Sconosciuta
Ritardo mentale familiare
Totale
Sindrome anossico-emorragica neonatale
Traumi, meningite, ipotiroidismo
Paralisi cerebrale infantile
Ambientale, ereditario
5
21
6
100
L’intervento
Completata la valutazione diagnostica del ritardo mentale, lo psicologo potrà proficuamente
partecipare alla presa in carico terapeutica multidisciplinare. Da un lato sarà necessario verificare
che sia effettuato il monitoraggio evolutivo periodico con valutazione almeno annuale delle
prestazioni cognitive (Q. I.) e dell’adattamento sociale (Scala di Maturità Sociale di
Vineland,1984). Dall’altro potrà contribuire al piano educativo individualizzato, che ogni 6-12
mesi fissa gli obiettivi psicoeducativi da raggiungere. Il piano è definito dalla famiglia insieme al
team interdisciplinare composto solitamente da: pediatra, psicologo o neuropsichiatria infantile,
assistente sociale, insegnanti. Il piano determina chi fa che cosa e chi è il referente del piano per la
famiglia. Nel determinare gli obiettivi da perseguire la scala di Vineland può costituire una traccia
di riferimento utile, poiché fissa nei vari ambiti sociali le tappe evolutive in successione di difficoltà
crescente. A seconda dei contesti organizzativi lo psicologo potrà costituirsi come referente del
piano; essere incaricato del counselling ai genitori (Parent Training individuale o di gruppo).
Un compito di grande rilievo ma anche denso di difficoltà (che vale per tutte le forme di
disabilità che abbiamo considerato) sta nella iniziale comunicazione della diagnosi, quel momento
di grande intensità emotiva e profonda sofferenza in cui il genitore viene a conoscenza della
condizione del proprio figlio (tetraparesi spastica, sindrome di Down, autismo infantile, deficit
uditivo, ecc): un momento che rappresenta inevitabilmente una sorta di “lutto” rispetto alle
rappresentazioni interne e alle aspettative che il genitore stesso aveva maturato riguardo al proprio
figlio e al proprio ruolo genitoriale. Una brusca rottura di tali attese con la sollecitazione di forti
sentimenti di dolore, di rabbia, di allarme. Il lavoro clinico in tale contesto dovrà muoversi
armonicamente su due livelli: da un lato l’accoglienza, la condivisione empatica, il contenimento e
l’elaborazione delle emozioni in gioco; dall’altro un adeguato supporto sul piano della
comprensione della condizione del figlio, offrendo chiare informazioni sulla diagnosi, sulle sue
cause e sugli aspetti prognostici futuri. Per lo psicologo, rappresentare adeguatamente questo ruolo
ed essere in grado di attraversare insieme ai familiari il loro dolore, costituisce spesso l’elemento
cruciale nel costituirsi con loro di una positiva alleanza terapeutica, una solida relazione entro la
quale poi affrontare le tante sfide che l’itinerario di sviluppo di un bambino con bisogni speciali
comporta (visite, interventi, problemi di integrazione sociale, difficile adesione alle regole
educative, inserimento e passaggio ai vari livelli scolastici, l’accettazione del sostegno scolastico, i
vissuti di diversità, la difficile gestione degli affetti e della sessualità in adolescenza, ecc).
Evoluzione in adolescenza e in età adulta
Per quanto riguarda la prognosi a distanza del ritardo mentale, genitori e professionisti non
considerano a sufficienza il fatto che la prognosi a distanza dei soggetti con ritardo è influenzata più
dal Quoziente di adattamento sociale (scala Vineland) che dal Quoziente intellettivo. In altre parole
i fattori educativi, mentre modificano scarsamente le abilità intrinseche del soggetto di tipo logico,
verbale o matematico, sono capaci invece di determinare, al di là del Q.I., abilità pratiche, manuali,
motorie che possono rendere il soggetto del tutto indipendente nelle attività della vita quotidiana e
di un lavoro procedurale e meccanico, oppure al contrario del tutto dipendente dal contesto
familiare e ambientale in cui vive.
Sul piano educativo familiare e scolastico preadolescenza, adolescenza e uscita dalla scuola
dell’obbligo sembrano momenti critici in cui si decide il futuro dei soggetti. In uno studio
trasversale di Q.I. e Quoziente di Vineland in tre popolazioni di soggetti Down (età prescolare, età
scolare, adolescenza), mentre in età prescolare e scolare il Q.Vineland risulta più alto del Q.I., con
valori assai omogenei tra i bambini, in adolescenza il Q.Vineland si differenzia significativamente
da un soggetto all’altro e la sua evoluzione positiva o negativa sembra legata alla “positività” o
“negatività” della famiglia di provenienza e alla positività o negatività dell’inserimento lavorativo
(Ciotti, 2002). Ad esempio una famiglia con stile relazionale iperprotettivo che si sostituisce al
ragazzo nei compiti e nelle decisioni quotidiane tende a deresponsabilizzarlo, a evitargli esperienze
all’esterno anche lavorative, a isolarlo in casa rendendolo passivo e dipendente con una bassa
qualità della vita. E’ questa l’area in cui un intervento psicologico sensibile e mirato può mobilitare
nei familiari risorse educative, affettive e relazionali atte a promuovere più soddifacenti livelli di
adattamento personale e sociale.