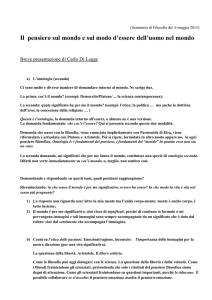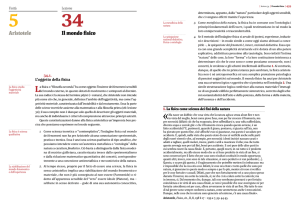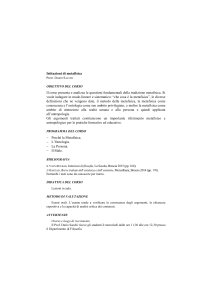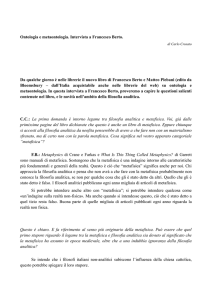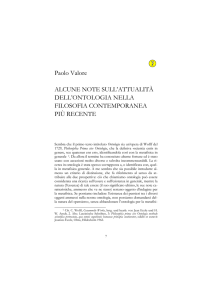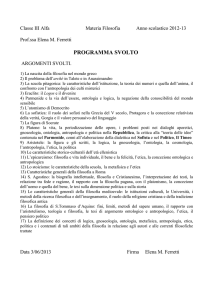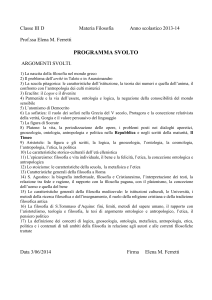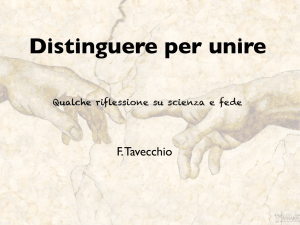storie dell’ontologia
Tiziana Andina, Carola Barbero
INTRODUZIONE.
STORIE DELL’ONTOLOGIA
Che cosa studia l’ontologia? L’ontologia studia tutto quello che c’è (spesso
anche quello che non c’è, ma ci potrebbe essere e a volte addirittura quello che
non c’è e non ci potrebbe essere perché contraddittorio). Tutto quello che c’è in
filosofia ha più volte – dall’antichità fino quasi ai giorni nostri – preso il nome di
«essere». La scienza che si occupa dell’essere in quanto tale (quindi non, ad
esempio, dell’essere in quanto essere in movimento, altrimenti si tratterebbe
della fisica, né dell’essere in quanto essere quantitativo, se no sarebbe il caso
della matematica, né dell’essere in quanto qualsiasi altra cosa che non sé medesimo) è una scienza specifica, che dal XVII sec. prende il nome di ontologia1
appunto, ma che, prima di allora, si chiamava metafisica. Il primo filosofo che
ha cercato di individuare un settore specifico per lo studio dell’essere in quanto
tale, cioè dell’essere con i suoi princìpi, le sue modalità di esistenza e le sue
proprietà, è stato, come noto, Aristotele che, nel quarto libro della Metafisica,
esprime proprio l’esigenza di una scienza teoretica che si occupi dell’essere nella sua generalità (che prenda quindi in considerazione «l’essere in quanto tale»)
e multivocità (perché «l’essere si dice in molto modi»). Aristotele – come vedremo meglio più avanti – ha battezzato questa scienza «filosofia prima» o «metafisica»: si tratta di una scienza che ha per oggetto la sostanza (l’essere in quanto
tale appunto), i suoi attributi e le sue relazioni metafisiche (per esempio, il rapporto tra uno e molti, tra la potenza e l’atto e così via).
È dunque evidente che fin dall’antichità i filosofi si sono posti la domanda
sull’essere, tanto da spingersi fino a fondare una vera e propria scienza che se ne
occupasse. Quello che però non è evidente sono le ragioni di tanta impellenza;
e cioè: perché l’essere fa problema? E soprattutto: perché l’essere continua ad
essere un problema?
1 Il termine «ontologia» viene utilizzato per la prima volta nel 1613, rispettivamente nelle opere di Göckel (o
Goclenius) e di Lorhard. Il primo vero e proprio saggio di ontologia (o meglio, di «ontosofia») è tuttavia opera
di Clauberg che nel 1647 pubblicò, appunto, una Metafisica dell’ente, che più correttamente si chiama ontosofia.
Rivista di estetica, n.s., 22 (1 / 2003), XLIII, pp. 3-13 © Rosenberg & Sellier
3
Si tratta di domande che probabilmente ricorderanno al lettore l’impostazione
heideggeriana. Come si legge infatti nell’esergo a Essere e tempo: «Abbiamo noi
oggi una risposta alla domanda intorno a ciò che propriamente intendiamo con
la parola “essente”? Per nulla. È dunque necessario riproporre il problema del
senso dell’essere. Ma siamo almeno in uno stato di perplessità per il fatto di non
comprendere l’espressione “essere”? Per nulla. È dunque necessario cominciare col ridestare la comprensione del senso di questo problema»2. Già a questa
altezza possiamo comunque puntualizzare che Heidegger non si pone esattamente le nostre stesse domande; infatti ciò che lui intende fare è riproporre la
domanda sul senso dell’essere o, meglio, sostituire il problema dell’essere con
quello del senso dell’essere. Si tratta di una mossa importante e ricca di conseguenze: Heidegger, in sostanza, relativizza ampiamente le questioni ontologiche
ad un soggetto (l’Esserci) conoscente per il quale, appunto, si può parlare di
senso dell’essere (qualcosa ha senso solo e sempre per qualcuno, mai di per sé).
L’ontologia, dunque, racconta molte storie (quelle dei molteplici modi in cui
si è tentato di dire o spiegare l’essere) e la sua storia può essere raccontata in
molti modi. Le storie dell’ontologia che verranno qui presentate sono storie della scienza dell’essere in quanto tale e intendono privilegiare la narrazione di
una storia: la storia della scienza dell’essere in quanto tale.
Le vicissitudini di questa scienza tanto antica, quanto interessante, mostrano
come lo studio dell’essere si sia potuto realizzare non tanto come studio dell’essere in quanto tale come l’ambizioso progetto aristotelico potrebbe far pensare,
bensì attraverso l’analisi di una serie di argomenti che, se da un lato possono
aiutare a chiarire il concetto stesso di essere, dall’altro necessitano essi stessi di
un approccio ontologico per stabilire, in prima battuta, lo statuto degli oggetti
del loro dominio. Cerchiamo di spiegarci meglio.
Che cosa vuol dire studiare «l’essere in quanto essere»? Innanzitutto, che
cosa si intende per «essere»? L’ essere di cui si è occupata la metafisica prima e
l’ontologia poi, è un nome astratto, che non ha plurale (infatti studiare gli esseri
sarebbe già fare un’altra cosa) e che comprende in realtà due problemi che, se
pur correlati, vanno tenuti distinti: un problema è infatti quello concernente il
significato predicativo di «essere», come quando «essere» compare con funzione
di copula, ad esempio in «Pegaso è un cavallo alato»; altro problema è quello
riguardante il significato esistenziale di «essere», come per esempio nella frase
«Pegaso è». Si potrebbe pensare che il significato predicativo sia in qualche modo
inglobato in quello esistenziale: per «essere un cavallo alato», si potrebbe argomentare, occorre per prima cosa «essere». In realtà la questione non è così semplice perché, se sostenessimo questa posizione, ci accorgeremmo che il problema da cui siamo partiti si riproporrebbe nuovamente in un regresso che continua
all’infinito dato che, di nuovo, ci chiederemmo: ma se per «essere un cavallo
alato», Pegaso deve innanzitutto «essere», che cosa vuol dire che «Pegaso è»?
Che cosa vuol dire «essere»? Si può «essere» senza «essere qualche cosa»? E poi,
che differenza c’è tra dire che «Pegaso è» e dire che «Pippo Baudo è»?
2 M. Heidegger, Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1927; trad. it. di P. Chiodi, Essere e tempo,
Longanesi, Milano 1995, p. 14.
4
È evidente che se si vuole tentare di dirimere, o anche solo affrontare la questione senza tema di cadere in regressi senza fine, occorre porsi delle domande
differenti, più specifiche. Ad esempio, per quanto concerne Pegaso, e ammesso
che se ne voglia trattare, ci potremmo chiedere che differenza c’è tra «essere» e
«esistere», se siano la stessa cosa oppure no. Altrimenti, lasciando perdere Pegaso
e prendendo in considerazione la totalità degli oggetti, ci potremmo domandare
in che modo si può definire la complessità e quanti tipi di complessità esistono
(ad esempio, le quattro noci sul tavolo e il quadrato formato dalle quattro noci
che sono sul tavolo, sono la stessa cosa?); o in che cosa consiste la diversità
contrapposta all’unità numerica e che cos’è invece la diversità contrapposta all’uguaglianza qualitativa; o che cos’è una relazione (esterna o interna che la si
voglia considerare); oppure, ancora, che cosa caratterizza la durata e,
correlativamente, il mutamento nel tempo (fino a quando una cosa rimane la
stessa e quando invece cambia diventando qualcos’altro: basti pensare alla nave
di Teseo); o che cosa sono le proprietà, che cosa sono – se sono qualcosa – gli
universali.
Tutte queste domande (peraltro ce ne sarebbero molte altre ancora) sono ciò
di cui si occupa l’ontologia: esse ci permettono di avvicinarci alla generalissima
questione dell’essere avendo già in mente cosa cercare, cosa esaminare e cosa
tentare di concettualizzare. Solo così si può sperare di dare una qualche delucidazione del problema dell’essere: grazie cioè agli argomenti (o ai settori, se si
preferisce) che lo definiscono. L’idea aristotelica secondo cui «l’essere si dice in
molti modi» non era poi così diversa da questa.
Le risposte che nel corso dei secoli sono state date a queste domande rappresentano ciò che propriamente costituisce una «storia dell’ontologia». Questa storia
è fatta di molte storie, ognuna delle quali ha cercato di rispondere al problema
dell’essere, della sua vaghezza concettuale, della sua difficoltà di definizione,
per darne ora una descrizione, ora una definizione, ora, più semplicemente,
una problematizzazione.
Da un lato, dunque, le questioni e i temi che formano il complesso problematico e tematico dell’ontologia hanno una lunga tradizione storica, dall’altro –
e ci preme sottolineare questo elemento sin da ora – continuano ad essere al
centro della ricerca (teorica e formalizzante) della filosofia e, più in generale,
delle ricerche applicative (pensiamo all’informatica o alla giurisprudenza) contemporanee. Certamente, perché tutto questo sia possibile è concretamente necessario che la ricerca filosofica, oltre a interessarsi di questioni extradisciplinari
e trasversali, riesca a far convergere le proprie prospettive di ricerca su nuclei
problematici forti, a prescindere da prospettive di ricerca particolari e tipiche
delle diverse scuole.
Più sopra si è detto che l’ontologia prende, ad un certo punto della storia, il
posto precedentemente occupato dalla metafisica. Questa annotazione è certamente vera, ma è necessaria ancora una precisazione. Nella filosofia moderna
l’ontologia si caratterizza come un settore specifico della metafisica: se da un
lato la metafisica si occupa, secondo la definizione corrente, della natura ultima
di tutto ciò che esiste, e se attiene ancora alla metafisica il compito dell’indagine
preliminarissima che stabilisce i criteri metodologici della ricerca; dall’altro lato,
all’ontologia spetta sia la messa a punto formale di questi criteri (nonché la loro
5
discussione teorica), sia la loro ricontestualizzazione storiografica e, ove possibile, la loro iscrizione all’interno di panorami teorico-filosofici il più possibile
consapevoli delle ragioni che li hanno determinati.
La domanda sull’essere, come si diceva, è antica3 ed è stata posta almeno a
partire dalle ricerche di Parmenide che, nel fr. 6 del Poema sulla natura, parlando dei «mortali bicefali», discute se l’«essere e il non essere sono identici e non
sono identici». Il cuore della dottrina parmenidea, che costituisce per altro anche la parte meglio documentata e più celebre del poema, è certamente il frammento B 8, preceduta dall’esame preliminare delle vie o modi possibili della
ricerca che si aprono al filosofo. Le vie di ricerca che si possono pensare formano
un incrocio, spesso variamente interpretato, in cui l’elemento nevralgico è costituito dalla voce esti («è»): a) la via del puro essere («che è e non può non essere»); b) la via del puro non essere («che non è e che non è necessario che non
sia»); c) la via del puro divenire (in cui «l’essere e il non essere sono ritenuti
identici e non identici» fr. B 6, 8-9).
Quale che sia l’interpretazione migliore, la via che ricerca la verità resta quella del «che è». L’ostacolo interpretativo, a questa altezza, è rappresentato proprio dalla voce è e dal suo significato in Parmenide. In particolare, l’ esti
parmenideo è interpretabile in greco almeno in tre direzioni: copulativa (è qualcosa), esistenziale (esiste) o veridica (è vero). Si pone perciò il problema di quale possa essere il soggetto della voce «è», che in Parmenide rimane anonima.
L’ontologia parmenidea, riportata nel frammento B 8 e conservata da Simplicio,
ha la struttura di una argomentazione concisa condotta in forma deduttiva. Il
frammento inizia elencando le proprietà fondamentali dell’ente: ingenerato e
indistruttibile, intero, di un solo genere, immobile e così via. L’ente di Parmenide,
il solo che può essere oggetto di ricerca, è dunque ingenerato e indistruttibile; è
un intero continuo nello spazio e nel tempo, inalterabile e immobile, la cui durata si comprime in un puro presente escludendo passato e futuro, e la cui forma
compiuta è simile alla massa di una «sfera ben rotonda».
Com’è noto, Platone affronta il problema parmenideo nel dialogo omonimo.
La questione che crea maggiori problemi a Platone è che le cose che compongono la nostra esperienza sensibile, e che conservano lo stesso nome delle idee,
sono ciò che sono grazie al loro rapporto di relazione reciproca e non grazie alla
relazione con l’idea corrispondente (per esempio: un figlio è tale rispetto a una
donna concreta che è sua madre, non in rapporto all’idea di madre). Ne deriva
una separazione concreta tra il mondo sensibile e quello delle idee; in buona
sostanza, dunque, l’assoluta separazione del mondo delle idee dalla realtà concreta finirebbe per renderle perfettamente inutili.
Per uscire da questa aporia, nel Parmenide, Platone affronta il problema del
rapporto fra uno e molti, fra l’essere e il non essere, sostenendo che dell’essere,
così come è concepito dagli eleati, non è lecito predicare alcunché, neppure che
è uno. Ma è nel Sofista che Platone enuncia la propria posizione: il non-essere
non si contrappone all’essere come sua negazione assoluta, piuttosto è da intendersi come diverso, dunque una sua negazione relativa che conserva – e si tratta
3 Per una lettura più articolata e completa della storia dell’ontologia si rimanda a M. Ferraris, Ontologia,
Guida, Napoli 2003.
6
dell’elemento importante – una realtà al pari dell’essere (XLII 257c-258c). Sempre nel Sofista Platone individua cinque generi sommi: oltre a essere, moto e
quiete (ciascuno identico a sé e diverso dagli altri), identico e diverso (XL 254b255e). Quando infatti di una idea o di una cosa si dice che essa è, non si intende
che la cosa in questione si identifica con l’idea dell’essere, ma solo che in qualche modo ne partecipa, al pari di tutte le altre cose o idee di cui si dice che sono.
Analogamente avviene tutte le volte che attribuiamo dei predicati.
All’interno di questo dibattito articolato e complesso, il primo ad aver pensato ad una disciplina specifica concernente l’essere e i suoi princìpi è stato, come
si è detto, Aristotele che separa la filosofia prima (che si occupa dell’essere in
quanto essere e delle sue proprietà) dalle scienze particolari (che si occupano
invece di indagare aspetti settoriali della realtà). Il sapere, per Aristotele, è composto dalla conoscenza delle cause e dei princìpi; in questo senso la forma di
sapere suprema è quella che sa in qualche modo tutte le cose, poiché possiede le
cause e i princìpi da cui tutto dipende. Nel libro VI della Metafisica, le scienze
vengono suddivise in teoretiche, pratiche e poetiche; tra le scienze teoretiche la
matematica studia i princìpi dell’essere inteso come quantità, la fisica l’essere in
quanto divenire, mentre la filosofia prima studia l’essere in quanto tale. Secondo la prospettiva aristotelica in tutti gli esseri è presente una struttura di base che
resiste al mutamento e costituisce il loro essere proprio; questa struttura risulta
chiaramente visibile là dove si unisce al movimento. Da queste premesse
Aristotele fa derivare la sua filosofia prima o teologia, orientando l’indagine
metafisica verso due direzioni preferenziali: quella che si occupa dell’essere in
generale e quella che invece si occupa precipuamente della sostanza divina.
L’importante alternativa indicata da Aristotele viene raccolta ed elaborata rispettivamente da Avicenna e da Averroè: il primo si occupa dell’ente in quanto
ente, mentre il secondo si dedica soprattutto allo studio di Dio e delle intelligenze separate. Tuttavia – se rimaniamo alla metafisica – sarà l’impostazione di
Avicenna a prevalere: Avicenna modificò infatti significativamente (Libro di
scienza) l’ordine delle scienze, conferendo priorità, in una ipotetica gerarchia,
alla logica e alla metafisica. In questo senso, la realtà finisce per essere il risultato di un processo emanativo che parte da Dio e comprende le sottostanti intelligenze celesti, secondo una rigida concatenazione causale.
In un tale quadro, la metafisica si occupa dell’ente in quanto tale (cioè di ciò
che tutti gli enti hanno in comune), e poi, all’interno di questa indagine, si
preoccupa di isolare degli oggetti determinati (per esempio, Dio, l’anima e il
mondo). Qui viene per la prima volta esplicitata quella distinzione che porterà,
soprattutto in ambito medievale, ad ascrivere l’essere in generale (la sostanza) a
specifico oggetto di indagine di pertinenza della metafisica (filosofia prima);
mentre la distinzione tra materiale e immateriale (parte, questa, che comprende
la riflessione su Dio e le sostanze separate) diventa se non secondaria certamente successiva – in questa direzione vanno, con le differenti declinazioni che qui
non possiamo certamente dettagliare, sia le riflessioni di Tommaso d’Aquino sia
quelle di Giovanni Duns Scoto. In particolare Scoto, nel Periphyseon, divide la
natura in quattro ambiti distinti: la natura che non è creata e che crea (Dio), la
natura che è creata e che crea (le idee platoniche), la natura che è creata e non
crea (le cose sensibili), la natura che non è creata e che non crea (Dio come fine
7
ultimo di tutte le cose). Per un discorso che ha di mira l’ontologia e la sua storia
è importante notare che, nella versione di Scoto, esiste una scienza dell’essere
che precede la teologia.
È in questo quadro che si colloca un lavoro fondamentale per la nascita di un
discorso ontologico: siamo alla fine del Cinquecento, e ci riferiamo allo scritto
del gesuita Francisco Suárez. Le sue Disputationes metaphysicae, rappresentano non solo un’opera di grande erudizione che compendia l’intera tradizione
antico-medievale, ma presto diventano anche il manuale filosofico di riferimento, e continuano ad esserlo per almeno due secoli, esercitando un’influenza determinante sulla costituzione dell’ontologia moderna. In Suárez la catalogazione dell’ente in quanto ente corrisponde, in pratica, all’ente reale (ente dotato di
essenza) che deve essere trattato dalla metafisica generale. Esso comprende le
cose sensibili, ma anche Dio, l’anima e le sostanze separate, mentre esclude gli
enti di ragione.
Nel 1613, nei lavori di Rudolph Göckel (Rodolphus Goclenius), segnatamente
il Lessico filosofico, e di Jacob Lorhard, Teatro filosofico, compare per la prima
volta il termine «ontologia». Siamo in un’epoca in cui la speculazione aristotelica
non è più sufficiente, e si fa sempre più pressante l’esigenza di una logica riformata che serva, oltre che per la discussione delle questioni degli antichi, anche
a dare un ulteriore impulso alle ricerche delle nuove scienze; mentre – almeno a
partire dalla riflessione di Cartesio – l’ordine aristotelico tra mondo esterno e
mondo interno viene sovvertito, diventando quest’ultimo (il cogito), la realtà
più certa di cui l’uomo può disporre. A grandissime linee, abbiamo pertanto
una critica serrata all’impianto aristotelico che si struttura come un passaggio
graduale, ma radicale verso lo studio e la definizione dei trascendentali del soggetto. Una ontologia dunque che si sovrappone, come avverrà soprattutto con
Kant, sempre più chiaramente all’epistemologia.
Nel 1647 Johannes Clauberg pubblica un saggio dal titolo: Metafisica dell’ente, che più correttamente si chiama ontosofia; si tratta del primo lavoro esplicitamente dedicato all’approfondimento di questioni ontologiche. Va notato che
il passaggio dalle riflessioni di Clauberg a quelle di Wolff e Baumgarten, autori
di scuola leibniziana, è scandito da una progressiva differenziazione di quella
che abbiamo visto essere la domanda classica della metafisica: «che cosa c’è?».
Se infatti, per Clauberg, c’è tutto quello che può essere detto e pensato, per
Wolff esiste solo ciò che non è contraddittorio.
In altre parole, l’originalità di Wolff consiste nell’aver sottolineato l’esigenza
di un metodo di indagine razionale: ogni scienza rigorosa ha il compito di richiamarsi al principio di non contraddizione, e per fare ciò deve servirsi dell’analisi o della deduzione in quanto fondamenti di ogni possibile. Da qui deriva la distinzione di un duplice tipo di conoscenza: la prima si costituisce appunto
in base al principio di non contraddizione attraverso l’analisi o la deduzione (si
tratta della conoscenza superiore articolata dalla metafisica e comprendente
l’ontologia che tratta delle determinazioni più generali degli enti); la seconda si
occupa invece, deduttivamente o sperimentalmente, dei rapporti tra idee e fatti
storici (si tratta della conoscenza scientifica o inferiore).
Analogamente, Baumgarten (Metafisica) – compendiatore del sistema
wolffiano – definisce la metafisica come la scienza di ciò che può essere cono8
sciuto senza l’ausilio della fede (buona la distinzione tra metafisica generale e
metafisica speciale, comprendendo, quest’ultima, cosmologia, psicologia e teologia naturale). Dalla metafisica discendono tutti i saperi concernenti l’uomo
(etica, filosofia del diritto, filosofia del linguaggio e così via); ad essa Baumgarten
prepone la teoria della conoscenza che definisce, per primo, gnoseologia e che
suddivide in due parti: la teoria della conoscenza sensibile (estetica) che si occupa appunto della conoscenza sensibile e della teoria del bello e delle arti liberali,
e la logica che riguarda invece la conoscenza intellettuale. L’impianto è ancora
quello tradizionale dell’enciclopedia wolffiana, con una particolare attenzione
per la psicologia che, di fatto, finisce per fondare la logica e la metafisica, sancendo il passaggio dalla logica alla psicologia.
Si tratta certamente di uno dei momenti fondamentali nella storia dell’ontologia moderna che culmina, per altro, nel profondo ripensamento kantiano delle funzioni e delle possibilità conoscitive della logica e dell’esperienza sensibile.
In estrema sintesi il problema di Kant è quello di portare la metafisica agli stessi
livelli conoscitivi della matematica: dato che i risultati prodotti dalla metafisica
erano imbarazzanti se confrontati con quelli della matematica, Kant si propone
di verificare la possibilità che la metafisica sia in grado di produrre conoscenze
ad un tempo sintetiche (vale a dire accrescitive) e apriori (e cioè sottratte alla
mutevolezza delle acquisizioni dell’esperienza). Ne esce, come è noto, una filosofia trascendentale che costruisce l’esperienza attraverso le forme a priori che
la rendono possibile: spazio, tempo e categorie. Se risolviamo tutto questo in
una dimensione ontologica, avremo che in una prospettiva come quella kantiana
e post-kantiana (per intenderci le posizioni di Friedrich Albert Lange prima e di
Nietzsche poi), l’esperienza dipende direttamente dalla costruzione che ne dà il
soggetto attraverso gli apriori della sensibilità e dell’intelletto e, nel caso specifico dei neokantiani, anche dalla conformazione fisiologica degli organi di senso
degli esseri umani.
È proprio nell’ambito della radicalizzazione neokantiana che emerge bene la
differenza, teorizzata compiutamente peraltro già da Kant, tra ontologia e
epistemologia: in qualche misura, il mondo è completamente rimesso alla mediazione dei nostri organi di senso:
fin dall’inizio della nostra opera, abbiamo incontrato questo principio, quando vedemmo Protagora
andare più in là di Democrito. In seguito […] troviamo due uomini di nazione diversa […] che
tuttavia abbandonano entrambi nel medesimo punto il terreno del materialismo: il vescovo Berkeley
e il matematico d’Alembert. Il primo ravvisava nell’intero mondo dei fenomeni una grande illusione dei sensi: il secondo dubitava che fuori di noi esistesse qualche cosa che rispondesse a ciò
che noi crediamo di vedere. […] Esiste nello studio esatto della natura un problema che impedisce ai materialisti odierni di respingere sdegnosamente il dubbio che colpisce la realtà del mondo
dei fenomeni: ed è quello della fisiologia degli organi dei sensi. […] Quando sarà dimostrato che
la qualità delle nostre percezioni sensibili dipende completamente dalla struttura dei nostri organi, non si potrà più eliminare come «inconfutabile ma assurda» l’ipotesi che perfino il complesso
del sistema in cui facciamo entrare le nostre percezioni sensibili, in una parola tutta la nostra
esperienza, sia sottoposta alla nostra organizzazione intellettuale, la quale ci sforza a sperimentare così come pensiamo, mentre i medesimi oggetti possono sembrare del tutto diversi ad un’altra
organizzazione, e che la cosa in sé non possa essere compresa da nessuna creatura mortale4.
4 F.A. Lange, Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart, Reclam, Leipzig
1866, 2 voll.; trad. it. di A. Treves, Storia del Materialismo, Monanni, Milano 1932, 2 voll.: vol II, pp. 13-14.
9
Che è come dire: non possiamo pretendere di conoscere davvero come sono
le cose fuori di noi, semplicemente perché, per una conoscenza completa, potrebbero anche mancarci5 gli organi di senso6.
L’idea di un mondo – il nostro mondo – condizionato e corretto dai sensi e
dall’intelletto ha avuto importanti conferme scientifiche nell’ambito del quadro
teorico in cui, da un punto di vista fisico, si procede a dematerializzare e a
riconcettualizzare le unità concettuali di riferimento (all’atomo si sostituisce il
campo di forza); mentre, da un punto di vista psicologico, l’inferenza e la costruzione del portato dello stimolo diventano gli elementi essenziali del mondo
percepito e, contemporaneamente, si discute l’idea che debba necessariamente
esistere un rapporto di corrispondenza tra lo stimolo e l’oggetto esterno – gli
studi di von Helmholtz intendono esplicitamente porre questo argomento sotto
il segno della problematicità: non esistono elementi scientifici sufficienti per
avallare la corrispondenza tra stimolo e oggetto, dunque in via ipotetica è necessario procedere come se tale corrispondenza di fatto non esistesse.
Filosoficamente, Helmholtz si richiama in primo luogo a Kant, e alle su riflessioni sugli apriori. L’idea fondamentale dell’Introduzione del saggio intitolato Ueber die Erhaltung der Kraft è che i fenomeni naturali sono la risultanza
di cause interne – identificate con le forze di attrazione e repulsione immanenti
alla materia – dipendenti direttamente dalle reciproche distanze degli oggetti
materiali a cui appartengono. Seguendo questa prospettiva, la natura si presenta come un sistema materiale i cui cambiamenti sarebbero dovuti, in primo luogo, all’azione conservativa delle forze.
Comprendere il mondo naturale corrisponde – in questo quadro – alla possibilità di comprendere, e di spiegare, le relazioni tra le forze, nonché i loro
rapporti con la materia. Il mondo esterno non viene quindi percepito attraverso
l’esperienza diretta (il tavolo che tocco o la mela che mangio), ma piuttosto
attraverso i suoi effetti (per esempio le forze) – dunque il mio toccare il tavolo, e
mangiare la mela saranno, nel complesso, i segni di un’esperienza che mi dice
qualcosa a proposito della realtà del tavolo (o della mia realtà) soltanto attraverso l’atto con cui tocco il tavolo o mangio la mela: «dal momento che non possiamo percepire le forze per loro stesse, ma solamente attraverso i loro effetti, dobbiamo tralasciare la testimonianza dei sensi nella spiegazione di qualsivoglia
fenomeno naturale, per rivolgerci agli oggetti non osservabili che sono determinabili solamente attraverso l’utilizzo dei concetti»7. Dal che se ne deduce un
mondo (ri)costruito a partire dai propri effetti (proiezioni sulla retina,
decodificazione di stimoli sonori o nervosi e così via), mancando del tutto –
almeno stando all’idea centrale di von Helmholtz – la possibilità di conoscerlo
5
F. Nietzsche, Frammenti postumi 1888-1889, Adelphi, Milano 1974, vol. VIII, t. III, 8-14-[168], p. 142.
6 È generalmente noto, per esempio, che i nostri sensi riconoscono soltanto alcuni stimoli in ingresso, quelli
per cui sono cablati, tutti gli altri, invece, sono ovviamente trascurati; così come è generalmente noto che la
differenza qualitativa delle sensazioni è direttamente dipendente dai sensi coinvolti: una stessa lunghezza
d’onda sarà luce oppure suono a seconda che incontri l’occhio oppure l’orecchio; oppure non sarà nulla se i
nostri apparati percettivi non sono attrezzati a ricevere lo stimolo in questione (per esempio con la nostra
dotazione sensoriale non siamo in grado di percepire gli ultrasuoni).
7 H. von Helmholtz, Ueber Goethes naturwissenschaftliche Arbeiten. Vortrag, gehalten 1853 in der deutschen
Gesellschaft in Königsberg, «Kieler Monatsschrift», Mai 1853; ora in Id., Vorträge und Reden, Friedrich Vieweg
und Sohn, Braunschweig 19035, 2 voll., p. 40.
10
per via diretta. In questo caso siamo di fronte a un mondo fatto di tracce che
vanno decodificate e ricostruite dal soggetto; in ultima analisi, un mondo riportato del tutto agli apriori concettuali e fisici dei soggetti conoscenti.
Una prima soluzione differente che cerca di autonomizzare l’ontologia e la
metafisica dalla fisica esperta (che invece, com’è noto, aveva ispirato sia Kant sia
la radicalizzazione neokantiana) è quella proposta, anche se con significati diversi, da Brentano e Husserl prima e da Frege poi. Sia Brentano sia Husserl
conservano il trascendentale kantiano sostenendo l’esistenza di fenomeni che si
danno alla nostra coscienza. Brentano lavora per sganciare la psicologia dalla
fisica, postulando la specificità del mondo psicologico (il cui carattere distintivo
è l’intenzionalità) rispetto a quello fisico e materiale. Husserl, da parte sua, indaga la realtà nelle sue varie espressioni, siano esse fisiche o psichiche, e formula
un insieme di leggi certe in grado di operare i processi di fondazione (Fundierung)
delle molteplici strutture del reale (basti pensare alla Terza ricerca logica). Se –
come si è accennato – sia Brentano sia Husserl conservano, almeno in parte,
l’impianto trascendentale, Frege muove invece a una sua critica organica e approfondita. Distingue cioè le rappresentazioni soggettive dal pensiero oggettivo, e quest’ultimo dall’oggetto del pensiero: infatti mentre il senso e il significato sono oggettivi, la rappresentazione, essendo una sorta di immagine mentale,
risulta inevitabilmente soggettiva. La particolarità degli oggetti secondo Frege –
elemento estremamente interessante in una prospettiva ontologica – è che tendenzialmente possono essere conosciuti come esistenti indipendentemente dagli apriori del soggetto; in particolare, la loro natura non dipende dai nodi linguistici atti a indicarli, cosa che invece non vale per concetti e proposizioni che
risultano più intimamente vincolati ai modi e alle situazioni linguistiche che
usiamo per esprimerli.
Certamente, un posto particolare – all’interno delle ontologie proposte nel
Novecento – spetta a Russell, il cui atteggiamento nei confronti dell’ontologia
può essere distinto in due momenti: un primo momento (fase logico-ontologica
che si conclude con La filosofia dell’atomismo logico del 1918-1919) in cui viene affidato alla logica il compito di descrivere ed esplicitare la struttura ontologica
del reale; L’analisi della mente del 1921 avvia invece il secondo momento,
naturalistico, caratterizzato da un radicale cambiamento di prospettiva: la logica da specchio del reale viene declassata a mera teoria del simbolismo, e l’inventario dei fatti e degli oggetti del mondo diventa di esclusiva pertinenza delle
scienze.
Soprattutto nel Novecento, dunque, il terreno di scontro diventa sistematicamente la questione del soggetto; diviene cioè sempre più urgente capire se le
leggi del mondo devono in ogni caso essere ricondotte ai trascendentali del soggetto, oppure se hanno un andamento proprio, indipendente da qualsivoglia
soggetto eventualmente conoscente. In un caso come quello di Heidegger, poi,
la posizione è ancora più debole e sfumata, nel senso che si compie il tentativo
di risolvere il problema dell’essere in quello del senso dell’essere. Se cioè l’ente si
dice in molti modi, viene da chiedersi – operazione per altro già tentata da Platone e Aristotele – quale sia il modo fondamentale, e cioè qual è l’essere dell’ente. In Essere e tempo Heidegger indica nella comprensione «media e vaga» che
l’ente ha dell’essere su cui si interroga (che fatalmente è il proprio) la via per
11
risolvere la questione: è l’Esserci che interroga l’essere a partire dal proprio essere, accentuando in questo modo il senso della dipendenza dell’essere dal soggetto che lo comprende, e aprendo la via all’ermeneutica.
Su un altro versante l’eliminativismo di Carnap (La costruzione logica del
mondo) tenta di ricostruire il processo attraverso cui il soggetto costruisce il
mondo esterno a partire da semplici elementi primitivi. Sotto l’influsso di Mach
e della psicologia della forma, questi dati sono concepiti da Carnap come dati
elementari, costituiti dalle esperienze istantanee del soggetto.
In ambito più strettamente analitico, poi, è Quine nel 1948 a notare (o meglio, a ricordare) che la domanda fondamentale su «che cosa esiste?»8 nasconde
una ambiguità di fondo. Da un lato, infatti, la risposta non può che essere tutto,
dato che sarebbe una vera e propria contraddizione dire che qualcosa non esiste
(poiché l’assunto di base è – ovviamente – che oggetto ed esistente facciano
tutt’uno); dall’altro Quine, riprendendo ampiamente le idee esposte da Russell
in On Denoting (1905), risponde che «essere», per una certa teoria, viene ad
identificarsi con «essere il valore della variabile vincolata dal quantificatore».
Secondo Quine, dunque, alla domanda che cosa è l’essere bisogna rispondere,
che essere è essere il valore di una variabile. Questo significa forse che il problema dell’ontologia viene ridotto ad un problema logico-linguistico? Certamente
no, dato che le variabili vincolate non ci dicono che cosa c’è nel mondo, ma
soltanto ciò che la teoria ci dice che ci sia. Quindi il criterio dell’impegno
ontologico ci fa assumere tutte (e solo) quelle entità che sono necessarie affinché gli enunciati di una certa teoria siano veri. Su quali basi allora privilegeremo una ontologia rispetto ad un’altra? Quine sostiene che il criterio che ci guida
sia di natura epistemologica, e che si adotti un’ontologia così come si adotterebbe una teoria scientifica. L’ontologia si definisce nel momento stesso in cui accettiamo uno schema concettuale che ci permette di articolare la scienza. «Ma il
problema della scelta effettiva di una ontologia rimane ancora aperto, e il consiglio ovvio è di essere tolleranti e di procedere con spirito sperimentale»9.
Siamo alle soglie della distinzione recente tra metafisica descrittiva e prescrittiva10: se esistono dei dati elementari che costituiscono la base delle nostre
esperienze è ragionevole pensare che questi dati siano separati dal soggetto –
nel senso che non ne dipendono – e, probabilmente, si può altrettanto ragionevolmente pensare di poterne elaborare una descrizione sufficientemente soddisfacente. Rimane aperta e interessante la questione del rapporto tra metafisica
descrittiva da un lato e scienze cognitive e fisiologiche dall’altro, visto che un
lavoro ontologico che si autointerpreta a partire da una prospettiva descrittiva
deve probabilmente, in ogni caso, affrontare la questione della costituzione fisiologica del soggetto.
Questi sono i tratti, necessariamente generalissimi, almeno in questa introduzione, delle diverse storie che si fanno storia.
Tuttavia, prima di concludere è opportuno fare ancora un’osservazione: parlando di «storie dell’ontologia» oggi – con l’importante rinascita di interessi
ontologici che in questi ultimi anni ha avuto luogo sia sul versante teorico sia su
quello applicativo – non si rischierà forse di attribuire al titolo una sfumatura
ironica, quasi che le «storie» in questione fossero semplicemente delle storielle,
per non dire delle chiacchiere del tutto inutili all’ontologia «vera e propria»,
quella di cui oggi precisamente si rivendica tanto l’importanza?
Non si tratta di un punto da sottovalutare. Infatti, l’ontologia che si fa oggi,
teorica o applicata che sia, non si caratterizza tanto per essere una sorta di esposizione universale delle concezioni dei filosofi sull’essere, da Parmenide ai giorni nostri, quanto piuttosto per essere un’attenta analisi vòlta all’esplicitazione di
metodi e griglie concettuali che vengono poi utilizzate e applicate negli ambiti
più disparati: se nell’ontologia teorica vengono infatti impiegate per edificare
nuove e più appropriate (o convenienti) visioni del mondo o di quelle parti del
mondo che intendiamo prendere in considerazione, nell’ontologia applicata trovano riscontro all’interno dei settori propri dell’informatica (in cui vengono adoperate per programmare i computer), della medicina (in cui sono utili per uniformare i dizionari o relazionare sintomatologie e patologie), delle assicurazioni
(in cui servono per capire, ad esempio, fino a che punto un oggetto x è coperto
dall’assicurazione) fino ad arrivare alle proprietà immobiliari e alle proprietà di
idee.
L’ontologia, almeno quella applicata, oggi viene per lo più utilizzata per effettuare delle catalogazioni, e proprio per questo si potrebbe essere tentati di
pensare che la sua storia sia del tutto superflua e che la si possa tralasciare. La
nostra idea è che se si volesse optare per una tale scelta si sbaglierebbe. Perché è
ben vero che l’ontologia non si riduce alla sua propria storia, ma è anche vero
che quella storia è da un lato testimonianza di secoli di ricerca e dall’altro riserva ancora ricca di soluzioni possibili, strade battute solo in parte, e altre strade
magari intuite ma ancora tutte da esplorare.
Le storie dell’ontologia che seguono sono frutto degli incontri che hanno avuto
luogo a Torino nell’autunno del 2002 durante due convegni organizzati dal
Centro Interuniversitario di Ontologia Teorica e applicata (Labont): Ontologie
analitiche (24-26 ottobre) e Storia dell’ontologia (5-6 dicembre).
8 W.V.O. Quine, On What There Is, «Review of Metaphysics», II, 1948, pp. 21-38; trad. it. di E. Mistretta, Su
ciò che vi è, in W.V.O. Quine, Il problema del significato, Ubaldini, Roma 1966, pp. 20-44.
9 Ibidem, p. 44.
10 A. Goldmann, Liasons: Philosophy Meets the Cognitive and Social Sciences, MIT Press - Bradford Books,
Cambridge (Mass.) 1992.
12
13