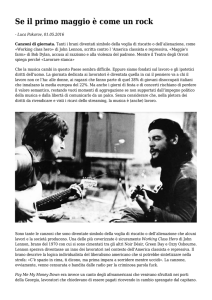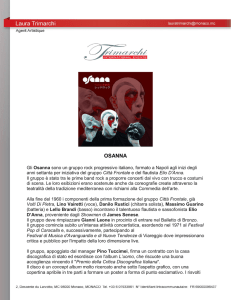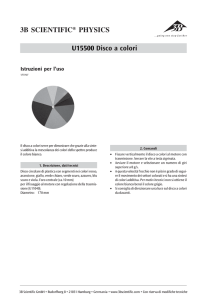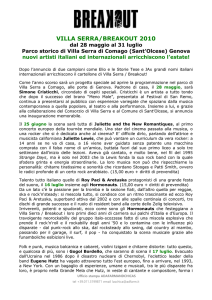digital magazine dicembre 2009
N.62
neverending summer
Candeggina
pop
Washed Out, Neon Indian,
Memory Tapes, Delorean,
Föntan
Lightning Bolt
The folly and the fury
Alessandro Grazian // Shit & Shine
Mr. Henry // Appaloosa // Cheater Slicks
Six Finger Satellite
3-D parte seconda
Hans-Joachim Roedelius
62
Sentireascoltare n.
La casa editrice Odoya e SentireAscoltare presentano:
Turn On
p. 4
Alessandro Grazian
5
Shit & Shine
PJ HARVEY
6
Appaloosa
8
Mr. Henry
Musica.Maschere.Vita
10
Cheater Slicks
Un libro di Stefano Solventi
La sua musica è una sferzata misteriosa e misteriosamente liberatoria.
Un’ossessione blues sbocciata nella culla del Dorset, cresciuta tra inquietudini adolescenziali e una incontenibile brama di mondo. Quando infine
è esplosa, lo ha fatto col piglio travolgente dei predestinati. Dei suoi primi
quaranta anni, Polly Jean Harvey ne ha dedicati venti a tracciare una
parabola fatta di musica, maschere e vita.
240 pagine
Volume illustrato
euro 15,00
Rubriche
Tune In
12 Six Finger Satellite
100
Giant Steps
101
Classic Album
102
La sera della prima
Drop Out
16
Lightning Bolt
22
Candeggina Pop, Neverending Summer
CONCEPT ALBUM
Recensioni
Un libro di Daniele Follero
Introduzione Franco Fabbri
Nata sull’onda della rivoluzione musicale di fine anni Sessanta, la pratica
del concept album ha accompagnato la maturità del rock, scrivendo un
capitolo importantissimo nella storia della popular music. I dischi “a tema”
continuano ancora oggi a rappresentare un affascinante mezzo espressivo,
anche negli ambienti del pop da classifica. I recenti concept album dei Green Day sono la testimonianza più lampante di un filo rosso che, partendo
da Frank Sinatra, tiene insieme Sgt. Pepper’s dei Beatles, Tommy degli Who,
The Dark Side of the Moon e The Wall dei Pink Floyd, le storie d’amore di
Claudio Baglioni arrivando fino ai Dream Theater e al brit-pop.
226 pagine
Volume illustrato
32
Annie, Kuupuu, King Midas Sound, Hollowblue, Zelienople...
Rearview Mirror
88
Roedelius, Nirvana, Julian Cope, Metalheadz...
Direttore: Edoardo Bridda
Direttore Responsabile: Antonello Comunale
Ufficio Stampa: Teresa Greco
euro 15,00
Coordinamento: Gaspare Caliri
Layout
e
Grafica: Nicolas Campagnari
Redazione: Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Antonello Comunale, Teresa Greco, Stefano Pifferi, Stefano Solventi.
Hanno
www.odoya.it
www.sentireascoltare.com
Leonardo Amico, Gianni Avella, Luca Barachetti, Salvatore Borrelli, Marco Braggion,
Luca Colnaghi, Gabriele Marino, Francesca Marongiu, Andrea Napoli, Massimo Padalino, Giulio Pasquali, Aldo
Romanelli, Costanza Salvi, Giancarlo Turra, Fabrizio Zampighi.
Guida
In
In tutte le librerie
collaborato:
spirituale:
copertina:
Adriano Trauber (1966-2004)
washed out
SentireAscoltare online music magazine
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05
Editore: Edoardo Bridda
Direttore responsabile: Antonello Comunale
Provider NGI S.p.A.
Copyright © 2009 Edoardo Bridda. Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale, in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, è proibita senza autorizzazione scritta di
SentireAscoltare
Shit & Shine
Alessandro Grazian
Cronaca di una maturità annunciata
Diamanti e Letame
Acidi e steroidi per l'ottimo 229 2299 Girls
Against Shit, riconferma della forza propulsiva
dei conigli tribali
Per una volta L'abito fa il monaco: torna Alessandro Grazian con un Ep che riassume quattro
anni di musica scritta e suonata
D
i artisti raffinati come Alessandro Grazian non
ne nascono tutti i giorni. Come dimostrato da
una musica fuori dal comune in bilico tra orchestrazioni e canzone d'autore, aspirazioni da soundtrack
e folk aristocratico. Materiale che ha bisogno di
tempo. Per decantare, sorprendere, comunicare.
Anche perché può accadere che la strada da percorrere si faccia paradossalmente insidiosa, quando
la scrittura è in potenza complicata e le conoscenze
tecniche non si limitano a due accordi di chitarra e
un 4/4 di batteria. Pur avendo le capacità per comprimere in tre minuti di canzone il classicismo di
Bach e il Fabrizio De Andrè più profondo, una
voce à la Jeff Buckley e un fingerpicking virtuoso,
certa ipertrofia dei testi e una serietà compita, può
succedere di perdere la bussola.
Deve passare del tempo prima che ci si accorga
che il messaggio ha bisogno di strutture lineari - per
quanto elaborate - e non di conglomerati pulsanti di
strumenti e sillabe; ci si deve mettere in discussione, per capire come far respirare musica e parole.
Magari portandole in giro in tour o confrontandole
con forme d'arte complementari (il Grazian musicista di scena nelle ottanta repliche dello spettacolo
Nati sotto contraria stella). Si arriva allora a una sintesi
perfetta tra un disco pretenzioso e intrigante come
4
Turn On
Caduto (Macaco/Trovarobato, 2005) e un successivo
Indossai (Trovarobato, 2008) più a fuoco e depositario di episodi commoventi come la title track o la
suite San Pietroburgo. In un EP L'abito (n.61 del pdf)
summa di un percorso di crescita costante e ammirevole, nella sua fedeltà a un'estetica riconoscibile.
C'è anche dell'altro. Parlando di Alessandro Grazian ci si rivolge giustamente a un musicista solista
ma in realtà si ha a che fare con un collettivo. Un
parco strumentisti che può vantare Nicola Manzan (violino), Gianbattista Tornielli (violoncello), Riccardo Marogna (clarinetto), Nereo Fiori
(fisarmonica), Alessandro Arcuri (contrabbasso),
Tommaso Cappellato (batteria) e quell'Enrico Gabrielli in forza ad Afterhours e Mariposa.
Quest'ultimo a condividere con lo stesso Grazian
orchestrazioni e arrangiamenti. Un gruppo di lavoro che non solo sostanzia la scrittura elegante del
musicista padovano, ma ne valorizza i passaggi, ne
indirizza il carattere, ne allarga le prospettive, ne aumenta il fascino, fino a diventare una componente
fondamentale delle geometrie dei brani. In tempi di
social network fittizi, un network reale che funziona
benissimo e senza aver bisogno di un server.
Fabrizio Zampighi
A
ssistere a un concerto di Shit & Shine è un
esperienza quasi mistica. Tour-de-force tribali,
da 5 a 10 batteristi a colpire all'unisono il medesimo immutabile ritmo, torturato da feedback maligni,
ultrabassi tellurici ed elettronica potente sparati al
massimo da amplificatori Orange. Se poi si aggiunge
una teatralità fatta di galline epilettiche a contorcersi dentro costumi da coniglio, improbabili caricature
da fine del mondo e in generale grotteschi scenari
dell'assurdo, si ha un quadro completo dell'universo
Shit & Shine. Si capisce così anche perché quel
tempio della musica stramba e rumorosa che è la
Load abbia prodotto il loro scorso album, Küss
Mich, Meine Liebe. Un disco che poco aggiunse
al precedente acclamato Cherry, ma che consacrò
la band nei circoli alti del noise "out" d’inizio millennio. A spartire il posto con le altrettante batterie di
Burmese o con le creature di Brian Chippendale:
Lightning Bolt e soprattutto quei Mindflayer
dallo stesso vizio per l'elettronica arrugginita.
La band nasce da un’idea del texano Craig Clouse
(oltre che nei Todd, è stato uno dei tentativi degli
Hammerhead di sostituire il chitarrista Sanders )
che trasferitosi a Londra, voleva una valvola di sfogo
per le sue perversioni: rumore e ritmo. Assoldati
Larry Mannigan e Frank Mckayhan - per batterie e
tagliaerbe, recitano i loro booklet - ecco Shit & Shine. E se dei loro concerti pazzeschi, che hanno reso
famosa la band in giro per i festival di mezzo mondo
(Sonar, ATP) si è già data un idea, la stessa carica
massimalista si ritrova nei loro dischi, seppure in
maniera diversa. Fatta eccezione per Ladybird (su
disco quello che sono i live della band: 40 minutes,
one riff=evil fun) lungo le tracklist della discografia
si passa con disinvoltura attraverso house balorda
da 200 lire al chilo, tragedie grind-core, dub clippatissimi e lunghe cavalcate motorik lorde da far schifo. Pezzi lunghissimi, senza capo né coda: come delle
finestre spalancate immobili e poi richiuse di colpo
su abissi primitivi, sabba di streghe chissà-quandoiniziati e chissà-se-finiranno-mai, tutto sostenuto da
un numero imprecisato di batterie, così superflue
eppure così stilisticamente essenziali.
Ed è questo il materiale di cui è composto anche
l'ultimo lavoro della band 229 2299 Girls Against
Shit. Nessuna rivoluzione stilistica, essenzialmente,
ma l'ennesima prova di forza, una conferma, se possibile ancora più gonfia di acidi e steroidi. Canzoni
(?!) tra le più ispirate della band e un suono meno
indulgente che mai, ultra-compresso, sempre sul
rosso e sempre sul limite del bang. Una buona occasione, quindi, per ribadire le capacità di una band
che continua imperterrita a confezionare merdosi
splendori.
Leonardo Amico
Turn On
5
Appaloosa
Cavalli di razza
Gli Appaloosa ritornano dopo quattro anni con un sound
più lucido e definito. Senza risparmiarci sorprese
L
ivorno è città contradditoria e sfaccettata. Acuta e sonnacchiosa, frenetica e immobile, sarcastica e
generosa. Oltre il mare, il ponce, il cacciucco e il Vernacoliere c'è di più. Molto di più. Riguardo al rock,
per dirne una, c'è parecchio fermento. Una febbre sproporzionata rispetto ai non troppi locali disponibili
dove sfogare la voglia di suonare e ascoltare. Tuttavia, non è certo un caso se la fondazione Arezzo Wave
ha deciso di organizzare proprio a Livorno la sua celebre manifestazione estiva (Italia Wave) dopo l'infelice
esperienza fiorentina. Qualcosa, anche a livello di band, inizia ad emergere. Gli Appaloosa, ad esempio.
Fondati nel 1998 da Enrico Pistoia (basso e tastiere) e Niccolò Mazzantini (basso, chitarra e tastiere) e
subito raggiunti dal batterista Marco Zaninello, iniziarono a coltivare un torrido math-funk con attitudini
psichedeliche, beccheggiando sull'onda lunga del post che li convinse a rinunciare al canto. Pezzi spigolosi
ma geometrici, un invasamento lucido che trovava nel ricorso ai due bassi la giusta temperatura di fusione.
L'omonimo album d'esordio del 2003, uscito per l'etichetta Ondanomala, portò a compimento una ragguar-
6
Turn On
devole razzia di consensi. Ma il bello doveva venire.
L'ingresso in squadra nel 2004 di Simone Di Maggio
- che portò in dote la sua abilità con, samples, drum
machine e sintetizzatori - fu l'ingrediente decisivo.
Le successive esibizioni misero in mostra un
sound sempre più esuberante e versicolore, che si
concretizzò nell'ottimo sophomore Non posso
stare senza di te (Urtovox, 2005), registrato col
producer Giulio Favero. Una prova convincente seguita da un intenso biennio di concerti. L'attesa per
la terza prova è stata lunga, ma ne è valsa la pena.
Un buon motivo per scambiare due mail con gli Appaloosa.
Innanzitutto una curiosità riguardo al vostro nome (una razza equina nordamericana
molto apprezzata dai nativi pellerossa e dai
cavallerizzi contemporanei, ndi). C'è qualche
appassionato di equitazione nella band?
No ma quei cavalli ci affascinavano molto nel lontano 1998.
Cosa avete fatto, pensato, annusato in questi
lunghi quattro anni di assenza discografica?
Nei primi due anni eravamo sempre impegnati con
le date, dopo c'è stato un periodo di pausa riflessiva
e ognuno è andato un po' per la sua via. Poi abbiamo
iniziato la produzione dei nuovi pezzi, all'inizio non è
che venissero cose che ci esaltavano ma piano piano
ci siamo sbloccati, le canzoni del disco sono uscite
quasi tutte nei 10 mesi prima della registrazione. In
realtà in questi anni il pensiero, l'obbiettivo è stato
sempre fare il nuovo disco.
Vi ritrovo più lucidi, definiti e concisi, come
se aveste deciso di dare una bella sistemata al vostro naturale derapage sonoro. Cosa
cova sotto questo restyling?
Abbiamo scartato molte idee che erano anche belle
ma in un certo senso scontate, ovvero le nostre canzoni classiche a due bassi molto violente, lavorando
su linee più particolari e magari per noi meno convenzionali. Ci siamo soffermati molto sulle rifiniture
e gli arrangiamenti elettronici, sicuramente questo
disco suonerà meno grezzo dell'altro.
Direi che è ufficiale: Giulio Ragno Favero è il
vostro George Martin. Giusto?
Dopo l'esperienza e i risultati di 4 anni fa era naturale tornare da Giulio. Al Blocco A (lo studio padovano di Favero, ndi) sai di essere in ottime mani e di
lavorare con una persona che è in linea con i tuoi
gusti musicali, ottenendo quello che cerchi molo facilmente. Sei rilassato durante la registrazione e sei
più portato a prendere consigli magari non accet-
tandoli tutti ma riuscendo ad avere uno scambio.
Siamo cresciuti molto dopo queste due esperienze.
E' stato come andare a scuola!
La penultima cosa che mi sarei aspettato in
un vostro disco è un funky-soul dalle brume
spacey in scia Zero 7. L'ultima è il ricorso ad
un chitarrista e cantante pisano (Andrea Appino degli Zen Circus). Che vi ha preso?
La canzone funky soul è venuta fuori prima per gioco poi ci siamo presi sul serio e l'abbiamo finita e
tenuta. Di solito non decidiamo o discutiamo niente a priori, si prende in considerazione la canzone
dopo aver buttato giù l'idea o aver improvvisato
qualcosa, il risultato è che salta fuori di tutto. L'idea
di fare una collaborazione con Andrea Appino c'era
da molto tempo, dato la stima che abbiamo per gli
Zen e le vicinanze geografiche e il fatto che siamo
molto amici anche se sono pisani!! La canzone (Glù)
era già stata scritta mesi prima, l'abbiamo ripresa e
finita con Andrea e Michele Ceccherini che è l'altro
bassista che ha fatto con noi molti concerti.
Nel disco precedente mi azzardai a paragonarvi agli Oneida, non so se vi abbia fatto
piacere. Per Savana invece ho le idee meno
chiare. C'è una situazione cui avete fatto particolare riferimento?
No, penso che sia una fusione di tutto quello che
abbiamo suonato ascoltato in questi anni, un riferimento ben preciso davvero non c'è. Nessun problema per il paragone con gli Oneida, in realtà non li
avevamo mai ascoltati e conoscendoli siamo rimasti
lusingati.
Non vi ho mai visti dal vivo, dove pare che
ve la caviate parecchio bene. In genere riarrangiate i pezzi o siete fedeli alle versioni in
studio?
Siamo abbastanza fedeli alla versione in studio, al
massimo può capitare che dopo un po' che suoniamo una canzone live iniziamo a cambiarla magari in
qualche stacco o scambio e mischiamo canzoni tra
di loro. Sicuramente il concerto è la dimensione che
ci permette di esprimerci al meglio, non vediamo
l'ora di proporre la nuova scaletta con pezzi nuovi
e vecchi.
Avete già programmato il tour?
Il tour è in programmazione in questi giorni curato
da Locusta e Urtovox. Partirà da Dicembre.
Stefano Solventi
Turn On
7
L
Mr. Henry
Se la terra è desolata
Rabbia e disperazione in blues elettronici che raccontano il dopo apocalisse. Mr. Henry rinuncia al
declino con ottica DIY e spirito da artigiano
8
Turn On
a vicenda di Mr. Henry, alias Enrico Mangiorne
da Varese, potrebbe essere l'esempio perfetto di
come la solitudine in un tempo di crisi-rivoluzione
discografica diventi un valore, inteso come prerogativa necessaria per chi nell'agire da musicista pensa
prima di tutto alla musica - anzi, alla musica e basta,
quale esigenza e sfogo.
Tre dischi dal 2003 ad oggi di canzoni-bozzetti
fermate su supporto nell'urgenza del momento, per
un crescendo qualitativo che ha allargato sguardo
e influenze. Le prime due uscite su Ghost Records
e Suiteside (Lazy Go Through..., 2003 & the
Hot Rats, 2006), poi la scelta di fare tutto da sé
in direzione DIY: “Dalla musica ho sempre ricevuto
pochissimi soldi e la maggior parte dello sbattimento
(cioè guidare, montare, smontare, fare i suoni, registrare,
rinunciare a giorni di lavoro) me lo sono fatto quasi sempre da solo. Non ho avuto problemi con le etichette che
mi hanno prodotto, ma dopo un tour negli States dove
ho incontrato ed ho suonato con gente che praticano il
DIY alla lettera ogni giorno come Robert Inhuman
dei Realicide o Captain Ahab mi sono chiesto se
veramente valesse la pena continuare a suonare in un
certo modo. Ovviamente visto che la musica per me è
irrinunciabile, ho rinunciato volentieri a tutto il resto e ho
continuato da solo”.
Dunque un indirizzo che fa dell'indipendenza
non un marchio da sbandierare ma un rifiuto rabbioso in forma di (disperante) denuncia e reazione
vitale ad uno stato delle cose desolato. “La musica
sta diventando quasi esclusivamente una questione di
moda: gli ascoltatori non ascoltano, i critici non criticano, le etichette non promuovono i meritevoli ma solo gli
amici e gli amici degli amici”. E proprio Terra Desolata
è il nome dell'etichetta - con omaggio a Eliot - che
marchia il nuovo corso: “Se vai sul MySpace di Terra
Desolata c'è una 'Lettera aperta al pubblico e alla critica italiani' in cui spiego le ragioni della fondazione di TD.
Quella lettera l'ho inviata a tutti i direttori delle riviste
di musica italiana, voleva essere oltre che una denuncia
ed una dichiarazione di intenti, anche una provocazione
dalla quale un qualsiasi critico poteva partire per un
articolo sulla situazione musicale italiana. Invece non ho
ricevuto nessuna risposta”.
Ma Henry è uno che non demorde, se non altro perché la sua musica ha bisogno di continuare
ad esprimersi. E l'ultimo lavoro Ornery (uscito nel
maggio dello scorso anno che colpevolmente recuperiamo solo oggi), titolo sintomatico traducibile
all'ingrosso come “Testa dura”, divarica lo spazio tra
lui e il nume generativo Tom Waits - già rimastica-
to alla meglio nei due precedenti titoli con contagi
di Mark Lanegan, Leonard Cohen e Violent
Femmes - spostando l'attenzione verso un utilizzo
dell'elettronica che era già nei sette minuti inquieti
della No-Sense # 0 in chiusura di & the Hot Rats.
Beat siderali alla Nine Inch Nails primo tipo, bordate da fabbrica che furono Throbbing Gristle,
brusii primigeni e martellate di scuola Pan Sonic,
ognuno insieme all'elettrica e più raramente al piano, accentuano qui un sentore da post-apocalisse
che spurga la rabbia e la disperazione di cui sopra.
“E' probabile che la rabbia percepibile il questo disco
sia legata anche alle scelte che ho fatto. Io ho sempre
scritto molto di getto ed ho sempre cercato di mantenere questa urgenza anche nelle registrazioni per non
snaturare i pezzi. Era da tempo che volevo registrare
qualcosa di più elettronico e al contempo più aggressivo,
ma non riuscivo a trovare i suoni giusti, poi Alessandro
dei Clark Nova mi ha passato uno dei suoi Fuzz e mi si
è aperto un mondo!”.
Difficile non immaginare ascoltando le otto tracce di Ornery la figura di Mr. Henry stagliarsi da un
vano sotterraneo ed osservare, per poi raccontarlo,
il nulla conseguente all'esplosione che ha cancellato
ogni cosa. E' questo d'altra parte lo spirito di chi
rinuncia al declino rimanendo vivo in una solitudine
artigianale sempre più attiva. “Ultimamente ho registrato un disco con un nuovo progetto che si chiama
Downlouders in cui suonano anche membri di Freelance Co., Encode e Twisted Logic, intanto sto
lavorando al quarto disco che sarà ancora diverso e mi
piacerebbe lavorare con il miglior bluesman italiano, ossia Angelo Leadbelly Rossi. Invece Terra Desolata
ha già in catalogo sei dischi (Freelance Co., Lucha
Libre, The Lonely Rat, Mr. Henry, Downlouders, Clark Nova) e per dicembre sto preparando
una compilation natalizia su cassetta in venticinque
copie in cui il primo lato sarà compilato da me ed il
secondo sarà bianco in modo che ognuno possa crearsi
la propria compilation. Più DIY di così...”.
Luca Barachetti
Turn On
9
L
Cheater Slicks
Long Gone Rejects
Cheater Slicks, ovvero come tirare avanti a schiena
dritta suonando dinamitarde miscele di noise e r’n’r
dal 1989.
10
Turn On
a loro è una proposta che ha fatto scuola, portando avanti quel processo di rilettura della
tradizione musicale americana che fu prima dei
Cramps, poi di Gun Club e Beasts of Bourbon,
ed infine di Pussy Galore e Chrome Cranks.
Parliamo dei fratelli Tom e Dave Shannon e del batterista Dana Hatch, in arte Cheater Slicks, quartetto (con il bassista dei Real Kids "Alpo" Paulino)
per un soffio e rigoroso trio poi. Formazione garage
per antonomasia dagli elementi focali quali il folkblues-rock (la materia viva su cui agire) e il modus
operandi dei Velvet Underground, quelli di White
Light/White Heat.
E' dal 1989 che i nostri sono on the road e da
allora sono sempre stati fuori moda; mai completamente dentro alle cose che girano e all'inizio addirittura con un pubblico che li guarda attonito. A fine
anni '80 infatti impazzava il revival purista del garage
sixties, con Fuzztones e Fleshtones alfieri di una
ripresa fedele e pedissequa del rhythm'n'blues bianco di vent'anni prima. "Agli inizi nessuno capiva cosa
facevamo" dice Tom Shannon, chitarra scordata e
voce rauca fin dal giorno zero. "Non c'era cognizione
di cosa fosse un garage-punk come il nostro ai tempi e
certamente noi eravamo una delle pochissime band di
r'n'r rumoroso esistenti".
Nel lustro successivo, con il punk-rock di casa
Rip-Off a farla da padrone, il trio continua a fronteggiare le avversità. "Nei '90 tutto era piuttosto dritto e
quadrato, e noi volevamo fare altro. Ci piaceva il garage
dei '60 e il punk dei '70 ma volevamo rivederlo aggiungendoci qualcosa di nuovo". Presto però sembra
aprirsi uno spiraglio; etichette come la In The Red
stanno scandagliando gli antri più bui del sottomondo garage e gruppi come i Cheater Slicks non possono passare inosservati. E non sono i soli: presso
la label di Larry Hardy albergano anche Gories,
Bassholes e ’68 Comeback e il soggiorno è così
invitante da durare fino al 2003. Dieci anni in cui i
tre licenziano cinque album, compreso il capolavoro
Forgive Thee, un doppio compact che è un vero e
proprio manifesto letterario a base di corde rotte,
false partenze e linee vocali sbagliate.
Il destino dei tre è tuttavia segnato: con il nuovo
millennio si passa a etichette più piccole e nuovi
culti. "Lo svantaggio risiede nella tiratura delle pubblicazione; solo un numero limitato di copie viene stampato.
Il vantaggio sta invece nella maggior libertà del processo
creativo e nella velocità con cui si riesce a far uscire
qualcosa. Dover aspettare i tempi dei grossi distributori è esasperante e spesso anche molto ingiusto per le
band". Quest’anno, per il ventennale, la formazione
ritorna con Bats In The Dead Trees. Un assalto
frontale senza strofe, ritornelli e strutture: la cosa
più prossima al noise che un gruppo garage-punk
abbia mai registrato. E ovviamente c'è della coerenza in tutto ciò. "È stato un leggero allontanamento,
ma chiunque ci conosce sa bene cosa stiamo facendo.
Ci sono le influenze di sempre, soltanto in strutture più
libere. Ci tenevamo molto a mostrare l'altra faccia del
gruppo: quella che non avevamo mai registrato". Le
prime copie vanno sold-out in un lampo e, qualche
mese dopo, la label ristampa l'LP con un compact
disc contente l'unica esecuzione dal vivo dell'album.
E' la testimonianza migliore dell'interesse che ancora ruota intorno a Cheaters.
"I puristi non hanno mai gradito gruppi come il nostro; a qualcuno invece siamo piaciuti questo ha dato
vita a nuove band, a un nuovo modo di fare musica più
primitivo e selvaggio. E' bello vedere una nuova generazione più scomposta e rumorosa; è un po' come se
fossero figli nostri". E i Times New Viking? "Quelle
band sono più indie, noi pienamente rock'n'roll; la nostra musica nasce da lì e non certo dai dischi dei Pavement. Amiamo piuttosto la violenza di Hunches,
Hospitals e TV Ghost".
Andrea Napoli
Turn On
11
Six Finger Satellite
Neu Wave, il futuro era un'ipotesi
A volte ritornano più arrabbiati
che mai. Contro tutto e tutti. E
con un cuore tanto.
12
TUNE IN
“Senza cuore e artisti dove i loro compatrioti sono
accorati e senz’arte, i Six Finger Satellite
sono il miglior gruppo della Sub Pop
dai tempi di chi-sapete-voi.”
(Melody Maker)
C
i aveva preso, il defunto Melody Maker, una
volta tanto. O quasi, poiché questi ragazzi
del Rhode Island un cuore l’avevano e assai
rivelatore, benché mediato da ragione e sarcasmo.
E’ noto che chi ami sia critico dell’oggetto dei propri sentimenti, ed è cosa logica: i Six Finger Satellite, come i Devo, amavano - nel loro perverso
modo… - la società americana. Ne erano perfetti
figli degeneri, come appare dall’etica del lavoro incanalata dentro una critica verso la “american way of
life” assai sottile. Ed è soltanto se disponi di un cuore indurito al punto giusto, puoi resistere mentre
altri mediocri incassano danari sulle tue intuizioni.
La soddisfazione, se tale è, resta l’aver indicato da
pionieri un passato recuperabile da smaliziati che
non restano stritolati, che cavalcano l’onda che fu
nuova senza annegare. Perché guardavano anche a
quella Germania Anni Settanta che oggi fa chic citare ogni minuto, e sa di scontato, di fretta d’arrivare
da nessuna parte.
Nel 1992, in pieno grunge, era la cosa più fuori
dal mondo che si potesse pensare era un recupero
- e personale il suo - di istanze kraut e new-wave. Se
aggiungevi un lavoro sulla psicologia dell’ascoltatore
(messo in difficoltà da repentini cambi di stile e audaci trapianti) e la capacità di fomentare la paranoia
per demolirla nello spazio dello stesso brano, le
carte per entrare nelle enciclopedie non mancano.
Sarà una questione di tempo, che vorremmo vedere aiutata dall'attuale ritorno sulle scene, sempre
col loro tempismo fuori sincrono oppure no; con
quell’abilità nel complicarsi la vita da finti tamarri a
stelle e strisce. Con la svagatezza da personaggi di
Douglas Coupland, non fossero ben più maligni pur
sempre a nostro beneficio: di occhi aperti di fronte
al nulla pneumatico del post-moderno non se ne
parlava; piuttosto di condurre una vita normale con
un lavoro normale in modi che normali davvero
non sono. Prendete un concittadino illustre come
H.P. Lovecraft o i terroristi sonori giunti da Providence nell’ultimo decennio: ti fanno riflettere su
cosa ci sia nell’acqua da quelle parti, laddove si tratta
della benefica dislocazione tipica della vita lontana
dai grandi centri. Della provincia, a farla breve, che
permette di rileggere mode e fenomeni in modo
critico. Poche storie: come in un romanzo di Philip
K. Dick, se prevedi, preconizzi.
Poteva nascere solo al tramonto del rock “indie” americano, una band siffatta, in un 1990 dove
i Sonic Youth arrivavano alla Geffen. L’impero di
sabbia delle “indie label” cedeva sotto lusinghe e
pressioni e il revival sixties lasciava posto ai ’70. Tra
i tanti che oltre i Led Sabbath non sapevano andare, Jeremiah “J.” Francis Ryan (voce/tastiere), John
MacLean e Peter Phillips (chitarre), Chris Dixon
(basso), Rick Pelletier (batteria) osano di più e di
meglio: “Eravamo soliti provare ogni sera della settimana, non per diventare dei virtuosi dei rispettivi strumenti ma per trovare il modo di suonare la musica più
potente possibile.Venivamo da un retroterra punk dove
l’impegno rappresentava tutto; da ragazzini ascoltavamo hardcore, per cui volevamo esprimerci al meglio con
dedizione quasi fanatica.” (John McLean) Detto fatto:
i primi risultati sono inviati con un demo alla Sub
Pop che li assolda all’istante; il nastro esce come
l’e.p. Weapon nel 1992, attestato acerbo benché recante in tralice quanto nascosto tra il punk e l’hard.
La medesima annotazione valga per il doppio 45
dell’anno seguente spartito con i Green Magnet
School, Declaration Of Techno-Colonial Independence, vieppiù disseminato di indizi come fiati, synth e
stramberie assortite.
Non deluse dunque le attese il debutto a 33 - in
realtà due mini riuniti - The Pigeon Is The Most
Popular Bird (Sub Pop, 1993; 7,5/10), dove Kurt
Niemand subentra a Dixon e Bob Weston siede alla
regia. Metamorfosi robusta e in retrospettiva incompleta, alterna dieci canzoni vere e proprie con
undici strumentali, alcuni semplici schizzi e altri - i
migliori - più compiuti, che spaziano dal "krautismo"
(7,9) al rock spaziale (5) per mischiarli (11) come
fanno con Cluster e il David Bowie berlinese del
plumbeo masochismo 21. Le composizioni vere e
proprie sono operazione analoga, rileggono la new
wave mischiando la visione di discepoli e maestri col
favore del distacco critico e cronologico. Laughing
Larry esce dal Metal Box e Save The Last Dance
For Larry da un più esasperato Entertainment!;
Love (Via Satellite) può dirsi inedito dei Mission
Of Burma e diverse tracce omaggiano l’amata
asse Birthday Party/Jesus Lizard. La scala reale
si cala col sensazionale boogie blues destrutturato
in stile Captain Beefheart Hi-Lo Jerk (Marcellus
Hall dei Railroad Jerk all’armonica) e una Takes One
To Know One di jazzata demenza. Tra una genuflessione noise e l’altra, afferri squadrature ritmiche e
TUNE IN
13
piccoli dettagli d’elettronica citazionista etichettabili
oggi come post-rock.
Oltre il rock e non solo stavano, alla luce del
successivo di un anno Machine Cuisine, 10” che
pigia il pedale su tastiere e assurdità in scia agli
Mx-80’s come del resto la semiomonima cassetta,
mentre al corcevia tra omaggio e sfoggio di carattere sono i concerti interminabili e dissacranti, il
sintetizzatore a tracolla e le tutine indossate. Aria
di cambiamento che reagisce all’uscita di scena
di Phillips e Niemand, stroncato da un’overdose:
dentro James Apt per il capolavoro Severe Exposure (Sub Pop, 1995; 8,0/10), che mostra la via ai
Trans Am - e Brainiac e VSS, Lost Sounds ed
El Guapo - tramite un cocktail di Beefheart e krautrock ad elevata tossicità. Fusione indistinguibile di
moog e chitarrismo abrasivo, solidità d’impianto e
capacità d’elevazione, di Chrome, Shellac, Blues
Explosion (Board The Bus: nel delirio sentite anche
il basso letteralmente copiato dai manichini Strokes). E cento altre cose ancora, come chiariscono
l’isteria danzereccia di Cockfight, gli echi industriali
in Simian Fever, l’adrenalina colante da Bad Comrade e Dark Companion. Geniale trasfigurazione della
tradizione dall’interno, il disco smonta e rimonta
strutture (esemplari Rabies e Where Humans Go)
senza lesinare sfregi.
Frattanto, una fetta di anticipo contrattuale se
n’è andata nell’allestimento di un proprio studio di
registrazione - inciso lì quanto appena magnificato
- chiamato The Parlour. Da lì, un po’ come i Kraftwerk, il triennio seguente vedrà gente di belle
speranze prendere esempio per smuovere le fondamenta del rock alternativo. Poco dopo, un video
a basso costo della tambureggiante Parlour Games
si infiltra in un episodio di Beavis And Butt-head
ma non sarà la loro Whip It. Almeno non in termini di vendite incrementate, giacché Paranormalized
(Sub Pop, 1996; 7,1/10) esce troppo a ridosso del
predecessore e a tratti perde di vista la scrittura,
sino a quel momento lenta e tuttavia inesorabile a
conquistare spazio. Sebbene ci si muova di lato e
non avanti, la caratura resta buona (Padded Room,
Great Depression) e addirittura ottima (la tagliente
Greatest Hit e il Lydon rimbambito dalle strobo in
Coke And Mirrors; i ronzii di Paralyzed By Normal Life
e il senno perduto da Slave Traitor.)
Lo stallo, però, però più grave del previsto, un
arenarsi su secche sperimentali che avrebbero meglio figurato agli inizi; a questo punto, sospetti una
tartaruga che tira la testa dentro al carapace. Il
14
TUNE IN
12” su Load di quello stesso anno, dal titolo “programmatico” - autocritico? - Clone Theory, si fa
ricordare solo per i Tubeway Army con parentesi “concreta” di Ich Weil Nacht e una War Cries da
coltello tra i denti. Il resto sono strumentali limitati
entro una “weirdness” episodica ed eccessivamente compiaciuta. Logorati, i Six Finger Satellite, s’imbarcano in una tournee lunga mesi in compagnia
di numi tutelari (Shellac, Jesus Lizard) e discepoli
inizialmente simpatici (Trans Am). Al termine, tirano
il fiato e assoldano un produttore/musicista che di
strada ne farà parecchia e lastricata d’oro, James
Murphy. Logico dunque che, oltre a rivelarsi egregio per penna ed esecuzione, il quarto lp Law Of
Ruins (Sub Pop, 1998; 7,5/10) sia quello che “suona
meglio”: festa raffinata ma energica d’intarsi e magie
della consolle, richiami space-rock in contesti rumoristi e sagaci intuizioni da scuola teutonica anni
’70.
Guarda da adulto lo ieri dei suoi artefici (Race
Against Space, Lonely Grave) e cambia le carte in
tavola (l’elettro-dub che non esplode mai Fall To Pieces, l’omonimo metal cibernetico); apre il suono al
“panorama” (una Fuer Immer Liebe prossima a lidi
Schwingungen, la struttura stratificata di The White Visitation e Hertz So Good), s’impiastra allegro le
mani in laboratorio (Sea Of Tranquility: undici minuti
di Sonic Youth elettronici; New Kind Of Rat: nuovo
miracolo hard rock).
Terminano qui i giochi, alla dimostrazione di affinità elettive e al reciproco scambio di favori sottolineati dall’investitura del futuro LCD Soundsystem a “uomo del suono” negli spettacoli dal
vivo. Si chiude benissimo un cerchio ispirativo ed
esistenziale: MacLean saluta per accomodarsi sulla
pista da ballo sotto l’egida della murphiana DFA ed
è un colpo bassissimo. Ecco la prima dissolvenza,
costellata da problemi con l’etichetta: “Nulla da dire
circa il comportamento della Sub Pop, che si è anche
rifiutata di lavorare alle nostre recenti uscite. Probabilmente è meglio così: sarebbe stato un ennesimo giorno
coi soliti problemi, dato che oggi Sub Pop è nel pieno
di una sbandata “retro ‘60”. Fossimo ancora con loro,
salterebbero fuori le vecchie questioni: siamo fuori posto e non saprebbero che fare di noi. Un decennio fa
stavamo per raggiungere un certo “successo”, però il
mondo della musica è per ritardati, come chiunque con
un pizzico di cervello può capire. Suppongo che in quanto gruppo “influente” potremmo far soldi da qualche
cazzo di reunion, ma non accadrà. A questo punto, mi
basta registrare nuove canzoni.” (J. Ryan)
Nuove uscite, già: nel ‘99, Ryan e Pelletier, vicendevoli bracci destri, ricompongono il puzzle con
due membri dei Landed - Apt è tornato a Boston
- fino al 2001 senza registrare alcunché. Occorre
l’arrivo degli altri locali Dan St. Jacques e Brian Dufresne per lavorare su otto brani, “riesumati” dalla
Load soltanto pochi mesi fa per Half Control (cfr.
spazio recensioni). L’ascolto riconsegna la difficoltà
a reagire, dote umana che conferma il cuore di cui in
apertura e qui sta il pregio più profondo dell’opera.
Purtroppo, rabbia e distrazioni annebbiano la mente e appesantiscono un passabile noise-punk in cui
l’elettronica viene messa da parte ed è una mossa
a vuoto. Ci sono muscoli, foga e fracasso da vicolo cieco o, tutt’al più, da uscita laterale: solo due le
cose irrinunciabili - l’articolata ed elegante Artificial
Light; il “lato oscuro” Bored Oracle - eppure sufficienti a un’assoluzione e a uno spiraglio di speranza.
Succede però che tutto venga all’epoca accantonato per cause di forza maggiore e ci si separi più a
lungo. Rick Pelletier fa del dub con i La Machine e
siede dietro tamburi e piatti per i validi copisti P.I.L.
The Chinese Stars; Ryan si trasferisce in Colorado e
suona con gli Athletic Automaton. E’ la pausa necessaria a ricaricarsi e a lenire delusioni e amarezze.
“Credo che la differenza o la direzione siano ora basate
sui membri del gruppo: ci sono stili personali distinti che,
quando combinati, danno nuova magia. Inoltre è salutare
che non vi sia un “programma” e che suoniamo ciò che
ci piace fino a renderlo nostro. C’è stato un tempo in
cui Six Finger Satellite prendevano idee per trasformarle
in canzoni; persino i riff e i suoni più stupidi potevano
essere cool, ma verso la fine dei ‘90 siamo incappati in
qualche esercizio di stile. Ora siamo tornati a un approccio più libero e disinvolto verso i nostri modi eccessivamente perversi. Siamo sempre in movimento!” (J. Ryan)
Possibile che siano queste - e una sana indifferenza
verso il tribolato passato, vorremmo aggiungere - le
ragioni dell’ottima forma attuale, in un 2009 in cui la
nuova wave al cubo affoga nell’insipienza.
L’equipaggio è cambiato di nuovo, Rick sta alla chitarra timpiazzato da Jon Loper dei Made In Mexico. Mai allontanatisi veramente, come quei Three
Mile Pilot al pari importanti e redivivi, Pelletier e
Ryan posseggono un’intesa rodata e messa a frutto
in cinque mesi di calibrato lavoro in studio. Lavagna
ripulita da dubbi e abbozzi, A Good Year For Hardness
mostra coerenza e verve ritrovata, confermandosi
presenza necessaria nell’odierno pantano sonoro.
Che viene smosso con vigore, soprattutto da Don't
Let Me (essere sexy secondo The Fall), Midnight Rails
(ostacoli triturati con noncuranza), Hearts And Rocks
e Rise (la tradizione rinasce splendida). Bentornati,
ragazzacci dal cuore duro.
Giancarlo Turra
TUNE IN
15
S
Dieci anni alla velocità della luce e un nuovo album che
non ne vuol saperne di scalare marcia. Osservazioni in
movimento e qualche appunto...
- Stefano Pifferi
16
DROP OUT
tadio nido d’uccello di Pechino o Olympiastadion di Berlino, finale delle Olimpiadi o
dei Mondiali che sia per lui non fa differenza.
Brucia tutto e tutti sullo scatto, parte a velocità supersonica e con una progressione devastante straccia il nastro del traguardo lasciando tutto il
mondo molto dietro di sé. Poi, incurante di tutto e
tutti, ricomincia la sua sceneggiata buffonesca fatta
di balli primitivi e sconclusionati, risatine sguaiate e
facce buffe.
Follia e velocità, guasconeria e scatto bruciante.
Questo è ciò che fa di un ragazzone giamaicano di
nome Usain, il Bolt più veloce e pazzo del pianeta.
A chi si intende di musiche dell’underground quel
nome - e soprattutto l’essere abbinato a velocità e
follia clownesca - dev’essere apparso qualcosa di simile ad uno scherzo del destino. Sì, perché l’ascoltare/vedere un Bolt sfrecciare in quel modo irriverente e devastante, non può non aver richiamato alla
mente un duo di altrettanto furibondi personaggi
anch’essi al limite del cartoonesco. Di nome fanno
entrambi Brian; uno (Chippendale) suona la batteria
e ogni tanto urla frasi sconnesse, l’altro (Gibson)
suona il basso. Sono il duo più potente al mondo
e il nome che si scelsero ormai più di un decennio
fa non lascia spazio a dubbi: Lightning Bolt. Proprio
come è stato soprannominato quel pischello giamaicano tutto mossette e furia.
Non sono però le gesta da recordman del giamaicano a spingerci a parlare del duo americano, quanto
un’altra ghiotta occasione. Di quelle da non lasciarsi
sfuggire per offrire una riflessione di più ampio respiro sul fenomeno Lightning Bolt. È infatti appena
uscito il quinto album Earthly Delights, dopo che uno
iato quasi quinquennale dal precedente Hypermagic
Mountain aveva addensato tristi presagi sul progetto: o la dismissione (cosa peraltro smentita da una
attività live piuttosto cospicua per gli standard del
duo e dai continui side-project Mindflayer, Black
Pus e Wizardzz) o, peggio ancora, una preoccupante pausa di riflessione su una direzione musicale
talmente incompromissoria da essere sempre sul
crinale del cedimento strutturale.
Insomma, non ci meraviglieremmo se a molti di
coloro che seguono approfonditamente le vicende del duo di Providence la notizia del comeback
- dopo l’iniziale brivido entusiastico - avesse posto
dei dubbi sul cosa (e soprattutto sul come) avrebbero combinato quei due. Il rischio, in casi estremi
come questo, si sa, è che la formula mostri la corda, soprattutto nel lungo periodo. Che, cioè, partita
letteralmente a spron battuto finisca col diventare
parodia di se stessa, ripetizione standardizzata, vuota e fiacca di quello che assomiglia più a un “gesto”
che a un “suono”. È successo a mostri sacri come i
Napalm Death, perché non temere che possa accadere a due nerd della provincia americana?
Tra
matematica ed educazione
fisica
La storia dell’entità LB è ben nota ormai: l’occupazione/creazione di Fort Thunder (squat, laboratorio
DROP OUT
17
Una breve intro li mostra alla guida di una macchina
scassata e piena di peluche coloratissimi come due
nerd americani qualsiasi in fissa con la vita on the
road. Ma è una illusione, perché tempo di sistemare
ampli e batteria e parte una sarabanda di live footage - che questo è il realtà il dvd, una fotografia del
tour del 2001 inframmezzato da qualche sporadica
intervista agli amici Pink & Brown, Dan Auchenbach
e altri - da lasciare interdetti. Sì, perché specialmente dal vivo, quello dei LB è uno scontro. Estenuante.
Sfibrante. Abnorme. Sempre sul filo della tensione e
dell’eccesso di volumi e violenza sonora senza mai
finire nel parossismo o nella parodia. Non è wrestling, insomma, nonostante l’immaginario da supereroi fake possa ricordarlo, specie nelle maschere
usate da Chippendale per reggere in bocca il microfono. Quella dei LB è qualcosa che al limite rimanda
alla lotta greco-romana. È sfavillio di muscoli e lucentezza di sudore.Tanto sudore. E tanta, tantissima
energia.
C avalcando
artistico, sala prove/concerti, e solo il dio del rumore sa cos’altro) intorno alla metà dei ’90; l’esordio
proprio in quelle stanze da archeologia industriale
come trio col nomade noise Hisham Baroocha (di
lì a breve transfugo nei Black Dice); la crescente
fama extra-musicale come artisti e/o creativi sui generis che ha scoperchiato il vaso di pandora di una
nuova arte brutta made in Usa.
Prima di tutto questo, l’amicizia ormai pluridecennale tra Chippendale e Gibson nata sui banchi
del Rhode Island School Of Design (RISD); dopo,
la credibilità conquistata a squassoni basso&batteria
che ne ha fatto gli assoluti paladini del nuovo weirdnoise brutale a cavallo dei due millenni. Punto di riferimento e prisma iridescente di cacofonie “brutte”,
la coppia di fatto(ni) si sarebbe a breve dimostrata
esempio di “artista del 2.0” in grado di interagire sia
col sottobosco diy di matrice punk che coi circuiti
d’arte istituzionalizzati.
Proprio il RISD occupa una posizione fondamentale nella genesi dei LB. Da quell’ammasso di
creatività deforme che è l’istituzione arty per antonomasia del Rhode Island sono usciti personaggi
niente male (da David Byrne a Gus Van Sant, per
arrivare a - sembra - mostri come Prurient…) e
da lì prende il via quel continuo mesh-up tra arte e
18
DROP OUT
musica, vita e attitudine che ne segnerà il percorso.
Da quel contesto scolastico però i due Brian traggono anche una metafora utilissima per definire il
proprio suono e ribadire affinità e divergenze con
altri mostri sacri del rumore. Ecco cosa dichiaravano in una intervista datata in merito ai Ruins, duo
nippo-noise molto affine all’eruzione sonica del duo
americano: Se fossimo studenti della stessa classe loro
sarebbero i più bravi in matematica e noi i migliori in
educazione fisica.
Semplice, vero? Una metafora che in nemmeno
un paio di righe riassume grossomodo tutto l’universo LB. Un universo fatto sì, di rumore primordiale, di scale vorticose, di ampli fumanti e costantemente al massimo livello ma soprattutto di estrema
fisicità, di atletismo spinto, di agonismo brutale. Ed
ecco che l’accostamento iniziale con l’altro Bolt,
quello giamaicano, torna di diritto. Solo che se lì si
tratta di mettersi alla prova con se stessi, nel caso
dei due fulmini (o fulminati?) di Providence lo scontro è col mondo intero, racchiuso circolarmente
intorno a sé. Basta fare un giro su youtube o dare
uno sguardo al dvd The Power Of Salad And Milkshakes (Load, 2003) per rendersene conto. Proprio il
secondo è un documento fondamentale per farsi
una idea di chi e cosa siano questi due scotennati.
i cieli
Restii alle interviste (Non è che non ci piace essere
intervistati… semplicemente non lo cerchiamo, dichiarava tempo fa Chippendale in proposito) i due preferiscono far parlare ampli e tamburi. Annichilendo
l’ascoltatore messo egli stesso ogni volta alla prova
- che sia live o semplice ascolto casalingo - dallo
sconquasso mongoloide e selvaggio inscenato ormai da un buon decennio. Tutto nasce con Ride The
Skies, l’album del 2001 che li consegna all’attenzione
di un numero crescente di ascoltatori, anche fuori
dai confini americani. Quel monolite sfaccettato in
8 tracce però non è l’album d’esordio. Prima, molto
prima, diciamo intorno al 1997 c’era stato l’omonimo album giallo, anche conosciuto col nome di
Yellow Album o First Record. Della serie, evviva l’originalità. Eppure di originalità ce n’è eccome sepolta
sotto una coltre cacofonica da far spavento. L’impatto soprattutto, è di quelli devastanti: metal deviante suonato da hardcore freaks per una gioventù
bisognosa di distorsione e feedback che si raccoglie
devota intorno ai suoi dei in quello che è un vero
e proprio rituale pagano dedicato ai gods of thunder. L’edizione vinyl-only viene poi ristampata sempre dalla Load nel 1999 con l’aggiunta di un paio di
monstre bonus track (Zone conta ben 32 minuti di
devastazioni free-noise in modalità impro) e - seppur limitata in quanto a resa sonora - resta un ottimo punto di partenza per decodificare il fenomeno
LB. Certo, l’hi-fi non è che sia al centro dell’universo
del duo, ma il passaggio dalla registrazione casalinga
in quel di Fort Thunder ad uno studio professionale
(e soprattutto ad un ingegnere del suono come David Auchenbach) si farà sentire eccome al momento
di Ride The Skies.
L’amplified tribe of two, secondo la splendida definizione che ne da l’etichetta, spicca il volo e cavalca
letteralmente i cieli del suono rumoroso in un disco che però è anche dolorosa polaroid della fine
di un’epoca. Fort Thunder è infatti, a quell’altezza,
sull’orlo dell’esproprio. Il microcosmo weird messo
su dalla comune artistoide di Providence sta collassando e i due sembrano sfogare tutta la frustrazione
accumulata in un disco che è non solo una bomba in
quanto a violenza sonica e nitidezza di suoni, ma anche un accorato epitaffio al proprio mondo. Alcuni
brani (Force Field, St. Jacques) sono esplicite dediche
a chi ha condiviso l’esperienza dello squat, ma è l’albo nella sua interezza a porre la devastante proposta del duo sullo stesso piano delle efferatezze di
progetti made in Japan come Ruins, Zeni Geva,
Boredoms. Merito del basso di Gibson, modificato
e accordato in modalità eterodosse, capace di esprimersi quasi fosse una orchestra di rumorose corde
in scale vertiginose e assalti all’arma bianca, mentre
DROP OUT
19
il sodale Chippendale percuote pelli come un primitivo armato di clava e gorgheggia incomprensibili
nenie autistiche (la aliena The Faire Folk). La situazione personale è lì lì per degenerare, ma l’indole
cazzona dei due non perde occasione per mostrare
il proprio spirito freak e buffonesco: ascoltate Wee
Ones Parade, pezzo che per buona parte dei suoi
5 minuti gioca di sponda tra un basso che sembra
imitare una gallina scontrosa e una batteria che gli
fa il verso, prima di infilarsi nel vicolo cieco di un
maelstrom reiterato e cafonissimo.
La fase post-Fort Thunder procede poi a scatti
biennali con Wonderful Rainbow, prima e Hypermagic
Mountain, poi. Ma non si tratta di timbrare stancamente un biglietto guadagnato sul campo. Si tratta
di porre un abisso ancora più ampio tra sé e tutti
gli altri efferati calpestatori di decibel del pianeta.
Roba da bang post-atomico, fusione termonucleare
a caldo, Tetsuo deforme di mille forme di musica
estrema ma… umano all’inverosimile. Sì, perché lo
scarto - uno dei tanti possibili - risiede proprio nella materialità fisica, concreta, corporale del suono
dei due, nella sua componente ipoenergetica fatta di
muscoli, sudore, movimento ipervitaminizzato. Ipercinesi è un ottimo termine per sintetizzare il portato della band all’altezza del distico centrale della
propria produzione. Il suono si ispessisce all’infinito,
20
DROP OUT
si centuplica. Le frasi musicali si stratificano mentre
l’assalto ritmico sembra sfasarsi in contorsioni epilettiche. Su tutto, un inquietante wall of noise letteralmente annichilente e aberrante. Dracula Mountain
dal primo e 2 Morro Morro Land dal secondo sono
forse i vertici mai toccati dai LB e vette realmente
irraggiungibili per moltissimi adepti al culto del rumore.
Do
it yourself metallaro e
delizie terrestri
Nell’immaginario rutilante dei due Brian tutto rimanda al do it yourself d’ascendenza punk. L’occupazione di stabili in disuso come difesa dalla fottutissima
quiete dell’americano medio (Mat Brinkmann dixit);
l’arte fumettistica e non, fatta di riutilizzo di scarti
post-industriali come referente immaginifico o, più
spesso (come nel collettivo Forcefield) come reale riuso arty della pattumiera; lo schiaffo in faccia
delle musiche dure e prive di compromessi che diviene urlo munchiano di chi è troppo spesso senza
voce e si vede costretto ad inventarsi un megafono
che la amplifichi (in una parola, l’hardcore).
Però a ben vedere dietro la musica dei due, o
meglio dentro, c’è il metallo, anche se suonato con
la furia iconoclasta tipica degli hc kids. Strumentalmente parlando, non passano inosservate le verti-
ginose scale del basso distorto di Gibson - spesso
capace di fare il verso a Van Halen et similia - così
come i ritmi impostati dal furibondo e tentacolare
collega Chippendale sfiorano lo stomp metal, tanto
cadenzato quanto cafone e esagerato. La musica del
duo è insomma un continuo incitare all’headbanging
e alla slam dance furiosa, nello stesso modo in cui
è l’immaginario anche semplicemente discografico
(titoli e copertine, insomma) a richiamare alla mente un cartoon heavy metal. E del metal la musica
del duo mantiene in nuce una sorta di spiritualità
incompromissoria, depurata però delle sovrastrutture e degli orpelli inutili. Niente pose (rimando al
dvd perché le immagini sono più esplicative delle
parole), zero politica o denuncia sociale; solo autoironia e attitudine dissacratoria per una musica che
è etimologicamente metallo (fuso) pesante.
Riprova ne è anche l’appena uscito Earthly Delights. Sin dal distico iniziale, il comeback si immola al verbo del metallo e del rumore, dissipando i
dubbi di cui parlavamo in apertura e (ri)collocando
i due sull’olimpo delle musiche noise. Rispetto ai
brothers in arms Wolf Eyes e Black Dice - trimurti ormai storicizzata del nuovo noise a stelle e
strisce - i LB sono come si sarà capito quelli più
matericamente umani, gli unici che non ricorrono
a macchine o tecnologia per produrre le quintalate di rumore puro col quale da un decennio fanno
sanguinare le orecchie di chi li ascolta. Earthly Delights conferma, inoltre, che delle mille sottorivoluzioni cui abbiamo avuto modo di assistere in questo
scorcio di terzo millennio, i LB sono - sia rispetto
ai precursori from Providence (Landed, Arab On
Radar, i redivivi Six Finger Satellite…), che ai
mille contemporanei ed epigoni - quelli che forse
meglio hanno retto la prova del tempo. Un universo coloratissimo e in continua espansione, un buco
nero che tritura e ingloba in egual misura Slayer e
AC/DC, Ruins e Melvins, Napalm Death e Flying
Luttenbachers (ri)proponendo se stesso come
un classico delle musiche brutte e rumorose. I LB
hanno mano a mano messo a fuoco una proposta
incompromissoria e devastante che tale è rimasta
negli anni, variandola lievemente (pensiamo alle melodie che sottostanno al wall of sound dei due o alle
via via più pulita perizia sui suoni) ma non arretrando mai di un passo in quanto ad aggressività e ferocia. Drum’n’bass del paleolitico; speed-trash-metal
rinsecchito dopo essere stato lavato con l’acido
muriatico; panzer noise-math-metal out of control:
tutte queste e molte di più le possibili definizioni
valide per descriverne musiche. E tutte azzeccate.
Per forza di cose, rimangono fuori da questa trattazione alcuni aspetti dell’arte del duo. In campo
musicale, i side-project: Wizardzz (Gibson stavolta dietro le pelli con Rich Porter ai synth), Black
Pus (Chippendale in solo tra noise e spasmi free)
e Mindflayer (sempre Chippendale col fraterno
amico Mat Brinkmann in un progetto tra rumore e
immaginario fantasy) meriterebbero un discorso a
parte, se solo avessimo ulteriore spazio. Così come,
in campo più ampiamente artistico, lo meriterebbe
tutto il coinvolgimento nelle arti visive, dal fumetto
all’istallazione, all’animazione che contraddistingue
i due da Fort Thunder in poi. Basterà qui citare il
dvd Mystery Tail (Load, 2006) in cui Gibson anima
le sue creaturine Barkley’s Barnyard Critters o
le prove di Chippendale ben sintetizzate/celebrate
nella retrospettiva Wunderground: Providence, 1995
to the present (Picturebox Inc, 2006) o nella appena
conclusa mostra al Macro Future di Roma dal titolo
New York Minute (insieme, tra gli altri, a Dearraindrop, Paper Rad, Mat Brinkmann…).
Insomma, come concludere il discorso Lightning
Bolt senza apparire banali? Beh, depurando il tutto
dalle tendenze superomistiche, si potrebbe citare
Friedrich Nietzsche e il suo Zarathustra: “…Io vi insegno il Superuomo: egli è il fulmine e la demenza”. Chi
più dei Lightning Bolt rientra in questa categoria?
DROP OUT
21
Candeggina
Pop
Neverending
Summer
Una generazione di artisti under trenta riporta gli Ottanta da Ibiza
nelle camerette post-club. Synth-hypno-pop is the now loud.
- Edoardo Bridda, Marco Braggion, Stefano Pifferi
22
DROP OUT
è
dall'estate scorsa che Rolling Stone (edizione americana), Wire, Fader, Stereogum,
Blissout, e non da ultimo Pitchfork, cercano
di definire prima e diffondere poi un verbo
dai contorni conturbanti. All’inizio era un'etichetta piuttosto piatta (e non troppo aderente) come
dreamwave, successivamente avamposti in vista del
giornalismo di settore hanno diffuso hypno pop e
glo-fi e le cose hanno cominciato a girare. Al giornalista di Wire David Keenan ha risposto Simon
Reynolds assieme a migliaia di bloggers e forum in
rete: tutti a fare quadrato e ad aumentare l’hype.
Grossomodo a settembre il fenomeno è scoppiato,
innescando un’onda lunga che non sembra scendere di un millimetro neppure ora che vi scriviamo e
imponendoci pertanto la scelta di campo, anzi, d’etichetta.
Aggiudichiamoci glo-fi. La potremmo definire, se
non l’ufficiale, la più sintetica e immediata, oltre che
la più di successo (autori: i tipi di Pitchfork). Glo
sta per glow, luce soffusa da crepuscolo, calore soft
che ricorda l’estate e, nel contempo, per day-glo, il
colore fluorescente, gli ‘80.
Soggetto pulsante, oggetto della labelizzazione
e cuore della faccenda sono sonorità che hanno
nell’estate un inconfutabile minimo comune denominatore; mix fatti in casa di una generazione
specializzata in vacanze ai tropici mai fatte, pretrentenni con il numero/spada di Damocle a calargli
sulla coppa, gente senza scrupoli quando si tratta di
rivangare l’infanzia e zero problemi o conflitti con
Ottanta mai vissuti se non attraverso i bleep bleep
dei videogiochi.
In pratica il glo-fi non è una scena ma un club immaginario: la membership promette abbandono dei
sensi, Utopia onirica, un sound che più che dreamy
è hypno. E Hypno induce de facto ai sogni. Dopo il
glo c'è pure il Fi. Fi senza Lo, storico prefisso, per
distinguerlo dalla bassa fedeltà dei vari Lou Barlow,
e pure dalle camerette dei cugini più vecchi che si
sono fatti i ’90.
Ombre lunghe sulla spiaggia del ricordo estivo
DROP OUT
23
paninaro-milanese. In mezzo: gente e suoni ancora
più off, il decennio con l’8 davanti come Thule parallela; in comune la sola tecnologia in un misto di estasi ed ecstasy consumata in casa, nostalgia dell'allora
presente, e nostalgia per la nostalgia in un gioco di
specchi straniante e derivativo. (EB)
Padrini ,
ducktails
che non sono le proiezioni dei children dei Boards Of Canada, ma che ci danno la perfetta scusa per tracciare una bella demarcazione: al di qua
della linea glo i sintetici e i provetti produttori /
remissatori, al di là (dunque al di fuori di essa) gli
psichedelici e i new ager più freak amati da Wire.
Fi-ers con i sintetizzatori e Fi-ers con le chitarre.
Due generi che, fatti i dovuti distinguo per qualcuno
che li cavalca entrambi, ci permettono di dividere
altrettante tipologie e prendere le dovute distanze
sia dall'articolo apparso su Wire lo scorso agosto,
sia dal nostro approfondimento (SA59). Un ponte tra le indagini comunque c'è, e fuor di dubbio
è racchiuso nella creatura di Matthew Mondanile
aka Ducktails: l'ideale zona di confine tra gli psichedelici infatuati per l’acqua, il mare e la chillwave
(altra definizione che viaggia per la rete). Non solo.
Fa capolino pure un recentissimo progetto, i Real
Estate, il cui disco omonimo è esattamente quel
sogno estivo fi e glo e hypno di cui stiamo cercando
di darvi le coordinate. Tutte tranne una.
Questi ultimi newbies insieme a Predator Vision,
Parasails e tutti i progetti del versante Tropical
non hanno il taglio synth pop che è invece la matrice dell'intera faccenda qui narrata. Così la Real
24
DROP OUT
Estate entrata in scena per un attimo, già ci tocca
abbandonarla, come pure Julian Lynch (molto affine a Mondanile) e tanti altri tra cui il celeberrimo
James Ferraro.
Il synth è la sfaccettatura che ci porta dalle parti
degli Ottanta, pure più rovinosi e trash. Preparatevi. Dopo aver trattato l'ambient revival nell'ambito dell'elettronica targata UK, e quasi in risposta al
Wonky che spopola nelle camerette londinesi, oltre
Atlantico troviamo un movimento in rapida crescita
e in fissa per una magica intersezione: quegli 80/90
che portarono in una breve luna di miele gli Ottanta
funk-soul alle tastiere, i neonati Novanta della futura IDM e un pizzico di New Age firmata Windham
Hill d’antan. Giusto dietro l’angolo: i miti estivi della
borghesia yuppie incarnati in clip del calibro di Rio
dei Duran Duran, Club Tropicana degli Wham!, Do
You Really Want To Hurt Me dei Culture Club ricordati sullo sfondo di uno schermo con una palla gialla
che mangia pixel bianchi.
E dunque ancora sole e mare, colorazioni che iniziano ad assumere contorni più definiti: un misto di
waspness britannica che sfocia a Ibiza, isola paradigmatica più che reale, estate da dopo party, e nostalgia Pet Shop Boys (We Will Never Being Boring) e
ponti , eccezioni
A proposito di tutte le immagini con le quali vi
abbiamo fasciato la testa, ai lettori più scafati non
saranno sfuggiti i rimandi agli ultimi Animal Collective. Sacrosanto, ma se vogliamo scovare lo zio
di turno, il nome è presto detto: Ariel Pink, quel
pazzo reclutato proprio dal trio a inizio Duemila
che aveva riempito gli scaffali di ristampe di album
mai usciti alla ricerca di un mitico pop perduto.
Pink proclamava che il pop migliore era quello senza nome dalla familiarità disarmante. Affermava che
più l’ascolto era distratto e confuso e più risultava
stregante. L’autoproclamata hauntology dello striminzito genietto è la lezione che oggi i ragazzi mandano più o meno consapevolmente a memoria.Tutti
loro, come prima Ariel, s’addormentano davanti a
MTV sparandosi in uno stato R.E.M. i So Eighties e
i So Seventies del caso. La differenza è il mancato
massimalismo e l’assenza di presupposti estranei al
revival di una golden age. Pink invece aveva messo
la magia in scatola, l'aveva concettualizzata, le aveva
fatto acquistare una patina psichedelica indiretta e
dentro la lavatrice sonica ci aveva ficcato di tutto, da
Tin Pan Alley a Madonna.
Washed Out, Neon Indian, Memory Tapes,
Delorean, Föntan (in panchina per ora la riserva
svedese Boat Club e Air France), Toro Y Moi
delimitano invece il campo d’azione. I campioncini
del glo preferiscono l’utopia all’arrovello complesso
delle citazioni. Anche da queste parti le eccezioni
confermano le regole: l’ultimo dei ragazzi citati, personaggio occhialuto e stiloso, apre un ponte con il
britannicissimo e colto Bibio attraverso break di
rimandi vintage (leggi funk soul e rare groove) che
vanno oltre la mania Ottanta. Pure in quegli intarsi
però il sole picchia forte e così la nostalgia dei suoni
sentiti da piccoli che confusamente si mescolano ad
altre fonti fuori tempo massimo: Giorgio Moroder, le sigle dei cartoni, i primi Depeche Mode, il
nostrano Gazebo, la lounge dei b-movies e così via,
fino alle voci grosse degli immancabili Daft Punk e
Air, entrambi fondamentali per qualsiasi approccio
vintage ai sintetizzatori. Il tutto sotto una mostruosa lente sepia. Eppure il glo, contenute le voglie da poseurs, è una
cosa intimista fatta di combriccole e di provincia,
nerd cresciuti con le consolle che rivendicano il
past perfect e si ribellano con pastiglie fatte in casa.
Gente che non disdegna il ballo e che ama saltellare
in casa con gli amici, tra un sampling affilato pop/
kitsch e perché no, una cassa dritta che li riappacifica con il presente (EB)
D olce V ita
America e nostalgia. In due parole Washed Out.
La visione sepia tone, gli scatti con la Lomo in bassa
fedeltà, il suono balearico chilling che torna nelle camere. Voglia di vecchio, di tastierato analogico. Vedi
lo stile nelle copertine e nei video del ragazzo Ernest Greene: gente che fa cose normali come una
nuotata, gente che si sballa senza speed. Il relaxing
chimico di questi anni sul baratro (i pallidi ‘manager
nella nebbia’ degli Amari).
La crisi vista dalla parte degli slackers, di chi non si
muove se non per star tranquillo e in pace, senza
rivoluzioni, senza miti, solo buona musica per buona
compagnia. Oggetti sonori che lasci andare e non
ti accorgi che sono in loop mentale da ore. Sarà
ambient, sarà di nuovo ancora e sempre new age,
ma stavolta si aggiunge anche il battito di quelle tastierine Bontempi tipo clavietta filtrato Boards Of
Canada.
Quel beat sporco lo-fi che lo digerisci a qualunque
ora. Non servono le luci stroboscopiche e i laser,
qui è tutto senza mediazioni. Cose di pancia da picnic countryside americano; scampagnate di provincia che fanno scena e bisboccia di classe. Ernest sta
nell’angolo, schivo, il bravo ragazzo senza cresta, col
taglio di capelli appena rifilato dal barbiere di fiducia,
col Mac e con la tastierina a due ottave che suona
sui palchi nascosti della grande mela. Aggiungici la
cravattina stretta, il maglioncino col collo a V e anche le mamme son contente.
La sua linea la professa già dal primo EP: Life Of Leisure (Mexican Summer, agosto 2009). Dolce vita per
lui e per i suoi amici che si immergono in acque fatte di funk ciccione (l’intro di Lately è l’omaggio nascosto ai Daft Punk) ma sempre con quelle vocals
in riverbero infinito, segno di grandi spazi ma anche
di presa distanza dal mondo. In più ci sono l’obbligatoria new wave (Hold Out), i rimandi agli ‘80 del pop
da classifica britannico (gli Wham! in Get Up e le
discotechine in You’ll See It) ma anche ai salotti della
lounge da pulp movie (Feel It All Around). Come in
una grande visione dall’alto il ragazzo ci vede giusto
DROP OUT
25
e non si preoccupa del successo, tanto che riporta
poi su nastro altre considerazioni, le chiacchiere del
dopo barbecue, magari sorseggiando qualche Bud. Il
nastro (sì, proprio la cassetta) in questione è High
Times.
Come sopra, il titolo è già estetica. High Times nel
senso di sballo, ma anche di fuga estemporanea dal
qui e ora. Temporalmente si viaggia negli ‘80 synthetici à la Comanchero(Olivia), nelle brughiere new age
dell’ambient targata Warp (Clap Intro) e nell’appartenenza a una generazione post-Beloved (Belong)
che non si può aspettare più nulla e che ha come
unico scopo lo sballo. Una rivisitazione in chiave 00
dell’estetica balearica e del disco-funk (vedi la citazione all’Incredible Bongo Band in Yeah). Lo sgami subito che il ragazzo è americano. Il funk ce l'ha
nel DNA. Prima parte dalla città natale Philly, poi
approda al sogno mentale delle isole ispaniche.
Il suo è il ritmo che movimenta il passaggio dal ban-
con gli ultra citati Boards Of Canada. Chaz in tutte
le sue incarnazioni fa da spola tra le avenues della
grande mela e l'elaborazione sintetica europea targata Daft (il funk ibizenco di Low Shoulder), il bbreaking hop che si intrufola nello space surf estivo di
Wilson e compagnia bella (Fax Shadows). Il compromesso tra melodia e ritmo che punta al beat in slomotion e che ricorda gli eroi del soul chic in falsetto
Bee Gees (You Hid).
Toro Y Moi è poi anche un'esperienza che viene
narrata sul blog Toroymoi.blogspot.com con i soliti
link ai video cool, alle foto e ai ricordi della scuola
di graphic design. Un bel tipetto, questo Chaz, che
promette già di avere materiale sufficiente a stampare un secondo album nel corso del 2010 e che fa
il verso al pargoletto di casa Warp Bibio. Il quattro
hip-hop ben piantato in testa, le forbicine da sartoproducer taglia e cuci e gli accenni al funk. Sta a
vedere che non lo chiamino da Londra... (MB)
cone del bar alla sdraio. Generazione senza spina
dorsale? I nuovi smidollati (al plurale, perché Ernest
è spalleggiato dal già citato amico Chaz Bundick
in arte Toro Y Moi) sono modellati dalle droghine
da cameretta in un pongo che ha la maschera di
Aphex Twin truccato American Dream. Dietro ai
sorrisi vedi quindi la mutazione di un sentire 2.0
che ha nuovi eroi e nuove modalità di scambiare
esperienza (musicale e non solo). Le visioni citazionistiche dal passato sono pezzetti di memoria che
dura un attimo, gettoni per l’autoscontro che non
ricordi ma su cui vuoi riprovare a salire. Più che documentare, il ragazzo ‘fa sound’. E per ricordartelo,
come la droga, devi rimandarlo in play. Addicted to
rhythm (MB)
You S hould B e D ancing
with
M oi
Come abbiamo appena visto, Chaz è un grande amico di Ernest. Il sound dei due si situa sulla stessa
I ndiano
Toro Y moi
washed put
26
DROP OUT
linea stilistica, ma il Toro prende un sentiero che
non punta solo sulla melodia, anzi ci va di ritmo.
Il ventitreenne della South Carolina ha un passato
newyorchese che lo connette a gruppi più blasonati
(Animal Collective, Flaming Lips e inevitabilmente Ariel Pink) e gli permette di allargare le vedute di
provincia del vicino.
La sua produzione si accosta inizialmente a quella
di Washed Out: un nastro su Mirror Universe (Body
Angles) e un remix del mini-inno Feel It All Around.
Passa ben presto al vinile con il singolo Blessa / 109
che preannuncia l'album Causers Of This in uscita a
febbraio 2010 su Carpark, ma già disponibile sui fidati siti di downloading. Blessa è l'America che incontra le sonorità 4AD passando per il breaking
slavato di J Dilla. 109 è il lato B: il ricordo che si
spinge fino ai ‘60 di motowniana memoria, ci infila
dentro delle Les Paul da surf e il gioco è fatto. I due
estremi che si incontrano sulla supernova del ritmo
e che per questo aprono le porte a un mix che va
oltre i riferimenti ‘80.
Il ragazzo non si accontenta poi del moniker glo-fi
e si reinventa dancefloor con il progetto Les Sins.
Andate a vedere il suo myspace e vi accorgerete
che la rete dei rimandi è fitta e non si risolve solo
al neon
Alan Palomo è il suono delle estati del Texas riportato a Brooklyn. Lui è l’Aphex Twin della situazione. Produzione in camera, chili di nostalgia,
qualche lacrimuccia, i suoni dell’Atari e vai di culto.
Tradotto in disco: Psychic Chasms, appunto. Abissi psichici, nel senso di ricordi che vengono fuori
direttamente dai suoni in un’aura pop diversificata
nella proposta: reggae à la Attenti al lupo - sì, il Lucio
Dalla trashpop - in Laughing Gas, il ricordo Darkel
(Terminally Chill), il pop da balera con gli echi wave
(Should Have Taken Acid With You) e tanto per sbordare un po’ di bbreaking (Ephemeral Artery).
L’eredità del padre Jorge, una specie di pop star
messicana della fine Settanta viene fuori nelle tecniche del figlio, che esplora l’antico e lo riporta in una
dimensione di sogno elettronico. Quello che fa Alan
è un po’ il background che accomuna l’intera scena
glo. Suonini campionati dai videogames dell’epoca,
un po’ di arpeggi italo, coretti in background lounge,
un approccio che a qualcuno potrebbe ricordare i
Daft Punk un po’ slavati, senza mordente dancefloor. Il tutto viene poi ripassato su nastri rallentati o
velocizzati, il trucchetto (grazie anche alle mitiche
tastiere Korg) infonde l’aura di magico e di onirico
che già il Beck d’antan aveva ripescato per il suo
ripensamento del blues.
L’old-school si riprende tutto lo spazio che può e ci
innesta pure un buon quantitativo di droghe. Perché
se già dai titoli capiamo che qualcosa scorre nelle
vene e nei neuroni, è proprio questo perdersi in una
DROP OUT
27
N astri
dimensione broadcastiana (e prima stereolabiana)
che dà al suo viaggio lo status underground di coolness garantita. L’origine messicana del ragazzo, collegata alle insalate di funghi e peyote chiude il cerchio.
Non c’è però spocchia poshy. C’è l’improvviso successo decretato da critici over 30 che rivedono in
questo teen il sogno degli anni ormai andati, dei club
e delle paillettes su spalline oltremodo vistose e su
qualche paio di Levi’s 501 troppo stretti. C’è la non
consapevolezza che il suono di oggi è quello di ieri
proiettato phuture. Un po’ come il revival ‘90 che
Crookers e compagnia bella stanno sparando nel
fidgeting. Qui la base di partenza sono gli ‘80 sprofondati in qualche bel divano. Stupid (?) Dance Music
per il nuovo Richard D. James glo. (MB)
28
DROP OUT
e memoria
Dayve Hawk ha il suo ‘giro giusto’ nel New Jersey,
stato-provincia del più vicino e blasonato New York.
In poco tempo ha sfornato un EP (Call & Response) come Memory Cassette, si fa chiamare anche
Weird Tapes e poi rimescola i due nomi nell’LP
a nome Memory Tapes (Seek Magic). Un modo
per scartare i fan e per rinnovare una proposta che
scava inevitabilmente nel passato. L’ex frontman del
gruppo post punk Hail Social si rivela essere il più
maturo dei ragazzi glo.
Non ancora trentenne è già papà di una bambina di
quattro anni, non ha un cellulare e nemmeno l’auto.
Se gli chiedi come fa a muoversi ti risponde che non
gira poi così tanto. Si accontenta di stare a casa e
di passare il tempo con la pupa. Un bradipo? Non
si direbbe, dato che ha remixato pezzi per Yeah
Yeah Yeahs, Peter Bjorn and John, Britney Spears
e ha ricevuto pure una proposta dai Major Lazer e
dalla label di Michael Jackson per un remix del re
del pop. Questa maturità indie e un po’ eremitica
si traduce nel ritmo quadrato del singolone estivo
Bicycle con gli archi per Robert Smith, nell’ostinato
quattro che scandisce il tempo e che fa gola a James
Murphy (Stop Talking), nei rimandi a Elizabeth Fraser
(che - dice lui - lo aveva contattato tempo fa per una
collaborazione) e nei suoni in remember 4AD.
La voce androgina, filtrata in stile Flaming Lips, trapassata dal fantasma Police e dai Pink Floyd pastorali
(nella lunghissima coda Treeship) è il suo biglietto da
visita. Ingrediente che si riverbera con tastierine e
field sounds come in qualche vecchia polaroid sbiadita. Quel vedo/non vedo che affascina e infonde l’aura
magica del ricordo attualizzato. Il diario dell’americano
non è comunque critica storica. Visto che siamo nel
mondo del pop, viviamo l’attimo e basta, ricordiamo
dettagli riciclabili e dopo un attimo dimentichiamo.
Con lo stereo in loop ci si accorge infine che la ‘lofiness’ di Memory Tapes è in sordina rispetto agli
altri personaggi chillwave. Sarà una piccola sfaccettatura, sarà che gli echi di Geogaddi si mescolano alle
chitarre pulite dei New Order, comunque quello
che esce dagli speaker è un afflato più vicino alla pulizia, una cosa che puoi addirittura pensare di ballare.
Il paparino dai molteplici nomi preferisce la pulizia
(poco) mascherata da sporcizia.Volente o nolente si
fa quindi portavoce di una sensibilità da dancefloor
‘adult’ che con il suo full lenght raggiunge una maturità inattesa. Aspettiamo entro la fine di questo
2009 una conferma (/smentita) negli annunciati due
(!) lavori in uscita... (MB)
Fontän
S vezia
lisergica
La new age di Andreas Vollenweider mescolata con le progressioni kraut del dopo Lindstrøm.
Se ci aggiungi poi gli effettacci dei Pink Floyd cadi
sul territorio dei Fontän. Molta Windham Hill. Ricordate? L’etichetta che nei ‘90 riuniva il gotha chill
mondiale: quando c’era la new age la gente si prendeva sul serio e partiva con dei trip per la via della
seta (Kitaro) o si innamorava di tutto quello che
era indiano: il tantra, lo yoga, il Tibet (Mark Isham)
e altre infinite suggestioni. Metteteci il motore dalla
Germania, i filtri a scomparsa multipla (che sì, son
sempre ereditati dal cavaliere in seta bianca Moroder) e allora vi potete autoinvitare a mangiare salmone per cena dagli svedesi Jesper Jarold e Johan
Melin.
I Can e Ibiza in testa per i due ragazzi alle prese con
un suono congelato nel passato (il titolo del disco
è Winterwhila, che sta per ‘ibernazione invernale’)
ma pieno di vita con la miccia pronta a far esplodere progressioni space-disco à la Alan Parsons.
Un pantalone a zampa, un organetto, qualche beat
e i giovani del nuovo surf sono qua. Parola d’ordine
chillwave psych-robotica. La leggenda narra che i due
casalinghi abbiano editato tutto l’album nel magazzino della nonna. Sembra di vederli là, nella capanna in
mezzo alla neve a scaldarsi con qualche sigarettina +,
a registrare takes e consumare i vinili della collezione dello zio strafatto di ambient.
La chillwave è una corrente anticiclonica che li lega
alle Baleari, ma che col ghiaccio che li circonda ti fa
veder pure l’aurora boreale. E allora per scaldarti
non puoi non invocare i movimenti delle macchine
umanoidi ‘80, il funk bianco (il basso degli Spandau
Ballet in ...You Too), i demoni degli Happy Mondays, le tastierine a 8 bit e Super Mario sgranato a
16 colori. Un sentire decisamente più suonato e live
rispetto ai cugini americani traduce il sogno in una
DROP OUT
29
O uter E ighties
delorean
visione ‘70 (i Goblin in Neanderthaler) e ‘80 (i Japan
di Sylvian in The Bridge) che non contempla passivamente il tempo che fu, ma che ha al suo interno
delle coordinate progressive in caduta libera per far
muovere la gente sotto il palco.
Un’estetica al limite tra rock e contemplazione,
Syd Barrett che viaggia a braccetto con Morricone
(Nightrider), il tutto attualizzato dal fantasma Eskimo
(Lindstrøm e Prins Thomas in primis). L’agenzia spaziale di viaggi Fontän ci dà il benvenuto per un’andata ritorno Ibiza-Göteborg. Alla cabina di pilotaggio
ci sono due robot pronti a farci dirottare sul lato
oscuro della luna. (MB)
A yrton S enna I s R iding A
D elorean
Se fin qui avevamo sentito l’assenza di un effluvio
p-funk, ecco che spuntano i Delorean. Il combo
barcellonense fleshato dalle prove tropical psych
di El Guincho aggiunge alla proposta oltre all’ingombrante eredità di Rapture e !!!, il camp targato
Patrick Wolf, le tastierine spastiche ereditate dal
bbreaking ‘90, la wave danzereccio-minimal e il sentire ‘estivo’ di Panda Bear e Todd Terje. Il documento sonoro su cui possiamo mettere le orecchie
30
DROP OUT
per ora è l’Ayrton Senna EP (oltre a qualche remix
per Glasser, Franz Ferdinand, The XX, Teenagers e
altre briciole sonore), uscito a maggio 2009. Pubblicato dalla Fool House, la label dei dancebloggers
francesini Fluo Kids, il disco è un perfetto mix di
rock wave mutato house in 25 minuti.
Il dancefloor si illumina di un sole che non ha nessuna intenzione di spegnersi e il suono del quartetto
è la carta da giocare nelle piste affollate da giovani
che non osano più il pogo post-techno dei Justice. Il
pubblico dei Delorean è quindi il distillato electropop stanco delle chitarre degli Strokes ma sempre e
comunque concentrato sulle vetrine. L’accostamento cui probabilmente aspirano è ai Beach Boys. Ma di
mezzo ci sono stati i Wavves, il fidget e molto altro.
Le senti tutte queste contaminazioni 00 nel singolo
Seasun con quel ritornello che è già anthem e che
mima la Kids di MGMTiana memoria. Se poi la riascolti nella versione di John Talabot ti vengono i brividi da spiaggia ibizenca. Per chiudere degnamente ti
rilassi con le tastierine ‘90 e gli echi degli archi disco
di Big Dipper e stai lì a prenderti il sole anche se non
c’è. Babe, if you want to we could run away up into the
sun / But we would only fade from black to black. (MB)
Prendiamo un bel respiro e facciamo una pausa. Saltiamo di nuovo il fosso della delimitazione che sta
all’origine di Candeggina Pop e ritorniamo dalle parti di “quelli con le chitarre”.
I più si staranno chiedendo quale senso abbia ritornare su quel tropical sound approfondito non più tardi di un paio di mesi fa, soprattutto alla luce di un suo ipotetico, teorico sviluppo laterale (o speculare,
dipende da dove lo si guardi). Ci si torna perché il fenomeno non sembra essersi fermato, anzi è in
grande fermento. Partiamo dal capostipite Matt Mondanile aka Ducktails che ha appena pubblicato
il suo disco migliore Landscapes; mentre nello stesso tempo ha portato all’esordio - dopo qualche 7”
e cassetta d’ordinanza - il progetto Real Estate, vero e proprio supergruppo di cui fanno parte (più
o meno marginalmente) Alex Bleeker e Julian Lynch. Quest’ultimo da tradizione bedroom-pop hero
ha esordito in solo con Orange You Glad per Olde English Spelling Bee (marchio anche di Landscapes),
mentre il primo è in procinto di farlo col progetto Alex Bleeker & The Freaks, sempre su Underwater Peoples; ideale spiaggia (è il caso di dirlo) su cui naufragano un po’ tutti i protagonisti qui
elencati.
Metteteci anche che l’omonimo non è l’unico disco in uscita in questo periodo per Real Estate (sta
per essere pubblicato il 12” Reality per Mexican Summer, casa anche di Washed Out - e magicamente
tutto torna) e che, nel frattempo, le gemme sparse nella compila Summertime Showcase hanno cominciato a germogliare mostrando ottimi frutti (su tutti Frat Dad e Family Portrait con 7” in arrivo)
e capirete il perché di questa postilla. Diciamo che siamo al livello dell’attualizzazione del presente, in
questo (sotto)mercato onnivoro e inarrestabile.
Nomi diversi, seppur di poco, per proposte diverse, seppur di poco. Eppure se le si unisse come i
puntini di uno di quei giochini della settimana enigmistica avremmo un microcosmo interessantissimo
e frastagliato. Prendiamo Real Estate e Julian Lynch. Affini lo sono, visto che il secondo suona spesso coi primi che, a loro volta, lo considerano una delle loro influenze principali. Ma ad ascoltare Real
Estate e Orange You Glad non è che ci si ritrovi proprio sullo stesso piano. RE è pop sixties sotto valium,
forma canzone + melodia compressa come se provenisse dal fondo del mare; Lynch un caleidoscopio
freak che del pop mantiene strutture e accessibilità. Inserirli sotto la cappella del hypnagogic pop made
in Keenan non è affatto sbagliato, a patto che si consideri la definizione non tanto come un suono
specifico, bensì come un feeling, un immaginario rievocabile “a mente”. La linea di demarcazione di cui
sopra - fi-ers con synth vs fi-ers con chitarre - perde un po’ della sua nettezza. A riprova di ciò, il fatto
che proprio l’iniziatore di questa “riflessione catalogatoria” inserisca nel calderone progetti molto diversi come Oneohtrix Point Never e Zola Jesus, Pocahaunted e Emeralds arrivando a mostri
sacri della merda-music più oscura e carbonara come James Ferraro & Spencer Clark aka Skaters
e mille altri nomi ancora (Lamborghini Crystal e Vodka Soap i più significativi).
Non è dunque il suono in sé ma la “memoria offuscata” o “nostalgia artificiale” il tratto unificante.
Le musiche degli hypnagogici sono proprio questo: il ricordo di un ricordo, modificato, deviato, scontornato dal suo contesto, come derivante da un dormiveglia continuo e cosciente che crea spesso
cortocircuiti assurdi che nemmeno il bastard-pop: ascoltatevi a proposito Green River dall’omonimo di
Real Estate e ditemi se non vi torna in mente Il Cielo È Sempre Più Blu di Rino Gaetano.
Fermiamoci. Altrimenti i cerchi concentrici che si aprirebbero ci farebbero perdere di vista il punto
focale della postilla: se nella fluviale indagine di Keenan è stato facile perdersi in mille e più rivoli, nella
nostra una linea comune c’è ed è piuttosto evidente. È quella di un immaginario da spiaggia in bassa
risoluzione, immagini sfocate e lampade bubble da hippie fuori tempo massimo. (SP)
DROP OUT
31
Recensioni::::dicembre::
►►►►
2020 Soundsystem - Falling (2020
Vision, Novembre 2009)
G enere : electro suonata
Quando l’elettronica si pulisce e si pompa con i
compressori da floor vai sul sicuro e sai che puoi
aspettarti il suono duro che ti trapassa fino all’alba.
La nuova fatica di Ralph Lawson (ex DJ al Back To
Basics di Leeds), Danny 'Dubble D' Ward, Fernando
Pulichino e Julian Sanza (questi ultimi due argentini
ex Silver City importati UK) è un buon compromesso tra le stanze
plastiche dei Gus Gus
e l’energia rock-based
dei redivivi Depeche
Mode.
Un’elettronica che non
spinge troppo sul tempo
e che si avvicina alle modalità compositive dei New
Order puntando però su una coerenza deep che
ama e coccola il suono caldo. Le svisate tagliagola
prog di Bisco, il clubbismo wave F Communications
di Falling, i rimandi funk 80 di Satellite, la wave postStone Roses di Closure e in definitiva un suono che
sta in piedi da solo, ci portano egregiamente from
disco to disco. Suonabilissimo da cima a fondo, il
disco ha però solo un apice che potrebbe sbancare
(Everytime guardacaso richiama la minimal di Circlesquare). Li aspettiamo di nuovo sui palchi del
Sonar.(6.5/10)
Marco Braggion
3 Shades - Thank God For Beatniks
(Alien Transistor, Ottobre 2009)
G enere : psichedelia lo - fi
Thank God For Beatniks è un disco di confine. In bilico tra il “non del tutto riuscito” e il “più che
sufficiente”. E pazienza se tra i crediti c'è gente che
in vita è stata capace di scrivere pagine importanti
dell'indie e dell'elettronica contaminata come Carl
Oesterhelt (Carlo Fashion, F.S.K., MS John Soda,
Tied & Tickled Trio), Ivica Vukelic (Die Regierung,
Ligthnin' Ivi), Markus Acher (The Notwist, Tied
32
recensioni
& Tickled Trio, Village of Savoonga, Lali Puna,
13 & God) e Micha Acher (The Notwist, Tied &
Tickled Trio, MS John Soda).
Mood minimale e lo-fi per questo ennesimo progetto collaterale degli elettronici dutch; suono adagiato
su una base di chitarre, organo, glockenspiel, basso, batteria; aspirazioni che sfiorano concettualità
kraut, ipnosi da bar sport, hip-hop elettroacustico,
psichedelia scassata. Come dei Pavement blues
traviati dalle tastierine dei nostri Father Murphy
(Tiny Beats Of Terrible), certi Whitest Boy Alive
sgualciti e poco glamour (Thank God For Beatniks),
dei Notwist gangsta senza rivoltelle (Subsequently,
alla voce Fat Jon). Materiale che si diverte a disegnare nuovi orizzonti tra i generi (e questo è bene)
ma che nel contempo non riesce sempre ad ottenere risultati all'altezza delle “esplorazioni” promesse
sul sito dell'etichetta (e questo è male).
Piacciono soprattutto El Topo, Bombay Can e la già
citata Tiny Beats Of Terrible, la prima un blues desolato mixato a ottoni malinconici, la seconda una cavalcata innaturale sul terreno accidentato del rock
tedesco che tutti conosciamo. Il resto però, è per
lo meno opinabile.(6.4/10)
highlight
Aidoru - Songs Canzoni – Landscapes Paesaggi (Trovarobato,
Dicembre 2009)
G enere : art post post - rock
Quarto album in studio per i cesenati Aidoru, ensemble rock e non solo, le cui esperienze si
sono da sempre contaminate con il teatro e le arti performative.
Songs canzoni - Landscapes Paesaggi raccoglie cinque anni di lavori dei quattro membri del
gruppo, suggestioni esclusivamente strumentali questa volta, fatte di frammenti sonori. Frammenti di paesaggio, per meglio dire, in un disco diviso in due parti: Songs
canzoni comprende, come sempre, strutture atipiche e non canoniche
della forma canzone, evoluzioni che dal post-rock alla contemporanea
all’art rock al jazz e all’improvvisazione contribuiscono a formare la
cifra stilistica degli Aidoru, che tende perlopiù alla sottrazione in questo ultimo album.
In Landscapes Paesaggi le trame si fanno ancor più rarefatte e accompagnano musicalmente l’evocazione di paesaggi naturali e urbani. Una
serie di induzioni che tra rumori, timbri e soprattutto silenzi, fanno
procedere togliendo e scarnificando; il risultato è suggestivo, segnando un’ulteriore evoluzione
della band, che si fa più minimale, ma non meno espressiva, anzi. L’emotività resta sempre infatti
il suo tratto distintivo, per una musica mai fredda e distaccata. Una colonna sonora di stati emozionali profondi.(7.4/10)
Teresa Greco
Fabrizio Zampighi
50 Cent - Before I Self Destruct
(Interscope Records, Novembre
2009)
G enere : gangsta rap
Che dire del quarto disco di 50 Cent? Che prima
di autodistruggersi, Curtis Jackson ci tiene a dare
un'ultima succhiata alla mammella del gangsta rap
versione Duemila. Che si rimpiange l'ultimo Eminem. Che le basi sono così fiacche (con l'eccezione
di Death To Enemies, firmata da Dr. Dre e Mark
Batson) da fare sembrare il film allegato al disco
qualcosa di eccitante. Che John Cena - e non è
solo una battuta - rappa meglio.
(4/10)
Gabriele Marino
AGF - Einzelkämpfer (AGF
Production, Novembre 2009)
G enere : elettronica avant
Sesto album solista per Antye Greie meglio nota
ai più come AGF. A dispetto della recente produzione, per il nuovo lavoro solista prosegue lungo la
traiettoria tracciata da Words Are Missing, ovvero concentrarsi soprattutto sul suono della voce
e delle parole. Il taglio delle composizioni non potrebbe essere più avantgarde nel senso proprio di
immaginare nuovi ambienti sonori in un’ottica di
sperimentalismo puro. Si perde così per strada gran
parte della ritmica.
Quando appaiono i beat non sono mai per muovere
ritmo, quanto piuttosto parte dell’arredo di scena,
dettagli in un mare magnum amniotico e stordente.
Detto che Einzelkämpfer sta letteralmente per
“Guerriero Solitario”, quello di cui l'album difetta
è essenzialmente il suo concept stesso (nonché il
modo di sviscerarlo). Composizioni astratte e severe come Her Beauty Kills Me, non aggiungono niente
a quanto detto fin’ora, e in più non si giovano di
alcuna forma di comunicatività, chiuse come sono in
un profilo algido e intoccabile. Gran parte del disco
va preso in questo modo. Un monolito androide
che guardi di profilo senza mai riuscire ad entrarci.
Quello che ad AGF riusciva brillantemente nel precedente lavoro, qui si perde per strada, come una
foto che non riesci mai a mettere a fuoco. Un lavoro
interessante come al solito, ma per l’appunto fuori
recensioni
33
fuoco, soprattutto nelle ipotesi post Bjork di Worin
Mein Mund Zur Bewegung Fand e Alone In The Woods
(The Fox, The Skunk And The Rabbit), o nelle le geometrie congelate model Zavoloka di A Poem. Per la
cronaca è il primo disco registrato dopo il trasferimento in Finlandia con il compagno Vladislav Delay… si aspettano nuovi sviluppi nel perenne trip
sperimentalista dell’artista teutonica.(6/10)
Antonello Comunale
Alessandro Magnanini - Somewhat
Still I Do (Schema Records,
Novembre 2009)
G enere : jazz
Che gli italiani siano dentro al jazz è cosa nota. Rava,
Bollani, Fresu, Conte (sia Nicola che Paolo) e compagnia bella hanno riportato il mondo (e l’America)
a considerare il Bel Paese come uno dei punti di
riferimento per il linguaggio black per eccellenza.
Non è da meno il disco d’esordio di Alessandro
Magnanini: chitarrista, arrangiatore e direttore di
quella Duke Orchestra che ha decretato il successo
di Mario Biondi.
L’emiliano si avvale qui della complicità di un roaster di tutto rispetto: le voci di Jenny B (stupenda
nella bossa So Long, Goodbye) e Liam McKahey (il
cantante dei Cousteau in gran spolvero nella ballad Livin’ My Life). In più il cameo della meravigliosa
Rosalia De Souza che canta in italiano lo slow
brasileiro à la Astrud Gilberto (L’estate è qua singolone da pelle d’oca) e la partecipazione di Stefania
Rava e Renata Tosi (direttamente per un remix
su F Communication lo swing uptempo di Stay Into
My Life).
In più tanto per far quadrare il cerchio la base musicale di un gruppo ultrapremiato come l’High Five
Quintet. Che dire di più? Qui si sente come ci sia
ancora un enorme spazio per il jazz popular (nella
miglior accezione del termine) di classe. Canzoni
che dopo un’istante sai già fischiettare, sulle orme
di Mancini, Morricone (Suddenly...) e della tradizione
brasiliana. Dopo This Is What You Are Alessandro ha
fatto il botto e ora è pronto a farsi riconoscere.
Seguitelo, non vi deluderà.(7.2/10)
Marco Braggion
Amolvacy - A La Lu La (Ultramarine,
Novembre 2009)
G enere : avant impro
Il trio che muove le fila del progetto Amolvacy è di
quelli di origine controllata.Tutta gente con un certo
34
recensioni
pedigree nel settore, a partire da Aaron Moore dei
Volcano The Bear, che per l’occasione si accompagna a Dave Ness della No Neck Blues Band e
Sheila Donavan dei Laboratory Theater Company. Questo licenziato per l’italianissima etichetta
Ultramarine è il secondo parto della compagine. Il
centro del discorso è una partitura strumentale che
poggia le sue fondamenta su una base percussiva
ispida e creativa, arrivando anche a mimare battiti e
tremolii, con strumenti e voci.
Siamo in un territorio che per forza di cose arriva
a tratti a collidere con il
Beefhart più obliquo e
anfetaminico (Beat Of The
Drum) o il Moondog più
naive e visionario (On
Top Of Unknownille), tutto
ovviamente calato in una
tenebra esotica alla Volcano The Bear su cui la
mano di Moore si muove sicura come un alchimista che sa quali sostanza
miscelare nei suoi alambicchi. L’altro protagonista
dell’operazione sta poi nelle parti vocali di Sheila
Donovan, sorta di incrocio tra Yoshimi e Lydia
Luch, che riesce al tempo stesso a farsi cartoon
isterico (Ho-Ho-Kus) e suffragetta no wave con assorbente chiodato (Lula, Vehicular Bitterness).
Non meno interessante poi tutto l’assunto base del
disco, che prendendo le mosse dalle parole riportate sul retro ad opera di Jose da Fonseca e Pedro Carolino, autori portoghesi che nel 1855 scrissero un
libro di prose in inglese intitolato “English As She
Is Spoke”, pur non conoscendo una parola di inglese. Da qui e da una riflessione sul ruolo del suono e
della musica nella comunicazione nello scambio primordiale tra linguaggi diversi e inintelligibili il titolo
ironico-dadaista di A La Lu La.(7.3/10)
Antonello Comunale
Ancestors - Of Sound Mind (Tee
Pee, Novembre 2009)
G enere : prog stoner - rock
Il comeback del quintetto californiano allarga il
respiro e mostra la voglia di sviluppare trame più
complesse rispetto all’esordio Neptune With
Fire. Nelle otto tracce, Of Sound Mind alterna brevi
sketches, semi-interludi, momenti di rilascio (From
Nothing),malinconiche reiterazioni pianistiche (Not
The Last Return) borbottii di synth e drones a fluttuare liberi (A Friend) e epocali e stakanovistiche
dilatazioni prog-psych-metal dal minutaggio esoso
(ben 4 pezzi girano intorno al quarto d’ora) .
Proprio qui risiede il pregio maggiore dell’album: le
aperture, come in Mother Animal (dall’iniziale pantano stoner agli umori hard-rock sixties) o Bounty
Of Age (dai Pink Floyd ai Neurosis passando per
King Crimson e Goblin) e soprattutto i continui,
ben piazzati ponti interni ai pezzi stessi, configurano
le canzoni come vere e proprie suite attualizzanti il concetto di “heavy-psych rock” tra infiltrazioni doom, sludge, stoner, prog e hard-rock. A volte
il risultato è eccessivamente prolisso, anche se un
brano catastrofico e ancestrale, mefitico e angelico, liquido e acido come The Trial fa correre brividi
lungo la schiena. Eppure la sensazione generale è
di un lavoro autoreferenziale o da iniziati, rivolto
cioè a chi il macro-genere di cui sopra lo mastica a
fondo.(6.8/10)
Stefano Pifferi
Andrea Belfi/Machinefabriek Pulses & places (Korm Plastics,
Settembre 2009)
G enere : D rums & D rones
Impulsi e radar, macchine e materie: questo l'intruglio sinestetico di Andrea Belfi con Machinefabriek.
C'era una volta la psicoacustica, sorta di sistema
immaginario della percezione; in “Pulses & Places” c'è psicosintesi, evoluzione sintetica del piano
mentale, immaginario prodotto da spazzole, radiofrequenze misteriche, contatto percussivo.
Rutger Zuydervelt ed Andrea Belfi si dividono i piani: scorribande dronico-ammalianti il primo,
processi ritmico-spezzettati il secondo. Quattro
traccie per tanti varchi, finestre aperte, nascondigli dove i suoni restano illesi, fisicamente accessibili,
liberi di sedurre. Le trame diventano ondate monolitiche di segnali morse, monogrammi leggiadri,
scenari filmici.
Addirittura in “Pulses & places 4” l'organo accenna
un iniziale motivetto melodico e la musica si sposta su atmosfere nostalgiche fatte per accarezzare e
meravigliare. Per chi ha amato “Knots”, questo duo
ne rappresenta un'evoluzione tangibile, perché prolunga grazie a Machinefabriek, tutto ciò che d'involuto e vuoto si registrava in quel brano solitario del
Belfi. Un buon connubio tra post-rock progressivo,
dronica-leggera ed elettronica emotiva.(7.2/10)
Salvatore Borrelli
Andrea Salvini - Senza paura (The
Lads Productions, Novembre 2009)
G enere : easy listening
Andrea Salvini sta' a metà strada tra la musica
di Barry White - e di conseguenza del suo più
prossimo emulo, Mario Biondi - e certo crooning
traviato dal jazz, canzone d'autore e funk, easy listening e melodia. In una terra di mezzo che è un
equilibrio precario, vista la pericolosa vicinanza con
certi ambienti mainstream in cui sguazzano i furbetti
del quartierino, ma anche un piccolo rifugio affidato
alla sensibilità di ogni musicista. Fuor di metafora:
se sei uno che sceglie la qualità a discapito dell'ammiccamento facile, c'è anche modo di realizzare un
buon prodotto.
Salvini ha la fortuna di possedere una voce che non
ricalca i modelli citati e una cifra artistica che, salvo qualche caduta di tono, osa qualcosina in più: se
in Pesche e Tulipani c'è fin troppa “canzone italiana”,
se in Mat Sicuri siamo quasi dalle parti di Love Is
In The Air, se nella title
track vengono in mente
i Dirotta su Cuba, nello scat di Oscar si coglie
invece qualche rimembranza Bryter Layter - per
lo meno negli arrangiamenti -, in Non chiedetemi
si respira un jazz fumoso
e affascinante, in Mariposa si gioca con ritmi centroamericani eleganti ricorrendo pure alla steel guitar.
Quando ci si sposta di qualche centimetro dalle coordinate easy che dovrebbero solleticare il giro delle radio commerciali, si ottengono i risultati migliori, nell'ottica di un prodotto che rimane comunque
legato a un interplay virtuoso tra pianoforte, basso,
batteria e ottoni.
(6.4/10)
Fabrizio Zampighi
Apse - Climb Up (ATP Recordings,
Ottobre 2009)
G enere : indie pop
L’effetto è a dir poco straniante, tanto che ci si ritrova spesso a guardare nomi e copertina, note e rimandi online per comprendere se questi Apse sono
“quegli” Apse. Per capire come sia possibile che il
gruppo che nemmeno 3 anni fa distribuì, prima in
solitaria, poi con l’appoggio nientemeno che della
ATP, lo splendido Spirit sia lo stesso dietro questo
Climb Up.
recensioni
35
L’esordio era infatti un album wavish che riesumava sentori da trance-rock californiana piegandoli di
volta in volta agli stilemi della wave, del post-punk,
financo del post-rock più dilatato e dreaming. Ma
sempre virando quelle
sensazioni al nero. Ora
il comeback, sempre per
ATP, spiazza completamente perché sembra una accozzaglia non
troppo originale di suoni
di derivazione post-indie
pop in cui i tratti che facevano risaltare Spirit restano seminascosti o in secondo piano. Un album fatto di pezzi malinconici,
struggenti, al limite del gothic sound in alcuni casi
(All Mine), romantici e progressivi in altri (le aperture ariose di The Return), altrove pericolosamente vicini a orchestrazioni catchy alla Arcade Fire (3.1)
o - peggio ancora - ad un pop intriso di sentimentalismo di matrice radioheadiana (al limite del plagio,
in Lie). Insomma, non un brutto disco: ben suonato,
sentito, appassionato nelle sue scelte ma totalmente
distante dal precedente. Ma forse la chiave di lettura
per interpretare quanti danni abbiano fatto Thom
Yorke e soci alla comunità musicale underground è
proprio in dischi come questo. Una sufficienza di stima nella speranza che rinsaviscano presto.(6.2/10)
Stefano Pifferi
Avion Travel - Nino Rota L'amico
magico (Sugar, Ottobre 2009)
G enere : pop d ' autore
Che sia riqualificare in senso nobile brani finiti ingiustamente nel carrello delle canzonette di consumo (Ma che freddo fa di Nada, tanto per dirne
una) o recuperare tesori seminascosti dal tempo e
dell'incuria della critica (Che cosa sono le nuvole? di
Domenico Modugno-Pasolini) o ancora rileggere classici in vita rivelandone attitudini pop non del
tutto attese (il difficile ma riuscito tributo a Paolo
Conte di due anni fa), quello degli Avion Travel
è sempre stato un percorso a mano stretta con
la tradizione, come principio e fine di un modo di
intendere la musica decisamente obliquo e (chissà
che vorrà dire?) postmoderno. 

Con L'amico magico è la vota di Nino Rota, ripreso non in senso generale, e quindi generalista, ma
calibrando l'attenzione soprattutto sulla collaborazione con Fellini (e Wertmüller, Scorsese, Zeffirelli)
in una direzione piuttosto canzonettara, e quindi
36
recensioni
meno conosciuta, a sfavore dei temi più celebri che ci sono, seppur rispettosamente interpretati:
vedi un Amarcord che con dobro e vibrandoneon si
fa desertica e stellata come il canto notturno di un
pastore errante della Pampa.

Il risultato, lo diciamo subito, è ottimo. Perché gli
Avion Travel in compagnia dell'Orchestra Camerata Ducale di Vercelli fanno una cosa semplice e difficile allo stesso tempo: calcano la mano
sull'aspetto onirico della musica di Rota ma evitano
(quasi) del tutto quello circense-surreale-utopico,
che fatti i conti rimane solo nella chiusura (ovvia,
ma a quel punto ci sta) con La passerella di “8 e
mezzo”. 

Il nodo sta nella scelta dei brani, tutti attraversati
da un leggero tratto verticale, volatile, se non addirittura spirituale, che i tre casertani amplificano
a dovere. Gli Avion Travel del tributo a Rota, come
di quello a Conte, non hanno più un suono da Piccola Orchestra (e difatti è scomparsa quella parte
di nome) ma da ensemble modernista, vedi una Giulietta Masina di Caetano Veloso - reintitolata non
troppo felicemente Pelle bianca - coverizzata come
l'avrebbe rifatta Arto Lindsay.
L'utilizzo di didascalie blues, eleganze pop anche
radiofoniche e accenti nu-jazz è al servizio di una
materia da manipolare tenendone intatta l'identità,
che ha come protagonisti la solita interpretazione
teatrale di Peppe Servillo e qui come non mai la
chitarra di Fausto Mesolella, abile nel passare da
pennellate aeriforme quasi Robert Fripp (la sinuosa Parlami di te) a terrigne narrazioni acustiche
che rispondono alla volta celeste dell'orchestra (lo
strumentale The immigrant, da “Il Padrino II”), fino ai
soliti campi lunghi morriconiani quali conferme di
una tendenza cinematica a tratti un po' ridondante.

L'orchestra dal canto suo sottolinea e riempie, a volte esagerando secondo il difetto di
molte produzioni italiane ad alta tiratura. Ma tanto il resto della magia, non come mero incanto ma
proprio come tensione verso il mistero, lo fanno
le composizioni di Nino Rota. Almeno tre su tutte:
l'architettura mistica di Ai giochi addio (da “Giulietta
e Romeo” di Zeffirelli) con gli archi sapientemente
attraversati da un gorgoglio elettronico di maniera ma efficace; una perlacea e sontuosa Gelsomina
(“La Strada”) perfettamente interpretata da Servillo
e il divertissement in zona Beatles di Bevete più latte (“Boccaccio '70”), colorato come una b-side di
Yellow Submarine e la guest di Elio senza Storie
Tese.
Completa il tutto un dvd con sei brani registrati agli
Arcimboldi di Milano lo scorso maggio, quando il
progetto venne presentato. Avion Travel in grande
spolvero.(7.4/10)
Luca Barachetti
Barbacans (The) - God Save The
Fuzz (Go Down Records, Novembre
2009)
G enere : garage
Ci sono dischi che dichiarano la propria appartenenza sin da titolo e copertina. God Save The Fuzz opera prima del quartetto marchigiano - appartiene
a questa categoria. Un dio hippie e frikkettone giace
con spinello, chitarrina e occhialetti alla Lennon sul
retro della cover mentre i loschi figuri armati di caschetto d’ordinanza irrompono come novelli Mosè
con le tavole dei comandamenti del garage-rock.
E infatti God Save The Fuzz è un 12 tracce sparato dritto in faccia, senza fronzoli o ammiccamenti
alla moda, intriso di garage sound fino al midollo e
in cui Joe Carnarelli (voce, farfisa),Walker (chitarra),
Purple Guescio (basso) e Il Sindaco (batteria) non
si risparmiano affatto. E nemmeno annoiano, a dirla
tutta, con la loro viscerale energia che tritura tutto
ciò che esiste dai Sonics in poi passandolo attraverso la ingombrante e decisiva presenza del farfisa
e del fuzz nella migliore tradizione dei Fuzztones.
Ne escono piccole gemme garage ’60 virate di volta in volta verso lidi psych-lisergici (Turn Away), power-pop (i coretti di Time For The Choice), punk 77
(What’s Fantastic), addirittura gothic (We Have The
Right Sound) o horror-rock (il finale di White Mask,
Jude The Honest, la coda di Walking On Newspapers)
alla Morlocks, in cui riverberi ed echi la fanno da
padrone e l’immaginario evocato non è così lontano
dal Batcave. Insomma, se questi sono i risultati, cosa
dire se non lunga vita al fuzz?(6.7/10)
Stefano Pifferi
Benjamin Biolay - La Superbe
(Naive, Ottobre 2009)
G enere : canzone d ' autore
Figliastro di Serge Gainsbourg, scapestrato sì ma
mai come il padre putativo, Benjamin Biolay è il
classico personaggio che farebbe bene a qualsiasi
tradizione musicale ancorata sul fondale della propria classicità e in attesa di una spinta per tornare
a galla. Dal 2001 ad oggi il cantautore francese ha
prodotto, rinnovandone l'allure, i lavori di alcuni dei
nomi bene del più ordinario songwriting d'oltralpe
(Julien Clerc, Coralie Clement) e scritto canzoni per colonne portanti mai veramente usurate
come Henri Salvador, Juliette Gréco, Francoise Hardy. Il tutto con un approccio teso a riprendere e riqualificare la mitologia pop del suo Paese
lungo quegli canali transgenere che già furono del
suo genitore artistico-spirituale.
La Superbe, sesto lavoro dal 2001 ad oggi, arriva
quindi a fare i conti con l'oste per dimostrare una
volta per tutte il valore di Benjamin, ed espone i capisaldi di un'estetica di certo derivativa ma ancora
parecchio in salute, poiché racchiusa in un doppio
disco-romanzo che è prima di tutto un inarrestabile florilegio creativo. La trama è quella una storia
d'amore che inizia e finisce con conseguenti risvolti
dolorosi, tossicodipendenza inclusa, da cui alla
fine il protagonista tenta
di rinascere: plot e toni rimangono intrisi di un'aurea maudit-metropoliana
che a molti potrà sembrare un po' di maniera,
tuttavia è nella quantità
incredibile di influenze e cambi d'espressione che
La Superbe dà il suo meglio. 
La track-list,
sempre sopra la media, assesta metodicamente il
colpo decisivo un attimo prima che affiori la noia;
il songwriting brucia del fuoco di uno spirito senza
regole che emerge tanto nei testi quanto nelle scelte sonore. E le canzoni vengono così costruite rubando a destra e a manca oggetti dalle forme e dai
colori più vari per comporre sculture dall'impianto
sempre riconoscibile ma decisamente multiforme
sul piano evocativo ed emozionale.
Ecco dunque, accanto ad episodi tipicamente da
chansonnier più o meno moderno (Sans viser personne, Ton héritage), la genesi di calligrafie dandy
pop-rock tra Morrissey e David Bowie in Reviens
Mon Amour e Prnons le large, gli ammorbidimenti jazz
di spazzole-pianoforte-tromba nella splendida La toxicomanie, le cellule hip hop che fanno da appoggio
a talkin' ballad mozzafiato come Brandt Rhapsodie
(in duetto con Jeanne Cherhal), gli esercizi synthpop spudoratamente anni ottanta con sottofondo
di chitarrine funky e tanta voglia di fottersene di
tutto di Assez parlé de moi. Addirittura ad un certo punto le chincaglierie andaluse di Lyon Presqu'Ile
e l'imitazione Noir Desir tutt'altro che artificiosa
di Tu es Mon Amour, ennesimi tasselli di un mondo
sonoro che traccia dopo traccia pare rigenerarsi
recensioni
37
in soluzioni sempre inedite ma altrettanto in linea
con le precedenti. Lo zenith gestativo di Benjamin
Biolay si realizza in un disco importante per la canzone d'autore francese e definitivo per il suo titolare.(7.5/10)
Luca Barachetti
Benjy Ferree - Come Back To The
Five And Dime, Bobby Dee Bobby Dee
(Domino, Dicembre 2009)
G enere : songwriting
Bobby Driscoll chi era costui? Il ragazzino che
aveva dato la voce a Peter Pan nel film della Disney
del 1953 e interpretato altri film negli anni 40 e
50, per poi venire scaricato da adolescente, avere
in seguito una vita burrascosa tra alcol e droghe e
morire di un attacco di cuore a 31 anni, solo e dimenticato. Una storia tristissima, emblematica delle
regole spietate della “società dello spettacolo”.
Per il secondo album, il songwriter Benjy Ferree
fa un omaggio e una riflessione su fama e morte.
E lo fa alla sua maniera, inscenando un quasi
musical empatico, dove
i T. Rex convivono con
Jimmie Rogers, e dove
la teatralità di Freddy
Mercury si fonde con il
dramma nero alla Nick
Cave.
Uscito a inizio 2009 e distribuito solo ora da noi,
Come Back To The Five And Dime, Bobby
Dee Bobby Dee - che riprende sin dal titolo un
riferimento che Robert Altman aveva fatto negli ’80 all’altra icona giovanile, James Dean, - è una
elegia per il Driscoll che Ferree aveva idolatrato
da bambino. Roots music, Americana, rock, samba,
songwriting, musical, dramma teatrale sono i generi
lambiti, con la passione che lo contraddistingue.
Un’ode cantata allora, che possiede un senso del
sacro e una tensione palpabile, teatrale come è nello stile dell’autore di Washington. Che si conferma
songwriter dotato e di grande sensibilità. Heavy weighs the burden of Brother Dee.(7.2/10)
Teresa Greco
Bill Orcutt - A New Way To Pay Old
Debts (Palilalia, Settembre 2009)
G enere : B rutal B lues
Dopo l'omonimo datato 1996, annunciato da un
7'' in edizione limitata, arriva il primo vero ellepì
38
recensioni
dell'ex-Harry Pussy Bill Orcutt. Come un Son
House moderno, l'uomo è un pugnalatore e questa
collezione di "cadute" su una chitarra ne sono l'ideale compendio.
Chino su una sei corde acustica, Orcutt inciampa in
movimenti sghembi, stecche terrificanti e intervalli
dissonanti che sono un po' il pane di Ian Williams e
dei compianti Storm & Stress, con la differenza
che il piglio è visceralmente punk, un rutto hardcore ai contorsionismi di Derek Bailey.(7/10)
Leonardo Amico
Black Cobra - Chronomega
(Southern Lord, Novembre 2009)
G enere : S toner /M etal
Chronomega è un viaggio senza pause, plasmato da
un suono massiccio, vigoroso e forgiato nel fuoco.
Giunti al terzo disco, i Black Cobra paiono dei
Kyuss più truci e incazzati dopo una dieta a base di
anabolizzanti. Ci troverete tutto quello che è successo negli utimi anni in ambito stoner/heavy-metal,
dagli High On Fire passando per i Mastodon.
Difetto dell'operazione non è di poco conto: nell'incapacità di domare il magma se ne diventa schiavi.
Ne consegue il classico pastrocchio di tracce troppo simili le une alle altre, annichilimento e infine
noia. Alla prossima.(6/10)
Nicolas Campagnari
Black Keys - Blak Roc - Blak Roc
(Blackroc, Novembre 2009)
G enere : hiphop rock
Damon Dash, l'altra metà della Roc-A-Fella Records
di Jay-Z, scopre l'indie blues sanguigno dei Black
Keys e se ne innamora. Vuole combinarci qualcosa
e se li porta in studio assieme al rapper Jim Jones.
Recluta poi altri dieci vocalist, e partono così undici
giorni di session per undici brani fatti e finiti, il tutto documentato da nove video disponibili sul sito
del progetto Blak Roc. Sono nomi HH con la 'n'
maiuscola, da Mos Def a Pharoahe Monch a Raekwon e RZA del Clan (e c'è anche un ripescaggio
del fu Ol'Dirty Bastard) a Q-Tip alla singer Nicole Wray, che dà un tocco r'n'b soul al tutto.
La prima metà del disco, fino alla performance di
Raek (pura classe rap), è ottima, con pezzi efficacissimi (tipo quello di Mos Def, sempre in zona chico
hop solarizzato come in The Ecstatic, ma molto più
a fuoco). L'altra metà è invece un po' buttata lì, per
quanto i pezzi siano sempre costruiti bene e la Wray,
affusolata e brava, dove la metti sta. La vera questione:
highlight
Annie - Don't Stop (Smalltown Supersound, Ottobre 2009)
G enere : electro pop
Le ragazze che ambiscono al trono del pop. Anne Lilia Berge-Strand, la piccola grande norvegese in comeback. Ed è già gara e parallelo obbligatorio con l’impertinente La Roux. Annie parte
favorita. Uno: l’album che ha sbancato, quell’Anniemal che nel 2004 ha fatto alzare le antenne anche a Pitchfork (il singolo Heartbeat è stato inserito addirittura nella top 20 del decennio). Due: il
pregevole mix DJ Kicks su !K7 (targato 2005). Tre: la provenienza da Bergen, ovvero dal calderone
Telle Records che ha sfornato gente del calibro di Kings Of Convenience e Röyksopp.
Ma torniamo al ring. La bionda e la rossa, si diceva. Se per l’albionica c’era l’impertinenza del palco,
qui ci sono pulizia e raffinatezza. Annie è la secchiona della classe, quella che non la saluti perché
è troppo tutto: bella, intelligente, misteriosa e simpatica. L’altro paragone now è se volete anche
con Lady Gaga. Quest’ultima almeno ha la patina rozza della tedescona uscita dalla birreria con il grasso del wurstel mit kartoffen sotto
le unghie. Qui invece non ti puoi attaccare a niente, tutto è asettico,
come nelle installazioni giapponesi alla Biennale, quei mondi perfetti
al neon con la popness che ti mette a disagio. Annie è quindi un robot
post-Kraftwerk che incarna le visioni patinate sulle fashion cover ma
che ha anche la storia delle indie-stars (la prematura morte del partner Tore Korknes nel 2001 la avvicina infatti a noi comuni mortali).
Dopo qualche controversia con i Girls Aloud e dissapori varî con la
linea della Island (che hanno fatto cambiare idea alla ragazza oggi approdata su una indie label),
abbiamo finalmente il ciddì definitivo. Il suono è quello che ognuno si aspettava: Madonna meets
Kylie Minogue meets Nelly Furtado. L’essenza storica incarnata pop si professa ancora una
volta per l’esercito dei non più teen che oggi sono transformers poshy (e che una volta erano
paninari). Per capire cosa gira nelle menti dell’ascoltatore medio è necessario sostare su questo
sussidiario della gioventù uber-00.
La voce nordica e wasp che muta con la base break hop (Hey Annie), lo spettro degli 80 che non
incombe ma che aiuta con le sue tastierone e laser (My Love Is Better è puro distillato Ciccone,
The Breakfast Song e Songs Remind Me Of You sono Sabrina Salerno senza tettone), i synth maranza 90 (Bad Times), la classe nella traccia omonima puro distillato teen-floor, l’accenno al fidget
e alle esperienze di Miss Kittin (altro santino che Annie ha nel wallet) in I Don’t Like Your Band e
per chiudere l’obbligatoria ballad (When The Night).
O bionda, surfa ancora sulle onde quadre della cresta ingellata del pop.(7.5/10)
Marco Braggion
che dietro tamburi chitarra ed effetti ci siano i Keys,
ecco, questo si capisce e non si capisce. Un po' come
il senso di tutta la cosa, forse semplicemente occasione di reciproca promozione.(6.3/10)
Gabriele Marino
Black To Comm - Alphabet 1968
(Type Records, Novembre 2009)
G enere : F orest drone
Entità misteriosa Black to Comm ovvero Marc
Richter, animatore di meccanismi cibernetici, musicista iper-meccanico dall'impronta arcana. Parola d'ordine: Migrazione, perché migratorie sono le
criptiche cifrature di Jonathan; il collagene transizionale Void; l'occupazione indebita di spazio di Houdini
Rites. Ovunque regna il migrare basato sul caoide, il
luogo-tunnel dove innesti vintage-analogici masturbano passaggi sotterranei, ricurvi, emblematici. In
ogni anfratto sonoro di Alphabet 1968 si nascondono meccanismi isolazionistici, centrifugati su sorecensioni
39
stanze imprevedibili con un occhio rivolto agli abissi,
e l'altro al canovaccio oscurissimo fatto di rigurgiti
solidi ed ipnotici.
E non si tratta solo di questo, Black to Comm è autore d'immaginari mortiferi, sulla soglia del collasso
trasformazionale, attraversati da un suono perverso
a metà tra rito funebre e dronismi ben lontani dalle
mode. Ce lo dice pure il titolo Alphabet 1968:
un cespuglio, un alberello diradato e al centro un
personaggio forse in estasi, forse in caduta libera,
forse solo rapito di un'apparizione. Ce lo dicono
le geometrie maligne, rigonfie di materia cerebrale,
i cunicoli spaziali ed i buchi neri di questi vortici
che con l'elettronica condividono solo l'uso del sequencer, ma che di elettronico hanno poco o
niente. E questa è l'altra
grande consapevolezza
di Richter: quella di trattare il suono come forma pura, evitando che il
contenuto lo faccia il genere piuttosto che l'imprinting e l'immaginario
che c'è dietro.
Si chiude con Hotel Freud, altro tassello di una discografia misteriosa e impetrabile, in pratica, un
William Basinski nella foresta infernale o se preferite, un Fennesz a campionare riti magici. Eppure
l'evoluzione di questa musica consiste nel trattare
l'ambient, la weird-folk, i field-recordings come se
fossero un'unica pasta color-seppia, su cui imprimere un linguaggio post-digitale imparentato coi
sentimenti e la lirica. Una miscela ermetica quella
di Black To Comm, musicista solitario, misterioso,
mistico.(7.8/10)
Salvatore Borrelli
Body Hammer - Origins of
Body Hammer (Improvvisatore
Involontario, Dicembre 2009)
G enere : impro / lounge post - bomba
Agosto 2002, Sampieri (Ragusa): Francesco Cusa
e Carlo Natoli, compagni abituali di improvvisazioni involontarie, sonorizzano il secondo capitolo
della saga cyberpunk-cronenberghiana di Shinya
Tsukamoto, The Body Hammer. E' la scintilla di
questo progetto, poi trio assieme ad un altro habitué come Emiliano Cinquerrui, tutto costruito
sull'immagine tetsuiana di fusione tra carne (batteria e chitarra) e macchina (laptop). Ma se in Tetsuo
40
recensioni
l'unione delle due componenti è violenta e traumatica, qui appare invece perfettamente naturale, forse
perché rassegnata (senza per questo intendere che
la musica che ne viene fuori sia pacificata).
Mood scurissimo e opprimente (disco monocromo,
colore grigio), forma jazz (Cusa non manca mai di
ribadire il concetto), risultato che è una lounge per
questi nostri giorni - maltrattata e instabile - nutrita
da accordi di chitarra e da crescendo residui del
post-HC, da bruciature al silicio accese dagli Autechre, da dub chetaminico e broken beats, da zornianerie per spazzole cangianti, da vuoti & pieni tipici
dell'impro.
I tre riescono a fugare quel frequente effetto collaterale di tanta avanteccetera (numi tutelari, da
Zorn in giù, in testa) motivo delle idiosincrasie del
sottoscritto nei confronti del "genere": il fumo senza l'arrosto, la fuffa figa ma che sempre-fuffa-è, i rumorini e i rumoroni buttati lì come semini che non
germoglionano mai, la sperimentazione da catena
di montaggio. L'avanguardia automatica. Da queste
parti l'avanguardia è involontaria: c'è intensità (cosa
sempre più rara dentro e fuori la parrocchia), non
ci si annoia, il disco scivola e al contempo avvince.
Sfibra e sbriciola, eppure costruisce.
Sette pezzi per dire che si può ancora fare avant
senza rompersi le palle, in Italia.(7.2/10)
Gabriele Marino
Boys Noize - Power (Boys Noize,
Ottobre 2009)
G enere : P ost -D aft techno fidget trash
Alex Ridha, il tedesco mago del mix che ti fa saltare
il club con quattro passaggi di mixer, ritorna dopo
svariate compilation in zona minimal fidget. Il seguito di Oi Oi Oi spinge i soliti tasti che tagliano a
metà i dancefloor laserati dagli ormai onnipresenti
Crookers o Steve Aoki (Sweet Light). Et voilà: il
menu a base di techno scuola Mr. Oizo (Starter),
di sampling selvaggio dei Daft Punk versione forza
nuova (Jeffer) e, da metà scaletta, della sperimentazione tra Kraftwerk e Pump Up The Volume (Transmission, Nerve, Trooper), pegni infiniti alla techno belga (Drummer); per finire una bella bussola che punta
al rave nordico (Nott). E' il dancefloor now: revival
faceless bollocks. Ma come in un arcade game sparatutto, e tanto di citazioni evidenti.(6.5/10)
Edoardo Bridda
Bruce Gilbert - Oblivio Agitatum
(Mego, Novembre 2009)
G enere : ambient
Non sempre è un bene per gli artisti andare dietro
alle proprie idee ed inclinazioni. Bruce Gilbert che
deve gran parte della sua fama agli acclamati Wire,
si è infatti già da tempo spostato in un territorio
che ha sempre cercato: la drone music più estatica e senza compromessi. Oblivio Agitatum è la
summa di questo suo perdersi nelle frequenze più
alienate.
Sorta di ep camuffato da disco, laddove l’album sta
tutto nella centrale Zeros, il disco non fa altro che
mimare i soliti ambienti astratti, con costruzioni su
tessuti sintetici da epoca digitale senza anima. Non
c’è passione, né energia creativa nei corridoi horror
con echi siderali dei venticinque minuti del brano.
Tutto è eccessivamente statico e prevedibile. I brani
di contorno che incorniciano il tutto, aumentano il
senso di insufficienza, per una musica che vorrebbe
essere visionaria e invece è solo l’ennesimo disco di
drone music da scaffale. Non se ne può più.(5/10)
Antonello Comunale
Bum Bum Baby San - Al sicuro
(Effetti Collaterali, Ottobre 2009)
G enere : rock
L'onda lunga del punk macerato di paranoie e tabule rase, le frenesie che sprizzano dai meravigliosi
tubetti e l'escursione sonico-letteraria, come dire
un'eredita di cui i Bum Bum Baby San - trio che
potremmo definire emo-power casomai significasse
qualcosa - s'incaricano con la convinzione del caso.
Formatisi nel 2000 in quel di Bernalda (provincia di
Matera), il nome ispirato alle signorine di piacere
vietnamite che allietavano e terrorizzavano le giovani macchine da guerra statunitensi (vedi Full Metal Jacket), denunciano discendenze evidenti dai
nineties italiani come appunto CSI, Afterhours
e Marlene Kuntz, cui possiamo aggiungere senza
indugio il Santo Niente e un pizzico di Massimo
Volume.
Abbiamo già dato, ho pensato io e penserete voi.
Però, attenzione: c'è quella vena di lucido delirio,
l'avventatezza che non fa sconti, l'ambizione un po'
disperata e perfino ironica di chi nella vita sembra
non voler fare altro. Qualcuno avverta questi tre lucani che il demonietto della wave cantautorale se li
è presi. E' raccomandabile un bell'esorcismo. L'alternativa è pasturarlo ben bene. Farlo diventare grasso
e spesso che ci sono mostri da mettere al mondo
negli anni a venire. Intanto, di fronte a fenomeni di
tal fatta, accantono la sensazione del già udito e - a
voi piacendo - mi scappello. (6.9/10)
Stefano Solventi
Carmen Consoli - Elettra
(Universal, Ottobre 2009)
G enere : cantautoriale
L'amarcord dell'anno scorso con la ripubblicazione
in formato deluxe del fondamentale Mediamente Isterica non ha riportato Carmen Consoli al
rock. Ed Elettra continua invece su quella strada
folk che dal precedente Eva contro Eva ha sciolto il nodo lento-acustico/veloce-elettrico in favore
della prima ipotesi, levando la siciliana da un'impasse
che nel fin troppo manieristico L'eccezione rischiava di soffocarla. Così il songwriting di Carmen Consoli continua in quell'elogio della complessità che
è la cifra costante della sua ultima produzione: un
repertorio in cui le canzoni arrivano lente ma durano, e scelgono l'intensità non istantanea di bozzetti
dalla forza poetica sottocutanea, che a frasi musicali
elaborate, cangianti, eppure sobrie fa corrispondere la ricercatezza quasi filologica dei testi - basti
pensare ai tanti rimandi tra mito, figure femminili e
simbologie assortite riqualificate in chiave moderna
che riguardano le dieci canzoni di questo disco e il
titolo in primis.

La livrea folk-mediterranea del predecessore Eva contro Eva si sposta ora verso il nordeuropa. Più NMA che world, insomma, più Kings of
Convenience che il De André di Anime Salve.
Ma di quest'ultimo rimane l'attenzione verso le vittime e le loro storie, alternate alle riflessioni personali di una donna matura dinanzi a ciò che accade..
Ecco dunque il saluto
al padre scomparso di
Mandaci una cartolina,
memoriale dolceamaro
di un tempo all'insegna
del buon senso e del
pudore che pare ormai
finito («Viva l'Italia, il calcio, il testosterone / gli
inciuci e le buttane in preda all'ormone») e i versi
raggelanti della storia d'abuso di Mio zio, un brano
che qualche anno fa avrebbe sfuriato elettrico e che
invece oggi si trattiene ugualmente incisivo su un
bouzouki trotterellante come un banjo.
Ecco ancora l'eleganza alla Domenico Modugno,
direttamente citato nel testo, di Col nome giusto
recensioni
41
(archi in volteggio suadente e ritornello accorato
per una vicenda d'amore che accumula separazione,
dolore ma anche piacere) e lo splendido omaggio
a Rosa Balistreri di 'A finestra, cantato in un dialetto grasso ed espressivo che acuisce veracità e
ironia nella denuncia del perbenismo incafonito di
un paese qualsiasi, ovvero l'Italia tutta, osservato e
raccontato affacciandosi da una finestra come nella
tradizione dei cantastorie.

Immagine, quest'ultima, perfetta per descrivere Carmen Consoli e il suo percorso, ormai capace di usare trasversalmente le radici di tutto il mondo per
raccontarne le storture e la vita.(7.4/10)
Luca Barachetti
Cheap Wine - Spirits (Cheap Wine
Records, Ottobre 2009)
G enere : rock - folk
Affezionati a una gestione autarchica - compresa
l'etichetta, non a caso Cheap Wine Records - e a una
formula da sempre in direzione ostinata e contraria,
i Cheap Wine potrebbero essere ben rappresentati da un "faccio la mia cosa nella casa" del buon
Frankie HI-NRG. A conferma, una lontananza evidente dalle sirene più “in” dell'indie rock attuale e
un suono incastonato in certo hard-rock-folk quasi
immutabile.
Del resto, quando arrivi al settimo disco - compreso l'Ep d'ersordio Pictures del 1997 - in dieci anni di
carriera, di cose ne hai viste fin troppe e poco t'importa di quello che si dice in giro. Soprattutto se già
agli esordi eri una mosca bianca. Soprattutto se chi
ti segue - in Italia, ma anche all'estero - sa bene dove
andrai a parare ed è disposto a condividere ogni tuo
passo, come si fa solo con i mostri sacri.
Roots e dintorni, arpeggi di chitarre acustiche che
si intrecciano, aromi (naturali) western: è questa la
svolta di Spirits. Un disco che stacca idealmente il
jack dall'amplificatore pur senza mescolare troppo
le carte, che si tratti di brani autografi (il blues crepuscolare di Just Like Animals rubato a certi Dire
Straits un po' ruffiani, gli Allman Brothers di Leave Me A Drain, i chiaroscuri jazzati di La Buveuse) o
di cover (Man In The Long Black Coat di Bob Dylan
e Pancho & Lefty di Townes Van Zandt).
Per una band che viaggia sui binari di un classicismo
nobile e sferzante ben piantato nell'immaginario
americano tradizionale ma al tempo stesso al riparo
dalla nostalgia.(7/10)
Fabrizio Zampighi
42
recensioni
Cheveu - Cheveau (Permanent,
Settembre 2009)
G enere : NO B lues
Dopo l'omonimo album di debutto dell'anno scorso
e l'ottimo singolo Like A Deer In The Headlights,
il trio parigino più calvo in circolazione torna a farsi
sentire con un LP che raccoglie outtakes, rarità e
pezzi presi da demo sperduti nel passato neanche
troppo prossimo. È buffo come di questi tempi raccolte del genere non vedano più la luce solo dopo
svariati anni, ma sempre più spesso a seguito del
primo disco; in ogni caso, a fugare qualsiasi dubbio ci
pensano subito i primi pezzi del disco. Si parte infatti con un tripletta da convulsioni isteriche (Pangolin,
Palestine e soprattutto Kadir Du Porno, che mostra gli
Cheveu più violenti che memoria ricordi).
Da qui in poi è un continuo alternarsi obliquo e debilitante di nenie rumoristiche (St. Jazz, Planet Camping) synth-blues moribondi (Sacha, Espace Detente)
e vorticosi electro-boogie (Elvis, Psyx). Certo non è
l'organicità la dote da cercarsi in dischi come questo; al contrario è importante lasciare le redini ed
annegare nei fumi e nei laser giocattolo che i tre ci
sparano dritti in faccia e, per quanto possibile, ballare la danza post-atomica del Capello.(7.1/10)
Andrea Napoli
Chinese Stars (The) - Heaven
On Speed Dial (Anchor Brain,
Novembre 2009)
G enere : noise dance - punk
Era la fine del 2002 e una delle realtà più strambe,
storte e destabilizzanti del sottobosco americano
decideva di mettere la parola fine alla propria esistenza. Neanche il tempo di celebrare il giusto funerale che 2/4 degli Arab On Radar risorgevano
a nuova vita da quelle ceneri, con il moniker The
Chinese Stars: il chitarrista/cantante Eric Paul e
il batterista Craig Kureck per l’occasione tiravano
dentro l’altro chitarrista Paul Vieira e soprattutto
l’ex Six Finger Satellite Rick Pelletier al basso,
poi sostituito da V.Von Ricci.
Un esordio col botto (l’ep a forma di stella Turbo
Mattress), un album lungo che lasciava soddisfatti
ma non troppo (A Rare Sensation) e un secondo che deludeva totalmente (Listen To Your Left
Brain) e ora, in concomitanza con i ritorni epocali del Providence sound (Lightning Bolt e Six
Finger Satellite su tutti) questo vinyl only che,
almeno sulle prime, rinverdisce i fasti di un suono
spastico e sopra le righe. Rabbit Face è un assalto
highlight
Hollowblue - Wild Nights, Quiet Dreams (A Cup In The Garden,
Novembre 2009)
G enere : rock
Disco dopo disco - siamo al terzo - gli Hollowblue stanno ritagliandosi un mondo proprio.A forza
di storie che esplorano, indagano, mettono in scena e alla prova le turbe esistenziali, il dilemma del
sentimento, l'ombra terribile ed enigmatica della morte che guata le
caviglie. Romanticismo noir dal piglio assieme cinematico e letterario,
ogni canzone l'atto di una rappresentazione teatrale ben delimitata,
che procede per situazioni scenografiche in bilico tra rock incandescente e cantautorato mitteleuropeo.
T'imbatti quindi in una mischia tra ugge cameristiche e ghigno elettrico, frenesie da blues sclerotico e jazzato (le vampe di tromba, il pianoforte prezioso ed elusivo...),come dei Dirty Three alle prese con
l'idioma languido e sferzante d'un Paolo Benvegnù (impressione rafforzata dal sorprendente finale in italiano di Sigma), o come un Nick Cave in bilico tra laconico
struggimento Venus e rovello Morphine (come nel melò appassionato e ossessivo di Wild &
Scary). Altrove l'impasto si tinge di asprezze desert, come la murder song da mariachi impazzito
di Honeymoon, sempre però sul punto di contagiarsi d'altro, come le suggestioni tra Canterbury
e deserto Mojave di The Last Day, per non dire della "texbalcanica" Shout, cogli umori decadenti e
la febbrile escursione art-wave sbilanciata prog.
Quando se la giocano più dura, sanno essere assieme saturi ed eterei (una You Cannot Stop che
potrebbe addirittura piacere ai fan dei Placebo), acidi e tormentati (il funky nervoso di I've Go
The Key To Change The World). Poi ci sono le ballate, un po' Leonard Cohen e un po' Radiohead,
tutto un caracollare fra tumulti sanguigni ed ebbrezza malsana (su tutte la trepida Wild Dogs Run,
ospite Sukie Smith al canto), salvo poi spiazzarti in chiusura di programma con una Cry Hell! che
imbastisce un raga psych febbrile come un bolero deragliato tra Haight-Ashbury e CBGB's.
Sound elaborato, denso e intenso per un disco che sgrana complessità risolte come un rosario
d'inquietudini. Gli Hollowblue sono una signora band. (7.3/10)
Stefano Solventi
ossessivo a base di noise-core spastico con un intermezzo robotico a metà tra Six Finger Satellite e
dei Devo sotto anabolizzanti, mentre la seguente
No Car No Job è un dance-punk groovy e irregolare come una versione p-funk dei Blood Brothers.
Premesse ottime, ma presto disattese, perché l’ipercinetico, massimalista, sboccato suono dei quattro si
appiattisce su se stesso, legandosi troppo ad alcuni
elementi (il suono modificato delle chitarre e l’invadente vocalità di Paul) e pregiudicando così ogni
forma di sviluppo.
La durata breve (mezzora esatta) e la continua riproposizione, al limite del monolitico, dello stesso
sound può però far pensare ad una sorta di provocazione messa in scena dai quattro reietti. Dopotut-
to l’area di provenienza e il background sembrano
avallare questa ipotesi. E così nel dubbio ci manteniamo su una sufficienza di stima.(6.5/10)
Stefano Pifferi
Chris Forsyth/Shawn Edward
Hansen - Dirty Pool (Ultramarine,
Novembre 2009)
G enere : avant impro
Forsyth e Hansen sono due figure abbastanza defilate della scena avant rock di questi anni, eppure
con la sigla Phantom Limb & Bison, che li vede
protagonisti entrambi e ancora di più con i Peeesseye (che è la band madre dietro cui si muove il primo), hanno attirato le orecchie giuste dei palati più
recensioni
43
difficili e raffinati. Dirty Pool, titolo che sigla una
jam psichedelica in tre movimenti tra le più riuscite
di questi anni, non è però pubblicato sull’etichetta di Forsyth (l’ormai mitica Evolving Ear), quanto
piuttosto sull’italiana e promettente Ultramarine,
che si va ad aggiungere idealmente all’altra italiana
Qbico nella difficile tradizione del vinile di culto. Il
disco parte sonnacchioso e criptico, nell’intimità di
un dialogo intimo tra chitarra e organo che occupa
tutto il primo lato, in un modus che fa pensare sia a
Tom e Christina Carter che al Loren Connors
più lunare. Il secondo lato si anima sulle spartane
orme di un blues stiracchiato, che si aggroviglia lento
e mantrico su un arpeggio appena elettrico in crescendo epico che come
giustamente fa notare
qualcuno strizza l’occhiolino ai Television,
seppure in un modo del
tutto desueto.
In chiusura, una frase
emozionata di chitarra in partitura stellare a
due con il farfisa di Hansen nella scrittura di una
stupefatta nuova Dark Star degli anni 2000. Disco
raffinato eppure sempre e comunque comunicativo
e immediato, lontano dalle nebbie più criptiche, presuntuose e snob di tanta avant-“merda” di questi
anni.(7.3/10)
Antonello Comunale
Cindytalk - The Crackle Of My Soul
(Mego, Novembre 2009)
G enere : dark ambient
Fa un certo effetto avere tra le mani un disco nuovo dei Cindytalk. Indimenticata sigla dietro cui si
muove il demiurgo goth Gordon Sharp, ennesimo
residuato bellico dei vorticosi anni ’80 al suono di
un Post-Punk tra i più truci e malati dell’epoca. Che
il percorso sonoro della band sia poi passato per
l’ormai quasi canonico abbandono delle strutture
più rock in favore di una malsana distesa dark ambient questo ormai non sorprende più nessuno.
A rigor di logica non saremmo molto distanti dall’excursus Loop-Main di Robert Hampson, ovvero
preferire astrazione e spirito in favore di forma e
sostanza, ma Sharp non aggiunge nulla di nuovo, né
eccelle lungo il canovaccio post industrial.
A The Crackle Of My Soul va tuttavia riconosciuto
il pregio del rinnovamento. Se Sharp si fosse presentato con un disco nello stile più classico della
44
recensioni
Soilelmoon lo avremmo liquidato storcendo il naso,
ma i riferimenti vanno maggiormente nella direzione di Pita e Kevin Drumm, soprattutto nei momenti più harsh come Feathers Burn e Trasgender
Warrior.L’ultima Debris Of A Smile strizza persino
l’occhiolino a Fennesz…
Un ritorno che non sorprende, né brilla per qualche
merito particolare, che non sia quello di riconoscere a Sharp un certo buon gusto.(6/10)
Antonello Comunale
Clare & The Reasons - Arrow
(Fargo, Novembre 2009)
G enere : chamber art pop
Si diceva l’anno scorso delle potenzialità del duo
di Brooklyn Clare & The Reasons, in bilico tra
songwriting jazz pop e umori chamber; c’erano collaborazioni illustri (Sufjan Stevens e Van Dyke
Parks) in quel disco d’esordio, The Movie e
ascendenze Lee Hazlewood/Beach Boys tra le
altre cose.
Dopo poco più di un anno li ritroviamo con Arrow:
siamo ora dalle parti di un pop sofisticato, un po’
più leggero ma consistente. Se prima era il mood
jazzato di Rickie Lee Jones, ora uno dei punti di
riferimento di Clare Muldaur, cantante e songwriter del combo, è Shara Worden alias My Brightest
Diamond, non a caso ospite del disco. Ecco allora arrangiamenti stratificati, umori tra operetta e
chanson, echi alla Bjork più imprevedibile ma anche
percentuali di Belle And Sebastian, Nina Persson (The Cardigans), Andrew Bird e Beirut
(quest’ultimi fanno parte del gruppo che li accompagna live, e tutto torna).
Arrow rappresenta allora un passo in avanti, nel
quale Clare e Olivier Manchon, la prima autrice di
quasi tutti i pezzi, il secondo arrangiatore compongono un album equilibrato con una cifra personale
ben riconoscibile.(7.2/10)
Teresa Greco
Controluce - Aprile (Novunque,
Novembre 2009)
G enere : pop , songwriting
Il duo milanese Controluce, sulla scena indie da
qualche anno, esordisce con Aprile su etichetta
Novunque. Una declinazione dell’indie cantato in
italiano, in bilico tra pop e canzone d’autore, psichedelia (Pink Floyd, Beatles) e post rock, questo è
essenzialmente l’album in questione.
Con la collaborazione di amici musicisti, come Lele
Battista e Giorgio Mastrocola (La Sintesi) con il
primo a produrre, e numerosi altri, il progetto Controluce (Simona Rotolo e Miky Marrocco) si distingue per chiarezza e sintesi compositiva innanzitutto
e per un buon controllo espressivo. Poi atmosfere
autunnali e dimesse, acusticità diffuse, testi interessanti e raffinatezza pop. I rimandi sono per un certo
cantautorato romano degli ultimi anni (si pensi per
esempio a Max Gazzè) ma non solo, anche Afterhours, C.S.I. e Cristina Donà. Esordio interessante.(7/10)
Teresa Greco
Converge - Axe to Fall (Epitaph,
Novembre 2009)
G enere : M etal C ore
La velocità impressionante delle prime quattro tracce delinea un suono inquieto che possiede ancora
l'urgenza a premere sull’accelleratore. Axe to fall
prova nuove strade senza
rivoluzioni epocali e per
una band che ha raggiunto l'apice nei primi anni
Novanta c'è di cui godere. Non mancano i consueti rallentamenti intrisi
di scorie noise (Worms
Will Feed e Damages) ma
qualcosa d'inedito si muove nelle ultime tracce: Cruel
Bloom, in cui dà man forte la voce di Steve Von Till, è un blues sbilenco e acido come solo a Tom Waits
riuscirebbe; la lunga Wretched World, con l’assistenza
dei Genghis Tron al completo, dilaga in una nenia
tanto sonnolenta quanto bastarda.
Non avranno superato il “complesso Jane Doe”, ma
non hanno smesso d'incidere dischi degni d'essere
comprati e consumati.(7.4/10)
Nicolas Campagnari
Crookers - I Love Techno 2009
(Lektroluv, Ottobre 2009)
G enere : compil ation techno
Tons Of Friends sarà l’album in uscita a gennaio 2010.
L’anticipo è qui per i Crookers, una compilation
velocissima ma piena di cose intense, come l’inno
iniziale che fa già tutto, quella Glamourama di Photek spoken inno post-floor, un po’ di dubstep e di
wonky (Zomby e ovviamente quel tagliagole di
Rustie con la sua immortale Bad Science), il remix
per Fever Ray (Seven banghra-fidgeting nell’alto
dei cieli) e ovviamente l’acido che corrode (Peanuts
Club di Noob e Brodinski e l’ossessione deep di
Osborne). In attesa dell’ellepi, i ragazzi ci han fatto
venire l’acquolina in bocca. (7/10)
Marco Braggion
Curtis Harvey - Box Of Stones (Fat
Cat, Dicembre 2009)
G enere : country folk
Un artista “paradigmatico”, Curtis Harvey. Per la
modestia e la partecipazione che emergono da un
curriculum folto e immacolato, caratteristiche tipiche di un sentire defilato e, proprio per questo, autenticamente indipendente. Trovi in lui la devozione
alle radici e uno sguardo contemporaneo che le trasfigura in misura diversa a seconda delle occasioni;
maniere risolute da artigiano esperto e ben consapevole del proprio ruolo. Figura rara che va premiata perché esiste e ancor più quando pubblica dischi
di vaglia. Si è dunque preso del tempo per il debutto
da solista, l’uomo, dopo aver militato in Rex, Pullman, Loftus e diversi altri progetti incrociando via
e strumenti con i Red Red Meat. Affine del resto
approccio e provenienza: come innumerevoli connazionali, Curtis è cresciuto con il bluegrass e i suoi
dischi di Carter Family, Bill Monroe e dei “nuovi
tradizionalisti” non prendono polvere.
Sapete perciò cosa attendervi e cioè l’ennesimo solido mattone sulla strada del cantautorato americano, affrontato spesso e volentieri rifacendosi alla
scuola texana del capostipite Townes Van Zandt
(Borrowed Time, Bag Of Seeds) e proseguita da Steve Earle (Oldertoo, Across The Sea); concedendosi
distrazioni in territori più strettamente folk come
la corale Seen o l’inchino a John Fahey di Nod. Sarebbe tuttavia figlio del suo tempo, se non lasciasse
tracce in alcuni passaggi strumentali modernisti ben
integrati alla scrittura (Medicine), se non ragionasse
su una redenzione per Elliot Smith in Joking o non
si abbandonasse al familiare blues teatrale e strafatto nella conclusiva Bad Patch?
La risposta sta nel sapiente approccio e nella conoscenza della materia che respiri in questo lavoro
sincero, sovente catturato alla prima take sfruttando al meglio mezzi minimali e felici casualità. Un diario illuminante su un amico riservato, ma che batte
sulla spalla quando serve. Negli ultimi tempi, molto
spesso.(7.2/10)
Giancarlo Turra
recensioni
45
highlight
King Midas Sound - Waiting For You... (Hyperdub Records,
Novembre 2009)
G enere : r ' n ' b step
Anticipato nel Dub Heavy / Hearts and Ghosts EP, il progetto di Kevin Martin (aka The
Bug) è quel che ci voleva in un anno magro di lavori potenti in campo step. Quasi ci tremano le
mani a scriverlo ma Waiting For You... possiede il peso specifico dell'Untrue di Burial. La personalità c'è e pure i gradi di separazione necessari. Ma soprattutto a non mancare è l'alchimia tra
presente e passato: un suono figlio della scala di grigi e dell'urbanesimo fumoso del misterioso
londinese, portati però su un inedito piano sexy, minimal e afro.
Le fondamenta del resto sono potenti: Martin tocca l'r'n'b come Burial toccò il soul, entrambi hyper-ventilano l'anima, ancorandola però
all'umbratilità del dub e a quel che rimane della battuta scandita. L'innesto dell'r'n'b lavora in Waiting For You... per sottrazione, per rarefazione. Eppure ne sgorga una sensualità impalpabile, come gas che
si propaga in una stanza.
La collaborazione con l’MC di Trinidad Roger Robinson e con la
vocalist dei Dokkebi Q Kiki Hitomi ci porta pure in territori triphop (Massive Attack e persino Portishead: sentite Goodbye Girl),
conditi con una dose calibrata di afrofuturismo, mentre altre rifrazioni del prisma rivendicano
un'anima Prince nella nebbia (Meltdown) di Bristol, il falsetto Marvin Gaye nel minimal-caraibico di Cool Out, One Thing e Dahlin, e un perfetto bilanciamento ragga/darkness nelle movenze
di Outer Space.
Un album che brilla di una luce nerissima e non di meno accecante.(7.7/10)
Edoardo Bridda
Digital Leather - Warm Brother
(Fat Possum, Novembre 2009)
G enere : indie - synth
Warm Brother vuol dire omosessuale, secondo
un’espressione gergale nazista. E giù a cercare di capire sotto quale registro il titolo del nuovo album
di Digital Leather, il primo per Fat Possum e il
primo realizzato in studio, citi quel modo di dire.
Che sia ironico o meno, sicuramente Shawn Foree
è un ragazzo che si diverte a suonare con synth e
chitarre d’annata. Dopo qualche uscita per l’etichetta dell’amico Jay Reatard, la Shattered Records, ci
ri-presenta oggi i suoi strumenti preferiti - a fronte
di un lavoro di realizzazione più professionale - nel
contenitore a volte poco più che pretestuoso di
una raccolta di canzoni. E abbiamo detto quasi tutto. Manca giusto dire che Warm Brother suona
come un indie sintetico che va nel filone tanto di
Beck che a volte degli Eels (All The People), senza
risparmiarci evitabili momenti synth-pop (Modern
Castles, Gold Hearts). Ma i protagonisti sono i suoni,
46
recensioni
di tutti i tempi. Al loro,
Settimo Serradifalco e
la sua cricca hanno invece incontrato il nostro
Cesare Basile, che non
sarà forse l'Anticristo
ma certo rimane uno dei
migliori autori italiani in
circolazione. Ad accomunarli, oltre alla provenienza
geografica, un folk rinsecchito, notturno, in bilico tra
canzone d'autore e cadenze popolari.
Se per l'esordio - Donsettimo - i punti di contatto
tra il mentore e i discepoli erano evidenti, tra le
pieghe del seguito Notte di mamma (prodotto sempre da Basile) le cose cambiano: il gruppo allarga lo
spettro delle influenze e al tempo stesso affonda le
mani nella tradizione locale, da un lato citando Tom
Waits (Viziosa) e Vinicio Capossela (Il vangelo di
Toto' e Padrino compagno) e dall'altro omaggiando
anche artisti distanti anni luce dall'immaginario rock
come Renato Carosone (Sceriffo, non a caso cantata in dialetto).
Nessuna contraddizione e nessuna imitazione, comunque. Semmai un'ispirazione dai presupposti
riconoscibili, in accordo con venature autoriali ancora presenti (soprattutto nei testi, risultato di un
taglia e cuci magistrale) e certi aromi bandistici che
già nel primo episodio rivelavano una Sicilia sempre
più vicina.(7.3/10)
Fabrizio Zampighi
anzi la loro pasta, per usare un termine caro a chi
coi sintetizzatori ci ha a che fare fin nel metalinguaggio. La sovrastruttura diventa struttura. L’intro
del disco in questo è rivelatore, e affascinante, per
quel pubblico, mentre poi i brani passano senza farsi
ricordare (tranne casi isolati come Your Hand, My
Glove, punk sintetico semplice e rotondo; o come
Homesick For Terror, dove si compie l’equilibrio tra
scrittura e cultura strumentistica). Ma se così è,
come ci pare, niente ci farà voltare quando sentiremo che è uscito il prossimo disco di Digital Leather.(6/10)
Gaspare Caliri
Donsettimo - Notte di mamma
(Malintenti Dischi, Novembre 2009)
G enere : folk - musica d ' autore
Ogni musicista ha un personale “crocevia”. C'era
il Diavolo in persona - almeno, così si narra - ad
attendere a quello di Robert Johnson per sottrargli l'anima e farlo diventare il più grande bluesman
Elm - Nemcatacoa (Digitalis,
Novembre 2009)
G enere : country - drone
Esistono diversi modi di raccontare il deserto. Quello che Jon Porras ha scelto di scrivere con il suo
progetto solista Elm, è il capitolo più mistico e metafisico di una ideale e ineasauribile desert session
che percorre tutta la storia del rock. Metà esatta
del duo di drone masters di stanza a San Francisco, chiamato Barn Owl, già autori di per sé di una
musica quanto mai alienata, quella di Elm è una fantasiosa elegia degli spazi vasti. Una base quanto mai
blues su cui sperimentare diverse gradazioni di echi
e riverberi a mimare un infinito che sembra potresti
toccare con una mano. Porras è un eccellente pittore di paesaggi. Di quelli languidi e abbandonati.
Lontano da Dio e dagli uomini, una natura silenziosa
e ripiegata su se stessa cura le proprie ferite ricurva
sul ventre molle delle proprie debolezze. Elm mima
con pochi mezzi una panoramica immensa: sparu-
te corde di chitarra acustica, scheletro blues su cui
innalzare cattedrali di droni maestosi come aurore
boreali (Nemcatacoa, Arc Of Wisdom); echi di sirena
su note sostenute dal piglio ipnotico (In The Shadow
Of Red Rock); romanze folk che si sciolgono acide al
sapore di peyote e droghe pellerossa (Silver Dust In
Moonlight, Sacrament At Dusk).
Il country-drone di Elm è come il western in bianco
e nero di Jarmush, una radiografia di elementi mitici
che come una visione alterata dagli acidi distorce
le cose più evidenti per rivelarti quello che c’è dietro.(7.5/10)
Antonello Comunale
Embassadors (The) - Coptic Dub
(Nonplace, Novembre 2009)
G enere : fusion
Secondo album, stavolta interamente strumentale, per il collettivo multietnico guidato dal fiatista
neozelandese Hayden Chisholm. Morbida fusion
e atmosfere come da deserto jazz-noir, suono (coproduce Burnt Friedman) impeccabile, disco suonato benissimo, protagonista il contrabbasso nodoso di Matt Penman (uno che di solito suona con
John Scofield). Un paio di pezzi intriganti, su tutti
la sinuosa arabeggiante Polar Sexus, il resto elegante
sofisticato sottofondo.(6.3/10)
Gabriele Marino
Flipper - Love (Mvd Visual, Maggio
2009)
G enere : noise
L’uscita di American Grafishy, disco della prima
ricomparsa dei Flipper, nel 1992, aveva una motivazione abbastanza trasparente. Si era immersi nel
grunge e coloro che dagli adepti del movimento furono considerati degli iniziatori non potevano che
presenziare all’evento. Chi scrive è tra quelli che minimizzano il collegamento Flipper-grunge (sebbene
in questo disco il basso sia suonato da Krist Novoselic, membro fondatore dei Nirvana); e che ciononostante oggi non rinuncia a posizionare Love in
un mercato di riferimento.
Il motivo è semplice: i Flipper di Love sembrano inseguire quello che già hanno fatto, quando hanno creato vie di fuga e nodi nella rete. Oggi riattraversano
quei corridoi che non possono che sapere di vecchio. Gran parte di questa sensazione è da addurre
alla mancanza (neanche questa una novità) del primo
vocalist Will Shatter, morto nel 1987. Bruce Loose,
che lo sostituisce oggi, fa quel che può, cioè la voce
recensioni
47
grossa; nei momenti migliori somiglia a Von Lmo,
nei peggiori è imbarazzante (Trasparent Blame).
Senz’altro alla band di oggi riescono meglio gli incubi
lunghi e lenti, piuttosto che quelli veloci. E nel mood
si gioca parte della differenza con il passato, che
in quanto tale è una buona notizia, visto che sono
passati 25 anni. Prendete Sex Bomb, che chiudeva
Album Generic: era infinita ma aveva qualcosa di
euforico. E ora prendete Old Graves, ultima traccia di
Love: altra prova dilatata dove però tutto è fosco.
E' questo il numero più convincente del lotto, visto
che finalmente la voce non è sgolata, non si sforza di
essere violenta, anzi si limita a essere uno spokenword rassegnato ma sostenuto. Peccato rimanga un
caso isolato.(5.8/10)
Gaspare Caliri
Fm Belfast - How To Make Friends
(World Champion, Ottobre 2008)
G enere : S ynth P op
L'aspetto a saltare all'orecchio per primo è l'estraneità ai classici suoni a cui l'Islanda ci ha abituati:
niente Sigur Rós e niente Mùm, per il trio della
Capitale (che alla bisogna s'allarga fino a trenta elementi), al loro posto la fetta di synth pop che ruota
attorno l'EBM, l'indie imbastardita con l'hip hop e
quel pizzico di Go! Team, il cui riferimento ci fa
sempre comodo in questi casi.
La miscela è autoironica e giocata sul cool, aspetto
che ha mandato in visibilio l'isola un anno fa che pacatamente ci convince a partire dal brano con il quale
probabilmente verranno ricordati: Pump Up The Jam,
cover dei Technotronic, qui in versione ultra sincopata. E non è la sola: Killing In The Name dei Rage Against
The Machine subisce lo stesso divertente trattamento portandosi a casa qualche sorriso.
La medesima carta arrangiativa - un equipaggiamento minimo che prevede due tastiere, una drum
machine e due microfoni dove corrono le strofe
intrecciate un po' alla Stereo Total di Árni Rúnar
Hlöðversson (Plúseinn) e Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir
- ce la ritroveremo nelle restanti tracce, intriganti soprattutto le conversioni bianchissime dei soliti
riferimenti black ovvero funk, disco e soul (Synthia,
Frequency, I can feel love). Attenzione però al disclaimer: è un disco mordi e fuggi, dietro alle citazioni
tamarre (leggi euro techno laser connessi), e ai momenti di puro cheese (Par Avion, President con le tastiere di Van Halen e Europe), c'è una batteria scarsa
quanto quella dell'Iphone.(6.3/10)
Edoardo Bridda
48
recensioni
Fontän - Winterwhila
(Information, Novembre 2009)
G enere : kraut chillwave
Due ragazzi da Göteborg riportano il paradigma
ibizenco a Nord e, senza accorgersene, si insinuano
nella scena glo-fi. Così, a base di krauti a merenda,
l’esordio di Jesper Jarold e Johan Melin viaggia
su coordinate new age (Backustugu), si bea del successo di Lindstrøm (mescolandolo con le chitarre
di David Gilmour in ...You Too), pompa nelle vene
l’energia di certi Goblin (le cavalcate prog da urlo
di Neanderthaler), aggiunge qualche spezia orientale tagliata con la lounge di Morricone e Umiliani
(il koto filtrato nello sciccosissimo downtempo di
Land Of The Dragon), rivanga gli '80 con il basso slappato che è marchio Japan (The Bridge) e sogna visioni pastello nella suite
conclusiva Nightrider.
Registrato in un capanno in mezzo ai boschi,
nell'album
ritroviamo
l’energia del sole balearico ma anche l'aurora
boreale. Il tramonto sul
mare trasfigurato in un
misto di rock à la Can
contaminato da tastierine disco, zampa d'elefante e
tanta anima in movimento. In bilancia: basi Donna
Summer e i capelli lunghi da progger. E' ancora remember, anzi, flash forward...(7.1/10)
Marco Braggion
Four Tet - Love Cry 12'' (Domino,
Dicembre 2009)
G enere : M inimal psych
Un singolo in edizione limitata piazzato (ovviamente dalla Domino, che segue Four Tet da quasi un
decennio, ormai) per far salire la proverbiale antiscimmia dell’IDMer. Un assaggio di There Is Love
In You, in uscita a gennaio, l’anello mancante tra
questo e il precedente Ringer EP.
Love Cry è il modo in cui Kieran apparecchia la
discussione mostrandoci gli agoni che animano la
sua musica, gli opposti che hanno però una radice
comune, fosse anche solo il tavolo dove giocare a
scacchi.
Minimo comune denominatore, una quasi-parola:
minimal. Che a essa gli si faccia succedere -ismo (e
che la si traduca in meditazione trascendentale), oppure o che lo si isoli per trovarla contestualizzato
nell’elettronica, è la ripetizione e la trance indotta
- niente a che vedere con le catarsi psicotrope - ad
arare il campo di Four Tet.
I campanellini di Our Bells sono le sue riflessioni
orientali. Da perfetto londinese di origini indiane
qual è, Hebden non ci arriva certo con viaggi col
pensiero, ma con il lavoro di studio, certosino fino
alla mania, al quale ci ha abituato. E che trascina per
nove minuti anche Love Cry, traccia (presente anche
sul My Space) che davvero sa di apripista (da camera) del corso di Four Tet 2009-2010. E l’attesa sale
ancor di più.(7/10)
Gaspare Caliri
Francesco Buzzurro L'esploratore (Irma Group,
Novembre 2009)
G enere : chitarra cl as sica / jazz
Fa zigzag e torna alla chitarra sola di Freely (2002)
Francesco, dopo avere ripreso con Naxos (2006)
il discorso col Quartet, inaugurato da Latinus
(1999). Se in Freely rileggeva per lo più classici jazz e
latin, qui si concentra su classici "etnici", dalla Sicilia
agli Stati Uniti passando per la Spagna, dalla Grecia
alla Cina passando per la Russia. Francesco ne conserva le specificità senza scadere nel cartolinismo
(rischio che si corre se si ha a che fare con Tico Tico),
iniettando della sua debordante mediterraneità, ora
solare ora agrodolce, brani anche lontanissimi dalla
nostra tradizione musicale.
Buzzurro, nato a Taormina, formazione classica e
tecnica cristallina, cuore votato alla melodia e al
ritmo, insegue sempre il filo dell'emozione, in un
modo che a chi non lo conosce può forse apparire
retorico, e invece è semplicemente genuino. I suoi
due dischi in quartetto sono senza mezze misure
pirotecnici, con brani autografi e riletture sorprendenti per freschezza e incisività. L'esploratore, pur
sentito e intenso come sempre, ci sembra la sua
creazione meno bella finora: e questo la dice tutta
sulla qualità della sua musica.(7/10)
Gabriele Marino
Gemma Ray - Lights Out Zoltar!
(Bronzerat, Ottobre 2009)
G enere : folk - pop - psych
Superato il primo impatto con una copertina a dir
poco orripilante e per nulla rappresentativa della
musica contenuta in Lights Out Zoltar!, potreste anche scoprire uno dei vostri dischi dell'anno. A patto che siate consapevoli ammiratori del lavoro di
Lee Hazlewood, dei Beach Boys e in generale
di certe cadenze tarantiniane anni sessanta/settanta
venate di rimembranze chicane - 1952 e 100 mph
(in 2nd Gear) - e “cowboy psychedelia”. Locuzione,
quest'ultima, che starebbe ad indicare lo stile dei
brani dello stesso Hazlewood portati al successo
anche da Nancy Sintatra - su tutti This Boot Are
Made For Walkin' ma anche la Bang Bang (My Baby
Shot Me Down) di Sonny Bono -, materiale non
troppo distante nella concezione generale da quanto si ascolta in questo secondo disco dell'inglese
Gemma Ray.
L'obiettivo, in questo caso, è attualizzare l'imprintig
di base mascherandolo con un pop di scuola anglosassone (Tough Love), progressioni a marca Portishead (Snuck A Peek), un' Isobel Campbell decisamente folk (No Water) e vaghezze oniriche (If You
Want To Rock And Roll), pur mantenendo gli aromi
legati a un certo tipo di immaginario. Più o meno gli
stessi che nove anni fa fecero la fortuna degli Shivaree di Ambrosia Parsley, con quella Goodnight
Moon tratta da I Oughtta Give You A Shot In
The Head For Making
Me Live In This Dump
tutta sensualità e fascino
d'antan.
Ecco. Dove la band americana era fashion ed eleganza patinata da classifica,
l'artista inglese è creatività e accelerazione sul versante psichedelia, nell'ottica di un disco che riesce a
suonare fresco anche senza inventare nulla di nuovo.(7.2/10)
Fabrizio Zampighi
Gianmaria Testa - Solo dal vivo
- Special edition (Produzioni
Fuorivia, Ottobre 2009)
G enere : canzone d ' autore
Tra i migliori cantautori italiani per quanto riguarda la performance dal vivo in qualsiasi situazione
e formazione (solo, duo, trio), Gianmaria Testa
propone qui la registrazione di un intero concerto tenuto nel maggio del 2008 all'Auditorium Parco
della Musica di Roma. Il disco era già uscito all'inizio
dell'anno e viene ora riproposto con un bonus dvd
contenente un'intervista e un videoclip. L'intento
dell'operazione è sicuramente antologico ma anche
e soprattutto “fotografico”, visto che l'uscita del cd
non era prevista ed è stata decisa solo per la particolare intensità dell'esibizione e per la sintonia crerecensioni
49
atasi tra il titolare e il pubblico. Intensità e sintonia
che si ritrovano in toto nella registrazione, non eccelsa sotto il profilo tecnico ma vivida come certe
foto scattate per caso e senza troppi accorgimenti
che riescono a cogliere l'anima di ciò che è ritratto.


Testa per l'occasione si accompagna con la sola chitarra e propone uno dietro l'altro brani da tutti i suoi
dischi, con una particolare attenzione verso l'ultimo
Da questa parte del mare risalente ormai a tre
anni fa ed in apertura una cover de La nave di Angelo Ruggiero. In chiusura, invece, l'unico inedito
intitolato Come al cielo gli aeroplani e registrato in
studio. 

Non fa nulla di straordinariamente nuovo il cantautore piemontese ma ciò che fa lo fa straordinariamente bene. Una canzone d'autore, la sua, che
sull'onda di Ivano Fossati e Paolo Conte - ma è
una parentela più vocale che altro - dosa con parsimonia accordi e versi, insistendo su una scrittura che narra procedendo per scorci evocativi ed
immagini quotidiane ma fantasiose. Grazie ad una
capacità interpretativa in grado di pesare le parole
al meglio e ad una voce che sa di terra coltivata e
fumo, sul palco le sue canzoni sanno prendere vita
più che su disco (Dentro la tasca di un qualunque mattino e Biancaluna su tutte). Provare per credere in
questo live, punto di partenza ideale per un primo
approccio all'artista.(7/10)
Luca Barachetti
Githead - Landing (Swim, Novembre
2009)
G enere : new wave
E’ impossibile accostarsi ai Githead senza tenere
in considerazione il curriculum di chi vi suona. Poiché non si tratta di carneadi o esordienti allo sbaraglio, bensì di gente in circolazione da decenni e
che in un caso ha pure fatto la Storia, il campo non
lo puoi livellare. Uscita numero tre in un lustro, a
due anni da un Art Pop che convinse se non esaltò,
Landing non teme né pretende confronti; diligente e
sereno, si mette in fila a osservare la propria contemporaneità. Mai dubbia e a maggior ragione da
che (facciamo un paio di annetti) l’ennesimo revival
del Post-Punk è in grave debito d’ossigeno. Verrebbe da obiettare che è facile, se di nome fai Colin
Newman, Malka Spigel, Max Franken e Robin
Rimbaud/Scanner, uscire con martellamenti secchi tuttavia agili, bassi rotondi e chitarre taglienti,
pop e paranoia. La magia sta comunque nella fre50
recensioni
schezza, in quell’attitudine diventata realtà e nelle
visioni plasmate a concretezza.
Qui allora il punto, cui si deve aggiungere l’appartenenza allo ieri che chiamiamo attualità e che frantuma le ossa a ogni sbiadito clone: inquadri subito
Lightswimmer e Take Off come figlie spirituali di Chairs Missing (Over The Limit di 154: ma il basso dub,
sbiancato e genialmente trattenuto?) finché la voce
le consegna ai primi Stereolab e attorno si levano
energici aloni shoegaze; lo stesso valga per From My
Perspective e Before Tomorrow spostando la lancetta
su A Bell Is A Cup. Accelerate la ritmica di Displacement & Time ed ecco Madchester a cavalcioni della
jungle, laddove la title track ricopre di zucchero i
Neu! e Ride immagina Laurie Anderson in vesti
jazz-wave.
Infine, il capolavoro Transmission Tower gestisce otto
minuti di (falso) ghiacciaio emotivo con disinvoltura esemplare. Basta e abbonda, giacché Landing non
approfitta subdolamente della nostalgia e preferisce indicare una via per riappropriarsi di coraggio e
avanguardia nella forma canzone. La testa ronza, e ci
sentiamo leggeri come di rado accade.(7.4/10)
Giancarlo Turra
Golden Serenades - Hammond Pops
(+3dB, Ottobre 2009)
G enere : H ammond N oise
Jørgen Træen e John Hegre non sono due novellini.
Sotto il moniker Golden Serenades, i due norvegesi torturano i timpani degli incauti ascoltatori
già dal lontano 1999 e da allora ad oggi hanno dispensato svariate cassette, Cd e Cd-r che sanno di
apocalisse e che fanno sanguinare le orecchie. La
loro specialità, e il motivo sostanziale per il quale ne
parliamo, è l'instrument bashing: ovvero il suono degli
strumenti mentre vengono distrutti. Del tipo che,
nel 2007, mandano in pezzi una chitarra del valore
di 5000 dollari e che anche i momenti più blandi
farebbero impallidire i sabotaggi dei primi Einstürzende Neubauten.
Con Hammond Pops il duo s'allarga a trio. Entra l'organista e ricercatore Sigbjørn Apeland e il titolo del
disco si traduce in "scoppi di hammond", quelli che
i tre fanno fare al malcapitato strumento. L'incubo
è totalizzante, tra picchi acuti e distorti e violenza sconvolgente come solo un maelström dei loro
mari artici potrebbe essere. Figura centrale:Apeland
e gli sconfinati modi attraverso i quali agghiaccia, e al
contempo, ammalia l'ascoltatore.
Quello dei Golden Serenades non è un mero as-
highlight
Kuupuu - Lumen tähden (Time Lag, Novembre 2009)
G enere : P re - birth folk
Dal lotto delle sorprese weird-finlandesi, di cui Comunale e Collepiccolo, avevano già parlato,
sfugge un personaggio finora rimasto ai margini, ma non meno necessario. Si tratta di Kuupuu,
al secolo Jonna Karanka, agitatrice di quell'oggetto non-identificato posto sotto le direttrici della
scena finlandese, variopinta freakkeria di folkers e noisers. La Karanka
solo per confermarne l'ossutezza sta dietro a nomi quali Avarus, The
Anaksimandros, Maniacs Dream, Kukkiva Poliisi, Hertta Lussu Ässä, ma Kuupuu resta a tutt'oggi il suo progetto principale.
Cantautrice acid, manipolatrice di objet-trouvé, impastatrice di pittura
e collageista psichica, Kuupuu approda su Time-Lag, dopo due buoni
lavori su Dekorder. Le sue composizioni sono come i suoi quadri: isterismo cronicizzato da incanti vaudeville, oggetti-senza-oggetto dispersi
tra lividi colori pastello, volti mozzati su lane-mosaico.
Kuupuu è la croce ed Islaja la testa della stessa moneta: la prima forza
l'ascolto all'inferno, la seconda ammalia come un'incantatrice di cobra. In Kuupuu c'è del ferro
pesante, in Islaja un lago tra foreste; una è il corpo, l'altra l'anima. Non sorprende la vicinanza di
ambedue, con l'altra principessa Lau Nau: un modo tutto angelico e diabolico di fare-musica dopo
l'apocalisse.
Lumen tähden è una foresta tantrica con i suoi personaggi depressi ed onnivori, i suoi pianoforti malandati, le arpe attraversate da pietre smeraldo, l'inferno dei campioni harsh, le svolate
perpendicolari delle viole e dei carillon, le pennellate colorate ed inusuali.
Se la musica è un immaginario prima che un suono, se è fatta di visioni trascendenti e sferzate cataclismiche, questa è la sua cripta, come quei musei egizi dove il tempo pareva fermarsi nell'altrove e nel domani. Sarebbe impossibile descrivere le coordinate di Kuupuu: si passa dal forest-folk al
drone sinfonico, dal pre-birth folk alle vocalizzazioni Fursaxa, dai campionari pianistici eleganti al
surrealismo ipnotico. C'è molta ossessione nelle linee vocali, frasi che si ripetono come una cantilena malefica, un rito stregonesco. Un rebus la cui forza sta nell'avere una terra dietro: la Finlandia
sempre attraversata dalla notte; e un genere musicale che ha il sapore di una magia antichissima
e fieramente inattuale.(8.2/10)
Salvatore Borrelli
salto frontale; una sorta di malsana dipendenza si
insinua mentre si è sottoposti agli eccessi dell'unica
traccia di 40 minuti. Un effetto narcotizzante che
impedisce la fuga. Solo per palati estremi e ruvidi,
ciò nondimeno attenti, come non mai.(6.8/10)
Andrea Napoli
Heavy Trash - Midnight Soul
Serenade (Fat Possum, Novembre
2009)
G enere : folk blues rock
Heavy Trash atto terzo vede la ditta Jon Spencer &
Matt Verta-Ray sempre più simbiotica ed efficace, in
quello che si delinea sempre meno come un capriccio della mezza età e sempre più come un progetto dal senso compiuto. Con della sostanza annidata
tra i ruggiti fumettistici, i ghigni gotic, le melliflue
pseudo-nostalgie, la verve da fantasma carnoso
degli Elvis andati. Un Elvis primitivo, scosso dalla
stessa demoniaca possessione che rese possibile il
big bang delle Sun Sessions, figura dai contorni
scomodi, misteriosi e tutt'oggi minacciosi, con le radici affondate nella zona d'ombra della multicultura
americana.
Va da sé che i Nostri ci si tuffano di testa. Sgranano
un rosario acido di rumbe sgranate ed errebì torrecensioni
51
vi, squarciano tex-mex tarantiniani e soul caramellosi, spiaccicano al suolo un blues tra cianfrusaglie
e borbottii cinematici psych fino a farlo sembrare
un prequel trip-hop (The Pill), oppure lasciano che
una tempesta Cramps frusti lo stomp appiccicaticcio di Bedevilment. I ciuffi impregnati di catrame,
gli organi fumettistici, il piglio stradaiolo e quel senso di malia assieme calda e insidiosa dominano gli
spurghi estrosi di Good Man, la circospezione androide di Isolation, la caramellosa In My Heart (al sapor Ritchie Valens), una (Sometimes You Got To Be)
Gentle che fa azzuffare i primi Rolling Stones coi
Primal Scream più roots e quella Bumble Bee che
rifà un vecchio cavallo di battaglia errebì (l'originale
è di Lavern Baker, anno domini 1960) come un
amante posseduto dallo spirito killer di Jerry Lee
Lewis.
Pensavo fossero pantomime, invece somigliano
sempre più a carotaggi sonori nella carne malsana
ma (ancora) viva dell'immaginario rock.
(6.9/10)
Stefano Solventi
Helena Verter - Questione di ore
(Sana Records, Novembre 2009)
G enere : rock - wave
Questione di ore è un fulgido esempio di un rock
all'italiana che funziona. Materiale che dalla new
wave nostrana di fine anni Ottanta - inizio Novanta
riprende la tendenza a declinare le influenze musicali estere in una formula musicale di stampo generalista - senza che al termine vengano assegnate
connotazioni negative -, poco riconoscibile e fortemente legata ai tempi e ai modi di chi suona. La
sensazione che si prova davanti a brani come Squali avvoltoi buffoni voyuer, Gondole viola, 5mg...di vero
niente è un po' quella che si doveva provare negli
anni Sessanta ascoltando i gruppi beat nostrani che
copiavano i modelli inglesi: un dejavù controllato dal
sapore peninsulare e valorosamente provinciale.
Degli Helena Verter si apprezzano testi capaci di
unire significati e musicalità ragionata, una voce femminile virtuosa e mai sopra le righe, la sobrietà degli
arrangiamenti, l'onestà creativa. In una produzione
geograficamente ben radicata nel costume - quello
intelligente - di casa nostra e venata di rimembranze
autoriali per nulla campate in aria.(7/10)
Fabrizio Zampighi
52
recensioni
Hello=Fire - Hello=Fire
(Schnitzel, Ottobre 2009)
G enere : rock
Hello=Fire è la creatura solista di Dean Fertita,
membro in pianta stabile dei Queens Of The Stone Age nonché touring member dei Raconteurs
e recentemente accanto a Jack White nei fin troppo chiacchierati Dead Weather. Che cosa faccia
in questo nuovo (ennesimo) progetto lo si capisce
dai musicisti che lo accompagnano, a partire da quel
Brendan Benson già con lui nei Raconteurs - e che
qui firma insieme al titolare cinque brani - passando per Michael Horrigan
degli Afghan Whigs
fino a Troy Van Leeuwan,
Joey Castillo e Michael Shuman dei QOTSA:
rock, of course, virato al
più classico classicismo
sessanta-settanta con ingenti dosi di psichedelia,
prima passione di Dean.
Dunque riffarama a non finire, lisergici com'è ovvio
quando non semplicemente vitaminici, gran lavoro
operaio d'organi che crea fondali e occupa spazi e
una carica che in quaranta minuti non cede mai il
passo se non per l'immancabile ballad. Qui arriva
alla traccia cinque, con una Nature of our minds inacidita e sognante che appoggia sul ricamo acustico
luccichii di rhodes e chitarra reverse. Il resto, come
si dice in questi casi, piacerà a chi già piacciono i
gruppi sopracitati (soprattutto i Raconteurs) ma
anche i Super Furry Animals, rimanendo l'ascolto piacevole anche per tutti gli altri.(6.3/10)
Luca Barachetti
I gatti mézzi - Struscioni (SAM,
Novembre 2009)
G enere : jazz
Il nome scelto per il gruppo e il titolo del disco
fanno sorridere. Eppure anche questi sono dettagli
importanti nell'ottica del progetto. Un immaginario
in cui rientrano Paolo Conte, Fred Buscaglione,
Enzo Jannacci e tutta quella scuola musicale “alta”
in bilico tra eleganza e ironia che ha fatto un po' la
fortuna commerciale del jazz italiano.Tradizione che
i Nostri fanno propria, facendola girare su uno swing
in dialetto pisano infarcito di cronaca locale e toni
semiseri da “toscanacci” d.o.c..
Dietro alla ragione sociale si nascondono Francesco Bottai e Tommaso Novi, oltre ai musicisti
aggiunti Matteo Anelli e Matteo Consani, per
un quartetto più o meno classico (pianoforte, voce,
contrabbasso, batteria, chitarra e fischio) che gioca
con certe rincorse scapicollanti à la Conte (Portami
a pescare) come con lentezze melodiche crepuscolari da night club anni quaranta (Morandi). Su arrangiamenti che da un lato dimostrano una certa classe
nel reinterpretare cadenze nobili del jazz francese e
autoctono e dall'altro stupiscono per vitalità.
Non per originalità, però, visto e considerato che
c'è chi questa formula l'ha praticamente inventata. Il
gruppo comunque conosce bene il mestiere e stando a quanto si sente in giro sembra pure diventato
un piccolo “caso” a Pisa e dintorni.(6.9/10)
Fabrizio Zampighi
I've Killed The Cat - Forgiveness
Party EP (Smoking Kills, Dicembre
2009)
G enere : blues - rock - wave
C'è una buona componente glamour negli I've Killed
The Cat. Un'impeto rock & roll "de noiartri" che
va dalle capigliature scapigliate à la Nick Cave periodo berlinese alle giacchette strette di pelle, dagli
scatti in bianco e nero in pose da Rimbaud della
chitarra elettrica ai Ray-Ban d'ordinanza. I nostri
Stooges di quartiere non si fanno mancare nulla
e dimostrano di aver trascorso una giovinezza felice a scartabellare tra i
magazine specializzati e
i dischi dei fratelli maggiori. Prendendo dagli
stessi ciò che ritenevano
più adatto a veicolare la
propria voglia di rock e
di vita “on the road” nei
club alla moda della Milano da bere. Nello specifico, voci che più Iggy Pop
di così non si potrebbe, il fascino sdrucito di certi
Gun Club e un pizzico di wave-post punk ultimo
periodo, giusto per non scontentare nessuno.
Il risultato è un suono di chitarra, batteria, basso e
synth semplice, immediato, persino orecchiabile, ma
con poche pretese. Roba che se fossimo nel 1969
e senza tutto quello che si è ascoltato di lì in avanti a Detroit e dintorni funzionerebbe pure, ma che
nell'Anno Domini 2009 porta l'azienda a un inevitabile commissariamento. In attesa di un primo disco
lungo che speriamo non si trasformi in un fallimento annunciato.(6/10)
Fabrizio Zampighi
Illàchime Quartet - I'm Normal, My
Heart Still Works (Fratto9 Under
The Sky, Settembre 2009)
G enere : avant - jazz
Della serie meglio tardi che mai, ci ritroviamo tra le
mani un disco che sarebbe peccato mortale non evidenziare. In primo luogo per il ricco parterre de roi
schierato per l’occasione di supporto all’Illàchime
Quartet: Rhys Chatham, Mark Stewart (Pop
Group e Maffia), Graham Lewis (Wire) e il jazzista nostrano Salvatore Bonafede. Poi perché, seppur
valide e roboanti, queste insigni presenze non sono
l’unico motivo di vanto di I’m Normal, My Heart
Still Works.
L’ensemble napoletano - Gianluca Paladino (chitarra, samples), Pasquale Termini (cello, synth) e Fabrizio Elvetico (piano, basso elettrico) con l’ospite
fisso/quarto membro Agostino Mennella (batteria,
electronics) - è un vero portento nell’amalgamare
elettronica e strumentazione acustica, fondendo
il freddo e asettico portato della prima con il caldo fluire della seconda. La miscela che ne esce è
letteralmente esplosiva: se di base I’m Normal… è
un disco che si nutre di post-(punk)-rock jazzato
e avanguardistico, la commistione infrageneri e la
stratificazione di suoni trovati e/o modulati unita
alle screziature fornite dai vari ospiti ne fa un mix in
cui convivono slanci neo-cameristici e deformazioni
wave, silenzi anatrofobici e invettive da Pop Group
del terzo millennio, aperture etno-jazz, richiami al
rock cinematico e citazioni davisiane; il tutto spesso suonato con un incedere angolare e in modalità
improvvisativa.
E se Discentro e Terminali (Source) si fanno preferire
- la prima in virtù di un techno rock vorticoso impreziosito dall’ugola al vetriolo di Mark Stewart; la
seconda per il senso (e)statico ed ectoplasmico della composizione - in ogni pezzo dell’album vive un
microcosmo di suoni/sensazioni che necessiterebbe
di una rece a parte per essere descritto. Insomma, è
l’intero album a mantenersi su standard veramente
eccellenti, a dimostrazione di una rinascita napoletana (si veda A Spirale, Mesmerico, Asp/Sec) in
ambiti out-rock.(7.5/10)
Stefano Pifferi
JC Brooks & The Uptown Sound Beat Of Our Own Drum (Vampisoul,
Novembre 2009)
G enere : vintage soul
A meno che non si tratti di una (non granché) umorecensioni
53
highlight
Ninni Morgia Control Unit - Ninni Morgia Control Unit
(Ultramarine, Dicembre 2009)
G enere : free - jazz psichedelico
Quello di Ninni Morgia from Catania è un girovagare artistico oltre che fisico. Lo spostamento
verso NYC, mecca indiscussa di certo rock rumoroso, alla distanza è equivalso alla necessità
quasi fisiologica di allargare i confini di un suono al quale era legato e col quale era cresciuto.
Questa (in)consapevole e costante crescita ha fatto vedere i suoi frutti sia nella padronanza dello
strumento - sempre più matura e personale -, sia nell’allargamento
dei riferimenti - ormai un vero e proprio universo fluttuante in cui
convivono noisers e jazzisti, bluesman e folksters - e soprattutto nella
considerazione di pubblico e critica, colti e non.
Tutta questa premessa per introdurre quella che è, ad oggi, la migliore prova del nostro. Giocato proprio su un terreno a lui non nuovo,
quello della copula tra free jazz spirituale e psichedelia diluita e mistica,
NNCU vibra di nuovi stimoli grazie anche a compagni di ventura non di
poco conto. Ad accompagnare la chitarra di Morgia sono il batterista/
percussionista Jeff Arnal e soprattutto Daniel Carter, sassofonista
e multistrumentista già avvistato in una collaborazione coi Talibam! e tra i più attivi della scena free newyorchese. Non di poco conto il fatto che elementi del genere - si nota anche Scott
Colburn in cabina di regia - si “prestino” ad un progetto focalizzato intorno alla figura di Morgia,
vero?
Tutto meritato. L’ennesima creatura di Morgia è un concentrato di alta scuola jazz-psych, in cui
suite raga senza tempo e visioni davisiane, mantra inaciditi e mistici deragliamenti free convivono
agilmente e in splendido equilibrio. NNCU è uno splendido doppio vinile in cui non c’è realmente
una nota fuori posto. La dimostrazione dello spessore di un Artista.(7.5/10)
Stefano Pifferi
ristica boutade, JC Brooks e i tre Uptown Sound
- visi pallidi provenienti da Chicago a chitarra e sezione ritmica - hanno una bella opinione di se stessi.
Si descrivono come Otis Redding accompagnato
dagli Stooges. Beato il “brother” che ci crede, essendo la verità ascrivibile alla moda che nell’ultimo
lustro testimonia un ritorno al soul come lo si suonava nei Sessanta e/o nei primi Settanta. Non possedendo corde vocali memorabili, JC si appoggia ai
propri santini - Curtis Mayfield, Donny Hathaway, giustappunto Otis - mentre la band gli sfacchina dietro con appassionato calligrafismo. Dunque
non si capisce che c’entri l’approccio iconoclasta
alla negritudine di Iggy Pop e soci, giacché la filologia domina e siamo lontani dalla ruvidezza dei BellRays (l’ottimo stomp Baltimore Is The New Brooklyn
vorrebbe ma è troppo stiloso…).
Forse dal vivo le cose stanno diversamente: fatto
54
recensioni
è che del manuale del perfetto soulboy non manca nulla, dai “booty shakers” (Alright, l’invocazione
al fu patron della Motown Berry Gordy in Berry
Please…) alle sensuali ballate (Here Comes The Fall)
e gli spigliati tempi medi (Love One Another, 75 Years
Of Art Sex); trovate il gusto pop “di una volta” (Hold
You Back, una He Does The Town che immagina il giovane Joe Jackson risvegliatosi con la pelle nera) e
la produzione puntualmente elegante.Tutto “piuttosto” godibile, comprese liriche non banali che compensano la penna non esattamente brillante ed è
uno dei due problemi. L’altro essendo la carenza di
personalità che fa spiccare il balzo autentico sopra
la massa.(6.8/10)
Giancarlo Turra
Jello Biafra - Jello Biafra & The
Guantanamo School Of Medicine The Audacity Of Hype (Alternative
Tentacles, Novembre 2009)
G enere : punk - hc
Riemerge di tanto in tanto come un fiume carsico
della controcultura occidentale. Ed ogni volta bastano pochi, brevissimi secondi del suo cantato per
riconoscerlo e far riaffiorare in chi ascolta mille e
mille ricordi. L’affronto/sberleffo di fine '70 ad una
intera cultura dominante con la scelta di chiamare il
proprio gruppo i Kennedy morti (immaginatevi oggi
un corrispettivo italiota cosa provocherebbe…);
l’ascesa/provocazione politica che lo portò a sfiorare la poltrona di sindaco di San Francisco; le mille
dispute col sistema che ne fiaccarono temporaneamente la carica sovversiva (il processo per la inner
sleeve di Frankenchrist o quello contro la Alternative
Tentacles…). Su tutto, il punk straight in your face dei
Dead Kennedys.
Poi, una volta dismessi i panni di frontman di quella
band epocale, Jello Biafra - metà Johnny Rotten, metà
Noam Chomsky - ha intrapreso una carriera equamente divisa tra spoken word al vetriolo e caustici
one-shot d'appoggio a band sodali quali D.O.A., Melvins, Mojo Nixon e NoMeansNo. Adesso è il turno
della Guantanamo School Of Medicine, estemporanea (ma non troppo…) e solidissima formazione che
coinvolge personaggi come Billy Gould (Faith No
More), Ralph Spight (Victim’s Family), Jon Weiss
(Sharkbait) e Kimo Ball (Freak Accident) e che si
propone fresca e velenosa come nella migliore tradizione del nostro. In The Audacity Of Hype non
c’è, però, traccia dell’hc evoluto dei Victim’s Family
o delle schizofrenie rock dei FNM, ma soltanto per
corpose, potenti, devastanti stilettate sotto forma di
punk song impreziosite dall’ormai leggendario cantato al curaro di Jello Biafra. Clean As A Thistle, New Feudalism, la stupenda Electronic Plantation vivono dello
stesso spirito aggressivo, ironico, amaro e caustico
dei primi Dead Kennedys con Jello Biafra spirito libero e contro che, come si premura di rassicurarci nel
conclusivo tour de force I Won’t Give Up, ha ancora
molto da dire. Lunga vita a Jello Biafra.(7/10)
Stefano Pifferi
Jewelled Antler Collective - The
Jewelled Antler Library (Porter
Records, Luglio 2009)
G enere : N ature P sych
La Jewelled Antler Collective merita un posto
d'onore nelle vicende dell'ultimo decennio (weird)folk. Creata da Loren Chasse e Glenn Donaldson nel 1999, come un'estensione dei Thuja, il collettivo ha concentricamente riguardato nomi più o
meno altisonanti del panorama dell'Outdoor-Folk
internazionale. Gli artisti coinvolti fanno Nature
Psych, ovvero registrano all'aperto, con mezzi
di fortuna in condizioni
estemporanee. Una sorta di "Dogma", di accordo stabilito a-priori tra
gli adepti su taluni punti. 1) le riprese sono quasi sempre field recordings
bucolici, dove a risuonare è "l'aperto" insieme agli
strumenti stessi come fossero parte della natura; 2)
la scelta del luogo: spazi abbandonati come esterni
di negozi, cantieri dismessi, vecchi capannoni industriali o spiagge assolate; 3) l'uso preferenziale di
alcuni "oggetti" come terriccio, erba, arbusti, carta,
sassi, in simultanea ai suoni; 4) lo strumento inteso come "Arpa" sia da sfregare con l'archetto, che
d'accarezzare per produrre note aperte e lunghe.
Porter Records ristampa i primi dodici 3” in quattro cd con box cartonato. Dentro ci troverete tutte
le copertine di quei lavori che impiegarono l'arco
di un anno, per venire alla luce con singola uscita
mensile. Si parte dalla giungla metafisico-zoofila di Loren
Chasse, per toccare gli interstizi merzbowiani
e catacombali di Tomes; la liturgia autunnale di Ivytree cade come foglie secche tra ballate e canti
d'uccelli; fino ai balcani di Steven R. Smith con i
suoi Hala Strana che suonano tra la desolazione
di cani che abbaiano su chitarre straziate. Tre sonnambolici soliloqui con voce recalcitrante e chitarra
contrappuntata per Dead Raven Choir, passando
per lidi più angelici ma comunque oscuri con Famous Boating Party, fino alle astrazioni cacofoniche e disperate del finlandese Uton. Claypipe
sforna alcune cantilene che suonano come lo Julius
Caesar di Smog, voce compresa; Thuja si presenta
con due composizioni-manifesto: musica concreta
per dronica roboante, oggetti percossi, campanellini
e caos: San Francisco come baricentro emotivo della nuova-psichedelia. Harbinger of spring di Fursaxa
è il diamante del lotto: 18 minuti di vocalizzazioni
celestiali, flauti pan, fiori a cascate, petali che si staccano dal cervello. Un colpo sorprendente al cuore
di disarmante ed autentico forest folk. A seguire il
recensioni
55
folk magico di Kemialliset Ystävät, carico di figure ipnotiche. Chiude il box, Ways of God to Man,
altro progetto di Chasse e Donaldoson, la loro cosa
meno riuscita.
Lo Psych-folk con Jewelled Antler diventa acqua,
terra, vento e fuoco; qualcosa di metafisico che non
risiede più dentro un brano con chitarra, voce ed un
delay. E' come se l'ambient naturalistico di Eric La
Casa ed il folk intimista di Pearls Before Swine
convivessero in uno spazio completamente assediato da fantasmi e visioni alchemiche.(7.8/10)
Salvatore Borrelli
Jim Jones Revue (The) - Here To
Save Your Soul – Singles Volume
One (Punk Rock Blues, Novembre
2009)
G enere : r ' n ' r
Arde in fretta e si immola completamente al verbo
del rock’n’roll questo Here To Save Your Soul.
Come recita il sottotitolo non di disco originale si
tratta, bensì del recupero di 4 singoli pubblicati tra
le fine del 2008 e il 2009. Quattro singoli per otto
pezzi e nemmeno mezz'ora di bruciante, incattivita,
arrogante rock’n’roll music tanto che essi stessi
la indicano “guaranteed
to rock any house party till the roof falls in”.
Insomma, un piccolo ed
agguerrito bignami che
parte da Elvis e Little Richard (le due cover di Big
Hunk O’ Love e Good Golly
Miss Molly, rispettivamente), passa per le brutture
della Detroit dei sixties, supera a destra il primo
della Jon Spencer Blues Explosion e arriva fino
ai Dead Weather di cui, non a caso, supportano le
date in terra d’Albione.
La band dell’ex Thee Hypnotics, e ci saremmo
meravigliati del contrario, è molto più tradizionalista nel trattare la materia: ciò che importa è solo
che le spie degli ampli siano sempre al rosso come
nell’iniziale Rock’n’roll Psychosis (il punto di contatto tra Jerry Lee Lewis e i Birthday Party?), nel
bluesaccio limitrofo ad un rochissimo Tom Waits
alla guida degli MC5 di Burning Your House Down,
nella fusione postatomica di Chuck Berry e Sonics di Princess And The Frog. Uniche pecche, la brevità
e il fatto che siano già pezzi editi.(6.5/10)
Stefano Pifferi
56
recensioni
Joan of Arc - Flowers (Polyvinyl
Records, Giugno 2009)
G enere : post indie
Non sai mai come pigliarlo un disco dei Joan Of
Arc, tanto il caso suona anch’esso una sua musica,
sbilenca e perciò perversamente adeguata. Nello
specifico, Flowers consta di brani ricavati da quattro distinte sessioni in compagnia di altrettante diverse formazioni, unico comune denominatore la
presenza del deus ex machina Tim Kinsella. Che
dici libero come sempre di sperimentare e colpire
in contropiede le aspettative dell’ascoltatore con la
naturalezza di chi la stravaganza ce l’ha nel DNA.
Gli eccessi di autoindulgenza stanno sulle dita di una
mano e per l’ennesima volta avanza spazio. Quando
arrivano, perdoni subito Tim perché maneggia uno
spirito dotto in maniera educata, del tipo che non ti
sbatte in faccia la collezione di volumi di semiotica e
la laurea incorniciata al muro. Un intellettuale americano, per questo somigliante più a Mayo Thompson che a Green Garthside e coerentemente i
suoni vanno dietro a tale carattere.
Lungo gli accidentali e sempre apprezzati percorsi
riconoscenti a Red Krayola, Art & Language e
Gastr Del Sol (prevalgono l’ondeggiare sensazionale del brano omonimo e una sdrucciolevole Tsunshine) inciampi in frammenti e deviazioni. Ben vengano l’elettro-wave gustosamente d’annata (Fogbow) e
la vibrazione urbana colata dallo stampo velvetiano
(Delicious Herbal Laxative); le citazioni lucide di Robert Wyatt (The Garden Of Cartoon Exclamations),
la psichedelia in prestito (restituita liquida in Explain
Yourselves e contorta per Life Sentence/Twisted Ladder) e i bordoni e i rumori che sembrano scale nei
quadri di Escher. Ti pigli un’emicrania se cerchi ciò
che non può esserci, ovvero un senso convenzionale che sorregga il tutto. Le dettano i punti interrogativi, le regole, e un sagace enigmista con fior di
genitori di cui va orgoglioso. Sono indubbiamente
altri i lavori su cui si fonda la bellezza della pulzella
di Chicago, ciò nonostante si ascoltano qui cose che
voi umani…(7/10)
Giancarlo Turra
John Zorn - Femina (Tzadik,
Ottobre 2009)
G enere : musica da camera + concreta
Zorn torna al collage via game card e dirige un ensemble di sole donne (con Laurie Anderson ad
introdurre il tutto) per un omaggio all'eterno femmineo, incarnato da figure come Meredith Monk,
Frida Kahlo, Gertrude Stein, Yoko Ono. I momenti
strettamente musicali sono spesso molto belli, focalizzati sulla recente riscoperta zorniana del minimalismo (molti suoi dischi 2009), con passaggi solari
e romantici - guardando a Sakamoto - e altri più
solenni (l'inizio della terza traccia). E' però proprio il
giochetto dell'alternanza rumore-melodia a sembrare stanco: stanchi i siparietti "di disturbo", ricalcati
sopra quel Zorn che ama incasinare il camerismo
con inserti concreti, quasi a rifare il collage sessantottino zappiano di Lumpy Gravy (la cosa appare
in tutta la sua sconcertante evidenza nell'incipit della seconda traccia, tra archi schonberghiani, rumori
metallici e versacci umani).
Forse progetti del genere verrebbero meglio testimoniati da un dvd, dando il giusto peso al lato
scenico-performativo.(6.2/10)
Gabriele Marino
Jon Hopkins - Seven Gulps Of Air
(Domino, Novembre 2009)
G enere : ambient ' n ' beats
Un inedito e quattro rmx dall'ultimo Insides (uno
autografo e tre firmati da altri). Jon fiuta il vento
Hyperdub & Co. e mette in apertura un buon wonky
sincopato e poliritmico con scat battidenti (ce ne
aveva dato anticipazione a Ypsigrock 2009). Occhei
le riletture che sviluppano (A Small Memory by Tunng, il pezzo migliore), riarrangiano (The Low Places by
Geese, esoteric-folkie) e in generale movimentano
gli originali, migliorandoli. Lui però toglie la ritmica
da A Drifting Up (e la ribattezza Down), lasciandola
tutta nebule di tastiera, un po' inutile, e Tom Middleton manda Light Through The Veins in disco, ma la
cosa è solo parzialmente riuscita: meglio l'originale.
Resta su Jon la sensazione di uno tecnicamente bravo e che fa esercizi, per quanto ben fatti, con risultati finora mai troppo personali. Continua a non
spostare nulla.(5.9/10)
Gabriele Marino
Julian Lynch - Orange You Glad
(Olde English Spelling Bee,
Novembre 2009)
G enere : hypnagogic pop
Per la serie “cogli l’attimo”, ecco che continua l’onda lunga del tropical sound o hypnagogic pop che
dir si voglia. Non si è spenta l’eco del nuovo Ducktails che già Matt Mondanile si ripresenta con l’altra faccia della medaglia, quella di Real Estate. In
mezzo, ma proprio in mezzo (tanto da esserci quasi
dentro) ai due progetti c’è Julian Lynch, già amico
d’infanzia di Mondanile e con uno split 7” d’esordio
su Underwater diviso proprio con Ducktails. Ora,
dopo la pletora di cd-r d’ordinanza, è il momento
dell’esordio lungo e, guarda caso, proprio su quella Olde English Spelling Bee che il mese scorso ha
rilasciato proprio Landscapes. Quando si dice le
coincidenze eh?
OrangeYou Glad, non sarà difficile intuirlo, si muove lungo quel crinale lì: una psichedelia pop sonnacchiosa e ovattata, soffusa, incerta, barcollante eppure
sempre così fortemente childhood friendly. L’euforia
(ehm) che segna alcuni momenti targati Ducktails
lascia però qui il campo aperto ad una sorta di melanconia soffice, dominata da venature lo-fi ma intrisa di ariose e intriganti aperture a oriente. Così se
Venom è un pezzo che ormai diremmo classico di
certo psych-pop indolente e Winterer One naviga letteralmente su un
oceano di reminiscenze
(a sto punto, tanto vale
dirlo) ipnagogiche, un
pezzo come Mercury
si avvicina all’onnivoro
distendersi di Valerio
Cosi mentre la lunga The Flood parte come un mantra e si apre in un acidissimo trip orientaleggiante.
Julian Lynch, si sarà capito, è un altro piccolo genietto pazzo e solitario sputato fuori dal qualche lontana galassia dello spazio-tempo di ognuno di noi.
Multistrumentista, studente di etnomusicologia, con
un passato alla Smithsonian Folkways Recordings di
Washington. Uno che si prende il lusso di suonare
live in broadcast all’Underwater Peoples Late Summer festival direttamente dal salotto di casa sua, nel
Wisconsin. E che pensa di organizzare futuri live
sempre rimanendo comodamente in casa sua. La cameretta che ingloba pure la dimensione live. Cazzo,
è bedroom pop totale!(7.3/10)
Stefano Pifferi
King Khan & BBQ Show (The) Invisible Girl (In The Red Records,
Novembre 2009)
G enere : r ' n ' r garage
Da Mark Sultan in versione King Khan & BBQ
Show possiamo solo aspettarci qualcosa che sta al
centro del mondo In The Red. Garage e ancora garage.
Ecco quello che si può trovare in Invisible Girl (olrecensioni
57
trepassando, so che è dura, l’orribile copertina): del
rock’n’roll anni Cinquanta virato Nuggets. E nel fare
questo Mark Sultan è maestro. Riesce a citare pedissequamente la tradizione mettendo giusto qualche
storpiatura garagista, se non altro nel timbro degli
strumenti (cioè, delle chitarre). A volte (Untitled, Crystal Ball) poco più punk e Ramones-iano (Crystal
Ball) - e chi continua a dire che la differenza che
corre con il r'n'r dei primordi è poca, ha ragione.
Mezzi avvisati, mezzi salvati. Decidete voi.(6/10)
Gaspare Caliri
Klein Blue - Fertilizzafrasi EP
(Vaggimal, Novembre 2009)
G enere : pop folk
Questo quartetto veronese al debutto testimonia
un senso di recupero e sbrigliatezza, la voglia di fare
(indie) pop che sbocci dal basso delle camerette e
delle camporelle, sgranando canzoni come pietruzze di una collana tenuta assieme dal filo d'inquietudine del vivere moderno. Ballate e ballatine perlopiù
acustiche (la sola Sistri dimostra contagi elettrici, in
ossequio alla tensione smithsiana che la innerva)
all'insegna di viola, chitarra e una batteria vivida, a
cui si aggiunge spesso e volentieri una tromba, per
un impasto assieme arguto e naif.
Un po' come i testi. E come la voce di Carlotta,
sorta di nipotina sensibile e screanzata di Edie
Brickell (cui la fragrante Nubicuculia rimanda più
o meno direttamente). Ci senti l'estro vagamente
hippie del folk studio, la voglia di jingle-jangleggiare
a spine staccate (un po' Housemartins) e la spiegazzata verve dei neo-bucolici contemporanei (alla
Peksniff, per intendersi). Inolte, e soprattutto, certa
graziosa scompostezza che se da un lato reclama
una più robusta produzione, dall'altra colpisce proprio per la grana tenera e malferma.(6.4/10)
Stefano Solventi
Krallice - Dimensional
Bleedthrough (Profound Lore,
Novembre 2009)
G enere : B l ack
Krallice è l'idea di black metal di Mick Barr (Orthrelm, Ocrilim/Octis) e Colin Marstron (Behold...
The Arctopus). E quello che all'inizio poteva sembrare un progetto occasionale dei due - solitamente
dediti a musiche ben meno ordinarie - sta acquistando una dimensione importante, complice anche
la riuscita dell'esordio. Dimostrazione ne è l'ingresso in pianta stabile del bassista Nick McMaster e il
58
recensioni
fatto che quest'anno il gruppo si sia speso molto nei
concerti della attiva scena black metal americana.
Krallice percorre i territori di genere, evidenti nei
toni epici, nelle grida agonizzanti, nei saliscendi vorticosi. Il susseguirsi frenetico di riff in tremolo perpetuo sembra fare il verso a Blind Idiot God e agli
intrecci chitarristici di Don Caballero, ma aggiunge alle trame asettiche del math una componente
emotiva - tanto da ricordare i disagi violenti di casa
Ebullition e Gravity Records. C'è spazio anche per
atmosfere scure e dilatate, e in alcuni episodi il suono si fa Neurosis (forse a causa della presenza anche in fase di scrittura del nuovo bassista, che come
secondo cantante, affianca una voce più profonda
alle urla sguaiate di Barr).
Non lontano dal precedente, Dimensional Bleedthrough risulta maggiormente calibrato e meno
impulsivo.(7/10)
Leonardo Amico
Kreidler - 2014 (Italic, Ottobre
2009)
G enere : K raut -D etroit
Pur bravi e fedeli al "ritmo + groove" che andava
dalla metà dei Novanta, i Kreidler non hanno mai
brillato di luce propria. All'inizio erano troppo filo
Tortoise, poi assomigliavano a una discreta versione dei primi To Rococo Rot, dopodiché ad un mix
già ampiamente masticato di Tarwater e Schneider TM, infine (nell'ultimo fino ad ora Eve Future,
del 2002) a un meditato progetto tra classica e campionamento che peraltro sublimerà e sfonderà, nel
2008, con il famoso Recomposed di Craig e Oswald.
In pratica, il loro bello stava nell'eleganza a incastro
tipica della deutsche welle e nell'effetto zero compiacimento filiato dall'estetica Techno: non sbottavano,
non emozionavano, ma cercavano di ammaliarti attraverso mood rigorosi, quasi come se si ponessero
in dialettica con i calorosi "sudismi" dei Mouse On
Mars e i riff brandizzanti dei Tortoise.
Poi in buca ci si sono messi da soli, incapaci di scegliere da quale parte inclinare la cloche: tra Basic
Channel (o certa IDM) o le istanze chicagoiane che
così tanto avevano influenzato la compagine "Postwall" (Mort Aux Vaches), il progetto s'insabbiò lasciando pure aperta la storica forbice che li vedeva far
pensare nel salotto e ballare nei live set.
Con 2014, a ben sette anni dall'ultima prova, tra relax balearico in filo rosso con certe sonorità altezza Kreidler (2000) e ritmi più impattanti, una sintesi
pare possibile, soprattutto grazie all'inedita scelta
highlight
Ramadanman/Chef - Dubstep Allstars Vol. 07 (Tempa, Novembre
2009)
G enere : D ubstep & C o .
Curato da Hatcha e datato 2004, il primo volume aveva acceso la miccia dubstep nell'overground. Il settimo volume ne è un bignami targato 2009 oltre l'avanguardia Hyperdub. Un disco
mixato da Chef aka Chefal (nero, stazza importante tipo vecchia scuola house o hip hop), uno
da Ramadanman (bianco, occhiaie e sguardo chetaminico), giovani dj e producer in prima linea nelle serate dubstep anni Duemila. Una valanga gli artisti presenti,
pezzi grossi come Benga e Skream (e poi Cyrus e il duo spezzato
Digital Mystikz) accanto a nomi mai sentiti.
Per quanto ci siano intersezioni di mood e di suono tra le due tracklist,
fin dalle aperture si delimita una separazione di campo: Chef parte con
un ragga vocoderizzato, suo e di Coki, e prosegue col soul di Von D
per la splendida languida voce di Lady Phe Phe; Ramadan attacca col
legno e colle bolle melmose di Untold & D. Franklin e col minimalismo addirittura Steve Reich (via Four Tet) di Peverelist. Si balla
sempre, più o meno dritti, più o meno wonky, ma un ciddì è a colori,
l'altro in bianco e nero, uno più dancefloor (ovviamente sporco), uno più IDM, più asciutto, elegantemente monocromo e fumoso. Fino alla buonanotte miagolosa firmata da Mount Kimbie.
Bassi profondi, fuzz e bordate droniche e troniche, (alcuni) pezzi drogatissimi, reminiscenze house
e drum'n'bass, esplicitazioni delle radici ragga-dancehall, e quel clima da bunker, da dopobomba, da
post-umano (eredità questa della Weltanschauung techno) che caratterizza le cose migliori che
ultimamente ci sono passate per le orecchie.(7.5/10)
Gabriele Marino
d'incidere la tracklist in una sola settimana.
Le indagini afro-futuriste sono le migliori, e se a tratti i nuovi Kreidler faranno rimpiangere i Radian,
è innegabile la qualità di un album dalle krauterie
ponderate giù fino a Detroit; e un Vangelis, alla
bisogna, ambient senza timori.(7/10)
Edoardo Bridda
La Sindrome - L’arena del peccato
(Autoprodotto, Ottobre 2009)
G enere : rock
Esordio dei milanesi La Sindrome, tra indie/classic
rock e influenze italiane. Nella nostra lingua sono
infatti i testi che si incastrano con sonorità che privilegiano il più delle volte la melodia. C’è infatti più
di un’influenza nella recente musica nostrana, vengono in mente soprattutto i Negramaro, mentre
per la ricerca melodica rimandano in alcuni casi ai
Pearl Jam.
Gruppo nato prima con cantato in inglese e poi
evoluto verso l’attuale direzione, La Sindrome con
L’arena del peccato confeziona un prodotto curato dal punto di vista delle sonorità, non originalissimo ma che grazie a una certa espressività si ritaglia uno spazio nel genere di riferimento. Che però
non è poi chiarissimo, oscillando più che verso l’alternative, verso uno stile radiofonico con tendenze
a certo mainstream di moda. Se son rose.(6/10)
Teresa Greco
Le Loup - Family (Hardly Art,
Settembre 2009)
G enere : family - folk
Programmatici già dalla bio, “Le Loup is still a young
family, of course, but Family is nothing short of
a musical coming-of-age, and adulthood never
sounded so promising”. A chi pensa fosse evitabile
la citazione messa qui, a esordio del discorso, rilancio dicendo che la famiglia Le Loup è cresciuta a
pane, Akron/Family e Animal Collective, quali
recensioni
59
fossero burro e marmellata. Scegliete voi chi fa l’uno
e chi fa l’altro.
In Family c’è la solita summa degli ’00, di quel cantautorato corale, già dall’iniziale Saddle Mountain,
che del collettivo degli animali sa fino a un miglio
di distanza. E non finisce qui. Passando dalla critica
all’ascolto ingenuo, chi
scrive ammette che la
prima volta che ha ascoltato questo disco, dopo
qualche traccia, l’ha tirato fuori dal lettore per
accertarsi che non si
trattasse di una raccolta
inedita dei primi Akron/
Family. Probabilmente il punto preciso si attestava
sull’ascolto di Morning Song, filiazione diretta della
famiglia di Akron, con tanto di ukulele e di coro decisamente aderente alla fonte. Oppure al momento in cui passava la title-track, che ha uno sviluppo
che segue pedissequamente le vicende della band di
folk-freakers. E lo dice anche il nome, ovviamente.
Ora, in casi come questi, generalmente, si passa per
derivativo punto ciò che ci fa dire quanto appena
detto. Eppure Le Loup convincono, pur nel loro
essere direttamente collegabili ad altre esperienze.
Sherpa è un brano come ne abbiamo sentiti tanti altri, ma testimonia, come il successivo nella track-list
(Neahkahnie), il passaggio di un gruppo da bedroom project di una persona (Sam Simkoff, in questo
caso) a progetto di una piccola collettività. Il che è
uno degli aspetti più interessanti di questo decennio
che si chiude. Specie quando riesce bene.(6.6/10)
Gaspare Caliri
Leg Leg - Manta (Wallace Records,
Novembre 2009)
G enere : math - rock
Continua a stupire il suono chitarristico proveniente
dalle Marche, anche se stavolta non si tratta di esordienti ma di veterani che, a dispetto della giovane
età, hanno curriculum invidiabili. E questo assaggio
di nuova formazione non fa che confermare questo
sentore. Punta di diamante è Mattia Coletti, già
noto anche ad altri panorami impro. Con Leg Leg
il chitarrista ritorna al trio, dopo l’esperienza Sedia:
ad accompagnarlo ci sono la batteria di Roberto
Ceccacci dei Lleroy e il basso di Andrea Giommi di
Edible Woman a tagliuzzare, masticare e risputare fuori la tradizione math-rock a stelle&strisce più
varia e cangiante.
60
recensioni
Manta è un sei pezzi breve e compatto che arde
del sacro fuoco juneof44iano, con il gusto per gli intarsi dei Don Caballero e quello per le poliritmie
dei Battles. Robusto, corposo e con la chitarra di
Coletti attenta a cesellare arpeggi post ma anche
sempre ben memore delle sue esperienze out-rock:
così se Manta e A Roof In Spring sono ottimi bignami
di rock intricato e strumentale, il finale in arpeggio haiku di Ibis e la conclusiva, acidissima cavalcata
mathey Telephone Rings From The Hand Of Summer
offrono interessanti spunti altri rispetto ai canoni
del genere. Dettagli senza dubbio, ma che lasciano
ben sperare in evoluzioni future.(6.7/10)
Stefano Pifferi
Lorenzo Bertocchini - Uncertain,
Texas (Autoprodotto, Settembre
2009)
G enere : roots - folk - rock
Bruce Springsteen versione E-Street Band ma
anche Dire Straits. E di lì non ci si sposta. Uncertain,Texas rappresenta una rivisitazione fedele
ad opera di un emulo del Boss di quel classic rock
venato country che andava negli Usa un paio di decenni fa. Stile vocale e scelte estetiche che fanno il
paio con le foto di un Bertocchini sorridente mentre canta con l'idolo di gioventù e che involontariamente definiscono tutti i pregi e i limiti del disco in
oggetto.
La dietrologia rispettosa e curatissima del varesino,
comunque, non dispiace per nulla. Anche se sempre
di gloria riflessa si tratta, visto che l'unico brano che
si discosta dai modelli genitoriali è la parentesi reggae di Too Lazy.(6.3/10)
Fabrizio Zampighi
Luke Lukas - IIII (Lepers
Produtcions, Ottobre 2009)
G enere : folk rock pop
Il caro Luke Lukas torna sul luogo del delitto Lepers
Produtcion, stesse modalità riguardo al free download, sempre nel solco d'un folk-rock dalla laconica
tensione, dal solipsismo lunatico, dalla ciondolante risolutezza lo-fi. E' nuova semmai la lucidità di
un'ispirazione che serra i ranghi, si concede a situazioni più ammiccanti senza cedere di un millimetro
sul piano del carattere, anzi guadagnando un paio di
tacche nella scala del registro espressivo.
E' il caso di una Maybe Maybe Maybe che col suo
incedere da filastrocca alienata sembra non attendere altro che una breccia (uno spot, una sigla, un dj
occhiuto...) per infilarsi
nelle playlist d'ogni ordine e grado. E poi di quella Bacon che architetta
un serafico miraggio a
cappella col malanimo
nel taschino e tutto un
mondo sintetico dietro
l'angolo. Per non dire di una Mr. Strange che nel finale si estenua per quasi nove acidi ed enfatici minuti,
chitarre gracchianti, violino e tastiere.
Poi, ok, restano pur sempre quelle sciroccate e adorabili traiettorie in obliquo tra marcette The Band
disidratate Beck (Dead Woman Blues), quadretti
onirici colti nel giardinetto Radar Bros (Echo Of
My Soul), certe bestioline cresciute a Beta Band
e Nirvana (Seems Funny). Non mancano insomma
gli indizi per sostenere che il ragazzo è cresciuto,
anzi maturo, pronto ad ammaliare e stupire. Tenetelo d'occhio. (7.3/10)
Stefano Solventi
Martha Wainwright - Sans Fusils,
Ni Souliers, a Paris: Martha
Wainwright's Piaf Record (V2
Music, Novembre 2009)
G enere : chanson
Quanto Marta Wainwright fosse personaggio poco
prevedibile e dalle risorse ancora tutte da esplorare ce lo immaginavamo. In un certo senso, i suoi
lavori ci avevano fatto intuire finora potenzialità e
carattere senza però esprimerli con la dovuta forza,
lucidità e determinazione. Questo omaggio a Édith
Piaf invece va fino in fondo, e pazienza se il repertorio del passerotto francese non è quel che si dice
il massimo del cool per le giovani generazioni contemporanee.
Della Piaf la cara Martha coglie tuttavia quel languore malsano e irrequieto che ne fanno un classico
dalle vibrazioni attualissime, vi basti la decadenza
jazz-blues di Le Brun et le Blond e soprattutto il cinematico struggimento di Adieu Mon Coeur e Soudain
Une Vallée (cui l'incanto obliquo d'una Goldfrapp
non appare così estraneo). La sorella del beneamato
Rufus non difetta certo di corde vocali, ma ancor
più si fa apprezzare per l'agilità delle modulazioni,
per come s'incarica del mood fino al limite della
recitazione (sentitevi Non, La Vie N'est Pas Triste o
L'Accordéoniste), come si conviene per chansons di
tal fatta.
A tal proposito, sono belle le orchestrazioni, mai
tronfie, in cerca del magico che brulica in punta di
palcoscenico (le incisioni sono avvenute in parte
dal vivo), in bilico tra avanspettacolo e dimensione
teatrale. Una nota filologica che un po' impreziosisce e un po' stranisce un album più che apprezzabile.(7.1/10)
Stefano Solventi
Matias Aguayo - Ay Ay Ay (Kompakt,
Dicembre 2009)
G enere : world funk
Sudamericano. Caliente. Cittadino del mondo. Pensate a Paul Simon e proiettatelo nel nuovo secolo.
Ay Ay Ay è il Graceland dance. Dimenticatevi i Closer Musik, Are You Really Lost (il debutto dell'uomo datato 2005) e ascoltate Menta Latte comodi in
poltrona. Il piede inizierà a muovere il ritmo sopra
un tappeto funk declinato world. Poi c'è Ritmo Tres
che rammenta il disincanto dei Talking Heads e le
fattezze Tv On The Radio, Desde Rusia indolente e ipnotica, Ritmo Juarez e Koro Koro dagli smalti
d’Africa. La title track invece è pura psichedelia moderna. E di elettronica c'è poco o nulla. Di umano
- nel senso organico del termine - tanto, poiché è
il beatboxing (per la cronaca, l’arte di riprodurre
percussioni d’ogni tipo col solo uso della voce) il
motore dell’intera faccenda. Dopo la techno, l’essenza del ritmo.(7/10)
Gianni Avella
Mattress - Low Blows (Malt Duck,
Ottobre 2009)
G enere : S ynth -C rooning
Rex Marshall, in arte Mattress, è un personaggio
oscuro. Viene da Portland, e se questo già la dice
lunga, da sempre è un tipo solitario e poco incline
alle mode e alle tendenze. Da vero one-man project,
Rex fa da sé senza bisogno di tanto clamore: dal
2006 rilascia Cd-r e 7" e Low Blows è la seconda
prova lunga dopo il debutto Heavy Duty su Reluctant Recordings. Si riparte dalla voce, un crooning
umbratile e baritonale che ricorda, a seconda dei
momenti, Ian Curtis o Jim Morrison. Attorno
poco altro: un synth proprio come se fosse un piano a coda e qualche scheggia impazzita di chitarra
ad enfatizzare le parti incalzanti.
Senza dimenticare episodi più accessibili (Light My
Life, Gone To Waste), la vera novità è la componente
drammatica e lirica, accentuata ed enfatizzata come
solo nella hit Eldorado in precedenza. Roll Roll Roll, Remember e Stay Poor agitano lugubri spettri nell'aria,
recensioni
61
highlight
Six Finger Satellite - A Good Year For Hardness (, Maggio 2009)
G enere : electro - rock
Gran casino quando arrivi per primo ma - i tempi non maturi eccetera - la grana finisce in tasca
agli epigoni del decennio dopo. Sintetizzando brutalmente la storia dei Six Finger Satellite è
questa e la buona notizia è che i lucidi folli del Rhode Island sono di nuovo tra noi con due dischi:
uno Half Control "recuperato"; e il presente A Good Year For Hardness nuovo di zecca.
Raccolto attorno al nocciolo radioattivo di J. Ryan e Rick Pelletier, il progetto si arricchisce di
una sezione ritmica giovane ma abile: mossa decisa che fa ulteriore tabula rasa di ciò che ruota
attorno a musica ed estetica. Immutate ambedue ma anche no, attualissime - il paragone da farsi
non è con pivelli tipo Rapture, semmai verso seguaci un tempo acuti:
vedi alla voce Trans Am - al punto che i diretti interessati spiegano
quanto le loro mutazioni siano sempre state graduali.
Ci piace starli a sentire perché un gancio che spedisca al tappeto è
gradito, necessaria conseguenza di argomenti solidi e ottima forma.
Sancite dal ricorso affatto scontato a movenze chitarristiche di scuola
Gang Of Four, all’ossessione di muscoli più sarcasmo (uguale moog
krauto e sei corde irruenti) e quel che sta nel mezzo. Dalla postdisco golosamente paranoica Don't Let Me (The Fall in sexy fogge
Jon Spencer) ai rinvigoriti pronunciamenti circa la ”american way” (Wilson P., Swamp Wanda);
da cingolati AOR secondo il vangelo Shellac (Midnight Rails, Half Life) a stordenti giostre (Broken
Brain).
Piazzando in chiusura, con scelta di classe e perspicacia, le gemme assolute: il sixties garage in trasferta a Manchester Hearts And Rocks e i Joy Division a passeggio - indecisi tra colonna sonora
o cosmico afflato - lungo il buio capolavoro Rise. Un riassunto che non vuole esser tale e perciò
centra il bersaglio, lontanissimo da un’autocelebrazione impossibile in chi maneggia sapientemente l’ironia. Il dilemma, semmai, è che a questo mondo non esiste giustizia.(7.4/10)
Giancarlo Turra
proprio nulla (archi, fiati, contrabbassi, glockenspiel,
bidoni, mandolini ecc...).
Manfredi, lo dicevamo, ha tanto del classico cantautore italiano, vuole che le parole pesino e lascia che
siano pesanti, ma allo stesso modo esige sostanza
dagli spartiti. E l'esito è spesso frutto di strategie
ben studiate, per accumulo o contrasto emotivo.
L'ora del dilettante monta incubi e tensioni di un
mondo ammattito dove trionfano i mediocri con
archi tellurici e cromorni rinascimentali; Il regno delle
fate narra su toni da fiaba di chitarra, piano e spring
drum il brulicare di vita multiforme di una viaggio
in treno dove ognuno si cerca un senso; Zimbalom
sparge magie e sensualità in un viaggio da Belgrado
a Bombay passando per Istanbul.
In chiusura, prima della riproposizione di un vecchio duetto proprio con De Andrè (che di duetti ne
faceva davvero pochi) su La fiera della Maddalena, Il
morale delle truppa lancia su un'andatura da marcia
slava una storia di decadenza da vodka e trincea,
mentre Il treno per Kukuwok dichiara programmaticamente la poetica del genovese: da «un cartello
sballato in stazione a Pavia» che appunto reca la destinazione Kukuwok nasce infatti una fantasia folk
(come il Vinicio Capossela quacchero di Da solo),
dove i pendolari diventano nuovi indiani di «praterie con aziende vinicole doc» in fuga verso quel
luogo fantastico generato dalla follia di un display.
L'identica follia, amplificata da una curiosità intellettuale inarrestabile, che attraversa tutte le canzoni
di Luna persa: oggi disco outsider che fra qualche
anno potremmo tuttavia considerare parecchio importante.(7.4/10)
Luca Barachetti
probabilmente gli stessi le cui mani vediamo sorgere nell'illustrazione di copertina. La stampa su vinile
trasparente e l'inserto con alcuni testi, infine, suggellano una delle produzioni più interessanti degli
ultimi mesi.(7.2/10)
Andrea Napoli
Max Manfredi - Luna persa (Ala
Bianca, Settembre 2008)
G enere : canzone d ' autore
La Targa Tenco 2009 come miglior disco dell'anno
sigilla un percorso lento (cinque dischi in diciotto
anni) ma attento a rivitalizzare una canzone d'autore ultimamente in debito d'ossigeno. E probabilmente se Max Manfredi fosse nato una decina di
anni prima, lui classe 1956, oggi ce lo ritroveremmo
nel pantheon del cantautorato nostrano. Questio62
recensioni
ni di tempi mutati, ma anche di un approccio alla
canzone che cercando nella complessità la propria
cifra - una complessità che è continua generazione
di sfumature e punti di vista inediti, lontana da ogni
sterile sortita - si trova fuori rotta rispetto al tuttosubito degli anni zero.

Luna persa nasconde significati fin dal titolo, nel quale l'aggettivo non corrisponde a “perduta” ma ad un participio passato fuori uso significante rossastro; dunque una luna rossa, di smog, di città.
E si autoalimenta nelle tredici canzoni previste di
un continuo intrecciarsi di influenze che partendo
dall'ultimo Fabrizio De André allargano la propria
anima mediterranea a stralci classicheggianti, fragranze balcaniche e slave, esotismi turco-indiani alla
Paolo Conte e sparuti inserti elettronici che completano un arco strumentale nel quale non manca
Meat Puppets - Sewn Together
(Megaforce, Maggio 2009)
G enere : indie 80' s
Spiega tutto il titolo in questo dodicesimo disco
dei Meat Puppets. E che bella scelta è, echeggiata dall’artwork ma soprattutto dal contenuto. Sewn
Together significa “cucito assieme”: subito pensi a
una coperta indiana composta da differenti pezze
che acquista senso osservata da lontano. Soltanto
così la squisita totalità restituisce la sua superiorità
alla mera somma delle parti. Secondo passo della
reunion dei fratelli Kirkwood questo album, graditissimo a prescindere visto l’inferno attraversato
da Cris causa vicende di droga e cronaca nera che
paiono seppellite definitivamente.
Lo sottolinea una ricomparsa in grande stile del-
la “sexy music”, come la
battezzarono i diretti interessati; del coacervo di
punk, psichedelia e radici
che li rese esponenti tra
i più sinceri e persuasivi
dell’underground americano anni ‘80. Musica del
deserto che non suggeriva desolazione e solitudine,
casomai il ricordo di policromi, raggianti “trip” interiori. Così è l’Arizona dalle loro parti e ciò accadeva quando erano giovani, persi dentro un paesaggio
suggestivo a mescolare l’impossibile in un cocktail
stordente. Succede anche qui, tuttavia con continuità e brillantezza sconosciute al predecessore Rise To
Your Knees, servito forse da riscaldamento e idem i
concerti nel frattempo tenuti col nuovo batterista
Ted Marcus.
Ipotesi plausibile alla luce di una dozzina di brani che
del succitato stile propongono il riassunto mentre
ne sottolineano l’immutata unicità. Senza cigolare di
giunture, spediscono i Grateful Dead a formarsi
nei primi ’70 (la title track, Rotten Shame) o parafrasano i R.E.M. (Blanket Of Weeds, Smoke). Stringono
al cuore il country con svagata vivacità (la fischiettante The Monkey And The Snake, il banjo in I'm Not
You) e affidano la propria Grandezza alle traslucide
ballate Smoke e Sapphire, senza dimenticarsi certi
ibridi tra hard rock, funk e oriente.
Curt oggi risiede in Texas, ma non c’è dubbio che
la sua mente vaghi sempre lungo i cieli stellati sopra
Phoenix: prova ne siano l’attaccamento al fratello
e un ospite che imbraccia la chitarra in un pezzo, il
quale - buon sangue non mente - fa di nome Elmo
Kirkwood. E’ suo figlio e chissà che in futuro non
possa sorprenderci, da fortunato frequentatore di
una scuola da elevare ad esempio per eternarne
l’insegnamento.(7.4/10)
Giancarlo Turra
Memory Tapes - Seek Magic
(Acephale, Agosto 2009)
G enere : G lo F i
Vicino più a Washed Out (e in distanza perimetrica dal wizkid Neon Indian), Dayve Hawk aka Memory Tapes (e prima Memory Cassette) è uno di
quelli che con gli Ottanta ci lavora pesantemente
senza dimenticare alcune lezioncine. Flirta gagliardo con l'idm infantile firmata Aphex Twin (Bicycle),
con le krauterie sintetiche, osserva iperlucido resistendo agli oppiacei e poi c'è l'house. Parigi. I Daft
recensioni
63
Punk. Il suono vintage dai campioni neri di vent'anni prima, la materia dell'arrangiatore più che dell'autore, del remissatore più che del musicista puro.
Quando c'ha le melodie in testa, Hawk le pensa
black nell'accezione della sua Philadelphia e la mano
è quella del dj chino sull'euro-disco, eppure non siamo in una groove mission: metà scaletta è fatta di canzoni che si fanno contenitori. Si parte in un modo
per poi finire in un altro. Si aprono sipari inaspettati
e di lì, come nelle cose di Ariel Pink, non sai mai
bene come andrà a finire. Prendi Graphics: memorabilia istantanea di Cocteau Twins, chitarre Cure,
riff New Order e Yellow Magic Orchestra, spezie a sorpresa amate e poi affogate in altre.
Il mood è il tratto aggregante. Chiamiamolo glo-fi.
Roba velata, zuccherosa e all'occorrenza new age,
Tangerine Dream (Pink Stones) e di nuovo in risalita WARP. E non mancano neppure l'indie song
(Plain Material), il dancefloor in veste DFA (Stop Talking) e il classico momento del sole che cala all'orizzonte in un finalone da ben 22 minuti (Treeship).
Frankie Knuckles è li a sorriderti da lontano. E'
un laboratorio. Ma l'alchimista sa il fatto suo. Che
trip.(7.1/10)
Edoardo Bridda
Mirt - Most (The bridge)
(MonotypeRec., Novembre 2009)
G enere : D isintegration loops
Tomek Mirt, dei Brasil and the Gallowbrothers Band, torna in solitario col suo nuovo Lp
in 250 copie, due traccie registrate nel 2003 che
raggiungono appena i 24 minuti.
“Si si”, il full-lenght precedente, diramava su planimetrie notturne, migrazioni interstiziali poste tra
circolarità basinskiane. Questo nuovo lp parte dalle
medesime fissazioni analogiche ma è attraversato
da motivi oscuri, che hanno un sapore più amaro
e memoriale. “Most 2” è il momento più compiuto:
isolazionismo termico fitto di uiniverso Labradford, disintegration loops e istanze concrete prese
dalla strada, da voci che si raccontano sotto una
coltre spessa di reiterazioni nostalgiche. Tra le note
impalpabili, una trombetta processata che dona
spunti quasi fusion.
Nulla di particolarmente nuovo; William Basinski
si nasconde dietro ogni dettaglio con un pugnale in
mano, eppure "Most" piacerà agli innamorati persi
dell'ambient filodiffusa.(6.2/10)
Salvatore Borrelli
64
recensioni
Miura - 3 (Prismopaco, Novembre
2009)
G enere : rock
Terzo lavoro per i Miura, band di Diego Galeri, ex
batterista dei Timoria, ma quest'ultimo nome non
vi preoccupi troppo. Del resto, qualcuno potrebbe
conservare buoni ricordi del precedente Croci (Prismopaco, 2008), prodotto dal buon Giorgio Canali. Nel caso, il qui presente 3 spinge più a fondo sulla cura dei suoni, scegliendo quale partner in
studio quel Giacomo Fiorenza che non ha certo
bisogno di presentazioni. Il risultato è un adult-indie
rock che tira le fila delle evoluzioni alternative italiane da un quindicennio a questa parte, veicolandone
le traiettorie in una forma compatta e nervosa.
Dove la trepidazione indolenzita dei Perturbazione incrocia veemenza Afterhours (Malati Sani),
dove il chitarrismo senziente dei CSI mescola le
carte con la vis teatrale dei Massimo Volume (Underworld), dove i Marlene Kuntz indossano le maschere dai Tre Allegri Ragazzi Morti (Non vado
forte), dove i Verdena si fanno strattonare dai Ministri (Giuda). Eccetera. Ovvero, rendendosi disponibili ad allucinazioni sintetiche (Andiamoci piano con
le emozioni) e pacate inquietudini quasi Max Gazzé
(Normale).
Come certi centravanti dal tiro troppo pulito, non
mettono a segno troppi goal. Però si fanno apprezzare. (6.3/10)
Stefano Solventi
Mr. Chop - For Pete’s Sake (Now
Again, Novembre 2009)
G enere : jazz - funk
Proprietario di uno dei migliori studi vintage (leggi
"analogici") d'Inghilterra, gli Ape, amico e collaboratore di MF Doom e di Catto e dei suoi Heliocentrics (due di loro li ritroviamo anche qui), di casa a
Now Again, Stones Throw e Jazzman come ingegnere
del suono e produttore, autore di prove soliste su
piccola e media distanza (ultimo l'ep Lightworlds)
votate ad una miscela di jazz, funk e colonne sonore,
il polistrumentista Coz Littler propone adesso la
sua rilettura - tutta suonata e interamente strumentale - di dieci produzioni di Pete Rock, alternate a
sette pezzi autografi perfettamente calati nel mood
(eccezion fatta per l'elettronica psych-concreta del
sesto intermezzo e l'epica tastierosa del settimo).
Interessante l'idea - peraltro sempre più diffusa, vedi
cose analoghe fatte col repertorio di J Dilla, per
non dire di Christian Prommer con l'house - di
suonare cover di produzioni hip hop ormai classiche. Il risultato è intriso di passione e piacevolissimo, forse a tratti un po'
troppo sottofondo, ma
come per molti prodotti
di questa area stilistica e
di questo pugno di label
tra loro affratellate, l'appassionato ha davvero di
che godere. Pare uscirà
presto anche un singolo
su vinile con due pezzi
cantati da CL Smooth, spalla vocale per antonomasia di Rock.(6.9/10)
Gabriele Marino
Music Go Music - Expressions
(Secretly Canadian, Novembre
2009)
G enere : iperpop
Della serie californiani estrosi, i Music Go Music debuttano via Secretly Canadian con un disco pazzesco. Immaginatevi un minestrone di pop, prog, disco
e folk con la barra puntata verso i primi seventies,
nello specifico: la verve pastello degli Abba, il torrrido algore moroderiano di Donna Summer, l'enfasi bucolica dei Fletwood Mac e quella tronfia
degli Electric Light Orchestra. Un frankenstein
affabile ai limiti dell'untuoso con velleità arty, inseguendo un'aura po-mo d'accatto che ce li rende assieme irresistibili e insopportabili.
La penna non gli manca, vedi quella specie di Waterloo aggiornata che risponde al titolo di Light Of Love,
la pseudo suite quasi King Crimson di Reach Out,
oppure quella Love, Violent Love capace persino di
sbriglire caligini Ultravox e giochetti asprigni Syd
Barrett. In qualsiasi modo tiri le somme, alla fine
ti ritrovi con un adorabile baraccone, improbabile e
impagabilmente balzano.
(5.8/10)
Stefano Solventi
Naam - Naam (Tee Pee, Novembre
2009)
G enere : heavy psych
Trasuda spiritualità da ogni poro l’universo Naam,
terzetto americano di lungocriniti asceti e devoti al
versante più mistico del suono psichedelico odierno. I 17 monolitici minuti di The Kingdom che danno
la stura all’omonimo esordio danno il segno del tutto: un crescendo sepolcrale sul quale si innestano
rifferama hard-rock e vocals effettate che, una volta
raggiunto il climax, si accartocciano su se stesse in
un tripudio di miasmi mediorientali e intrecci doom-stoner.
Gli Sleep privati della fattanza e gli Om dell’ultimo
periodo (quelli della svolta mistica, per capirsi) sono
gli ovvi punti di riferimento del suono arcaico del
trio, ma non di limitati orizzonti si tratta; fuzz a gogo e una certa predilezione per atmosfere spacey
e kraute tirano dentro l’ipotetica cosmogonia del
fenomeno Naam anche Can e Hawkwind, Black
Sabbath e le nuove leve dell’heavy-psych contemporaneo (Mastodon, Earthless, Ancestors),
Monster Magnet e certi campioni open-minded
dell’era grunge, Soundgarden su tutti.
Naam, insomma, ci consegna una band in totale
espansione, capace di insidiare a breve i mostri
sacri del genere, e nello
stesso tempo consacra la
scena heavy psych newyorchese, in cui Ryan Lugar (chitarra, voce), John
Bundy (basso, voce) e Eli
Pizzuto (batteria, percussioni) sono in bella compagnia: White Hills, Weird Owl e perché no?
pure Psychic Ills.(7/10)
Stefano Pifferi
Naked Musicians - Emiliano
Culastrisce (Improvvisatore
Involontario, Novembre 2009)
G enere : jazz - avanguardia
Improvvisatore involontario frantuma e reinventa. Si
autoreplica. In una serie di progetti e in collettivi di
vario genere che hanno il solo scopo di non avere
(apparentemente) uno scopo. Tra i tanti, i Naked
Musicians di Francesco Cusa. Un gruppo che fa
della forma un informe sformato di genere imprecisato. Del jazz una stanza senza più pareti ma alberi.
Dell'avanguardia una massa di note per masse pensanti poco massificate.
In questo terzo episodio del gruppo si incrociano
voci che sono loops ad uso e consumo della ritmica
(ilfunkydinoccolatoilfunky di Emiliano e Biagio in funky
town), urla e battere tribale su ottoni à la Archie
Shepp periodo Attica Blues (Emiliano e gli animali
felici), sordine, hard bop e chitarre noise (Emiliano e
il codice fiscale), samplers e nonsense in rima (Emiliano Biagio e l'incanto della sirena). Con lo scopo di
recensioni
65
highlight
Zelienople - Give It Up (Type Records, Novembre 2009)
G enere : psichedelia
Musica che muove fantasmi e animi inquieti come marionette in un teatrino al di là del tempo,
ovvero come flirtare con l’ambient e la psichedelia facendo tesoro della tradizione. Gli Zelienople del 2009 meritano di essere considerati gli unici legittimi eredi di gente ben oltre la sostanza
come Talk Talk, Bark Psychosis e Slowdive.
Give It Up è infatti lavoro che non si presta a fraintendimenti e gioca
subito, in maniera quasi istintiva, la carta della classicità. In altre parole,
il trio di Chicago sta provano ad interfacciarsi con i propri modelli
travalicandoli secondo il proprio gusto e la propria estetica e qui sta
la vittoria del loro approccio a tratti quasi calligrafico con la band di
Mark Hollis. Pertanto questo nuovo lavoro si permette subito un intro di oltre sette minuti (Aging) che, senza alcuna paura di suonare eccessivamente lenta, fa della proprio del suo passo malfermo e sospeso
l’ideale porta di ingresso in un territorio languidamente psichedelico.
Musica che sa essere felice ibrido tra i Pink Floyd più mistici e gli Slowdive più epici (Can’t Stop)
o tenebrosa discesa nel mondo dell’ombra al suono di un Badalamenti ai confini della realtà (All
I Want Is Calm). Il meglio, i tre lo raggiungono quando la forma convive con l’astrazione, quando i
residui di una forma canzone ormai provata ed abusata in tutti i modi, passano in maniera quasi
impalpabile nel regno dell’informale (Little Little Eye-Full, Flurry). Ben più a fuoco e rifinito del precedente lavoro su Type, Give It Up consegna i suoi autori tra gli eroi della psichedelia anni 2000.
(7.5/10)
Antonello Comunale
sincopare testi e musica in un'entità inscindibile e
al tempo stesso “involontariamente” coerente con
il tema centrale del brano. Il tutto entro confini
prestabiliti da particolari sonori (emblematica la ripetizione ad libitum di “piorrrrrrrea” in Emiliano e la
Piorrea), sovrapposizioni di livelli, timbriche lontane
anni luce tra loro, liriche che giocano sapientemente
col significato e col significante musicale.
Registrato dal vivo - come del resto tradizione di
Improvvisatore Involontario vuole - e realizzato
in forma di concept da una ventina di musicisti di
varia estrazione, Emiliano culastrisce pare un parto
assai convincente, in più baciato da una “semplicità” d'uso che non diresti possibile visto il polverone
anarchico sollevato dai settantatrè minuti di programma.(7.5/10)
Fabrizio Zampighi
66
recensioni
Namosh - Keep It For Later
(Crippled Dick Hot Wax, Novembre
2009)
G enere : synthpop
Mitteleuropeo fino all’osso, Namosh. I suoi synth
risuonano della tradizione che ha investito anche gli
Ultravox di Vienna, ma lui è capace di rivolgersi,
oltre che al suono, alle melodie di quasi-decadentismo da centro-Europa. Come See Me è un manifesto,
uno dei brani sci-fi-synth-pop più riusciti che mi sia
capitato di ascoltare. Una canzone bilanciata e progressiva come appunto solo quegli Ultravox avevano
saputo fare. Contiene e si chiude con quell'organo
che pare essere lo strumento preferito di Namosh,
al secolo Namosh E. Arslan, tedesco classe ’81, di
origine curda e di stanza a Berlino. Peccato che poi
Who Were You? sia una ballata melensa che scivola
sulle proprie intenzioni, cioè omaggiare il synth-pop
di fine Ottanta.
Del resto sta tutto qui il filo su cui cammina Namosh, in bilico tra proprietà di penna e caricatura.
Arslan è un poseur, che
sa spaziare da Jean Michel Jarre (Farever) al
canto a cappella (Entrain).
È un performer, che comunica la voglia di salire
sul palcoscenico anche
mentre lo si ascolta su
disco. È uno che immaginiamo vestito da ballerino
dada, a fare gesti con una mano, mentre con l’altra
suona la tastiera in Two Pieces (in cui risuonano i
Tuxedomoon, altro gruppo che parla pietanze europee). In questo modo ha convinto anche Bjork,
che nel 2005 ha dichiarato di ritenere Cold Cream
(singolone elettropop a firma Namosh, appunto,
confluito l’anno dopo nel primo album, Moccatongue) la sua preferita dell’anno. E ci siamo convinti
anche noi.(7/10)
Gaspare Caliri
New Rhodes - Everybody Loves A
Scene (Urtovox, Novembre 2009)
G enere : indie pop rock
Per questo quartetto bristoliano è il secondo album,
dopo quel Songs From The Lodge che nel 2006
consentì loro un paio di singoli nelle classifiche UK
ed una certa fama nel paese del sol levante. Non
era abbastanza, ovviamente, per una band la cui ambizione presumo sia pari alla freschezza del piglio
pop, una formula che sbriglia melodie baldanzose e
un pizzico indolenzite in sella a chitarre generose
ai liiti del volitivo. Ogni complessità emotiva risolta
anzi spianata in un vero e prioprio tritatutto adrenalinico, un po' come usano fare da qualche tempo
gente come Killers, Bravery e Kooks, tanto per
abbozzare la cerchia stilistica.
Nel caso specifico, la voce di James Williams possiede quella marcia in più che ce li fa sembrare dei
nipotini pettoruti degli Smiths morsi da una tarantola che arriveresti persino a dire Hüsker Dü (solo
e soltanto per il piglio da gioiosa macchina da guerra pop). Schema tattico che si prende una tregua
con la sola The Bells Of St. John, ballatina sognante
pescata in un acquario fifties, buona a scomodare
scampoli d'immaginario New Pornographers, fermo restando lo stampo brit della cosa.
Molto talento e poco genio, contagiosi ma sostanzialmente innocui, ergo: radiofonici a palla. Ci siamo
capiti?(6.4/10)
Stefano Solventi
Nina Kinert - Pets & Friends
(Ninkina Recordings, Novembre
2009)
G enere : folk - rock
Gioca, Nina Kinert. Con tutto quell'immaginario
folk anni Settanta che va da Leonard Cohen (Love
Affair e Me Love U Long Time) in avanti. Filtrato dall'algido trasporto di una Svezia ABBA citata più dal
look nostalgico apposto su una già generosa Madre
Natura - ciglia finte lunghissime, fascia per capelli,
trucco eccessivo - che nella musica, eppure trasversale al pari di una Goldfrapp pop su obliquità P. J.
Harvey mixate a certe cadenze istituzionali in stile
MTV (A-Worn Out).
Cerchiamo di essere più precisi. Combat Lover è un
singolo ragionato, tanto che dentro ci trovi batterie
Jesus & Mary Chains, un tribalismo percussivo
Joy Division e certe sonorità di mellotron e harpsichord che ti spediscono direttamente nell'orbita
di un cosmic rock da zeppa. Che pero', nel caso specifico, non è rock in senso classico, ma una specie di
ballata wave malinconica con un approccio quasi disco. Chiaro, no? Nei minuti successivi ti aspetteresti
come minimo di continuare con lo stesso registro e
invece Golden Rings e Get Off introducono una Cat
Power con carta di identità svedese; I Shot My Man
recupera un blues desertico che sarebbe piaciuto a
una Nancy Sinatra progressista come a dei Sons
& Daughters meno sboccati; Beast è Tori Amos
ai confini con l'Islanda; The Art Is Hard è la Harvey
dell'ultimo disco ma rinsecchita su una drum machine. Siete confusi? Anche noi.
Dote maggiore della Kinert è la capacità di rivitalizzare le influenze, mescolando strumentazione e
arrangiamenti in un caleidoscopio stilistico che garantisce una certa “libertà” espressiva. Il tutto finemente calcolato e congeniale a un pop ingarbugliato
che ti si appiccica addosso, a capacità vocali e musicali sopra alla media, alle qualità di una scrittura che
non si lascia troppo sbugiardare .(7.2/10)
Fabrizio Zampighi
Notwist (The) - Music From Storm
(OST) (Alien Transistor, Novembre
2009)
G enere : soundtrack
Strano cimento per i Notwist, quello della
soundtrack per il political thriller Storm del regista
tedesco Hans-Christian Schmid. La gravità delle situazioni spinge il mood sonico verso un ambient carico di inquietudini tese, rese con un piglio minimale
recensioni
67
ma intenso, parente in qualche modo degli scarni
quadretti periferici imbastiti dai primi Godspeed
You Black Emperor (tolte ovviamente le sfuriate
elementali), cosicché una Jan o una Jonas sbocciano
da bordoni caliginosi e ossessivi su cui agisce una
malferma teoria di chitarra e tastiere, quando non
prevale la struggente malinconia degli archi (come
nella toccante Storm 2).
Altrove la trama è più sintetica, quasi una folktronica incupita e dimessa (vedi The Hague), oppure
un Autechre spossato (Prayer), mentre un pizzico dei "soliti" Notwist fa capolino in Sarajevo 2, se
non altro per quell'arpeggio di banjo che però non
alleggerisce il senso di generale apprensione. Una
soundtrack pura, funzionale alla pellicola cui s'ispira, e in questo senso riuscita. Meglio arrangiata che
ispirata, a dirla tutta, però almeno sorretta da una
progettualità forte.(6.5/10)
Stefano Solventi
Oh No - Dr. No's Ethiopium (Stones
Throw, Dicembre 2009)
G enere : basi hip - hop
E ci torniamo su. La quantità influenza la qualità, il
come il cosa. Ma non sempre e non troppo. Oh No
raddoppia (quantità) i pezzi della tracklist presentata a ottobre e rimescola la sequenza (il come). Tra
le new entry ci sono cose interessanti, e in generale
non mancano singoli numeri molto buoni (specialmente quelli in chiaroscuro come il dilliano Melody
Mix, già nella versione "light"), ma si trovano come
dispersi tra troppi pezzi che non vanno oltre
l'intermezzo. Il giudizio
di fondo resta insomma
inalterato, resta la sensazione che il nerdismo
jacksoniano - che ben
conosciamo - non abbia
qui giovato. Cresce un
po' il voto perché è (opportunamente) aumentata
la carne al fuoco.(6.4/10)
Gabriele Marino
Owen - New Leaves (Polyvinyl
Records, Ottobre 2009)
G enere : chamber pop
Se non ci siamo persi nulla per strada, New Leaves
è l’album numero sei di Owen, pseudonimo dietro
cui si nasconde Mike Kinsella in libera uscita dai
Joan Of Arc. Il titolo promette “nuove foglie” e di
68
recensioni
conseguenza nuovo è anche il volto del Nostro, che
risulterà gradita a quella fetta di palato indie che
ama le belle maniere e che verso Red Krayola e
Gastr Del Sol ha sempre nutrito diffidenza. Registrato lungo l’arco di un biennio, il materiale non risulta disorganico e in tal modo indica che la mossa è
frutto di pianificazione. Lascia viceversa perplessi il
risultato, gradevole benché (eccezioni il brano omonimo e la ritmata Good Friends, Bad Habits; la Amnesia And Me al gusto di primi Belle & Sebastian e
un’elaborata The Only Child Of Aergia da post-rock
decaffeinato) poco incisivo compositivamente.
A proprio agio con atmosfere argute, pregevoli storture o alvei acustici, Mike non riesce ad azzeccare le
melodie adatte al pop d’autore; altra la sua indole,
coglie la trama intimista e le lusinghe cameristiche,
conserva la cura formale e l’arguzia dei testi. New
Leaves dondola come un acrobata sulla corda tesa:
poiché l’artista possiede esperienza e talento, cade
solo qualche volta e sempre sulla rete. Raramente
però le sue evoluzioni lasciano a bocca aperta, così
che lo sguardo finisce catturato altrove.(6.5/10)
Giancarlo Turra
Peanut Butter Wolf - Straight To
Tape 1990-1992 (Stones Throw,
Settembre 2009)
G enere : H ip H op
Cinquanta minuti di produzioni inedite targate
PBW 90-92, la "four track era" come la definisce
lui, quando ancora viveva con la mamma e reclutava i rapper di San Jose per fare una compila, forte
dello status di unico uomo nella zona a possedere
un campionatore. Il progetto venne abbandonato
per lavorare col solo Charizma (Charles Hicks),
l'amico del cuore e il partner musicale più dotato, ucciso per strada nel 1993, gettando PBW nella
disperazione totale. La rinascita nella musica come
unica possibile salvezza con la fondazione della Stones Throw nel 1996.
Questi pezzi erano intesi come ruff draft da portare
in studio e rifare, realizzati in maniera che definire
artigianale è eufemismo, zero effettistica e qualità
audio da bootleg ripulito (sono in pratica dei provini), ma le produzioni di Peanut sono davvero colorate e freschissime, e le performance dei rapper
spesso sorprendenti (Deshee, N.O.T.U., Quiz
One, Peace Maker, Mc Twan, Raised by Suess,
Double Duce & Kid Krush e ovviamente Charizma). Goduria che trasuda dalla passione.(7/10)
Gabriele Marino
Pecora - Le patrie balere ep
(Dizlexiqa, Maggio 2009)
G enere : punk hip - hop
Come se gli Altro si mettessero a fare hip hop,
o come se Frankie Hi NRG si lasciasse produrre dai Dälek per una volta più pacificati del solito.
L'urgenza punk dei Pecora non diviene urlo a pieni
polmoni ma elucubrazione tagliente volta a ripulire
la realtà dalle fiabe e a cogliere il lato grigioalienazione di una luna in technicolor. Nel gregge belante
e catodico l'ovino dei quattro milanesi è ovviamente nero, sta fuori dal gruppo e lo prende a zoccolate ipotizzando un tacito patto di non aggressione
tra sistemi di potere monoteistici (Benedetto) e dichiarando resa all'attuale sistema economico dominante (L'erba voglio), dove ogni forma di consumo
alternativo è solo il lavacro di coscienze non meno
conformate. 

Qualunquismo? Voglia di dire troppe cose in troppo
poco spazio? Può darsi, ma a parte l'effetto tazebao
di alcuni passaggi (Il qualcosologo) - anche derivazione di una precisa appartenenza, testimoniata dalla
rilettura Crass di The sound of free speech - dei Pecora interessa il punto di vista spiazzante su basi
ridotte all'osso, la forza sillogica che preannuncia
impasti chitarristici abrasivi. Elettrica, basso e groovebox per istanze tutte da sviluppare insieme a un
lavoro maggiore sulle voci (maschile e femminile) e
ad un'eco Oneida che scorre sotterraneo e che
potrebbe rendere il tutto ancora più avvincente di
quanto non lo sia ora. Cresceranno i Pecora, il gregge purtroppo no.(6.6/10)
Luca Barachetti
Pelican - What We All Come To Need
(Southern Lord, Ottobre 2009)
G enere : P ost - metal
Cosa può promettere un nuovo album dei Pelican
di Chicago in questo tardo 2009? E soprattutto:
mantiene quello che promette? Laurent SchroederLebec (chitarra), Trevor de Brauw (chitarra), Bryan
Herweg (basso) e Larry Herweg (batteria), in realtà, sono gruppo ben meno monolitico di quanto distrattamente sembrerebbe. City Of Echoes
(2007) aveva raffinato quella formula di post-rock
strumentale che il precedente Australasia (2003)
pian piano sottraeva agli idoli Neurosis e Fugazi
per spostarla persino verso ambiti dreamy, ambient,
assolutamente raffinati nell'intreccio chitarristico
marchio di fabbrica del gruppo. Che in questo nuovo What We All Come To Need perviene ad
una sintesi (già adombrata nel più recente ep Ephemeral): squarci sinfonici, melodie sempre più distese
un partiture latantemente prog (Glimmer) e in virtù
della quantità di elettricità diffusa dagli amplificatori
(The Creeper) persino psycho-metal.
Partecipano al disco un'orda di graditissimi ospiti:
Greg Anderson (Sunn O)))), Aaron Turner (Isis),
Ben Verellen (Harkonen e Helms Alee) e Allen Epley
(The Life & Times, Shiner). Un disco che è fumigante
e complesso al contempo, che suona posato e veemente ad un mentre, che sancisce la maturazione
(di disco in disco, anno dopo anno) dei Pelican verso una forma di strumentale 'post' (metal? dreammetal? psych-metal?) "assoluto".(7/10)
Massimo Padalino
Phill Niblock - Touch strings
(Touch Music UK, Novembre 2009)
G enere : M acro -M inimalism
Dei tre movimenti in cui è divisa la quarta mastodontica impresa di Niblock per Touch, Poure è quello che mette d'accordo tutti. L'ameranno i tantrici
adoratori del para-sinfonico, i naturalisti del neopaganesimo acusmatico e i divoratori di decibel
ammainati alla deità Sunn O))). E' anche la traccia
meno processata e quella più ricca di dettagli e misticismo ma come negare la bruttezza di Stosspeng?
Un corpo unico imbottito di tensioni e distensioni
di 59 minuti, un vagone di
gradazioni monocromatiche e velocità variabili,
una ghost-sonata dronata...
Se li porterà anche bene
gli anni Niblock, eppure
non possiamo tacergli
un'ambizione per la "forma pura" che sconfina troppo facilmente nell'accademismo forzato. Un'evidenza la ritroviamo sostanzialmente nell'uso delle
macro-strutture circolari basate sul medesimo canovaccio temporale, omogeneo e lineare. Ma qui si
rischia anche peggio: duplicare se stessi all'infinito.(6.3/10)
Salvatore Borrelli
Pipers - No One But Us (Materia
Principale, Novembre 2009)
G enere : brit pop
Non ci girano intorno, i Pipers: quattro napoletani dediti al verbo del brit-pop. Lo fanno del 2007,
con tanto entusiasmo e convinzione da guadagnarsi
recensioni
69
il ruolo di opening act per le date italiane di The
Charlatans e Ian Brown, ottenendo altresì il ticket per suonare in UK con relative note di merito
da parte della stampa d'Albione. Ed eccolo quindi
inevitabile l'album d'esordio, intitolato - tra l'arguto
e lo sbruffone - No One But Us, nel quale appunto ribadiscono i paletti attorno alla loro sbandierata
attitudine.
Che è brit nel senso di indie-pop emotivo e casomai
acidulo per non dire sognante. Nel guado insomma tra estro baldanzoso (come in Britpop Lovers, in
pratica una dichiarazione d'intenti) e sbrigliatezza
sbarazzina (la briosa Sick Of You, col coretto al sapor
di college e vaghi aromi
John Lennon nel ritornello), tra apprensione
affabile (la title track) e
turgori psych (Flourish
Again, roba da cuginetti svenevoli dei Verve),
passando dalla ballata
popadelica di Don't Ask
For More (come potrebbero dei Manic Street
Preachers in fregola Elbow) a quella tra chamber
e twee di Eveline (con l'indie che comunque entro
gli rugge).
I limiti sono quelli tipici delle band al debutto, ovvero certe cadute di tono, gli episodi interlocutori
che non sanno elevarsi oltre l'insipido (è il caso di
Chance e Bitter, tanto per metterne due in croce). Lo
sanno tutti del resto che la differenza tra le grandi
squadre e le matricole, seppur "terribili", passa anche dalla continuità dell'azione. Ragion per cui, tempo al tempo. (6.6/10)
Stefano Solventi
Pontiak - Sea Voids (Thrill Jockey,
Ottobre 2009)
G enere : post hard rock
I tre Pontiak lavorano davvero all’insegna del più
spinto stacanovismo: alle spalle hanno un ottimo
12" in coabitazione con gli Arbouretum, un album
intitolato Sun On Sun (venduto durante i tour ma
ristampato dalla Thrill Jockey) e il validissimo successore Maker che la scorsa primavera richiamò la
nostra attenzione.Tutto quanto in qualcosa più di un
anno, alternato con un’attività live che le cronache
riferiscono intensa e convincente. Può essere fatale
l’iperattività, anche per dei bravi ragazzi americani
venuti su con una robusta etica del lavoro, ragion
per cui ci siamo accostati un poco trepidanti a que70
recensioni
sta ennesima fatica, composta, registrata e mixata in
otto sessioni sparpagliate lungo tre settimane. Abbiamo dato troppi numeri, è vero, e non siamo i soli:
fortuna vuole che Sea Voids prosegua imperturbabile
e sardonico la rivisitazione psichedelica dell’hard a
cavallo tra ’60 e ‘70 condotta sin qui.
Punteggiata da limpide oasi folk (Life And Coral, It's
The Life) e rallentamenti che mescolano l’acido lisergico alla codeina (The Spiritual Nurse, World Wide
Prince); percorsa da echi attitudinali di Thin White
Rope (la stranita Feeling, il brano omonimo) e riduzioni minimaliste del vocabolario appartenuto a
Blue Cheer e Black Sabbath secondo la grammatica di Kyuss e Melvins. Un po’ come accadeva
nei giovani Motorpsycho, il revival non prevarica
l’esecuzione e la scrittura perché ci si volge indietro assorbendo l’ispirazione e restituendola alterata. Trucchi antichi (accordature grevi e rimbombi
di batteria; distorsione stordita e stordente) che
in mano ai copisti creano un buco nero di patetica
nostalgia, qui respirano con personalità sfuggente e
intrigante il giusto.
Edizione su vinile limitata a mille copie e mezz’ora
di durata da godere a tutto volume, mentre i fratelli
Carney - incredibile ma vero! - sono all’opera su
un altro 33 giri previsto per il 2010. Ma quando accidenti dormono?(7/10)
Giancarlo Turra
PULP-iTO - La vergine e la
rivoluzione (Snowdonia, Novembre
2009)
G enere : art wave
Fanno tredici anni che i PULP-iTO si sono formati
su iniziativa dei fratelli Luca e Simone Giordani. Il
luogo è la provincia di Lecco. Il piano padano paranoico covava più sotto le residue scorie geniali
che porteranno al canto del cigno CSI di lì a poco.
I Marlene Kuntz dribblavano il testimone entrando nel vivo di una calligrafia che sarà sempre più
propria, come già avevano dimostrato con Il Vile. Il
momento era di transizione, in bilico sugli anni zero.
Per i PULP-iTO, ormai un collettivo che di stabile
aveva solo l'idea d'un rock che sperimentasse sul
proprio farsi linguaggio e comunicazione, era tempo di autoproduzioni. Uscirono Kiosa nel 2001 e
Gagliardo nel 2004. Il live si faceva performance
sempre più strutturata.
Si arriva quindi al 2008. Il combo si stabilizza in quintetto e arriva il contatto con la sempre occhiuta
Snowdonia. Eccoci quindi ad oggi, a La vergine e la
rivoluzione. Il piglio è punk-wave e arty, le chitarre ghignano rumore, il drumming è frastagliata nevrastenia, le elettroniche
innervano le strutture
imbizzarrendole, il violino taglia e cuce l'atmosfera come un brumoso
retaggio High Tide. Una
congettura piuttosto instabile e insidiosa capace
di epico trasporto, aperture melodiche (si prenda il caso di Lei) e sarcasmo
obliquo (la splendida Rivoluzione), che prende sia a
modello che di mira il verbo Ferretti, alla cui voce
le voci maschili (di Luca e Cecco) si rifanno fino
allo sberleffo (La luna e le stelle), riuscendo talora
a riarticolarne la forza in un presente che beffardamente riecheggia l'ultimo Massimo Zamboni
(X-Rosmarino).
Quanto alla voce femminile (è Birò aka Roberta
Maddalena, tra l'altro illustratrice già al lavoro per
Paolo Benvegnù e Marta Sui Tubi), quel misto di devozione e svenevolezza è un contrasto che produce
delizioso sconcerto rappresentando il link più evidente con l'estetica Maisie, qualunque cosa questo
significhi. Ci sono idee, c'è una direzione, ci sono
svolte e scelte controverse, qualcosa che brulica
dentro e intorno. Disco e band difficili da ignorare.(7.2/10)
Stefano Solventi
Racoon - Little Shapes (Disaster By
Choice, Novembre 2009)
G enere : elettronica
“Il fine di Racoon non è la sperimentazione di nuove
forme (shapes) sonore quanto piuttosto la ricerca di
una dimensione intima e forse per questo spesso impercettibile”. Oh! Eccone uno che finalmente non si
nasconde dietro il dito della sperimentazione. Uno
che non sta lì a menartela con chissà quale ricerca
inedita e inaudita camuffando così l’assenza di idee
e la facilità con cui si fanno dischi oggi.
Quello che Distasters By Choice pubblica in questi
giorni è un disco di musica elettronica “pop” senza
tanti grilli per la testa. Luigi Marino, artista romano
formatosi al Mills College di Oakland (e che quindi
una certa frequentazione con la musica contemporanea può sicuramente vantarla), con Racoon è interessato soprattutto alla vignetta elettronica, una
sorta di nuovo madrigale elettro, mai eccessivamente astratto e sempre carico di una malinconica no-
stalgia. Non siamo per niente distanti dagli Sparkle
In Grey che pure, con le dovute eccezioni, frequentano questi ambienti, ma l’elettronica di Racoon è
più orientata al paesaggio dell’anima. Tanto Squarepusher quanto Dntel, eppure sufficientemente
personale.(7/10)
Antonello Comunale
Raoul Sinier - Tremens Industry
(Ad Noiseam, Ottobre 2009)
G enere : elettronica
Raoul Sinier è un artigiano parigino. Crediamo sia
la frase che meglio inquadra il personaggio. È uno che
tratta l’elettronica come un saper fare, e così pure
il disegno grafico con il suo mac, che ci mostra con
auto-compiacimento. Allo stesso modo è uno che
si costruisce da solo la chitarra e video-documenta
l’episodio. È appunto la capacità, il sapere artigianale,
che lo contraddistingue. L’opzione operativa.
Da qui, il passo successivo sarebbe potuto essere
un’ipertrofia documentale e produttiva. Cioè il fatto
di non saper limitare il fare (e il riportare), all’interno di quel saper fare. Tremens Industry, viene da
dire, è proprio la testimonianza di tale aspetto di
Raoul, anche se - lo immaginiamo - questo cd e dvd
sarà sicuramente frutto di un’attenta scrematura
del magma di atti musica e visual realizzati da Raoul
negli ultimi anni.
Il difetto di Sinier è di lasciare sotto-sviluppata una
questione che altri suoi colleghi più avveduti ritengono giustamente cruciale, onde evitare di rimanere
nel limbo (vecchio e ormai con scarsissime chance
di andare in paradiso) dell’elettronica intelligente da
ascoltare. Parliamo della chiarezza estetica, dell’eloquenza e del decisionismo stilistici. È lì che capiamo
solo in parte; Raoul fa parte di quella schiera che
preferisce i colori freddi a quelli caldi, le figure inquietanti a quelle cristalline, i toni cupi e cyber alla
serenità figurativa. Ma questa non è più una scelta
da decenni.(5.5/10)
Gaspare Caliri
Real Estate - Real Estate (Woodsist,
Novembre 2009)
G enere : B each P op
Matthew Mondanile ha un'evidente ossessione per
l'acqua, sia essa di mare, di lago o quella al cloro
di una piscina. E come più volte analizzato, il trip
acquatico ha trovato in progetti come Ducktails,
Predator Vision e Parasails esiti piuttosto simili nel rimanere sempre in bilico tra psichedelia,
recensioni
71
kraut e free form. Nei Real Estate, ferme restando
alcune coordinate di partenza, il sound si riconcilia
con il pop; fate conto una versione surf/exotica dei
Clean, fra tempi lenti, chitarre riverberate e voci
serafiche tra Beatles, Beach Boys e Todd Rundgren. Tutto come si era intuito nei singoli usciti
per Underwater Peoples e Woodsist, ma anche di
più, con brani come la zuccherosa e corale Snow
Days o l'ipnotica Suburban Beverage che in sei minuti
rapisce ed incanta. Quello evocato dai Real Estate è, ormai si saprà, un mondo perso nelle pieghe
della memoria, nascosto dietro una caligine spaziotemporale che i nostri tentano di diradare tramite
un mood sonnolento, placido e dilatato. Nel caso
specifico però l’uso del pop sixties non fa che aumentare la presa rapida come cemento: ascoltare
Beach Comber e il suo coretto jingle-jangle per farsi
una idea. Non solo atmosfere e immaginario sono
sempre nel solito stile Mondanile, ma anche i titoli
dei pezzi giocano di brutto alla giostra del tropical
(Black Lake, Let's Rock The Beach e Pool Swimmers)
e faranno sicuramente la gioia di Pitchfork. Per ora,
fanno anche la nostra, contenti come bambini nel riassaporare ricordi che consideravamo persi.(7/10)
Andrea Napoli, Stefano Pifferi
Rodolfo Montuoro - Lola
(Mythologies 3) EP (Believe,
Novembre 2009)
G enere : wave - canzone d \' autore
C'è la parte legata al marketing. Quattro Ep pubblicati nell'arco di un paio di anni (questo dovrebbe essere il secondo) che confluiranno in un unico
album nel 2010, ognuno il risultato di uno scambio costruttivo tra artista e fans e ognuno ispirato
all'esplorazione della mitologia della notte. Con titoli come Orfeo e, appunto, Lola.
E poi c'è la musica, un'elettro-wave traviata dagli archi
che duetta con certa canzone d'autore del Battiato
più facile, citando nel contempo cadenze notturne à
la Giancarlo Onorato. Nel taschino la Berlino primi Ottanta e in primo piano una voce non virtuosa
ma affascinante nei suoi recitati avvolgenti.
Chanson obliqua, stridente ma dall'estetica ad ampio
respiro. Frutto di una scrittura elegante e per nulla
spaventata dallo spingersi in intellettualismi ricercati
ormai appartenenti - per lo meno nella complessità
generale - ad altre epoche (il progressive). In attesa
di un disco "lungo" che potrebbe confermare la statura artistica di Montuoro.(6.8/10)
Fabrizio Zampighi
72
recensioni
Sam And Me - The Battle of Hemsby
(Akoustik Anarkhy, Settembre 2009)
G enere : folk psych
Sam Zindel and Rowan Dawes scrivono e suonano
assieme da un pezzo. Almeno dieci anni. Può esservi
capitato di incontrarli nei Datura Dream, casomai qualcuno di voi abbia mai incontrato la musica
dei Datura Dream (io neanche sospettavo che esistessero). Poi hanno deciso di aprire una ditta più
snella e laconica, a partire dalla ragione sociale. Perché c'erano sogni pop da far decollare come piccole
mongolfiere multicolori.
Come innesco vale bene l'immaginario dei Flaming
Lips più accomodanti, quelli di Do You Realize? per
intendersi, citata non a
caso nell'iniziale Sonic Boomerang, per il resto tutto un estro Beach Boys
via Radar Bros. contagiato di affabili complicazioni prog. Alt, però. Non
fate divagare le aspettative. Che se c'è da additare
una progenitura non è certo a Coyne e compagni
che si deve guardare, ma a dei più aulici Simon &
Garfunkel (massimamente in London), opportunamente disciolti in una brodaglia madreperlacea
insaporita da fregole psych post-moderne (lasciate
perdere quindi i Kings Of Convenience).
Capace cioè di travestirsi da ballatina McCartneyBrian Wilson (Green Fingers) e ammantarsi di piglio
indie Neutral Milk Hotel (A Lying Down Disposition), di sfiorare le ugge technicolor dei REM altezza Reveal (I Fall, Can I?) oppure il Badly Drawn
Boy ancora in grado dei più morbidi sbigottimenti
(The Book, Something I Can Give). Una pacchia, insomma. Che si crogiola un po' troppo di se stessa,
specchiandosi nella propria facoltà d'incantare, incantandosi. Scordando affilatura, profondità, spessore. Tutto il resto però resta. Ed è un bel sostare.
(7/10)
Stefano Solventi
Sean Lennon - Rosencrantz And
Guildenstern Are Undead (Chimera
Music, Novembre 2009)
G enere : soundtrack
Di Jeff Buckley ce n’era purtroppo soltanto uno e
stava nell’empireo con altri Grandi. Sotto, a faticare
cercando un’identità, decine di figli d’arte portatori sventurati di un cognome troppo pesante per le
loro capacità. Soggetti smarriti in cerca di personalità, chi più e chi meno per sempre artisticamente
irrisolti. Una tragedia quotidiana, vieppiù quando nei
pasticci costoro ci s’infilano con le loro mani. Perché, caro Sean Lennon, va benissimo allontanarsi dai
dischi affatto male che hai sin qui pubblicato e dalle
millanta collaborazioni per musicare una pellicola di
Jordan Galland. Quando, però, propini incertezze
orchestrali lontane dall’erudizione di John Cale e
composizioni prive dell’ironia che ha reso grande
Pascal Comelade o dell’umanesimo appartenuto
alla Penguin Café Orchestra, qualcosa non va.
Per tacere di una canzone disarticolata come Desire
che nemmeno Kool Keith e Miho Hatori redimono, o episodi dove punti gli Air e precipiti in
una pompa che più magna non si può. Le aspirazioni
sono un macigno che non ti lascia respiro e, pur
volonteroso, affastelli discreti passaggi noir ed emuli
fiacco Ennio Morricone e Bruno Nicolai. Poche
cose tediano come la musica che, se slegata dalle
immagini che commenta, non vive autonomamente:
per quello occorre una sensibilità verso la materia che qui latita. Sean, la prossima volta che tocchi
qualcosa che non ti appartiene, chiedi prima il permesso alla mamma.(4/10)
Giancarlo Turra
September Collective - Always
Breathing Monster (Mosz,
Novembre 2009)
G enere : elettronica
Gran parte di Always Breathing Monster sta
nella spiegazione della tecnica di realizzazione
dell’album. Si tratta di un lavoro, austero ma non
troppo (Waldflöte, Terzian), di trattamento in midi
del suono dell’immenso organo della chiesa protestante di Düsseldorf. Qualcosa di assolutamente
teutonico, spesso e probabilmente anche volentieri,
ma non sempre. E in questo scarto ci si sguazza.
Vi nuota meccanico il gioco dodecafonico e minimalista di Prinzipal, trattato sui timbri e sulle dissonanze come in una versione organista e ancora più
astratta dei Denison/Kimball Trio. Così come la
successiva Mechanik, un break percussivo fatto, supponiamo, dei rumori sordi dei pedali premuti senza
pigiare i tasti. Scarto nello scarto. Una procedura
che va al termine ultimo dell’errore (chi ha detto
glitch?), citato a tre navate da Dulzian, come se fosse
una sua versione per kraut d’annata.
In effetti, dopo le parabole dei protagonisti del moniker September Collective (Paul Wirkus, Ste-
fan Schneider, Barbara Morgenstern), come di
tutta la compagine elettronica tedesca, questi suoni
sembrano per certi versi un ritorno all’austerity, intellettuale e analogica. Non tanto per l’organo in sé
(del resto alla Morgensen e al suo piano ci siamo già
abituati). Ma per aver lasciato che, come si diceva
nelle prime righe, dato strumento fosse il protagonista indiscusso della pubblicazione. E che la tecnica,
il modus operandi, venisse prima dei cervelli (che
evidentemente, mordendo la coda al cane, lo hanno
scelto).
Del resto lo abbiamo già segnalato in altre sedi.
Accanto alla decostruzione (Sasqualtera) c’è la leggerezza (in senso calviniano). La combinazione è
sempre più rinfrancante. La risposta contenuta nella
domanda: dove possiamo arrivare se frammentiamo
il suono magniloquente di un organo a canne? Arriviamo a fare della piccolissima scala un ambiente.
E questo è ciò che più conta di dischi come questi.(7/10)
Gaspare Caliri
Sergio Cammariere - Carovane
(EMI, Ottobre 2009)
G enere : canzone d ' autore
Nel 2002 Dalla pace del mare lontano lo propose come nuovo esponente di una scuola d'autore
che passando per Umberto Bindi e Sergio Endrigo guardava agli chansonnier francesofoni (Jacques Brel e Charles Aznavour su tutti) senza
accantonare uno spirito jazzistico nato e cresciuto
sotto l'aureola di Keith Jarret. Un ottimo “esordio” - con virgolette d'obbligo, dato che il primo
passo Sergio Cammariere lo fece in realtà già
nel 1993 con I ricordi e le persone insieme al
fido paroliere Roberto Kunstler - seguito poi da
prove non altrettanto
all'altezza, che rimanendo
stabili nelle coordinate
sonore, con giusto qualche tonificante scampagnata carioca ogni tanto,
non trovavano brani capaci di eguagliare la forza
dei primordi e lasciavano
in bella mostra un canovaccio ripetuto e ripetuto
ancora.
Ora, giunto al quinto disco in studio, Cammariere
prova una svolta non del tutto azzardata ma significativa. Carovane infatti amplia lo spettro d'azione
del cantautore crotonese verso lidi etno, speziando
recensioni
73
il solito connubio da quartetto jazzistico formato
da piano-contrabbasso-batteria-tromba (di Fabrizio Bosso) o sax (di Javier Girotto) più voluttuosa orchestra con aromi indiani di tabla e sitar. Il
risultato, stante un effetto un po' da cartolina quasi
inevitabile dato l'innesto didascalico su un marchio
a sua volta consolidato nella memoria, non è male,
e non è quindi aleatorio che i brani migliori tra i
tredici del disco siano quelli dove la speziatura si
realizza in forma canzone (La rosa filosofale), magari
con qualche striatura elettrica (di Michele Ascolese sul cinemascope Senti), o in strumentali vicini
ad un Ludovico Einaudi virato all'improvvisazione
moderata (Varanasi, La forcella del rabdomante).

Che sia quella world la strada da seguire in
futuro per Sergio Cammariere? Di fronte ai risultati
di altri pezzi più vecchio stampo, dove è tutto perfetto ma anche piuttosto soporifero (Insensata ora, il
singolo Carovane), viene da dire razionalmente di sì.
Ma a pelle la sviata indiana appare momentanea, appunto cartolinesca. Anche se l'augurio è ovviamente
di sbagliarci.(6.2/10)
Luca Barachetti
Shackleton - Three EPs (Perlon,
Ottobre 2009)
G enere : minimal dubstep
Sam Shackleton è il personaggio dietro Skull Disco (assieme all'amico Appleblim), giovane label di
culto pompata da opinion leader come The Wire e
Mary Anne Hobbs, vicina al mood asciutto e astratto di gente come Coki, Mala e Digital Mysticz
(li trovate tutti su Dubstep Allstars Vol. 07). Affida però alla tedesca Perlon, decisamente fuori dai
soliti giri dubstep, il debutto sulla lunga distanza:
nove pezzi su tre EP. Il perché è abbastanza chiaro:
Shackleton è un produttore che non parte dal dubstep e che ha fatto sua
prima di tutto la lezione
della minimal techno (da
Thomas
Brikmann
alla Basic Channel) e della deephouse minimalista (dalla jazzofilie delle
origini agli elicotterismi
di un revivalista radicale
come Omar S), tingendo il tutto di tribal, facendone il cuore di un desolato scenario dubstep. Una
minimal che si veste di dubstep, un dubstep che si
nutre di minimal.
Dici tribal e pensi a Luciano (che guardacaso su
74
recensioni
Perlon ha stampato delle cose, come del resto Ricardo Villalobos, con cui il nostro ha collaborato),
ma qui ovviamente non c'è nessuno tributo al sole,
semmai colori scuri illuminati dalla bruma londinese. Le composizioni ci sono (scenari ambientali pittati benissimo), nessuna ruffianeria timbrica, e però
vince lo stesso quello: un suono che sa di organico,
legno su legno e pelli tirate, come in molte delle migliori cose electroniche degli ultimi anni, dalla gommosità dei Cobblestone Jazz alla porcellana e al
budello di Bruno Pronsato e del nostro Andrea
Sartori. Minimalismo sì, e fino al pauperismo produttivo di There's a Slow Train Coming, ma con puntate anche più generose come in Mountains Of Ashes.
Disco austero, compatto, elegante. Musica desolata
ma non disperata, in questo Shack diverso da Burial o Flying Lotus.(7.5/10)
Gabriele Marino
Sight Below (The) - Murmur EP
(Ghostly International, Dicembre
2009)
G enere : techno shoegaze
Per il nuovo Murmur Ep,The Sight Below chiama a
sé Simon Scott degli Slowdive affidandogli il remix
di At First Touch. E' la conferma che il producer di
Seattle, oltre agli omaggi (vedi Glider) e alle parole
(vedi interviste), muove i fatti. Tra le quattro tracce,
due delle quali inedite, si disgiunge la title track dal
beat ipnotico (mutuato al solito dalla Basic Channel), dalle coltri dreamy e gli echi dub prossimi a
Deadbeat. Wishing Me Asleep, invece, rammenta i
migliori momenti di Glider, mentre il lavoro di Eluvium, No Place For Us (dall’omonimo Extended del
2008, in download gratuito via Ghostly) acuisce il
muro dreamy (e la battuta a farsi rantolo incantevole). Di contro, Simon Scott spoglia At First Touch (che
apriva il debutto adulto) d’ogni fattezza techno: ne
estirpa il battito per farne brumosa ambient isolazionista. Per gli interessati, l’edizione in vinile comprende The Sunset Passage remixata da Biosphere.
P.s. The Sight Below e lo stesso Scott sono al lavoro
per del nuovo materiale.(6.5/10)
Gianni Avella
Six Finger Satellite - Half Control
(Load Records, Anchor brain
Aprile 2009)
G enere : electro - rock
Come chiariamo da altre parti su Sentireascoltare,
Half Control non è la “nuova” fatica dei Six Finger
Satellite: registrato nel 2001, l'album rappresenta il seguito cronologico a Law Of Ruins, che undici
stagioni or sono li mostrava lucidi adepti krautrock
sotto la supervisione del semisconosciuto James
Murphy. Costui se ne sarebbe andato poco dopo
per mietere meritati allori (e con lui Juan McLean) ibernando la sigla fino ai giorni nostri.
Messi allora da parte “ubi maior”, gli otto brani vedono la luce remixati e affidati alla conterranea Load
e raccontano di un gruppo in stallo, concentrato su
un appena discreto martellamento noise-punk con
l’elettronica in un angolo, smarrito dentro l’abbondanza di aggressività e fracasso senza risolverli dal
punto di vista compositivo.
Erano con tutta probabilità indecisi sul da farsi, i Nostri, cercavano di reagire incanalando la frustrazione
o poggiandosi sulle rare certezze; da brava gente
che alle risposte preferiva i punti interrogativi, inciampano sovente - le uniche eccezioni una Artificial
Light potentemente elegante e l’oscura epica Bored
Oracle - in rabbia ed energia fini a se stesse. Prigionieri del proprio genio, si prenderanno una lunga
pausa per tornare rafforzati e maturi. Fotografia
della confusione di quei giorni, il disco è di spietato
rigore storico, come si conviene allo scomodo ruolo che incarna.(6.5/10)
Giancarlo Turra
Slayer - World Painted Blood
(American, Novembre 2009)
G enere : T hrash - metal
Sarà poi vero che agli Slayer gli si chiede solo di
esistere e di non incappare in incidenti di percorso
come fecero a loro tempo i Metallica. Soltanto
tre anni fa usciva Christ Illusion, che oltre a
vedere il ritorno dietro
i tamburi dello storico
Dave Lombardo, fotografava il combo californiano in ottima forma,
dopo prove non memorabili quali God Hates Us All e
Diabolus in Musica.
World Painted Blood cerca di svecchiare la formula pur mantenendo saldi i piedi nella tradizione.
Andatevi a sentire le rasoiate iperveloci e abrasive
di Unit 731, Hate Worldwide, Psychopathy Red o Public
Display of Dismerberment, e capirete che Kerry King
e soci non hanno nessuna voglia di appendere gli
strumenti a chiodo, anzi. Si fanno apprezzare anche
midtempo heavy, scarni ed essenziali come la title
track o Beauty Through Order, a metà strada tra South
in Heaven e Divine Intervention.
Da segnalare il ritorno ai bei tempi di Jeff Hanneman che firma sei pezzi degli undici totali portando
la band un passo prima di quel cul de sac nu-metal
che fu Diabolus in Musica. Le liriche riescono ancora graffiare come si deve (la critica antiamericana
di Americon, l’atto d’accusa verso la religione organizzata di Not of this God), testimoni di un invecchiamento dignitoso senza improponilbii appelli a
pacchiani “ritorni alle origini” (Death Magnetic vi
ricorda qualcosa?).(7/10)
Nicolas Campagnari
Sudden Weather Change - Stop!
Handgrenade in the Name of Crib
Death 'nderstand? (Kimi Records,
Novembre 2009)
G enere : indie noise
Ah, la gioventù sonica. Rifiorisce sempre, con la tenacia di un salnitro, come la celebre ruggine che non
dorme mai. E' uno spettro che si aggira per il mondo, almeno in quella parte di mondo devota al verbo
del rock. E' il leviatano bianco (bianco come il rumore) che abita gli abissi, riemergendo per marcare
una mappa di apparizioni ubique.
Prendete i Sudden Weather Change, quintetto di
Reykjavík al debutto: in loro si agita forte la fregola
Sonic Youth, è un intercalare che strattona la vena
espressiva fin dall'iniziale Kilgore Trout III e continua
a pulsare - inabissandosi e riemergendo - nelle restanti dodici tracce. Durante le quali si fa luce altresì
una febbre melodica indolenzita che sembra rifarsi ad uno strano connubio Robert Smith-Greg
Dulli. Un quid appassionato e malsano che trova
apoteosi nella melmosa Pray Mode (con altresì echi
dello scabro lirismo Crazy Horse altezza Weld)
per poi esorcizzarsi nel trafelato punk'n'roll di Ampeg!. Fermo restando quel caracollare sperso e convulso denuncia chiare ascendenze lo-fi e post-post,
segnatamente Pavement (immancabili) e Polvo
(immarcabili), una devozione che non si fa mancare
contagi electro e ammiccamenti punk funk.
Merito di questi ragazzi è saper esprimere entusiasmo come se fosse urgenza, districandosi tra spasmi
e burrasche in direzione di un'epica garagista che
riesce a suonare genuina, congrua, mai tronfia malgrado i tanti ingredienti e l'ampiezza della portata. In
ragione di ciò, perfettamente attuale.(7.1/10)
Stefano Solventi
recensioni
75
Tarwater - Donne-Moi La Main (OST)
(Gusstaff, Novembre 2009)
G enere : S oundtrack
La seconda uscita per la polacca Gusstaff vede i Tarwater (e l'ospite Stefan Schneider di Mapstation, To
Rococo Rot) alle prese con le musiche di un road
movie diretto dal regista Pascal-Alex Vincent e
un sound anche parecchio distante dalla formula del
duo. Dimenticatevi dunque il sound wavey'n'eighties e pensate a certo folk smaltato dell'America
dagli spazi sconfinati: c'è il tratto (non il fingerpicking) del John Fahey amato profondamente da
Jim O’Rourke, la spruzzata ambientale-elettronica
tipica della compagine berlinese, ovviamente tutto il
sostrato post-rock europeo che tutto ciò comporta, e il tocco dubby specifico di Mapstation.
Il mix finale, vincolato dal regista anche attraverso
l'indicazione di determinati strumenti da utilizzare
(banjo, armonica a bocca e fisarmonica), presenta
un'attenzione rurale resa con trame di chitarra e
una cura spaziale riprodotta attraverso fascinazioni
morriconiane.Tentazioni spaghetti ampiamente sedate comunque, e nella tipica maniera post per mano
di ricchi contrappunti (i citati strumenti più tastiere
varie, effetti, vibrafono, oboe ecc.) e risultati non distanti dai Califone. Sono pertanto le tre canzoni a
riportarci su binari propriamente tarwateriani anche
se, compiutamente, soltanto nella finale Chairs li si
riconosce appieno, benché non nella forma migliore.
E' la colonna sonora tutta a soffrire - come avvantaggiarsi - dell'impalpabile personalità. La bella e
cortissima Le Chemin Traversait La Forêt (ampio spettro strumentale, ricco interplay tra gli strumenti) è
l'unica a godere di un certo peso, altrove è un attento smalto sonoro al film. Solo per cultori ma anche
un approfondimento ambientale dell'ultimo lavoro
dei Tarwater, Spider Smile.(6.5/10)
Edoardo Bridda
Thomas Function - In The Valley Of
Sickness (Fat Possum, Dicembre
2009)
G enere : rock eighties
La NY eighties punk rock del fu Jim Carroll e di
Richard Hell, ma anche dei Violent Femmes
ibridati Modern Lovers attraverso Jerry Harrison,
con dosi di powerpop e country: questi i riferimenti
principali dei Thomas Function, gruppo proveniente da Huntsville, Alabama che si era fatto notare
l’anno scorso con l’esordio Celebration! al quale
avevamo dedicato spazio ed approfondimento.
76
recensioni
Una voce convulsa, quella di Joshua Macero, che ricorda Tom Verlaine, un’acidità palpabile, un senso
del divertimento, dell’immediatezza e della furia del
rock’n’roll che, se non raccontano niente di nuovissimo, lo fanno da post-tutto come avviene diffusamente in questi anni. Ma qui l’attitudine conta,
eccome, per far distinguere i poseurs (pensiamo
a Strokes e compagnia) da chi, come i Nostri, riprendono quelle sonorità per costruire qualcosa
che abbia un senso, musicale ed esistenziale, oggi.
E’ quindi musica, quella della band, sentita e vissuta
sulla propria pelle, e si percepisce, senza artifici di
sorta. Un buon dosaggio tra scrittura e produzione,
così come era avvenuto per il primo album, del resto, fanno di questo secondo lavoro, se non il botto,
difficile probabilmente con questo tipo di sonorità,
un buon proseguimento di carriera.(7/10)
Teresa Greco
Tom Waits - Glitter And Doom Live
(ANTI-, Novembre 2009)
G enere : blues
Diciassette pezzi dal tour europeo e americano del
2008 in un cd, mentre il secondo, Tom Tales, contiene un lungo monologo di affabulazioni alle quali
l’autore americano non è di certo nuovo. Un tour
celebrato, Glitter And Doom, che l’anno scorso lo ha
visto portare sui palchi tutto il suo mondo fatto di
blues fangosi, ironie e ritmi indiavolati, con la sua più
tipica raucedine.
Una carriera che negli anni si è mantenuta, anche
negli inediti, a livelli più che buoni, segno di una longevità appassionata e mai indomita. Non fa eccezione questo album dal vivo e la relativa tournée
che lo ha visto protagonista anche dalle nostre parti. Un’occasione da non
lasciarsi sfuggire, anche
se ascoltando qua e à i
brani si percepisce una
carica maggiore che forse mancava in qualche
occasione nelle esibizioni italiane. Ma tant’è, il
Nostro non si discute o
perlomeno non ci sembra veramente ora il caso,
visto dall’alto di una carriera così scintillante.
Una testimonianza quindi per chi c’era e per chi
non c’era, del carico di visionarietà, si veda il monologo sbilenco per esempio, che tuttora Tom Waits
riesce a costruire intorno a sé.(7.3/10)
Teresa Greco
Tricky - Tricky e South Rakkas
Crew - Tricky Meets South Rakkas
Crew (Domino, Novembre 2009)
G enere : dancehall electro fidget versions
La pratica del versioning sta alla base del dub: riprendere le tracce senza vocals e trasformarle con
i suoni contenuti nelle B-sides. Ha un po’ di questa
tecnica in mente Tricky, quando pensa di rivisitare
l'ultimo Knowle West Boy in chiave electro dancehall.
Non è un disco di dub: il buon vecchio kid chiama in
studio la South Rakkas Crew, gruppo pescato a
Orlando (mescolato a origini giamaicane e sviluppi
canadesi) che viaggia su coordinate ragga dancehall
e ha al suo attivo remix per VIP del settore (Diplo,
Sinden, Switch, Surkin, A-Track).
Il risultato va da un electro col vocoder (C’mon Baby)
a uno step di classe (Coalition), break con i tagli acidi
(Slow) e il classico ragga (Baligaga). Aggiungici un po’
di electro 80 (Numb), laseroni (Far Away) e scopri
che le coordinate si amalgamano alla perfezione con
il vocione di Tricky, conferendo nuova vita all’album
che sarebbe rimasto in una dimensione off-dancefloor. Divertissement godibilissimo.(6.6/10)
Marco Braggion
Uncode Duello - Tre (Wallace
Records, Dicembre 2009)
G enere : impro - rock
Stavolta siamo proprio all’essenza ultima del duello. Xabier Iriondo e Paolo Cantù sono soli, l’uno
di fronte all’altro, lame sguainate ad affronarsi. Lo
scontro è senza esclusione di colpi. Breve, intenso
e all’ultimo sangue, come nella migliore tradizione
cavalleresca.
Il duo si mette in gioco in toto, passione per le musiche rumorose e propensione free: due uomini e
un’anima divisa in due, aderente ai due lati del 10”
Tre (anche in splendida versione cd cartonato): il
primo, quello primitivo, aggressivo, rumoroso viaggia sul noise espressivo (Le Stesse Cose Che Ho Fatto), tutto spigoli e curve a gomito, sfaccettato come
un caleidoscopio rotto e sull’orlo della distorsione
(Sono La Nostra Storia); il secondo frammenta l’animo a colpi di impro, elettrico ed acustico scavano
l’uno nelle vene dell’altro mentre voci trovate rendono il tutto sfuggente ed ectoplasmico (Train Is The
Place). Uncode Duello dimostra ancora una volta non solo di saper camminare nelle impervie vie
dell’impro-rock più deforme e rumoroso, ma anche
di indicare il cammino a chi voglia seguirli.(7/10)
Stefano Pifferi
Underworld - Underworld vs the
Misterons - Athens (!K7, Novembre
2009)
G enere : J azz e other
I fantasmatici Misterons altri non sono che Darren
Price e il Junior Boys Steven Hall. Cosa ci facciano
in una compila che pare abbia scritto in fronte "I
Love Canterbury" è un vero enigma. "Tutto il disco
gira attorno al jazz e ai groove" dichiara il duo, "gli
Underworld hanno sempre dato enorme importanza al
suonato. C'è troppa musica automatica nei club e l'idea
attorno a questo lavoro nasce proprio dalla voglia di sottolineare le tracce in cui l'intesa live avesse un'impronta
determinante".
I brani selezionati per Athens pescano quindi sia
dalla storia della contaminazione jazz sia dai suoi
recenti innesti in territori house e techno. Gli Underworld stessi sono abilmente calati nel mood
(Oh) tra hip house, psych Mahavishnu Orchestra
(presenti con You Know,You Know) e la tribal filo Settanta di Osunlade (The
Promise). Non mancano
poi le chicche. Entrambe
con Brian Eno dietro
le quinte come la storica
ballatona 2HB dei Roxy
Music (arrangiamenti
jazzy per loro) e l'inedito con lo stream-of-consciousness rap di Karl Hyde, Beebop Hurry, registrato a Sydney un paio di mesi fa (ancora jazz ma in
chiave ancora più moderna). Cosa abbia portato gli
Underworld così dentro Canterbury è un enigma.
E poi, sarà vero amore? E come fa Squarepusher
(Theme From Sprite) ad innestarsi perfettamente nei
Soft Machine di Penny Hitch? Ci sta ci sta...(7/10)
Edoardo Bridda
Uv Race - The Uv Race (Aarght!,
Settembre 2009)
G enere : G arage P ost P unk
Gruppo di punta di una carbonara scena post-punk
australiana raccoltasi attorno ad etichette come
Stained Circles, Aarght! e Fifth Column, gli UV
Race giungono ora al debutto sulla lunga distanza.
Che siano australiani si sente fin dai primi accordi,
dalle influenze più classiche come Electric Eels e
Urinals giù fino a leggende locali quali X e Saints
(le asimmetrie di Dog Tired e Make You Strain e il sax
di Driving In Our Car che ricorda il gruppo di Chris
Bailey altezza Prehistoric Sounds). Poi potremmo tirecensioni
77
rare in ballo i Tyvek di Detroit, ma è l'anima più
sghemba ed obliqua del garage punk ad essere fagocitata, masticata e risputata sul piatto.(6.8/10)
Andrea Napoli
Vals (The) - Sticks & Stones
(Electrique Mud, Ottobre 2009)
G enere : psych pop
Quintetto da Belfast che da qualche anno scalpita
facendosi le ossa, concerto su concerto, finalmente
i The Vals debuttano e lo fanno nel segno della più
convinta, densa, piena devozione al verbo John Lennon. Senza restarci imbalsamati, ovvero declinandolo in diversi modi perlopiù opportuni e arguti, tipo il
brit-soul squillante dell'iniziale Too Many People (una
brusca festosità Style Council) o il boogie pop con
tentazioni eighties di With You (un autentico gioiello
power pop), o ancora le striature (le contaminazioni?) George Harrison/Kinks di These Little Reasons e infine quella sorta
di estro Echo & The
Bunnymen posterizzato Franz Ferdinand
che carbura in Where I'm
Most Alive.
Ribadiamolo, perché ne
vale la pena: lo spirito di
Lennon è dappertutto,
abita le movenze e la fibra di ogni pezzo. Un'attitudine che in qualche modo riesce a sembrare genuina,
certificata da un senso d'urgenza e di vissuto che
ricorda i primi I Am Kloot, tanto che una Yesterday
Today si può certo decifrare come una profusione
d'espedienti lennoniani (diciamo una Mind Games
trasposta su un piano di affabilità assoluta) ma del
tutto convincente, avvincente, irresistibile. Nei termini che abbiamo appena descritto, è un disco eccellente. (7.2/10)
Stefano Solventi
Very Best (The) - Warm Heart Of
Africa (Moshi Moshi, Novembre
2009)
G enere : W orld
Non poteva che essere Londra, città-mondo da sempre epicentro di molteplici innesti e contaminazioni,
a propiziare la nascita di questi The Very Best, sodalizio che unisce il duo di produttori/dj Radioclit
(il francese Etienne Tron e lo svedese Johan Karlberg) ed Esau Mwamawaya, giovane talento originario del Malawi con in curriculum svariate espe78
recensioni
rienze musicali. Succede che i tre si incontrano in
un negozietto d’usato, si fiutano ed evidentemente
si piacciono, tanto da decidere di capitalizzare i rispettivi background dando vita a una nuova creatura sonora. Risultato: il folgorante mixtape-manifesto
diffuso gratuitamente in rete sul finire del 2008, oltre 300.000 download pervenuti sul loro myspace a
far montare l’onda dell’hype e un altro bel colpaccio
assestato ai danni delle detestabili major.
Considerate le premesse, c’era da attendersi un
esordio coi fiocchi, e così - per una volta - è: dodici tracce in programma, dodici formidabili schegge
pop che sorvolano coordinate d’ogni genere (geografiche, musicali, linguistiche) muovendo verso
nuovi orizzonti, sorta di immaginaria free zone al
crocicchio fra lucidità contemporanea (vedi i beat
ultracromatici e i calibratissimi innesti elettronici) e
slancio ancestrale (il mantra innalzato al cielo d'Africa sulle note della conclusiva Zam’dziko).World music a uso e consumo delle platee indie rock, si dirà,
e allora ben venga un pezzo come Rain Dance - con
quella ritmica battente che pare prendere di petto
le fregole afro dell’ultima Bjork (altezza Earth Intruders) e una special guest del calibro di M.I.A. - ad
aprire le danze, laddove la title track (altro ospite di
riguardo, Ezra Koenig dei Vampire Weekend) è miraggio pop memore del Paul Simon sudafricano.
E il resto? Tutto un susseguirsi di polifonie estatiche
(Yalira), esotismi da stordimento dei sensi (Ntende
Uli, Kamphopo, uno dei due pezzi ripescati dal mixtape, l’altro è un remix di Kada manja) e aperture
melodiche semplicemente irresistibili (Julia, Chalo).
E allora non resta che denudarsi, commuoversi e
ballare.(7.3/10)
Nunzio Tomasello
War Duo - La commissione
d'ascolto (Improvvisatore
Involontario, Novembre 2009)
G enere : jazz - avanguardia
Batteria e pianoforte. Il secondo che diventa uno
strumento percussivo al pari del primo, tanto da seguirlo a scapicollo in ogni mutazione ritmica. Sembra
di ascoltare un Dave Brubeck periodo Time Out
fuori controllo o un Art Tatum traviato da certo
classicismo da camera avanguardista (Monovano vista mare), il tutto decontestualizzato. Fuori da ogni
melodia e lontano da temi facilmente identificabili.
Improvvisazione, destrutturazione, ma soprattutto
scambi continui e tensioni irrisolte tra i tamburi di
Francesco Cusa e i tasti di Marcello Di Loren-
zo. Free come non ti aspetteresti (Fun 2), crescendo
inquietanti in cui si passa dai legni alle pelli a seconda dell'intensità del suono, rincorse ironiche a perdifiato (Giuvanni? Alléviti!), cascate di note dissonanti
su basi dispari (Puglisi). Unire l'avanguardia jazz alla
classica più sperimentale giocando con la ritmica:
questo l'obiettivo dei due musicisti. Il risultato è un
disco ostico e di spessore, capace di concedere al
gusto più tradizionale solo i ventitré secondi (complessivi) del Prologo e dell'Epilogo.(7/10)
Fabrizio Zampighi
Washed Out - Life Of Leasure / High
Times (Mexican Summer, Novembre
2009)
G enere : glo - fi nu - new age
Il formato dice tutto: si va sulla breve distanza per
l’esordio dell’americano Ernest Greene. Nel giro
di due mesi, prima ai nastri (a settembre) dalla sua
label / blog / showroom
Mirror Universe Tapes,
poi su digitale. E torniamo su terreni glo-fi tra
tinte sepia, sound ovattatissimo e tastierine
con il setting esplicito ai
riferimenti anni Ottanta:
Englishman in NY per Belong, gli Wham! in Get Up, la memorabilia mixage in
Good Look e Olivia e poi giù di spezie soul (Hold
Out) alla ricerca di un eldorado edonista.
Strano tipo Greene: sogna una provincia americana
senza western, né bisogno di conquista, si dipinge
paladino blog di una generazione dell’ancora-un-video-so-eighties-e-poi-esco, prova nostalgia per degli
Ottanta inglesi - e per la Milano da bere via Paninaro
dei Pet Shop Boys - che non ha vissuto. Ti gira poi
la frittata in blacksploitation (It's Kate's Birthday), ci
va di funk facendo rientrare dalla porta l'america
black che era uscita per un attimo dalla finestra per
togliersi lo sfizio wasp wave di fine '80.
Operazione riuscita e tutta in divenire quella di
Washed Out. Come dire nu-lounge, mossa hip e
non solo martini bianco e pompelmo rosa a bordo piscina.Grande cura per l'atmosfera che poi è
quel che conta e distingue questo ennesimo revival.(7.1/10)
Marco Braggion
Weltraum - Sy (Toxo Records,
Novembre 2009)
G enere : R izomatil C haos
Sette movimenti ondivaghi, sette traccie, sette rizomi.
Un rizoma è qualcosa di più di un arbusto: non ha linee, circola in particelle autoriproduttive, ha un dna
multiplanare, è infinito al suo interno. Questi sono
i Weltraum, ovvero P'ex (chitarra preparata e
metalli), Luca Piciullo (batteria e campane), _Sec
(synth, elettronica e microfoni).
Un tempo adoravamo i Laddio Bolocko, c'era
freschezza lì dentro, krauta ed ermeneutica; i Weltraum hanno il loro corpo senza organi appollaiato su quelle stesse coordinate fantasmatiche, ma in
loro c'è l'infinita ciclicità del caos, la profondità oceanica di ciò che è occulto, la caduta tra la materia
e l'antimateria. Si parlò per qualche stagione di quel
miracolo chiamato The union of a man and a
woman, con cui il gruppo in questione può condividere l'età, approssimativamente giovane, ma qui
dentro non c'è taglio e ritaglio, questi brani sono totali perché diretti, senza copia/incolla, suonano così
perché sono così.
Concatenamenti collettivi, rotture e riorganizzazioni mimetiche, inversioni e cervelli deterritorializzati:
"non c'è speranza" c'è scritto sulle note, non c'è
veemenza, lasciate il cuore da qualche altra parte,
perché qui ogni strumento è doppio, poi triplo e
poi moltiplicabile al rizoma ed è quindi dovunque.
L'ascoltatore è condannato a morte sotto questi
suoni...
I Weltraum sarebbero capaci di far suonare un synth
come un vulcano ed una chitarra come una meringa,
hanno coordinate mentre non ci sono coordinate
nel loro manifesto programmatico: prendono un
suono e lo capovolgono, un barile di benzina diventa
una pianta carnivora, una lastra di metallo un igloo
per animali spaziali. Non si sa da che direzioni stiano
arrivando gli schiaffi, i calci, se questi siano abbracci
o addii. E' una musica che fulmina, che chiede attenzione alla stessa maniera di una persona che saluti
da un treno e non rivedrai mai più. Non sai se dopo
sarai esausto, morto, vivo e vegeto; quello che conta è rimanere collegati al tragitto, camminare sulle acque, sfondare montagne per trovarsi dall'altra
parte del nulla. Segnatevi questo nome: mettetelo
sulla lista nera oppure portatelo sulla vostra isola
deserta ideale. Ne riparleremo in sede appropriata.(7.7/10)
Salvatore Borrelli
recensioni
79
Wizzard Sleeve - Make The World
Go Away (Hozac, Ottobre 2009)
G enere : C yber G arage P unk
Nell'affollato microcosmo del weird-punk americano c'è spazio anche per gruppi provenienti dalle periferie del Nuovo Continente e i Wizzard Sleeve
ne testimoniano il valore; certo rispetto ai loro colleghi di NY sono tendenzialmente meno smaliziati e
più legati al vecchio modo garage di suonare, ma ciò
non è da considerarsi un male, anzi. Proprio quando
la matrice blues-rock esce di scena è bene che ci
sia qualcuno che ne ricordi l'importanza radicale; in
altre parole: come avvicinarsi al synth senza dimenticarsi del fuzz. Non stupisce quindi che tradizione
e (archeo)futurismi convivano pacificamente e fruttuosamente in solchi come questi.
Così i vecchi blues dell'Alabama sembrano ora essere suonati da macchinari robotici (Chrome Intensifier),
e gli stomp polverosi da sapore sudista (Shapeshifter
Blues) sono messi a sedere vicino a dei cyborg con
la fissa, manco a dirlo, per i Chrome (No Mongo).
Unica nota dolente, se così la vogliamo considerare,
l'elevato numero di pezzi già pubblicati sui singoli
degli scorsi anni che, purtroppo, non sempre sono
all'altezza delle prime versioni. In particolare per chi
ha ancora nelle orecchie la take di Alabama's Doomed presente sullo split con gli Amber Alerts,
questa nuova, oltretutto messa in apertura di album,
sarà un po' deludente; ma è solo un primo intoppo,
il resto poi scorre via che è un piacere.(7/10)
Andrea Napoli
Wora Wora Washington - Techno
Lovers (Shyrec Records, Novembre
2009)
G enere : electro - post - punk - psych
Sono taglienti e acuminati, ma non c'entrano nulla con i coltelli “Miracle Blade”. Con certi Arcade
Fire shoegaze (Daisy) e un elettro-post-punk in stile techno-Rapture pero' si, con tutti gli annessi e
connessi del caso. Il che significa programming eccitato (Drum Machine), chitarre acide (Seven Days),
synth scostanti (Ten Seconds) e in generale una
tendenza a scovare l'arrangiamento più cool tra
hype sincopato e staffilate in distorsione.
La macchina di Marco De Rossi, Matteo
Scarpa e Giorgio Trez
80
recensioni
è ben oliata, tanto che il primo impatto è di quelli
che lasciano il segno. Poi capisci che dietro ci sono
ascolti ripetuti di antecedenti illustri e un'ottima capacità di selezionare in quella complessità di patterns
e riff ad effetto che un orecchio sveglio e una mano
veloce possono garantire. Con due anime distinte
che si mescolano all'interno del disco: una traviata
da bordoni sintetizzati massicci quanto ingombranti
e l'altra interessata a solleticare le elettricità malleabili di chi nell'indie “emodelico” degli ultimi tempi
ha trovato un comodo asilo politico. A fare da collante, un'ombrosità new wave sottomessa eppure
palpabile, invischiata nei suoni delle chitarre quanto
nelle progressioni armoniche.
L'esordio dei veneti Wora Wora Washington è di
quelli che valgono un messa. Ben suonato, coscienzioso, sottilmente conservatore, adatto a un rock
club con aspirazioni “danzereccie” come allo stereo di qualche orfano di The Faint, The Music e
compagnia. Tanto che sarebbe un delitto non dargli
almeno una possibilità.(7.2/10)
Fabrizio Zampighi
Xabier Iriondo/Stefano Giust/
Gianni Gebbia - L'Edera, il Colle
e la Nebbia (Setola Di Maiale,
Settembre 2009)
G enere : impro - jazz
Titolo poetico per l’ennesimo lavoro collaborativo
tra Mr. Setola di Maiale Stefano Giust e Gianni
Gebbia. Al batterista extraordinaire spesso e volentieri citato in queste pagine e al sassofonista free
palermitano si aggiunge in occasione di queste sessions dal vivo un terzo elemento che non sfigura
affatto come terzo vertice del triangolo: Xabier
Iriondo.
Le sette improvvisazioni libere che compongono
l’album, dopotutto, non lasciano spazio a dubbi sulle
capacità creative e sulla sensibilità del trio: obbiettivo centrale delle registrazioni di tre diverse live
sessions targate 2007 è quello di plasmare la materia di partenza, ovviamente e latamente impro-jazz,
secondo l’umore del momento. In questo è centrale
l’operato di Giust e del suo indubbio orecchio musicale, capace di sottolineare col drumming eterogeneo che lo caratterizza da sempre ogni momento
della performance. Ai lati, per modo di dire, il sax
alto di Gebbia contrappunta con dettagli, frammenti, frattaglie e stacchi minimi mentre Iriondo, persa
ormai per strada la chitarra, si china sulle sue creazioni artigianali (in primis la mahai metak, ma anche
electronics e crackle box) per condire, riempire,
stranire il suono prodotto dai sodali.
L’edera, Il Colle, La Nebbia è il sunto di performances live dei tre in cui si procede per sottrazione,
anzi per riduzione senza per questo risultare minimali, perché a scavare, anche nei vuoti e nei silenzi
che lo condiscono (vedi Camminando Guardo), se
ne trovano eccome di gemme. Veramente pregevole.(7/10)
Stefano Pifferi
Zoey Van Goey - The Cage Was
Unlocked All Along (Chemikal
Underground Records, Ottobre
2009)
G enere : indie - pop
Un canadese, un irlandese e un'inglese che si incontrano nei “verdi giardini dell’Università di Glasgow” e
fondano un gruppo che porta il nome di una pittrice
Amish raggiunta da una
certa fama underground
dopo essersi trasferita
a Berlino per poi scomparire nel nulla in seguito alla caduta del muro
può fare solo un genere
di musica: il famigerato
indie-pop-da-cameretta,
croce e delizia per tutti coloro che sì la malinconia,
sì la tristezza, sì le atmosfere sognanti e crepuscolari
ma ogni tanto anche scendere in strada e annusare
l'asfalto no che non è male.

Così i Zoey Van Goey, ultima scoperta Chemical
Underground, invero camerettari ma non così tanto. I tre infatti narrano con spirito naïf, voci dolcificate (due: una maschile e una femminile) e melodie
a ventosa le loro magagne sentimental-amicali, ma
ogni tanto aprono anche le finestre della loro stanza
e durante una giornata di cielo sereno con qualche
nuvola all'orizzonte guardano il mondo o almeno
quel che appare a loro come tale. Per il resto fanno
ciò che ci si aspetterebbe da qualsiasi pop-band degna di questo nome, ovvero canzoni confortanti e
fantasiose, nelle quali da un armamentario strumentale assai assortito (chitarre, piano, synth vari, ma
anche banjo, drum machine, viola, dulcimer, casiotone e l'immancabile xylophono) emerge soprattutto
un'anima folk-pop tutta arpeggi legnosi e coloratissime foglie che cadono.
Con City is exploding, riflessione non del tutto comprensibile sull'apocalisse che sta per arrivare, provano a scrivere la canzone e quasi ci riescono, con
quel tanto di atmosfera irlandese che date le origini di uno dei tre componenti è anche normale che
venga fuori. Buon esordio insomma, e bello l'artwork del booklet un po' fiaba, un po' fumetto, un
po' realtà come loro.(6.7/10)
Luca Barachetti
recensioni
81
live report
Zen Circus
Officina 49 (Forli-Cesena)
07 Novembre 2009
Bastano un basso, una chitarra e un rullante per fare
serata. E ovviamente un gruppo come gli Zen Circus.
Già lo sappiamo. Finiremo col perderci in una trafila
di luoghi comuni. Cerchiamo di esaurirli nel giro di
qualche riga, dicendovi in primis che gli Zen Circus
sono semplicemente una delle migliori macchine da
concerto uscite in Italia negli ultimi anni. Se non ci
credete chiedetelo al pubblico “incravattato” e trendy dell'Officina 49, capace di trasformarsi nel giro di
un'ora in un Hyde con diritto di replica alle provocazioni (volute) di un Appino decisamente in serata.
Sottolineando poi come il trio pisano eviti con grazia gli stereotipi legati alla “notorietà” - nonostante
gli ottimi riscontri raccolti da Andate tutti affanculo -,
grazie a un set sudatissimo e coinvolgente. Rilevando
infine come l'esperienza non sia solo un accessorio
ma torni utile quando c'è da confrontarsi con situazioni in cui non tutto gira per il verso giusto.Vedi alla
voce “acustica”, in un locale in cui - complice anche
una morfologia evidentemente poco consona - l'impianto spara nel modo giusto gli strumenti ma perde
per strada la voce.
Venendo alla cronaca, si parte con Gente di merda e
si finisce con It's Paradise, per un concerto che prende in prestito soprattutto episodi tratti dall'ultimo
disco (tutti in scaletta a eccezione di Amico mio) e
dal precedente Villa Inferno. Segno evidente che dello
scarto esistente tra il nuovo materiale e la produzione passata s'è accorta anche la band e non solo
qualche critico particolarmente puntiglioso.Tanto più
che l'impatto live dei nuovi brani è devastante, sia per
chi con certe cadenze punk-rock-autoriali ci traffica
già da un po' sia per chi non ha mai sentito parlare
della formazione. Conseguenza diretta, crediamo, di
una scrittura finalmente riconoscibile e ricca di personalità.
Nella girandola delle richieste c'è tempo per il pop di
Punk Lullaby e l'ironia di Vent'anni, i Talking Heads
di Wild Wild Life e il Sud America di Mexican Requiem,
la poesia da strada di Figlio di puttana
e il punk di Vana gloria, oltre che per amor fou
82
recensioni
una cover raffazzonata ma cattivissima di White Light
White Heat dei Velvet Underground. Quest'ultima suonata con un signor “nessuno” - probabilmente un autoctono - emerso dal pubblico con chitarra
elettrica al seguito e deciso a improvvisare una jam
session con il Circo Zen. Dettagli, anche questi, che
la dicono lunga su un approccio alla musica che per la
band rimane democratico, senza filtri e slegato dalle
dinamiche di ruolo che lo stare su un palco di solito
dovrebbe prevedere.
Fabrizio Zampighi
Wilco
Teatro della Pergola Firenze
13 Novembre 2009
Oltre due ore di generoso e sincretistico rituale adult-rock
officiato da una band in forma straordinaria. I Wilco, al
loro meglio.
E adesso che il concerto è finito, ti resta la sensazione
d'aver assistito a due, anzi tre, a non so bene quanti
concerti incastrati assieme. Compressi ed espansi in
oltre due ore sudate, tirate, distese ed infine - ahinoi
- evaporate in una nuvola di ricordo indelebile. Di
questo sincretistico rituale adult rock, Jeff Tweedy è
impagabile quanto improbabile cerimoniere, stretto
nel suo tipico giubbottino jeans, l'aria da povero cristo stropicciato e vagamente pasoliniano, un disilluso
che forse ha finalmente fatto pace con la vita. Forse.
Attorno a lui, assieme a lui, una band con i controcoglioni. Nella quale spiccano i contributi di Nels Cline
- dalla cui chitarra spasmodica e incendiaria il Wilcosound davvero sembra non poter più prescindere - e
Glenn Kotche, probabilmente il batterista rock più
dinamico ed evoluto sulla piazza. E' un sestetto che
impressiona per la compattezza, quel senso di interplay assieme disinvolto e rigoroso che permette anzi
incoraggia anzi esige evoluzioni soliste sempre ben
integrate nel sound. Sound che quindi si sbriglia come
tumulto organizzato, una tempesta mentale che ora
infuria ora si placa fino ad uno stato di quiete armata, dove comunque quella tempesta non smette mai
d'esserci e somiglia maledettamente a qualcosa di veramente accaduto. Che forse la vita ha metabolizzato.
Forse.
E' una sarabanda di cicatrici che tornano a farsi sentire, di fitte nell'anima che metti a tacere con scariche d'adrenalinico abbandono, questa la formidabile
terapia che il rock'n'roll può - e sa - apparecchiare.
Le ricette si sbrigliano tra il chimico e l'alchemico:
una versione cubista della Band, un John Lennon
risorto post-rock, certe imponderabili epilessie Steely Dan, Gram Parsons infebbrato soul, una autobahn tra San Francisco e Chicago... Ad ognuno la
cura adeguata, lo sciroppo prediletto. Il dosaggio è
pur sempre quello della canzone.
Tra queste, al sottoscritto hanno provocato brividi
fin dentro lo stomaco Via Chicago e At Least That's
What You Said. Su tutte però ho gradito i positivi effetti di una stratosferica Impossible Germany, nonché
il conforto del cazzeggiare generoso e impeccabile
durante Hate It Here e Spiders. Scaletta ricchissima,
orientata dalle parti di A Ghost Is Born. Se guardi al resto del repertorio hai l'impressione - oserei
dire la certezza - che se ne potrebbe ricavare almeno
un'altra di pari bellezza e intensità. Questo sono i
Wilco, oggi. Bontà loro. Fortuna nostra.
Stefano Solventi
Margareth/Alessandro Grazian/Guru
Banana
Macaco Country Birthday Party Macaco Night
(Treviso)
31 Ottobre 2009
Metti una sera a casa Macaco per un Halloween indierock senza maschere e lontano dall'Italia in sbornia yankee
Autocarri solitari, SUV tirati a lucido che ti tampinano da dietro per schizzare chissà dove e una sfilza
di paesi della bassa veneta - con relativi incroci, autovelox e pensionati valorosi che pedalano a bordo
strada - da attraversare. La statale SS309 è un piccolo
inferno, inconsapevolmente in tema con la serata di
Halloween. Roba da restarci secco. Roba da “periferia
del mondo occidentale” come cantava Gaber un po'
di tempo fa. Inevitabile pero', visto che la destinazione sono i dintorni di Mogliano Veneto e questa è la
strada più breve per arrivare.
L'occasione è importante: si festeggiano i primi cinque
anni di una delle etichette discografiche più in vista
del panorama sotterraneo nostrano. Vino, persone,
ma soprattutto musica, come dimostra una locandina
che chiama a raccolta Guru Banana, Alessandro
Grazian e Margareth in concerto. Memorizziamo, apprezziamo la scelta e aspettiamo, il tempo di
una pasta e fagioli con radicchio - in piena tradizione
locale - biologica e decisamente gustosa. Del resto
il posto merita, immerso com'è nella campagna più
sperduta. Una co-housing ritagliata in un lembo di
terra enorme tra l'A27 e il passante di Mestre - il
traffico è a due passi, ma non si sente - che vive in
totale autarchia. Il che significa colture di prima mano,
gruppi di acquisto, cooperazione e solidarietà. Bello
e insolito per un Paese come l'Italia in cui ci si ammazza tra vicini di casa. E in linea con una concezione
di indie-rock che cerca di coniugare la qualità a uno
scambio vicendevole tra le parti, vivendo nel contempo di situazioni sempre più ridotte (complice, anche
la crisi economica).
Come dimostrano le serate organizzate periodicamente dalla Macaco in questa sede - cena più musica
- e in generale la moda degli house concerts diffusasi
negli ultimi anni.A spiegarcelo è anche Paolo Zangara
dei Lo.mo, uno che può vantare una certa lungimiranza in questo senso con l'associazione Sur Le Sofa.
Il “successo” del format, ci fa capire, va ricercato in
elementi banali quanto fondanti: prezzi ridottissimi,
ambiente intimo e la certezza di assistere a un evento (quasi) irripetibile. Chi suona apprezza il clima familiare e l'estrema attenzione che ne deriva mentre il
pubblico ha la possibilità di vedere e ascoltare musica
senza doversi svenare. Adatto, ne converrete, a un'
Italia del rock indipendente in miniatura, con scarsissime risorse a disposizione ma non certo a corto
di idee. Ci dice anche altro, Paolo. Ad esempio che
Milano non è più la terra promessa per ogni buon
musicista che si rispetti, soprattutto per una carenza
cronica di spazi intermedi - tra il centro sociale e il
grande club, per intenderci - in cui suonare. Passiamo
in rassegna le principali città italiane e tra le tante ci
viene da salvare solo Torino, che anche Bologna ultimamente non se la passa troppo bene. E allora viene
da pensare: ma non è che questa cosa del “piccolo
ma bello” che si vede nei concerti faccia un po' il paio
con una rivalutazione della provincia (nell'organizzare
eventi e nel trovare spazi deputati) a discapito delle
grandi città?
Una riflessione plausibile, ma da destinare ad altra
sede. Anche perché ora c'è da fare altro. Nello specifico dribblare conigli, galline, pavoni e filari infiniti di
radicchio trevigiano per assistere a questa versione
country - field concert ? - dei concerti da appartamento. Nel freddo pungente della campagna si socializza il
giusto, ci si confronta con Alessandro Grazian su
canzone d'autore e dintorni e si ripassano nomi: Giovanni Ferrario, Andrea Fusari, Scott Mercado
(Black Heart Procession, Manuok). Ognuno di loro
recensioni
83
presente, ognuno di loro un ruolo nella storia dell'etichetta. A cominciare proprio dal Ferrario produttore
artistico e punto di riferimento per molta della musica della label veneta, come potrebbero confermarvi
i Grimoon di Lanterne Magique e Le 7 Vies Du
Chat o lo stesso Fusari di quei Gurubanana in cui
milita anche il musicista lombardo. Meriti conquistati sul campo e lavorando sodo, tra una P.J. Havey e
un John Parish, Hugo Race e Morgan. Insomma, più
guru di quanto non ti aspetteresti, ma forse, a ragione.
L'americano deve invece alla Macaco un No End To Limitations di due anni fa ed è qui per offrire i suoi servigi dietro al mixer per l'imminente quarto disco dei
Grimoon.Tanto che si presenta solo in tarda serata e
per suonare dieci minuti, dopo aver passato tutto il
giorno a lavorare proprio alla nuova fatica della band
veneta. Il giorno successivo ci sarà modo di ascoltare
pure un paio di pezzi del CD in anteprima, troppo
poco per pensare anche solo lontanamente di trarre
conclusioni di alcun genere.
E siamo al concerto. La sorpresa sono i Gurubanana: bravi su disco e “tiratissimi” dal vivo, con una sezione ritmica di carattere e certe chitarre elettriche
assassine a cesellare brani come Cold Water e Bucky
Bucky. Non c'è un attimo di tregua durante il set e il
rock lourediano della compagine fa morti e feriti tra
gli ospiti un po' su di giri, ribadendo il concetto che
per suonare ottima musica non servono progettualità
mirabolanti ma soltanto qualche buona idea (i brani
di Fusari) filtrata da un certo buon gusto (la produzione di Ferrario). Che dire, vorremmo rivederli al più
presto, al completo e magari più vicino a casa. Come
rivedremmo volentieri anche Grazian: lui è sempre
lui, che lo si ascolti con una schiera di musicisti classici attorno o da solo con la chitarra acustica, come
in questa occasione. Voce toccante, musica vera, canzone d'autore di livello come sono rimasti in pochi a
farla in Italia. La verità è che ci vorrebbe più attenzione per proposte del genere ma l'attualità del rock indipendente è purtroppo anche esterofilia e questioni
di corsi e ricorsi stilistici, questi ultimi spesso poco in
linea con la serietà compita di una musica come la sua
(parliamo di Grazian, ma potremmo citare anche 33
Ore,Adriano Modica, Cesare Basile, ecc..). Nella terra
di mezzo tra l'uno e gli altri si posizionano i Margareth, nuova scoperta in casa Macaco. Il loro set è un
succedersi raffinato di trombe in sordina e pianoforti,
batterie e chitarre, tanto che tornano in mente certe
derive dei Mojave 3 con meno istinto pop e più eleganza. A febbraio uscirà il disco d'esordio, per cui rimandiamo tutte le possibili elucubrazioni al momento
84
recensioni
della recensione. L'impressione generale, comunque,
è positiva.
Finisce così la serata, tra musica suonata, DJ di rito e
sacco a pelo. Prima di chiudere ripensiamo a un caffè preso il mattino del primo novembre a un metro
da un campo arato e sotto un sole capace ancora di
riscaldare; a Scott Mercado che azzanna una fetta di
pane e nutella dopo aver dormito tutta notte con un
gatto sulla barba; a un Andrea Fusari appassionato di
rock e blues d'annata in un'epoca in cui - purtroppo
o per fortuna, decidete voi - si ascolta tutt'altra roba.
Il resto è un ritorno a casa sulle note di It's Not Supposed To Be That Way dei Phosphorescent, con qualche
ora di sonno in meno e molte buone vibrazioni in
più.
Fabrizio Zampighi
Hair Police
XM24 (Bologna)
11 Novembre 2009
Hair Police ed Hundebiss fanno tappa a Bologna per un
tour all'insegna dell'antistile
Mike Connelly lancia un guaito lacerante e s'accanisce
sulla chitarra. Mano aperta-chiusa-su-giù come nella
migliore tradizione Dead C. La batteria dietro monta
ritmi incalzanti e poi c'è quella carcassa elettronica a
collo ad agghindare la bolgia. Noise barbaro. Post nucleare. Sono le frigotecniche dell'Xm24 di Bologna ad
accogliere l'unica data italiana di Hair Police, uno dei
primi tra i mostri sonici partoriti negli ultimi 10 anni
da quel pezzo d'america che ha dato i natali anche a
Wolf Eyes, di cui lo stesso Connelly fa parte stabile.
L'occasione è l'uscita per Hundebiss (quella dei concerti segreti milanesi, per intenderci) di un nuovo album che per la cronaca è stato registrato in un motel
dell'Ohio (dove la band è rimasta bloccata in seguito
a una tempesta di neve). Prima di loro, giusto menzionare i Catrame da Bologna. Suonano come dei
Minutemen ritrovati hardcore: ritmi funk, chitarra
surf e Negazione. E Dracula Lewis (una metà della
Hundebiss); un set solitario per nastri ed effetti tra
muggiti distorti ed ectoplasmi. Trenta e venti minuti
rispettivamente e poi, appunto, ci becchiamo i capi
branco: momenti sbronzi e brutali assalti, cavalcate
percussive e così via. Poco resta dei brani degli Hair
Police. Di rumore rituale, sociale e religioso si tratta
ma restituito a mo d'immondizia in un ciclo perpetuo
senza direzioni né obbiettivi. Ogni promessa di catarsi
è dunque azzerata.
Se c'è una parte della della scena intenta a riesumare linguaggi (Black Dice, Giffoni, Emeralds, Sigh-
tings...) ce n'è un'altra che si ostina a distruggere.
Leonardo Amico
Dente/Franco Battiato/Vinicio
Capossela/Ginevra Di Marco/Morgan...
Premio Tenco 2009 Teatro Ariston (Imperia)
dal 12 Novembre 2009 al 14 Novembre 2009
Premio Tenco 2009. Trentaquattresima edizione tra conferme, consacrazioni e poche novità.
Assegnate due delle quattro targhe dell'anno scorso
a Baustelle e Le Luci della Centrale Elettrica,
e data così una spinta piuttosto decisa a quel ricambio generazione che per quanto riguarda la canzone
d'autore negli ultimi tre lustri non ha ancora trovato
nomi davvero di peso (se escludiamo Vinicio Capossela), il Premio Tenco di quest'anno propone
soprattutto consacrazioni e conferme.Targhe dunque
a Max Manfredi con Luna persa ed Enzo Avitabile con Napoletana, rispettivamente per il miglior
disco dell'anno in assoluto e in dialetto, e a Ginevra
Di Marco con Donna Ginevra per il miglior disco d'interprete, i quali confermano le cose buone
fatte su disco anche durante le esibizioni all'Ariston.
Deludono invece i vincitori della Targa per il miglior
esordio, ovvero i romani Elisir e il loro jazz-pop venato di francesità che guarda da lontano (molto da
lontano) la Piccola Orchestra Avion Travel e Paolo Conte. Di prime prove migliori del loro Pere e
cioccolato ne abbiamo sentite parecchie quest'anno,
e anche i nomi nuovi proposti dal Club Tenco non
hanno brillato di chissà quale luce. Bravi Piji (ancora
Conte, ma anche Natalino Otto e Sergio Caputo), Alessandro Mannarino (Vinicio Capossela,
Gabriella Ferri, Franco Califano e il talking folk
di Bar della Rabbia che si porta via tutti i presenti) e
un Dente che tanto nome nuovo non è ma per l'occasione veste con lo smoking le canzoni di L'amore
non è bello.
Poca roba gli altri, tra tentativi di patchanka elettrificata tipo Gogol Bordello ma con un decimo della
stessa energia (gli Ex, con membri di Mazapegul,
Daunbailò, Mau Mau e Luca Morino ospite alla
voce), bozzetti teatrali oppressi dall'emozione del palco (Momo) ed outsider presenti per la prima volta
in solitaria come Edgardo Moia Cellerino, ex Le
Masque Premio Siae, che strozza la classicità delle
sue canzoni in suoni di tastiera che quasi nemmeno
negli anni ottanta, o Franco Boggero e i suoi bozzetti ironico-amarognoli, divertenti e nulla più.
Quasi sempre positivi al contrario i giudizi sul resto dei
partecipanti - che non citeremo interamente per non
rendere questo pezzo un mero elenco - a partire dai
due Premi Tenco 2009 Franco Battiato e Angelique Kidjo. Il cantautore siciliano arriva trafelatissimo
e accompagnato dal pianoforte canta magnificamente
cinque canzoni con omaggio a Giuni Russo (L'addio), ripescaggio di un brano minore (Le sacre sinfonie
del tempo), duetto che tutti attendevano (su I treni di
Tozeur con Alice, alla quale è anche affidata la sigla
Lontano lontano), hit vecchie (La cura) e nuove (Inneres
auge, assai applaudita visti i mala tempora). Mentre la
cantante originaria del Benin anticipa qualche brano
dal nuovo disco Oyo di prossima uscita e sveglia il
sempre un po' assopito pubblico dell'Ariston con un
set vitale e forsennato nei ritmi. Ma gli applausi vanno anche al combat-folk rinvigorito da arrangiamenti all'altezza e canzoni piuttosto riuscite degli Yo Yo
Mundi e a un Vinicio Capossela che coi suoi suoni inconsistenti (theremin, cristallarmonio, autoharp)
pare aver (definitivamente?) trasferito la propria residenza artistica da Pomona ad un punto tra l'Arizona
e l'Ohio che pare più letterario che geografico, visto il
sentore Sherwood Anderson e Cormac McCarthy di
cui sono intrise le canzoni del recente Da solo. ;
Pollice verso invece per un Daniel Melingo perso
in troppe pose bohèmienne - ed è un peccato perché
il suo tango bagnato nello whisky di Tom Waits e
nei fantasmi di sega e banjo della provincia americana potrebbe dare esiti più fecondi; per un Morgan
ipertrofico in tv come sul palco - dove vuole suonare
qualsiasi strumento maltrattando il canto e non rendendo servizio ne a sé ne al pubblico ha di fronte; e
infine, prevedibilmente, per Vittorio De Scalzi con
il Gnu Quartet, tanto fuori tempo massimo (alla
fine arriva pure un revival New Trolls che ci starebbe se, appunto, l'atmosfera non fosse così nostalgica)
quanto ancora alla retorica un po' stucchevole di una
manciata di poesie inedite del poeta anarchico Riccardo Mannerini messe in musica.

Fatti così i conti, la trentaquattresima edizione del Tenco mostra un movimento cantautorale
che, come si diceva all'inizio, necessita di nomi tanto
pesanti da scalzarsi di dosso l'ombra dei soliti padri
putativi. Nel suo incessante ed essenziale lavoro di
promozione di tutto ciò che è canzone d'autore e
dintorni da qualche hanno la direzione del Club Tenco
sta tentando anche un rinnovamento che parta dai
nomi e arrivi ai linguaggi. Per riuscirci occorre continuare sulla strada intrapresa, magari calibrando un po'
di più il tiro, e soprattutto non demordere.
Luca Barachetti
recensioni
85
WE ARE DEMO
#42
I migliori demo giunti nelle nostre cassette postali. Assaggiati, soppesati, vagliati, giudicati
dai vostri devoluti redattori di S&A.Testo: Stefano Solventi, Fabrizio Zampighi.
Folktronicopera - Lucine intermittenti EP (Autoprodotto, Ottobre
2009)
G enere : folk blues
Alberto Mancinelli da Siracusa scrive, canta, suona la chitarra e porta
in giro un'anima da busker. In passato ha fatto rock soprattutto cogli
Electric Bayons (dal '93 al '96), per poi rimbalzare tra situazioni
diverse (Bayons, Noybas, Buffalo Flint & Barbecues...), ma dal 2004
è Folktronicopera, il suo progetto solista, quello che riassume tutto
nella dimensione cantautorale.
Questo EP è il terzo titolo sotto tale egida, quattro canzoni in italiano
a base di folk blues basale, ruvido, torvo ma generoso, appassionato
ma cinico, intenso e amaro, qualcosa che potresti immaginare a metà strada tra Cesare Basile e il
Bugo di Sentimento Westernato, con qualche aggancio plausibile al dimenticato Erz (soprattutto per la voce) e un santino del Bob Dylan beffardo sullo specchietto retrovisore. Credibile
dalla prima all'ultima nota.(7.1/10)
Stefano Solventi
tre il drumming ribatte prezioso e misurato assieme
(Giovanni Volpe dei Bisca). I testi in italiano se la
cavano piuttosto bene, stendono le vocali senza forzare, s'avvitano intriganti e sinuosi.
Insomma, parliamo di due pezzi originali ben messi,
segnali promettenti di una calligrafia che deve solo
trovare la giusta via tra fascino traditional e tremori
contemporanei (come ben fa Tutto si altera). Scegliere poi la buckleyana Morning Glory quale terza traccia, interpretata con grande sensibilità e sostanziale
mancanza di timore reverenziale, è il tassello che
completa l'opera. Bel lavoro.(6.8/10)
Stefano Solventi
Emblema - Mare senza isole
(Autoprodotto, Dicembre 2009)
G enere : rock - wave
Il rock che propongono gli Emblema dalla provincia di Forlì-Cesena è di quelli immediati, generalisti
e poco cerebrali. Una via di mezzo tra new wave,
distorsioni hard e una buona dialettica dei testi. Materiale che non impressiona per originalità - si parla
inevitabilmente di soluzioni musicali trite e ritrite
- ma che può vantare comunque un dignitoso livello qualitativo in mezzo a miriadi di produzioni
sul genere decisamente meno efficaci. Grazie a un
impianto musicale solido, qualche riff azzeccato e
in generale una formula godibile che riesce a unire
melodia e chitarre pungenti.(6/10)
Fabrizio Zampighi
(AM) - Soundtrack (Autoprodotto,
Novembre 2009)
G enere : foltronica ambient
Gli (AM), ovvero Alessandro Degli Angioli e Michele
Ducci mettono al centro del loro limpido discorso
musicale una folktronica stropicciata da glitch birbantelli e resa squillante da una verve dance-pop
che diresti senza indugio Royksopp. I Mùm quindi
sono il riferimento inevitabile di questo Soundtrack,
pubblicato in free download per la netlabel Musicaoltranza, ma non manca una certa inquietudine Radiohead stemperata da tentazioni melodiche che
diresti Notwist ma altresì capace di folate vocali
Sigur Ros (vedi ad esempio la bella Døra).
Altrove poi li colgono spasmi scabri come se da
fosse passato a trovarli zio Trent Reznor a tirare
qualche scapaccione (_ N novella_), il che amplia il
86
recensioni
ventaglio sonico/espressivo nonché le aspettative.
Perché se è vero che non ci si libera dalla sensazione del già udito, di un orizzonte oramai esplorato
ed esausto, i due dimostrano ottima padronanza di
mezzi e una invidiabile chiarezza d'intenti. Teniamoli
nella dovuta considerazione. (6.6/10)
Stefano Solventi
Dilis - Self Titled (Autoprodotto,
Novembre 2009)
G enere : folk
Pietro Di Lietro è Dilis. Il suo è un cantautorato sensibile ma con carattere. Folk onirico che stempera
inquietudini con una certa raffinatezza, cuce con la
chitarra (acustica ed elettrica) trame di percussioni,
flauto, contrabbasso (a cura di Ilaria Scarico degli ElGhor) e un canto capace d'insinuarsi sottile, men-
Gardening At Night - Act Surprised
EP (Autoprodotto, Ottobre 2009)
G enere : indie rock pop
Cinque ragazzi da Torino con le ascendenze ben
chiare e dichiarate, indie rock melodico come se ne
sentiva a bizzeffe nei nineties innamorati dei R.E.M.,
senza scordare ovviamente quanto fatto dalla band
di Athens fin dagli eigthies. Così, questi tre pezzi che
costituiscono l'Act Surprised EP ti rammentano un
po' i Counting Crows e un po' i The Blue Aeroplanes, rock chitarristico con la fiammella della
melodia sempre alta, irrequietezza pastosa ad altezza di post-adolescente, roba da college radio come
può esserti capitato d'immaginartene una, casomai.
Attitudine e calligrafia attagliatissime. Attendiamoli
sulla prova lunga.(6.4/10)
Leo - Hagakure (Autoprodotto,
Dicembre 2009)
G enere : cl as sica - ambient
Portare la musica da camera ai confini con l'ambient
e il progressive, in un disco di composizioni minimali
in cui si respirano marcette di synth e note di pianoforte, glockenspiel e strumenti classici. Incisioni su
incisioni che vanno a comporre un'opera gradevole
e per nulla invasiva, da cui emerge il background
accademico di Leonardo Barilaro quanto la sua
voglia di perdersi in intellettualismi alti da compositore “serio”.
Certo, le note in latino sul Myspace di riferimento
forse sono un po' troppo pretenziose e non depongono certo a favore di una personalità disposta a
diffondere la propria musica su più livelli.(6.4/10)
Fabrizio Zampighi
Mad Creudo - Dress The Reindeer
(Autoprodotto, Dicembre 2009)
G enere : psych - jazz - sperimentale
La qualità audio di questo terzo demotape dei Mad
Creudo fa a pugni con la buona creanza e a un
primo approccio non si è nemmeno troppo sicuri che i nostri abbiano ricevuto una qualche forma
di educazione musicale. Eppure viene naturale promuovere a pieni voti un'opera di destrutturazione,
sperimentazione e follia musicale come Dress The
Reindeer, coacervo di frammenti in bilico tra noise
e toni faceti, blues à la Captain Beefheart e psichedelia, rumorismi e jazz, Grateful Dead e stomp,
parti recitate e improvvisazione.
In realtà è sufficiente dare un'occhiata ai titoli dei
ventuno brani in scaletta (Anal Intrusion, La pastorella, Milingus) con uno sguardo un po' critico per
rendersi conto che i Nostri ci stanno prendendo
ampiamente per i fondelli. Nascondendo dietro a
una crew sgangherata musicisti preparati e ben consapevoli di dove si andrà a parare con certe scelte
stilistiche. Nello specifico, verso un non genere in
cui si incontrano surrealismo e coraggio espressivo.(7/10)
Fabrizio Zampighi
Stefano Solventi
recensioni
87
Ad
astra
“La facilità con cui si fanno dischi oggi non è cosa che
mi riguardi. Sono qui per spingermi oltre gli ostacoli e
ampliare la mente. Per andare oltre i confini a vedere
e accettare le sfide e imparare ciò che è necessario affinché io sia soddisfatto. Non me n’è mai importato del
successo: mi dedico con tutto me stesso all’arte e alla
vita, alla bellezza e al mistero del momento.”
P
Hans-Joachim
Roedelius
L'alchimista
Elettronica, house, idm o post-rock, Herr Roedelius di tutte
ha posto le fondamenta e di tutte respinge la paternità. La
classe e l'umiltà di un grande.
- Giancarlo Turra, Gianni Avella, Filippo Bordignon
88
rearview mirror
ensate alle cose più eccitanti dell’ultimo ventennio che esulino dal rock con evidenti radici country/blues ed eseguito avvalendosi del
relativo, tradizionale apparato sonoro. Lasciatevi
andare sotto pelle la vibrazione di house e techno
che, dal dancefloor, si prestano a un ascolto “critico”; assaporate la capacità di riscrivere le regole
appartenuta al post-rock e, infine, cullatevi nel senso di totalità che investe alcuni dei dischi migliori
apparsi negli ultimi due decenni. Da quando, cioè,
barriere e muri andarono giustamente a catafascio
e si era finalmente felici di ibridare e imbastardire
l’esistente in qualcosa di originale e nuovo. Per tornare, tra l’altro, allo spirito originale del “rock” (termine da intendersi nel senso più ampio possibile):
andare oltre col cervello spalancato e attraversare
un mare di splendide, elettrizzanti possibilità; fregarsene della banalità per vivere ininterrottamente sul
filo di un rasoio, stupiti un giorno sì e l’altro pure. Di
questo spiccato gusto per la scoperta, forte di una
creatività che sfrutta mezzi minimali e non ostenta roboante inutilità - la differenza tra krautrock e
progressive, insomma - i progetti cui Hans-Joachim
Roedelius (classe 1934 da Berlino) ha posto mano
nella sua pluridecennale carriera indagano ogni possibile risvolto.
Ha scoperto mondi inauditi e senza spocchia si
comporta da Maestro modesto, schiatta nobile che
rifiuta il piedestallo pur conscia del proprio ruolo;
che trova ragioni per la vita e l’Arte nel collaborare con chi è sulla medesima lunghezza d’onda, a
prescindere dal campo d’azione: “Credi davvero che i
Labradford o i Mouse On Mars siano davvero figli dei
Cluster? Che proseguano ciò che abbiamo fatto? Non
saprei dirlo con certezza e, fosse vero, non è che sto a
pensarci più di tanto. Ognuno impara dagli altri, siamo
tutti connessi in una sorta di network universale che
non ha bisogno di internet per funzionare.” Colui che
sa indicare vie nuove poi frequentatissime, lasciandosene trasportare fino a sparirvi dentro come
un ancestrale artefice di prodigi. Tutto questo fa di
Roedelius un autentico Genio di portata non igno-
rabile, anche se il tempo dei suoi capolavori è alle
spalle e la sua produzione eccessivamente copiosa:
ti rimane la certezza che possa consegnare ancora
un gran disco, attuale o fuori da ogni epoca mentre intuisce e assapora il respiro del presente. Non
potrà uscirsene con novelli Zuckerzeit o Cluster II,
ma del resto nemmeno i tempi sono più gli stessi
e va allora benissimo così: “Tutte le persone che ho
incontrato nella mia carriera hanno lasciato un segno;
artisti da ogni parte del mondo che ho avuto l’onore di
incontrare e coi quali ho percorso un tratto della mia
vita. Molti di loro sono diventati ottimi amici come Tim
Story e Alessandra Celletti, oppure Georg Taylor, Peter
Baumann, Conny Plank e moltissimi altri.”
Il segreto è, verosimilmente, di duplice natura: nel
saper scegliere le anime affini, certo, e innanzitutto
in un approccio alla materia sonora che è combinazione sapiente di assiduo studio e illuminata casualità. Un po’ come quel Brian Eno la cui strada
incrocerà spesso e volentieri, Roedelius ha saputo
porsi nei confronti dell’Arte da moderno umanista,
collocando l’anima al centro del suo agire, appoggiandosi a una curiosità robusta e sull’applicazione
indefessa - quella sì, rigidamente “teutonica” - alla/
della tecnologia.
Senza argomenti da comunicare, avrebbe fatto la
fine di chi è rimasto schiacciato dalle velleità, dal virtuosismo e dall’eccesso di mezzi. Ecco perché oggi i
suoi lavori “storici” sono freschissimi, come se avessero visto la luce la scorsa mattina o la settimana
ventura. Giocano con la nostra percezione cronologica perché se ne collocano al di fuori pur essendo
databili (che non significa datati…). E’ il pregio di
ogni musica innovativa con sentimento: “Non ricordo affatto quale fu il primo disco che acquistai. Sono
cresciuto col suono delle bombe e delle granate, c’era
poco da divertirsi! In ogni caso, mi piace la musica che
abbia rilevanza a prescindere dallo stile. All’epoca del
krautrock ero totalmente assorbito da ciò che facevo,
ma la vita stessa - con tutta la bellezza e il dolore - era
e rimane la principale ispirazione.”
Per
aspera
All’inizio c’erano i Kluster, devoti al nostrano
Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza e a Karlheinz Stockhausen. Un ensemble
progressivo ma radicale calato dentro un contesto - l’underground tedesco - che stranezze non
se ne fece mancare e che prese forma nel fatidico
’68. A Berlino, Conrad Schnitzler, allievo di Joseph Beyus, coinvolge Hans-Joachim Roedelius (già
rearview mirror
89
nella comune Human Being; alle spalle un passato
da attore fanciullo e militare disertore imprigionato
per due anni…) nello Zodiak Free Arts Lab, sorta di
Factory locale dedita a un’arte “libera” e multimediale. Palestra per Klaus Schulze e i Tangerine
Dream dello stesso Conrad, tra le tante cose, soliti
lanciarsi in tirate free-rock di sei ore mentre HansJoachim preferisce “essere consapevole di quanto
stavo facendo e apprezzare e utilizzare l’attrezzatura
tecnica a mia disposizione. Nessun approccio accademico, "solo" molta pratica con rumori, toni e suoni per imparare a utilizzarli e creare un mio linguaggio. Nessun
movimento artistico: solo curiosità, divertimento, senso
dell’avventura. Sia nella comune Human Being che allo
Zodiak sperimentavo come capire il perché sono qui e
a quale scopo.”
E’ in questo humus che il Nostro si imbatte in
Dieter Moebius, studente d’arte grafica svizzero
di dieci primavere più giovane, e nel 1970 - dopo che
i Tangerine Dream si sfaldano con Electronic Meditation e resuscitano - lo persuade con Schnitzler a formare appunto i Kluster. Faccenda incompromissoria
lontana da armonia, ritmo e melodia; che disturba e
rimane fuori da qualsiasi corrente coeva. Al punto
che si fatica a trovare un’etichetta finché non arriva
90
rearview mirror
la Schwann, specializzata in musiche sacre che impone la presenza di almeno una traccia per disco contenente liriche a sfondo religioso. Scappa da ridere,
se non fosse che nei due lp - già registrati con Conrad Plank: Klopfzeichen (1970; 7.5/10), Zwei-Osterei
(1971; 7.5/10) - non c’è nulla per cui sghignazzare:
voci che si accavallano e distorcono su rantoli percussivi; organi dissonanti ed echi minacciosi; i testi
sono salmodiati in uno straniante tedesco alimentando morbosità e apprensione. Ci trovate anche
chitarre, percussioni, violoncello e flauto, ma più di
tutto un senso del (dis)ordine - i Kraftwerk ancora Organisation un vago referente - che si spaccerà poi per nuovissimo chiamandolo “industrial”.
Può durare poco senza diventare parodia: nel ‘71 un
concerto a Gottinga conclude la vicenda.
E’ una morte necessaria, giacché la crisalide ospita la meravigliosa farfalla Cluster. Si cambia una
sola consonante e ciò nonostante la metamorfosi
è graduale benché netta, monitorata com’è dal solito Plank: “All’inizio era più o meno una versione musicale dell’Azionismo (tana per i Throbbing Gristle,
N.d.A.), e tutti coloro che erano coinvolti nei Kluster
sapevano che era il modo giusto di fare; finché non capimmo che quella "musica" non funzionava e idem il
lavoro con Schnitzler. Moebius e io avevamo maturato
convinzioni differenti su come agire e vivere, pertanto
sciogliemmo i Kluster per provare da soli. Come ben sai,
le cose funzionarono”.
Occorreranno ventiquattro mesi per carburare
tramite due lp non facili, eredità di transizione benché di vaglia. Dapprima la creatura è ancorata ancora un pò al recente passato, e lo chiarisce un primo
omonimo edito dalla Philips nel ’71 (7.3/10) colmo di
gassosità ambientali, involucri fantasmatici e nervosi
che levitano all’ora di chiusura dalle fabbriche della
Ruhr verso lo spazio profondo. Come farsi ingoiare da un buco nero, volontariamente. Spetta al successore 2 (Brain, 1972; 7,8/10) restituire un’ancor
più attenta, livida riflessione sulla Germania in bilico
tra passato drammatico e scintillio dell’industrializzazione. Di renderla metafora dell’occidente prossimo venturo nella sua totalità, teatro di vendette
perpetrate dalle divine e progressive sorti e un’indesiderata eredità da scontare come si può, più in
fretta che si può. Martin Rev e Alan Vega, frattanto, esplorano inconsapevolmente le stesse minacce
latenti, rispondono alle crisi interiori ed esteriori
che esploderanno nel ’77. L’estetica urbana e grigio
fumo del dopo punk risiede in massima parte qui,
sappiatelo.
Torniamo ora al cuore color pece dei Settanta:
occorre una svolta dopo aver sviscerato un canone,
di nuovo tramite una coppia di vinili. Provvidenziale
per la “sterzata” Harmonia di tre anni più tardi
l’entrata in scena di Michael Rother, in momentaneo sabbatico dai Neu!: “Ogni cosa nei Cluster e
nel nostro lavoro accadeva in maniera accidentale. Così
poteva trovare il proprio momento di fiorire e poi morire.” Ci piace tuttavia sottolineare anche una motivazione psico-geografica: dalla città il trio si sposta in
una fattoria riconvertita a studio nella rurale Forst,
sulle rive del fiume Weser. Zona di foreste e primordiali vedute, di paesaggi che piegano l’anelito di
fuga cosmica dall’urbano in un’elettronica bucolica.
La terra riconsegna musica e relativi artefici a una
dimensione umana: “Rother fu importante, ma è stata
più la vita rurale di Forst a cambiare le cose. La bellezza
di quella parte della Germania, le vecchie case costruite
tre secoli fa, il giardinaggio e la raccolta di frutta selvatica; cucinare e faticare per sopravvivere.”
Paesaggi che appaiono sulla copertina di Sowiesoso, parto numero due della nuova vita, essendo
il primo il quantico Zuckerzeit (Brain, 1974; 9,0/10)
così abbagliante di melodico vignettismo; sorridente
e contorto a seconda di chi componga (rispettiva-
mente: Roedelius e Moebius) e in ogni caso in anticipo sull’elettronica ambientale e la trance. Melodie
stralunate dai riflessi giocosi (illuminante il titolo: il
tempo dello zucchero), tastiere caramellose e drum
machine primitive che paiono incartarsi allorché
inventano la sognante nostalgia - da Vhs scolorita
e stridente - dei Boards Of Canada. Roba per
sonorizzare cortometraggi della mente o fungere
da commento ai primi esperimenti della tv a colori,
inoltre, e non a caso gli Young Marble Giants del
Testcard E.P. e gli Stereolab serbano gratitudine.
Non se ne stanno con le mani in mano, i tre:
intraprendono un tour e decidono di registrare un
nuovo lavoro cambiando ragione sociale. Immutata
la grandezza, la forma segue vie più ritmate e altrettanto importanti mediando l’esperienza Neu!. Musik
Von Harmonia (Brain, 1974; 8,0/10) viene spinto con
adeguato battage pubblicitario dalla casa discografica e vale l’impegno, segnalando il chitarrismo minimale e la pulsione “motorik” rotheriane; assemblato
con pazienza su un paio di registratori a bobine, è
traslucida magia di pop futurista e cavalcate sospese, sensazionali presentimenti di misterica techno
nel nucleo di attuali ossessioni: musica umanissima
prodotta con macchine e pazienza da artigiani entusiasti e perciò pulsante, mistica: “Harmonia fu sostanzialmente la via d’uscita di Michael Rother dai Neu!,
che non riusciva più a lavorare con Klaus Dinger; desiderava rivitalizzare lo stile dei Neu!, almeno il “tiro” e la
bellezza melodica. Andò bene per un po’, poiché come
Cluster eravamo dissimili e non potevamo andare avanti
all’infinito con la sua idea.” Bellezza che fa il paio col
seguito Deluxe (Brain, 1975; 7,5/10), mentre qualcuno ha preso nota e imboccato una favolosa carriera
con non pochi parallelismi. Ci arriviamo tra poche
righe, magnificando prima gli emozionanti acquerelli
Cluster di Sowiesoso (Brain, 1976; 7,5/10) che - paradosso ma mica tanto - sanciscono l’archiviazione
del progetto Harmonia.
Ora di accogliere il discepolo Brian Eno e, come
spesso accade tra illuminati, inscenare un vantaggioso, duplice scambio. L’ex Roxy Music palesa l’influenza di Zuckerzeit in Another Green World e conseguenza ne è che si rechi in pellegrinaggio a Forst. Il
rapporto di reciproca stima evolve nella composizione spontanea di numerosi brani e nelle posteriori collaborazioni: “Incontrare Brian fu un avvenimento
grandioso e lo stesso lavorare con lui a tutti quegli album. Suonammo e registrammo assieme ciò che finì sui
nostri lp, poi ci chiese il favore di mettere By This River
su Before And After Science. Di certo era influenzato da
rearview mirror
91
noi anche quando era nei Roxy Music e con le cose che
pubblicò dopo con Robert Fripp e da solo. Collaborare fu divertente: eravamo interessati alle sue cose, non
intendevamo sottomettere il suo stile.”
Comprova ulteriormente il valore dell’operato il
fatto che i vinili siano stati ristampati svariate volte
in digitale e recentissimamente dalla Bureau-b. Il sublime Cluster & Eno (Sky, 1977; 8,0/10) è l’iniziazione che figlierà la controversa - non per noi - “musica per film e aeroporti”: produce Plank con ospiti
di riguardo Holger Czukay e Asmus Tietchens.
Il lavoro si racconta gemma che dai prati punta il
cielo prima e il cosmo poi come il microfono in
copertina; sintesi iridescente di tecnologia minimale
e minuetti riflessivi, di intuizioni orientaleggianti ed
estatici volteggi. Malinconico col sorriso, spiana la via
a generazioni di trafficanti di elettronica e rimembranze da cameretta, stendendosi idillico ponte sul
successore After The Heat (Sky, 1977; 7,4/10) figlio
delle stesse session. Bizzarramente, trattasi di cosa
diversa come si intuisce dall’intestazione - figurano
i soli cognomi - e dallo stile, ritmicamente più folto
e ricco di “groove”. Sorta di funk bianco surrealista
anche se fosco, annebbiato e propenso a interpretare le radici terzomondiste con l’ansia che talvolta
percorre il coevo Before After And Science , disperde
92
rearview mirror
David Bowie negli strumentali di Low e “Heroes” inconcepibili senza... - ed è pronta a oltrepassare
l’Atlantico verso i Talking Heads. Le strade infatti
si dividono: Moebius/Roedelius proseguono come
Cluster a stemperare la grandezza in eccellente mestiere, laddove l’indaffarato “non musicista” non ha
più un minuto libero.
Resta da citare il recente recupero Tracks And
Traces (Gronland, 2009; 7,5/10) che simbolizza un
anello mancante nella narrazione. Per l’occasione
battezzatisi Harmonia '76, i ranghi imprimono
su nastro materiali destinati a vicende piuttosto
complesse: pubblicati una prima volta nel ‘97, sono
ritirati dal mercato su pressione di Rother; i master andranno smarriti e successivamente ritrovati.
Brian, da par suo, ebbe a definire Harmonia come
la band più importate del momento e parteciparvi
fu motivo d’orgoglio e ginnastica spirituale. Al supergruppo kraut per antonomasia si aggiunse un
illuminato dell’art rock anglosassone e i risultati
non potevano essere trascurabili. Vicini per forza di
cose al luccichio di Musik Von Harmonia, al sapore
melodico di Rother e dell’Eno di lì a venire, a verve
ipnotica e oasi liquide che, sommate, danno classe
immacolata e rilevanza storica confermata. Da qui
si plana in parallelo con lo spegnersi della stagione
krauta dentro la progenie new wave e il colpo di
coda Rastakrautpasta (Sky, 1980; 7,8/10), pregevole
assurdità a firma del solo Moebius (in combutta con
Plank...) che cela apocrifi Suicide, giostre dub sinistri e ironia finto-etnologica. Meglio dei conclusivi
capitoli clusteriani, benché validissimi e non oltrepassati dal presente, essendo semmai quest’ultimo
a essere stato forgiato dal duo. Apprezzabili sono il
riepilogare in classicheggiante serenità e nervosismi
occasionali di Grosses Wasser (Sky, 1979; 7,2/10) e il
più ansiogeno Curiosum (Sky, 1981; 7,2/10), storto
di un'elettronica a "fedeltà domestica" che per moltitudini - la Sheffield di allora e la posteriore Warp,
per dire - varranno più della stele di Rosetta.
A ge
of changes
Prolifico fino allo sfiancamento l’Hans Joachim Roedelius da qui in poi, solista che sconfina nel solipsismo e, in tal modo, indica la necessità di avere
a fianco qualcuno in cui specchiarsi creativamente.
Trentasei fatiche in proprio - cui s’aggiungono quella
quindicina tra collaborazioni e progetti vari… - disegnano una discografia intricata e dispersiva dell’innegabile talento. Perché a questi ritmi sbracherebbe
chiunque occorre intervenire di setaccio e separare
il grano dal loglio, e in ragione di ciò abbiamo deciso
di offrirvi un orientamento il più possibile esaustivo
che risparmi confusione ed emicranie. Il Nostro comincia alla pari di Moebius nel 1978: si abbandona
però quasi del tutto la gloria passata mentre l’ex socio ne riprenderà diverse caratteristiche. Peculiari e
non in positivo Durch Die Wüste e Jardin Au Fou, che
il tedesco licenzia nel biennio susseguente in pagine
didascaliche e rimasugli prog accesi da fiochi bagliori.
Non lasciano segni rilevanti e sarebbe stato opportuno del riposo per un Genio prossimo alla cinquantina. Fa così storia a sé il progetto Selbstportraits,
tre volumi dal 1979 al 1980 che mettono in scena un
guardarsi indietro edulcorando outtakes dei Cluster
con un’ambient a base di piano e synth nel frattempo divenuta maniera.
Professionalità e rigore senza colpo ferire anche
nell’accademia in scia a Brian e Harold Budd (Lustwandel e Wenn Der Südwind Weht, 1981; Flieg' Vogel Flieg', Wasser Im Wind e Offene Türen, 1982) che
lambisce la tappezzeria col passaggio discografico
alla Venture. Il lascito migliore di questa fase disordinata appartiene però all'ex compagno di cordata
Moebius ed è il sorprendente Zero Set (Sky, 1983;
7,6/10), di freschissima riedizione su Bureau b e
complottato a sei mani con l’ubiquo Plank e il batterista dei Guru Guru, Mani Neumeier. Rinfrescante figura, costui, che macina poliritmi math-rock
in possenti composizioni che qui i Battles e là citano i King Crimson e Remain In Light. Serve forse a smuovere qualcosa, essendo dodici mesi dopo
un (minore) acuto Geschenk des Augenblicks, archi
e atmosfere severe ma all’occorrenza delicate che
segnalano ritrovata verve avanguardista. Parrebbe la
via giusta, sennonché il berlinese devia affidandosi a
minuscole label e sentieri laterali di jazz applicato a
beat techno. Bastionen Der Liebe guadagna irruento il
confine tra jazz-rock e fusion postmoderna, mentre
nel ‘94 Theatreworks riprende le sedute con Harmonia ed Eno e campioni da ogni dove per un pregiato avant jazz e una suggestiva neocontemporanea.
Lieder Vom Steinfeld e Sinfonia Contempora sono
i progetti allestiti poco dopo, il secondo rivelatorio
per esito e metodologia: ancora vecchi nastri, però
spezzati e sfasati in un straniante armonia.
Resta a lungo l’ultima cosa rilevante fino al nuovo millennio dove - a un’età in cui tanti hanno tirato i remi in barca o non sono più tra noi - Hans
Joachim allestisce nuove collaborazioni curiose per
quanto in sostanza pletoriche. Eccezione incarnata
da Inlandish con Tim Story (Gronland Records,
2008; 7,3/10), equilibrato saggio di cinematismi alla
Erik Satie, parentesi cosmiche regalate dal passato
illustre e strizzate d’occhio ad Alva Noto. Nondimeno: il passato è difficile scacciarlo e si accovaccia
dietro l’angolo, lo si voglia o meno è lì pronto abalzarti addosso. Lungo la ridda di cui sopra i Cluster
si riformano e, nel 1990, Apropos guarda alla stessa
avant-techno di Grosses Wasser nel frattempo divenuta “hype” del giorno. Così come accade alla riscoperta del rock krauto di lì a qualche anno, che
cagiona due tour dei Cluster che toccano Stati Uniti
e Giappone e sfoggiano un suono non fossilizzato.
Lo ribadisce un disco affatto male - conscio del percorso fatto sin qui benché non passatista - come
Qua (Nepenthe Music, 2009; 7,1/10): “Decidemmo di
ripartire dopo parecchio tempo perché, in realtà, come
Cluster non ci eravamo mai sciolti. Avevamo bisogno di
rendercene conto, perché esiste una sorta di motivazione psico-dinamica tra noi dopo tutti questi anni. Non c’è
gran differenza tra i Cluster del 2009 e quelli dei Settanta: operiamo nella stessa maniera e non c’è dubbio
che le nostre carriere soliste e le esperienze personali
influiscano su di noi.”
Da cosa nasce cosa, e anche gli Harmonia tornano in pista per un breve momento, lasciando alla
fine l’amaro in bocca: “E’ stato bello tornare assieme
ma, dal momento che siamo finiti a rimasticare lo stesso
vecchio materiale, ho preso interesse e mi sono chiamato fuori. Cluster sono imprevedibilità, sperimentazione e
avventura, cambiare strutture e umori.“ Filosofia antica
e trionfante che sorregge Roedelius fin dagli albori
e oggi gli permette, andando tranquillo incontro al
proprio tramonto, di chiudere il cerchio senza dormire sugli allori. In un mondo dove chi pubblica anche
un unico e mediocre disco sproloquia da emissario
del divino, ne porti in palma di mano la lucidità: “L’attitudine non è mutata. La tecnologia oggi permette un
miglior approccio sia dal vivo che in studio; del mercato
non ci importa granché, la musica che facciamo si crea
da sé un pubblico. Probabilmente molti artisti oggi sono
“bloccati” ma potrebbe non essere colpa loro. Il business
crea le proprie necessità, che siano o meno rilevanti per
la consapevolezza di ciò che è giusto o sbagliato.
Ci sono sempre state persone alle prese con un’arte che tocca spirito e cuore altrui, aiutando a cambiare
mentalità. La cosa più complicata rimane rispondere a
domande come ‘chi sono’ e ‘cosa faccio ‘qui’.“ Vecchio
saggio, Hans Joachim, ha creato anni fa non poco del
qui e ora con la quieta modestia e la visione cristallina dei Grandi. Sua la nostra riconoscenza, da qui
all’eternità.
rearview mirror
93
Ristampe
AA.VV. - 15 Years Of Metalheadz
(Metalheadz, Novembre 2009)
G enere : D rum ' n 'B as s
Assieme a Reinforced, Metalheadz è l'etichetta
drum'n'bass per eccellenza, la label per la quale bisognava aver inciso almeno un 7’’ per esserne considerato un vero e riconosciuto protagonista.
Fondata dal famigerato Goldie, Storm e la compianta Kemistry, la label festeggia un anniversario che
non è di certo il primo, senz'altro però va sottolineato il tentativo della compila di restituire un’essenza
pulsante al figlio vip dell’ardkore e della Jungle. La
tracklist spara i colpi migliori grazie alle produzioni del periodo d’oro (il 1995-1997), sorvolando il
biennio buio (1998-2000) e contenendo abilmente
le complicazioni dei sottogeneri (la techstep portentosa di Doc Scott in Swarm e quella ancora più
mefitica di Adam F in Metropolis) si porta in zona
contemporanea. Ci troviamo le produzioni recenti,
tutte peraltro impregnate di ricordi balearici e
qualche rovescio belga.
Sulla medesima linea
estiva, la conclusiva Be
True datata 2007; al mix
i Commix, maestri da
sempre e questa volta
in taglio minimalista di
scuola Laurie Anderson.
Attenzione alla Metalheadz night a Roma il 19 dicembre. Ci saranno i fondatori e tanti altri al Alpheus Multiclub. Grandi assenti della compila: Ed
Rush & Optical.(7/10)
Edoardo Bridda
94
rearview mirror
AA. VV. - Zevolution Ze Records
Re-Edited (Strut Records, Ottobre
2009)
G enere : mutant disco
Proseguendo le celebrazioni per il trentesimo compleanno della ZE, la Strut si spinge un passo oltre
in una collaborazione che, alla luce dei risultati, ci
auspichiamo più duratura che mai. Intrigante e riuscitissima infatti l’idea di
radunare brani del catalogo in versioni proposte
da alcuni dj. Un progetto
che, in verità, prendeva le
mosse già nel 2004 con
un 12” dove Optimo
rifaceva nientemeno che
Contort Yourself: da leccarsi i baffi in prospettiva, se non che la prematura
scomparsa della povera Lizzy Mercier Descloux
imponeva una pausa di riflessione. Altre le necessità
dell’esistenza, così che la faccenda veniva accantonata.
Frattanto l’interesse attorno all’etichetta newyorchese e alla sua estetica cresceva, diventava oggetto
di tributi per l’attualissima miscela di post-punk e
tentazioni danzanti, groove taglienti e obliqua solarità pop. Come trasportare il dancefloor in mezzo
ai vicoli della Big Apple prima che gli Yuppies s’impadronissero del Village, laddove a condurre in porto
la medesima operazione ci pensava frattanto Arthur Russell. Tra gli attestati di stima figuravano
anche gli “edit” da ballo che andavano accumulandosi, sovente dando corpo a veri classici. Ne sfilano
qui una dozzina e la festa è grande, con recuperi e
novità commissionate per l’occasione che si con-
fondono ed è complimento dei più alti.
Nella scaletta - compatta e scorrevole nonostante la durata; disintossicante per muscoli e meningi - spiccano la On A Day Like Today di Gichy Dan
(con quel famigerato loop di “la la” fanciulleschi che
Todd Terje rende ancor più irresistibile) e Felix
Dickinson che si lavora di gorgogli e pialla gli Aural Exciters (Spooks In Space), una devastante ricongiunzione a firma Richard Sen delle due Almost
Black (così che James White risulta tutt’uno di
No Wave e Mutant Disco) e i Material con Nona
Hendryx che stracciano di lame rock il “post soul”
Bustin’ Out. Tanto per dire, perché sarebbe insensato
accantonare la favola disco-pop in creme d’archi Encore L’Amore (bellezza eterna griffata Garcons che,
“trattata” da Leo Zero, spazza via tutte le simili
nullità attuali) o il guasconeggiare da balera tropicale
marca Kid Creole (addirittura due i brani, e ottimi:
la take Idjut Boys su I’m Corrupt e Soul Mekanik
che si occupa di Annie, I’m Not Your Daddy).
Uscita da possedere assolutamente per almeno due
ordini di motivi: la classe elevata della musica e la
clamorosa modernità di quest’ultima. Non si può
dire lo stesso di ogni suono che fu innovativo alla
sua prima apparizione.(7.7/10)
Giancarlo Turra
AA. VV. - In The Christmas Groove
(Strut Records, Novembre 2009)
G enere : soul nuggets
Ci vuole un bel po’ di cinismo e un cuore di pietra per affermare che le dodici rarità raggruppate
qui dalla Strut sono robetta per curiosi e nulla più.
Oppure bisogna ignorare che l’era aurea della black
nutriva un amore costante - spesso ironico e divertito: è esattamente lo spirito adeguato - a materiali
ispirati e/o dedicati alle feste di fine anno. Il fatto
è che non puoi non ridere di gusto ascoltando gli
Electric Jungle sciorinare Funky Funky Christmas
tra voci alla Funkadelic e sax fumigante, oppure
la Soul Santa dei Funk Machine quintessenza di
Curtis Mayfield addomesticato, dire no a Milly &
Silly quando ti invitano col wah-wah a un’improbabile Getting Down For Xmas. Che nessuno sia meno
di un patrimonio per intenditori - eccezion fatta per
Jimmy Reed, che sparge vischio sul blues e se la
cava pure… - ci sta a pennello, giacché il punto non
è chi ma come.
Ovvero l’attitudine di gioiosa noncuranza che spingeva questi artigiani a piazzare cose del genere sui
retri dei singoli facendola franca cavandoci un sorri-
so e talvolta qualcosa in più. Bisogna proprio essere
dei barbogi tediosi per non apprezzare i ragazzini
dell’Harlem Children’s Chorus (affatto scontata
Black Christmas, idem il suo “messaggio”) e la dissennata Bogaloo Santa Claus (!) di J.D. McDonald, una
sensuosa Let’s Get It Together This Christmas (Harley
Averne Band) e il classico Auld Lang Syne affrontato con piglio vibrante dai Black On White Affair.
Non vi cambieranno la vita, nondimeno il buonumore è garantito. Dopo tutto è Natale, no?(6.8/10)
Giancarlo Turra
Claw Hammer - Live In Texas 1995
(Munster, Novembre 2009)
G enere : P unk B lues
I losangelini Claw Hammer catturati all'altezza
della loro svolta major, dopo anni di praticantato
indie. L'anno è il 1995, quello dell'album Thank The
Holder Uppers (Atlantic), e davvero un solo rammarico si può esprimere, una volta finito di ascoltare
e riascoltare questo live: peccato non esserci stati quella sera in Texas.
Peccato perché la band
di Christopher Bagarozzi (chitarra), Jon Wahl
(voce) e Robert Walther
(basso) dal vivo spaccava.
Anzi: spacca ancora in
questo disco. Come in
Moonlight On Vermont, con
quell'armonica a bocca per intermezzo, lo stomping
fatale e blusey, la voce di Wahl che richiama tutti, ma
in fondo nessuno.
Un po' Axel Rose, un po' Capitano Cuor di Bue,
un po' un adolescente strafatto. E un po' nessuno
proprio. E non mancano qui i 'classici' della band
riproposti: Succotash (da Ramwhale, SFTRI, 1992) o
ancora Malthusian Blues e William Tell (da quel capolavoro che ha nome Pablum, Epitaph, 1993). E
poi l'omaggio agli eroi assoluti di questo folle combo: i Devo. Una cover dal loro capolavoro: una Uncontrollable Urge che tira da matti, perfetta!, e che ci
ricorda che questo è proprio il gruppo che omaggiò
i prime movers di Akron coverizzandone per intero
il primo disco a 33 giri. Peccato manchino all'appello
piccole gemme, come il lato a sul loro terzo 7", datato 1989: Candle Opera, quella dove forse emerge
con più compiutezza un'altra bizzarra influenza del
gruppo, specie per il cantato di Wahl, ossia i Guns
N' Roses.(8/10)
Massimo Padalino
rearview mirror
95
Emil Viklický - The Funky Way Of
(Vampisoul, Novembre 2009)
G enere : jazz funk
Sembra che non sappia più dove sbattere la testa in
cerca di originalità da ristampare, il capoccia della
Vampisoul Inigo Muster. In chiusura di un fiacco
2009 punta i riflettori oltrecortina, su quella Cecoslovacchia che fu più rapida a recepire i mutamenti socioculturali degli anni Sessanta nonostante
la repressione. Questo il contesto in cui lavorava
Emil Viklický, tastierista jazz colà tra i più rinomati e
oggetto di questa retrospettiva relativa al periodo
1975-1987. Tutt’ora attivo, nasce nel 1948 e inizia la
carriera professionistica a ventisei anni con il jazzrock degli Energit incappando subito nella censura
di regime; la cosa non gli impedisce di figurare poi
nei affini SHQ, dirigere una propria “big band” e
accompagnare la cantante Eva Svobodová.
Lungo i ’70 si cimenta con jazz latino e mescolato
alla tradizione morava, con folk-rock e new thing.
Durante la borsa di studio annuale al prestigioso
Berklee College Of Music di Boston, stringe amicizia con un giovane Bill Frisell e Vinnie Johnson
e incide con costoro un lp in patria nel ‘78. In base a
siffatto curriculum ci s’aspetterebbero cose ottime
e invece nisba: l’ascolto restituisce la buona tecnica
di un compositore devoto - parziale eccezione il
passabile materiale con Frisell - a una fusion talora
screziata di funk scolastica, quando non a un jazz
più tradizionale de medesimo livello. Spiace, giacché
non era facile suonare dalle sue parti all’epoca, ma
non si va oltre la mera curiosità.Vampisoul, svegliati
prima che sia troppo tardi…(6/10)
Giancarlo Turra
Julian Cope - Peggy Suicide (Deluxe
Edition) (Universal, Ottobre 2009)
G enere : psych - funk - rock
Cope l'aspirante pop-star (Beautiful Love), Cope il
santone del folk lisergico (Pristeen), Cope l'autore di ballate crepuscolari (Promised Land), Cope il
bluesman tamarro e in acido (Safesurfer), Cope il
Velvet Underground mancato (Drive She Said),
Cope il Morphine inglese (You...), Cope il rocker
pantaloni in pelle e stivali (Hanging Out And Hang Up
On The Line) ma soprattutto Cope e il funk. Peggy
Suicide ne è impregnato fino al midollo, in brani
come East Easy Rider (ortodosso), If You Loved Me
At All (minimale), Soldier Blue (tribale), Not Raving But
Drawning (psichedelico) e chi più ne ha più ne metta.
Una boccata d'ossigeno che arriva dopo un tritti96
rearview mirror
co di dischi per lo meno discutibile, costituito dallo
scialbo My Nation Underground, dall'acustico Skellington e dal dispersivo Droolian. In un momento in cui
l'ex Teardrop Explodes ha decisamente bisogno di
ritrovarsi.
Peggy Suicide è l'opera giusta, un buon viatico per i
novanta appena cominciati e un modo per rimettere a posto le idee. Diciotto brani in cui il Nostro
recupera la vena creativa messa in mostra fin dagli esordi di World Shut Your Mouth e Fried cedendo
all'inventiva, lasciandosi trasportare da un mix di follia incontrollata e abuso
di droghe, mescolando
generi e appartenenze.
Ne nasce un concept sul
rapporto uomo-natura
(ma non solo) dai risvolti sorprendenti, un disco
che certo non raggiunge
le vette dei primi due
episodi solisti ma ribadisce comunque la statura artistica di un musicista
enciclopedico e perso nelle sue elucubrazioni.
Nella ristampa deluxe uscita a ottobre trovate il cd
originale più un secondo cd che raccoglie singoli, remixes, e b-sides: materiale che, a essere sinceri, poco
aggiunge all'economia del disco originale.(7.3/10)
Fabrizio Zampighi
Marta Kubišová - NE! The Soul
Of Marta Kubišová (Vampisoul,
Dicembre 2009)
G enere : sciantosa d ' oltrecortina
Si possono estendere anche a questo cd le considerazioni sulla raccolta di Emil Viklický pubblicata in
contemporanea da Vampisoul, col distinguo di una
caratura qui leggermente superiore. Simili consto
e vicende: Marta Kubišová era alla fine dei
Sessanta la cantante più popolare della Cecoslovacchia, all’epoca in cui la contestazione fu schiacciata
sotto i carri armati sovietici. Viene dunque spontaneo essere indulgenti con chi fu bandita per venti
anni, benché la ragazza possedesse una voce niente
male: profonda e versatile, indecisa tra pop irrobustito di negritudine e tentazioni più sperimentali alla
Grace Slick. Questi gli estremi di brani estratti
dagli archivi della Supraphon e risalenti al periodo
’66-’70, quando l’artista calcava professionalmente
le scene da tre anni dopo la gavetta in provincia.
La svolta fu seguire il pigmalione/produttore Bohuslav Ondrácek a Praga e diventare attrazione fissa
highlight
Nirvana - Bleach Deluxe Edition (Sub Pop, Novembre 2009)
G enere : grunge primigenio
Sembra ieri e invece sono passati vent’anni. Non si stenta a crederlo, dato che di acqua (leggi
mp3) ne è passata eccome sotto i ponti (della circolazione musicale), ma fa pur sempre un certo
effetto, soprattutto se quell’uscita - a posteriori fondamentale - la si è vissuta in diretta.
Non è però solo una questione anagrafica; a suscitare impressione è l’attualità di un disco partorito in garage da quattro drop out di provincia ma cresciuto alla distanza nella considerazione dei
fan fino a divenire il trademark dei Nirvana primigeni: quelli cupi, grezzi, ruvidi, straccioni… In
una parola - che all’epoca aveva eccome ancora un senso - underground.
Non che le cose sarebbero poi cambiate col successo post-Nevermind, col corollario di intrinseca
irrequietezza e angosciosa inadeguatezza culminato in quello che ormai è storia del rock (e del
gossip), ma si sa, la pepita “nascosta” è sempre quella che agli occhi dei fan più accaniti, quelli della
prima ora, brilla di più. Perchè riascoltare il grezzume del riffone d'attacco di School, lo stomp
melvinsiniano di Paper Cuts, l'aggro-punk in stop'n'go di Negative Creep, il boogie scavezzacollo di
Mr. Moustache è sempre un tuffo al cuore oltre che l'apertura di nuovi
mondi per il rock underground a venire.
L’occasione è quella giusta. Così il ventennale dell’uscita viene celebrato dalla Sub Pop, per mano dell’allora ingegnere del suono Jack Endino, con la riproposizione in versione rimasterizzata di quella pietra
miliare: doppio vinile bianco da 180gr, arricchito da un live del 1990,
catturato al Pine Streets Theatre di Portland, e da un booklet che è
gioia per gli occhi. E se il live - già circolato sotto forma di bootleg
- permette di comprendere la vena aggressiva e incompromissoria
dell’allora quartetto e l’accluso booklet di 16 pagine (52 nell’edizione in cd) mostra foto d’epoca
praticamente inedite, a fare la differenza restano sempre quelle 11 tracce del vinile originario.
Pezzi apparentemente semplici che segnano, però, la grandezza di un gruppo (e di un artista) da
cucciolo, quando suonare dentro le quattro mura scalcinate di un garage era l’unica vera via per
incanalare una rabbia e una sensibilità troppo diverse e difficile da comprendere per l’ambiente
da boscaioli in cui Cobain e soci erano cresciuti.
Non lo spartiacque che fu Nevermind, con tutto quello che significò per l’emersione di suoni
destinati ad un pubblico sempre crescente, insomma. Ma pur sempre un disco capolavoro che
mischia asperità e poesia, melodia e rumore, mostrando il lato ferino e genuino di quello che
sarebbe poi divenuto il crack più clamoroso della storia del rock.(8/10)
Stefano Pifferi
del teatro Rokoko, fondare i Golden Kids (degli
Os Mutantes assai meno geniali…) e, nel ’68, conferire lineamenti più ruvidi a un leggero beat-pop
orchestrale venato soul.
Il meglio lo offrono i brani autografi: Tak Dej Se… e
Svlikam Lasku sono i Jefferson Airplane in chiave
errebì, l’ottima Tajga Blues ’69 sta tra Lee Hazlewood e uno Scott Walker femmineo e terreno; le
strutture della sensuosa Legendy e della tesa Jakoby
Nic sfuggono la banalità. Quando l’Armata Rossa
irrompe le luci si spengono: senza paura, Marta se-
guita a sostenere il dissenso, figura popolarissima
però scomoda cui è proibito esibirsi.Trascorre i due
decenni successivi a fare la mamma e il portavoce
del movimento Carta 77 con l’amico Václav Havel.
Caduto il regime, raccoglie infine il plauso dei compatrioti. Un talento non disprezzabile il suo, in fin
dei conti, benché la cosa più eclatante regalataci da
quel paese in ambito rock seguitino a essere i Plastic People Of The Universe.(6.8/10)
Giancarlo Turra
rearview mirror
97
Peanut Butter Wolf - 45 Live:
Classic Rap 45s (Stones Throw,
Settembre 2009)
G enere : H ip H op old skool meraviglia
Chris Manak - bianco di San Diego, capelli rossicci, smunto, orbite scavate - è Peanut Butter
Wolf (PBW), il fondatore e il capo della Stones
Throw, l'uomo di Madlib
e J Dilla (citiamo giusto
i due che sono già classici). E' un nerd del vinile
(ti pareva), un maniaco
degli anni Ottanta (soprattutto del funk Ottanta; Dam-Funk mica
per caso sta alla ST), un
cultore della old skool rap. Ecco allora questo box
di latta stile biscotti della nonna - artigianale e bellissimo come i migliori manufatti ST - con dentro
dieci 45 giri: 18 classici hip hop editati da PBW (mai
usciti prima in questo formato) e due sue produzioni preistoriche, 14 anni all'anagrafe (non incluse
però nel promo, che è in formato cd mix).
E' la musica perfetta per muovere il sedere ad un
party indie che sia davvero indie, tutta sulla solarità
delle basi - coi piedi piantati nel funk e un occhio al
mondo dance - e dei rappati flowiali: "O-o-o-o-Old
Skool". I nomi più noti sono veri pezzi di storia HH:
T La Rock, Big Daddy Kane, Mantronix, Jungle
Brothers, Boogie Down Productions. Andatevi
a recuperare l'unico vero album prodotto finora da
PBW, My Vinyl Weighs A Ton (1999).(7.1/10)
Gabriele Marino
Rastafarians (The) - Orthodox
(Makasound, Novembre 2009)
G enere : roots reggae
Una vicenda che lascia di stucco: i Rastafarians
erano un sestetto dedito alla piena devozione verso indovinate un po’ quale credo. Fin qui nulla di
straordinario, non fosse che - in luogo di Kingston
- erano domiciliati a Santa Cruz, California. Mica finita: stando alle dicerie, pare avessero occupato con
amici e parenti assortiti nientemeno che una chiesa
Battista, dalla quale officiavano il rito Rastafariano
ogni domenica mattina con dovizia di fumate colossali e lodi all’altissimo su bassi da far crollare i muri.
Ci si immagina lo sgomento del vicinato alla vista di
questi personaggi intenti a ballare attorno al fuoco
coi regolamentari dreadlocks che svolazzano per
aria. Fin qui il folklore e l’aneddotica.
98
rearview mirror
La musica? Buona e coerentemente adeguata a
quanto sopra, nel solco di una battuta in levare
che celebrava nelle liriche l’epoca “consapevole”
e politicizzata mentre dietro l’angolo attendeva la
“slackness”. Reggae che omaggia le radici africane
secondo il manuale, allora, che non si nega azzeccati
slarghi dub (Occupation, This Ya Music) e tuttavia patisce una scrittura non proprio memorabile (eccezioni il passo guizzante di A Love We Deal Wit e l’accorata Jah Greatest Blessings). Sorta di straight edge
del credo, i nostri dedicavano quest’album del 1981
a Sua Maestà Haile Selassie I ed erano forse troppo
presi dal fervore religioso per sgobbare quel tanto
a raggiungere una promozione piena. Prescindendo
dalla bizzarria del contesto, la riscoperta è discreta
ma destinata in sostanza agli specialisti.(6.8/10)
Giancarlo Turra
Roll Deep - Street Anthems (Roll
Deep Recordings, Ottobre 2009)
G enere : G rime & C o .
Collettivo nato nel 2002 nella Londra garage, cardine e vivaio della scena grime, con dentro figure
chiave come Wiley, Skepta e la cash cow Dizzee
Rascal. Tre album all'attivo, questa è la prima compilation, con diciannove tra classici assoluti del genere (la Eskimo di Wiley cantata da Rascal) e inediti,
dalle prime prove underground, caratterizzate da un
suono chiuso opprimente ipnotico gommoso e da
un flow inintellegibile (cui tanto deve molta scena
hip hop d'oggi, Eminem in testa), alle puntate pop
(Do This Ting, Shake a Leg, Avenue), hip hop/r'n'b/dance (Remember The Days, They Should Know, Do Me
Wrong) e reggae (Movin in Cicles). Ci sono cose belle (perché importanti, perché riuscitissime) e cose
davvero brutte, messa comunque in conto la ripetitività dei pezzi più puristi. Basilare però per capire il
grime.(6.5/10)
Gabriele Marino
Stone Roses (The) - Stone Roses
(SonyBMG, Dicembre 2009)
G enere : pop
Nulla accade per caso, nemmeno l’episodio più sensazionale. Nella musica, poi, men che meno. Eppure,
l’opera prima degli Stone Roses fu salutata come
la salvezza del rock. Un evento sensazionale. In realtà, messo da parte un clamore di stampo(a) per lo
più britannico, Ian Brown, John Squire, Mani e Reni
dalla loro ebbero il modo di imporsi senza inventare nulla. Tamponarono laddove necessario, ovvero
nella crepa post Smiths-iana, capitalizzando in termini messianici lo zeitgeist dell’epoca.
Nella metà degli ’80, con la fine della new wave, dagli Stati Uniti alla Bretagna si propagò un ritorno
al passato rimosso, ai tempi, dall’immaginario collettivo: i Byrds. Da un lato il Paisley Underground,
dall’altro gli Smiths; e nel mentre, ancora dal Regno Unito, band a loro
modo rapite dalla Quinta Dimensione come Jesus & Mary Chain e
My Bloody Valentine
muovevano i primi passi,
seguite dalla cricca C86.
Si era, dunque, in pieno
revival sixties. Si respirava un’aria diversa.Tanto è vero che Londra, sospinta
dall’avvento dell’ecstacy, intuendo nella club culture
ibizenca una via traversa all’hippysmo d’antan, inaugurava la nuova estate dell’amore.
Nella grigia Manchester si provava altrettanto con
l’Haçienda. C’era, però, uno spauracchio da fronteggiare, cioè il mal de vivre che da Ian Curtis arriva
a Morrissey. Tuttavia, proprio nel locale di Tony Wilson fiorirono gli Happy Mondays, cinque reietti
capaci di suonare come dei B.T. Express strafatti (di
ecstacy, naturalmente) e punk. Prodomi di Madchester. I Roses ebbero pochi (ma rilevanti) contatti con
tale crossover, visto che Squire elargiva jingle-jangle
d’altri tempi e Brown esalava assunti da nuovo Dio
in terra. Solo che alla pari di tanti coetanei, frequentando la nuova movida mancuniaia, ragionavano con
l’intento di far festa: hippy fuori tempo massimo
credibili e restaurati nel milieu in atto. Musicalmente, rimandando a Byrds (ops!) e Rolling Stones
con qualche puntata nel folk, figurano tipo Smiths
svampiti. Differisce l’urgenza.
She Bangs The Drums (le regole del futuro guitar
pop), Made Of Stone (Stones e Byrds compressi in
meno di cinque minuti), Elizabeth My Dear (breve
pillola à la Simon & Garfunkel), I Wanna Be Adored
(il proclama) sono i numeri di un debutto assai classico. Ma si cela, subdolo, del groove. Il bello infatti è
nel finale: I Am The Resurrection (beh, mica un titolo
qualunque…) chiosa d’un funk ossuto. Di quelle jam
infinite. Come infatti, nel 1990, in formato singolo
esce Fool's Gold: l’evoluzione della specie. Hendrix
al Paradise Garage, in sintesi. Con Pills 'n' Thrills and
Bellyaches dei Mondays, rock e dance in un colpo
solo. Madchester, per i libri di storia.
Accadeva vent’anni fa. Oggi, celebrandone la ricorrenza, ci ritroviamo tre diverse ristampe di Stone Roses: Special (il debutto con in più Fool's Gold), Legacy
(oltre al debutto, l’inedito Pearl Bastard, un cd intitolato The Lost Demos e un dvd live del 1989) e Collectors Edition (dionisiaco cofanetto di 3 vinili, 3 cd, un
dvd, una penna Usb, un libro e sei disegni ad opera
di Squire, l’artista del gruppo artefice dell’artwork
originale). Il successivo raduno di Spike Island, malamente gestito (c’era pure Frankie Knuckles), da
intuizione vincente si rivelò un disastro. Second Coming ne fu la conseguenza. Ad ogni modo, in Stone
Roses vi troverete la spocchia degli Oasis e le pose
dei Blur. Il brit-pop come lo abbiamo conosciuto.
Passò da qui, la risurrezione.(8/10)
Gianni Avella
(GI)Ant Steps #33
classic album rev
Tina Brooks
P.I.L.
True Blue (Blue Note, Luglio 1960)
Metal Box (Virgin, Ottobre 1979)
In Giappone ci sono individui o intere famiglie che
scompaiono. Letteralmente. La sera ci sono, il mattino
dopo non ci sono più. La causa principale va individuata nei debiti, altre volte in questioni d'onore. Va da sé
che spesso le due cose coincidono. Persone che scompaiono, anzi: evaporano. Azzerano la propria esistenza
per avviarne una altrove, su altre e spesso più modeste basi. Li chiamano johatsu, gli "evaporati", appunto. Anche nel jazz le evaporazioni sono frequenti. Gente
che scompare. Musicalmente, ovvio. Ma un po' anche
a se stessi. In se stessi. Da se stessi. Ad esempio Tina
Brooks.Tra gli altri.
Si fece luce durante i ruggenti fifties, Harold Floyd detto "Tina" per la sua magrezza (e perciò apostrofato
"tiny", o "teeny", smilzo, sottile), nato a Fayetteville nel
North Carolina nel 1932 ed emigrato in quel di New
York nel '44, nel pieno della febbre be-bop. Imbracciato il sax tenore, si barcamenò tra le istanze di senatori
come Lester Young e Charlie Parker e le nuove
soluzioni proposte da rampanti come Sonny Rollins
e Hank Mobley, maturando in questo solco sospeso
tra estro tradizionale e swingate più dure (con licenza
di sperimentare) uno stile che non mancherà di convicere Alfred Lion, il quale lo recluterà nel già lussurioso
roster Blue Note. Correva l'anno 1957. Di lì a poco verranno le incisioni col chitarrista Kenny Burrell (Blue
Lights) e soprattutto con l'organista Jimmy Smith
(House Party, The Sermon! e Cool Blues), quattro titoli nel solo 1958, anno che lo vide altresì incidere l'opera prima come leader Minor Move, che però
inspiegabilmente non ha visto la luce che nel 1980, in
una stampa giapponese. Un disco evaporato, un johatsu
che ha trovato nella terra del sol levante un modo per
esistere. Per fortuna, considerata la qualità della proposta (calde trame hard-bop) e il personale coinvolto
(vi bastino i nomi di Lee Morgan e Art Blakey).
Tina non si lasciò scoraggiare, anzi. Iniziò a lavorare
con Freddie Redd e Jackie McLean, quindi piazzò
la prestazione indimenticabile nello stupendo Open
Sesame del nuovo fenomeno della tromba Freddie
Hubbard. Pochi giorni dopo fu la volta della sua seconda prova come leader, e stavolta la Blue Note non
100
rearview mirror
si tirò indietro.
True Blue vide
un caricatissimo
Hubbard ricambiare il favore, più una sezione ritmica
di tutto rispetto come Duke Jordan (piano),Art Taylor
(batteria) e Sam Jones (contrabbbasso).
Dei sei pezzi in scaletta, cinque sono firmati da Tina
stesso. Splendidi, dalla felata e bluesy Good Old Soul
all'eleganza cool in fregola latin tinge di Miss Hazel,
passando dalla rumba languida e urbana di Theme For
Doris al be-bop sbuffante di Up Tight's Creek, fino ad
una title track che smaltisce mambo con beffarda ostinazione e fatalismo implacabile. Hubbard fa frullare la
tromba come un friguello elettrificato, con la febbrile
(in)compostezza che ben sappiamo. Al contrario, Tina
calca ogni nota come dovesse spalmarla sulla tela, imprimerla a fondo, impregnare la trama. La sua agilità è
un prodigio perché contrasta con questo senso plastico, di stasi timbrica. I rispettivi assolo dei due primattori si marcano, si guatano, si sfiorano armonici,
rivelano una natura stranamente aliena e complementare. In Nothing Ever Changes My Love For You, traccia
conclusiva a firma Jack Segal e Marvin Fisher, mettono
in scena un cuore diviso e incrinato, cerchio fatuo di
pulsioni swing e latine in cui ha buon gioco anche il
piano di Jordan, spedito sulle tracce solenni e trepide
del Duke per antonomasia (Ellington, of course). In poche parole: questo disco è un capolavoro. Che tuttavia
arrivava in un periodo particolarmente fecondo per
il jazz, impollinato solo pochi mesi prima dal monstre
davisiano Kind Of Blue e in procinto di squadernare
energie sempre più ardite e diverse. In questo scenario
formidabile, Tina Brooks l'introverso non trovò e non
ebbe posto. Nell'ottobre inciderà un ancora superbo
Back To The Tracks, seguito da un piuttosto sfocato
The Waiting Game. Quindi, l'evaporazione. In una
nuvola tossica e (perciò) problematica che gli consentì fantomatiche esibizioni nei club newyorkesi, spesso
assieme a band dedite a sonorità latine ed errebì. Morì
dimenticato il 13 agosto del '74 per insufficienza renale. L'ultima evaporazione. Stefano Solventi
Un putiferio. I Sex Pistols sbracano, Sid Vicious
che tira le cuoia in quel di New York, il filmmaker
Julien Temple che dà in pasto ai fan del punk La
grande truffa del rock'n'roll. E Johnny Rotten nel bel
mezzo, che tutto osserva. Uno, Johnny, che mica si
fa pregare troppo. E infatti, morti i Pistols, subito
mette su una cosa tutta sua, e mostra di avere un
paio di coglioni grossi così: chi aveva, anche solo
per un attimo pensato, fosse tutta una "grande
truffa" (la sua), vada a farsi fottere.
E' il 1978. La Virgin, vampirizzata e manipolata dal
Nostro - ormai ribattezzatosi col suo vero nome:
John (Joseph) Lydon - sputa in faccia al punk. In faccia al mondo. Critica, pubblico, decisi, indecisi. Tutti,
ma proprio tutti... Fuck You! First Issue era stato
un album drogato, biascicato, suonato per non suonare bene. Tanti lo avevano schifato, alcuni lo compresero; ora però si attendeva una mossa numero
due degna di cotanto esordio. Ed eccola la n°2. Sempre su Virgin, appena un anno dopo. Non gli bastava
un singolo vinile a John? Quattro facciate di quella
robaccia allucinante doveva propinarci? Meglio non
farsi scrupoli del genere, perché il disco (allora) in
uscita della nuova creatura di Lydon - i Public Image
Ltd - è addirittura un doppio. O meglio, un triplo.
Metal box, infatti, nell'edizione originale (indovinate
un po' perché si chiama così...) è composto di tre
dischi a 12"; Second Edition, invece, nella ristampa,
distribuita in America a 1980 fatto, risulta un classico double album. E adesso passiamo in rivista il
molosso dei PiL (uno dei massimi della new wave
tutta!). Si parte con Memories, canzone scelta anche
come singolo.Top 40. Anzi, neanche quello. Un disco
che ha bucato l'occasione giusta? Macché. State a
sentire: nonostante tutti i 12 pezzi dell'album siano
(in sostanza) un 'buona la prima', il disco inanella numeri di lusso uno dietro l'altro. Tipo? Tipo Albatross,
ad esempio, 10 minuti in cui il basso del sommo
Wobble irrompe sulla voce catatonica di Lydon e
sulla tramatura della batteria stracca eppure trascinante. Insomma: i tipi si strafanno di droghe e mettono su dischi reggae di tutti i tipi stravaccati nel
salotto di Gunter Grove. E si sente!
Memories è già più allegrotta. Un up-tempo, ma sempre in salsa dub. La techno con qualche annetto di
anticipo? Forse. Tim Walker lavora alla batteria su
basi disco sciattissime e ci tira fuori cupezze new
wave che sono pura avanguardia. E meglio lo si capisce in una Swan Lake. Altro che Tchaikovsky. Il dub
di Wobble è tetragono e paradossalmente mobilissimo. La chitarra affilata e free. La voce di Lydon
un urlo soffocato, un canto soffocante. Apice della
claustrofobia-camuffata-rock del disco è Poptones,
che promette il contrario di quel che il titolo dice:
la perfetta canzone dei P.I.L. Canzoni-suite, che potrebbero incastrarsi ad anello le une alle altre, fagocitando le une le parti delle altre. E davvero non
cambierebbe un cazzo: tutto rollerebbe a meraviglia.
E quindi Metal Box/Second Edition è proprio questo:
un disco epocale. Sega in due la new wave di fine '70
e a calci in culo la fa volare nei rave anni '90.
Occhio: siamo nel 2009 e Lydon ha annunciato la
reunion dei P.I.L. Ma non quelli della formazione aurea: mancano all'appello Wobble e Levene. In compenso ci sono Lu Edmonds e Bruce Smith, già al
fianco di Lydon nei dischi dei PiL dei tardi '80. Con
in più un signore che di nome fa Scott Firth e che
ha suonato con Steve Winwood tanto quanto con
le Spice Girls. E non aggiungiamo altro...
Massimo Padalino
rearview mirror
101
3-D parte
seconda Gli anni ’50
Mostri e alieni dallo spazio profondo (e altre cose fantastiche).
Seconda parte di uno speciale dedicato alla bidimensionalità.
- Costanza Salvi
102
la sera della prima
Nella serata della festa del Ringraziamento, anno
1952, si tenne la prima del film Bwana Devil con
una folla urlante, dotata di occhialini, che in sala si
accucciava sulle poltrone per ‘evitare’ la pioggia di
lance e l’attacco dei leoni affamati. Il 3D era finalmente arrivato ad Hollywood. Perché arriva in quel
momento? Che tipo di spettacolo offre? Che rapporto c’è fra Hollywood e il 3-D?
Rispondere alla prima domanda è davvero facile: l’intera macchina hollywoodiana si era messa in moto
per combattere il potere della televisione. Col 3-D
Hollywood cercava di accostare lo spettacolo cinematografico ad una nuova prerogativa che avrebbe tirato fuori le persone dai loro comodi salotti.
Secondo alcune fonti centinaia di cinema avevano
chiuso i battenti e gli studios avevano tagliato drasticamente la produzione. Molte star si affrancavano
dalle strette dipendenze delle majors per stipulare accordi a produzione; alcuni attori si ritirarono,
altri passarono ad altre forme di spettacolo. Nelle
pellicole di quegli anni il soprannaturale e la paura
dell’ignoto furono utilizzati come uno strumento di
grande appeal per attirare un pubblico di teenager
senza troppe pretese. Non è un caso che gli anni 50
siano accostati, nella nostra mente, proprio al genere fantascientifico. Del resto lo stesso decennio storico coincide, sempre nel nostro immaginario, con
l’apice del cinema in 3.D.
Ma fermarci alla sola minaccia della televisione non
ci farebbe capire adeguatamente il rapporto 3-D/
Hollywood. Secondo R. H. Hayes l’idea del 3D come
un evento strettamente hollywoodiano non è del
tutto esatta. A suo avviso questa novità non poteva
costituire una posta in gioco abbastanza allettante
per Hollywood se prima un qualche interesse commerciale non si fosse rivelato. La diffusione in massa
della fotografia stereo aiutò molto a formare nel
pubblico un gusto e a convincere che si potesse creare una domanda di quel tipo di prodotti anche al
cinema. Era, poi, necessario che persone intraprendenti (curioso che questo - un uomo e il suo sogno
- sia uno dei plot più amati proprio dalla fabbrica del
cinema) con buon naso per gli affari spianassero la
strada ai pezzi grossi del mercato, puntando tutto
su una buona dose di fortuna. Fino a quel momento
il 3-D sarebbe stato considerato a Hollywood più
come problema tecnologico che come valore commerciale.
Inoltre un altro fattore fu decisivo per Hollywood: la
concorrenza con altre società che operavano nel
settore globalmente e localmente, soprattutto in
termini di sviluppo tecnologico. In sostanza si creò
una storia simile a quella, successiva, della Space Race,
la rivalità tra Usa e Urss a proposito dello Sputnik.
Una società inglese, la Stereo Techniques Ltd., aveva
avuto molto successo in Inghilterra e in Canada con
un sistema chiamato British Telecinema, creato
da Raymond Spottiswoode. Secondo Hayes fu proprio la concorrenza internazionale aizzata da questo
sistema a convogliare l’attenzione sul 3-D. Così, anche in Usa, un’equipe d’esperti sviluppò un dispositivo chiamato Natural Vision durante l’estate del
1951. Il sistema, tecnologicamente inferiore a quello
inglese, fu visionato da molti studios ma nessuno
ne volle acquistare i diritti d’utilizzo, forse per le
suddette ragioni. Era necessario che quello spirito
libero e intraprendente menzionato più su indicasse
la strada alle majors: un produttore radiofonico e
occasionale moviemaker, Arch Oboler, cominciò
ad interessarsi alla cosa. Questo personaggio, non
troppo lontano dalle ‘parti’ di Ed Wood - convinto
di poter riportare in auge il 3-D dopo l’andamento
a singhiozzo dei decenni precedenti - prese accordi
con la Natural Vision Corporation per l’utilizzo del
dispositivo. Il film, Bwana Devil, venne fatto sotto
regia e apporto finanziario dello stesso Oboler; il
soggetto raccontava di un paio di leoni feroci che
in Africa avevano sbranato gli operai impegnati nella
costruzione di una ferrovia trans-africana. Era una
sorta di reminder per il pubblico che già conosceva
le strane storie che Oboler raccontava alla radio
durante il suo programma Lights Out; lui sosteneva
che il soggetto fosse basato su una storia che aveva
sentito durante un suo safari negli anni 40; la stessa
storia è alla base anche di Spiriti nelle tenebre
(The Ghost and the Darkness) con Michael Douglas e
Val Kilmer. In origine - il 30 novembre del 1952 - il
film di Oboler uscì col titolo The Lions of Gulu.
Il film Bwana Devil, nonostante il 3-D fosse stato
ampiamente pubblicizzato, faceva un uso piuttosto
blando della tridimensionalità ed era, a dir la verità,
piuttosto scarso ma la risposta del pubblico fu entusiasmante. Nonostante la pessima critica, il pubblico
continuò per settimane a far la coda per vederlo,
tanto da smuovere anche l’interesse della United
Artists che, a partire dal marzo del 1953, cominciò a
distribuirlo sul territorio. Il fatto creò una reazione
a catena causata, senza orma di dubbio, dall’enorme
competizione fra gli studios. A dicembre del 1952
Variety già chiamava l’industria del 3-D “the next big
thing” e fonti interne riportavano un dato che metteva tutti i capi della produzione all’erta: le majors
la sera della prima
103
stavano lavorando, ciascuna al proprio interno, con
equipe alle strette dipendenze, sul sistema 3-D. Se
fino a poco tempo prima il Cinerama era ancora
in lizza per far scatenare il suo potenziale risolutivo
nella lotta contro la tv, dopo il successo di Bwana
Devil, tutte le carte del 3-D ritornavano in gioco. Ricordiamo che il Cinerama era una creazione di Fred
Waller, che consentiva di proiettare il film su uno
schermo enorme e curvo attraverso tre proiettori
che davano l’idea della tridimensionalità ma che, di
fatto, non la utilizzavano (offrivano una sorta di illusione di profondità). L’invenzione fu presentata nel
1939 alla New York World’s Fair e più volte riproposta ma il costo per installare un simile schermo
era improponibile per un esercente di un cinema
medio.
Warner Brothers era stato il primo studio ad
aver introdotto il sonoro nel 1929 e voleva mantenere questo primato anche nel 3-D: Jack Warner
- le cui capacità persuasive passarono alla storia - fu
alquanto abile nelle trattative con la Natural Vision.
Poco dopo anche la Columbia prese accordi per
girare alcuni film in 3-D. La MGM costruì la sua unità
3-D battezzandola Metrovision Tri-Dee e definendola
la migliore di tutte. In realtà le unità tecnologiche
utilizzate per il 3-D più o meno si equivalevano,
ma ciascuno studio aveva i propri tecnici e deteneva una sorta di copyright sui propri dispositivi. La
RKO, per esempio, lavorava con un sistema chiamato Future Dimension, basato su di un’unica camera
(invece di una twin camera) più leggera e piccola.
La Paramount, invece, produsse il Paravision, una
versione della Natural Vision brevettata dai propri
tecnici. Ovviamente qui si parla solo di dispositivi
per il 3-D ma non dobbiamo dimenticare che per
ogni altra innovazione tecnica valeva lo stesso discorso di copyright e rivalità. Per tecnica intendiamo il widescreen (Variscope di MGM, VistaScope
di Columbia, ScenicScope di RKO, Wide-Vision di
Universal, PanoramicScreen di Paramount, CinemaScope di 20th C.F.) ma anche lo stereosound.
Per esempio la Warner aveva brevettato un sistema
molto sofisticato, WarnerPhonic, che consentiva di
dare un’illusione di profondità anche attraverso il
suono.
Ritornando ai film di questo breve ma intenso periodo, di fatto, siamo costretti a dire che non furono
molti quelli davvero memorabili. Molti si possono
ricordare per ragioni non diverse dall’uso estensivo dei cosiddetti trucchetti della terza dimensione.
L’utilizzo a tappeto del lancio di oggetti acuminati,
104
la sera della prima
pistole puntate contro il pubblico, incidenti stradali
che lo ‘colpivano’ erano a volte usati con troppa disinvoltura. Ma questo non toglie che si girarono anche buoni film. Uno dei migliori prodotti di questo
periodo fu La maschera di Cera (House of Wax,
1953) di Andre de Toth. De Toth aveva già girato
buoni film per la Warner e da tempo si stava interessando al 3-D. Le parole usate per terminare l’accordo furono, nel tipico stile di Jack Warner: “Quello
che puoi ottenere è 50 giorni, un milione di dollari e un
quarto degli incassi”, a dimostrazione del fatto che
niente è sicuro e certo nel mondo del cinema. Il
soggetto era basato sull’omonimo (in italiano) film
di Michael Curtiz (Mistery of the Wax Museum) del
1933, in stile espressionista, uno dei più noti horror
di quel decennio particolarmente favorevole a questo genere. Il soggetto macabro - uno scultore, rimasto vittima di un incendio nel suo museo delle cere,
inventa uno strano metodo di lavoro - era tratto
dalla pièce di Charles Belden, The Waxworks. Andre
de Toth decise di girare il remake di questo film in
3-D, contando sulla collaborazione di un corposo
cast, a partire da Vincent Price che, con La maschera di cera, cominciò la sua ‘carriera’ nell’horror.
Il set fu disegnato in modo semplice, con l’obiettivo
di fornire la base migliore per l’effettistica. La scena
dell’incendio fu girata in un unico piano-sequenza,
con tre mdp Natural Vision montate su enormi dollies, mentre l’intero set era invaso dalle fiamme. Il
make-up di Price richiedeva un lavoro di tre ore
ed era estremamente scomodo, ma portava la firma
di Gordon Bau, sotto contratto con la Warner, uno
dei più esperti del settore. Durante la prima settimana a New York il film fece 123.000 $ e, in seguito, fu programmato a Los Angeles in una maratona
che durò 24 ore. Sarebbe interessante confrontare
questo film con un altro, L’uomo nell’ombra (Man in
the Dark, Columbia), la cui proiezione coincise con
quella di La maschera di cera ma che ottenne molto
meno successo. Si potrebbe, così, dimostrare che la
qualità del soggetto e della creazione registica non
potevano essere sottovalutate rispetto alla sola effettistica e che già il pubblico aveva sviluppato un
certo senso critico riguardo al 3-D.
Siamo sicuri di poter dire che i migliori film in 3D
degli anni 50 siano stati film horror e di fs. Pensiamo, per esempio, a Il mostro della laguna nera
(Creature from the Black Lagoon, 1954) o a Destinazione terra (It Came from Outer Space, 1953). Non
che venissero girati in 3-D solo pellicole di questi
due generi: molti studios, infatti, vedendo lo straor-
dinario successo di Bwana Devil, si buttarono nel business senza fare troppi calcoli teorici. Furono convertiti in 3-D o direttamente girati in stereovision
molti film d’animazione come Melody, un cartoon
molto stilizzato, primo di quella serie della Disney
che si intitola Adventures in Music; saghe storiche
come Forte t (Fort Ti) della Columbia e drammi
in costume come Sangaree della Paramount, western come Hondo con John Wayne (Warner) e
musical come Baciami Kate! (Kiss Me Kate, 1953,
MGM), comici come Money from Home (I figli
del secolo, Paramount) con la coppia Martin/Lewis,
di guerra come Cease Fire! (Paramount), un serioso docudramma in b/n sulla guerra in Corea. Ma ci
furono anche documentari scientifici, didattici, musicali, sportivi e commerciali.
Di certo, per comprendere la relazione fra fanta/horror e 3-D, non ci vuole molto acume: la percezione
di profondità e d’immersione è un valore aggiunto
rispetto alla condizione emotiva di uno spettatore seduto in sala, al buio, in attesa che qualcosa di
estremamente minaccioso, cattivo, mostruoso, raccapricciante, orrendo si manifesti in qualche modo.
La sensazione prodotta dal film è parecchio esaltata
quando i segni visivi e acustici prodotti dal ‘mostro’
non rimangono appiattiti sulla bidimensionalità ma
vengono proiettati in modo estensivo. Jack Arnold,
regista di Destinazione Terra, spiegò, durante
un’intervista, di credere nella visione stereoscopica
solo nel caso in cui fosse motivata dalla storia. Nella
scena iniziale dell’atterraggio della navicella spaziale
in Destinazione Terra le rocce avrebbero dovuto
‘bombardare’ il pubblico solo in quanto era richiesto dal plot. Addirittura Arnold ricorda che alla prima del film al Pantages Theater di Los Angeles una
catapulta piena di rocce di polistirolo fu installata
sull’arco di proscenio per scattare proprio durante
quella scena! Eppure il film è ricordato più per aver
mostrato l’incredibile forza metamorfica degli alieni
prima del mitico L’invasione degli ultracorpi di
Don Siegel e in pieno clima paranoico/maccartista.
la sera della prima
105
Il fatto è che, nonostante tutte le trovate possibili
e immaginabili (nel western L’indiana bianca di Gordon Douglas, il regista si inventò una gag in cui un
soldato sputa tabacco da masticare contro la macchina da presa per allontanare un serpente a sonagli!) siamo costretti a dire che il 3-D - almeno
nei suoi anni ‘maggiori’ - rimane un fatto di tecnica
mai di ‘grammatica’ del linguaggio cinematografico.
Non riesce a trasformare il linguaggio e a rendersi,
in un certo senso, necessario affinché il senso possa
manifestarsi. Non basta il fatto di porre gli oggetti sullo stesso asse di lunghezza focale per poter
parlare di nuova grammatica: è solo una questione
di incremento delle occasioni di percezione della
profondità. In sostanza le stesse inquadrature, girate
‘flat’, farebbero magari un po’ meno paura, creerebbero meno eccitazione ma il loro senso rimarrebbe lo stesso. Questo spiegherebbe anche come mai
film western o drammatici o, comunque, quelli più
squisitamente narrativi, furono i peggiori film in 3-D
girati in quel periodo. Inoltre i film che, in seguito,
furono celebrati ed esaltati - alcuni anche diventando dei veri e propri cult come i due citati più
su - lo sarebbero stati anche se girati senza visione
106
la sera della prima
stereoscopica. A dimostrazione che, forse, la guerra
tra cinema e tv poteva essere battuta solo attraverso altre strade. In fondo, a partire dal mitico treno
dei Lumiére, il rapporto fra immagine e percezione
sensoriale negli anni non è mai variato. Questo, ovviamente, non vuol dire che non potessero nascere
dei tentativi di ‘sfondare’ in qualche modo questa
barriera e cercare una percezione eccessiva: più
grande (widescreen), più volumetrica (Cinerama
o 3D), odorosa (Smell-O-Vision). Ma sicuramente
queste percezioni eccessive avrebbero avuto meno
possibilità di creare una vera e propria necessità linguistica o reale desiderio nel pubblico al di là della
sola infatuazione.
Gli anni 50 non sono stati solo gli anni di McCarthy e della caccia alle streghe, in senso strettamente
politico identificati in un profondo anticomunismo,
ma rappresentano anche un preciso clima sociale e
culturale. Sono anche anni d’evasioni e scappatoie
culturali rispetto ad un periodo di profondo malessere psicologico: la cattiva coscienza di Hiroshima,
la nevrosi della bomba atomica, la paura degli UFO.
“Sono gli anni di una fantascienza profondamente infantile, fatta di avventure spaziali su astronavi di cartone”
(La Polla). Non ci può essere definizione più chiara
e precisa di un’epoca che, cinematograficamente, è
stata anche giocosa, intraprendente, giovane, a volte
originale e bizzarra (come dimenticare la Smell-OVision?). È ancora La Polla: “Sembra un ritorno al cinema delle origini, un rilancio della natura baracconesca
della messa in scena” (Franco La Polla, Stili americani,
Bononia University Press, pag.127/128).
Una delle componenti forse più intriganti di questo
periodo è la sua natura adolescenziale non solo perché il cinema si rivolge esplicitamente agli adolescenti ma anche perché ringiovanisce la sua componente
primaria, registi e attori. I divi, per esempio, hanno
le facce di ragazzi come James Dean e Marlon
Brando. Inoltre c’è più spazio per gli intraprendenti, che sperimentano su set ricostruiti in miniatura,
con materiali improbabili e che nell’horror e nella fs
trovano perfetto campo di esercitazione. Come dimenticare Ed Wood, prototipo di tutti quei giovani
registi alle prime armi, coinvolti dal lato manuale,
operativo, squisitamente pratico del cinema; affascinati tutti dai trucchi - una sorta di antecedente degli
effetti speciali - soprattutto quelli basati sulla manipolazione del set (i trucchi del profilmico) molto
più economici in termini di sforzo cognitivo di quelli, più complicati e costosi, basati sull’utilizzo della
sola macchina da presa o della pellicola. L’evoluzione
tecnologica ha riguardato più i trucchi prettamente
cinematografici (mdp, pellicola, digitale) che i trucchi
del profilmico, che non sono cambiati di molto. Il
modo in cui si manipola la realtà materiale è rimasto più o meno uguale mentre invece sono di molto
cambiate le potenzialità tecnologiche. Pensiamo, per
esempio, a flou, accelerato, ralenti, tendine, iris, mascherine, dissolvenze, sovrimpressione…interventi
che negli anni 10/20 erano piuttosto complicati ma
che ora apparirebbero dilettantistici. Una specie di
‘archeologia’ dell’effetto speciale poi ‘naturalizzata’
come codice linguistico: per esempio il ralenti al cinema coincide col sogno o con la memoria e non ci
sembra più un ‘effetto speciale’.
Anche dal punto di vista produttivo “i piccoli indipendenti come Roger Corman e Willliam Castle capiscono
molto meglio degli Zanuck e dei Selznick quel che stava accadendo e varano pellicole di poco prezzo ma di
grande impatto sensazionalistico (talune di esse, almeno) sulle platee di adolescenti che ormai hanno preso il
posto dei padri e dei nonni” (La Polla). In effetti il fatto
che proprio in questi anni si assista ad un revival
del mostro sulla scena, dopo i grandi horror degli
anni 30, è indicativo di una scelta di agire in favore
della popolazione giovanile del pubblico del cinema.
Il mostro degli horror di questi anni interpreta pienamente le angosce e i patimenti dell’adolescenza, il
senso di diversità e solitudine di quell’età: la ritualità
della vita sociale, il problema dell’aggregazione e le
sue disfunzioni. I problemi della gioventù saltano agli
occhi proprio a cavallo fra i ‘50 e i ‘60 con tutta una
serie di studi di psicologia adolescenziale e sociologia
che utilizzano anche i film come loro appiglio teorico. Thomas Doherty ha sviluppato un’interessante
idea riguardo al rapporto quasi biologico fra adolescenti e mostri. In Teenagers & Teenpics.The Juvenilization of American Movies in the 1950s dice: “Avendo migliori ragioni della maggior parte delle persone per sentire
un’affinità con gli esseri umani malformati e ipertiroidei,
gli adolescenti furono fedeli adepti e simpatetici osservatori dell’istanza di coloro che erano ormonalmente svantaggiati; il loro stesso stato biologico deve essere sembrato
ugualmente capriccioso e incontrollabile”. In fondo questo aspetto metaforico del mostro è stato portato
avanti anche da film successivi come Carrie e, per
certi versi, anche da Nightmare che ripropongono
quello stesso disagio adolescenziale in vesti rinnovate. Il discorso potrebbe andare avanti ma ci basta qui
aver stabilito questo sicuro legame tra un genere cinematografico e l’età media del pubblico.
Nonostante film mediocri, il 3-D continuò ad esse-
re un fattore particolarmente attraente almeno fino
al 1954. È il 1953 il suo anno migliore: il pubblico
poteva scegliere ogni sera tra almeno cinque film in
stereovision e la Warner annunciò che tutte le sue
maggiori produzioni nel futuro sarebbero state tridimensionali. Nel 54, invece, la produzione diminuì
lentamente anche come conseguenza dell’introduzione di una nuova ‘next big thing’ ovvero il CinemaScope; nel 1955 un solo film fu realizzato in 3D,
La vendetta del mostro (Revenge of the Creature),
che aveva lo scopo di rinnovare il successo di uno dei
più amati e ben riusciti film in stereovision, Il mostro
della laguna nera. Il bilancio finale di questo periodo
comprende un numero molto alto di produzioni nei
tre anni clou, con pochi film veramente buoni, alcuni
ricordati per essere i peggiori, moltissimi dimenticati.
A onor del vero il peggiore di tutti i tempi fu proprio
un fanta/horror, Robot Monster (1953) uno dei
meno costosi, fotografia amatoriale, suono scadente e recitazione approssimativa. Per protagonista un
insolito alieno dall’improbabile costume da gorilla e
per casco una sorta di vaschetta dei pesci rovesciata
completa di antenne radio (!).
È indubbio che l’introduzione e il lancio del CinemaScope fu uno degli ostacoli più forti da affrontare
nella storia dell’evoluzione tecnologica del 3-D. Fu
20th Century-Fox a lanciare il primo film che utilizzava questa tecnica, La tunica (The Robe). Il direttore delle ricerche della 20th C.F., Earl Sponable, aveva
acquistato i diritti sul brevetto della lente anamorfica;
questa lente consentiva di espandere in larghezza il
frame della pellicola senza provocarne una deformazione. In questo modo si poteva avere un effetto simile a quello del Cinerama (dotato di tre proiettori
e schermo curvato) con un costo dimezzato (un solo
proiettore e una pellicola da 35 mm). Inoltre l’effetto complessivo era, in qualche modo, simile a quello
prodotto dalla visione stereoscopica perché simulava, di fatto, una sorta di tridimensionalità. La 20th C.F.
buttò molta carne al fuoco riguardo al CinemaScope
ma si tenne, comunque, anche la carta del 3-D per
giocarla durante i mesi estivi, poco prima dell’uscita
di La tunica, con il film Inferno. Tutti stavano col fiato sospeso aspettando la risposta del pubblico che
quell’estate poteva optare per grandi produzioni
come Gli uomini preferiscono le bionde, Band
Wagon e La vergine sotto il tetto. La stampa
cominciava a ridimensionare le parole d’entusiasmo
riguardo al 3-D e gli studios rispecchiarono questa
deviazione e così sembrò fare anche il pubblico. Invece La tunica, uscito nel settembre del 1953, rila sera della prima
107
scosse davvero molto successo. Come in una specie
di calamita, in modo quasi automatico, molti direttori
della produzione a Hollywood iniziarono ad essere
attirati dal CinemaScope. Incerti riguardo al futuro, i
reparti-produzione della MGM decisero di testare il
3-D per il nuovo musical Baciami Kate!: il film era il
loro asso nella manica dal momento che la MGM era
sempre stata associata a grandi film musicali pieni di
fascino e di magia. Sei città avrebbero funzionato da
‘cavie’: tre proiettandolo in 3-D, tre in versione piatta.
Il risultato fu nettamente a favore della tridimensionalità, così si decise una distribuzione in stereovision,
nonostante le polemiche che iniziavano a montare.
Infatti, oltre alla ‘concorrenza’ con il CinemaScope, il
3D doveva affrontare un altro problema perché stava diventando uno dei maggiori terreni di scontro fra
studios ed esercenti. Era questione dei costi incredibili che quest’ultimi segnalavano riguardo alla conversione dei cinematografi verso il 3-D. Gli schermi
dovevano essere più grandi e supportare una nuova
tecnologia di proiezione ma, soprattutto, erano lenti,
proiettori e sistema del suono a dover essere ria-
dattati; fatti che si aggiungevano agli eventuali costi di
noleggio, all’aumento delle percentuali sul box office
e agli svantaggiosi rapporti contrattuali sul booking
del film. La proiezione, inoltre, necessitava di una figura aggiuntiva a quella del proiezionista con il compito
di curare l’allineamento e la sincronizzazione delle
due pellicole. Sale di piccole e medie città furono costrette a chiudere. L’introduzione di un sistema ‘single strip’ - ovvero costituito dalla stampa di una sola
pellicola che combinava i due frame presi dalle due
mdp, proiettandoli poi con una luce polarizzata che li
sovrapponeva - invece della doppia pellicola ha semplificato la proiezione ma senza modificare di troppo il problema degli esercenti. Gli studios, del resto,
non godevano di una condizione migliore quanto a
gravità dei costi degli strumenti utilizzati contro la
televisione: suono stereo, technicolor, cinemascope
e 3-D erano tutti sistemi alquanto costosi in termini
di personale e di tecnologie. Gli studios ritenevano
che i film che utilizzavano queste tecnologie, costati
in media il doppio o il triplo di un film ‘standard’, dovessero costare agli esercenti la stessa percentuale.
Esattamente come accade ancor oggi, tutto si ripercuoteva sul prezzo del biglietto allontanando ulteriormente la gente dal cinema. Hollywood, inoltre,
contava moltissimo sulle sale delle piccole città perché consentivano il passaggio di un film anche dopo
molti mesi dalla sua uscita (un po’ come oggi accade
con la tv, pay-tv e home-video). Senza il passaggio nelle sale delle piccole città un film medio non poteva
neanche coprire le spese della produzione mentre i
film di serie B o le seconde visioni, che rimanevano
settimane nelle sale minori, tenevano a galla le majors
oberate dalle grandi produzioni. Gli studios arrivarono, così, a concedere agevolazioni sugli occhiali e sul
noleggio dei materiali ma i sindacati (che in America
sono molteplici e riguardano ogni singola categoria)
richiedevano l’assunzione di personale aggiuntivo e
chiarezza nei contratti. Il risultato di questo pasticcio
si ripercuoteva sulla qualità della visione: luce scarsa,
asincrono e problemi di proiezione erano fin troppo
denunciati. Un effetto speciale 3D low-budget, per
esempio, consisteva nel riprendere l’azione in un set
costruito appositamente, con una mdp stereo mentre lo sfondo era proiettato in 2D su uno schermo
retroilluminato. L’effetto finale in un film come Lo
straniero ha sempre una pistola è curioso perché
sembra che le rocce siano completamente immobilizzate su di uno sfondo mobile.
Il CinemaScope, invece, andava molto meglio al botteghino: era grande, luminoso, poco costoso. Chiunque era in grado di capire che sarebbe stato il modo
migliore per andare avanti, il modo, se non altro, più
pratico. I critici, intanto, disinteressati ai problemi
finanziari, continuarono a demolire la presunta qualità del 3-D dimostrando un certo fanatismo per
quei vecchi tempi in cui c’era solo il bianco e nero,
il formato 1.33:1 e il suono mono. Per reazione
Hollywood aumentò la pubblicità che sbandierava
l’alta qualità del 3-D invece di risolvere i problemi
di proiezione che gravavano solo sulla testa degli
esercenti. La cattiva stampa finì col stravolgere anche il CinemaScope presentato come se fosse un
‘3-D senza occhiali’.
Comunque sia, le cose, di fatto, andarono male per
il 3-D: fu capace di un solo colpo di coda prima
dell’oblio con il film di Alfred Hitchcock, prodot-
to dalla Warner, Delitto perfetto (Dial M for Murder). Riguardo all’atteggiamento di Hitchcock sul
film non si è troppo sicuri; qualcuno ritiene che si
disinteressasse completamente della tridimensionalità, altri che, come per altre tecnologie, fosse interessato a sfruttare al massimo la nuova invenzione.
Scelse, per esempio, di riprendere gli oggetti in primo piano, disponendoli in sequenza sull’asse della
visione (utilizzando la tecnica delle proporzioni giganti per mantenere tutto a fuoco). Molti di questi
trucchetti avrebbero potuto essere apprezzati solo
in 3-D ma i cinema che lo proiettarono in versione stereo furono numericamente inferiori a quelli
che lo proiettarono ‘flat’. Durante il secondo revival
del 3-D, nel 1984, il film fu rieditato in una nuova e
migliore versione stereo, che permise a molte più
persone, trent’anni dopo, di vederlo nella sua veste
‘originaria’.
Negli anni successivi (‘60/’70) il 3-D sarebbe stato
tenuto in vita solo grazie a produzioni indipendenti
e ad un particolare genere, quello erotico. Ma può essere indicativo ricordare che anche negli anni 50 la
produzione aveva preso quella strada. In particolare
un film della Columbia, Pioggia (Miss Sadie Thompson), fece abbastanza scalpore. L’ufficio censure a
Memphis lo definì “the dirtiest movie we have ever
seen: rotten, lewd, immoral…” e infatti venne vietato
in città. Ma la gente trovava incredibilmente affascinante essere avvolta dal fumo di sigaretta soffiato
da Rita Hayworth, le sue grazie ostentate e protese in avanti; le location in Hawai e l’eccellente fotografia fecero il resto, creando un grosso successo
di pubblico. Anche la RKO, almeno finché fu legata
ad Howard Hughes, si lanciò in produzioni in 3-D
giustificate dalla starlet di turno, a cui Hughes prometteva mari e monti. Passò alla storia, per esempio,
il programma pubblicitario di La linea francese
che faceva riferimento sia alla tridimensionalità che
al già reso famoso (Il mio corpo ti scalderà) seno di
Jane Russell. Sorpresa finale è un numero ‘skin flick’
(soft porno) girato da Francis Ford Coppola per
il film Bellboy and the Playgirls. Ma questo fa
già parte della successiva fase della nostra piccola
storia del cinema in 3D.
Riferimenti bibliografici
•R. H. Hayes, 3-D Movies: A History and Filmography of Stereoscopic Cinema, McFarland and Company, Jefferson, 1989.
•Hal Morgan e Dan Symmes, Amazing 3-D, Little Brown, Boston, 1982.
•Le citazioni di Franco La Polla sono tratte da Stili americani, Bononia University Press, 2003.
108
la sera della prima
la sera della prima
109
Up
P ete D octer /B ob P eterson (USA, 2009)
La prima parte di Up ha davvero il coraggio della poesia. Una lirica a metà strada tra il futurista e
il nostalgico. Prima di tutto ci si vede specchiati in
uno schermo: noi al cinema con gli occhialoni per
il 3-D e lui, ragazzino sognatore, ugualmente al cinema e con occhialoni da nerd. Oddio sono io! Lo
seguo mentre se ne sta nel suo modesto e bucolico
quartiere di provincia, usa il cinema come luogo di
sconfinamento e con la mente va all’avventura, posti irraggiungibili, lontani. C’è un eroe, ovviamente,
che sullo schermo agisce per lui. Carl, il ragazzino,
lo vede in un documentario cinematografico in b/n,
di quelli che andavano tanto di moda, sull’aviazione,
in quel periodo in cui la visione dall’alto sembrava
la cosa più fantasmagorica e affascinante ci potesse
essere al mondo. Incontra Ellie e c’è un altro ‘riconoscimento’: sulla poetica americana del soul mate,
soprattutto in termini di serialità, si potrebbero
spendere interi saggi tanto è ricca e densa di suggestioni. Così ecco un altro meccanismo di proiezione
che funziona perfettamente: loro sono, appunto, soul
mate ma noi, in sala, non rimaniamo solo testimoni
ma diretti destinatari di una piena identificazione.
L’operazione strategica riesce benissimo, tanto
quanto una strizzatina d’occhio in una direzione
di reciprocità; il vortice di immagini e colori della
prima mezz’ora è straordinario. I segni della confidenza, della specularità fra i due ragazzini sono
perfetti: si incontrano, si appoggiano l’un l’altro nei
momenti di difficoltà, si sposano e vivono e, intanto, sognano. Questo processo di identificazione e
riconoscimento dell’inizio è funzionale alla parte
successiva della storia: quando Carl, il ragazzino,
diventerà Carl burbero e vecchio, uomo inutile se
non dannoso, quei primi minuti di identificazione si
riveleranno fondamentali. Dal momento del matrimonio in poi il racconto è pieno di ellissi e ciò che
viene mostrato ha già la forma del ricordo: singoli
frame sugli avvenimenti e le peripezie della quotidianità, interpolati dall’immagine iterata della rottura del salvadanaio. Come da canone le immagini
sono fané, circondate dall’opacità della memoria. E
la vita scorre via mentre il sogno (bisogni, desideri,
aspirazioni…) rimane irrealizzato. Il risveglio nella
quotidianità di questo vecchietto intrappolato nel
passato è impossibile: qui ricorda Clint Eastwood,
seduto nel suo portico in Gran Torino, anche lui
immobilizzato dentro la memoria di una realtà ormai andata mentre un’altra che non gli appartiene
110
la sera della prima
sta avanzando. Il ragazzetto gli viene in soccorso pur
non sapendolo - nel solo modo, cioè, in cui lo può
fare un bambino, appunto, ingenuamente - e lo fa
impersonando lo stesso potere salvifico che molte
altre volte nel cinema abbiamo visto rappresentato
da figure angeliche e naif.
Quante suggestioni crea il miracolo del volo della
casa? Ne Il mago di Oz la casa se ne vola via con
lo stesso obiettivo di fuga che redime da una vita di
mancanze, disequilibrata. Ma a molti ha fatto pensare a Hayao Miyazaki. Di fronte alla speculazione
edilizia un gesto del genere - far librare una casa
con miliardi di palloncini colorati - è non solo un
gesto poetico ma politico (Dolinar in ‘Film Tv’): fa
persino venire in mente - concedetemi questo volo
di idee libere - un’insostenibile leggerezza dell’essere (la casa, in fondo, è libertà ma anche peso). E
allora ecco che si ritorna allo straccione futurista
WALL-E, altra figura altrettanto poetica e politica, che dell’anticonsumismo fa un vero e proprio
stile di vita. Alla Pixar sono bravissimi a creare personaggi del genere: non solo possono farlo grazie
alla produzione digitale delle immagini - che non li
costringe al realismo e non li sottopone alle bizze
della realtà - ma sanno anche farlo per il semplice
motivo che hanno creato una vera e propria poetica
che li precede. I personaggi e le storie della Pixar
sono riconoscibili e questa riconoscibilità è la chiave di volta che trasforma un semplice buon prodotto in un marchio. Operazione commerciale finchè si
vuole ma, in fondo, il cinema è un’industria no?
Per me UP poteva anche finire qui, nel momento in
cui la casa prende il volo ma, ovviamente, si tratta di
un prodotto per un pubblico ben preciso: è lì, infatti,
che inizia l’avventura per i bambini. Da quel momento il film ha momenti divertenti, sfrutta il famoso
lancio-di-oggetti-modello-3-D, ha cani che parlano,
una ‘sagoma’ di uccello che viene battezzato ‘struzzo in technicolor’ e un classico cattivone, come nel
più classico e rodato dei modelli. È strano: come
mai alla Pixar fanno dei meravigliosi primi quarti
d’ora silenziosi? È una firma, sicuramente. Ma, forse
potrebbe essere qualcosa di più: la riscoperta di un
cinema delle pure immagini, in qualche modo anche
diverso da quello della tradizione americana. É un
modo di pensare alle immagini che ricorda, in parte,
il cinema orientale, fatto solo di suggestioni visive
ed emozioni silenziose; con in più una cura dell’immagine incredibile: provate anche solo a guardare la
trama dei tessuti, un ordito perfetto fatto di ombre,
luce e colore.
Costanza Salvi
Parnassus - L’uomo che voleva
ingannare il diavolo
T erry G illiam (C anada , F rancia , 2009)
Partiamo da due presupposti. Il film è stato un discreto successo nonostante la data incerta d’uscita e
il basso numero di copie distribuite. Con un incasso
di € 2.419.207,25387.945 e 387.945 presenze
il film di Terry Gilliam entra in classifica nazionale
al secondo posto, per poi balzare in testa davanti ad Up (Pete Docter e Bob Paterson, 2009)
della Pixar. Secondo punto da cui dobbiamo partire
è che tolto qualche cinefilo - in via d’estinzione e
già pochi, ancora meno quando si tratta di andare
al cinema - la maggior parte del pubblico è rimasta
irretita grazie al nome di Heath Ledger. Requiem.
la sera della prima
111
Perché alla fine c’è sempre quel qualcosa di morboso. Come quando tra amici si rivede il Corvo (Alex
Proyas, 1994) e c’è sempre qualcuno che segnala il
momento in cui il protagonista diviene un ammasso
di pixel in computer grafica. Ovviamente ogni volta
indicando un momento differente. Solo per questo
il titolo potrebbe essere cambiato in pornassus, perché di vojagerismo morboso di tratta.
Il nodo centrale è noto a tutti: Johnny Depp, Jude
Law, Colin Farrell vengono usati per sostituire
Heath Ledger post mortem. L’espediente dello specchio equiparabile ad un calcio d’angolo, a suo modo
riuscito. Gol con colpo di testa. O di (ghino di) Tacco, perché poi nelle varie conferenze stampa qualche furbetteria il buon vecchio visionario dei Monty Python se l’è concessa, oppure lasciata sfuggire
in buona fede. Ora, sulla riuscita dell’espediente ci
sono due scuole di pensiero. Chi vede nella realizzazione una forzatura. Chi, come me, ritiene che tutto
sommato la trasformazione dell’ennesimo Dorian
Gray sia riuscita, senza molte smagliature al racconto. Anzi, probabilmente se non si sapesse la tragica
necessità alla base, qualcuno riuscirebbe persino a
reclamarne la genialità. Se proprio bisogna cercare
un limite, e non occorre essere puntigliosi e certo112
la sera della prima
sini, lo si deve fare nella costruzione dei personaggi,
piatti, e in una storia faustiana che di nuovo non
aggiunge nulla. Ma niente proprio. Ma del resto Gilliam, come il suo buon illusionista racconta da anni
la stessa storia. E lo fa meravigliosamente. Parnassus
(Christopher Plummer) sembra essere più un
clochard ubriacone, il capo di una carovana dimezzata di Freaks, un uomo incline a vizi come alcool
e gioco d’azzardo. Il ritratto del perfetto gentleman
inglese, insomma. Tony è la versione anglosassone
di Calvi il banchiere di Dio, con tanto di cappio al
collo e ponte dei frati a seguito, ed è troppo viscido
per creare una minima identificazione.
Quello di Gilliam è un film di ricostruzione. Quella digitale con cui sono ricostruite le visionarie e
funamboliche peripezie oniriche dei personaggi. Il
livello realizzativo è ottimo, l’impatto visivo anche,
tolta l’agghiacciante immagine del cobra tentatore. Quella proprio no. Non siamo ai livelli visionari
di Brazil (1985), ma del resto la lezione del Tim
Burton di La fabbrica di cioccolato (2005)
sembra aver lasciato un segno indelebile nel cinema fantastico. Non nel profilo commerciabile del
regista inglese, però, che rimane ancora ancorato
ad un ritmo scivoloso e sincopato a volte fastidioso e difficilmente digeribile dal pubblico medio da
multisala e non. Ma Gilliam ha dalla sua la capacità di
contrapporre squallore reale ed escapismo virtuale,
ed è lì che il lato poetico trova il maggior vigore.
Una discesa lisergica nella tana del Bianconiglio in
cui vengono messi a nudo i lati nascosti della psiche
umana. Si pensi alla maschera, cortina sintetica tra il
Tony di Depp e quello di Ledger. Ricostruzione del
volto del compianto Ledger attraverso altri feticci.
Ma soprattutto è la ricostruzione della biografia di
Gilliam, il vero Parnassus, che con un espediente riesce a vincere la morte altrui e la propria, a livello
professionale. Una lenta eutanasia. Il vecchio trasandato che ha il potere di dar forma ai sogni della
mente, ma che non viene considerato dal pubblico
sembra essere davvero l’autobiografia del regista.
Dai fasti dei Monty Python ai problemi di Lost in
La Mancha (2002). Dalla terribile porcheria su I
fratelli Grimm e l’incantevole strega (2005)
all’incompreso e mal distribuito Tideland (2005).
Gilliam come Parnassus fa poesia, è l’ultimo grande Orfeo. Ma è troppo poco glam in un mondo in
cui a spuntarla sono i diavoli (un insuperabile Tom
Waits) dandy, da bombetta, sigaro e guanto in pelle.
Hollywood per l’appunto. Al posto dell’acqua di colonia, in diffusione c’è probabilmente un oppiaceo.
Il suo è un racconto eccezionale, ironico e amaro
allo stesso tempo, un canovaccio di manipolazioni
d’immagini e volti confuso e scombinato. Un’ottima
sbronza. Per questo gli si può perdonare il cerchio
alla testa di qualche raccordo confuso, di quell’idea
aleggiante di eterno divenire che non troverà mai
sosta e che lo porta da anni a trovare la forma compiuta del suo film forse più bello e meno riuscito, Le
avventure del Barone di Münchausen (1988).
Come il racconto del monaco Parnassus, uguale ed
infinito, ma allo stesso tempo troppo borderline ed
alternativo per essere accettato come tale. Forse
per questo debole, come la trama del film. Ma come
il mondo, anche il film può continuare.
È il cinema di Melies che si riprende la rivincita su
quello dei Lumiere, il trucco e l’artificio sul racconto. Un canovaccio da teatro delle meraviglie in
cui il fratello Grimm per eccellenza dialoga con la
sua musa-strega, il cinema, fino a rimanerne imbrigliato in un nomadismo psichico di cui da carnefice
diviene vittima. Il deserto del quotidiano e della solitudine in cui si ritrova un cencioso e sconfitto mago,
salvato solo dall’istrionico nano, l’eterno bambino.
La beffa di una realtà che si svela attraverso l’ennesima vetrata. Quella che separa illusionista e figlia
(Lily Cole), ormai in un altro mondo, quello moderno, a suo modo fatto di vetrine e illusioni. Non
necessariamente quello vero o quello buono. Nonostante il cashmere tenga più caldo di un vecchio
pastrano, i sogni della testa di Parnassus li si poteva
toccare con mano.
Luca Colnaghi
This Is It
K enny O rtega (USA, 2009)
Il re è morto, viva il re! Michael Jackson se n'è andato, forse, un giorno dell'estate scorsa e già tutti
sapevano che sarebbe uscito questo film. Al di là
delle aspettative, più o meno giustificate, il film di
Kenny Ortega è un horror inutile.
Nato come documentario backstage di quello che
doveva essere il grande ultimo ritorno di Jacko sul
palcoscenico, pensato come idea natalizia dai signori
del marketing musicale contraddistinti da modi simili a quelli degli squadroni della morte nicaraguegni,
il film “si arricchisce” del valore di testamento spirila sera della prima
113
tuale del più grande di tutti i tempi. Il fatto è che si
tratta di un testamento disperato e silenziosamente
urlato e non delle confessioni di una persona serena
e pronta all'ultimo sipario.
Nelle due ore di montato le canzoni, lo spirito di
Jackson, fanno capolino tra le lacrime dei ballerini
increduli per essere stati scelti, tra le perizie tecniche dei macchinisti ma si infrangono contro la
tristezza di un uomo che quando se n'è andato non
pesava più di cinquanta chili. La voce, dolorosamente
potente e ormai elemosinata al corpo minato fa ancora emozionare, le mosse più famose ancora entusiasmano ma l'occhio non è ingannabile ed è evidente che, quasi alla Bob Dylan di Todd Haynes, il re
del pop dica: Io non sono qui. O, meglio, non ci sono
già più. Dopo ogni piroetta, alla fine di ogni passo, i
grandi occhiali da sole che il protagonista indossa
per tutto il film si fanno scudo contro il dolore. Al
riposo dopo un acuto della sua voce angelica quegli
stessi occhiali trattengono l'orrore.
Dicono le cronache che il tour organizzato dall'
AEG all'arena O2 di Londra dovesse comprendere
originariamente un pugno di date poi estese a dieci
e infine espanse alla titanica cifra di quaranta. Dicono le leggende, e quando si tratta di Jackson si sa
che sono l'unica fonte di verità, che il re fosse ter114
la sera della prima
rorizzato da questo impegno preso con i suddetti
nicaraguegni e che dubitasse fortemente di riuscire
a farcela, ma che fosse necessario firmare quel contratto. Che fosse l'ultima possibilità. Il film del furbo
Ortega dimostra questo: prima dell'uomo viene il
mito ma quest'ultimo necessita un appoggio biologico nella sua permanenza sulla Terra. Mancando l'appoggio biologico il mito si spegne a cinquant’anni,
già tardi nella logica dell'immaginario collettivo, in
una villa di Beverly Hills affittata a trentamila dollari
al mese perché la casa dei sogni è all'asta. Sempre
secondo le veritiere leggende, i debiti accumulati da
Jackson durante il suo regno ammontavano a circa
quattrocento milioni di dollari; tre giorni dopo la
sua morte, grazie ai proventi delle vendite della sua
arte, rieditata a tempi di record, tali debiti parvero
scomparsi.
Qui va cercata la motivazione di This Is It, nella
più pura e semplice logica nicaraguegna della musica
mainstream. Non c'è altro da riportare. Posso aggiungere che il film è anche ben montato e che ha un
buon ritmo ma vorrei vedere come potesse essere
diversamente, visto il fantastico beat onnipresente
in ogni brano incluso e composto da quel genio
assoluto di Michael Jackson. In sala viene voglia di
ballare, quest'effetto è cercato e sostenuto di modo
da non far notare i segni sul volto del protagonista,
il suo spaesamento sul palcoscenico gigantesco e
le sue richieste d'aiuto ai tecnici e a Ortega, regista
dello spettacolo prima che del film, di accomodargli
il volume nelle cuffie perché da solo non ce la fa più.
Il re parla, ringrazia, dispensa consigli e indicazioni
ai suoi giovani collaboratori che lo guardano rapiti,
ripete estenuantemente “I love you”, “I love you all”.
Ma è solo. Comunque.
Aldo Romanelli
Il nastro bianco
M ichael H aneke (A ustria /G ermania /F rancia /
I talia , 2009)
Il regista di Niente da nascondere (Caché, 2005)
continua a lavorare per sottrazione e pulizia formale lasciando allo spettatore la parte più difficile
ed entusiasmante: significare quanto visto e sentito
raccontare. Proprio così funziona quest'ultimo lavoro del maestro austriaco, Il nastro bianco (Das
Weiße Band) Palma d'Oro a Cannes: attraverso un
racconto, una brutta storia della buona notte rivolta a tutti noi, in una notte che è quella del buio del
Mondo, dell'odio e della guerra.
Michael Haneke racconta una storia contadina,
una vicenda di strani fatti e vendette, un mito fondativo di violenza e repressione, di cattive educazioni
e brutte abitudini nascoste, caché appunto, che portano i bambini protagonisti di questo film a diventare tutti i bambini oppressi del mondo e, quindi, le
vittime dei regimi totalitari che di loro si nutriranno
nel corso della Storia. Molestie, incidentivoluti, abusi, castrazioni morali. Questo è quanto i bambini del
villaggio subiscono costantemente, senza possibilità
di affrancamento, se non nelle sequenze finali, con
l'episodio del pappagallino, simbolicamente prodromo di uno stravolgimento, vigilia di rivoluzioni future.
Il regista viennese racconta l'ascesa del Nazismo in
Germania partendo da vent'anni prima, dalla campagna tedesca bigotta e ignorante. L'educazione
protestante, ma potrebbe essere quella cattolica o
l'educazione integralista islamica, lede dall'interno la
pianta della società, colpendo dapprima le foglie, più
tenere e piene di vita, e sovverte la naturale successione delle fasi della vita. Molto chiaramente Haneke dice che la scelta dell'esempio tedesco è legata
alla sua vicinanza geografico e storica a quest'area
dell'Europa ma che è la volontà dell'esempio quanto imprime negli scuri 144' in 35 mm desaturati in
fase di post-produzione tanto da creare un bianco
e nero tanto espressivo da rimanere colorato. I movimenti di macchina semplici e classici, l'alternanza
di campi e controcampi nello splendore di un montaggio lineare e puro dapprima mettono in difficoltà
l'occhio e poi lo aiutano all'aumentare della luce.
Ancora una volta il regista non cerca colpevoli materiali, come l'autore delle videocassette minatorie
nel film del 2005 o i motivi della violenza illogica
dei due protagonisti di Funny Games (1997). Ciò
che sempre torna e stimola in Haneke è il sotteso percebile, il senso più profondo degli eventi che
negli esempi raccontati ha la manifestazione più
percepibile ed cangiante e visibile. Ad Haneke interessa l'oscuro che sta dietro le porte chiuse dallo
spettatore, non quelle mostrate nel film. Le cause
scatenanti. La deflagrazione dell'individuo, della società nella quale è inserito e della Storia che questa
società costituisce e governa.
Le parole del maestro di scuola aiutano lo spettatore in questo viaggio che procede come un incubo,
per simboli. Questo è quanto di nuovo Michael Haneke qui introduce ma solo apparentemente si può
parlare di una facilitazione, erroneamente considerarle un aiuto allo spettatore. In realtà fungono da
ennesimo diversivo sottile attraverso il quale allon-
tanare e rendere ancor più lontano l'incontro con
il senso finale. Haneke qui trova un colpevole, forse, ai mali raccontati ma ciò avviene solo per sviare
dall'accusa di colpevolezza i bambini. Tutto è solo
rimandato a pochi anni dopo quando saranno loro,
cresciuti castrati, a supportare l'ascesa del male e a
diventare male.
Aldo Romanelli
la sera della prima
115
www.sentireascoltare.com