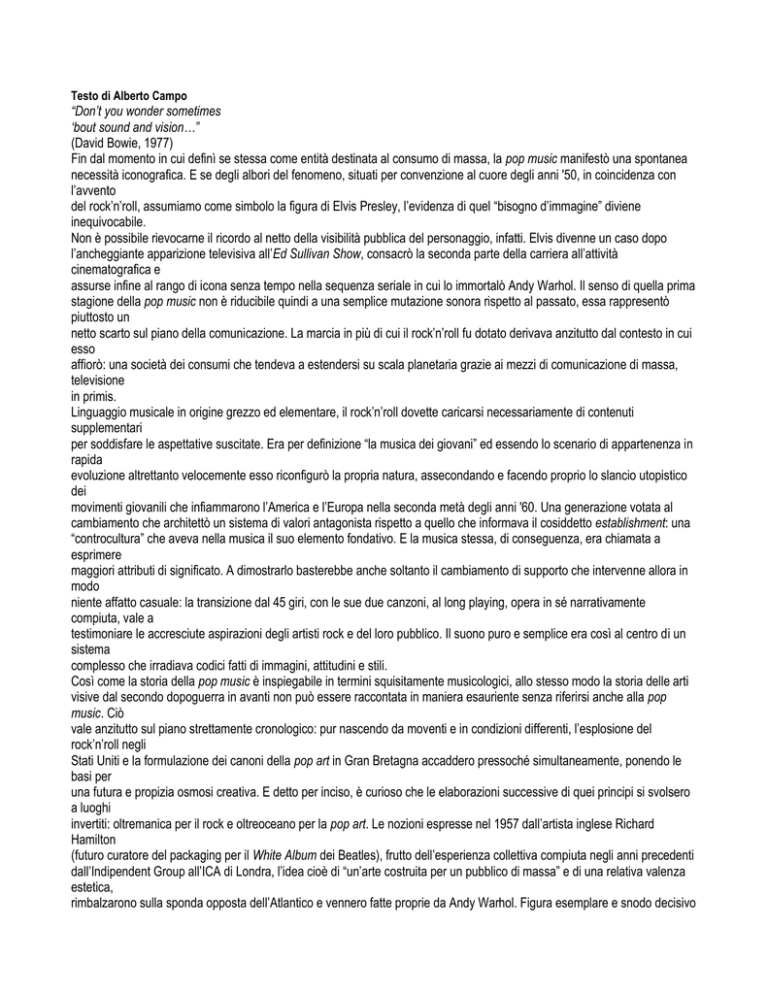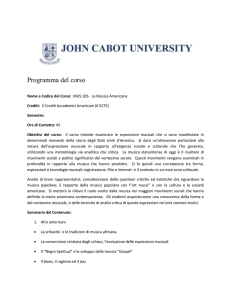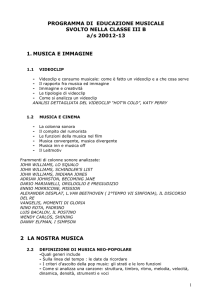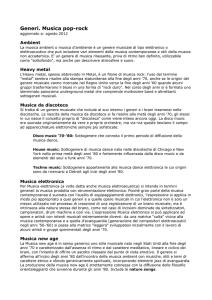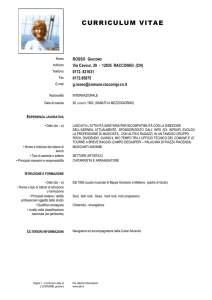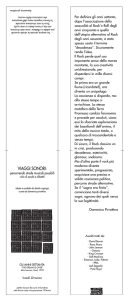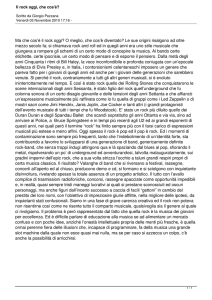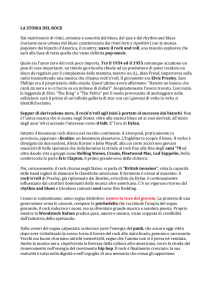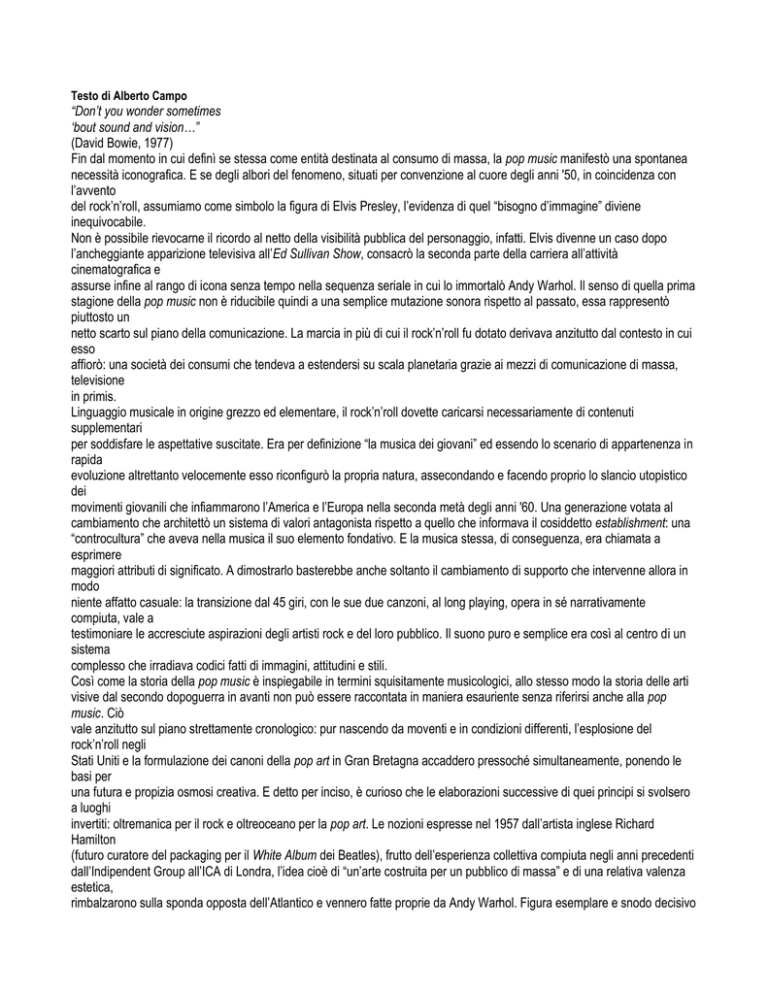
Testo di Alberto Campo
“Don’t you wonder sometimes
‘bout sound and vision…”
(David Bowie, 1977)
Fin dal momento in cui definì se stessa come entità destinata al consumo di massa, la pop music manifestò una spontanea
necessità iconografica. E se degli albori del fenomeno, situati per convenzione al cuore degli anni '50, in coincidenza con
l’avvento
del rock’n’roll, assumiamo come simbolo la figura di Elvis Presley, l’evidenza di quel “bisogno d’immagine” diviene
inequivocabile.
Non è possibile rievocarne il ricordo al netto della visibilità pubblica del personaggio, infatti. Elvis divenne un caso dopo
l’ancheggiante apparizione televisiva all’Ed Sullivan Show, consacrò la seconda parte della carriera all’attività
cinematografica e
assurse infine al rango di icona senza tempo nella sequenza seriale in cui lo immortalò Andy Warhol. Il senso di quella prima
stagione della pop music non è riducibile quindi a una semplice mutazione sonora rispetto al passato, essa rappresentò
piuttosto un
netto scarto sul piano della comunicazione. La marcia in più di cui il rock’n’roll fu dotato derivava anzitutto dal contesto in cui
esso
affiorò: una società dei consumi che tendeva a estendersi su scala planetaria grazie ai mezzi di comunicazione di massa,
televisione
in primis.
Linguaggio musicale in origine grezzo ed elementare, il rock’n’roll dovette caricarsi necessariamente di contenuti
supplementari
per soddisfare le aspettative suscitate. Era per definizione “la musica dei giovani” ed essendo lo scenario di appartenenza in
rapida
evoluzione altrettanto velocemente esso riconfigurò la propria natura, assecondando e facendo proprio lo slancio utopistico
dei
movimenti giovanili che infiammarono l’America e l’Europa nella seconda metà degli anni '60. Una generazione votata al
cambiamento che architettò un sistema di valori antagonista rispetto a quello che informava il cosiddetto establishment: una
“controcultura” che aveva nella musica il suo elemento fondativo. E la musica stessa, di conseguenza, era chiamata a
esprimere
maggiori attributi di significato. A dimostrarlo basterebbe anche soltanto il cambiamento di supporto che intervenne allora in
modo
niente affatto casuale: la transizione dal 45 giri, con le sue due canzoni, al long playing, opera in sé narrativamente
compiuta, vale a
testimoniare le accresciute aspirazioni degli artisti rock e del loro pubblico. Il suono puro e semplice era così al centro di un
sistema
complesso che irradiava codici fatti di immagini, attitudini e stili.
Così come la storia della pop music è inspiegabile in termini squisitamente musicologici, allo stesso modo la storia delle arti
visive dal secondo dopoguerra in avanti non può essere raccontata in maniera esauriente senza riferirsi anche alla pop
music. Ciò
vale anzitutto sul piano strettamente cronologico: pur nascendo da moventi e in condizioni differenti, l’esplosione del
rock’n’roll negli
Stati Uniti e la formulazione dei canoni della pop art in Gran Bretagna accaddero pressoché simultaneamente, ponendo le
basi per
una futura e propizia osmosi creativa. E detto per inciso, è curioso che le elaborazioni successive di quei principi si svolsero
a luoghi
invertiti: oltremanica per il rock e oltreoceano per la pop art. Le nozioni espresse nel 1957 dall’artista inglese Richard
Hamilton
(futuro curatore del packaging per il White Album dei Beatles), frutto dell’esperienza collettiva compiuta negli anni precedenti
dall’Indipendent Group all’ICA di Londra, l’idea cioè di “un’arte costruita per un pubblico di massa” e di una relativa valenza
estetica,
rimbalzarono sulla sponda opposta dell’Atlantico e vennero fatte proprie da Andy Warhol. Figura esemplare e snodo decisivo
nella
vicenda che stiamo tratteggiando per sommi capi, quest’ultimo. La sua percezione del consumo come gesto culturale,
presagio
dell’incipiente trionfo del capitalismo nella sfida tra modelli sociali simboleggiata dalla Guerra Fredda, rivoluzionò
irreversibilmente le
gerarchie del pensiero artistico, a cominciare dal collasso delle distinzioni fra cultura “alta” e “bassa” che lo portò ad
affermare: “La
nuova aristocrazia che dice agli artisti cosa vale e cosa no è la gente comune”.
Dopo aver replicato in serie la figura di Presley e prima di coniare il logo che tuttora contraddistingue i Rolling Stones,
Warhol
compì il più audace esperimento di combinazione fra arte e musica reclutando a metà anni '60 nei ranghi della sua Factory
newyorkese i Velvet Underground. Risultati dell’operazione furono il primo album del gruppo di Lou Reed e John Cale ma
soprattutto
l’Exploding Plastic Inevitabile, leggendario show che oggi chiameremmo “multimediale”. Fu la scintilla che mise
definitivamente in
corto circuito rock e arte, fomentando per induzione nella stessa New York l’esperienza del Mercer Arts Center, crocevia
interdisciplinare in cui finirono per convergere personaggi provenienti tanto dai piani alti della produzione culturale (Laurie
Anderson)
quanto dal sottobosco metropolitano (i New York Dolls). E che si fosse attivato un canale di comunicazione privilegiato fra i
due
mondi lo dimostrò nella seconda parte degli anni Settanta la trasmigrazione sui palchi del rock di intelligenze forgiate nelle
scuole
d’arte: da Patti Smith ai Devo passando dai Talking Heads.
La strettissima connessione fra art schools e scena rock, in cui sovente le prime fungono da serbatoio di risorse umane per
la
seconda, è ancora più visibile esaminando il caso britannico. Evidenziavano la relazione anni fa Simon Frith e Howard Horne
nel
saggio Art into Pop (Methuen, 1987), elencando quali e quanti protagonisti della musica locale provenissero dagli istituti
d’arte. John
Lennon, destinato a reimmergersi in quegli ambiti dopo il matrimonio con Yoko Ono (aderente al movimento Fluxus e fin dai
primi
anni Sessanta organizzatrice degli happening che in un certo senso anticiparono su scala ridotta le modalità rituali del
festival rock).
Keith Richards dei Rolling Stones e Jimmy Page dei Led Zeppelin. Freddie Mercury dei Queen (assoluti pionieri del videoclip
ai
tempi di Bohemiam Rhapsody). Brian Eno e Bryan Ferry (che al college aveva seguito i corsi di Richard Hamilton), insieme
nei
primissimi Roxy Music. Ma forse il personaggio che più di altri spiega nella propria biografia artistica la coesistenza delle due
motivazioni è Pete Townshend dei Who, alla definizione dello stile dei quali contribuì inizialmente Peter Blake (noto inoltre
agli
appassionati di rock come autore della copertina di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles), laddove il
proverbiale
vandalismo dei loro show dell’epoca - chitarre frantumate sul palco... - rimandava invece all’arte autodistruttiva di Gustav
Metzger
(anch’egli di scuola Fluxus).
Fu tuttavia con l’eruzione del punk che la convergenza dei due vettori produsse la massima risultante. Le due bande più
rappresentative della scena londinese, benchè in modi diversi, dovevano la propria identità alla scuole d’arte. Nel caso dei
Clash
poiché tre quarti del gruppo – Joe Strummer, Mick Jones e Paul Simonon - usciva da quel ciclo di studi, denunciando nella
propria
immagine pubblica l’ascendenza estetica esercitata da artisti quali Jackson Pollock e Robert Rauschenberg. In quello ancora
più
clamoroso dei Sex Pistols, viceversa, anziché il curriculum studentesco dei musicisti, valeva l’estrazione del manager (e
addirittura
“burattinaio”, secondo alcuni) Malcolm McLaren (diplomato alla scuola d’arte e seguace di Fluxus, Warhol e situazionisti) - e
di chi –
Jamie Reid - ne curava il corredo visuale, abrasivo quanto la musica. Un prodotto “pop” perfetto, ancorché in apparenza
“sovversivo”. Grande opera d’arte sic et simpliciter, secondo Fred Vermorel, tra i massimi esegeti del fenomeno: “I Sex
Pistols mi
ricordano Guernica di Picasso, un’opera epocale, inestricabilmente avvinghiata al trambusto e alle polemiche che provocò.
Bellezza
strappata alla disperazione”, scriveva a cose fatte, nel 1981.
La configurazione musica/moda/design che stava alla base dell’operazione Sex Pistols (il cui impeto rivoltoso era stato
covato
dentro la boutique di McLaren e Vivienne Westwood) altro non faceva che perfezionare un’alchimia sperimentata già nel
decennio
precedente, quando Londra “swingava” al ritmo delle canzoni dei Beatles, con i capelli dei ragazzi che si allungavanno e le
gonne
delle ragazze che si accorciavano, seguendo i dettami stabiliti da Mary Quant a Carnaby Street. Un intreccio non dipanabile
fra
impulsi creativi e interessi commerciali, che in epoca punk McLaren ebbe la sfacciataggine di dichiarare esplicitamente
condensando
l’avventura dei Sex Pistols nell’icastico slogan “La grande truffa del rock’n’roll”. Si avverava così la premonizione di Warhol a
proposito delle finalità intrinsecamente mercantili dell’arte di fine Novecento, diretta conseguenza del crollo dei valori culturali
tradizionali che aveva posto le premesse per l’affermazione della nozione stessa di postmodernismo.
La definitiva beatificazione di quella visione “profana” dell’arte, in ambito musicale e non solo, è coincisa con l’avvento del
videoclip (“unica originale forma d’arte televisiva”, secondo il massmediologo John Fiske) e la creazione del medium a esso
deputato, MTV. Un metalinguaggio che a lungo andare, definendo nuovi standard della comunicazione, ha condizionato
forme
espressive limitrofe: dai telefilm alla pubblicità televisiva, arrivando a influenzare persino le produzioni cinematografiche. Non
si
spiegherebbe altrimenti l’ininterrotto via vai da un settore all’altro: registi di cinema prestati al videoclip (John Landis, Sam
Peckinpah, Brian De Palma) e viceversa (Spike Jonze, Michel Gondry, Tarsem Singh). E puntualmente, quando ancora si
era negli
anni '80, il MOMA di New York decise con lungimiranza di creare un proprio archivio dedicato appunto ai videoclip. La
medesima
istituzione, del resto, aveva ospitato nel 1976 una mostra dei più significativi poster prodotti sulla West Coast durante
l’epopea
hippie. Segno che i fenomeni a vocazione musicale tendono – come dicevamo inizialmente - a sollecitare produzioni
artistiche
funzionali e complementari. Anzitutto copertine per i dischi: territorio di esercitazione creativa in cui, dagli anni Sessanta in
poi, si
sono forgiate intelligenze figurative di assoluto livello. Peter Saville per la Factory Records di Manchester (città di cui è stato
nominato recentemente brand consultant). Neville Brody, illustratore per la Fetish Records e quindi direttore artistico del
magazine
The Face. E ancora: lo studio 23 Envelope, artefice degli inconfondibili packaging dei prodotti 4AD. Attraverso le copertine di
quei
dischi e di molti altri ancora è possibile rivisitare dunque la storia della pop music per immagini. Ma anche – come volevasi
dimostrare - cogliere il modo in cui la pop music, richiedendo immagini, ha influenzato il corso dell’arte contemporanea.