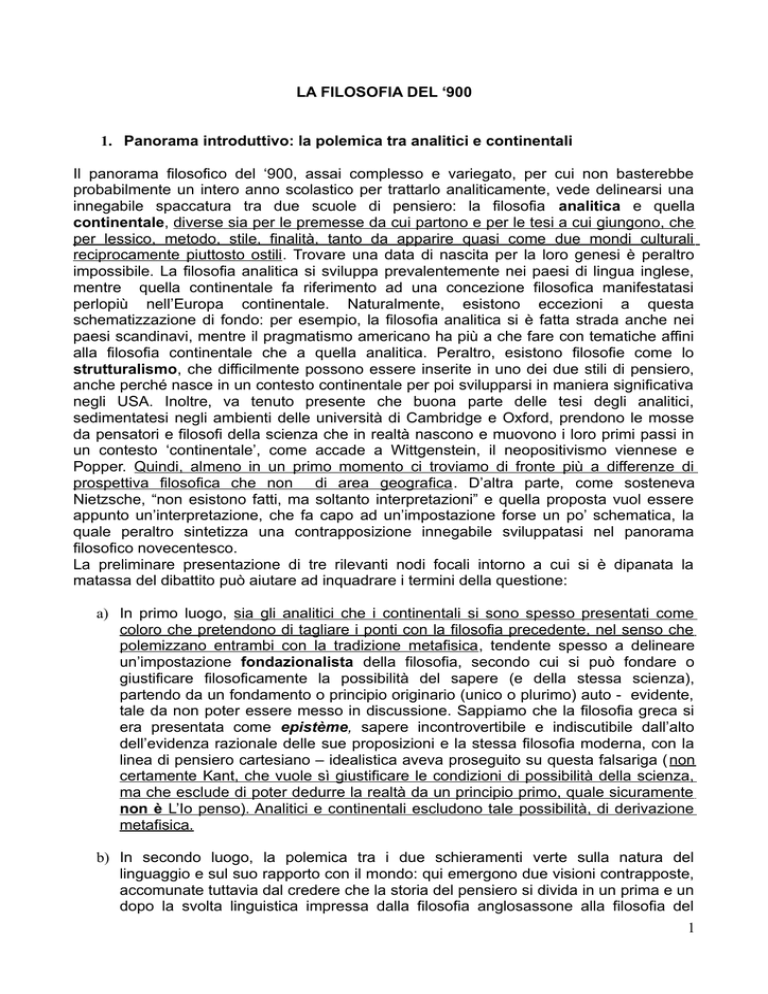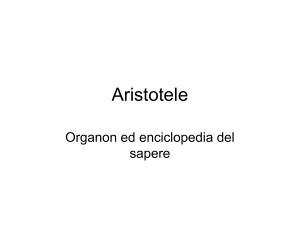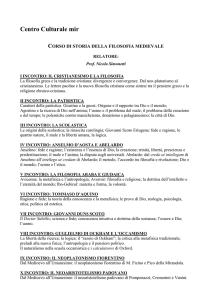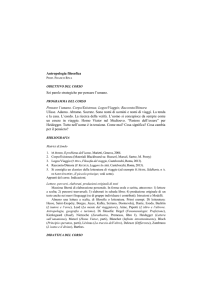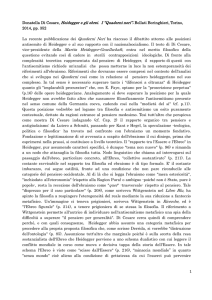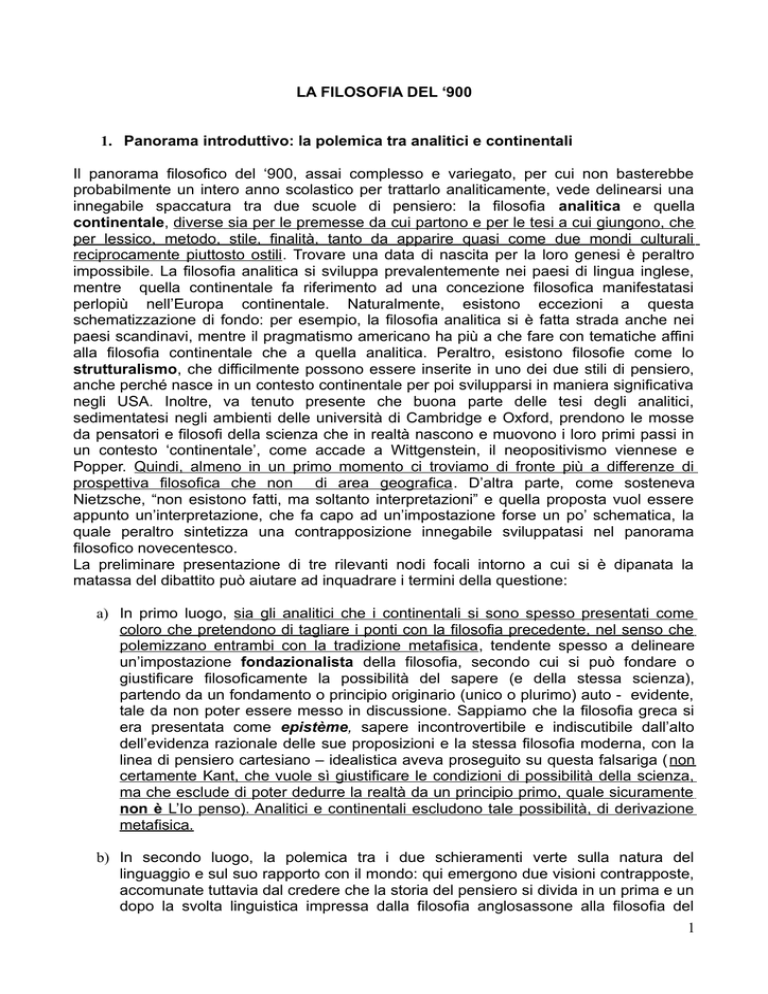
LA FILOSOFIA DEL ‘900
1. Panorama introduttivo: la polemica tra analitici e continentali
Il panorama filosofico del ‘900, assai complesso e variegato, per cui non basterebbe
probabilmente un intero anno scolastico per trattarlo analiticamente, vede delinearsi una
innegabile spaccatura tra due scuole di pensiero: la filosofia analitica e quella
continentale, diverse sia per le premesse da cui partono e per le tesi a cui giungono, che
per lessico, metodo, stile, finalità, tanto da apparire quasi come due mondi culturali
reciprocamente piuttosto ostili. Trovare una data di nascita per la loro genesi è peraltro
impossibile. La filosofia analitica si sviluppa prevalentemente nei paesi di lingua inglese,
mentre quella continentale fa riferimento ad una concezione filosofica manifestatasi
perlopiù nell’Europa continentale. Naturalmente, esistono eccezioni a questa
schematizzazione di fondo: per esempio, la filosofia analitica si è fatta strada anche nei
paesi scandinavi, mentre il pragmatismo americano ha più a che fare con tematiche affini
alla filosofia continentale che a quella analitica. Peraltro, esistono filosofie come lo
strutturalismo, che difficilmente possono essere inserite in uno dei due stili di pensiero,
anche perché nasce in un contesto continentale per poi svilupparsi in maniera significativa
negli USA. Inoltre, va tenuto presente che buona parte delle tesi degli analitici,
sedimentatesi negli ambienti delle università di Cambridge e Oxford, prendono le mosse
da pensatori e filosofi della scienza che in realtà nascono e muovono i loro primi passi in
un contesto ‘continentale’, come accade a Wittgenstein, il neopositivismo viennese e
Popper. Quindi, almeno in un primo momento ci troviamo di fronte più a differenze di
prospettiva filosofica che non di area geografica. D’altra parte, come sosteneva
Nietzsche, “non esistono fatti, ma soltanto interpretazioni” e quella proposta vuol essere
appunto un’interpretazione, che fa capo ad un’impostazione forse un po’ schematica, la
quale peraltro sintetizza una contrapposizione innegabile sviluppatasi nel panorama
filosofico novecentesco.
La preliminare presentazione di tre rilevanti nodi focali intorno a cui si è dipanata la
matassa del dibattito può aiutare ad inquadrare i termini della questione:
a) In primo luogo, sia gli analitici che i continentali si sono spesso presentati come
coloro che pretendono di tagliare i ponti con la filosofia precedente, nel senso che
polemizzano entrambi con la tradizione metafisica, tendente spesso a delineare
un’impostazione fondazionalista della filosofia, secondo cui si può fondare o
giustificare filosoficamente la possibilità del sapere (e della stessa scienza),
partendo da un fondamento o principio originario (unico o plurimo) auto - evidente,
tale da non poter essere messo in discussione. Sappiamo che la filosofia greca si
era presentata come epistème, sapere incontrovertibile e indiscutibile dall’alto
dell’evidenza razionale delle sue proposizioni e la stessa filosofia moderna, con la
linea di pensiero cartesiano – idealistica aveva proseguito su questa falsariga ( non
certamente Kant, che vuole sì giustificare le condizioni di possibilità della scienza,
ma che esclude di poter dedurre la realtà da un principio primo, quale sicuramente
non è L’Io penso). Analitici e continentali escludono tale possibilità, di derivazione
metafisica.
b) In secondo luogo, la polemica tra i due schieramenti verte sulla natura del
linguaggio e sul suo rapporto con il mondo: qui emergono due visioni contrapposte,
accomunate tuttavia dal credere che la storia del pensiero si divida in un prima e un
dopo la svolta linguistica impressa dalla filosofia anglosassone alla filosofia del
1
‘900, da un lato e per i continentali in un prima e un dopo la consapevolezza del
valore fondamentale dell’ermeneutica, atteggiamento culturale che sembra
contraddistinguere gli appartenenti a tale stile di pensiero. Naturalmente, tali
concetti saranno espressamente spiegati nel corso della trattazione.
c) In ultima analisi, tanto gli analitici quanto i continentali delineano un nuovo modo di
concepire e praticare l’argomentazione filosofica, per cui si fa strada l’idea secondo
cui la filosofia si presenta come meta - filosofia, ossia come un discorso filosofico
sulla filosofia stessa (una sorta di filosofia della filosofia).
Naturalmente, chi scrive è in questo contesto chiamato a fare della scelte. Perciò, si
tenga presente che la trattazione dei temi della filosofia analitica farà riferimento
alla filosofia del già citato Wittgenstein, del neopositivismo del Circolo di Vienna e
dell’epistemologia popperiana, da un lato; dall’altro, per quanto concerne i
continentali, rimandando in sede manualistica all’analisi dei caratteri fondamentali
dell’esistenzialismo, ci occuperemo qui del pensiero di Martin Heidegger.
2.a) Il ‘primo’ Wittgenstein
Il viennese Ludwig Wittgenstein (1889-1951), a lungo professore di filosofia al
Trinity College di Cambridge, lega la sua fortuna ad un testo destinato a fare epoca
nella filosofia della scienza del ‘900: il Tractatus logico – philosophicus (1921). Le
sue idee centrali sono le seguenti:
-
“Il mondo è tutto ciò che accade” (ossia, i fatti);
“Ciò che accade, il fatto, è l’esistenza dei fatti atomici”;
“La raffigurazione logica dei fatti è il pensiero”;
“Il pensiero è la proposizione esatta”;
“Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere”;
Ciò che Wittgenstein chiama pensiero o proposizione raffigura, rispecchia proiettivamente
la realtà. Con le nostre raffigurazioni ci rappresentiamo il mondo, per cui ad ogni elemento
costitutivo del reale ne corrisponde un altro nel pensiero. La realtà è costituita da fatti
atomici, composti a loro volta da oggetti semplici. Analogamente, il linguaggio è formato da
proposizioni complesse (molecolari), che si possono dividere in proposizioni o atomiche
(elementari) non ulteriormente scomponibili in altre proposizioni. Le proposizioni
elementari sono il corrispondente dei fatti atomici e sono combinazioni di nomi,
corrispondenti a loro volta ad oggetti. “Socrate è ateniese” è una proposizioni atomica, che
descrive il fatto atomico per cui Socrate è ateniese; “Socrate è ateniese e maestro di
Platone” è una proposizione molecolare, che riflette il fatto molecolare per cui Socrate è
ateniese e maestro di Platone. La proposizione atomica è la più piccola entità linguistica di
cui si può predicare il vero e il falso. Il fatto atomico è ciò che rende vera o falsa una
proposizione atomica. Il fatto molecolare è una combinazione di fatti atomici che rende
vera o falsa una proposizione molecolare.
In sintesi, queste sono le idee centrali del Tractatus. Naturalmente, l’unico criterio per
accertare se le proposizioni atomiche e molecolari siano vere o false è la verifica empirica,
ossia accertare, tramite l’esperienza, se i fatti da esse descritte esistano o no. Egli
presenta qui una concezione rigorosamente realistica del rapporto tra pensiero –
linguaggio - realtà. Tuttavia, Wittgenstein si rende conto che , sebbene quello della
scienza sia l’unico linguaggio che abbia senso in grado di rappresentare proiettivamente il
2
mondo, tuttavia al di là di esso c’è l’inesprimibile: “Non come il mondo sia, è ciò che è
mistico, ma che esso sia.” (prop. 6.44). E ancora:
“Il senso del mondo dev’essere fuori di esso. Nel mondo tutto è come è, e tutto avviene
come avviene; non v’è in esso alcun valore, né, se vi fosse, avrebbe un valore.” (prop.
6.41). “ Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche
abbiano avuto risposta, i nostri problemi vitali non sarebbero neppure toccati. Certo allora
non resta più domanda alcuna; e appunto questa è la risposta.” (prop. 6.52)
Indubbiamente, il Tractatus è stato uno dei libri di filosofia più influenti di tutto il XX secolo.
I neopositivisti in particolare, come vedremo tra poco, pur respingendone la parte ‘mistica’,
ne accettarono quella antimetafisica, assumendo l’idea di una filosofia come attività
chiarificatrice del linguaggio scientifico e non dottrina a se stante. Va tuttavia chiarito che
le differenze tra Wittgenstein e il neopositivismo sono notevoli. In una lettera all’editore von
Ficker del 1919, con cui il filosofo viennese stava trattando per la pubblicazione della sua
opera, Wittgenstein sostenne che il suo lavoro si divideva in due parti: “Di quello che ho
scritto, ed inoltre di quello che non ho scritto. E proprio questa seconda parte è quella
importante. Quello che non è scritto, quello che non è detto poiché non dicibile
scientificamente è la parte più importante: l’etica e la religione.”
Un Tractatus, dunque, che si divide in due parti, le quali si completano a vicenda: la prima
logica e filosofica, la seconda per così dire ‘mistica’. I neopositivisti non sepper
comprendere tutto ciò e bollarono come non senso la mistica di Wittgenstein, come fecero
con tutta la metafisica. In effetti, sia per l’influenza che ebbe sulla genesi del
Neopositivismo, che grazie all’introduzione che Bertrand Russell fece al Tractatus, tutta
una generazione di allievi poté vedere in quest’opera la Bibbia del neopositivismo. In
effetti, è innegabile che qualcosa in comune ci fosse: Wittgenstein aveva tracciato una
netta linea di demarcazione tra ciò di cui si può parlare (e il mondo si può descrivere
qualora se ne conoscano tutti i fatti atomici) e ciò di cui si deve tacere. Sia per il filosofo
viennese che per i Neopositivisti, come vedremo, la metafisica non ha senso, poiché
pretende di descrivere ciò che va al di là dei fatti empirici. Solo che per il neopositivismo
ciò di cui possiamo parlare è tutto ciò che conta nella vita. Per il filosofo viennese,
viceversa, tutto quello che conta nella vita è proprio ciò di cui, secondo lui, è necessario
tacere.
2.b) Il neopositivismo viennese
Ci possiamo chiedere il motivo per cui una filosofia della scienza come il neopositivismo
abbia trovato proprio a Vienna terreno fertile per potersi sviluppare. A tal fine, occorre
sapere che, a differenza della maggior parte delle altre università tedesche, Vienna si era
mantenuta, in virtù dell’influenza della Chiesa cattolica, sostanzialmente immune
dall’idealismo. Fu proprio la mentalità scolastica, oltre al prevalente orientamento politico
liberale della seconda metà dell’800 (figlio dell’illuminismo e dell’empirismo), a preparare il
campo per l’approccio logico alle questioni filosofiche. Tra i principali rappresentanti di
quello che passa alla storia con il nome di Circolo di Vienna, un gruppo di discussione
composto da vari studiosi che si riuniva il venerdì sera, vanno ricordati almeno Schlick,
Neurath e Carnap. Proprio gli ultimi due, insieme al matematico Hahn, pubblicarono nel
1929 il manifesto programmatico del Weiner Kreis: La concezione scientifica del mondo.
I concetti chiave di tale impostazione sono i seguenti:
a) Il principio di verificazione costituisce il criterio di distinzione tra proposizioni
sensate e insensate; tale principio è infatti il criterio di significanza delimitante la
sfera del linguaggio sensato dal linguaggio senza senso.
3
b) In base a tale presupposto, hanno senso unicamente le proposizioni in grado di
essere verificate a livello empirico o fattuale (ossia, le asserzioni delle scienze
empiriche.
c) Matematica e logica costituiscono complessi di tautologie, stipulate in modo
convenzionale e incapaci di dire alcunché sul mondo (come sostenuto dallo stesso
Wittgenstein);
d) Metafisica, etica e religione, non essendo costituite da concetti e proposizioni
empiricamente verificabili, sono questioni apparenti che si basano su
pseudoconcetti.
e) Il filosofo serio deve operare un’analisi della semantica (rapporto tra linguaggio e
realtà cui esso si riferisce) e della sintattica (relazioni dei segni di un linguaggio tra
di loro) di quello che è l’unico linguaggio significante, cioè il discorso scientifico.
f) Pertanto, la filosofia si configura come attività chiarificatrice del linguaggio
(scientifico) e non dottrina a sé.
Come già Wittgenstein aveva sostenuto, la maggior delle proposizioni espresse nella
storia Partendo da tali presupposti, Schlick paragonò i metafisici ad attori che recitano la
loro insulsa parte anche dopo che la platea si è svuotata. della filosofia non sono false, ma
semplicemente prive di senso. Carnap, da canto suo, sostenne che “i metafisici sono
musicisti senza talento musicale”: la metafisica sorge quando si accettano come
significanti termini che non hanno riferimento nell’esperienza e con tali termini (assoluto,
cosa in sé, sostanza) si producono frasi che pretendono di parlarci della realtà senza
poterlo. Alle riunioni del circolo il più radicale era sicuramente Neurath, il quale, durante la
lettura e la discussione del Tractatus di Wittgenstein, interrompeva spesso esclamando
“Metafisica”, irritando non poco Schlick. Hahn si pose come conciliatore, proponendo a
Neurath di dire solo ‘M’. Fu lo stesso Neurath, allora, a fare un’altra proposta: “Penso che
risparmieremmo tempo e fatica se dico ‘Non – M’ ogni volta che il gruppo non sta parlando
di metafisica”. Egli conduceva una autentica battaglia, come se si trattasse di andare
contro un nemico politico. Riguardo al principio di verificazione, aspetto fondamentale del
neopositivismo, due precisazioni sono di obbligo: in primo luogo, le proposizioni
metafisiche non sono false, ma prive di senso: falso è ciò che è smentito dall’esperienza,
insensato è ciò che non è verificabile; in secondo luogo, la verificabilità è di principio, non
di fatto: può darsi benissimo che una proposizione sia sensata e teoricamente verificabile,
ma che noi non possediamo i mezzi tecnici per verificarla in un determinato momento
storico. La proposizione “sull’altra faccia della luna esistono montagne alte 3000 metri” è
sensata, sebbene ci manchino i mezzi tecnici per verificarla. Pertanto, non ci sono fonti
accreditate di conoscenza oltre l’esperienza: non c’è nessun giudizio sintetico a priori e
nessuna intuizione. Le parole hanno un significato solo quando indicano qualcosa di
fattuale, le asserzioni hanno senso solo se esprimono un possibile stato di cose: solo se
saremo in grado di decidere in base ai dati empirici, sarà possibile trarci fuori “da
quell’inestricabile groviglio di problemi che è noto sotto il nome di filosofia”.
Tuttavia, le critiche al principio di verificazione non tardarono a farsi sentire. Soprattutto,
pareva di trovarci di fronte ad un dilemma: se il criterio è un’asserzione fattuale, allora non
è più una norma assoluta con cui giudicare il linguaggio come significante o non
significante; se la si vuole affermare come norma, si cade in un’ impasse, poiché la norma,
in base al suddetto principio, non ha senso (dal momento che va al di là di ciò che è
fattuale). Nel tentativo di superare le difficoltà di questa prima fase del Circolo di Vienna (la
cosiddetta fase semantica), Neurath prima e Carnap poi danno una direzione sintattica o
fisicalista al neopositivismo. E’ necessario porsi fin dall’inizio in una prospettiva in cui tutte
le proposizioni debbano risultare intersoggettive, quindi universalmente condivise.
4
A tal fine, il linguaggio non rappresenta fatti, ma è un fatto fisico, ossia un insieme di suoni
e di segni. La teoria della verità come corrispondenza tra una proposizione e un fatto,
ancora accettata dal primo Wittgenstein, è sostituita da quella della verità come coerenza
tra proposizioni. Una proposizione è corretta se si accorda con le altre accettate e
riconosciute nel contesto delle scienze, altrimenti non è corretta. Solo così sarà possibile
progettare un’enciclopedia delle scienze unificata, utilizzando l’unico linguaggio sensato,
quello delle scienze fisiche. Dal canto suo, Schlick mosse rilevanti obiezioni a tale deriva
fisicalista dei colleghi: tale posizione convenzionalista considera valido ogni linguaggio non
contraddittorio. Peraltro, questo non è sufficiente a rendere ragione della scienza, poiché
anche una favola ben congegnata può essere non contraddittoria, senza per questo
essere ritenuta scientifica. I convenzionalisti fuoriescono dall’empirismo, nel momento in
cui sembrano dimenticare che lo scopo delle parole è di occuparsi di cose diverse dalle
parole. La filosofia del ‘secondo Wittgenstein e l’epistemologia di Popper si porranno su
una strada decisamente diversa.
2.c) Il ‘secondo Wittgenstein: le Ricerche filosofiche
Se il pensiero del primo Wittgenstein aveva spronato il Circolo di Vienna alla formulazione
di un linguaggio rigorosamente universale e perfetto alla base della scienza, la svolta del
pensatore austriaco portò in un’altra direzione. Il contatto con il linguaggio reale dei
bambini delle scuole elementari, dove per alcuni anni egli svolse l’attività di maestro,
influenzò indubbiamente le ricerche di Wittgenstein, inducendolo a scrivere, tra il 1945 e il
1948 le Ricerche filosofiche, che elaborano la teoria dei giochi linguistici. Quando noi
parliamo ed elaboriamo proposizioni, con esse facciamo le cose più diverse. Basti pensare
alle esclamazioni ‘Acqua!’, ‘Ahi!’, ‘Aiuto’, ‘Bello’. I giochi linguistici che produciamo con il
linguaggio sono i più svariati e tale molteplicità non è fissa, ma passibile di dar luogo a
nuovi giochi linguistici. Se il linguaggio è un insieme di giochi di lingua, il significato di una
parola coincide con il suo uso. E l’uso ha delle regole, che si apprendono con
l’educazione. A questo punto dobbiamo chiederci: quando i filosofi usano certe parole,
tipiche del linguaggio metafisico, esse vengono mai effettivamente usate nel linguaggio
quotidiano? La filosofia costringe ad un uso univoco del linguaggio, adeguandolo
forzatamente a possibilità assai ristrette e creando crampi mentali. Quando viceversa la
filosofia diventa attività chiarificatrice del linguaggio, essa assume un ruolo terapeutico, è
cioè terapia delle malattie del linguaggio: deve mostrare, suggerire usi e possibilità a cui
non avevamo mai pensato, al di là delle prospettive anguste della filosofia tradizionale.
Descrivendo gli innumerevoli usi del linguaggio, la filosofia deve dissolvere i suoi falsi
problemi in cui per secoli si è aggrovigliata. “Qual è il tuo scopo in filosofia? Indicare alla
mosca la via di uscita dalla bottiglia.” Ciò che dà significato alle parole è l’uso che se ne fa
nel linguaggio comune: questo è il nuovo criterio di significanza, non più la verificabilità
empirica, ossia analizzare l’impiego che nei vari giochi linguistici viene fatto dei vari termini
per controllare se esso è effettivamente conforme all’uso comune.
5
2.d) L’epistemologia di Karl Popper (1902-1994)
Nella Logica della scoperta scientifica (1959), Popper rimprovera agli analisti del
linguaggio la falsa credenza che non ci siano genuini problemi filosofici o quanto meno, se
essi esistono, riguardano l’uso linguistico o il significato delle parole. Anziché preoccuparci
delle parole e del loro significato, prendiamo in esame le teorie, i ragionamenti e la loro
validità. Iniziamo dunque dal confrontarci con una teoria del ragionamento, l’induzione.
Ebbene, secondo Popper essa non esiste. Esistono due tipi di procedimento induttivo: la
prima è l’induzione ripetitiva (o per enumerazione), che si fonda su osservazioni
spesso ripetute, che dovrebbero fondare generalizzazioni alla base della teoria. In realtà,
nessun numero di osservazioni di cigni bianchi riesce a stabilire che tutti i cigni sono
bianchi. Allo stesso modo, per quanti spettri di atomi di idrogeno osserviamo, non saremo
mai in grado di stabilire che tutti gli atomi di idrogeno emettono spettri dello stesso genere.
Perciò, l’induzione per enumerazione non può fondare nulla. Il secondo tipo di induzione
usata è quella eliminatoria, fondata sul metodo dell’eliminazione o confutazione delle
false teorie. Bacone e Mill credevano che, eliminando tutte le teorie false, si possa far
valere la teoria vera. Non si rendevano però conto che il numero delle teorie rivali è
sempre potenzialmente infinito, sebbene in ogni momento particolare possiamo prendere
in esame soltanto un numero finito di teorie. “Il fatto che per ogni problema esiste sempre
un’infinità di soluzioni logicamente possibili è uno dei fatti decisivi di tutta la scienza; è una
delle cose che fanno della scienza un’avventura così eccitante. Esso infatti rende
inefficaci tutti i metodi basati sulla mera routine. Significa che, nella scienza, dobbiamo
usare l’immaginazione e idee ardite, anche se l’una e le altre devono sempre essere
temperate dalla critica e dai controlli più severi.”
In definitiva, il tentativo di basare l’induzione sull’esperienza fallisce, perché conduce
necessariamente ad un regresso all’infinito. Alla teoria dell’induzione è sempre stata
associata un’altra idea, il fatto che la mente sia tabula rasa. Questo aspetto, che Popper
definisce osservativismo, è in realtà un mito. Noi siamo invece tabula plena, una lavagna
piena di segni impressi in noi dalla tradizione o dall’evoluzione culturale. Un esperimento
presuppone sempre qualcosa da provare: questo qualcosa sono le ipotesi o congetture
che si inventano per risolvere problemi. La mente non può essere mai purgata da
pregiudizi e la ricerca dunque non parte mai da osservazioni, bensì da problemi, per
risolvere i quali c’è bisogno della creazione di idee nuove finalizzate alla risoluzione di quel
problema. Le idee scientifiche hanno le fonti più disparate: possono scaturire dal mito,
dalla metafisica, dal sogno, dalle emozioni; ciò che importa è che esse vengano provate di
fatto e, per poter essere tali, essere debbono essere controllabili di principio.
La ricerca inizia dunque dai problemi: essi esistono per essere risolti, sostiene Popper. E
per farlo, occorre inventare ipotesi che equivalgono a tentativi di risoluzione. Una volta
proposte, le ipotesi vanno provate. Ora, dato un problema P e una teoria T proposta come
soluzione, noi diciamo: se T è vera, allora dovranno darsi le conseguenze p1, p2, p3, …
pn; se ciò accade la teoria è confermata, in caso contrario essa è falsificata. “Io
ammetterò certamente come empirico o scientifico, soltanto un sistema che possa essere
controllato dall’esperienza. queste considerazioni suggeriscono che, come criterio di
demarcazione, non si deve prendere la verificabilità, ma la falsificabilità di un sistema. In
altre parole: da un sistema scientifico non esigerò che sia capace di essere scelto, in
senso positivo, una volta per tutte, ma esigerò che la sua forma logica sia tale che possa
essere messo in evidenza, per mezzo di controlli empirici, in senso negativo: un sistema
empirico deve poter essere confutato dall’esperienza”. Perciò, conclude Popper in
Congetture e confutazioni, “tutta la conoscenza scientifica è ipotetica e congetturale”. Se
da una teoria non è possibile estrarre conseguenze empiricamente controllabili (se non è
cioè falsificabile), essa non è scientifica. Può anche darsi che un’ipotesi metafisica possa
6
in futuro diventare scientifica, come è accaduto con l’atomismo di Democrito. In questa
concezione ipotetica e fallibilista della scienza, i controlli non si arresteranno mai: per
quante conferme una teoria possa aver ricevuto, essa non sarà mai certa, perché il
prossimo controllo può smentire la teoria. Mentre miliardi di conferme non rendono certa
una teoria, un solo fatto negativo può smentirla e falsificarla. Ma è proprio questa
asimmetria ad essere fondamentale: per quante conferme abbia ricevuto, una teoria resta
potenzialmente smentibile e allora bisogna tentare di falsificarla, perché prima si trova
l’errore, prima lo si potrà eliminare elaborando una teoria migliore della precedente. Sta
qui tutta l’importanza dell’errore nell’epistemologia popperiana.
A questo punto possiamo notare come la teoria della mente come tabula plena sembra
richiamare alla mente la tesi kantiana di una realtà strutturata dalle funzioni mentali del
nostro intelletto. Popper stesso ammette una certa affinità, affrettandosi tuttavia a
puntualizzare la propria differenza con la concezione di Kant: mentre per il filosofo di
Konigsberg gli schemi della mente sono necessariamente validi, in quanto la natura non
può contraddirli (di fatto la natura è da noi così percepita. Come è possibile? Sulla base
delle nostre strutture mentali disposte in un certo modo), secondo Popper essi sono pure
ipotesi che l’esperienza è sempre in grado di smentire, ossia congetture. Esse sono
certamente a priori, a livello logico e psicologico, ma non valide a priori dal punto di vista
gnoseologico. Secondo l’epistemologo viennese la scienza non è epistème, sapere
indiscutibile: la scienza non ha a che fare con la verità, ma con mere congetture. Egli
rifiuta il modello giustificazionista e fondazionalista del sapere: non crede che la scienza
abbia un fondamento certo che la filosofia avrebbe il compito di scoprire e legittimare
teoricamente; anzi, sostiene, tutte le filosofie fino ad oggi sono state giustificazioniste,
anche quelle che facevano riferimento allo scetticismo e all’irrazionalismo, perché, nel
momento in cui denunciano il fallimento della ricerca di simili presupposti, essi non
fuoriescono dalla questione della giustificazione del sapere. La nostra conoscenza è
problematica e incerta, e dunque fallibile e correggibile; il problema di come possiamo
giustificare la nostra conoscenza è privo di senso, poiché l’uomo non può accedere alla
verità, ma alla ricerca di essa, che è senza fine. Ecco spiegato il motivo per cui Popper
cita il non sapere socratico e lo stesso Einstein, quando sostiene l’incertezza del sapere
scientifico riguardante la realtà. L’errore è dunque pedagogicamente significativo ed è
parte integrante del sapere. Da qui la sua critica verso il marxismo e la psicanalisi, che
l’esperienza non può confutare: mentre la dottrina di Einstein ha un potere esplicativo
limitato, nel senso che non pretende di spiegare tutto, ed è aperta a possibili smentite, le
suddette teorie sono a maglie larghe, in quanto insufficientemente falsificabili. Anzi, i suoi
seguaci, invece di prendere atto della confutazione della realtà, scorgono in essa un
incessante flusso di conferme (quante volte la storia del ‘900 ha smentito le previsioni di
Marx? La stessa psicoanalisi, sulla base dei suoi concetti non empiricamente verificabili,
come inconscio, sublimazione, Super Io, può adattare a sé i più disparati comportamenti
umani e magari spiegarli in modo opposto a seconda dei vari tipi di teoria psicoanalitica,
facenti capo a Freud, Jung, Adler? Chi ha ragione? Non lo sapremo mai, perché
l’esperienza non sarà mai in grado di falsificarle).
Tre conclusioni sono a questo punto chiare: primo, il fatto che un asserto non sia
scientifico non è detto che sia insensato. I neopositivisti lanciarono accuse e insulti di ogni
genere alla metafisica, ma con il principio di verificazione reintrodussero la metafisica nella
scienza, visto che le leggi stesse di natura non sono verificabili in modo definitivo, ma solo
smentibili. D’altra parte, è innegabile come accanto a idee metafisiche che arrestarono il
cammino della scienza, ce ne sono state altre che lo hanno aiutato. Come se non
bastasse, la scoperta scientifica è impossibile senza la fede in idee di natura puramente
speculativa, che non sono scienza fino a quando non divengano controllabili. Secondo, in
Miseria dello storicismo Popper acuirà ulteriormente la sua critica verso il marxismo e tutte
7
quelle teorie di impianto olistico, per le quali sarebbe possibile cogliere la totalità di un
oggetto, di un evento, di un gruppo o di una società, e parallelamente trasformarla dal
punto di vista pratico – politico, proprio in quanto si ritiene di aver scoperto le ferree leggi
che governano la storia. Il metodo dialettico ne è un classico esempio. Secondo Popper, è
un grave errore metodologico ritenere che noi possiamo capire la totalità di un processo
dal più piccolo e magari insignificante pezzo di mondo, poiché tutte le teorie possono
cogliere soltanto aspetti selettivi della realtà e per principio sono infinite di numero e
falsificabili. Dal punto di vista operativo, l’olismo si traduce pericolosamente nell’utopismo,
in virtù della sua vocazione alla profezia storico – sociale e nel totalitarismo per quanto
concerne la prassi politica. Sappiamo bene come il filosofo viennese abbia indicato, ne La
società aperta e i suoi nemici, in Platone, Hegel e Marx i precursori del totalitarismo: la
loro impostazione è proprio di stampo olistico, totalizzante, pretendendo cioè di cogliere
ogni aspetto del reale. La giusta domanda politica non è tanto “chi deve comandare”,
quanto piuttosto “come è possibile controllare chi comanda e sostituirli senza spargimento
di sangue?”. Per questo il fallibilismo di Popper si riflette anche in ambito politico: egli è il
teorico della democrazia e della società aperta, da liberale progressista qual è: al metodo
rivoluzionario, definito di meccanica utopistica o di ingegneria olistica, egli contrappone
la tecnica sociale a spizzico, che prescrive interventi limitati e graduali, andando avanti
un passo alla volta, senza promettere paradisi che poi si rivelano inferni veri e propri,
senza porre fini assoluti, ma procedendo anche qui per via sperimentale, essendo disposti
a correggere mezzi e fini in base alle circostanze concrete e ai risultati ottenuti. Solo così
si riescono a controllare i mutamenti sociali evitando derive impreviste e pericolose,
mantenendo quel bene prezioso e sacro che è la libertà. Un metodo chiaramente
riformista.
In ultima analisi, è stato giustamente sostenuto che Popper sta ad Einstein come Kant sta
a Newton. Infatti, mentre il criticismo è la giustificazione teorica della scienza galileiano –
newtoniana, che come questione di fatto esso non mette in dubbio (la Critica della Ragion
pura ci presenta un universo deterministico e meccanicistico così come Newton lo aveva
descritto, al di là della differenza riguardo alla concezione del tempo e dello spazio), dal
canto suo la rivoluzione epistemologica di Popper risente di quella scientifica compiuta da
Einstein: il filosofo viennese rimase colpito dal fatto che lo scienziato avesse operato
previsioni rischiose, organizzate non in vista di facili conferme, ma di possibili smentite.
Sostenere che spazio e tempo non sono concetti assoluti, ma dipendenti dal sistema di
riferimento scelto dall’osservatore e che risultano tra di loro dipendenti o meglio
strettamente intrecciati in un’unica dimensione spazio – temporale non piatta ma curva,
come nelle geometrie euclidee, era tesi abbastanza azzardata agli inizi del secolo XX.
Eppure nessuna smentita ha finora falsificato la teoria della relatività di Einstein. Il nostro
universo è molto più complesso di quello sette – ottocentesco. A confermarlo è la stessa
rivoluzione della meccanica quantistica, secondo la quale la stessa causalità può essere
interpretata non più in senso deterministico, ma in termini rigorosamente probabilistici, in
virtù del principio di indeterminazione di Heisemberg: a livello subatomico non possiamo
determinare completamente lo stato di certi sistemi, perché lo stesso osservatore esercita
un’attività perturbatrice nei confronti dello stesso sistema. Anzi, a livello microscopico,
quanto più si conoscono le condizioni iniziali di un sistema, tanto meno se ne può
prevedere l’evoluzione. Pertanto, la modalità che io impiego per conoscere le condizioni
del sistema già lo modifica, incidendo sul suo futuro: se io posso conoscere con certezza
ad esempio la velocità dell’elettrone, ciò sarà possibile solo a discapito di altri parametri,
come la sua posizione, che potrò conoscere solo in termini di probabilità. Le grandezze di
un sistema non possono mai essere così espresse tramite valori ben definiti e tale
incertezza ontologica è presupposto fondamentale per comprendere la filosofia della
scienza del ‘900, in modo particolare l’epistemologia popperiana.
8
3.a) Il ‘primo Heidegger’: Essere e tempo
Martin Heidegger (1889-1976) è ritenuto uno dei maggiori filosofi del ‘900. Sicuramente è
una figura di spicco del cosiddetti ‘continentali’, poiché elabora quel metodo ‘storico –
ermeneutico’ che prepara la strada a significative teorie e indirizzi di pensiero come la
Scuola di Francoforte e l’ermeneutica. Nel suo capolavoro Essere e tempo (1927)
Heidegger pone, sin dalla prima fase del suo pensiero, la questione dell’essere. L’analitica
esistenziale di Essere e tempo è il tentativo di porsi una domanda fondamentale: “Presso
quale ente deve venir carpito il senso dell’essere?”. L’analitica esistenziale è l’analisi
interpretativa operata dall’uomo sul fondamentale senso del suo essere e di quello del
mondo circostante. Ora, il problema dell’essere coincide con quello del manifestarsi e
dell’apparire degli enti. E l’apparire e manifestarsi degli enti è in relazione all’attività
e alla prassi umana, attuata cioè dall’uomo. Pertanto, una corretta impostazione del
problema del senso dell’essere richiede un’esplicitazione di ciò che è l’uomo, che
Heidegger chiama con il termine Dasein (Esserci). Considerato nel suo modo di essere,
l’uomo è Da – sein, esser – ci: il ci (da) sta ad indicare l’esperienza che l’uomo ha
dell’essere, il fatto che l’uomo è sempre in situazione, gettato in essa, in rapporto attivo
con il mondo: egli è sostanzialmente apertura verso gli altri e verso le cose. L’esser gettato
dell’Esserci da un lato ha una valenza negativa, ossia essere gettato nelle situazioni del
mondo e nei condizionamenti della vita, ma dall’altro ne ha una positiva, nel senso che
l’uomo non può mai essere qualcosa di determinato, ma può solo aver – da – essere,
senza alcuna provenienza e alcuna finalità che sia altro dal proprio nudo esistere. In
questo senso, egli è privo di fondamento, di un perché e di una finalità che sia alla base
delle sue azioni. L’esistenza è così pervasa da una negatività strutturale, sia nel senso che
individua la nullità del nostro esser – fondamento, sia in quanto il progettare certe
possibilità ne esclude automaticamente altre. L’Esserci, oltre a porsi la domanda sul senso
dell’essere, è quell’ente che non si lascia ridurre alla nozione di essere, accettata dalla
filosofia occidentale, che identifica l’essere con l’oggettività, o come dice Heidegger con la
semplice presenza. Le cose, pur essendo diverse le une dalle altre, sono tutte oggetti
davanti a me: è questo esser presente il tratto fondamentale che la filosofia occidentale ha
visto nell’essere, per cui quello dei Greci (e di tutta la filosofia occidentale) è l’essere della
presenza, a cui la metafisica ha imposto significati differenti. Tuttavia, l’uomo non può
ridursi a mero oggetto nel mondo: l’Esserci non è mai semplice presenza, perché esso è
proprio quell’ente per cui le cose ci sono, sono presenti. Perciò, ancor prima di percepire
direttamente gli oggetti nel loro esser presenti alla nostra coscienza (in senso
teoretico – gnoseologico), l’uomo li usa, si prende cura di essi: allora esistere
significa innanzitutto attuare possibilità di agire: la prassi precede la conoscenza.
Fenomeno è così non solo ciò che si manifesta alla mia percezione di soggetto, ma anche
(e soprattutto) ciò che rimane assente e che, in qualche modo, non si manifesta (nel
senso che nel fare i miei gesti quotidiani di utilizzo delle cose o nel mio rapporto con gli
altri, il percepirli e il rendermi conto di questo processo può essere secondario al mio
entrare in rapporto pratico con essi). Pur essendo nuovo il contesto, la tesi non lo è: che la
prassi preceda la conoscenza è concetto che deriva da buona parte della filosofia
ottocentesca, da Marx, Kierkegaard e lo stesso Nietzsche.
Nel cercare il senso dell’essere la ricerca si imbatte nel concetto di differenza
ontologica, dove l’essere dell’Esserci, che esce fuori di sé, in quanto trascendenza, esser
gettato nel mondo, progetto, è abissalmente diverso rispetto all’ente come essere della
presenza, cioè come oggetto. Il modo di essere dell’Esserci è la sua esistenza, ed essa è
data, come già sostenne Kierkegaard, dalla possibilità, nel senso di possibilità da attuare.
Ogni singolo Esserci decide della sua esistenza e di conseguenza l’uomo può scegliersi,
può cioè conquistarsi o perdersi. L’esistenza è dunque poter – essere, non un mero
9
oggetto o esser – presente. E poter essere vuol dire progettare, trascendenza, nel senso
di oltrepassamento. L’uomo è progetto e le cose del mondo originariamente utensili in
funzione del suo progettare. Utilizzando le cose, egli trasforma il mondo e se stesso. Egli è
progetto, interpretazione della rete di significati in cui è immerso il mondo. Heidegger usa
qui il termine cura (Sorge), con cui indica la totalità delle strutture dell’Esserci, sia
autentiche che inautentiche. Il mondo è la totalità dei rimandi e dei significati tra gli
esistenziali che lo compongono: noi, le cose e gli altri. L’essere nel mondo implica un
rapporto di utilizzabilità fra i suoi ospiti, in una rete o catena strumentale di rimandi
continui.
Esistono due fondamentali modalità di esistenza per ognuno di noi: l’esistenza autentica e
quella inautentica. Quest’ultima riguarda il rivolgersi, da parte dell’Esserci, al piano
ontico o esistentivo, ossia il piano degli enti nella loro attualità o semplice presenza. In
tale contesto, qualunque progetto l’uomo attui si riduce ad un utilizzare le cose che si
ritorce contro di lui e lo rigettano a livello di fatto, anche nei rapporto sociali. Il linguaggio
stesso si trasforma nell’esistenza anonima della chiacchiera, nel senso che “la cosa sta
così perché così si dice”. Chiacchiera, curiosità fine a se stessa, equivoco: queste sono le
dimensioni dell’esistenza in autentica: è l’esistenza del si dice e si fa.
L’analitica esistenziale rivela che l’esistenza anonima è un poter essere dell’uomo e alla
base di tale possibilità c’è la deiezione, vale a dire la caduta dell’uomo sul piano delle
cose del mondo. La voce della coscienza, peraltro, può indurre l’uomo a distogliersi dalla
cura verso gli enti e a porsi non più sul piano ontico o esistentivo, ma su quello ontologico
o esistenziale, dove egli ricerca il senso dell’essere degli enti, cioè il senso del loro
esistere.
Per Heidegger, la stessa descrizione degli oggetti effettuata dalla scienza è di carattere
ontico; viceversa il discorso sul senso dell’essere e della stessa scienza è ontologico.
D’altra parte, i progetti e le scelte dell’uomo sono tutti equivalenti: io posso essere uomo
sia scegliendo un possibilità sia scegliendone un’altra. Quando considera ultima e
definitiva una di queste scelte o possibilità, l’uomo si disperde in un’esistenza inautentica.
Qui rischiamo di trovarci di fronte ad un vicolo cieco: l’esserci da un lato è totalità, nel
senso che esso, pur essendo sostanzialmente ex – sistere, uscir fuori dal nulla ed esser
gettato nel mondo, non è uno dei due poli di rapporto con il mondo stesso (non c’è un
esserci come soggetto - res cogitans e un mondo come res extensa, come in una
prospettiva gnoseologica); l’Esserci è la globalità di questo stesso rapporto con le cose e
con gli altri, è costitutivamente Essere- nel -mondo ed Essere -con -gli altri. Il rapporto
dell’uomo con il mondo non è assimilabile alla tradizionale relazione soggetto – oggetto
della filosofia moderna, poiché l’uomo non è il soggetto cartesiano confinato nel giro delle
proprie rappresentazioni: egli esiste solo come apertura al mondo, che a sua volta è il
piano globale di utilizzabilità di oggetti che esistono come strumenti del suo agire.
Dall’altro lato, l’Esserci è un ente che manca sempre costitutivamente di qualcosa (cioè è
sempre un aver –da –essere). Non vi è qui una contraddizione? No, perché secondo
Heidegger questo esser mancante dell’Esserci costituisce al tempo stesso la sua totalità
ontologica, per cui il mancare è l’unica forma definitiva e compiuta di esistenza
dell’Esserci. Secondo il filosofo di Messkirch, l’essere dell’uomo non è già dato una volta
per tutte, ma consiste nel pervenire a se stesso, nell’appropriarsi di sé. Tra le varie
possibilità, ve n’è una a cui nessuno può sfuggire: la morte. L’uomo può decidersi per una
strada anziché per un’altra, ma non può evitare di morire. Finché c’è l’esistenza, la morte è
una possibilità permanente ed essa è la possibilità che tutte le altre possibilità divengano
impossibili, e la fine di ogni progetto. La voce della coscienza ci richiama al senso della
morte e svela la nullità di ogni progetto di fronte ad essa. Se in relazione alla morte, alla
possibilità della morte, tutte le altre singole situazioni appaiono impossibili, il pensiero della
morte proibisce di fissarci su una situazione, mostrando la nullità di ogni progetto e fonda
10
così la storicità dell’esistenza. L’esistenza autentica è perciò un essere per la morte.
La voce della coscienza è la chiamata del poter essere che risveglia l’esserci al proprio sé
e lo rende consapevole che il fondamento stesso dell’esserci è un ‘non’, è nullità, assenza
di fondamento. Dando ascolto a questa chiamata, l’esserci assume l’angosciosa libertà
per la morte come una decisione anticipatrice: solo essendo consapevole di questa sua
radicale nullità, che anticipa la morte, solo comprendendo che, in quanto gettato da
sempre nel mondo, l’Esserci è già da sempre consegnato alla morte, l’uomo capisce fino
in fondo il proprio destino. La morte non sopravviene mai all’Esserci dall’esterno, perché
essa è nell’essere, nella natura stessa dell’uomo. Essa è l’origine che viene dal futuro, la
direzione dell’esistenza, la verità originaria dell’Esserci. L’uomo va verso la morte come la
freccia è diretta verso il bersaglio e per questo filosofare è, in fondo, imparare a morire,
come già Platone, in un senso molto diverso, aveva affermato. Heidegger cita un antico
proverbio boemo, secondo cui “l’uomo, appena nato, è già abbastanza vecchio per
morire”.
Quando l’uomo accetta la morte come possibilità incondizionata e insormontabile, egli fa
esperienza dell’angoscia, che già Kierkegaard aveva definito la vertigine della libertà:
l’angoscia rivela all’uomo la presenza del nulla. Essa non va confusa con la paura; infatti si
ha paura di qualcosa e questo stato trova cittadinanza quando l’uomo si prende cura di
enti intramondani. Viceversa, ci si angoscia di niente. L’uomo si angoscia davanti al nulla,
al nulla di senso, cioè al non senso dei progetti umani e della stessa esistenza. Esistere
autenticamente significa guardare il faccia alla possibilità del proprio non essere, di sentire
l’angoscia del proprio essere per la morte, di accettare la propria finitezza, mentre
l’esistenza anonima e banale, che vive nel Si impersonale, non ha questo coraggio (a
scanso di equivoci, si noti che qui Heidegger non critica in senso moralistico l’esistenza in
autentica, ma fedele alla sua analitica esistenziale, si limita semplicemente a prendere atto
e a descrivere le strutture dell’Esserci e del suo Essere nel mondo). Di fronte a tali
prospettive muta anche la concezione del tempo: il tempo inautentico si caratterizza per la
preoccupazione per il successo, per l’attenzione alla riuscita e rimanda all’esistenza
gettata tra le cose del mondo. Qui l’uomo che affonda nel Si impersonale rimane perduto
nell’ente presso cui di volta in volta è affaccendato. E’ questo il significato del tempo usato
nel pensiero comune e nella scienza. Il tempo autentico è quello in cui l’uomo vive
un’esistenza angosciata, che vede l’insignificanza di ogni progetto e fine umano, che
rende equivalenti tutti i progetti. L’uomo che vive autenticamente continua a vivere la vita
banale del suo tempo, giacché non può farne a meno, ma lo fa con tutto il distacco tipico
di chi ha avuto, attraverso l’esperienza anticipatrice della morte, la rivelazione del nulla dei
progetti umani e dell’esistenza umana.
Va detto, a scanso di equivoci, che precorrere la morte non vuol dire anticiparla come
realtà, con il suicidio oppure attendere il momento del decesso e prepararsi a tale evento:
se posta in atto, la morte si annullerebbe come possibilità. Precorrere la morte significa
mantenersi costantemente nell’imminenza della morte, un’imminenza che sovrasta, dice
Heidegger, come possibilità radicale. Solo così l’esserci si apre all’autentica comprensione
delle concrete possibilità offerte dalla vita, per sceglierle responsabilmente senza subirle in
modo passivo, banale e ripetitivo. Prendersi cura di sé e degli enti del mondo (compresi gli
altri) implica l’unificazione delle tre dimensioni temporali. Se l’uomo vive un’esistenza in
autentica, non è in grado di comprendere la stretta connessione tra le tre dimensioni
temporali: il passato è un essere – già – in, un essere gettato che ci inchioda al passato e
ci porta a subire gli eventi e ad accettare passivamente la tradizione che ci ha reso ciò
che siamo; il presente è un essere – presso , è deiezione che radica l’esserci nel
prendersi cura delle cose affannandosi banalmente e confusamente in esse, nella
dimensione della già ricordata esistenza impersonale, dove si è assorbiti senza requie
nelle cose da fare; il futuro è essere – avanti – a sé, progetto, che coincide con un
11
protendere verso la bulimica attesa del successo fine a se stesso. Viceversa, esistere
autenticamente implica vivere in modo pieno anche la temporalità non certo come strutture
tra di loro giustapposte e appiccicate una dopo l’altra: qui passato, presente e futuro
esistono solo nella loro relazione reciproca. Il tempo dell’esistenza autentica è l’unità del
suo destino e appropriarsi del proprio destino significa decidere di progettare il futuro a
partire dal passato. Il tempo è la struttura della possibilità che costituisce l’essenza più
piena dell’Esserci: “La temporalità rende possibile l’unità dell’esistenza (…) e costituisce la
totalità originaria della struttura della Cura. I momenti della cura non stanno assieme per
giustapposizione, allo stesso modo che la temporalità non risulta dalla somma ‘temporale’
di avvenire, essere stato e presente. La temporalità non è assolutamente un ente. Essa
non è, ma si temporalizza (…) nelle diverse modalità che sono proprie di essa”.
In definitiva, L’Esserci è tempo, e la temporalità è ciò che rende possibile l’Esserci nella
totalità delle sue determinazioni strutturali. Storicità autentica è assumere il proprio
destino, farlo proprio, dove destino è lo storicizzarsi originario dell’Esserci, l’atto con cui
l’uomo tramanda se stesso in una possibilità ereditata e tuttavia scelta.
Nella storicità inautentica, al contrario, L’Esserci “attento alle novità immediate, ha già
dimenticato l’antico. Il Si (l’esistenza anonima) rifugge dalla scelta. Cieco nei confronti
delle possibilità, non è in grado di ripetere l’essente – stato; si sofferma e si mantiene
presso le briciole di realtà vaganti nel mondanamente storico, presso le opinioni e le
informazioni prevalenti. Perduto nella presentazione dell’oggi, esso comprende il passato
a partire dal presente (…). L’esistenza inautenticamente storica, oppressa dal peso del
passato, per essa inconoscibile, non va in cerca che del moderno.”
3.b) Il ‘secondo Heidegger’
Dagli anni ’30 in poi Heidegger sviluppa ulteriormente il suo pensiero, sebbene la maggior
parte di questi scritti sarà pubblicata solo tra il 1943 e il secondo dopoguerra. Sui motivi di
questa svolta si è scritto molto. Noi qui ci limitiamo a ricordare l’adesione di Heidegger nel
1933 al nazismo, scelta politica che, anziché figlia di convinta adesione ideologica, è frutto
di una clamorosa illusione, piuttosto ricorrente nella storia della filosofia: il fatto che la
cultura possa servirsi della dittatura come di uno strumento, più efficace di altre forme di
governo, per condurre la filosofia al potere e rendere più razionale la stessa vita politica e
la sua fondazione. Egli manifestò, indubbiamente, poca intelligenza politica e scarso
senso di lungimiranza. Ben presto si rese conto dell’errore e il nazismo puntò a ridurlo al
silenzio a livello politico. Il problema è che Heidegger non rinnegò mai quell’esperienza
facendo autocritica: fu questo che lo pose nella condizione di essere interdetto
dall’insegnamento nell’immediato secondo dopoguerra, nel 1946, salvo essere poi
riabilitato pochi anni dopo (1951). E’ proprio a seguito di tale esperienza, che egli rimette
in discussione il rapporto tra attività umana e verità. Sul senso effettivo di questa svolta, la
domanda che molti interpreti si sono posti è la seguente: gli scritti posteriori a Essere e
tempo costituiscono una effettiva svolta (Kehre) nella filosofia heideggeriana o ne sono la
logica continuazione? Per rispondere a tale domanda, certo di per sé decisamente
complessa, occorre notare come Essere e tempo sia un’opera incompiuta: la terza
sezione del testo in questione, che avrebbe dovuto compiere l’ultimo sforzo della ricerca,
ossia il passaggio dalla temporalità dell’esistenza al senso temporale dell’essere in
generale, non è stata più pubblicata. Tale interruzione non è certo casuale e denota un
problema irrisolto, di cui Heidegger si rende conto: per giungere ad un’ontologia universale
che indaghi il senso dell’essere in generale, egli ha intrapreso la strada preliminare di
un’analitica esistenziale, cioè un’ermeneutica dell’ esserci; tuttavia, nel cercare il senso
dell’essere, se restiamo nell’ambito dell’analitica esistenziale, cioè dal punto di vista
12
dell’esserci che si pone la questione dell’essere, non possiamo andare oltre e tentare di
progredire nella questione dell’Essere.
Del resto, l’analitica esistenziale, nell’intento di Heidegger, non va scambiata per una
filosofia esistenzialistica, imperniata sul soggetto: infatti, mentre l’esistenzialismo si
impegna a descrivere la struttura costitutiva dell’essere umano, l’analitica esistenziale ha
un unico obiettivo: interpretare il senso dell’esserci in generale e si presenta dunque come
ontologia che si pone la fondamentale domanda sull’essere. Perciò, se apparentemente
Essere e tempo ha in comune con l’esistenzialismo molti concetti, tuttavia la prospettiva di
fondo all’interno della quale si muove è decisamente diversa. Heidegger ad un certo punto
si rende conto che il concetto di esserci, in altre parole di umanità, è del tutto inadeguato a
cogliere l’ambito ontologico entro cui si muove il senso dell’essere e dello stesso ente –
uomo. La prima soluzione che Heidegger ha dato al problema della differenza ontologica è
quindi inadeguato: il problema della differenza tra l’essere e l’ente consiste
nell’attribuire all’uomo la facoltà di attuare questa differenza, ossia è in virtù della
prassi umana che noi ci rendiamo conto che l’essere dell’ente come trascendenza e
progetto è radicalmente altro dall’ente considerato come pura presenza. Senonché, il
filosofo tedesco ribalta, a partire dalla metà degli anni Trenta, questa soluzione. Da ora in
poi la differenza ontologica non sarà più svelata e concepita attraverso il prodotto di
un’attività umana, bensì come un accadimento (Ereignis) di cui né l’uomo né i
singoli enti possono esser causa. La Lettera sull’umanismo del 1947 è indicativa al
riguardo: rispondendo ad una domanda postagli da Jean Baufret su come ridare senso
alla parola umanismo, avvertita come pressante soprattutto nel contesto del secondo
dopoguerra, Heidegger sostiene: “ogni umanismo o si fonda su una metafisica o pone se
stesso a fondamento di una metafisica del genere. E’ metafisica ogni determinazione
dell’essenza dell’uomo che già presuppone, sapendolo o non sapendolo, l’interpretazione
dell’ente, senza porre il problema della verità dell’essere.”
Cosa significa porre il problema della verità dell’essere? In Essere e tempo l’esserci, pur
ponendo la questione dell’essere, ha finito per ricadere in una impostazione metafisica e
tale opera è risultata incompiuta proprio in quanto esprimendosi nel linguaggio metafisico,
l’unico peraltro disponibile, non riusciva a cogliere la verità dell’essere. L’uomo, come egli
ha sostenuto in Kant e il problema della metafisica (1929), è il luogotenente del nulla,
poiché solo nell’angoscia di fronte al nulla si apre la dimensione per cui in noi possa
nascere la domanda stupita (che già Leibniz si era posto): “perché è in generale l’ente e
non piuttosto il nulla?”. La metafisica occidentale (e in parte il primo Heidegger) ha
cercato il senso dell’essere indagando gli enti, identificando l’essere con l’oggettività, cioè
con la semplice presenza degli enti. L’importanza di Essere e tempo è, potremmo dire, di
carattere ‘negativo’, poiché ha chiaramente mostrato (di qui il suo essere un testo
incompiuto) come sia impossibile porsi adeguatamente la domanda sull’essere se si resta
nel punto di vista dell’esserci, cioè dell’uomo. Per questo motivo nella Lettera
sull’umanismo Heidegger afferma la necessità di un rovesciamento della questione
dell’essere, così come essa è stata impostata in Essere e tempo. Con ciò, egli non vuole
abbandonare l’originario interesse ontologico, ma, mentre prima pensava l’uomo nel
suo rapportarsi all’essere, ora pensa l’essere e la sua verità in rapporto all’uomo. Ne
La dottrina platonica della verità (pubblicata nel 1942, ma risalente ai primi anni ’30),
Heidegger vede in Platone il primo responsabile di quel processo per cui la metafisica è
stata ridotta a fisica: con lui la metafisica ha smarrito il senso autentico dell’essere,
concependolo come oggetto e cioè come ente, separato e perciò altro dal pensiero, il
quale, ingabbiando l’essere e sottoponendolo ai suoi schemi, imponendogli le sue
categorie e i suoi valori, ha sostanzialmente dimenticato, occultato il senso autentico
dell’essere. L’essere in realtà non è l’ente, a cui lo ha ridotto la metafisica ma qualcosa di
abissalmente diverso da esso (si ripropone qui il concetto di differenza ontologica, in
13
termini diversi dalla prima fase). L’essere non può essere pensato sul modello degli enti,
poiché ne costituisce l’orizzonte all’interno del quale essi si manifestano. La verità
ontologica, ossia la comprensione dell’essere, precede e fonda per Heidegger la
verità ontica, cioè la conoscenza degli enti.
Non concependo il reale significato della differenza ontologica, la metafisica ha condotto
all’oblio dell’essere, alla dimenticanza del suo significato originario, che solo i cosiddetti
pensatori aurorali (Anassimandro, Eraclito, Parmenide) avevano intravisto. Essi, infatti (qui
sta il punto chiave) avevano concepito la verità non come adeguamento del pensiero
all’essere (un adeguamento del tutto apparente, poiché è il pensiero, ribadiamo, ad aver
imposto la sue strutture logiche ed etiche all’essere, trasformandolo in ente), bensì come
dis – velamento dell’Essere, come testimonia l’etimologia di Alétheia (che vuol dire
appunto disvelamento o non nascondimento). Platone ha capovolto i termini della
questione, fondando l’essere sulla verità del pensiero che lo giudica e lo finitizza. La
metafisica, così, si pone nel modo sbagliato la questione dell’essere e ne oblia il senso
più profondo. La dimenticanza del senso autentico dell’essere e quindi della differenza tra
essere ed ente è una sorta di oblio al quadrato, un oblio dell’oblio: la metafisica non solo
conduce a questo itinerario, ma ne resta fondamentalmente inconsapevole. Da qui in poi
la metafisica è stata onto – teo – logia, ossia unità inscindibile di ontologia (interessata al
fondamento dell’ente, cioè all’ente in quanto ente), teologia (facendo dipendere tutti gli enti
da quell’ente supremo che è Dio), logica (poiché ha pensato l’ente in riferimento alla
ragione, instaurando il predominio del pensiero sull’essere, approccio che ha in Hegel il
suo culmine). La metafisica occidentale trova il suo culmine ed inveramento nel pensatore
apparentemente più insospettabile: Nietzsche (“ il platonico più sfrenato” lo definisce
Heidegger), la cui filosofia, lungi dall’essere la distruzione della tradizione metafisica, è in
realtà l’ultima metafisica della storia. Egli infatti, riducendo l’essere a volontà di potenza,
non ha fatto altro che portare all’ennesima potenza l’oblio del senso dell’essere, ovvero la
tendenza occidentale a fare dell’uomo la regola o misura delle cose. Conducendo alla
dimenticanza più abissale dell’essere in favore dell’ente, la metafisica occidentale è
l’essenza stessa del nichilismo, e la sua è storia del nichilismo, poiché con tale approccio
dell’essere non ne è niente.
Qual è, si chiede Heidegger, il punto più alto, la manifestazione più significativa della
volontà di potenza e di dominio della civiltà occidentale? Sicuramente, la tecnica. Ne La
questione della tecnica (1949) egli sostiene che essa porta a compimento proprio quella
volontà di dominio con cui è iniziata, da Platone in poi, la storia della metafisica: poco
importa che tale volontà di dominio sia intellettuale nei filosofi e materiale nella tecnica,
poiché il presupposto è lo stesso, cioè asservire l’ente alla volontà, alla manipolabilità
umana. Per descrivere l’essenza della tecnica moderna, Heidegger usa il termine Gestell
(che Volpi traduce con impianto e Vattimo con imposizione). Mentre la tecnica antica si
limitava a favorire l’opera della natura, la tecnica moderna non si dispiega nella mera
forma della pro – duzione, ma in quella della pro – vocazione, traendo fuori dalla natura
energia da accumulare e da impiegare. Nell’ambito della tecnica, tutto si allinea
nell’orizzonte dell’utilizzabilità e dell’ordinabilità. Nessun oggetto è più neutro, ma asservito
alla volontà di dominio. Il Gestell, l’impianto, è la totalità del porre tecnico che costringe
le cose ad essere fruibili e manipolabili. I vari modi di questo porre (Stellen), che in
tedesco risultano strettamente collegati anche a livello linguistico, sono il rappresentare
(Vortstellen), il produrre (Herstellen), il disporre (Bestellen). In esso alberga un grave
pericolo, che non proviene tanto dagli effetti mortali che possono avere le macchine, ma
dal fatto che, a causa dell’essenza nichilistica della tecnica, l’essenza dell’uomo e della
verità possono andare smarriti. In ogni caso, a scanso di equivoci, l’uomo non ha alcun
potere sulla tecnica: essa non è il risultato di una macchinazione umana.
14
Allora, guardiamo di chiarire meglio, a questo punto, cosa intende Heidegger per Essere e
per disvelamento dello stesso, poiché qui sta l’autentica portata della cosiddetta ‘svolta’
heideggeriana. L’Essere non è un ente e nemmeno l’ente privilegiato, ma ciò che entifica
ogni ente, ciò che gli permette di essere e lo rende visibile, manifesto . L’Essere è
disvelamento, come abbiamo ricordato in precedenza, è svelatezza che accade, è
l’orizzonte o radura (Lichtung), al cui interno gli enti divengono manifesti. Radura vuol dire
luogo che si dirada a poco a poco e si apre alla luce. Lichtung, cui corrisponde la forma
italiana arcaica ‘chiarità’, ha in sé sia il significato di ‘chiaro’ che quello di ‘rado’: è lo
schiudersi di una chiusura, l’illuminarsi di una zona d’ombra. Heidegger usa tale termine
per indicare il carattere chiaroscurale della verità. L’accadere dei diversi mondi storici
costituisce la storia dell’Essere, che è la storia del suo donarsi all’ente (e all’uomo stesso)
e al contempo del suo celarsi, del suo nascondersi. L’essere, insomma, non si disvela mai
completamente e ogni epoca della storia dell’Essere è segnata da una sospensione
(epoché in greco) della rivelazione dell’essere: pertanto, il destino dell’Essere è tutt’uno
con il suo assentarsi. Sarà chiaro, allora, come la comprensione dell’essere, per quanto
esplicita e consapevole possa risultare all’uomo, apre ogni possibile altra comprensione e
il rapporto con le cose e il mondo che ci circonda.
Ciò significa anche che l’Essere non è una presenza statica o una struttura immutabile,
bensì un accadere storico, ossia un Evento (Ereignis) che si dà (Es gibt) agli enti e
all’uomo stesso in destini e linguaggi via via differenti. La differenza netta con la prima
fase è che, mentre in essa la storicità era fondamentalmente umana, adesso la storia
dell’uomo ha senso solo se si iscrive nel contesto della storia dell’Essere come Evento.
L’Essere, la cui manifestazione privilegiata è il linguaggio, come vedremo tra poco, non
coincide puramente con le varie epoche (quella heideggeriana non è una impostazione
meramente storicistica), ma è ciò che apre e istituisce le varie epoche della storia. “Das
Ereignis ereignet”, dice Heidegger, “l’evento eventualizza”, cioè ‘fa accadere’, permette
l’accadere degli eventi storici non riducendosi puramente ad essi (non a caso L’Essere è
un evento che si manifesta e si nasconde al tempo stesso).
Il termine Ereignis, tuttavia, non ha solo il carattere storico dell’accadere (e del suo
celarsi): esso deriva da eigen, che significa ‘proprio’ nel senso dell’appartenenza: ciò
significa che Essere e uomo sono tra di loro coessenziali, poiché se l’uomo è in quanto
appartiene all’essere, quest’ultimo, a sua volta, è riferito essenzialmente all’uomo. Il
mondo non è così come è solo grazie all’uomo, ma neppure prescindendo dall’uomo.
L’essere ha bisogno dell’uomo per la sua rivelazione, per la sua custodia e configurazione.
Ereignis indica dunque l’originaria coappartenenza di uomo ed essere, poiché nelle varie
aperture epocali dell’Essere avviene una reciproca appropriazione di uomo ed essere in
virtù della quale essi risultano ‘consegnati’ l’uno all’altro.
Ora, sebbene la filosofia heideggeriana ruoti interamente intorno al concetto di Essere,
tuttavia esso con il passare del tempo è apparso screditato o comunque insoddisfacente
agli occhi di Heidegger: volendo difendersi dal modo di pensare metafisico, egli iniziò ad
usare la grafia arcaica Seyn o addirittura la cancellatura cruciforme sopra Sein .
Risulterà chiara l’impostazione decisamente antiumanistica del pensiero del secondo
Heidegger. In Sentieri interrotti (1950) egli considera umanistica ogni dottrina “che spieghi
e valuti l’ente nel suo insieme a partire dall’uomo e in vista dell’uomo”. Del resto, nella già
citata Lettera sull’umanismo il filosofo tedesco distinse nettamente il suo pensiero da
quello esistenzialistico, criticando in modo particolare le tesi esposte da Sarte nel saggio
del 1946 L’esistenzialismo è un umanismo, per cui “siamo su un piano dove c’è solamente
l’uomo”. L’umanismo, sostiene Heidegger, contrariamente a quanto si pensa ( come fa lo
stesso Sartre), non è una dottrina antimetafisica, ma un’impostazione che fa parte
integrante della storia stessa della metafisica e del suo oblio dell’essere. Pertanto,
15
oltrepassare la metafisica vorrà dire andare oltre l’umanismo. L’uomo non deve essere più
il padrone dell’ente, ma il pastore dell’essere: egli non è più il soggetto privilegiato che
impone all’essere i suoi valori e la sua volontà di dominio (ciò significa padrone dell’ente):
“l’uomo è piuttosto gettato dall’essere stesso nella verità dell’essere, in modo che, così
esistendo, custodisca la verità dell’essere, affinché nella luce dell’essere l’ente appaia
come quel che l’ente è. Se e come esso appaia (…) non è l’uomo a deciderlo. L’avvento
dell’ente riposa nel destino dell’essere”. Per quanto concerne il rapporto con
l’esistenzialismo, sarebbe inopportuno (come Heidegger sembra fare) non evidenziare il
fondamentale contributo che questo filosofo ha dato allo sviluppo di tale corrente di
pensiero e di alcuni dei suoi concetti più rilevanti. Ma un conto è influenzare (e forse,
magari essere a sua volta influenzati) l’esistenzialismo e comprendere certi concetti
heideggeriani alla luce del contesto culturale esistenzialista, altro è ritenere, come a lungo
ha fatto la storiografia filosofica, Heidegger un pensatore esistenzialista, soprattutto in virtù
del pensiero successivo alla Kehre (Svolta). Del resto, alcuni concetti tipici di Essere e
tempo vengono ripensati alla luce della filosofia dell’essere e dell’Evento: l’esistenza non è
più il progetto in virtù del quale l’uomo si rapporta all’essere, ma lo stare dentro la verità
dell’essere, nel senso che non c’è un uomo in grado di prescindere da essa. Allo stesso
modo, inautenticità e deiezione non sono più modalità improprie del modo umano di stare
al mondo, bensì modalità improprie del rapporto dell’uomo con la verità e coincidono così
con aspetti facenti capo all’oblio dell’Essere. Il progetto stesso cessa di essere
espressione di un’attività umana, per divenire una manifestazione tipica di un’iniziativa
dell’essere. Un aspetto a questo punto dovrebbe essere chiaro: l’oblio dell’essere (e l’oblio
di questo oblio) non è dovuto ad un errore dell’uomo, ma il prodotto dell’accadere
dell’Essere stesso. L’oblio dell’essere, che è il tratto essenziale della storia della
metafisica, è il risultato del celarsi da parte dell’essere e della conseguente
incomprensione da parte dell’uomo. E’ in definitiva il prodotto necessario di un Evento: la
storia della metafisica in quanto essenza del nichilismo (per cui del senso autentico
dell’essere non ne più niente) si inquadra nella storia dell’essere stesso come
disvelamento, nel senso di rivelazione e occultamento. Il compito dell’uomo sarà quello di
rispondere ad una chiamata, a quello che Heidegger definisce l’appello dell’essere: il
sottrarsi in un certo modo (diverso a seconda delle epoche) da parte dell’essere ha dato
vita a quel modo particolare da parte dell’uomo di coappartenere all’Essere, che ha
prodotto l’interpretare l’Essere stesso in quanto ente ( e la storia stessa della metafisica).
Adesso, giunti all’epoca che ha segnato la fine della metafisica e la sua sostituzione con la
tecnica, il pensiero scopre che gli enti sono stati abbandonati dall’essere e proprio tale
abbandono ha prodotto il dominio degli enti e la riduzione del mondo a calcolabilità e
macchinazione. Perciò è improprio dire che Heidegger è contro la tecnica come contro la
metafisica: nella sua diagnosi (o sarebbe meglio dire interpretazione) egli evidenzia la
necessità di un processo. Egli non pensa all’utopia di un mondo senza tecnica; al
contrario, proprio nella tecnica sta la possibilità di un altro inizio. Infatti, se nell’età della
tecnica la metafisica giunge alla propria fine, con tale esito si apre la possibilità per il
pensiero di ascoltare il richiamo, l’appello dell’Essere e di corrispondervi in un modo non
più malato o obliato. Concludendo la conferenza che ha poi dato vita al testo La questione
della tecnica, Heidegger scrive: “Quanto più ci avviciniamo al pericolo, tanto più
chiaramente cominciano a illuminarsi le vie verso ciò che salva, e tanto più noi
domandiamo. Perché il domandare è la pietà del pensare”. ‘Che cosa significa Essere ?’
coincide per il filosofo tedesco, fin dalle prime battute del suo pensiero, con “che vuol dire
domandare?” Domandare significa porsi in modo autentico la questione dell’essere. Allora
superare la metafisica e il senso stesso del dominio non dipenderà da una decisione
umana, ma da una nuova e diversa rivelazione epocale dell’Essere. Quale potrà essere in
questo contesto l’atteggiamento dell’uomo, dal momento che gli è coessenziale all’essere?
16
La fine della metafisica per Heidegger coincide con la fine della filosofia (che non significa
smettere di pensare): questo processo implica l’avvento di un pensiero antitetico a quello
calcolante della scienza – tecnica, un pensiero che egli definisce rammemorante, che ha
lo scopo di mantenere vivo il problema dell’essere e di effettuare un salto al di là della
concettualità logica della filosofia. Il pensiero stesso appartiene all’Essere, in quanto è
esso stesso che lo fa avvenire. All’uomo, dunque, che non può più esercitare alcuna forma
di padronanza nei suoi confronti, non resterà altro (essendo non solo soggetto passivo ma
anche tramite attivo della manifestazione epocale dell’Essere) che l’ascolto dell’Essere e
la sua custodia, tale da trasformarlo in pastore dell’Essere. L’uomo non subisce mai in
modo passivo l’Essere e il disvelamento (non lo ha fatto neanche all’epoca della
metafisica): “ Sempre l’uomo è governato dal destino del disvelamento. Ma non si tratta
mai della fatalità di una costrizione. Infatti, l’uomo diventa libero solo nella misura in cui,
appunto, appartiene all’ambito del destino e così diventa un ascoltante, non però un
servo”. Se la verità non coincide mai interamente nel rendersi manifesto da parte
dell’essere (come ha creduto la metafisica da Platone in poi), ma anche con il suo ritrarsi;
se ciò ha causato un abbandono degli enti da parte dell’essere, e ciò appartiene del resto
all’essenza della verità (per cui il nichilismo stesso e l’oblio dell’essere è un tratto
essenziale della storia della verità), allora la libertà e l’atteggiamento dell’uomo
coincideranno con l’abbandono e con il lasciar essere l’ente (Gelassenheit),
assecondare, corrispondere al suo appello e alla sua manifestazione epocale. Solo così
potremo superare la metafisica e non assecondare il dominio con cui la tecnica pervade
di sé il mondo. Se in quest’epoca non si può uscire dall’oblio, si potrà però raccogliersi in
esso, affondare nella dimenticanza, in quel luogo aurorale dove l’Essere, celandosi, si
confonde con il nulla. Il pensiero a questo punto non è più una facoltà del soggetto che si
rivolge all’altro da sé, ma intima coappartenza di uomo ed essere. Più che voler afferrare il
mistero dell’essere, l’uomo deve ringraziare per il dono del pensiero, dimorando in ciò che
raccoglie ogni pensiero rammemorante, abbandonarsi radicalmente alla presenza
dell’essere che ci interpella anche attraverso la sua stessa assenza. Il compito del
pensiero, che ha portato in Heidegger ad un distruzione della storia dell’ontologia è
quello di rivolgersi ai pensatori aurorali (i lavori interpretativi su Anassimandro, Eraclito e
Parmenide non sono casuali) e di operare un’analisi del linguaggio. Da sempre l’uomo
esiste nel linguaggio e come linguaggio; tuttavia, parlare del linguaggio non è impresa
facile: “In verità, parlare del linguaggio è forse anche peggio che scrivere sul silenzio.” (In
cammino verso il linguaggio, 1959). Quest’opera, che tenterà di fare chiarezza su quanto
detto sopra, si inquadra in un contesto ben preciso: da un lato, Heidegger è a conoscenza
del dibattito sul linguaggio a cui la filosofia analitica si è avviata prendendo le mosse dal
‘secondo Wittgenstein’ e non ne è assolutamente soddisfatto, ritenendo che esso conduca
ad una mistificazione del significato stesso del linguaggio; inoltre, si è accostato allo studio
del taoismo, notando affinità importanti tra il Logos e il Tao, e un tratto di forte somiglianza
tra la cultura orientale e i primi pensatori greci, non ancora caduti nell’oblio dell’essere.
Qui l’antiumanismo raggiunge il suo apice: Heidegger sostiene che chi parla nel linguaggio
non è l’uomo, ma il linguaggio stesso. Qui si potrebbe istituire una sorta di sillogismo: se
l’essenza dell’uomo è il linguaggio e il linguaggio è questione che riguarda, che è istituita
dall’essere, allora l’essenza dell’uomo è principalmente relativa all’essere. Il linguaggio
che ci costituisce nei vari orizzonti storico – culturali non è creazione umana, bensì è
qualcosa di ricevuto, di donato all’uomo. Egli puntualizza che contrapporsi in modo
antiumanistico all’umanesimo, come quello sartriano, non significa svilire l’uomo,
svalutarne la dignità; se mai è l’umanesimo che, avendo ridotto l’uomo a padrone dell’ente
e avendo obliato l’essere, abbassa l’uomo e la sua essenza. La dignità umana consiste
proprio nella custodia ontologica della verità dell’essere. “L’uomo è piuttosto ‘gettato’
17
dall’essere stesso nella verità dell’essere, in modo che così e – sistendo, custodisca la
verità dell’essere”. (Lettera sull’umanismo).
Anche quando Heidegger parla di Destino (Geschick), esso non va inteso in senso
metafisico, come fato inesorabile, ma come insieme (Ge) che è inviato dall’Essere
all’uomo, una sorta di dono, di appello, che sottintende una sua necessaria risposta.
L’Essere si svela perciò nel linguaggio, ma non in quello scientifico che domina gli enti o in
quello inautentico della chiacchiera o dell’equivoco, ma nel linguaggio autentico dell’arte,
in particolare in quello della poesia (Dichtung): “Il linguaggio è la casa dell’essere. In
questa dimora abita l’uomo. I pensatori e i poeti sono i guardiani di questa dimora”.
(Lettera sull’umanismo). Nella forma aurorale, originaria della poesia, la parola assume un
carattere sacrale: la poesia, il Dire originario, dà nome alle cose e così facendo fonda
l’essere. Fondazione, ribadiamo, che non è opera umana, ma dono dell’essere. E’ il
linguaggio stesso e in esso l’essere che parla attraverso il dire poetico. “Dimora
dell’Essere è il linguaggio, perché il linguaggio, come Dire (Sage) originario, è il modo
dell’Ereignis”. (In cammino verso il linguaggio.) Ritrarre se stessi per porsi in silenzio,
nell’ascolto dell’essere, è l’atteggiamento di abbandono nei confronti dell’essere, l’unico
corretto. I pensatori essenziali, aurorali, come Anassimandro, Parmenide, Eraclito,
Holderlin sono i testimoni o gli ascoltatori della voce dell’essere, gli autentici pastori
dell’essere: “Il pensatore dice l’essere. Il poeta nomina il sacro”. (Sentieri interrotti, 1950).
Se Nietzsche era rimasto all’interno del nichilismo, Holderlin va oltre e per primo anticipa
un’epoca nuova: “Il poeta pensa nella regione delimitata da quell’illuminazione dell’essere
che, in quanto dominio della metafisica occidentale autocompientesi, è giunta alla sua
configurazione conclusiva (…). Le tracce, sovente, sono ben poco visibili, e sono sempre
il retaggio di un’indicazione appena presentita. Esser poeta nel tempo della povertà
significa: cantando, ispirarsi alla traccia degli Dei fuggiti. Ecco perché nel tempo della
notte del mondo il poeta canta il Sacro. Ecco perché, nel linguaggio di Holderlin, la notte
del mondo è la notte sacra”. (Sentieri interrotti).
Questo è il tempo della povertà estrema in quanto caratterizzato dal ‘non più’ degli dei
fuggiti e dal ‘non ancora’ del Dio che viene. Cosa intende Heidegger con la parola Dio?
Egli contrappone l’abbandono alle cose e all’essere (Gelassenheit) all’arroganza moderna
del volere e del produrre. Questo atteggiamento è intrinsecamente legato al tenersi aperti
per il mistero e alla concezione dell’Essere come assenza di fondamento (Abgrund), nel
senso di profondità o abisso: ai procedimenti dimostrativi della metafisica, egli
contrappone i versi di Angelus Silesius (pseudonimo di Johannes Scheffer), poeta tedesco
del XVII secolo): “la rosa è senza perché: fiorisce perché fiorisce”. Pensare è per
Heidegger ringraziare, connettendo tra di loro Denken (Pensare) e Danken (ringraziare).
Tale concezione del pensare come affidamento (all’essere) e ringraziamento (per il dono
dell’essere) ci fa comprendere la vicinanza del secondo Heidegger alla problematica
religiosa. In una intervista al giornale tedesco Der Spiegel della metà degli anni ’60 (che fu
rilasciata dal filosofo purché venisse divulgata solo dopo la sua morte, come in effetti
avvenne), egli così si espresse: “La filosofia non potrà produrre nessuna immediata
modificazione dello stato attuale del modo. E questo non vale soltanto per la filosofia, ma
anche per tutto ciò che è mera intrapresa umana. Ormai solo un Dio ci può salvare”.
Il senso di tale espressione non è affatto chiaro, così come ciò che Heidegger pensa
veramente di Dio: la sua riflessione (come avviene in definitiva per buona parte di ciò che
sostiene il ‘secondo Heidegger’) resta vaga e indeterminata. Di certo, egli si oppone al Dio
dei filosofi: anzi, un pensiero privo del Dio filosofico risulta più vicino al ‘dio divino’. Allo
stesso modo l’Essere non si identifica con Dio: l’essere non è Dio né il fondamento del
mondo, non è né il Dio dei filosofi né quello delle religioni. Peraltro, il manifestarsi di Dio
può avvenire solo nella dimensione dell’Essere, “poiché il sacro può apparire solo se
prima, dopo lunga preparazione, l’essere stesso viene a diradarsi ed è esperito nella sua
18
verità”. (Lettera sull’umanismo). L’avvento dell’essere sembra perciò accompagnarsi ad un
possibile nuovo avvento di Dio.
Ben più chiara è la concezione heideggeriana dell’arte. Egli rifiuta il modello storicistico.
L’arte non esprime né rispecchia l’epoca in cui si sviluppa, ma la plasma: il senso di
un’opera non si afferra attraverso la comprensione di una certa epoca, ma al contrario, è
attraverso un’opera che si capisce il senso di una determinata epoca. I poeti sono gli
inventori della cultura di un popolo, gli forniscono identità, istituendo usanze e costumi.
Con il rapporto stretto tra essere e linguaggio, l’ontologia diviene ermeneutica, ossia
esercizio di interpretazione. L’ascolto di cui parla Heidegger assume la forma concreta
dell’interpretazione. Di qui le innumerevoli disamine linguistiche e la capillare insistenza
sull’etimo delle parole da parte del pensatore tedesco, che non sono un orpello decorativo
fine a se stesso, ma sostanziano la sua riflessione. Il detto, del resto, si colloca sempre
nell’ambito del non detto e del non dicibile, che nutre e sorregge il Dire poetante e
pensante, così come il rivelarsi dell’Essere è l’altra faccia del suo ritrarsi. Questo non vuol
dire che Heidegger, quando parla di non detto o di mistero sia accomunabile ad un
pensatore mistico: la sua ontologia ermeneutica scorge nell’Essere un totalmente altro mai
interamente esplicitabile e comunicabile. Il suo è un pensiero costantemente in cammino
che non pretende di cogliere certezze sistematiche e assolute, ma si accontenta di
semplici ‘segnavia’: “itinerari, non opere”, è il motto in esergo che troviamo nella
pubblicazione delle opere complete del filosofo di Messkirch.
19