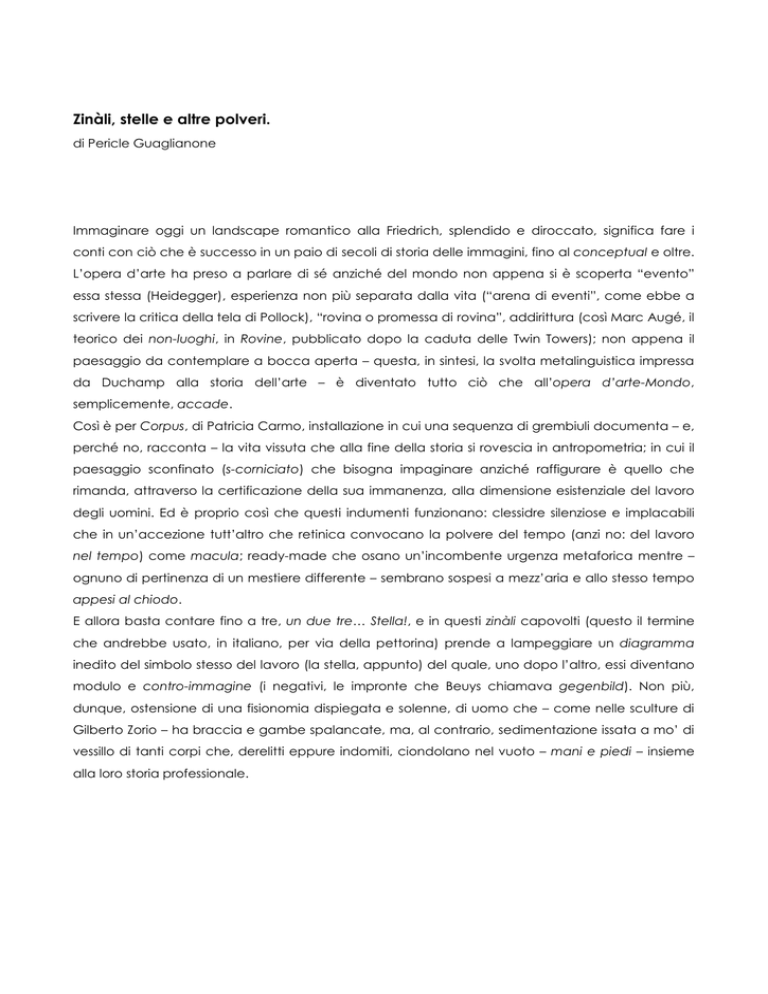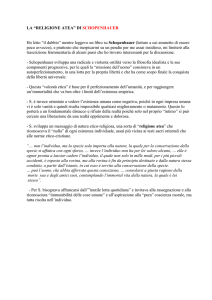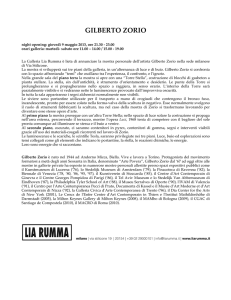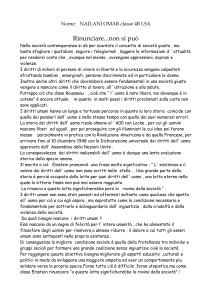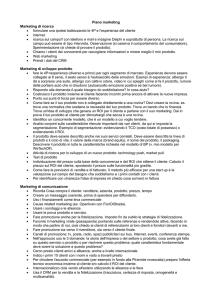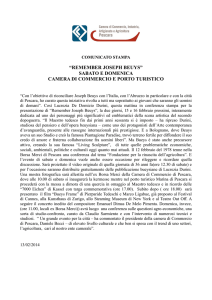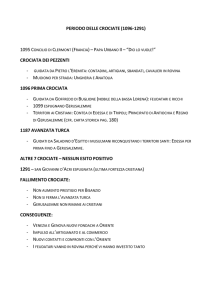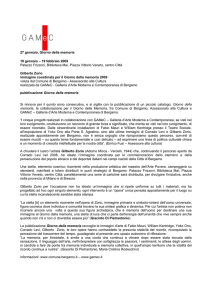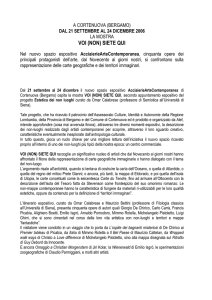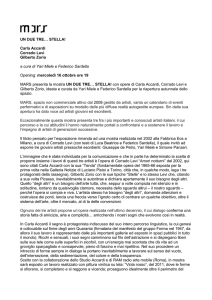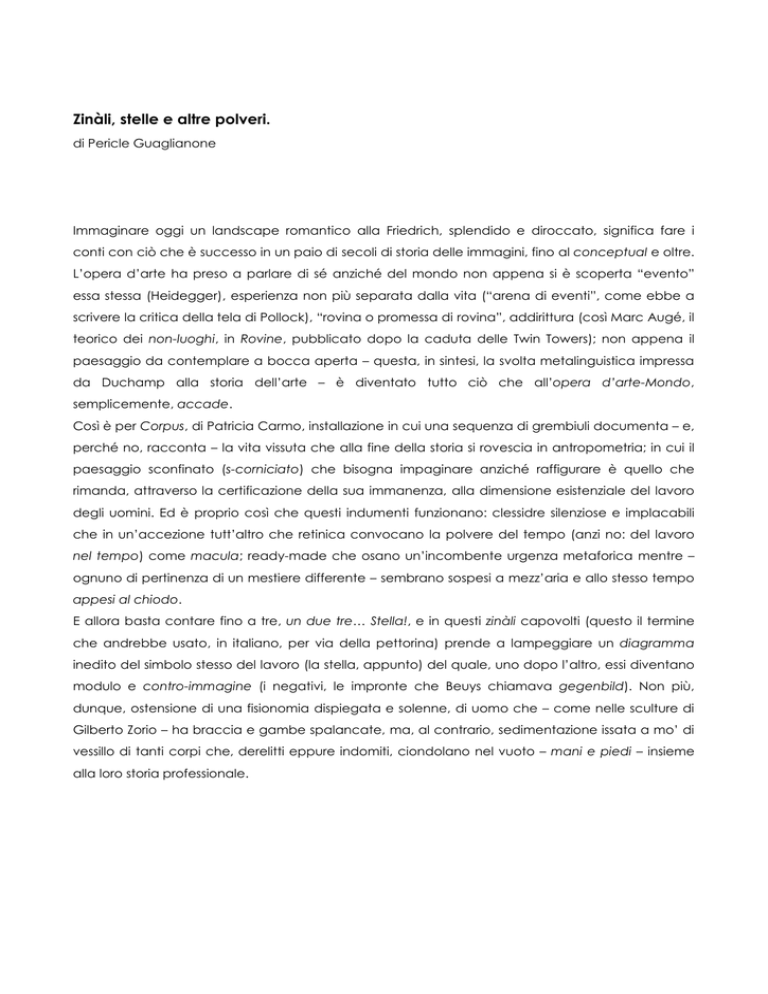
Zinàli, stelle e altre polveri.
di Pericle Guaglianone
Immaginare oggi un landscape romantico alla Friedrich, splendido e diroccato, significa fare i
conti con ciò che è successo in un paio di secoli di storia delle immagini, fino al conceptual e oltre.
L’opera d’arte ha preso a parlare di sé anziché del mondo non appena si è scoperta “evento”
essa stessa (Heidegger), esperienza non più separata dalla vita (“arena di eventi”, come ebbe a
scrivere la critica della tela di Pollock), “rovina o promessa di rovina”, addirittura (così Marc Augé, il
teorico dei non-luoghi, in Rovine, pubblicato dopo la caduta delle Twin Towers); non appena il
paesaggio da contemplare a bocca aperta – questa, in sintesi, la svolta metalinguistica impressa
da Duchamp alla storia dell’arte – è diventato tutto ciò che all’opera d’arte-Mondo,
semplicemente, accade.
Così è per Corpus, di Patricia Carmo, installazione in cui una sequenza di grembiuli documenta – e,
perché no, racconta – la vita vissuta che alla fine della storia si rovescia in antropometria; in cui il
paesaggio sconfinato (s-corniciato) che bisogna impaginare anziché raffigurare è quello che
rimanda, attraverso la certificazione della sua immanenza, alla dimensione esistenziale del lavoro
degli uomini. Ed è proprio così che questi indumenti funzionano: clessidre silenziose e implacabili
che in un’accezione tutt’altro che retinica convocano la polvere del tempo (anzi no: del lavoro
nel tempo) come macula; ready-made che osano un’incombente urgenza metaforica mentre –
ognuno di pertinenza di un mestiere differente – sembrano sospesi a mezz’aria e allo stesso tempo
appesi al chiodo.
E allora basta contare fino a tre, un due tre… Stella!, e in questi zinàli capovolti (questo il termine
che andrebbe usato, in italiano, per via della pettorina) prende a lampeggiare un diagramma
inedito del simbolo stesso del lavoro (la stella, appunto) del quale, uno dopo l’altro, essi diventano
modulo e contro-immagine (i negativi, le impronte che Beuys chiamava gegenbild). Non più,
dunque, ostensione di una fisionomia dispiegata e solenne, di uomo che – come nelle sculture di
Gilberto Zorio – ha braccia e gambe spalancate, ma, al contrario, sedimentazione issata a mo’ di
vessillo di tanti corpi che, derelitti eppure indomiti, ciondolano nel vuoto – mani e piedi – insieme
alla loro storia professionale.