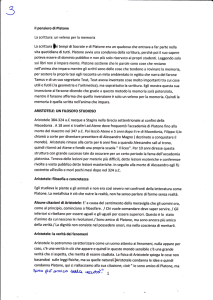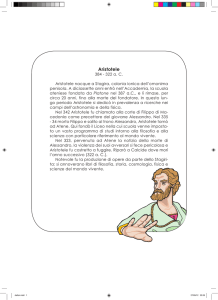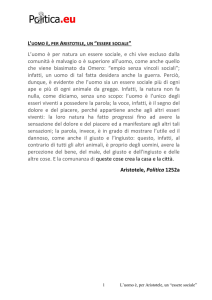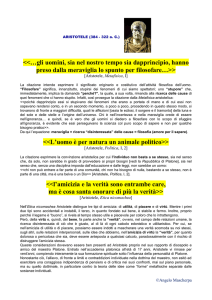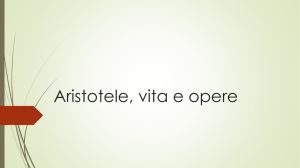Luciano Russi
La pace nella storia
Antologia a cura di Leone Melillo*
* Già ad uso degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza - sede di Avezzano dell’Università
degli Studi di Teramo.
Le note ed i commenti sono di Leone Melillo
(Dispense ad uso degli studenti)
1
INDICE
Platone
p.
3
Aristotele
12
Cicerone
25
Seneca
31
Agostino d’Ippona
36
Tommaso d’Aquino
42
Dante
48
Marsilio da Padova
56
Erasmo da Rotterdam
66
Kant
77
Aron
87
Bobbio
97
Cotta
109
2
PLATONE*
il maggior bene … è la pace
________________
* Platone (Atene 428-427 a. C. – 348-347), di famiglia aristocratica, già
scolaro della scuola di Eraclito, divenne discepolo di Socrate, che aveva
conosciuto a vent’anni. Si recò, quindi, prima a Megera, in Egitto, ed a Cirene,
poi nell’Italia meridionale (388), a Siracusa, da Dione, mentre era tiranno della
città Dionigi il Vecchio. Di nuovo ad Atene (387), fonda l’Accademia, così
denominata in ragione del ginnasio voluto da Accademo.
Nuovamente a Siracusa (367), alla morte di Dionigi il Vecchio, mentre era
tiranno Dionigi il Giovane, non riuscì ad influire positivamente sulle scelte
3
politiche della città. Ancora a Siracusa (361), fece poi ritorno ad Atene, dove
rimase fino alla morte.
Le Leggi
ATENIESE – Ed allora vediamo anche quest’altro motivo: quei tali fratelli, di
cui sopra abbiamo parlato, non potrebbero avere un giudice ?
CLINIA – Sicuro !
ATENIESE – Ma quale sarebbe il giudice migliore: quello che facesse morire
quanti fra di loro sono malvagi per poi ordinare ai migliori di governarsi da sé,
o meglio che conferisse il potere ai buoni e lasciasse in vita i malvagi,
inducendoli ad accettare volontariamente tale autorità ? Ma più virtuoso
dell’uno e dell’altro sarebbe un terzo giudice, il giudice che presa a curare una
famiglia discorde, senza mettere a morte nessuno, ne riconciliasse i membri, e,
dando loro leggi, riuscisse per l’avvenire a far si che costoro vivessero in una
reciproca, durevole amicizia1.
CLINIA – Ma di gran lunga migliore sarebbe un giudice ed un legislatore
simile !
ATENIESE – Eppure non sarebbe la guerra, ma proprio il suo contrario lo
scopo per cui darebbe loro le leggi.
CLINIA – Questo è vero.
ATENIESE – E che dire di chi ordina lo Stato ? Potrebbe egli armonizzare la
vita, tenendo soprattutto presente la guerra esterna, o piuttosto quella che ad
ogni momento può scoppiare nel suo interno, e che si chiama discordia2?
Guerra questa che nessuno, assolutamente, vorrebbe che mai nascesse nel
proprio Stato, e che, una volta nata, vorrebbe scomparisse al più presto.
CLINIA – Questa seconda, evidentemente.
ATENIESE – Ed in tal caso, cosa si preferirebbe, che la morte degli uni e la
vittoria degli altri facessero succedere la pace alla discoria, o che amicizia e
1
Motivo tipicamente platonico: amicizia e ordine specchio dell’ordine del tutto. Il legislatore vero che conosce
quell’ordine in quanto egli è ragione, deve di là dalle unilateralità riuscire a costituire in atto quell’ordine stesso,
traducendolo in termini giuridici.
2
Cfr. Repubblica, 470b – 471 a.
4
pace rifiorissero grazie ad una riconciliazione, sì che necessariamente
l’attenzione si volgesse ai nemici esterni […] ?
CLINIA – Ognuno preferirebbe per il proprio Stato questa all’altra soluzione.
ATENIESE – ED il legislatore non sarebbe dello stesso parere ?
CLINIA – Come no !
ATENIESE – Ma non è forse in vista del maggior bene che ogni legislatore
imposta tutto il complesso della legislazione ?
CLINIA – Certo !
ATENIESE – Ora, il maggior bene non è né la guerra né la discordia –
dobbiamo anzi augurarci che non si debba ricorrere ad esse -, ma è, ad un
tempo, reciproca pace e benevolenza. Non solo, ma direi anche che per uno
Stato il vincere se stesso non è il maggiore di tutti i beni, ma solo una
necessità: sarebbe come se ritenessimo che un corpo ammalato cui un medico
ha fatto prendere la purga, appunto per questo si trovi nelle migliori condizioni
di salute, e non pensassimo affatto ad un corpo che non avesse, invece, alcun
difetto; per la stessa ragione quando si tratta della prosperità di uno Stato come
di quella di un privato, chi pensasse in tal modo, e tenesse presente soltanto e
principalmente le guerre esterne, non sarebbe mai un vero politic; né sarebbe
un legislatore compiuto se non dettasse in vista della pace le leggi che
riguardano la guerra, piuttosto che in vista della guerra le leggi che riguardano
la pace. […]
ATENIESE – Oggi si ritiene che le cose serie siano in funzione del
divertimento. La guerra, ad esempio, si crede sia una cosa seria, da farsi come
si deve, in funzione della pace; secondo me la guerra non è né sarà mai un
divertimento, né è né mai sarà formazione educativa degna della nostra
attenzione. Noi sosteniamo, invece, che questa è la cosa più seria: ciascuno
deve trascorrere in pace la propria vita. Quale dunque la retta strada ?
Trascorrere la propria vita giocando il proprio giuoco, facendo sacrifici,
cantando, danzando, sì che da un lato ci sia possibile accattivarci il favore
degli dei, dall’altro difenderci dai nemici e vincerli in battaglia. Quali i canti,
quali le danze mediante cui si possono attuare questi due scopi, già lo abbiamo
5
detto, e già, in fondo, abbiamo tracciato le vie che bisogna percorrere, convinti
che il poeta ha davvero ragione3.
COMMMENTO
La comune convinzione secondo cui «per i Greci, “la pace indica uno stato,
una condizione di vita, piuttosto che un modo di essere o di comportarsi che
porti ad un tale stato”» non può esaurire la valutazione filosofico-giuridica al
riguardo.
Come precisa Lombardi – seguendo l’interpretazione di Cotta – per i
filosofi «la pace non è solamente una condizione esterna. È anche un
atteggiamento dello spirito che, particolarmente nel pensiero platonico, si
delinea come «“profonda correlazione tra l’armonia dell’anima e l’armonia del
cosmo, fra le quali, come termine intermedio si pone l’armonia della città”».
Un’immediata chiave interpretativa di questa “condizione” induce ad
escludere – sempre secondo l’interpretazione di Cotta – che possa esservi “una
progressiva distinzione tra la pace interna, dello spirito, e la pace esterna della
città”: “manca, in proposito – secondo Cotta – alla filosofia greca la
consapevolezza della dialetticità, in quanto manca la consapevolezza del male,
quale forza perturbatrice sempre presente nell’uomo e nel mondo”4.
Ancora alcune osservazioni. Nell’intervento proposto da Cotta ed analizzato
da Lombardi – che non trascrivo per brevità – sembra delineata una nuova
prospettiva secondo la concezione greca di “ordine”.
Come è possibile ammettere un ordine - «grandioso e profondo, segreto,
che unisce armonicamente tutte le cose e tutti gli uomini nel “cosmo”» introducendo l’assenza del “male” e quindi della “dialetticità della pace” per
poi rendere necessaria “l’armonia dell’anima e l’armonia del cosmo, fra le
quali, come termine intermedio, si pone l’armonia della città” ?
L’ordine della filosofia greca classica non può accettare la dialettica, in
quanto dimensione di uniformità in cui anche il male non ha significato
3
4
Dialoghi politici e lettere di Platone, a cura di F. Adorno, Torino, Utet, Vol. II, pp. 30-2, 290.
La pace come dimensione dello spirito, Bologna, 1967, p. 16.
6
dialettico: la positività del sillogismo contrasta con la negatività della
dialettica che trascende ogni esperienza concreta nell’ordine che la deve
esprimere.
Una trasposizione teorica della dialettica all’esperienza della filosofia greca
classica non può, neppure, a maggior ragione, considerare la dimensione
individuale della coscienza e quindi del “foro interno”, nel contrasto con il
male; così come la dimensione politica in cui il bene ontologico deve
configgere con il male: questa prospettiva del “foro interno” e di quello
“esterno” è proprio della concezione cristiana.
Una considerazione che può essere opportunamente resa, sottolineando con
Lana, commentato da Lombardi - «parlando di Aristotele – che “lo Stato
antico gioca la sua sorte su un terreno nel quale politica e morale si
confondono e lo Stato arroga a sé ogni diritto di decisione sulla vita sociale dei
singoli»5.
La condizione umana è di per sé idonea a garantire la pace ?
L’esistenza di un “ordine naturale”, necessariamente fondato sulla giustizia,
dovrebbe indurre a ritenere che l’uomo, che ne è espressione, possa garantire
la pace6.
5
La pace come dimensione dello spirito, cit., p. 16 e p. 149 s.
Il «pensiero platonico» esprime la «consapevolezza che la guerra sia fonte perenne di dolori». Nelle Leggi, Platone «fa
dire ad uno degli interlocutori [... che la] “pace, lo è soltanto di nome. In virtù di una legge naturale esiste sempre secondo Platone - uno stato di guerra, anche se non dichiarata tra ogni singolo stato e tutti gli altri”. Come spiegare una
presa di posizione così pessimistica e conciliarla con una visione dello stato etico, proteso al raggiungimento di
superiori obiettivi morali ? Come non meravigliarsi che lo stesso filosofo, che nel campo della conoscenza sottolineava
la portata illuminante dell’idea, tanto da paragonare l’umanità a un gruppo di prigionieri incatenati in una caverna, alle
cui pupille attonite la luce perveniva filtrando da uno spiraglio, per cui fissare la realtà per comprenderla dipendeva da
un processo di assuefazione, si esprimesse in modo tanto diverso nel caso della guerra, per la quale non prevedeva un
analogo processo di liberazione ? Evidentemente i vincoli che impongono all’individuo di sottomettersi all’autorità
statale, operante in un’atmosfera di conflitto tendenziale o di guerra aperta, gli apparivano di tale momento, da impedire
all’uomo di scuotere il giogo oppressore, sostituendo la concordia all’antica vocazione e alla primitiva fatalità guerriera.
[…] Platone era disposto a identificare nella guerra la causa di molte sciagure, ma non si illudeva. Non intendeva
passare per un sovvertitore, ansioso di distruggere modi di vita tradizionali o per un visionario smarritosi lungo i sentieri
dell’utopia. Per consentirgli di uscire dal tragico dilemma, si sarebbero resi necessari una fede o un impeto mistico,
capaci di rigenerare la tradizione politica e militare della società greca e avviarla verso posizioni etiche e religiose del
tutto nuove. Era peraltro già una prova di ardimento il tentativo di alimentare la certezza che la guerra non dovesse
rappresentare la massima cura dello stato. Questa certezza frutto, malgrado le apparenze, di un unico disegno razionale,
ci spiega perché nelle Leggi le attività pacifiche risultassero al centro delle preoccupazioni dei governanti. La pace ne
emergeva non soltanto come obiettivo terminale dell’esistenza umana, ma come ricompensa di una condotta virtuosa. Si
viveva felici, se ci si asteneva da ogni comportamento ingiusto e ci si poneva al riparo da quello altrui. Queste due
condizioni erano realizzabili soltanto attraverso la pratica della virtù. Lo stesso poteva dirsi dello stato. “Se sarà
virtuoso, vivrà in pace. Sarà invece travagliato da conflitti interni ed esterni, se sarà perverso”. Un’armonia tendenziale
coronava dunque il comportamento degli uomini e dei gruppi». G. Zampaglione, L’idea della pace nel mondo antico,
Torino, 1967, pp. 75-79.
6
7
L’“ordine” – precisato da Cotta7 – è accolto dalla filosofia greca con
modalità diverse dovute, con ogni evidenza, alle personali convinzioni
filosofiche che, in questo caso, ispirano Platone.
L’ “uomo e la città” – è questa la necessaria relazione proposta da Touchard
– evidenzia la necessità di “edificare una città giusta” per poter “ottenere un
uomo giusto”: la città “lungi dal fondarsi su di una popolazione omogenea,
sarà formata da tre classi nettamente distinte, la cui convivenza realizzerà una
sorta di società perfetta”8.
Ecco la ragione per cui – secondo la ricostruzione di Cotta - “la pace come
armonia del cosmo e dell’anima al tempo stesso, come profonda correlazione
fra l’armonia dell’anima e l’armonia del cosmo” pone “come termine
intermedio […] l’armonia della città” 9.
In questo senso non appare determinante considerare se – come precisa
Lana - in luogo della pace, sia diversamente la guerra ad ispirare la necessità
di sacrificare altri beni in “modo di ordinare la vita interna della città” 10.
Cosa può rappresentare “l’ordine” come armonia universale ? Ancora. È
necessaria
un’accezione
che
persegua
una
condizione
«che
unisce
armonicamente tutte le cose e tutti gli uomini nel “cosmo”»11 ?
L’esito è evidente. L’“ordine” vuole, con l’armonia, che si realizzi una
giustizia che non necessariamente deve considerare l’armonia del cosmo.
Una dimostrazione.
Fassò precisa adeguatamente le modalità con cui Platone perviene, dalla
definizione della “giustizia” come «virtù totale e perfezione dell’anima»12, ad
un’accentuata considerazione della legge come “scoperta dell’essere” nella
“corrispondenza fra l’ordine normativo umano e l’ordine ontologico”13.
7
La pace come dimensione dello spirito, cit., p. 150.
J. Touchard, Storia del pensiero politico, cit., p. 21.
9
La pace come dimensione dello spirito, cit., p. 149.
10
La pace come dimensione dello spirito, cit., p. 152.
11
La pace come dimensione dello spirito, cit., p. 150.
12
G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, Bologna, 1966, I, p. 67.
13
G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, cit., p. 79.
8
8
È, con ogni evidenza, il Platone della Repubblica, quello descritto da Cotta
quanto alla precisazione circa «l’ordine grandioso e profondo, segreto, che
unisce armonicamente tutte le cose e tutti gli uomini nel “cosmo”»14.
È questa una dimensione della giustizia che consegue la pace.
Con Fassò, ma secondo opportuni adattamenti, “questa concezione della
giustizia – e quindi questa interpretazione della pace – non è quella a cui ci si
riferisce quando di questa si parla come di principio del diritto. Vi è in essa
l’idea del rapporto, dell’armonia fra parti diverse, ma non quella del rapporto
fra diversi soggetti. L’armonia in cui la giustizia platonica consiste è armonia
fra gli elementi di un medesimo organismo”.15
Questa dimensione platonica non è unica perché subisce adattamenti resi
ancora più evidenti dalla redazione del “Minosse” – già citato – non
direttamente attribuitogli, secondo le interpretazioni più recenti.
Quale la ragione che induce a riflettere ?
La giustizia e quindi la pace come dimensione che esprime la sua
compiutezza, subisce adattamenti ed adeguamenti dovuti all’impossibilità di
storicizzare la “città ideale” platonica: il ricorso alle leggi, che nel “Politico” è
utile al perseguimento dell’ “uguaglianza”, diviene, nelle “Leggi” 16, strumento
etico per un rinvio di “conformità alle leggi”, pervenendo ad una concezione
del “diritto naturale razionale”.
14
La pace come dimensione dello spirito, cit., p. 150.
G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, cit., p. 70.
16
«Le leggi, un dialogo di argomento politico, diviso in dodici libri, attestano l’ultima elaborazione del pensiero politico
di Platone. L’intento pratico delle leggi è attestato anche dal preambolo del dialogo. Clinia intende servirsi, per dettar
leggi a una colonia recentemente istituita, degli ordinamenti proposti dagli interlocutori. Nei primi quattro libri si tratta
del fine cui deve ispirarsi il legislatore. Clinia e Megillo, l’uno di Creta e l’altro di Sparta, identificano il fine con la
guerra, avendo l’occhio alla costituzione dei loro paesi d’origine. Per l’Ateniese invece (che è il protagonista e in cui si
deve riconoscere lo stesso Platone), il legislatore deve formular le leggi in vista del maggior bene, quindi della pace e
della mutua solidarietà dei cittadini: egli deve por mente a tutto il complesso della virtù, giacché inseparabile dalla virtù
è la felicità. Per trovare poi quale forma di governo sia la più conveniente per attuar questo fine, Platone esamina
minutamente tutte le varie forme di governo, facendo la storia del loro progressivo sviluppo, parallelo all'incivilimento
umano. Egli prende le mosse dal diluvio. I pochi superstiti s'organizzarono allora in nuclei la cui costituzione dovette
essere il patriarcato; da questo passarono a forme più complesse, con cui entrarono nel regno della storia. Il minuto
esame di varie costituzioni finisce per attestare che se gli Stati cadono, è sempre per cause interne, per difetto dei capi o
delle legislazioni. E si conclude che il miglior governo è un governo misto, dominato da un oculato complesso di leggi
che tutelano gl'interessi di tutta la cittadinanza; solo in tal caso la saggezza non si discompagna dalla libertà e dal buon
accordo. Tra i governi esistenti, quello che si avvicina di più a questa forma quasi perfetta è il governo di Sparta, in cui
il potere regio è temperato dall’autorità popolare». Platone, Dialoghi vol. VII – Le Leggi (Libri VII-XII), trad. it. A.
Cassarà, 1921, Bari, pp. 221 s.
15
9
L’esito di questo panorama teorico si conclude con il “Minosse” in cui –
come precisa Fassò – la legge come “scoperta dell’essere” segna la
“corrispondenza fra l’ordine normativo umano e l’ordine ontologico”.17
Platone, scosso dai ripetuti cambiamenti politici che avevano provato il
mondo greco ed in particolare Atene, soprattutto con la morte di Socrate, non
può credere in una data dimensione storica della città stato. Nella
“Repubblica” egli designa – per il perseguimento della pace – una città ideale
in cui possano coesistere le tre possibilità umane come dimensione dell’essere.
L’analogia con le tre dimensioni dell’anima è evidente, così come
l’impossibilità di rappresentarle nell’equilibrio dell’anima umana. Come
ritiene Platone – assegnando il compito a Socrate di descriverlo in un dialogo
della “Repubblica” – solo lo Stato può rappresentare questo equilibrio
rendendo operante l’“ordine” come armonia.
Ecco che se l’uomo non può rendere l’armonia del cosmo, lo Stato può,
come termine medio, rappresentare da un lato la condizione umana, dall’altro
l’ordine cosmico, acutamente delineato da Cotta.
Ancora, il mondo greco e quindi Platone non riesce a dialettizzare il bene e
il male e quindi l’ordine nella definizione della perfetta giustizia.
Questa impossibilità induce Platone ad una definizione della città ideale: il
merito riconosciuto ai filosofi può garantire un “ordine” che è metastorico,
metagiuridico, appunto filosofico.
Ma questa enunciazione teorica – come abbiamo più volte ripetuto – non è
un dato immodificabile.
Platone comprende che la città ideale, come dimensione metastorica che
supera il rapporto tra il bene ed il male, non può prescindere dal ricorso alla
legge che era stata esclusa nella redazione della “Repubblica”.
Un aspetto non trascurabile di questa ricostruzione induce a riflettere ancora
sulla giustizia nella prospettiva che vuole realizzare la pace.
Per Platone, la pace può essere garantita dall’ordine cosmico di cui lo stesso
ordine della città è la dimensione. La legge viene sostanzialmente trascurata e
con essa la giustizia che questa può garantire.
17
G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, cit., p. 79.
10
Il limite è evidente: la legge, che regola i rapporti intersoggettivi, non è
accolta da Platone perché non è riconosciuta idonea a garantire l’ordine
cosmico.
I successivi adeguamenti che vogliono attribuire un significato alla legge le
riconoscono solo l’utilità di garantire l’uguaglianza ed ancora la loro
osservanza.
In quest’ultimo senso, la conformità alle leggi potrà garantire la compiuta
realizzazione della virtù e quindi dell’ordine che inizialmente Platone aveva
demandato all’educazione.
I limiti di questa prospettiva sono ancora più evidenti nel “Minosse”18 in cui
la natura razionale, riconosciuta alla legge, si risolve nell’ordine naturale.
L’“ordine cosmico”, sicuramente naturale, deve ancora poter esprimere
l’intera dimensione umana.
Indichiamo
ora,
brevemente,
come
premessa
espositiva,
alcune
considerazioni che saranno più ampiamente analizzate nella trattazione
riservata ad Aristotele ed a Marsilio da Padova.
Appare necessario da un lato considerare la “foelicitas” e la “tranquillitas”,
proprie dell’ordine cosmico tratteggiato dal “mondo greco contadino” - che
possono essere comprese analizzando il commento che Lombardi offre del
pensiero di Lana -, cui Platone rinuncia per la sua consapevolezza critica
quanto alle forme di Stato storicamente date; dall’altro considerare la funzione
normativa della giustizia che ad essa è correlata nella definizione dei rapporti
intersoggettivi trascurati da Platone.
Quanto al primo quesito. Con evidenze che conducono ad Aristotele - che la
successiva esposizione intende proporre – Marsilio da Padova – come precisa
Russi – ritiene che “la felicità […] [sia …] quella che si realizza nella
comunità civile” - per “la pace civile o tranquillità” - “soddisfa[cendo] sia le
funzioni dell’anima sia le virtù pratiche”19.
Quanto al secondo quesito. Se la città, storicamente data, non è in grado di
rappresentare la dimensione dell’ordine cosmico e quindi la giustizia, se non è
18
G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, cit., p. 78 s.
L. Russi, L’idea di pace in Marsilio da Padova, in La politica prima di Machiavelli. Atti del Convegno di tenutosi a
Teramo nei giorni 29 e 30 aprile 2004, in corso di pubblicazione.
19
11
possibile dialettizare il bene ed il male, garantendo l’ordine e quindi la pace
nella definizione di uno Stato, storicamente dato, sarà necessario, già con
Aristotele e quindi con Marsilio da Padova, ricorrere alle leggi, nella loro
dimensione intersoggettiva, che possano garantire la giustizia, l’ordine e
quindi la pace.
ARISTOTELE*
[come per l’uomo] la pace è salute del corpo sociale
________________
* Aristotele (Stagira 384-383 a. C. – Calcide 322-321) giunse nel 365 ad
Atene, divenendo discepolo di Platone e quindi dell’Accademia, fino alla
morte del maestro. Si recò quindi ad Asso (Asia Minore), dove costituì una
comunità platonica, potendo godere della protezione assicuratagli dal tiranno
Ermia. Successivamente si stabilì a Mitilene (isola di Lesbo), quindi in
12
Macedonia, alla corte di Filippo, assumendo l’educazione del figlio
Alessandro. Di nuovo ad Atene, fondò una scuola che fu denominata Liceo, in
ragione della vicinanza con il tempio di Apollo Licio, ma anche Peripato, in
ragione dell’abitudine di passeggiare, tenendo le lezioni nel giardino o sotto i
portici. Aristotele, in seguito alla morte di Alessandro, temendo Demostene,
dovette abbandonare Atene, recandosi a Calcide dove morì.
“La Politica”
«Resta da dire se bisogna ammettere che la felicità di ciascun uomo nella sua
singolarità e dello Stato sia la stessa o non la stessa20. Ma è chiaro anche
questo: tutti dovrebbero convenire che è la stessa. In effetti quanti a proposito
del singolo fanno consistere la vita felice nelle ricchezze, costoro ritengono
beato uno stato nella sua totalità se è ricco: quanti pregiano sopra ogni cosa la
vita tirannica, costoro dovranno ammettere che lo stato più felice è quello che
ha il più grande dominio: chi approva un individuo per la virtù, dirà che più
felice è lo stato che è più morale. Ma ecco due problemi che hanno bisogno di
esame: uno, se è preferibile la vita che comporta la partecipazione attiva allo
stato e alle cariche pubbliche o piuttosto quella che si estranea e si ritira da tale
partecipazione attiva; l’altro, quale costituzione e quale disposizione si deve
ritenere migliore per uno stato, sia che tutti intendano partecipare alla vita
politica, o, se alcuni no, più sì. Ora poiché questo problema rientra nella
speculazione e nella dottrina politica e non l’altro che prende in esame ciò che
è desiderabile per l’individuo, e poiché noi ci siamo accinti sul momento a
un’indagine politica, il primo problema dovrebbe essere accessorio, il
secondo, invece, materia di questa ricerca. Che la costituzione migliore sia di
necessità quell’ordinamento sotto il quale ognuno può stare nel modo migliore
e vivere in modo beato, è evidente: si discute, invece, anche da parte di quanti
ammettono che desiderabile soprattutto è la vita vissuta con virtù, se è
desiderabile la vita politica e attiva o piuttosto quella sciolta da ogni cosa
esterna, come ad es. una qualche forma di vita contemplativa che alcuni
20
Nota il Jow. (II, 256) che il problema qui posto era stato già risolto [...]. Parrebbe quindi che Ar. Lo riprenda “as if he
were dissatisfied with his conclusion”. Ma forse tale ripresa è dovuta all’importanza dell’argomento e, più, alla
necessità di spiegare ulteriormente una tesi solo fissata, non dimostrata.
13
dicono essere l’unica propria del filosofo. Perché sono questi, più o meno, i
due generi di vita che sembra abbiano scelto gli uomini più ambiziosi di virtù,
sia tra gli antichi sia tra i moderni, voglio dire quello della politica e quello
della filosofia. E non conta poco sapere in quale dei due stia il vero, perché di
necessità chi è assennato dispone le sue cose verso il fine migliore, se a
ciascun uomo in particolare, sia collettivamente lo Stato. Alcuni ritengono che
il governo sugli altri, esercitato in maniera dispotica, comporta un’ingiustizia
suprema; in maniera conveniente a cittadini, invece, non implica ingiustizia,
ma reca impedimento al benessere personale. Altri si trovano a ragionare quasi
dal punto di vista opposto a questi: che cioè la vita attiva e politica è l’unica
adatta all’uomo, poiché ogni virtù può essere praticata da chi vive vita privata
non meno che da quanti si danno agli affari pubblici e alla politica. Alcuni,
dunque, pensano così mentre altri dicono che la forma di costituzione
dispotica e tirannica sia l’unica beata: anzi, presso alcuni popoli il fine delle
leggi e della costituzione è proprio questo: esercitare un governo dispotico
sugli altri. Perciò sebbene la maggior parte delle prescrizioni legali in vigore
presso la maggior parte degli stati si trovi, diciamo così, in condizione caotica,
tuttavia se mai c’è un fine al quale le leggi tendono, questo è in tutte il
predominio: per es. a Sparta e a Creta l’educazione e l’intero corpo delle leggi
è ordinato, più o meno, in vista della guerra:così pure tra tutti i popoli non
ellenici che sono in grado di espandersi, è in grande onore la potenza militare:
per es. tra gli Sciti, i Persiani, i Traci, e i Celti. In taluni poi, ci sono anche
delle leggi che stimolano il valore militare: [...] tra gli Sciti a chi non aveva
ucciso nessun nemico non era lecito bere alla coppa che durante certe feste era
fatta girare tra i convitati: tra gli Iberi, poi, popolo bellicoso, piantano intorno
alla tomba di un uomo tanti spiedi quanti sono i nemici che egli ha soppresso:
così presso altri popoli ci sono molte altre istituzioni del genere, talune
ratificate dalla legge, altre dalla abitudine. Eppure a chi voglia riflettere
potrebbe forse sembrare davvero strano che compito dell’uomo di Stato sia
poter esaminare i mezzi per dominare e tiranneggiare gli altri volenti e non
volenti. Come potrebbe essere degno di un uomo di Stato o di un legislatore
ciò che non è legale ? E non è legale dominare, non solo secondo giustizia, ma
14
anche contro giustizia: e si può esercitare la forza anche ingiustamente. Negli
altri campi vediamo che questo non succede: in realtà non è compito del
medico, né del pilota usare persuasione o violenza sui pazienti nel primo caso,
sui naviganti nel secondo. Eppure i più pare che ritengono il dominio dispotico
una vera forma di governo, e quel che ciascuno non crede giusto né utile per se
stesso, non si vergogna di usarlo con gli altri: in effetti costoro cercano un
governo giusto per se stessi, mentre gli altri non badano affatto alla giustizia.
Sarebbe davvero assurdo, a meno che non ci fosse una naturale distinzione tra
popoli adatti ad essere retti in maniera dispotica e altri non adatti a tale regime.
Di conseguenza, se le cose stanno in questo modo, non si deve cercare di
dominare dispoticamente su tutti ma su quelli adatti a tale regime, proprio
come non si va a caccia di uomini per un banchetto o un sacrificio, ma solo di
selvaggina a ciò adatta: e selvaggina sono gli animali selvaggi che siano
commestibili. Ma poi anche in se stesso, uno Stato potrebbe essere felice, uno
Stato cioè che fosse governato bene, sempre se si ammette che perduri uno
Stato nel suo isolamento con l’ausilio di buone leggi: in tale Stato il sistema
della costituzione non sarà diretto alla guerra né ad asservire i nemici perché si
suppone che non c’è niente di questo. E’ chiaro quindi che la preparazione
bellica, nel suo complesso, la si deve tenere in pregio non come scopo
supremo di tutto, ma precisamente in vista di detto scopo il bravo legislatore
deve esaminare come uno stato, una stirpe e ogni comunità possano
raggiungere in qualche modo un’esistenza agiata e la felicità ad essa
possibile21».
21
Aristotele, La Politica, trad. it, introd., note e ind. A cura di R. Laurenti, Bari, Laterza, 1966, pp. 318-323.
15
COMMENTO
L’ordine finale – proposto da Aristotele – è quello in cui “tutte le cose sono
ordinate insieme intorno ad un’unica cosa”.
L’“idea dell’ordine, dell’armonia universale che – come precisa Cotta – non
è più soltanto l’ordine materiale della vita che si svolge secondo i suoi ritmi
abituali”22, può esaurirsi nella “concreta esistenza della polis” ?
La
risposta
sembra
negativa,
soprattutto
se
connessa,
secondo
l’interpretazione di Lana, alle sorti della polis.
Come è possibile, in altri termini, che l’ordine, come aspirazione cui tende
l’uomo, debba concretizzarsi nelle sorti di una città stato, condividendone
inevitabilmente le sue sorti per la libertà e per la pace ?
E ancora, la consapevolezza di una “caduta” non rappresenta quella
consapevolezza dell’alternativa propria della dialettica, per l’appunto esclusa
dalla civiltà greca ?
La conclusione cui perviene Lana giunge a ritenere che questa condizione
di stato induca “per la libertà e per la pace” a cercare “un territorio proprio
nella vita individuale del singolo, nel suo rapporto con la realtà nel suo
complesso: la libertà e la pace – secondo Lana – si configurano come
conquista della libertà interiore e della tranquillità dello spirito nel rapporto
dell’uomo con le cose che sono fuori di lui e con le passioni che sono dentro di
lui”.
Questa ricostruzione consente a Lana di pervenire alla consapevolezza del
“fato” che, in ultima analisi, ispirerebbe le scelte individuali nell’esperienza
storica.
22
La pace come dimensione dello spirito, cit., p. 150.
16
Ma, mi chiedo, è possibile collocare, in una progressione filosofica, l’ordine
che “unisce armonicamente tutte le cose e tutti gli uomini nel cosmo” – che
può giustificare “l’assenso al volere del fato” – con – cito sempre Lana – “la
libertà e la pace [che] si configurano come conquista della libertà interiore e
della tranquillità dello spirito nel rapporto dell’uomo con le cose che sono
fuori di lui e con le passioni che sono dentro di lui”?
Non più quindi l’“armonia della città” – secondo l’interpretazione di Cotta
– è il “termine intermedio”, tra “l’armonia dell’anima e l’armonia del cosmo”,
ma è l’uomo ad essere in rapporto – quindi termine intermedio – tra “le cose
che sono fuori di lui e con le passioni che sono dentro di lui”23.
A cosa è dovuto questo contrasto che induce Lana a riconoscere le
osservazioni di Cotta ritenendo, in questo punto, “deboli” le sue
argomentazioni ?
E, diversamente, ma per una connessione filologica, come è possibile
ritenere, con Zampagliene, che Aristotele – costantemente citato anche da
Marsilio da Padova quanto al “Defensor pacis”- come precisa Dolcini24 - non
esprima con chiarezza una “presa di posizione” circa la pace25 ?
Alcuni opportuni chiarimenti.
Precisare che con Aristotele non sia puntualmente analizzato il rapporto
possibile tra la pace e la guerra non può indurre a ritenere che Aristotele se ne
disinteressi.
Aristotele non ignora la guerra, ne tanto meno la pace perché persegue
l’ordine “totale” che è “essenzialmente un ordine finale”.
23
La pace come dimensione dello spirito, cit., p. 17.
C. Dolcini, Introduzione a Marsilio da Padova, Roma-Bari, 1999, p. 5.
25
Secondo Zampaglione, in Aristotele l’«alternativa pace-guerra, […] non riesc[e] a trasformarsi in materia di analisi
autonoma e in base di una dottrina. Se avesse indagato più accuratamente intorno al problema – sempre secondo
Zampaglione - il filosofo avrebbe forse determinato un totale ripensamento del fenomeno guerriero, sviluppando in
maniera sistematica elementi e giudizi, che hanno in lui soltanto un valore episodico […]. Ancora. Zampaglione ritiene
che Aristotele «non pote[sse] […] ignorare l’assurdità della guerra, causa di sciagure per la popolazione di uno stato,
cioè per la maggioranza, e, in special modo, per quella classe media, alla quale egli assegnava compiti essenziali per il
mantenimento dell’equilibrio sociale. Partendo dall’osservazione della realtà, per farne il fondamento della sua dottrina
politica, egli [avrebbe] mira[to] soprattutto a catalogare i criteri del saggio governare, per porre lo statista in grado di
adottare la condotta più consona alla natura dell’uomo». (G. Zampaglione, L’idea della pace nel mondo antico, cit., pp.
79- 86.)
24
17
È questa la dimensione teorica di Lana. Ed è proprio questa dimensione,
che vive la crisi della polis, a “trascina[re] inevitabilmente con sé, nella
caduta, la democrazia, la libertà, la pace”, inducendo alla centralità dell’uomo.
Questa dimensione – propria di Aristotele – induce a ritenere che «la pace
“non costituisca un proprio ideale di vita […], ma semplicemente la
condizione preliminare, utile per realizzare quello che ciascuno pone a se
come ideale di vita»26: è questo l’“ordine finale”.
L’altra tesi – proposta da Cotta – sembra giustificata dalla filosofia
platonica.
Ecco una possibile analisi.
Nelle osservazioni che Cotta muove all’impianto teorico proposto da Lana
– sinteticamente definito come la “visione della pace per il mondo greco,
contadino”, si definisce il pensiero platonico in cui nella città – “come termine
intermedio” – risiede la “profonda correlazione tra l’armonia dell’anima e
l’armonia del cosmo”.
Non solo questo.
L’ “apparato” che il mondo greco ha dato alla definizione della pace e
quindi della guerra non può e non deve essere trascurato anche in ragione del
contributo offerto da Platone ed Aristotele alla definizione delle filosofie
giuridiche successive, tra le quali non va trascurata quella di Marsilio da
Padova, in ragione dell’opera “Defensor pacis” in cui, puntualmente, l’Autore
si affida, nel suo argomentare, all’autorità di Aristotele.
Un’immediata precisazione.
Quale la ragione per cui Zampagliene trascura l’apparato di Aristotele
quanto alla definizione della pace e della guerra, risolvendo ogni
considerazione nei «termini qualitativi e quantitativi che, proporzionalmente,
possono coinvolgere lo Stato» ?
Ancor di più. Perché Cotta ritiene che la definizione della pace, propria del
mondo greco classico, secondo cui questa “non costituisce un vero e proprio
ideale di vita […] ma, semplicemente, la condizione preliminare, utile per
26
La pace come dimensione dello spirito, cit., p. 15
18
realizzare quello che ciascuno pone a sé come ideale di vita”, appartiene al
mondo greco contadino ?
Credo che la soluzione vada ricercata nell’ordine finale prefigurato dal
mondo greco – proprio del pensiero aristotelico – che non indulge
necessariamente sulle determinazioni pratiche dell’esistenza e quindi sulla
pace e sulla guerra per la prefigurazione di un ordine finale.
Ciò che può sorprendere in questa progressione logica - che si avvale del
contributo di Lana per porre in evidenza l’apporto della filosofia aristotelica
alla definizione della pace, accolta positivamente anche da Marsilio da
Padova, costituendo motivo di riflessione - è la ragione che adotta Cotta nella
considerazione della proposta teorica formulata da Lana. Lombardo omette di
puntualizzare l’invito che Cotta rivolge a Lana: un’opportuna analisi della
definizione di ordine, così come è proposta dalla filosofia greca, appare utile al
superamento della concezione che vuole risolverla nella rappresentazione del
mondo greco contadino che, con i dovuti adattamenti, viene qui attribuita ad
Aristotele.
Questa mancata considerazione può indurre ad una più approfondita analisi
della definizione della pace proposta da Platone.
La ragione è immediata. La possibilità di considerare la città “termine
intermedio” tra “l’armonia dell’anima e l’armonia del cosmo”, che per
espressa
ammissione
appartiene
al
pensiero
platonico,
consente
di
considerarne anche la valenza pessimistica.
Più chiaramente, non deve stupire la considerazione che Platone ha della
guerra “come causa di molte sciagure”.
Come sintetizza adeguatamente Fassò, Aristotele, diversamente da Platone,
non persegue la «perfezione assoluta dell’anima e della società, ma […la]
felicità e [… il] “vivere bene”: seguendo, soprattutto riguardo al problema
dello Stato, non il metodo a priori, deduttivo, con cui Platone traeva dalla
contemplazione della Verità assoluta i principi della condotta umana, ma
19
quello a posteriori, empirico, fondato sull’osservazione dell’effettiva realtà
storica».27
Due immediate considerazioni.
In primo luogo, il perseguimento della “felicità” e del “vivere bene” – che
possono garantire la pace – sono un presupposto teorico, con un’evidente
analogia alla condizione greca che Lana sintetizza nella dimensione del mondo
greco contadino.
Indubbiamente questa dimensione non è una condizione statica della teoria
aristotelica che si dischiuda, per il perseguimento della pace, ad una
dimensione della giustizia più apertamente giuridica, considerando il rapporto
esistente tra la legittimità e l’eguaglianza giuridica.
Ancora. L’“osservazione dell’effettiva realtà storica”, che aveva indotto
Platone a trascurare una dimensione dello Stato, già storicamente data, per il
perseguimento della “Verità” assoluta, nella definizione dello stato ideale, è
vissuta diversamente da Aristotele. L’ “osservazione dell’effettiva realtà
storica”, soprattutto se criticamente fondata, consente di comporre, in una
previsione storica, il contemperamento di condizioni politiche o sociali
diverse, senza necessariamente doverle dialettizzare.
Questi esiti appariranno ancora più evidenti dalla trama dei rapporti
istituzionali che Marsilio da Padova traccerà, pervendo a discutere il piano
della legittimità dei poteri – quello temporale e quello spirituale -, come la
dimensione umana dell’eguaglianza che giunge a disciplinare anche
l’irrogazione della sanzione penale canonica.
Ma, più opportunamente, proseguiamo nella trattazione del pensiero
filosofico giuridico che Aristotele riserva alla pace nel perseguimento della
giustizia.
Immediatamente ci si avvede – dissentendo in parte con quanto espresso da
Fassò – che Aristotele, pur non discostandosi assolutamente da Platone nel
perseguimento della giustizia, assume una concezione più giuridica della
27
G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, cit., p. 83 s.
20
giustizia, accogliendo risultati a cui Platone era pervenuto nei suoi
ripensamenti teorici.
Più precisamente, Aristotele considera la “legittimità” delle leggi che
Platone solo nella redazione delle “Leggi” aveva considerato come principio
di conformità.
Ancora. L’uguaglianza era stata definita da Platone una condizione dello
“strumento etico” della legge nella “Politica”28.
Non solo questo. Ancor di più appare emblematico l’accoglimento della
“condizione della giustizia come legittimità” – come precisa Fassò – che viene
preferita all’ “uguaglianza”.
La ragione della scelta sembra anche in questo caso immediata.
La “conformità alle leggi come legittimità” è già di per sé uno strumento
etico: l’utilità del diritto – come precisa Fassò commentando Platone – deve
garantire l’uguaglianza dei diritti in tutto lo Stato.
Consideriamo ancora l’“ordine del cosmo” che in Aristotele viene definito
finale: questo rappresenta - come precisa Fassò - la “giustizia virtù completa o
generale o assoluta”29.
In che relazione può essere questa dimensione della giustizia assoluta con
una realtà storica di una città in cui regna l’ingiustizia e quindi la guerra ?
28
«Le opere di Aristotele e [… quindi] la Politica, alla quale egli affidò le sue riflessioni intorno all’organizzazione
dello Stato, non contengono una chiara presa di posizione circa [… la pace]. Le sue ricerche erano tendenzialmente
favorevoli a una spiegazione razionale e a una soluzione empirica del problema». (G. Zampaglione, L’idea della pace
nel mondo antico, cit., p. 79 sgg.). Con particolare riguardo al libro VII, è bene precisare che, secondo Platone, chi
«vuole disegnare il tipo ideale di costituzione deve conoscere la forma di vita migliore per l’uomo, a causa dello stretto
rapporto tra i due piani individuale e sociale: se quindi l’uomo deve possedere la virtù per essere felice, lo stesso s’ha da
dire per lo stato. […] Due problemi: a) quale vita è preferibile, quella politica o quella privata, b) quale l’ordinamento
migliore, posto che i più prendono parte allo stato. Opinioni diverse intorno al primo problema: c’è chi nega la
legittimità del dominio dispotico sugli altri, c’è chi l’ammette e fa di questo lo scopo unico della legislazione. Il caso di
uno stato isolato e che tuttavia è felice dimostra che la preparazione bellica (e quindi l’educazione al dominio) non può
essere fine della legislazione, ma solo mezzo per giungere alla felicità. […]. Il territorio: natura, estensione, posizione:
bisogna tener conto del mare e della terra, in modo che in guerra sia di difficile accesso ai nemici e di facile sortita per
gli abitanti e in pace renda agevole il trasporto delle merci». (Aristotele, La Politica, trad. it, introd., note e ind. A cura
di R. Laurenti, cit., p. XXXI). «Nella «Politica […] Aristotele si riferisce alle parti di un organismo animale e ai
mutamenti del corpo (Aristotele, Politica, I, 2, 1254a, 28-33; ivi, I, 3, 1302b, 34-40 - 1303a, 1-3.) per spiegare il
coordinamento tra le parti e i cambiamenti in termini qualitativi e quantitativi, che proporzionalmente possono
coinvolgere lo Stato» ( L. Russi, L’idea di pace in Marsilio da Padova, relazione al convegno “La politica prima di
Machiavelli”, Teramo, 29-30 aprile 2004, in corso di pubblicazione): «il comportamento dell’uomo e della società
costituiva la base della morale associata, sulla quale ricadeva l’obbligo di indicare agli uomini il retto comportamento
nelle loro relazioni e in quelle intrattenute con la società umana e le sue istituzioni», senza trascurare «l’opinione della
maggioranza come fondamento della volontà statale». G. Zampaglione, L’idea della pace nel mondo antico, cit., pp. 7986.
29
G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, cit., p. 84.
21
In altri termini, diversamente da Platone, in che modo è possibile vivere
l’effettiva realtà storica reagendo all’ingiustizia ed al disordine ?
Si delinea, nella condizione di Aristotele, la necessità di una “giustizia virtù
particolare” che sottratta alla dimensione della città e ricondotta all’uomo
sappia ottenere giustizia e quindi la pace, stabilendo relazioni giuridiche
intersoggettive.
In altre parole, l’ordine del cosmo, come giustizia in senso assoluto, se non
può essere garantito dalla città, termine medio rispetto all’individuo, deve
poter essere garantito dall’individuo e quindi “da coloro che vivono associati
nella dimensione intersoggettiva”: anzi – come precisa Fassò - «il medesimo
comportamento è virtù in quanto “disposizione in sé” (cioè con riguardo al
soggetto che agisce), mentre è giustizia “in quanto riguarda gli altri”»30.
Da una concezione dell’“ordine totale”, perseguita dalla virtù totale –
secondo gli insegnamenti di Socrate e Platone – si passa ad una dimensione
dell’ordine giuridico che vuole e persegue la regolamentazione dei rapporti
giuridici intersoggettivi: è “la virtù ad alterum, sociale, [… cui] Aristotele
manifestamente […] riferisce nell’ulteriore corso della sua trattazione”31.
Ancora alcune considerazioni, in proposito, utili alla comprensione di
alcune riflessioni di Cotta, nel suo dibattito avuto con Lana.
Come opportunamente precisa Fassò, Aristotele «inquadra […] la giustizia
nella concezione generale che ha della virtù [… come] disposizione
dell’animo consistente nell’osservare il giusto mezzo tra comportamenti
opposti per eccesso o per difetto […], fra due opposti vizi [… o] via di mezzo
tra il compiere ingiustizia ed il subirla».
Ancora. Il “carattere di virtù” della “giustizia” «le viene dall’essere per se
stessa medietà […] “perché essa è caratteristicamente il giusto mezzo”» e
quindi «uguaglianza […] sia con riferimento alle persone, ai soggetti, sia con
riferimento alle cose, agli oggetti»32.
Alcune immediate precisazioni.
30
G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, cit., p. 84 s.
G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, cit., p. 85.
32
G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, cit., p. 86.
31
22
Come abbiamo già detto Aristotele, avvertendo la necessità di far assumere
alla giustizia il connotato della legittimità o dell’eguaglianza, propende per la
prima. L’uguaglianza è garantita dalle leggi che perseguendo «l’utilità comune
[…] comand[ano] di operare virtuosamente».
In che modo ?
La giustizia – garantita dall’ordine giuridico – è una virtù che persegue
l’uguaglianza garantendo la medietà tra comportamenti opposti.
In altri termini, basta la “semplice conformità alle leggi”, come legittimità,
per garantire l’eguaglianza. La giustizia, infatti, è virtù proprio garantendo
l’uguaglianza tra gli opposti.
Ancora. Come è possibile che ciò avvenga ?
La giustizia, come virtù, dispone all’osservanza del “giusto mezzo”.
Le perplessità che Fassò avanza, considerando questa costruzione filosofica
aristotelica, possono essere dissipate.
In primo luogo, il tema della giustizia come virtù che dispone l’animo nel
perseguimento del giusto mezzo viene accolta da Tommaso d’Aquino che
teorizza la “sinteresi”33 come disposizione dell’animo ai principi pratici che
tendono al bene.
Anche questa osservazione deve far riflettere.
Come precisa Cotta, a queste teorizzazioni – ci riferiamo espressamente ad
Aristotele – manca la capacità di dialettizzare il bene ed il male – ricostruiti
ontologicamente – per il perseguimento della giustizia e quindi della pace,
garantendo l’ordine.
Diversamente, la scelta di Tommaso, opportunamente orientata dall’etica
cristiana, tende al bene nella consapevolezza del male.
In Aristotele ciò non può essere possibile.
Egli può solo teorizzare la giustizia dell’ordine giuridico, come virtù che
dispone al bene nella mediazione tra gli opposti, senza che questi debbano
assumere una connotazione ontologica che li escluda reciprocamente ed
ancora possano essere dialettizzati nel perseguimento della perfetta giustizia.
33
Secondo Tommaso d’Aquino, la «sinteresi non è una speciale potenza più alta della ragione o della natura ma è
l’abito naturale dei principi pratici». Summa, I, q. 39, a. 12.
23
È questa la ragione che può giustificare la collocazione teorica della
giustizia – rispondente all’ordine giuridico – nell’ampia dimensione
dell’ordine totale, senza trascurare la felicità umana, la concordia e la
tranquillità che debbono rappresentare l’ordine totale.
Una precisazione sufficientemente dedotta dalle argomentazioni proposte.
Sembra che Aristotele, nel rapportare l’ordine generale delle cose a quello
giuridico – realizzato dall’intersoggettività – ritenga che la medietà e con essa
l’uguaglianza possa rappresentare, nella particolarità, l’ordine totale.
Come è possibile per Aristotele esprimere i “precetti razionali dell’etica”,
senza dover pervenire alla dimensione di uno Stato, come “suprema realtà
etica”, secondo la formulazione platonica ?
Aristotele riconosce la necessità dello Stato, considerando il rapporto
dell’uomo rispetto alla famiglia, al gruppo gentilizio o tribù e quindi allo
Stato, senza ritenere che questo debba garantire la «Giustizia assoluta, ma
semplicemente l’assicurazione delle condizioni che permettono il “vivere
bene”».
Il campo dell’etica viene riservato alla legge che deve “rendere
praticamente efficaci i [suoi] precetti razionali”.
Questa possibilità giuridica della legge consentirà quindi – secondo
Aristotele – di potersi distaccare da uno Stato ideale per poter perseguire la
realizzazione di “quell’ordinamento secondo il quale tutti si comportano
meglio e vivono felicemente”34.
Con quale modalità giuridica ciò potrà essere possibile ?
Aristotele – come precisa Fassò – fa riferimento “ad una vita alla quale a
tutti sia possibile partecipare e ad una forma di governo di cui possano valersi
la maggior parte degli Stati”35.
34
35
G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, cit., p. 91.
G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, cit., p. 92.
24
CICERONE *
le imprese di guerra non sono poi più grandi delle civili
25
_______________________
* «Nato ad Arpino nel 106 a. C., Marco Tullio Cicerone compì i suoi primi
studi a Roma quando già vi si stava diffondendo la cultura greca; e li
perfezionò successivamente in Grecia, a Rodi, dove seguì l’insegnamento di
Posidonio, e in Asia Minore. Tornato a Roma, pur continuando nell’attività
forense, cui fin da giovane si era dedicato con successo, si diede alla vita
politica, raggiungendo le più alte cariche fino a quella di console. Travolto
dalle lotte civili al tempo del secondo triunvirato, fu ucciso da sicari di
Antonio a Formia nel 43».
Lo Stato, le leggi, i doveri
«Occorre36 ridurre il pregiudizio dei più, i quali pensano che le imprese di
guerra siano più grandi delle civili. Molti infatti spesso andarono a cercare
guerre per ambizione di gloria, e questo succede generalmente con i
temperamenti magnanimi, tanto più se sono idonei alla milizia e bramosi di
attività guerresche; ma se vogliamo giudicare secondo verità, molte azioni
civili furono più grandi ed insigni di quelle militari.
Sebbene Temistocle37 sia a buon diritto famoso, ed il suo nome, più illustre di
quello di Solone38, venga menzionato a testimonianza della famosissima
vittoria di Salamina, che fu anteposta al provvedimento soloniano di
istituzione del tribunale degli Areopagiti39, nondimeno quest’ultimo fatto è da
considerarsi più insigne del primo: quello giovò alla città una volta sola,
questo le gioverà sempre; per questa deliberazione si custodiscono le leggi
36
XXII. [74].
«Temistocle […] uomo politico ateniese nato verso il 525 a.C. da nobile famiglia. Nel 493 occupò la carica di arconte
e, interpretando le esigenze della classe mercantile e democratica, diede inizio alla politica navale che doveva fare di
Atene la città più importante della Grecia. Guidati da Aristide, gli si opposero accanitamente i nobili e gli agrari, i quali
ritenevano che fosse necessario potenziare l’esercito più che la flotta […]. Morì nel 461 a. C.». G. Fassò, Storia della
Filosofia del diritto, Bologna, 1966, vol. I, p. 23.
38
« Solone, nato ad Atene intorno al 640 a. C. e annoverato tra isette sapienti, fu arconte nel 594. Dopo avere realizzato
le sue riforme si recò in Egitto e a Cipro; ritornatoad Atene verso il 580, mise in guardia gli ateniesi contro le
aspirazioni di Pisistrato alla tirannide. Visse gli ultimi venti annilontano dalla vita politicae morì nel 560. Dei suoi 5000
versice ne restano non più di 250, fra I quali alcune elegie come l’Eunomia e l’Elegia alle Muse». Manuale di storia del
pensiero politico, a cura di C. Galli, Bologna, 2001, p. 26.
39
Cfr. De repubblica, I, 27,43.
37
26
degli Ateniesi e le istituzioni degli antenati. Mai Temistocle potrà citare
alcunché in cui egli abbia giovato all’Areopago, mente l’Areopago potrà
veracemente affermare che Temistocle fu aiutato da esso, chè la guerra fu
condotta per decisione di quel consesso che fu istituito da Solone40. Il
medesimo si potrebbe dire di Pausania e di Lisandro41: sebbene si ritenga che
l’impero spartano sia stato fondato dalle loro imprese, tuttavia queste vanno
confrontate in non minima parte con le leggi ed il costume instaurato da
Licurgo42; ché, appunto in grazia di queste, quei due poterono valersi di
eserciti più disciplinati ed efficienti. A me d’altronde né durante la mia
infanzia M. Scauro sembrava essere inferiore a G. Mario43, né, quando già ero
entrato nella vita politica, Q. Catulo a Gneo Pompeo44: poco infatti valgono le
armi all’esterno, se non v’è senno all’interno. Né l’Africano, uomo condottiero
più unico che raro, giovò allo Stato distruggendo Numanzia di quanto non [...
fosse stato] fatto [...] con la soppressione di Tiberio Gracco45, sebbene
quest’azione non rientri soltanto nell’ordine della politica interna, ma tocchi
anche quella militare, essendo stata condotta con la forza ed il valore; pur
tuttavia fu compiuta senza bisogno di un esercito e con un atto di politica
interna. Ottimo è quell’aforisma che spesso viene bersagliato dai birbanti e
dagli invidiosi:
Cedano l’armi alla toga, si ritiri l’alloro innanzi alla gloria civile46.
Per non dire di altri infatti, le armi forse non s’inchinarono alla toga allorché
noi governavamo la repubblica ? Né mai vi fu maggior pericolo per la
repubblica né insieme maggiore tranquillità. Così per le nostre misure e la
nostra diligenza ebbero a cadere scivolando loro in mano le armi dei più
40
Cfr. ARISTOTELE, Athenensium respublica, XIII, I, in cui si ricorda l’intervento dell’Areopago con lo stanziamento
di fondi speciali per trattenere dallo sbandamento gli strateghi alla vigilia della battaglia di Salamina.
41
Ambedue spartani, vinsero il primo I Persiani a Platea nel 479 a. C., il secondo gli Ateniesi ad Egospotaini nel 405.
42
Cfr. De repubblica, II, 2, I.
43
M. Emilio Scauro, autore di un’autobiografia d’intonazione apologetica, console nel 115 e nel 108 a. C., fu esponente
del partito aristocratico, avversario dei Gracchi e di Mario.
44
Lutazio Catulo, il figlio del vincitore dei Cimbri, fu console nel 78 e in seguito avversario del primo triunvirato.
Amico di Cicerone, fu il primo a salutarlo col titolo di «Padre della patria». Pompeo Magno, il noto rivale di Cesare, fu
console nel 70, nel 55 e nel 52 a. C.
45
Cfr. De republica, I, 3, 6.
46
Citazione dal poema autobiografico De meo consulatu; per le reazioni di Cicerone alle critiche degli avversari sulla
sua vanità cfr. Philippicae, II, 8, 20.
27
spericolati cittadini47. Qual mai impresa così grande venne fatta in guerra ?
qual trionfo si sarebbe dovuto decretare ? […].
Le forti imprese civili non sono dunque inferiori alle militari, ed in esse è da
porre anche maggiore fatica ed impegno che nelle seconde. […].
[…] Ma quell’onestà48 che cerchiamo tutta consiste nella cura e nel pensiero
dello spirito; e sotto questo aspetto non recano minor utilità coloro che in toga
presiedono lo Stato, di coloro che fanno le guerre. Per deliberazione dei primi
spesso non vennero iniziate talune guerre, altre vennero condotte a termine, e
talvolta anche dichiarate, come la terza guerra punica per consiglio di M.
Catone, il cui prestigio valse anche dopo morto49. Si aspiri perciò piuttosto alla
prudenza del deliberare che alla prodezza del combattere, ma bisogna
guardarsi dal farlo più per evitare il combattimento che per un criterio di
utilità. La guerra poi venga intrapresa in modo che null’altro sembri esserne
l’obiettivo se non la pace stessa […]
In relazione50 alla distruzione delle città bisogna ponderare bene, che non si
agisca avventatamente né crudelmente. E’ del magnanimo punire i colpevoli
nelle sedizioni, salvare il popolo, mantenere rettitudine ed onestà in ogni
evenienza. Come infatti vi sono di coloro, come dissi sopra, che antepongono
le attività militari alle civili, così ne potresti trovare molti, per i quali le
decisioni rischiose ed avventate sembrano più grandi e splendide di quelle
quietamente ponderate»51.
47
Allusione alla repressione della congiura catilinaria.
XXIII.
49
In quanto la distruzione di Cartagine, avvenuta ad opera di Scipione Emiliano tre anni dopo la sua morte, era il
risultato soprattutto dell’insistente campagna di persuasione condotta da Catone nei suoi ultimi anni.
50
XXIV.
51
Cicerone, Opere politiche e filosofiche, a cura di L. Ferrero, Torino, Utet, vol. I, Lo Stato, Le leggi, I doveri, pp. 3769.
48
28
COMMENTO
Marco Tullio Cicerone «faceva coincidere con la pace la finalità di ogni
conflitto, sostenendo che il negoziato era preferibile all’impiego della forza
nella risoluzione delle controversie tra popoli, e che gli obiettivi della pace
erano superiori a quelli della guerra. “Poiché - secondo Cicerone - molte
persone ritengono che la guerra sia preferibile alla pace, è il caso di correggere
questa idea. Molti uomini cercano infatti le occasioni di guerra per avidità di
gloria. Questo si è verificato nel caso di uomini magnanimi e dotati di
ingegno, specie se sono idonei alle attività militari e desiderosi di battersi. Ma
se vogliamo giudicare serenamente la realtà, dobbiamo concludere - secondo
Cicerone - che esistono attività pacifiche più grandi e più nobili di quelle
guerriere”.
Questo non […] vietava [a Cicerone] di giustificare il comportamento feroce
dei combattenti, nella misura in cui affrettava la vittoria di chi militava dalla
parte del diritto. La giustizia, intesa piuttosto in senso giuridico che morale,
ispirava dunque vari atteggiamenti di questo celebre autore. E se, malgrado
tutto, alla guerra si doveva ricorrere, questo doveva avvenire nel rispetto delle
regole di diritto comunemente accettate. [… Cicerone] affermava infatti:
“Ingiuste sono le guerre dichiarate senza che si sia subita una provocazione.
29
Soltanto quelle intraprese in vista di una ritorsione o per respingere il nemico
sono da considerare giuste ... Nessuna guerra è giusta se non è stata
proclamata o dichiarata e se una riparazione non è stata dapprima richiesta”. E
ancora: “La sola ragione per intraprendere una guerra è che si possa più tardi
vivere in pace e sicurezza. Dopo la vittoria noi dovremmo risparmiare quanti
non hanno agito da sanguinari o da barbari nel loro modo di combattere”.
Quanto poi alla tecnica del combattimento, Cicerone affermava che il grado di
violenza impiegata doveva variare a seconda degli avversari. Bisognava infatti
comportarsi con minore crudeltà se appartenevano a una stirpe, con la quale
fosse possibile l’intesa, mentre si dovevano applicare i metodi della guerra
totale quando lo scopo finale del conflitto era l’annientamento del nemico.
[…].
In Cicerone agiva […] una lievitazione ideale […] che dirigeva gli uomini
verso una tendenziale solidarietà; troppo spesso tuttavia essa restava soffocata
da considerazioni di opportunità e dalla necessità di adottare soluizioni dettate
da convenienza politica, simboleggiata dalla guerra e non dalla pace. […]…
“Quale è dunque - secondo Cicerone - l’obiettivo, al quale debbono dedicarsi i
reggitori dello stato, e a cui debbono dirigere il loro corso ? E’ quello
considerato ottimo e sommamente desiderato da tutti gli onesti, i buoni e i
prosperi. Pace con dignità. Quanti la sollecitano sono considerati i migliori.
Quanti vi pervengono sono uomini sommi e salvatori dello stato»52.
52
G. Zampaglione, L’idea della pace nel mondo antico, cit., p. 218 s.
30
SENECA*
non fare la guerra neppure se ci porta alla pace
31
_____________________
* Lucio Anneo Seneca, nato a Cordova il 4 a. C., si trasferì a Roma, dove
studiò retorica e filosofia; nel 31 d. C. intraprese la carriera forense e iniziò
quella politica. Relegato per otto anni in Corsica, tornò a Roma nel 49,
divenendo precettore di Nerone. Nel 62 lasciò la corte e nel 65, coinvolto nella
congiura antineroniana di Pisone, si tagliò le vene su ordine dello stesso
imperatore.
Questioni naturali
«Quale follia […] ci esagita e ci dispone […] l’un contro l’altro perché ci
distruggiamo a vicenda ? Diamo le vele ai venti in cerca della guerra e
corriamo dei rischi53, tentiamo la sorte con le sue incertezze, la violenza delle
tempeste che nessuna forza umana può superare e una morte senza speranza di
sepoltura. Non ne valeva la pena, neppure se questi pericoli ci portassero alla
pace: ora invece, una volta scampati a tanti scogli nascosti e alle insidie del
mare disseminato di bassifondi, una volta sfuggiti alle cime tempestose dei
monti che scatenano un vento impetuoso giù sui naviganti, e ai giorni avvolti
da un cielo plumbeo e alle notti orrende di nembi e di tuoni e ai rottami dei
naufragi causati dalle bufere, quale sarà il frutto di tali fatiche e timori, quale
porto ci accoglierà stanchi da tante disgrazie ? La guerra appunto e il nemico
che si fa incontro sul lido e genti da trucidare, ma che trascineranno nella loro
rovina gran parte dei vincitori, e l’incendio di antiche città. Perché
costringiamo i popoli ad imbracciare le armi ? Perché arruoliamo eserciti che
si dovranno schierare in ordine di battaglia in mezzo ai flutti ? Perché
turbiamo la pace dei mari ? A quanto pare la terra non ci offre uno spazio
abbastanza comodo per morire. La sorte ci tratta con troppa delicatezza, ci ha
53
Cfr. l’analoga espressione pliniana (Nat. Hist., II, 125): piratae primum coegere mortis pericolo.
32
dato dei corpi troppo solidi, una salute prospera, gli incidenti non piombono su
di noi per annientarci, a ciascuno è permesso di trascorrere piacevolmente i
suoi anni fino alla fine e di raggiungere la vecchiaia avanzata: e allora
avventuriamoci sul mare e invochiamo contro di noi i fati che non si decidono
a colpirci. Infelici, che cosa cercate ? la morte, che è in agguato ad ogni angolo
? Essa vi raggiungerà anche nel vostro letto, ma procurate che vi trovi
innocenti; vi sorprenderà in casa vostra, ma non vi sorprenda intenti a tramare
il male. In verità, come altrimenti si potrebbe chiamare se non follia questo
comportamento di chi diffonde intorno a sé i pericoli e si scaglia contro coloro
che non conosce, distruggendo in preda all’ira ciò che gli si fa incontro senza
recargli offesa e trucida chi non ha motivo di odiare, come fanno le bestie
feroci ? Queste tuttavia mordono per vendicarsi o spinte dalla fame: noi
muoviamo gli eserciti e facciamo salpare le flotte senza risparmiare
minimamente il nostro e l’altrui sangue, affidiamo la salvezza ai flutti, ci
auguriamo venti favorevoli, considerandoli propizi quando ci portano senza
ostacoli alla guerra. […]54.
[… La] natura avrebbe agito meglio nei nostri confronti, se avesse impedito ai
venti di soffiare e proibendo le scorrerie dei pazzi, avesse costretto ciascuno a
restare nella propria terra: se non altro, certamente ciascuno nascerebbe
soltanto per far male a sé e ai suoi; ora invece non mi bastano i mali di casa
mia, devo soffrire anche a causa di quelli esterni. […] Nessuna terra è così
remotamente lontana da non poter esportare un male che nutre in sé: come
posso sapere se in questo momento un qualche tiranno di una grande nazione
in qualche paese sconosciuto, inorgoglito per il favore della fortuna, non
trattenga le armi dentro i confini, o allestisca flotte macchinando oscure trame
? Come posso sapere se questo o quel vento mi porta la guerra ? Sarebbe stato
molto importante per la pace fra gli uomini che i mari non fossero navigabili.
[…] Tuttavia, come dicevo […], noi non possiamo lagnarci di Dio che ci ha
54
«[…] così il re dei Persiani nella sua estrema stoltezza […], passerà in Grecia, ma il suo esercito non la vincerà pur
essendo riuscito a riempirla. Così Alessandro […] vorrà vorrà sopravanzare gli abitanti della Battriana e dell’India e
cercherà che cosa vi sia al di là dell’oceano e si sdegnerà che vi sia per sé un confine ultimo. Così l’avidità consegnerà
Crasso […] ai Parti, non lo spaventeranno né le imprecazioni del tribuno […] che tenta di dissuaderlo, né le tempeste di
un mare sterminato, né i fulmini di cattivo auspicio sull’Eufrate né l’opposizione degli dei: andrà verso l’oro sfidando le
ire degli uomini e degli dei […]».
33
procreati, se corrompiamo […] i suoi benefici e li facciamo diventare […] dei
malefici. Egli ci ha dato i venti per mantenere la giusta temperatura del cielo e
delle terre, per provocare od impedire le pioggie, per far crescere i prodotti del
terreno e i frutti degli alberi, che sono portati a maturità, insieme con altre
cause, proprio dallo scuotimento»55.
COMMENTO
« Riconoscendo che la fonte di ogni potere era ormai incarnata dal principe, la
cui volontà aveva forza normativa, lo scrittore formulava l’augurio che le sue
scelte fossero dettate dalla saggezza, dal proposito di agire da padre e non da
tiranno, dalla coscienza di dover ubbidire alle leggi e non di considerarsene
esonerato. Tutto questo per consolidare la pace che l’impero aveva assicurato
ai popoli dato che il nuovo orientamento costituzionale si identificava con la
Pax romana».
In Seneca «pace e avversione alla violenza non erano […] compiutamente
espresse in un piano organico, ma erano implicite nell’orientamento del suo
pensiero, rivolto a provare la brevità dell’esistenza e la futilità degli obiettivi,
per i quali si era soliti contendere.
Più che in un corpo di proposizioni concettuali, la dottrina di Seneca si
esprimeva in un complesso di regole di condotta, in base alle quali l’individuo
poteva regolarsi nella vita associata, evitandone pericoli e insidie. Per questo
consigliava agli esseri umani di guardarsi dall’ira, grave ostacolo al
concludersi della loro missione terrena. Seneca poneva così in risalto la
spiritualità dell’uomo, per liberarla da sovrastrutture e corrompimenti,
55
Questioni naturali di Lucio Anneo Seneca, a cura di D. Vottero, Torino, Utet, pp. 569-575.
34
destinati a indebolirne il contenuto e a limitarne l’influenza sulla vita
individuale e su quella associata. Stando al suo insegnamento, ciascuno
doveva considerare la propria esistenza nel suo insieme, respingendo ogni
impostazione frammentaria, intesa a suscitare pericolose difficoltà nella sua
esperienza umana. […]
L’organizzazione delle attività dell’individuo occupava nel pensiero di questo
scrittore un rilievo particolare, anche per le sue incidenze sul mondo degli
interessi pratici e sul quotidiano comportamento dei soggetti. Si superavano
così le valutazioni partigiane e precarie e i giudizi fondati sulla riflessione
filosofica astratta, per accogliere in loro vece una regola dettata da saggezza e
dalla effettiva ricerca della verità.
Da questa norma, anche se non lo si manifestava in maniera esplicita, ma
attraverso allusioni e una generica impostazione, la guerra, che delle turbative
suscitate dall’uomo è la più grave e delle sue azioni quella massimamente
irragionevole, non riceveva né una giustificazione, né una spiegazione».
Quale possibile conclusione.
Seneca «pronunciava [un giudizio negativo] a proposito della guerra, di cui
avvertiva gli effetti perniciosi, specie in rapporto alle prescrizioni morali
fissate per i singoli individui. Ecco come si esprimeva al riguardo: “La nostra
follia non è soltanto individuale, ma collettiva, Noi puniamo gli omicidi e le
stragi isolate. Ma che dire delle guerre, del reciproco omicidio tra nazioni,
crimine coronato di gloria ? Allora la cupidigia e la crudeltà non conoscono
freni. Queste calamità, se si compiono nell’ombra e per iniziativa di una sola
persona sono meno perniciose e meno mostruose. Eppure i medesimi orrori si
consumano per decreto del senato e in nome del popolo si impartisce alla
massa dei cittadini l’ordine di eseguire quanto è vietato ai singoli»56.
«Con [... Seneca] inizia una tradizione di pensiero destinata a un’enorme
fortuna, la quale, constatata l’impossibilità della prassi politica, affida il
controllo del potere all’etica. Il pensiero politico si ritrova così ad
argomentare, in modo esortativo e pedagogico, a favore dell’autolimitazione
56
G. Zampaglione, L’idea della pace nel mondo antico, cit., p. 231 ss..
35
del princeps, come unica via percorribile per recuperare un rapporto positivo
tra autorità e società, tra il capo e le sue membra»57.
«Questo concetto di pace (e di libertà), che apparentemente accetta il modo di
vedere ufficiale, in realtà lo rifiuta: […] la libertà che assicura il principe è
servitù per chi non si è liberato dalle passoni»58.
«Sono parole che sembrano cristiane: eppure cristiane non sono, perché sno la
necessaria conseguenza di una impostazione della vita morale che presuppone
la negazione dei rapporti effettivi di vita con i propri simili e con la comunità
statale. In altre parole, il saggio senacano realizza la pace e la libertà non già
dentro lo Stato e operando per lo Stato, cioè per i suoi simili, ma
nell’indifferenza per lo Stato e astenendosi dal vivere per lo Stato»59.
AGOSTINO *
La pace comune e la pace cristiana
57
Manuale di storia del pensiero politico, cit., p. 52.
La pace come dimensione dello spirito, cit., p. 141.
59
La pace come dimensione dello spirito, cit., p. 142.
58
36
_________________
* «Aurelio Agostino nacque a Tagaste in Numidia, nella provincia romana
dell’Africa, nel 354, e visse perciò durante la fase più drammatica della crisi
del mondo antico, mente l’Impero romano d’Occidente si sfasciava sotto i
colpi dei barbari; al momento della sua morte, nel 430, Ippona, la città africana
di cui egli da trentacinque anni era vescovo, era assediata dai Vandali. […]
Dei numerosissimi scritti di S. Antagostino […ricordiamo] il De vera
religione (390), le Confessiones (397), il De Trinitate (399-419), il De civitate
Dei (413-427)».
La città di Dio
«Dunque è infelice il popolo estraniato da questo Dio. Anch’esso tuttavia
persegue una certa sua pace non riprovevole, che però non manterrà per il fine
perché non ne usa bene prima del fine. Ma interessa anche a noi che nel
frattempo, in questa vita, l’abbia poiché, mentre due città sono ancora
mescolate, anche noi utilizziamo la pace di Babilonia […]
La pace propriamente nostra si ha con Dio anche nel tempo mediante la fede e
nell’eternità si avrà con lui nella visione. Ma nel tempo tanto la pace comune
come quella propriamente nostra è pace più come sollievo dell’infelicità che
come godimento della felicità. Anche la nostra dignità morale, sebbene sia
vera in riferimento al vero fine del bene al quale si rapporta, è così relativa in
questa vita da consistere più nella remissione dei peccatoi che nella pienezza
della virtù. […]
Infatti la ragione, sebbene sottomessa a Dio, tuttavia nell’attuale soggezione
alla morte e nel corpo corruttibile, che appesantisce l’anima, non pienamente
domina gli impulsi, perciò è indispensabile alle persone oneste una tale
37
preghiera. Sebbene si abbia il dominio, non si ha senza contrasto il dominio
sugli impulsi. […]
E quindi, finché si esercita un dominio sugli impulsi, non v’è pace piena
perché gli impulsi che resistono sono superati con una lotta pericolosa e quelli
che sono stati superati non ancora sono debellati in un tranquillo riposo, ma
sono sempre contenuti da un affannoso esercizio della libertà60. […]
V’è poi la pace finale, alla quale si deve riferire e per il conseguimento della
quale si deve osservare l’attuale giustizia. In essa la nostra natura, liberata per
mezzo della non soggezione alla morte e al divenire, non avrà più impulsi e
non resisterà più ad ognuno di noi o tramite l’altro o da se stessa. In quella
pace dunque non è necessario che la ragione domini gli impulsi perché non ci
saranno, ma Dio dominerà l’uomo, l’anima spirituale il corpo è sarà così
grande la serenità e la disponibilità alla sottomissione, quanto è grande la
delizia del vivere e dominare. E allora in tutti e singoli questa condizione sarà
eterna e si avrà la certezza che è eterna e perciò la pace di tale felicità ossia la
felicità di tale pace sarà il sommo bene61 […]
Ma come l’infelicità è contraria alla felicità e la morte alla vita, così la guerra
appare contraria alla pace.
Perciò giustamente si pone il problema, dato che la pace è stata
precedentemente esaltata come fine degli eletti, che cosa o di quale natura al
contrario si deve intendere guerra come fine dei reprobi. Chi si pone questo
problema esamini che cosa vi sia di funesto e di esiziale nella guerra e
costaterà che non v’è altro che l’urto degli avvenimenti in reciproco conflitto.
E non si può pensare a una guerra più grave e più rovinosa di quella in cui la
volontà è contraria all’inclinazione e l’inclinazione alla volontà, in modo che
60
«Dopo aver insistito sulla contrapposizione delle due città Agostino fa riferimento ad un problema che, ferma
restando la contrapposizione, permette di cogliere nella città terrena un aspetto non riprovevole. Si tratta della pace, che
– seppure la città terrena “non manterrà per il fine, perché non ne usa bene prima del fine” […] – interessa anche gli
abitanti della città celeste che, in questo mondo, utilizzano la pace della città umana. Per quanto questa pace (la pace
comune degli uomini) non s’identifichi con la pace cristiana, che si ha con Dio (nel tempo con la fede, e nell’eternità
con la visione), l’una e l’altra pace in questo mondo si configurano “più come sollievo dell’infelicità che godimento
della felicità” […] dovuto al fatto che ci sono gli istinti e una lotta per dominarli; pertanto “non v’è pace piena perché
gli impulsi che resistono sono superati con una lotta pericolosa, e quelli che sono stati superati non ancora sono
debellati in un tranquillo riposo, ma sono sempre contenuti da un affannoso esercizio della libertà”».
61
«Invece, la pace finale si avrà non quando la ragione sarà impegnata a dominare gli istinti, ma quando Dio dominerà
l’uomo e la Gerusalemme celeste avrà trionfato sulla Babilonia terrena: allora da una parte si avrà “la pace di tale
felicità [divina] ossia la felicità di tale pace” […] e dall’altra parte “un’infelicità eterna”».
38
simili contrasti non cessano con la vittoria dell’una sull’altra, e in cui la
veemenza del dolore è in tale conflitto con la natura del corpo che l’una non
cede all’altra. In questo mondo allorché capita questo conflitto o vince il
dolore e la morte strappa la sensitività, o vince la natura e la guarigione fa
cessare il dolore. Di là invece rimane il dolore per affligere e persiste la natura
per soffrire, perché né l’una né l’altra cessa affinché non cessi la pena»62.
COMMENTO
Scheler ritiene che la pace prospettata da Agostino, in quanto “dimensione
dello spirito”, nella “condizione peregrinante dell’uomo storico”, abbia
“sempre un carattere provvisorio, fragile, precario”63.
62
«Come il fine degli eletti è la pace, così il fine dei malvagi è la guerra, da intendere come il contrario della pace […],
come il conflitto tra la volontà e l’inclinazione e viceversa, per cui il controllo sarà insanabile: ecco dunque il senso
della guerra finale come eterna dolorosa conflittualità, cui saranno condannati gli uomini che hanno vissuto secondo
Satana, mentre quelli che hanno vissuto secondo Dio godranno della pace come assoluta tranquillità».Agostino, De
civitate Dei, XIV, 28, trad. it, La città di Dio, a cura di L. Alici, Rusconi, Milano, 1984, pp. 515, 691-692; trad. it., La
città di Dio, a cura di D. Gentili, Roma, Città nuova, 1988, pp. 85 sgg.
63
«Ci sono […] - secondo Agostino - due forme di pace : la pax Babylonis e la pax Christi. La prima è una forma
inferiore, una tela di ragno che dev’essere continuamente ritessuta e che in ogni istante del tempo si rompe: provvisoria,
non mai definitiva. E’il desiderio, profondamente umano (ma universale, ci ha detto Agostino: è la legge di
conservazione dell’universo), di una vita quieta et tranquilla; e tale pace è bonis malisque communis: come il sole e la
pioggia (Mt. 5,45). Anche per questa pace il cristiano deve agire: ma, soprattutto, deve pregare per essa […]. Il cristiano
prega ed agisce per la pace di Babilonia, la chiede a Dio (mentre Babilonia non prega per essa: s’illude di poter
costruirla da sé) perché sa che è un mezzo di cui può servirsi per la sua azione di “pietà ed amore” verso Dio e verso i
fratelli. Non s’accontenta però di tal forma di pace, tanto desiderata dai più, ma così sfuggente […]. La pace diviene
sempre più, dunque, un valore religioso, e si identifica con Dio e con la vita eterna […]. La sua realizzazione completa
ci sarà dopo questa vita. In questa vita, la pace di chi non è cristiano e s’accontenta di quella tregua fra le guerre che via
via si succedono è solacium miseriae, è un tentativo di rendere meno insopportabile l’angoscia dell’esistenza consumata
nella ricerca di una felicità sfuggente e deludente; ma solacium miseriae è, anche per il cristiano, la pace che Dio gli
pone nel cuore finché è in questa vita per quel suo dominio sul male e qui provvisorio, non definitivo, non assoluto:
“giustificati dalla fede, abbiamo pace con Dio […]”. Ma Agostino non cessa di ammonirci che l’uomo è una creatura
che vive quaggiù nella condizione di ogni creatura, limitata e finita, inquieta e in lotta: se alla pace tende tutto
l’universo, se la pace è, in quanto ordine, l’essenza stessa di ogni cosa che esiste, la vita è tuttavia incessante
trasformazione, mutamento, passaggio continuo del presente al futuro […]. La pace non è mai una condizione raggiunta
definitivamente, una volta per tutte: non quella che è tregua fra l’una e l’altra guerra, e neppure quella, più alta, la sola
vera, che Dio ci offre. Ma la prima è fondata sull’egoismo, la seconda sull’amore. […]. Consapevolezza che la pace, sia
quella mondana sia quella cristiana, è conquista di ogni minuto non equivale a sfiducia, inerzia, fuga dalle
responsabilità: bisogna cercare la pace ed essere pacifici (cioè fare la pace, costruirla), pazientemente e tenacemente
[…]. La contrapposizione […] fra la pax Babylonis e la pax finalis, non è indice di pessimismo […], né di
39
L’esito è evidente . La “condizione umana” – secondo l’interpretazione che
Cotta propone del pensiero di Agostino - vive una “tensione dialettica […] che
investe […] la pace temporale”.
Ancora. Proseguendo nelle annotazioni fornite da Scheler – che interpreta
Cotta – la «tensione dialettica […] non potrà aver fine se non col
“trascendimento” garantito dalla “vita ultra terrena”» in cui “apparirà nella sua
purezza la vera pace, la pace senza turbamento”.
Un interrogativo immediato. Come può la pace, secondo l’interpretazione
che Scheler fornisce di Cotta, essere una dimensione dello spirito ? In che
modo può la pace terrena rappresentare, anche nella provvisorietà, una
dimensione dello spirito ?
Il dubbio è chiarito da Cotta, secondo l’annotazione testuale fornita dallo
stesso Scheler, quando precisa che “la pace – secondo l’interpretazione che
Cotta fornisce di Agostino – è condizione naturale della vita, di ogni vita”, ma
non è “affermazione […] in se stessa [di] un valore”.
La contraddizione appare immediata.
Come può la pace essere dimensione dello spirito, anche nel perseguimento
della condizione umana, senza tendere ad un valore che scopre solo nella
dimensione ultra terrena ?
Questa eventualità può essere ammessa solo offuscando la dimensione dello
spirito, snaturandola per poi condurla alla sua purezza rinnovata nella sola
condizione ultra terrena.
Anche quanto alla considerazione dei valori sono opportune alcune
precisazioni, ma anche una conferma delle osservazioni già esposte.
Come Scheler precisa nella puntuale trascrizione delle considerazioni di
Cotta, nell’interpretazione di Agostino, “la pace cui aspira istintivamente,
naturalmente, ogni creatura non è di per sé un valore […] poiché se non è
scetticismo[…]. Se la pace terrena, pur incerta ed instabile, fosse intesa da Agostino come pressoché impossibile, queste
parole non avrebbero senso. Piuttosto […] la pace terrena è un mezzo, non un fine. Cioè, la preoccupazione prevalente
di Agostino è di spingere i cristiani alla ricerca di quei valori assoluti e religiosi che trascendono la vita terrena. Ma
questa preoccupazione non denota pessimismo. bensì rientra nel modo tipicamente cristiano di giudizio sui valori». E.
Gallicet, Pax Babylonis, pax nostra, pax finalis: la pace in Agostino, in Atti del Convegno nazionale di studi su “La
pace nel mondo antico”, Torino, 1990, pp. 303-307.
40
orientata al vero fine, a Dio, non è da considerarsi vera pace, cioè pace nella
perfetta giustizia”64.
Un’osservazione immediata. Come è possibile che la pace come
“dimensione dello spirito” – secondo quanto precisato precedentemente – “cui
[l’uomo] aspira istintivamente, naturalmente” non dia luogo a valori adeguati
?
Con ogni evidenza preoccupa la “scelta valoriale” scandita dalla pace
terrena che può non soddisfare la “perfetta giustizia” – come dimensione del
diritto divino -.
La dimensione dello spirito nel farsi della storia può non trovare attualità
nella scelta della valutazione giuridica che la pace richiede.
Una conclusione immediata.
La dimensione dello spirito senza perdere la sua condizione ontologica che
lo indirizza alla visione divina ultraterrena, può vivere la contingenza di una
scelta giuridica di valori relativi e storici, anche in contrasto con i valori
cristiani, assoluti e intemporali.
Sono, con ogni probabilità, proprio queste le considerazioni che inducono
Cotta a negare effettività al pacifismo giuridico – come sarà precisato
appositamente nel prosieguo della trattazione – e quindi al formalismo
giuridico di Bobbio, auspicando il ricorso all’autocoscienza individuale.
64
M. Scheler, L’idea di pace e il pacifismo, Milano, 1995, p. 105.
41
TOMMASO*
La pace è quiete nell’ordine
42
_________________
* «Tommaso dei conti d’Aquino nacque nel 1225 o 1226 a Roccasecca
nell’attuale provincia di Frosinone; studiò dapprima a Montecassino, e, entrato
nell’ordine domenicano, fu […] discepolo di Alberto Magno a Parigi e a
Colonia. A sua volta insegnò, come maestro di teologia, a Parigi, e da ultimo a
Napoli; morì nel 1274 nell’abbazia di Fossanova nel Lazio […]. Nella
straordinariamente vasta opera di san Tommaso supera per importanza ogni
altro scritto la Summa theologiae».
Compendio della Somma Teologica
«La Pace65
1. Pace non è lo stesso che concordia. La pace è anche concordia, ma la
concordia non è anche pace; la concordia la possono avere anche i cattivi, ma
per i cattivi non si dà pace.
2. Ogni cosa tende alla pace, perché ogni cosa tende al suo fine, per quietarvisi
superando gli ostacoli che impediscono l’ordine naturale66, e la pace è
appunto: quiete nell’ordine.
65
Questione 29.
«Nell’ambito di [… questa definizione] si possono distinguere tre nozioni specifiche: […]. l’ordine seriale è quello
proprio della relazione di prima e dopo. [… In tal senso] S. Tommaso riprendeva la definizione di Aristotele: “Si parla
sempre di O., egli diceva, nei confronti di qualche principio. E poiché si parla di principio in molti modi; cioè secondo il
luogo, come quando si parla del punto; secondo l’intelletto, come quando si parla del principio della dimostrazione; e
secondo le cause singole; così anche si parla dell’O.” (S. Th., I, q. 42, a.3). In questo passo l’O. causale è soltanto una
esemplificazione dell’O. generale; […] la seconda specie di O. è quella che consiste nella disposizione reciproca delle
parti di un tutto […] che S. Tommaso chiamava “O. dei fini” o “degli agenti” (S. Th., I, II, q. 109 a. 6); […] infine il
terzo concetto di O. è quello di grado o livello [… che] S. Tommaso [… tratteggiava con] la distinzione tra l’O. come
gerarchia e l’O. come singolo grado della gerarchia stessa: “Nel primo senso, egli diceva, l’ordine comprende sotto di sé
diversi gradi; nel secondo è un grado solo, sicché si parla di più ordini di un’unica gerarchia” (S. Th., I, q. 108, a.2)». N.
Abbagnano, Dizionario di Filosofia, Torino, Utet, 1977, p. 639 s.
66
43
3. La pace con Dio e con gli uomini è effetto della carità, la quale pure si estende
a Dio e agli uomini.
4. La pace è un atto, un effetto della carità, ma non è una virtù distinta dalla
carità, soggetta a un precetto speciale. […]
La guerra67
1. Perché una guerra sia giusta occorrono tre cose: I. l’autorità del principe, cui
spetta la tutela dello Stato; II. La giusta causa, cioè un’offesa o un danno
ricevuti cui l’offensore non vuol dare riparazione; III. La retta intenzione, in
chi la fa, di mirare al bene e di evitare il male; e non sono rette intenzioni,
secondo S. Agostino, la voglia di nuocere, la crudeltà nella vendetta, la
libidine di dominio e l’implacabilità dell’animo.
2. Il fare la guerra è affatto sconveniente agli Ordinati per le inquietudini che
cagiona e perché ad essi, che trattano il Sangue di Cristo, compete non di
uccidere e versare l’altrui sangue, ma di essere pronti a versare il proprio. Per
cui è stabilito che siano irregolari coloro che anche senza colpa versano
sangue.
3. Gli stratagemmi che consistono nel dire bugie e nel mancare alla fede data
sono illeciti; ma gli stratagemmi di finte e di diversivi per occultare al nemico
gli obiettivi e i piani sono leciti.
4. L’osservanza delle feste non impedisce ciò che è ordinato alla salute anche
corporale, perciò, se è necessario, è lecito combattere anche in giorno di
festa»68.
67
Questione 40.
68
G. Dal Sasso – R. Coggi, Compendio della Somma Teologica di S. Tommaso d’Aquino, Bologna,
Edizioni Studio domenicano, 1989, p. 213, 221. A questa versione sono state aggiunte alcune precisazioni
esplicative.
44
COMMENTO
«Nella dottrina dello Stato [ di Tommaso] è […] visibile l’influsso di
Aristotele, ed anche evidente è la differenza fra la teoria tomistica e quella di
S. Agostino. Per S. Tommaso lo Stato è un prodotto naturale e necessario alla
soddisfazione dei bisogni umani, esso deriva dalla natura socievole dell’uomo
e, sussisterebbe anche indipendentemente dal peccato. Lo Stato ha per compito
di garantire la sicurezza degli uomini consociati e di promuovere il bene
comune [e quindi la pace]; esso è un immagine del regno di Dio. Con ciò si ha
quindi una riabilitazione del concetto dello Stato, in confronto alla teoria di S.
Agostino. Tuttavia non muta la concezione fondamentale in questo senso,
perché anche S. Tommaso concepisce lo Stato come subordinato alla chiesa,
della quale è vassallo e alla quale deve sempre obbedire, aiutandola per
raggiungere i suoi fini. Uno Stato che si opponga alla Chiesa non è legittimo,
non può esistere; il papa come rappresentante del potere divino ha il diritto di
punire i sovrani, e può dispensare i sudditi dal dovere di obbedienza verso di
45
essi, sciogliendoli dal giuramento di fedeltà. Ciò ha grande importanza nella
storia politica del Medio Evo»69.
Un’opportuna precisazione. Tommaso chiarisce che «ogni cosa tende alla
pace, perché ogni cosa tende al suo fine [… per] l’ordine naturale»70.
Quale la conseguenza, quanto al rapporto tra l’ “ordine naturale e il cittadino”
?
«Secondo S. Tommaso, Dio trae dal nulla tutti gli esseri, ma gli esseri creati,
sospesi all’atto della libera volontà creatrice, fanno parte di un ordine naturale,
che è letto dalle leggi della casualità. […] Ci sono, dunque, due ordini di
realtà: l’ordine naturale e l’ordine soprannaturale; e nell’ordine naturale rientra
l’attività del cittadino. Appare allora rivoluzionaria la tesi tomista secondo cui
le quattro virtù cardinali (giustizia, fortezza, prudenza e temperanza), senza le
tre virtù teologali (fede, speranza e carità [“la pace è un atto, un effetto della
carità”] ) “erano perfettamente sufficienti a definire virtuosa un’azione basata
su di esse”»71.
Come si perviene alla guerra ?
Con «S. Tommaso vengono teorizzate le condizioni - una formale e obiettiva,
le altre due sostanziali ma soggettive - di una guerra giusta. Esse sono: 1) la
dichiarazione di guerra deve essere fatta dall’autorità legittima; 2) deve
sussistere una “giusta causa”; 3) il belligerante deve avere una retta intenzione.
Una quarta condizione, precisata dalla dottrina, sarà quella della necessità,
ossia dell’impossibilità di farsi giustizia con altri mezzi». (U. Gori, Guerra, in
Dizionario di politica, diretto da N. Bobbio- N. Matteucci, Torino, 1976, p.
460).
Un interrogativo immediato. L’ammissione della guerra giusta può
vanificare la dimensione positiva del “pacifismo cattolico romano” ?
Scheler
ritiene che “un pacifismo cristiano pienamente positivo è
impossibile” perché «contrasta con la teoria di Tommaso di Aquino che
ammette la guerra “giusta” (di difesa)»72.
69
G. Del Vecchio, Lezioni di Filosofia del diritto, Roma, 1936, p. 48.
G. Dal Sasso - R. Coggi, Compendio della Somma teologica di S. Tommaso d’Aquino, Bologna, 1989, p. 213.
71
G. De Rosa, Storia medioevale, Roma, 1980, p. 197 s.
72
M. Scheler, L’idea di pace e il pacifismo, cit., p. 151.
70
46
Anche in questo caso può sovvenire, per il pacifismo cattolico romano,
anche il pensiero di Agostino.
Senza voler fondare ontologicamente la “guerra giusta”, come è possibile
negare che la dimensione dello spirito possa ricercare la perfetta giustizia
ricorrendo alla guerra ?
Secondo l’interpretazione che Zolo dà della dottrina etico-teologica,
esponendo il pensiero filosofico-giuridico di Bobbio, quanto alla pace, il
«iustum bellum [… non è] un tentativo di sottoporre la guerra a regole morali,
ma, nella sostanza, un cedimento morale alle ragioni della guerra. […] Pur
essendo una teoria intermedia tra il bellicismo e il pacifismo, la teoria del
iustum bellum – secondo l’interpretazione che Zolo da di Bobbio – è stata
usata prevalentemente, a partire da Agostino, per negare la validità del
pacifismo e per ammettere come possibili le finalità etiche della guerra»73.
È possibile la resistenza all’autorità ?
«Il fine morale per cui esiste il governo politico implica che l’autorità sia
limitata ed esercitata solo in conformità alla legge. […] La resistenza è
giustificabile quando avviene per comune volontà popolare e quando il diritto
è salvaguardato dalla condizione morale che coloro che resistono sappiano
agire in modo meno nocivo al bene generale di quel che non sia l’abuso al
quale si oppongono. la sedizione è considerata un peccato mortale; ma
Tommaso non chiama sedizione la resistenza giustificata a un tiranno»74.
73
74
D. Zolo, I signori della pace. Una critica del globalismo giuridico, Roma, 1998, p. 72.
G. H. Sabine, Storia delle dottrine politiche, Milano, 2003, p. 192 s.
47
DANTE*
Sotto l’unità della pace … il genere umano cerca
di avvicinarsi alla perfezione di Dio
48
_______________
* «Dante Alighieri, nato a Firenze nel 1265, nel 1300 fu nominato priore. Nel
1301 si recò presso Bonifacio VIII per cercare di ostacolare le sue mire su
Firenze e di mitigare la sua avversione verso i Guelfi “bianchi”. Saliti al potere
i “neri”, mentre si trovava a Siena, fu condannato nel 1302 all’esilio per due
anni e successivamente al rogo in contumacia. Costretto a errare per le città e
le corti settentrionali, si illuse di poter rientrare in patria in occasione della
discesa in Italia di Arrigo VII (1310), ma l’opposizione dei fiorentini e la
morte di Arrigo fecero naufragare le sue speranze. Fu autore del De
Monarchia, (1312-13). Morì esule a Ravenna nel 1321».
La Monarchia
«[…] il genere umano può essere governato da un solo principe supremo, cioè
dal Monarca. E, a proposito di questa affermazione, c’è da considerare che,
quando si dice “il genere umano può essere governato da un solo principe
supremo”, ciò non deve significare che le più minute decisioni di qualunque
municipio possano provenire direttamente solo da lui – anche se le leggi
municipali talvolta siano difettose e abbiano bisogno di criteri interpretativi
generali, come con chiarezza leggiamo nel quinto libro dell’Etica
Nicomachea, lì dove il filosofo raccomanda l’equità -75. D’altronde i popoli, i
regni e le città hanno in sé76 caratteristiche peculiari che è opportuno siano
regolate da leggi differenziate: infatti la legge è regola direttiva della vita. […]
Ma questo è piuttosto il senso della predetta espressione: il genere umano deve
essere governato dal Monarca, per ciò che concerne le regole valide per tutti, e
75
In Aristotele (Eth. Nic.. V, 14 1137 a 31 – 1138 a 2) troviamo raccomandata l’equità (nel testo epyikiam , gr.
Epieíkeian) che è appunto un criterio interpretativo generale, supplente al difetto della norma positiva, quando
quest’ultima non riese a coprire la varia casistica delle situazioni concrete. E’ la stessa iustitiae ratio et communis
utilitas (S. Tomm., Summa theol. II II, q. 120, a 1) ad esigerla. Cfr. anche Decr., c. I, D. I, Omnes.
76
Seguo il Ricci nell’adottare la correzione intra se, motivata dal contesto, in luogo dell’inter se della tradizione, anche
se non sono banali i motivi della preferenza accordata dal Nardi a quest’ultima lezione.
49
deve essere guidato, con una norma valida universalmente, al conseguimento
della pace. Questa norma, o legge, i singoli principi debbono riceverla da lui,
nello stesso modo in cui l’intelletto pratico, per arrivare alla conclusione
sfociante nell’azione, riceve la premessa maggiore dall’intelletto speculativo e
subordina a questa la particolare che è propriamente sua […].
Infatti, così come il singolo uomo che si trovi nella migliore disposizione e
dell’anima e del corpo, costituisce una sorta di concordia – e nello stesso
modo una casa, una città, un regno – altrettanto si verifica per tutta l’umanità;
quindi l’ottima disposizione di quest’ultima dipende dall’unità che si trova nei
voleri. D’altra parte ciò non può accadere, se non vi sia un avolontà unica che
domini e diriga tutte le altre, riconducendole ad unità; mentre i voleri dei
mortali, adescati dagli allettamenti tipici della gioventù, hanno bisogno di una
guida superiore. Questo insegna negli ultimi passi dell’Etica Nicomachea il
Filosofo77. Però, tale volontà non può essere unica, se non vi sia un principe
unico per tutti, il cui volere possa dominare e dirigere tutti gli altri. Pertanto,
se tutte le deduzioni surriferite sono vere, come lo sono in realtà, è necessario
che nel mondo vi sia il Monarca, il quale assicuri le condizioni ideali per
l’umanità; di conseguenza la Monarchia è indispensabile al benessere del
mondo78.
[…] Conferma79 quanto sopra esposto un avvenimento memorabile, vale a dire
quella condizione particolare dell’umanità che il Figlio di Dio, in procinto di
diventare uomo per la salvezza dell’uomo, attese, o meglio, quando egli stesso
volle, predispose80. Infatti, se ripercorriamo con il pensiero la situazione del
genere umano nelle varie epoche, ad iniziare dalla caduta dei primi genitori,
punto di partenza deviante di tutti i nostri errori, troveremo che solamente
sotto il regno del divino Augusto, grazie all’esistenza di una monarchia
perfetta, il mondo fu dappertutto in pace81. E che allora il genere umano sia
77
La fonte è Alberto Magno, De nat. Loc., III, 38, secondo il quale, il circolo equinoziale (equatore) divide la terra in
due parti uguali. [...].
78
Exod. 18, 10 sgg.; Deut. 1, 10 sgg.
79
XVI.
80
Sono qui sottolineate le premesse ontologiche, nonché prospettate le implicazioni pratiche del concetto di unità. Tra
ente (ciò che è), uno e buono (nozioni trascendentali, generalizzate dell’ente), c’è stretta relazione, tenendo presente
l’ordine di priorità che fa dell’ente la radice degli altri due concetti. [...].
81
Aristotele, Metaph. X, 2 10053 b 20-28; 1054 a 9 -13.
50
stato felice nella tranquillità della pace universale, lo attestano tutti gli storici, i
poeti illustri82 e si degnò di testimoniarlo anche lo scrittore che ci parla della
mansuetudine di Cristo. […]
D’altronde, che il popolo romano si sia proposto il […] bene con la
sottomissione del mondo intero, lo testimoniano chiaramente le imprese
compiute. Attraverso esse infatti, svincolandosi da ogni cupidigia, nemica da
sempre dello stato, e prediligendo, al contrario, la pace universale insieme alla
libertà, quel santo, pio e glorioso popolo appare aver trascurato i propri
vantaggi particolari a favore di quelli pubblici per la salvezza del genere
umano. Perciò fu scritto giustamente: “L’impero romano nasce dal Fonte della
pietà”.
Ma poiché i propositi di coloro che agiscono per la libertà scelta si
manifestarono al di fuori del soggetto solo attraverso segni esteriori, e siccome
le argomentazioni devono essere individuate in relazione alla materia trattata –
come è già stato detto -, saremo sufficientemente esaustivi, se daremo rilievo
agli inequivocabili segni attraverso i quali si manifestò il proposito del popolo
romano sia nelle istituzioni collegiali come nelle singole persone. Per quanto
riguarda gli organismi collegiali, per cui le persone sembrano legate in un
certo qual modo allo stato, basta la sola autorevole testimonianza di Cicerone
nel secondo libro Dei doveri: “Finché l’autorità dello stato fu mantenuta con la
magnanimità e non mediante le prevaricazioni, le guerre venivano condotte a
beneficio degli alleati o in difesa della sovranità, e il loro esito era mite oppure
imposto dalle circostanze. Il senato era porto e rifugio di re, popoli e nazioni e
i nostri magistrati e condottieri s’impegnavano a cogliere la gloria soprattutto
nella difesa equa e leale delle province e degli alleati. E tutto questo poteva
essere definito piuttosto “patrocinio” che “dominio” del mondo”. Tali, le
parole di Cicerone. […]
Poiché dunque il fine del genere umano è un mezzo necessario al fine
universale della natura, quest’ultima deve mirare proprio ad esso. Per tale
motivo il Filosofo asserisce giustamente, nel secondo libro della Fisica, che la
82
Aristotele, Metaph. I, 5 986 a 15-b2. Qui D. accenna alla teoria dei termini correlativi (fra i quali, cioè, nell’ambito
della logica, si verifica opposizione in seguito a relazione). [...]
51
natura opera sempre in relazione ad un fine. D’altra parte, poiché la natura non
può conseguire questo fine per mezzo di un solo uomo, in quanto sono
necessarie per la sua realizzazione molte operazioni che richiedono una
molteplicità di operatori, essa deve produrre una moltitudine di uomini
preordinati ad azioni diverse. A tale scopo molto contribuiscono, oltre
l’influenza degli astri, le virtù e le proprietà della terra. Perciò osserviamo che,
mentre individui particolari ma determinati popoli sono naturalmente portati a
dominare, altri sono adatti alla sudditanza e alla servitù, come asserisce il
Filosofo nella Politica. “E per tali uomini – così egli dice – essere governati
non solo è utile, ma anche giusto, pur se si adoperi la forza nei loro confronti”.
Se le cose stanno in questo modo, non c’è dubbio che la natura ha predisposto
sulla terra una regione ed un popolo per il governo universale: altrimenti
sarebbe mancata a se stessa; ma questo è impossibile. A proposito della
regione e del popolo, è abbastanza chiaro, in base a quanto è stato detto sopra
e a quanto verrà detto più oltre, che si tratta di Roma e dei suoi cittadini, ossia
del suo popolo. Di questo parla con esattezza il nostro Poeta nel sesto libro,
laddove introduce Anchise che fa tale vaticinio ad Enea, quale padre dei
Romani:
Plasmeranno altri più mollemente bronzi animati – sia pure – e trarranno volti
viventi dal marmo, più abili peroreranno cause, le vie del cielo disegneranno e
prediranno il sorgere degli astri: tu, o Romano, a dominare e governare i
popoli, ricorda.
Queste le tue arti: dettar norme per la pace, perdonare chi soggiace e debellare
i superbi.
E inoltre nel quarto sottolinea con efficacia la qualità preordinata della
regione, quando introduce Giove che parla di Enea a Mercurio in questi
termini:
Non costui ci promise la bellissima madre, e due volte perciò dalle greche
armi lo salvava; ma colui che, feconda di dominio e fremente in guerra, l’Italia
avrebbe retto.
52
Ancora una volta si è persuasivamente dimostrato che il popolo romano è stato
predisposto dalla natura a comandare: quindi esso, con il sottomettere il
mondo, è pervenuto all’impero di diritto.
[…] Anche per afferrare83 con sicurezza la verità di quanto s’indaga, bisogna
sapere che il giudizio divino, a proposito degli accadimenti, è talvolta palese e
talvolta occulto agli uomini. Esso può manifestarsi in due modi: attraverso la
ragione e la fede. Dunque, vi sono alcuni giudizi di Dio che la ragione umana
può pervenire a conoscere con i propri mezzi: ad esempio, il caso in cui un
uomo si offra per la salvezza della patria. Se infatti la parte deve esporsi per la
salvezza del tutto, dal momento che l’uomo è parte della città, - come è
dimostrato dal Filosofo nella Politica - l’uomo deve esporsi per la patria, in
quanto bene minore a vantaggio del maggiore. Pertanto Aristotele dice
nell’Etica Nicomachea: “Se è amabile il bene concernente il singolo, ancora
più bello e divino è quello relativo ad un popolo e alla città”. E questo è un
giudizio di Dio; in caso diverso la ragione umana non si adeguerebbe, nelle
sue rette concezioni, all’intenzione della natura: il che è impossibile. Vi sono
invece alcuni giudizi divini che l’intelletto umano non può arrivare ad
indagare con le proprie forze […].
[… Le] mete e i relativi mezzi ci sono stati bensì indicati, gli uni, dall’umana
ragione che si dispiegò a noi totalmente per mezzo dei filosofi, gli altri, dallo
Spirito Santo che rivelò la verità soprannaturale, a noi indispensabile, grazie ai
profeti e agiografi, a Gesù Cristo figlio di Dio a lui costerno, e ai suoi
discepoli. Tuttavia, l’umana cupidigia li porrebbe in sottordine, se gli uomini,
come cavalli, vaganti nella loro bestialità, non venissero domati per via “con la
briglia e col freno”. Per tale motivo l’uomo necessitò di una duplice guida, con
riguardo al suo duplice fine: da una parte, il Sommo Pontefice che guidasse
alla vita eterna il genere umano, conformemente alla Rivelazione; dall’altra,
l’Imperatore che lo indirizzasse alla felicità temporale in linea con gli
ammaestramenti filosofici. Ma, siccome nessuno o in pochi – e questi con
soverchia difficoltà –possono pervenire a questo porto, a meno che siano
sedati i flutti della carezzevole cupidigia e il genere umano viva affrancato
83
VII.
53
nella serenità della pace, essa è la meta alla quale deve tendere con ogni
mezzo colui che ha cura del mondo, cioè il Principe romano. Solo così si potrà
vivere liberamente e pacificamente in questa aiola dei mortali. E poiché la
disposizione del mondo terreno è determinata da quella inerente al movimento
circolari dei cieli, è necessario, affinché gli utili insegnamenti della libertà e
della pace si adattino opportunatamente ai luoghi e alle circostanze, che il
sovrintendente del mondo sia istituito da Colui che con il suo sguardo
abbraccia simultaneamente tutta la disposizione dei cieli. Egli solo infatti la
stabilì preventivamente e provvide per suo mezzo al legame intercorrente fra
ciascuna creatura e il posto che a questa compete»84.
COMMENTO
«Allorché la lotta fra Chiesa e Impero si acutizzò con la crescente
affermazione delle due potestà, la teoria politica che più larga fortuna ebbe
nella pubblicistica medievale fu quella dei due “magna luminaria”. Il motivo
ricorre insistentemente presso gli scrittori, e si riconnette all’uso della
simbologia così caro alla letteratura del tempo. […]
Dante, immerso nella cultura del suo tempo, fa anch’egli uso dei suddetti
simboli: ma l’uso non è sempre uniforme, sicché gioverà chiarire in qual
rapporto i vari paragoni stiano fra loro e con gli schemi dell’epoca. Il passo
più noto, e certo il decisivo, è quello del De Monarchia (cap. V), nel quale, del
resto, si risolve l’assunto dell’opera, e in cui viene dimostrato che la luna (il
temporale) ha una sua luce e funzione propria non dipendente da quella del
sole (lo spirituale), ma tuttavia è debitrice al sole di una maggiore infusione di
splendore, cioè di grazia. Sulla portata di tale paragone dantesco abbondano i
commenti, che non hanno voluto prescindere, com’è giusto, dalla valutazione
del pensiero espresso nelle altre opere dell’Alighieri. […]
84
Dante Alighieri, Monarchia, a cura di M. Pizzica, introd. di G. Petrocchi, Milano, Rizzoli, 1988, p. 201, 207, 251,
263, 265, 343.
54
Ma si potrà ritenere che Dante abbia peccato di soverchia illusione,
supponendo l’esistenza di un’epoca contrassegnata da una felice convivenza
dei due poteri ?»85
«La Monarchia dantesca deve essere […] letta come momento di sconforto
dell’Alighieri verso la città natale e come ricerca di un’entità politica che
possa garantire una pace per l’intero genere umano.
Nell’Alighieri la pace è determinata dall’esistenza di un sovrano, poiché
“questa volontà unica non può esistere, se non esiste per tutti un unico
principe, la cui volontà possa essere sovrana e capace di regolare tutte le
altre”; ma nel momento in cui vive nella pace terrena, l’uomo “si trova
liberamente e facilmente nella sua propria attività che è quasi divina”. In
Dante il processo ascensionale porta necessariamente dall’unità al bene e
all’ente supremo, per cui sotto l’unità della pace, sotto l’egida di un monarca
universale, il genere umano cerca solo di avvicinarsi alla perfezione del bene
di cui Dio ha improntato tutto l’universo in una simbiosi tra civitas dei e
civitas humana »86.
Quale rapporto si stabilisce tra la sfera spirituale e quella temporale ?
«Alla fine del trattato Dante afferma che l’Imperatore, pure essendo
sufficiente ed autonomo, deve riverenza al papa come figlio al padre. Ma
questo non basta certamente a eliminare la totale separazione delle due sfere di un Impero che può agire e guidare il mondo senza bisogno di Cristo e di una
Chiesa privata del suo compito essenziale che è quello di guidare l’uomo in
questa terra, di sopperire alle insufficienze della ragione e della natura - che il
trattato stabilisce»87.
85
R. De Mattei, Aspetti di storia del pensiero politico, I, Milano 1980, p. 199, 203.
L. Russi, L’idea di pace in Marsilio da Padova, in Atti del convegno La politica prima di Machiavelli, cit..
87
Comprendere Dante, a cura di R. Montano-U. Barra, Napoli, 1979, p. 27 s.
86
55
MARSILIO DA PADOVA *
la pace ovvero la tranquillità civile
56
_________________________
* Marsilio, nato a Padova intorno al 1285, studiò a Parigi, dove nel 1324
compose la sua opera maggiore, il Defensor pacis. Scomunicato, seguì
l’imperatore Ludovico il Bavaro e scrisse ancora il Defensor minor (1342) e il
De translatione imperii. Morì nel 1343.
Il difensore della pace
«“Gloria a Dio nei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà”3 Per
questo motivo molto spesso [Gesù] ha augurato la pace ai suoi discipli. Infatti
Giovanni scrive: “Gesù venne, si sedette in mezzo ai discepoli e disse: “Pace a
voi”.4 Per esortarli alla pace reciproca ha detto, come si legge nel vangelo
secondo Marco: “State in pace tra voi”.5 Non solo insegnava loro a vivere in
pace tra loro, ma anche ad augurarla agli altri. Infatti leggiamo in Matteo:
“Entrando in una casa salutatela dicendo: “Pace a questa casa”.6 D’altra parte
questa è stata l’eredità che egli ha lasciato ai discepoli durante la sua passione
e morte quando ha detto, come leggiamo nel capitolo 14 di Giovanni: “Vi
3
[…] Il riferimento è soprattutto a Padova, che proprio in quegli anni è in guerra con Cangrande della Scala, signore di
Verona, che si impadronità della città nel 1328 dopo diciassette anni di guerra. Tuttavia, molto probabilmente il
Padovano fa anche riferimento alla lotta tra Giovanni XXII ela lega ghibellina lombarda (dei Visconti e di Cangrande)
di cui lo stesso Marsilio è stato al servizio. Per un’approfondita prospettiva panoramica storica cfr. C. Cincin, Marsilio,
Giappichelli, Torino, 1967, pp. 30-50.
57
lascio la pace, vi dono la mia pace”.7 Come Cristo, gli apostoli, suoi veri eredi
ed emuli, sapendo che i frutti della pace sarebbero stati i migliori, come è stato
dimostrato da Giobbe e spiegato più diffusamente da Cassiodoro, la
augurarono a coloro cui indirizzavano lezioni e moniti evangelici attraverso le
loro epistole.
§2. Tuttavia, poiché “i contrari producono i contrari”,8 dalla discordia, che è il
contrario della pace, derivano frutti dannosissimi per le comunità politiche:
come si può vedere anzi è noto a quasi tutti gli uomini, a proposito dell’Italia.9
Per tutto il tempo in cui i suoi abitanti hanno vissuto pacificamente, hanno
goduto dei frutti della pace di cui abbiamo parlato, e sono progrediti così tanto
da sottomettere tutto il mondo abitato. Tuttavia, non appena sono sorte liti e
discordie tra loro, il loro regno ha cominciato ad essere tormentato da sventure
e disgrazie di ogni tipo ed a subire il dominio di detestati popoli stranieri. E,
d’altra parte, anche oggi, di nuovo, esso è lacerato, quasi distrutto, dalla
discordia così che può essere invaso facilmente da chiunque voglia o abbia il
potere di conquistarlo. Non bisogna meravigliarsi di questo evento; infatti
Sallustio, nel De bello Jugurthino, dice: “Con la concordia le piccole cose
crescono, con la discordia le cose più grandi vanno in rovina”.10 Caduti in
errore a causa sua, gli Italiani sono privati miseramente di una vita degna
dell’essere umano, poiché, invece della pace desiderata, sono sottomessi alle
pene più dure; inoltre, al posto della libertà, subiscono la dura schiavitù della
tirannide, resi più infelici in patria rispetto agli altri che vivono in una
comunità civile, tanto che il loro nome patrio, che è solito offrire gloria e
protezione a coloro che lo invocano, viene loro rinfacciato come ignominia
dalle altre nazioni.
10
[…] Da un punto di vista filologico dobbiamo precisare che il termine latino civilitas, per altro poco usato dal nostro
autore, traduce il greco politeia (“costituzione”). E’ quindi Marsilio ad utilizzarlo come sinonimo di “civitas” e
strettamente connesso al termine “regnum” (v. I, II, 2, pp. 19-21), proprio per indicare la comunità politica nel senso più
lato.
58
§ 3. Quei miseri sono dunque precipitati nelle tenebre per la loro conflittualità
reciproca, che si sa essere una cattiva disposizione dei governi civili, così
come la malattia lo è per gli animali. Malgrado le cause originarie della
discordia siano molteplici e malgrado molte siano legate tra loro, quasi tutte,
potendo manifestarsi nei modi comuni, sono state descritte dal più esimio dei
filosofi nella Scienza civile. Tuttavia, oltre quelle ne esiste una particolare e
molto nascosta, per la quale l’impero romano ha sofferto per molto tempo ed
ancora soffre; contagiosissima, ha tentato di diffondersi, strisciando, in tutte le
altre comunità politiche; ora, per la sua avidità, ha tentato di invadere la
maggior parte di essi. Né Aristotele nè nessun altro dei filosofi a lui
contemporanei o precedenti avrebbe potuto comprenderne l’origine e la
specie. Infatti essa consiste ed è consistita in un’opinione pericolosissima, che
noi
spiegheremo
più
avanti,
che
cominciò
ad
essere
considerata
occasionalmente come un effetto miracoloso prodotto dalla causa suprema
molto tempo dopo Aristotele […].
§ 3. Perciò, dovendo descrivere la pace ed il suo contrario, siamo d’accordo
con Aristotele quando afferma nella Politica, libro I, capitolo 2 e libro V,
capitolo 3,1 che la città è come una natura animata o come un animale. Infatti,
come un animale ben disposto secondo natura è formato da alcune parti
proporzionate, ben ordinate tra loro, che si comunicano reciprocamente le loro
funzioni in vista del tutto, così, se è stata ben disposta e istituita secondo
ragione, la comunità politica è costituita da parti di questo tipo. Sembra esserci
una relazione tra la comunità politica, le sue parti e la pace, così come esiste
una relazione tra l’animale, le sue parti e la salute. Possiamo riconoscere la
verità di questa affermazione logica da ciò che tutti gli uomini comprendono a
proposito di ciascuna di queste due relazioni. Infatti ritengono che la salute
consiste nella miglior disposizione dell’animale secondo natura, e che la pace
consiste nella miglior disposizione della comunità politica istituita secondo
ragione. Ma la salute, come dicono i medici più esperti quando la descrivono,
1
Aristotele, Politica, I, 5, 1254°, 31 e segg.; V, 3, 1302b, 33-1303°, 2.
59
è la buona disposizione dell’animale attraverso la quale ciascuna delle sue
parti può compiere perfettamente le funzioni che si addicono alla sua natura;
quindi, secondo questa analogia, la pace sarà la buona disposizione della
comunità politica grazie alla quale ciascuna delle sue parti potrà compiere
perfettamente le azioni che le si addicono secondo ragione e secondo la
propria istituzione. E poiché chi dà una buona definizione nello stesso tempo
specifica il contrario, l’opposto della pace2 consisterà nella cattiva
disposizione della comunità politica, così cometa malattia lo è di un animale,
per cui tutte le sue parti o alcune non possono svolgere le azioni di loro
pertinenza, assolutamente o completamente.
Quindi, con lo stesso modo allegorico abbiamo parlato della pace e del suo
contrario. […]
§ 11. Ma ritornando al nostro intento diremo che, dalle cose che abbiamo già
detto, risulta in un certo modo chiaro in cosa consista l’unità numerica della
comunità politica; poichè questa è una unità d’ordine, non una unità assoluta,
ma una molteplicità di individui che viene detta “una”, queste persone
vengono dette “uno di numero” non perchè lo siano formalmente in relazione
ad una qualche forma, ma perchè lo sono in relazione ad una cosa che è una di
numero, cioè il governo al quale vengono ordinati e dal quale sono governati.
La comunità politica non è “una” grazie ad una qualche forma unica naturale,
come se fosse una unità di composizione o di commistione, poichè le sue parti
o le sue funzioni e le persone e le parti di esse sono molte in atto e
formalmente divise tra loro per numero, poichè sono separate nel luogo e nel
soggetto. Infatti non sono “una” per una cosa che inerisca loro formalmente o
che le circondi e le contenga come un muro. Infatti Roma con Magonza e con
le altre comunità politiche costituiscono un regno od impero numericamente
non solo per il fatto che ciascuna di esse per sua volontà è stata ordinata ad un
governo supremo unico di numero. In questo modo diciamo che il mondo è
uno di numero e non che ci sono più mondi, non a causa di una qualche forma
2
Da questo passo si capisce quanto affermato alla n. a del capitolo I, pp. 2-3, ovvero che per Marsilio il concetto di
“pace” è meramente politico, e non ha alcuna valenza etico-morale o religiosa.
60
numericamente una che inerisca formalmente a tutti gli enti; ma per l’unità
numerica del primo ente si dice che tutti gli esseri costituiscono un mondo
unico numericamente, poichè qualsiasi ente è rivolto e dipende dal primo ente.
Infatti la predicazione con cui tutti gli enti vengono detti un mondo
numericamente uno, non è formalmente la predicazione di una certa unità
numerica in tutti gli enti, nè la predicazione di un concetto universale
affermato secondo l’unità, ma è la molteplicità di alcune cose che vengono
dette “una”, poichè è ordinata a “una” cosa, e per “una” cosa. Così, anche gli
uomini di una comunità politicae vengono definiti come “una” comunità
politica, poichè vogliono un governo unico di numero.f
12. Tuttavia gli uomini non sono numericamente una parte della comunità
politica per il motivo per cui sono una comunità politica numericamente una di
numero, sebbene infatti essi desiderino un governo unico di numero, e per
questo si dice che siano un’unica comunità politica, tuttavia vengono riferiti a
questo governo numericamente uno da una diversa istituzione attiva e passiva,
che altro non è che un diverso comando impartito loro dal governante; grazie a
questo diverso comando vengono nominati a diverse funzioni. Appunto, anche
dalla diversità di questo comando, derivano queste parti e le diverse funzioni
della comunità politica. Ma si dice anche che qualsiasi funzione è
numericamente una o è numericamente “una” parte della comunità politica,
nonostante il gran numero di persone che sono in esse, e non per qualcosa di
numericamente unico che sia loro inerente. […]
Questo trattato88 prenderà il nome di Difensore della pace, perchè affronta e
spiega le cause specifiche grazia alle quali viene conservata e sopravvive la
pace civile o tranquillità, le cause dalle quali sorge il suo opposto, la discordia,
e quelle da cui essa viene impedita ed eliminata. Questo trattato permette di
conoscere l’autorità, la causa e la concordanza delle leggi divine e umane, e di
e
[…] Vi è però una differenza tra mondo e comunità politica: nel primo caso infatti la pluralità degli enti è tale perchè
dipendono metafisicamente da Dio, nel secondo caso la pluralità degli uomini è resa “una” dalla volontà degli individui
che si danno un governo unico. Sull’argomento cfr. P. Di Vona, I principi cit., pp. 233-237.
88
Capitolo III. A proposito del titolo.
61
ogni governo coattivo, che sono le regole degli atti umani, nella cui
conveniente misura, se non è ostacolata, consiste la pace o tranquillità civile.
Inoltre, il Difensore della pace rende tanto il governante quanto il suddito, che
sono gli elementi primi di qualsiasi comunità politica, consapevoli di che cosa
occorra osservare per la conservazione della pace e della propria libertà.
Infatti, il primo cittadino o prima parte del regime civile, cioè il governante (si
tratti di un unico uomo o di parecchi), comprende, grazie alle verità umane e
divine che sono scritte in questo libro, che è il solo a cui spetta l’autorità di
dare ordini alla moltitudine dei sudditi, collettivamente o singolarmente; che
detiene l’autorità di costringere chiunque, se è il caso, secondo le leggi
positive, e che non può fare nulla, soprattutto se difficoltoso, oltre a ciò che
consentono le leggi senza il consenso della moltitudine dei sudditi o del
legislatore. La moltitudine ed il legislatore non devono essere provocati da
ingiuria, perchè la virtù e l’autorità del governo consistono nella loro espressa
volontà. La moltitudine dei sudditi e ogni suo membro possono apprendere
ogni cosa da questo libro […]»89.
89
Defensor pacis, a cura di C. W. Previté Orton, Cambridge, Cambridge Universty Press, 1928; Marsilio da Padova, Il
difensore della pace, introd. M. Fumagalli Beonio Brocchieri, trad e note M. Concetti- C. Fiocchi-S. Radice-S.
Simonetta, Milano, RCS libri, 2001, Voll. I, II, p. 5, 7, 21, 23, 245, 247, 1221.
62
COMMENTO
L’influenza della filosofia giuridica di Marsilio da Padova, ancora oggi
estremamente attuale, invita ad una riflessione attenta alla dimensione
giuridica della pace.
«Il fine “desiderabile” di
[... Marsilio da Padova nel] Defensor pacis è
enucleato all’inizio dell’opera: come realizzare quella civilis foelicitas “che
sembra essere il miglior oggetto di desiderio possibile per l’uomo in questo
mondo e l’intento ultimo degli atti umani”. La felicità di cui parla Marsilio è
dunque quella che si realizza nella comunità civile e che soddisfa sia le
funzioni dell’anima sia le virtù pratiche.
Alla fine dell’opera, conclusa a Parigi il giorno 24 giugno 1324, troviamo lo
stesso ragionamento: “Questo trattato prenderà il nome di ‘Difensore della
pace’, perché affronta e spiega le cause specifiche grazie alle quali viene
conservata e sopravvive la pace civile o tranquillità, le cause dalle quali nasce
il suo opposto, la discordia, e quella da cui essa viene impedita ed eliminata”.
Se l’opposto della pace non è la guerra, ma la “prava disposicio civitatis aut
regni”, è subito evidente il preminente carattere politico, e non religioso, etico
63
o giuridico, assegnato alla questione della pax seu tranquillitas seu quies
civile. Considerare, come fa Marsilio, la pace non solo assenza di guerra ma
anche soluzione politica, giuridicamente motivata, capace di instaurare la
felicità civile, è una novità assoluta. La pace è il risultato dell’opera di tutti, e
non di qualcuno»90.
«Ecco perché, mentre il pensiero politico tradizionale aveva cercato l’origine
dello Stato nel “senso di giustizia” innato nell’uomo, Marsilio pone invece
proprio nella formazione delle istituzioni l’origine delle norme di giustizia e
considera la distinzione tra il giusto e l’ingiusto, il lecito e l’illecito come un
puro principio di regolamentazione sociale, dipendente esclusivamente dalla
volontà del legislatore e dalla sua conoscenza di ciò che è utile e necessario
per il mantenimento della società. Sicché, in luogo di fondare la sua teoria
della legge sul canone tradizionale della “legge naturale” precedente alle
istituzioni positive, il Defensor pacis pone in primo piano l’esigenza della
pace civile e fa quindi consistere il principale se non l’unico criterio di
giustizia nel mantenimento del normale equilibrio sociale, nella capacità delle
singole norme ad assicurare la convivenza e le reciproche relazioni delle varie
parti e dei singoli componenti dello Stato […].
In luogo delle considerazioni etiche che accompagnano, nella Monarchia
dantesca, l’esaltazione della pace, […] il Defensor pacis propone lo studio
accurato delle cause che permettono l’instaurazione, il mantenimento, oppure
la distruzione della pace, che è quanto dire delle ragioni di crisi dell’equilibrio
sociale. Non solo: questo concetto di pace non è neppure più inteso nel senso
che gli avevano dato gli scrittori imperiali come […] Dante ([…che] aveva
parlato di una pax universalis come fine della monarchia imperiale), perché è
soltanto l’”intera disposizione” di ogni singolo Stato, la sua perfezione
organica che esclude ogni conflitto o squilibrio»91.
Le ragioni sono immediate.
L’opera “Il difensore della pace” – che per espressa ammissione di Marsilio
non si sofferma sulla sua definizione – descrive una complessa varietà di
90
L. Russi, L’idea di pace in Marsilio da Padova, in Atti del convegno La politica prima di Machiavelli, cit.
Il difensore della pace di Marsilio da Padova, a cura di C. Vasoli, Torino, 1975, p. 29 s.
91
64
rapporti giuridici intersoggettivi di per sé non solo idonei a descrivere le
necessarie relazioni giuridiche che devono intercorrere tra lo Stato e la Chiesa.
Così come è chiara la necessità di disegnare un ordine giuridico in cui la
giustizia sappia garantire la “tranquillità” in luogo della “discordia”, è
altrettanto presupposta la necessità di un ordine totale in cui regni la “civilis
foelicitas” e quindi la pace92.
Una considerazione preliminare ci impone di valutare la natura giuridica del
rapporto intercorrente tra le leggi di diritto divino, naturale o positivo, e quelle
di diritto positivo.
Questa distinzione – in cui la dottrina riconosce una “prospettiva
democratica e laica” dello Stato93 – deve essere analizzata con opportuna
cautela.
La giustizia dell’ordine giuridico, come legittimità e quindi come
conformità alle leggi positive nel perseguimento dell’eguaglianza – sono
evidenti le analogie aristoteliche – non può subire la rilevanza del diritto
divino naturale o positivo. «Persino la legge naturale, che era considerata
dagli altri trattatisti aristotelici come il fondamento di ogni criterio di giustizia
e di perfetto ordine civile, è […] per Marsilio solo uno “statuto del legislatore”
che “tutti gli uomini ritengono norevole ed osservabile” e la cui “naturalezza”
dipende, in ultima analisi, solo dalla riconosciuta utilità civile delle norme che
esso pone»94.
Questo non può in ogni caso escludere che le diverse previsioni giuridiche
possano coincidere nel loro ambito previsionale.
Senza riserve, Marsilio attribuisce alla legge il compito di saper disporre
all’azione, su cui diversamente aveva teorizzato Aristotele.
Anche in questo caso l’esito sarà poter garantire la pace.
Un’applicazione immediata.
Marsilio analizza la necessità di dover irrogare una sanzione penale ad un
chierico.
92
L. Russi, L’idea di pace in Marsilio da Padova, in Atti del Convegno La politica prima di Machiavelli, cit.
Il Difensore della pace di Marsilio da Padova, a cura di C. Vasoli, cit., p. 10 sgg.
94
Il Difensore della pace di Marsilio da Padova, a cura di C. Vasoli, cit., p. 38.
93
65
Nuovamente si rende chiara la distinzione tra l’ordine totale della giustizia
divina e quello contingente e storico della giustizia dell’ordine giuridico
storicamente dato.
Marsilio non disconosce l’irrogazione di sanzioni divine – diversamente
proprie della dimensione ultra terrena – riconoscendo alle sanzioni statali una
riserva esclusiva nella previsione e nella irrogazione.
Il chierico sarà sottoposto alle previsioni giuridiche ed alla giurisdizione
temporale; la Chiesa avrà il solo compito di proclamare chi è incorso in quella
“condizione giuridica”.
ERASMO DA ROTTERDAM *
la pace ... fonte di ogni cosa buona
66
_______________________
* «Gert Geertsz, detto Erasmo, nacque a Rotterdam nel 1466 e, compiuti gli
studi a Parigi, visse in varie città europee, in continuo contatto con i dotti del
suo tempo. Propugnò una riforma religiosa capace di ricondurre il
cristianesimo alla purezza delle origini, Curò l’edizione critica del Testo greco
del Nuovo Testamento (1516) e insieme stigmatizzò, con l’Elogio della follia
(1509), il malcostume ecclesiastico. Scrisse gli Adagia (1505 -1515) […], l’
Institutio principis christianis (1515), [… e la] Querela pacis del 1517».
Il lamento della pace
«D’altronde, non sembra forse negli uomini una sorta di pazzia furiosa1
questo privarsi con le loro stesse mani di tutti i benefici insigni che porto meco
e procacciarsi in cambio una così cupa sentina d’ogni male? Sdegnarsi contro
gli scellerati è giusto, ma che altro si può fare, se non compiangere questi
invasati dalle Furie? Non v’è infatti, per commiserarli, ragione più forte del
fatto che essi non hanno pietà di sè medesimi e la loro infelicità suprema sta
nella loro incapacità di rendersi conto dell’infelicità che li affligge, visto che è
già un primo passo verso la guarigione aver contezza della gravità del proprio
male.
In effetti, se io sono quella Pace vantata in coro dagli dèi e dagli uomini,
fonte, genitrice, nutrice, propagatrice e conservatrice d’ogni cosa buona
posseduta dal Cielo e dalla terra: se nulla mai senza di me fiorisce, nulla v’è di
sicuro, nulla di puro o santo, nulla di piacevole per gli uomini o di grato agli
dèi: se, in contrasto con tutto ciò, la guerra è una specie d’oceano in cui si
1
Sulla guerra come follia criminosa aveva composto una bella pagina SENECA (Ad Lucilium epist., 95, 30). Erasmo,
naturalmente, aveva ripreso il motivo nell’Elogio della pazzia, XXIII (422 C-E-); contro l’infernale “ardore guerriero” si
scaglia anche nel cap. XXXVIII (439 B).
67
mescolano tutti i mali del mondo: se col suo flagello d’un subito fa imputridire
ciò che fiorisce, dissipa ciò ch’era cresciuto, rovina ogni cosa salda, annienta
ogni buon fondamento, tramuta il dolce in amaro: se, infine, è cosa tanto
profana da riuscire come una peste subitanea per ogni forma di pietà e di
religione, se, per questo solo, nulla è più funesto agli uomini nè più odioso agli
dèi, in nome di Dio immortale, io mi domando chi crederà mai che siano
davvero esseri umani e che abbiano conservato un briciolo di discernimento
coloro che si adoprano con tata spesa, impegno, ingegnosità, artifici, cure e
pericoli a cacciar via me, che son quella che sono, per acquistare a così caro
prezzo tante sventure.
Se fossero le fiere a disprezzarmi in questo mondo, lo sopporterei con
maggior rassegnazione e dell’ingiustizia arrecatami incolperei la natura, che
ha inflitto ad esse un istinto feroce: se fossi invisa agli ottusi armenti,
indulgerei all’ignoranza, sapendo che fu negato loro quell’acume, senza il
quale non è possibile rendersi conto dei miei pregi. Ma è vergognoso ed
inaudito il fatto che, pru avendo la natura generato un solo animale dotato di
ragione e capace di intelletto divino, uno solo destinato al reciproco amore ed
alla concordia, mi sia più facile trovare asilo tra le più belluine delle belve, fra
gli animali più bruti, piuttosto che in mezzo agli uomini.
Le sfere celesti, benchè non abbiano affatto eguali movimenti, nè eguali
influssi, pure da tanti secoli riconoscono e rispettano un accordo reciproco. Le
forze contrapposte degli elementi serbano fra loro un equilibrio costante, una
pace perpetua e, in così acceso contrasto, promuovono la concordia attraverso
gli scambi e le mutue relazioni. Negli esseri animati, com’è costante l’armonia
fra le singole membra, com’è organizzata la reciproca difesa! Cosa c’è di più
dissimile del corpo e dell’anima? Eppure proprio la loro separazione rivela
quanto sia stretto il legame con il quale la natura li ha congiunti: come la vita
altro non è che l’unione del corpo con l’anima, così la salute non è che
l’armonia di tutte le funzioni dell’organismo. Gli esseri ragionevoli serbano,
ciascuno entro la propria specie, il buon ordine e la concordia. Gli elefanti
vivono in branchi, a mandre pascolano porci e pecore, a stormi volano le gru e
le cornacchie, le cicogne, che danno anche esempio di amor filiale, hanno i
68
loro raduni, i delfini si proteggono a vicenda ed è nota la bene organizzata
solidarietà delle formiche e delle api. Ma perchè insisto a parlare di animali,
che sono sprovvisti di ragione, ma sono però dotati di sensi?
[…] Eppure diresti che anch’essi abbiano disposizione alla pace e alla
concordia. Così la calamita attira a sè il ferro e lo trattiene.
E non v’è forse un accordo anche tra le belve più crudeli? La ferocia dei
leoni non li spinge a lottare fra loro, il cinghiale non vibra la fulminea zanna
contro un altro cinghiale, la lince vive in pace con la lince, il serpente non
infierisce sul serpente, la concordia dei lupi è stata addirittura esaltata dai
proverbi2 Aggiungo – cosa anche più stupefacente – che persino gli spiriti
maligni, che per primi spezzarono l’accordo fra Iddio e l’uomo e che tuttora lo
insidiano, sottostanno a certi loro patti e rispettano tutti d’accordo una qualche
sorta di tirannico regime. Soltanto gli uomini, ai quali più che ad ogni altro
essere si addiceva l’unanime concordia e che più di tutti ne hanno bisogno,
non accettano di essere conciliati dalla natura, che pure è in altre cose tanto
potente ed efficace: l’educazione non li unisce, i tanti benefici che
nascerebbero dalla concordia non li inducono a stringersi insieme, la vista e
l’esperienza di tanti mali non li conduce infine all’amore scambievole.
Tutti hanno lo stesso aspetto e una medesima voce, e mentre le altre
specie animali si differenziano fra loro soprattutto per la struttura corporea,
all’uomo soltanto è stata infusa la forza della ragione, che accomuna tutti gli
uomini, mentre nessuno degli altri animali ne ha parte. A questo solo dei
viventi è stata concessa la parola, che ha funzione primaria nel promuovere le
relazioni amichevoli; in tutti gli uomini sono innati i germi delle conoscenze e
delle virtù, un’indole mite, pacifica e incline alla benevolenza, cosicchè per
natura piace a tutti l’essere amato ed è gradevole far del bene al prossimo
anche se compenso, a meno che non si tratti di qualcuno che sia degenerato, da
uomo che era, in belva, corrotto da turpi bramosie come la pozione di Circe3.
Ecco perchè la gente dà il nome di “umano” a tutti ciò che ha riguardo alla
mutua benevolenza, di guisa che la parola “umanità” indica non già la natura
2
Nei suoi Adagia (1363) Erasmo illustra il proverbio: “Furem fur cognoscit et lupum lupus”, la cui fonte è Aristotele,
Ethica eudemia, VII, I (1235 a). In italiano si dice: “Lupo non mangia lupo”.
3
Circe è la favolosa maga che trasformò in porci i compagni di Ulisse (Omero, Odyssaea, X, 210 segg.).
69
dell’uomo, ma i costumi che a quella natura si addicono. In più, all’uomo sono
state date le lacrime, prova di un’indole aperta alla commozione, in modo che
possa trovare facilmente la riconciliazione, se per caso sorgesse l’inciampo di
qualche offesa o una piccola nuvola oscurasse la serenità dell’amicizia.
Ecco con quanti argomenti la natura ci persuade alla concordia! E
tuttavia, non paga di questi allettamenti della reciproca benevolenza, ha voluto
che l’amicizia fosse per l’uomo non solo gradevole, ma addirittura necessaria.
A tal punto essa ha distribuito le doti sia del corpo che dell’animo, da far sì
che nessuno sia di tutte tanto ben fornito da non aver mai bisogno dell’aiuto
anche dei più umili; e non ha assegnato le stesse doti ad ognuno, nè in eguale
misura, in modo che questa diseguaglianza venisse compensata attraverso
mutui amichevoli servigi. Diverse regioni offrono prodotti differenti, in modo
che sia il bisogno stesso a suggerire i reciproci scambi. Agli altri animali
furono date armi e protezioni peculiari con cui difendersi, mentre l’uomo
soltanto è stato creato inerme e debole, in modo che per stare al sicuro non
possa fare a meno dell’accordo e dell’assistenza scambievole.
La società civile è nata dal bisogno e fu il bisogno a suggerire la
consociazione dei vari gruppi per respingere con forze congiunte gli assalti
delle belve e dei predoni. Tali sono le condizioni della vita umana, che non v’è
cosa in cui l’uomo basti a sè stesso. Il genere umano sarebbe subito perito sin
dagli albori della sua esistenza, se dopo la creazione l’unione coniugale non lo
avesse propagato: non nascerebbe infatti uomo alcuno, o morirebbe appena
nato e perderebbe la vita alle soglie della vita stessa, se la mano amica della
levatrice, la dedizione affettuosa della nutrice non venissero in soccorso del
neonato. In questa vicenda la natura ha inserito così vivide scintille di affetto,
che i genitori già amano colui che non hanno ancora veduto; vi aggiunse la
devozione scambievole dei figli verso i genitori, in modo che quelli a lor volta
siano di sostegno all’indebolirsi di questi, così che si attui quella situazione
per ogni aspetto lodevole […] 4.
Tanto numerosi sono gli argomenti con i quali la natura ci induce alla
pace e alla concordia, con tanti allettamenti ci invita, con tante funi ci trascina,
4
Letteralmente “ricambiare l’affetto della cicogna”, da parte dei figli verso i genitori.
70
con tanti mezzi ci sforza! E a questo punto, quale è mai questa Erinni5 così
efficiente nell’operare il male, che, dopo aver spezzato, sconnesso, rovesciato
tutti questi argomenti, ha insinuato nei cuori umani un insaziabile furore? Se
l’assuefazione non ci privasse dapprima della capacità di stupirci e poi della
stessa coscienza del male, chi crederebbe dotati di mente umana costoro, che
litigano, si azzuffano, mettono ogni cosa in sconquasso con dissidi, contese e
guerre perpetue fra loro? In breve, con rapine, sangue, stragi e rovine fanno
d’ogni erba fascio, e non v’è patto, per sacro che sia, che valga a separarli,
quando si accapigliano come forsennati con reciproco sterminio. Anche se non
fosse
sopravvenuto
dell’altro,
avrebbe
dovuto
bastare
la
comune
denominazione d’uomo per promuovere l’intesa fra gli uomini. Ma
ammettiamo pure che la natura, tanto potente persino tra le fiere, non abbia
avuto efficacia alcuna tra gli uomini: forse che tra i cristiani Cristo non è valso
a nulla? Ammettiamo pure che sia poco persuasivo l’insegnamento della
natura, che prue tanto può perfino nelle cose inanimate: ma perchè mai la
dottrina di Cristo, ch’è tanto più autorevole, non riesce a render persuasi
coloro che la professano del punto, che sopra ogni altro propugna, cioè la pace
e la mutua benevolenza? O perchè almeno no li dissuade da quella follia
bellicosa tanto empia e crudele?
Quando sento pronunciare il nome di uomo, subito accorro in cerca
dell’essere animato che è stato creato specificamente per me, con la fiducia di
poter trovare presso di lui la mia quiete: quando sento la qualifica di cristiano,
a maggior ragione mi precipito, nella speranza che fra gente siffatta potrò
sicuramente regnare. Ma anche qui, devo dirlo con pena e rossore, mercati e
tribunali, palazzi e chiese son tutti un clamore di litigi, cosa non vista mai
neppure fra i pagani, al punto che la turba degli avvocati, che pru costituisce
una bella fetta delle disgrazie umane, rispetto alle caterve dei litiganti sembra
rada e quasi scompare. Mi volgo a una città, e subito comincio a sperare che
l’accordo regni almeno fra coloro che sono cinti dalle stesse mura, governati
dalle stesse leggi e stretti insieme dal comune pericolo come passeggeri su una
5
Le Erinni erano gli spriti vendicatori, che perseguitavano chi si fosse macchiato di delitti contro i parenti. Qui sta per
dèmone di perdizione, secondo l’accezione di Virgilio, Aeneis, II, 573.
71
stessa nave. Invece, meschina me! Scopro che anche qui ogni cosa è
avvelenata dalle discordie, al punto che a stento mi risce di trovare una casa in
cui sostare per qualche giorno. Lascio così la plebe, che è squassata come un
mare dalle sue tempeste, e mi rifugio quasi in porto nei palazzi dei principi.
“Certamente qui”, dico a me stessa, “ci sarà posto per la Pace; costoro la sanno
più lunga del volgo, visto che son come l’animo della plebe e l’occhio del
popolo. Inoltre essi tengono le veci di Colui, che è maestro e principe della
concordia e mi ha bensì affidata a tutti quanti, ma ai sovrani in modo
particolare”. E tutto promette bene. Vedo saluti cortesi, abbracci amichevoli,
brindisi lieti e tutte le altre manifestazioni di cordialità ma, cosa indegna! non
riuscii a scorgere fra costoro neppure l’ombra dell’autentica concordia. Tutto è
menzogna e falsità, non v’è cosa che non sia corrotta dalle faziosità scoperte,
dai dissensi e dalle rivalità sotterranee. Alla fine mi rendo conto così
chiaramente, che fra quella gente non c’è posto per la Pace, da scoprire in essi
proprio la fonte e il semenzaio di tutte le guerre.
Povera me! Dove me ne andrò d’ora innanzi, dopo aver visto tradire
tante volte le mie speranze? Ma forse i principi sono più grandi che istruiti e si
lasciano trascinare piuttosto dalle bramosie che dal buon discernimento. Mi
rifugerò tra le turbe dei sapienti: le buone lettere formano degli uomini, la
filosofia dei superuomini, la teologia li rende divini. Dopo tante vicissitudini,
fra costoro potrò certo trovare un pò di quiete. Invece, che pena! ecco anche
qui un altro genere di guerre, certo meno cruento, ma non già meno
dissennato. Una scuola dissente dall’altra e, quasi che la verità muti da luogo a
luogo, certi concetti non varcano il mare, altri non valicano le Alpi, altri non
traghettano nemmeno il Reno; anzi, in una stessa Università il professore di
retorica è in guerra con quello di logica, il teologo dissente dal giurista e,
persino nell’ambito della stessa disciplina, il tomista si batte contro lo scotista,
il nominalista contro il realista6, il platonico contro il peripatetico, al punto da
non trovarsi d’accordo neppure sugli argomenti più insignificanti; e il più delle
volte si battono con estremo accanimento per questioni di lana caprina, fino a
6
Allude a una disputa che aveva diviso la Scolastica: secondo i nominalisti, solo i singoli oggetti sono reali e perciò gli
universali non sono che meri nomi o astrazioni della nostra mente; invece per i realisti essi posseggono un’esistenza
reale.
72
che la disputa si arroventa tanto da farli passare dalle argomentazioni agli
insulti e dagli insulti ai pugni; e anche se la contesa non si risolve con pugnali
e lance, si trafiggono con penne intinte nel veleno, si sbranano a vicenda con
pagine che par che abbiano denti, entrambi scagliano con la lingua saette
mortali per la reputazione dell’avversario.
Dove mi volgerò, dopo aver toccato tante volte con mano che fui
pasciuta di mere parole? Cosa mi resta, quale ultima ancora di salvezza, se non
la religione? Questa professione, anche se è comune a tutti quanti i cristiani,
tuttavia viene abbracciata in modo più peculiare, mediante titolo, abito e riti,
da coloro che il popolo onora con il nome di sacerdoti. Costoro dunque, a chi
guarda ogni cosa da lontano, lasciano sperare di costituire per me un rifugio
bell’e pronto. Mi allettano le vesti candide, cioè proprio del mio colore7; vedo
le croci, simbolo di pace; ascolto quel dolcissimo appellativo di “fratello”,
indizio di affetto singolare; sento nei saluti colmi di letizia augurare la pace8;
scorgo tutti i beni in comune, unico il Capitolo, unica la chiesa, eguale la
regola, quotidiane le riunioni. Chi non confiderebbe di trovare qui un posto per
la Pace? Invece, che vergogna! quasi non c’è luogo in cui il Capitolo sia
d’accordo col vescovo: e questo sarebbe il meno, se non si dividesse anch’esso
in fazioni. Dove esiste un prete che non sia in lite con un altro prete? Paolo
giudica intollerabile che un cristiano litighi con un altro cristiano9, e un
sacerdote deve aver beghe con un altro sacerdote, un vescovo con un altro
vescovo? In verità, qualcuno potrà forse mostrarsi indulgente nei loro
confronti, considerando che per abitudine ormai remota son venuti a
confondersi con la comunità dei profani, da quando cominciarono a spartirsi
con quelli le proprietà. Ebbene, si godano a buon diritto quanto rivendicano
quasi in forza di una maturata prescrizione!
Resta ancora un’ultima specie d’uomini, così attaccati alla religione che,
anche se volessero, non potrebbero in alcun modo staccarsene più di quanto
faccia la testuggine dal suo guscio. Avrei sperato di trovare asilo presso di
7
La Pace era immaginata con veste bianca; Erasmo rammenta qui probabilmente la “candida pax” di Ovidio, Ars am.,
III, 502.
8
Nelle formule di saluto augurale Pax vobiscum! Pax et bonum! E simili.
9
Richiama il rimprovero paolino di I Cor., VI, 6-10.
73
loro, se la speranza tante volte delusa non mi avesse insegnato a non farmi
alcuna illusione. E tuttavia, per non lasciare nulla di intentato, ci ho provato.
Vuoi sapere com’è finita? Non sono mai scappata così in fretta. Cosa potrei
infatti sperare dove la religione è in rotta con la religione? Tante sono le
fazioni quanti sono gli ordini: i Domenicani litigano con i Minori, i
Benedettini con i Bernardini; tanti i nomi, altrettante le fogge di vestire e le
cerimonie differenziate a bella posta per far sì che non ci sia nemmeno un
punto di accordo; ciascuno tiene alle proprie e critica e detesta le altrui.
Persino uno stesso ordine si divide in fazioni: gli Osservanti sono in rotta con i
Coletani, ed entrambi con una terza congregazione, che prende nome dal
convento, perchè non vanno d’accordo in cosa alcuna10.
Ormai com’è naturale, completamente sfiduciata, pensavo di andarmi a
nascondere almeno in un piccolo monastero, che fosse veramente tranquillo.
Devo però confessare – e volesse il Cielo che ciò non fosse anche troppo vero!
– di non averne finora trovato uno, che non sia infetto da rivalità e beghe
intestine. C’è da vergognarsi a dar conto delle battaglie che scatenano, per
sciocchezze e cavilli da nulla, uomini già anziani, venerandi per la barba e la
tonaca, e che per giunta si credono d’esser dotti e santi oltre misura.
Una qualche speranza mi sorrideva di trovare un posto purchessia da
qualche parte, presso una delle tante coppie di coniugi. Cosa non ci si
aspetterebbe là dove comune è la casa, comune il patrimonio, comune il letto,
comuni i figli, dove il reciproco diritto dell’uno sul corpo dell’altro ti fa
pensare ad una persona unica composta da due, piuttosto che a due persone
distinte. Ma anche lì s’è insinuata quella scelleratissima Discordia11 a separare
con i dissensi quelli che erano congiunti da così fitti legami. Eppure avrei
preferito star lì, piuttosto che in mezzo a coloro che per tanti titoli, tanti segni
esteriori, tante cerimonie, fanno professione di assoluta carità.
10
Con la bolla Ite et vos in vineam meam del 29 maggio 1517 Leone X separava proprio in quei giorni i Francescani
Conventuali dai Minori Osservanti. Venivano detti Coletani alcuni gruppi di Francescani riformati, dipendenti dai
superiori convenutali, che erano diffusi in Francia, Renania e Sassonia e si ispiravano all’impulso riformatore di S.
Coleta di Corbie (m. 1447).
11
Nell’originale: “Eris”, la dea della Discordia, sorella di Marte; ponendo in palio il pomo destinato alla più bella delle
dee, aveva dato l’avvio alla guerra di Troia.
74
Alla fine cominciai a desiderare di trovar posto almeno in petto ad
un’unica persona, ma anche questo non mi fu dato»95.
COMMENTO
«Erasmo ha un orrore profondo ed assoluto per la guerra che egli definisce
multorum commune homicidium et latrocinium. Egli la vede e rappresenta in
tutta la sua atroce realtà: eserciti schierati, fragore di armi, volti minacciosi di
combattenti, stragi vicendevoli, campi di sangue ... Sente e denunzia il tragico
dovere del combattente che immerge il ferro nelle viscere di un tale che non lo
ha offeso neppure con una parola. Non gli sfuggono le rovine materiali e
morali che ogni guerra porta con sé: raccolti distrutti, paesi bruciati, […]
vecchi fatti prigionieri, templi distrutti, rapine, furti ... Ma ancor più gli fanno
orrore le rovinose conseguenze che egli denunzia con spietato realismo: il
popolo spogliato, genitori privati dei figli, donne vedovate, figli rimasti orfani,
ricchi ridotti in miseria; e poi, quel decadimento del costume che è causa di
funesti disordini morali (disprezzo dei sentimenti di pietà, disprezzo delle
leggi, audace inclinazione ad ogni delitto etc.). […]
Quanto assoluta è la condanna della guerra, tanto assoluto è in Erasmo l’amore
per la pace, bonarum rerum et parens ... et nutrix. Quanto è cupo e terribile il
quadro che egli nei suoi scritti fa della guerra, tanto è ridente e spazioso il
quadro che fa della pace […]. La pace è la condizione che si addice alla natura
dell’uomo. Tutto dell’uomo indica come la natura, o meglio Iddio, lo abbia
generato, non bello sed amicitiae, non exitio sed saluti, non iniuriae, sed
beneficentiae: l’aspetto, l’uso della parola e della ragione, il naturale odio
95
Erasmo da Rotterdam, Il lamento della pace, Torino, Utet, 1968, pp. 31-40.
75
della solitudine e amore della compagnia, lo studio delle arti liberali e il
desiderio di conoscere.
Nella pace Erasmo vede riflettersi una legge fondamentale che governa tutte le
cose della natura: la legge dell’ordine e dell’armonia che regola tutte le cose
dell’universo, astri, elementi, esseri animati, bruti, alberi, etc. Per di più in
essa vede l’attuazione del fondamento essenziale della predicazione di Cristo,
la carità: tolle pacem et perit omnis Christianae vitae societas.
In realtà l’ideale della pace, nel pensiero di Erasmo non è limitato solo al
campo militare e politico. Egli non desidera solo la pace fra due stati, ma la
pace fra regione e regione, fra città e città, fra gruppi e gruppi, classi e classi,
cittadini e cittadini, uomo ed uomo. Egli ha mutuato dall’umanesimo due
motivi fondamentali: il culto ed il rispetto della dignità della persona umana,
la fede nel valore educativo della cultura, in particolare della sapienza. Questi
due motivi, accolti e sviluppati con singolare vigore sentimentale e ideale al
vaglio di una sempre acuta e accorta considerazione delle più diverse
esperienze,
ispirano
scritti
e
atteggiamenti
(talvolta
apparentemente
contrastanti) di Erasmo, anche se egli non fu sempre esente da debolezze e
incertezze[…]. Egli crede sinceramente […] che la cultura sottragga l’uomo
alla ferinità e alle passioni più carnali e animali e lo aiuti a trovare in se stesso
le più profonde voci della sua umanità […]. Perciò egli non biasima solo la
guerra guerreggiata sui campi di battaglia, ma ogni forma di lotta, di lite, di
dissidio, giacché in ogni caso l’uomo o da solo o collettivamente si sottrae alla
sua vera natura umana e ai precetti della predicazione di Cristo. […]
La pace quindi, cui Erasmo apira, è pace delle armi e delle coscienze, dei
popoli e dei singoli, pace di tutti gli uomini fra di loro e con loro. Perciò egli
crede che essa non poggi su vincoli di parentela o su patti di alleanza, ma sulla
sincera vittoria delle virtù sulle prave cupidigie. Fondamento di siffatta pace
per Erasmo è il Cristianesimo, messaggio di carità, di fraternità, di
comprensione, di amore, di perdono»96.
96
M. Santoro, Pace e guerra nel pensiero di Erasmo, in Giornale italiano di Filosofia, VI, 4, 1953, p. 338, 343 s.
76
KANT *
La pace non è una sospensione di ostilità, ma una situazione perpetua
77
______________________
* «Immanuel Kant nacque a Königsberg, allora capoluogo della Prussia
orientale nel 1724. Venne educato, nello spirito religioso del pietismo, nel
Collegium Fridericianum. Uscito dal collegio (1740) studiò filosofia,
matematica e teologia nell’Università di Königsberg. Fra le sue opere più
importanti vi sono la Critica della ragion pura (1781-17872), l’Idea per una
storia universale dal punto di vista cosmopolitico (1784), Che cos’è
l’illuminismo ? (1784), la Critica della ragion pratica (1788), la Critica del
giudizio (1790), la Metafisica dei costumi (1797), Per la pace perpetua
(1795), Il conflitto delle facoltà (1798). Morì nel 1804».
Per la pace perpetua. Un progetto filosofico
1. “Nessun trattato di pace deve considerasi tale, se è stato fatto con la tacita
riserva di pretesti per una guerra futura” 97
In tal caso esso sarebbe infatti un mero armistizio, una sospensione di ostilità,
non pace, che significa la fine di ogni ostilità; ed aggiungervi l’aggettivo
eterna costituisce già un pleonasmo sospetto. Le cause di guerra futura già
esistenti anche se eventualmente ignote agli stessi attuali contraenti, vengono
nel loro insieme annullate con il trattato di pace anche se potessero ricavarsi
cavillando con ogni possibile arguzia dai documenti di archivio. La riserva
(reservatio mentalis) di antiche pretese da farsi eventualmente valere in
avvenire (delle quali nessuna delle parti contraenti vuole per il momento far
menzione perché entrambi i contraenti sono troppi esausti per continuare la
guerra) è da sfruttare con malvagità alla prima occasione favorevole a questo
97
Prima dell’esposizione degli articoli preliminari, Kant si era soffermato a considerare l’espressione “Per la pace
perpetua”, rammentando un’ «iscrizione satirica posta sull’insegna di un oste olandese nel quale era dipinto un
cimitero». Egli a tal riguardo si chiede se “questa iscrizione” «valga per gli uomini in generale o in particolare per i
sovrani mai sazi di guerra, oppure valga solo per i filosofi che vagheggiano quel dolce sogno». La risposta è immediata.
Kant ritiene che come «il politico pratico assume di fronte al teorico l’atteggiamento di guardare quest’ultimo con
grande presunzione dall’alto in basso come un uomo della cattedra, che con le sue idee prive di contenuto reale è
innocuo allo Stato (che deve condursi con principi ricavati dall’esperienza) e al quale si può permettere di sbizzarrirsi
fino in fondo con le sue idee senza che l’uomo di stato pratico del mondo se ne debba dare pensiero, così [… lui, in
quanto] autore [… del] saggio [che sta introducendo] chiede per sé che, anche in caso di disaccordo, il politico pratico
sia conseguente e non sospetti un pericolo per lo Stato nelle teorie che il politico teorico affida alla buona ventura e
manifesta pubblicamente. Con questa clausola salvatoria [… Kant afferma espressamente] di voler dunque, nella forma
migliore, sapersi esplicitamente garantito da ogni maligna interpretazione».
78
scopo, rientra nella casistica gesuitica e, quando la cosa si giudichi in se stessa,
è indegna dei sovrani come è indegno di un loro ministro accondiscendere a
simili calcoli. Se però, secondo gli illuminati principi della ragion di stato si fa
consistere il vero onore dello Stato nell’accrescimento continuo di potenza
quali che siano i mezzi allora certamente tale formulazione apparirà una
pedanteria di scuola.
2. “Nessuno Stato indipendente (non importa se piccolo o grande) può venire
acquistato da un altro per successione ereditaria, per via di scambio, compera
o donazione”.
Uno Stato infatti non è (come il territorio su cui ha la sua sede) un bene
(patrimonium): è una società di uomini, sulla quale lei stessa può comandare e
disporre. Incorporare ora lo Stato, che come tronco ha le sue proprie radici, in
un altro Stato a’mo di innesto, significa sopprimerne l’esistenza come persona
morale, fare di questa una cosa e ciò contraddice all’idea del patto originario
senza il quale non può concepirsi diritto sopra un popolo98 Al quale pericolo il
pregiudizio di un siffatto modo di acquisto, per cui anche gli Stati possono
sposarsi tra di loro, abbia esposto nei nostri tempi, anche più recenti, l’Europa
(poiché alle altre parti del mondo tale sistema è sempre rimasto sconosciuto), è
notoa chiunque; è un nuovo genere di industria per cui con legami dinastici si
può aumentare la propria potenza senza dispendio di forze o anche estendere
in tal modo il possesso territoriale. Anche il vendere le truppe di uno Stato ad
altro Stato, contro un nemico non comune, rientra in un siffatto sistema,
poiché con ciò si usa ed abusa dei sudditi come se fossero cose di cui si può
disporre a capriccio.
3. “Gli eserciti permanenti (miles perpetuus) devono col tempo scomparire
interamente”.
Essi infatti minacciano incessantemente gli Stati con la guerra, dovendo
sempre mostrarsi armati a tale scopo, ed eccitano gli altri Stati a gareggiare
vicendevolmente in qualità di armamenti in una corsa senza fine: e siccome
per le spese a ciò occorrenti la pace diventa da ultimo ancor più oppressiva che
98
Un regno ereditario non è uno Stato che possa cadere in eredità di un altro Stato; ma è uno Stato in cui il diritto di
governare può essere trasmesso per via ereditaria ad un’altra persona fisica. Lo Stato acquista allora un sovrano, ma
costui come tale (cioè in quanto possiede un altro Stato) non acquista lo Stato [nota di Kant]
79
non una breve guerra, così tali eserciti permanenti diventano essi stessi la
causa di guerre aggressive condotte per liberarsi da quel peso. A ciò si
aggiunga che assoldare uomini per uccidere o farli uccidere appare un far uso
di uomini come di semplici macchine e strumenti nelle mani di un altro (dello
Stato), il che non può affatto conciliarsi con il diritto dell’umanità insito nella
nostra persona. Cosa ben diversa è l’esercitarsi alle armi volontario e periodico
dei cittadini al fine di garantire con ciò se stessi e la patria dalle aggressioni
esterne. Lo stesso effetto avrebbe l’accumulazione di un tesoro di guerra,
poiché venendo ciò considerato dagli altri Stati come una minaccia di guerra,
renderebbe necessarie aggressioni preventive (dato che delle tre forze, quella
dell’esercito, dell’alleanza e del denaro, quest’ultimo è probabilmente lo
strumento di guerra più sicuro), se a ciò non vi si opponesse la difficoltà di
valutarne l’entità.
4. “Non si devono contrarre debiti pubblici in vista di controversie fra Stati da
svolgere all’estero”.
Il cercare risorse dentro o fuori dello Stato nell’interesse dell’economia
nazionale (per costruire nuove strade, fondare nuovi insediamenti, istituire
magazzini di riserva per gli anni di scarso raccolto ecc.) non desta sospetti. Ma
il sistema del credito visto come un meccanismo con cui gli Stati si
fronteggiano l’un l’altro, coiè poi un sistema che porti all’aumento indefinito
dei debiti, i quali sono sempre al riparo da una restituzione immediata (perché
non tutti i creditori la richiederanno contemporaneamente): questo sistema –
ingegnosa invenzione fatta in questo secolo da un popolo commerciante99 costituisce una pericolosa forza finanziaria, vale a dire un tesoro destinato a
fare la guerra, e anzi un tesoro che supera quelli di tutti gli altri Stati presi
insieme e che potrebbe esaurirsi solamente per la minaccia di una fatale
diminuzione dei tributi: pericolo che però può essere ancora a lungo ritardato
per il ravvivarsi del commercio e per la conseguente reazione sull’industria e
sui profitti. Questa agevolazione a fare la guerra, congiunta con la tendenza a
farla da parte dei detentori del potere (tendenza che sembra inerente alla natura
99
Kant allude al popolo inglese. Il sistema dei debiti pubblici venne introdotto durante il regno (1688-1702) di
Guglielmo III.
80
umana), è dunque un grave ostacolo alla pace perpetua e tanto più si impone
un articolo preliminare per rimuoverlo, quanto più la comune inevitabile
bancarotta finale dello Stato coinvolgerà nel danno altri Stati che non ne hanno
colpa e che scorgerebbero in ciò una pubblica lesione dei loro diritti. Sono
quindi perlomeno giustificati quegli Stati che si uniscono contro un tale Stato e
contro le pretese di esso.
5. “Nessuno Stato deve intromettersi con la forza nella costituzione e nel
governo di un altro Stato”.
Che cosa infatti può giustificarlo a comportarsi in tal modo ? Forse lo scandalo
che quello Stato dà ai sudditi di un altro Stato ? Ma siffatto scandalo può
piuttosto servire di ammonimento per l’esempio dei grandi mali che un popolo
si è attirato con la sua anarchia: e in genere il cattivo esempio che una persona
libera dà ad altri (in quanto scandalum acceptum) non costituisce una lesione.
Diverso sarebbe invece il caso di uno Stato che per discordie interne si divide
in due parti, ognuna delle quali si costituisce in uno Stato particolare che
pretenda di dominare il tutto: nel qual caso l’aiuto prestato ad una delle parti
non potrebbe considerarsi come ingerenza esterna di uno Stato nella
costituzione di un altro (perché non di costituzione si tratta allora, bensì di
anarchia). Finché però tale conflitto intestino non si è apertamente
manifestato, questo intervento di potenze straniere sarebbe violazione dei
diritti di un popolo indipendente in lotta solo con un malessere interno, e
l’intervento sarebbe esso stesso uno scandalo e renderebbe malsicura
l’autonomia di tutti gli Stati.
6. “Nessuno Stato in guerra con un altro deve permettersi atti di ostilità che
rendessero impossibile la reciproca fiducia nella pace futura: come, ad es.,
l’assoldare sicari (percussores), ed avvelenatori (venefici), la rottura della
capitolazione, l’istigazione al tradimento (perduellio) nello Stato al quale si fa
guerra ecc.”.
Questi sono stratagemmi disonesti. Infatti una qualche fiducia nella
disposizione d’animo del nemico deve ancora sussistere anche nella guerra,
81
poiché altrimenti non potrebbe neppure concludersi alcuna pace e l’ostilità
degenererebbe in una guerra di sterminio (bellum internecinum). La guerra è
infatti solo il triste mezzo necessario nello stato di natura (dove non esiste
tribunale che possa giudicare secondo il diritto) per affermare con la forza il
proprio diritto, non potendo in tale stato essere considerata nemico ingiusto
nessuna delle due parti (perché ciò presuppone già una sentenza giudiziaria) e
decidendo solo l’esito del combattimento (come nel cosiddetto giudizio di
Dio) da quale parte stia il diritti: ma tra due Stati non è concepibile una guerra
punitiva (bellum punitivum) poiché tra essi non sussiste rapporto di superiore
ad inferiore. Ne segue che una guerra di sterminio in cui la distruzione può
colpire contemporaneamente entrambe le parti ed ogni diritto venire
soppresso, darebbe luogo alla pace perpetua unicamente sul grande cimitero
del genere umano. Una simile guerra, e con essa l’uso dei mezzi che vi
conducono, dev’essere pertanto assolutamente vietata. Ma che siffatti mezzi
portino inevitabilmente a ciò risulta chiaro dal fatto che, essendo quelle arti
infernali in se stesse nefande, esse, una volta entrate nell’uso, non si
manterrebbero a lungo nei confini della guerra – come ad esempio l’impiego
delle spie (uti exploratoribus) in cui si sfrutta solo la mancanza del senso
dell’onore di altre persone, la quale comunque non può venire sradicata -, ma
si estenderebbero anche allo stato di pace le cui finalità sarebbero quindi
interamente annullate.
Sebbene le leggi sopra esposte siano dal punto di vista oggettivo, cioè
nell’intenzione dei detentori del potere, tutte quante leggi di proibizione (leges
prohibitivae), alcune di esse sono però di natura stretta (leges strictae), cioè
valgono senza tener conto della diversità delle circostanze e impongono
l’abolizione immediata […], mentre altre […] non sono eccezioni alla norma
di diritto, ma eccezioni relative alla loro applicazione, in quanto tengono conto
delle circostanze, implicano la facoltà soggettiva di allargarle (leges latae) e
permettono che se ne differisca l’esecuzione, senza però perdere di vista lo
scopo che non consente di rinviare indefinitivamente (o, come Augusto
82
diceva, ad calendas Graecas100) questa dilazione (ad esempio il ristabilimento
della libertà tolta a certi Stati […]) e quindi nemmeno consente la non
esecuzione, ma permette soltanto, affinché l’esecuzione non sia affrettata e
quindi contraria allo scopo, che la si ritardi. Il divieto infatti concerne qui solo
il modo d’acquisto, che non deve avere validità per l’avvenire, ma solo lo
stato di possesso che, se anche manca del titolo giuridico richiesto, tuttavia
secondo la pubblica opinione del tempo (acquisto putativo) fu ritenuto
legittimo da tutti gli Stati […]»101.
100
“Alle calende greche”: Svetonio, Vitae Caesarum, Augustus, 87. Secondo il calendario romano le calende erano il
primo giorno del mese, mentre i greci non usavano quel vocabolo.
101
Filosofi per la pace, a cura di D. Archibugi – F. Voltaggio, Roma, Editori Riuniti, 1999, pp. 237-243.
83
COMMENTO
“Per la pace perpetua” di Immanuel Kant «si articola in due diverse sezioni la prima concernente gli articoli “preliminari” e la seconda quelli “definitivi”
per la pace perpetua fra gli Stati - che vanno interpretate come una
ricostruzione “critica” del problema della pace, intesa a porre in evidenza, in
primo luogo, la “forma” del problema, cioè il dovere di evitare o, meglio, di
non fare alcune cose e, per contro, farne alcune altre. La prima sezione
potrebbe definirsi la pars destruens, la seconda la pars construens del saggio.
[…] La sezione prima (gli “articoli preliminari”). Gli articoli preliminari […]
son quelli - almeno in parte - consueti della tradizione pacifista. Di tutti gli
articoli, i più significativi sono certamente il terzo e il sesto. Nel terzo - che
recita “gli eserciti permanenti devono col tempo scomparire interamente” -, si
identifica la causa della guerra con l’esistenza stessa di eserciti permanenti, e
si individua, perciò, nel disarmo la realizzazione stessa della pace. Nel
contempo si individua nell’ esercizio “volontario e periodico” dei cittadini alle
armi l’unico modo per difendere la nazione da potenziali nemici, il che
equivale all’accoglimento del principio, decisamente rivoluzionario, della
nazione armata che esclude l’idea dell’esercito come corpo separato e come
forza cogente nei confronti dei cittadini.
Nel sesto - “Nessuno Stato in guerra con un altro deve permettersi atti di
ostilità che renderebbero impossibile la reciproca fiducia nella pace futura” - si
pone in evidenza il carattere pernicioso di mezzi che, di fatto, si risolvono
nella pratica di un vero e proprio terrorismo di Stato, destinato, in prospettiva,
a corrompere la convivenza civile all’interno degli Stati che adottino una
84
pratica siffatta. Incontriamo qui, ancora una volta, una costatazione ricorrente
in altri testi della tradizione pacifista, anche se diversamente introdotta: la
guerra come strategia per esercitare la tirannia all’interno.
[…] La sezione seconda (gli “articoli defiitivi”). Il dovere, che nella prima
sezione ha una configurazione essenzialmente negativa - gli articoli
preliminari vi vengono espressamente definiti quali leges prohibitivae assume ora una valenza positiva. Lo stato di pace non esiste - né può
considerarsi tale la semplice condizione dell’assenza in atto della guerra, la cui
minaccia per contro è sempre attuale - e perciò deve essere istituito. La sua
istituzione prevede perciò i seguenti tre articoli: 1. La costituzione civile di
ogni stato deve essere repubblicana. 2. Il diritto internazionale deve essere
fondato su un federalismo di liberi stati. 3. Il diritto cosmopolitico deve essere
limitato alle condizioni di universale ospitalità.
I tre articoli costituiscono le condizioni per istituire lo stato di pace e le
immediate espressioni di questo»102.
Ancora alcune considerazioni.
Il richiamo costantemente rivolto alla pace nella ricostruzione del pensiero
filosofico giuridico di Kant non può risolversi nella sola opera “Per la pace
perpetua. Un progetto filosofico”.
Come è stato giustamente osservato, “l’atto di nascita del criticismo”
comporta un “richiamo […] alla struttura necessariamente pacifica della
ragione”.
“Il concreto bisogno di una pace per gli uomini e l’irrinunciabile disegno di
una pace per la ragione come tratto comune dell’umanità, ma anche come
prima pietra della filosofia costituiscono gli elementi di fondo per la
ricostruzione di un pensiero non banale sulla pace e sulla guerra nella visione
kantiana”.
Come precisa ancora Simari, queste considerazioni debbono pervenire ad
una definizione della “concezione kantiana dell’uomo”. La tensione tra “la
pace e la guerra” diviene per l’uomo “frutto non del caso, ma di una serie di
102
Filosofi per la pace, a cura di D. Archibugi - F. Voltaggio, Roma, 1999, p. 229 s.
85
fattori che spingono nell’una e nell’altra direzione e che possono assumere
configurazioni diverse”103.
Alcuni interrogativi.
L’ammirevole ricostruzione teorica qui appena lumeggiata consente alcune
osservazioni che possono forse fare assumere ampio valore – nella
ricostruzione giuridica di Kant, quanto alla pace – alla sua opera “Per la pace
perpetua”.
Se da un lato la ragione ha una “struttura necessariamente pacifica”,
l’impossibilità di poterla scomporre “in una moltitudini di ragioni individuali”
o di collocarla “in un luogo metafisico insieme immanente e trascendente”,
apre ad una possibilità spesso vana: solo i «cittadini della “repubblica della
ragione” possono dare» la speranza della pace tra gli uomini.
Ma ecco che nella ricostruzione fornita da Simari appare la necessità
dell’uomo che ispirato dalla ragione è diversamente sospinto dalla possibilità
del caso.
Un uomo che “subisce” la possibilità non rinuncerà e non potrà rinunciare
– secondo questa ricostruzione che si ferma al criticismo – non sembra per una
sua scelta, diversa da quella che la ragione attesterebbe, ma per un’essenziale
possibilità che non deve coincidere con la ragione.
Nulla di tutto questo sembra ispirare “Per la pace perpetua. Un progetto
filosofico”104: “la pace perpetua può […] rappresentare il vero coronamento
della filosofia pratica, in quanto in essa si manifesta la necessaria e conclusiva
convergenza tra morale diritto e politica. Di particolare importanza risulta
allora il legame tra l’idea della pace l’attività politica destinata a realizzarla, in
quanto è precisamente a partire da tale idea che Kant in grado di sviluppare la
propria teoria della politica nella maniera più persuasiva”105.
103
A. Simari, Pace e guerra nel pensiero di Kant, Milano, 1998, p. 279 s.
A. Simari, Pace e guerra nel pensiero di Kant, cit., p. 280 s.
105
A. Nuzzo, L’idea kantiana della pace perpetua tra morale, diritto e politica, in Teoria politica, 1995, 2, p. 59.
104
86
ARON*
la pace è il fine al quale tendono le società
_________________
* Raymond Aron (1905-1983), lettore all’Università di Colonia (1930), è stato
poi all’Accademia di Berlino (1931-33); di ritorno in Francia, ha sostenuto,
87
nel 1938, la sua tesi di dottorato, Introduzione alla filosofia della storia, per
dar luogo ad una carriera universitaria che ha seguito con successo il cursus
honorum. Aron è autore di opere storiche e politiche tra le quali ricordiamo:
L’oppio degli intellettuali, 1955; La tragedia algerina, 1957; Pace e guerra
tra le nazioni, 1962; Tre saggi sull’era industriale, 1966; Le tappe del
pensiero sociologico, 1967; Da una famiglia santa all’altra. Saggio sui
marxismi immaginari, 1969; Memorie, 1983.
Pace e Guerra tra le nazioni
« In tutte le epoche storiche106 e presso tutte le civiltà c’è stata e c’è la
guerra. Con asce o con cannoni, con frecce o con pallottole, con esplosivi
chimici o con reazioni atomiche a catena, da vicino o da lontano, isolatamente
o in massa, a caso o secondo un metodo rigoroso, gli uomini si sono uccisi
mettendo in opera gli strumenti che la consuetudine ed il sapere delle
collettività offrivano.
Perciò si potrebbe pensare che una “tipologia formale” delle guerre e
delle paci sia illusoria, e sia valida, soltanto una tipologia sociologica che
consideri le modalità concrete dei fenomeni. Eppure, se le analisi precedenti
contribuiscono a mettere in chiaro la logica della condotta diplomatica e della
condotta strategica, la tipologia formale che nel deriva potrà esserci in una
certa misura utile.
[…] Questa volta prendiamo come punto di partenza la pace, perché essa è
di regola il fine al quale tendono le società.
Questa proposizione non contraddice il principio dell’unità della politica
estera, cioè il principio della continuità delle relazioni tra le nazioni. Il
diplomatico non dimentica la possibilità e le esigenze dell’arbitrato delle armi
neppure nei periodi in cui egli si impone di non ricorrere ai mezzi violenti. La
rivalità tra collettività politiche non comincia con la rottura dei trattati e non
termina con la conclusione di una tregua. Ma quale che sia l’obiettivo della
politica estera – possesso del suolo, dominio sugli uomini o trionfo di un’idea
106
Dialettica della pace e della guerra.
88
– tale obiettivo non è la guerra in se stessa. Certi uomini amano il
combattimento in se stesso, certi popoli praticano la guerra come altri
praticano lo sport.[…]
La pace si è presentata a noi finora come la sospensione più o meno duratura
delle modalità violente della rivalità tra unità politiche. Si dice che regna la
pace quando i rapporti tra le nazioni non comportano le forme militari della
lotta. Ma siccome questi rapporti pacifici si svolgono all’ombra delle battaglie
del passato e nel timore, o nell’attesa, delle battaglie future, il principio della
pace, nel senso in cui Montesquieu si serve di questo termine nella sua teoria
dei governi2, non è per sua natura differente dal principio della guerra: le paci
sono fondate sulla potenza, vale a dire sul rapporto tra le capacità di agire le
une sulle altre delle unità politiche. Poichè i rapporti di potenza in un tempo di
pace, pur senza essere il riflesso esatto del rapporto delle forze attuali o
potenziali, sono un’espressione più o meno deformata di esso, i diversi tipi di
pace possono essere riferiti ai tipi di rapporti di forze. Distinguo tre tipi di
pace, equilibrio, egemonia, impero: in un dato spazio storico, le forze delle
unità politiche o si controbilanciano o sono denominate da quelle di una di
essi, oppure infine sono superate da quelle di una di esse in modo che tutte le
unità, salvo una, perdono la loro autonomia e tendono a sparire in quanto
centri di decisioni politiche. Lo stato imperiale, in definitiva, si riserva il
monopolio della violenza legittima.
Si potrebbe obiettare che proprio per questo la pace imperiale cessa di
essere, per definizione, una “congiuntura di politica estera”. La pace imperiale
non si distinguerebbe dalla pace civile, sarebbe l’ordine interno di un impero.
Potremmo tener conto di questa obiezione soltanto se la tipologia fosse
puramente astratta, priva di relazioni con i dati della storia. Anche se ci sono
casi in cui la pace imperiale, una volta stabilitasi, non si distingue più dalla
2
Vale a dire il sentimento o, come diremmo oggi, la pulsione o l’emozione necessaria al mantenimento di un certo tipo
di governo: virtù, onore, timore.
89
pace nazionale, l’assimilazione della pace imperiale in quanto tale alla pace
civile si indurrebbe a disconoscere la diversità delle situazioni107. […]
[…]
Tra la pace dell’equilibrio e la pace dell’impero si intercala la
pace dell’egemonia. L’assenza di guerre non dipende dall’approssimativa
parità di forze che regna tra le unità politiche e impedisce che una di esse o
una colazione impongano la propria volontà, ma dipende al contrario dalla
superiorità incontestabile di una delle unità. Questa superiorità è tale che gli
stati insoddisfatti disperano di modificare lo status quo, e tuttavia lo stato
egemonico non cerca di assorbire le unità ridotte all’impotenza. Esso non
abusa dell’egemonia, rispetta le forme esteriori dell’indipendenza degli stati e
non aspira all’impero.
In un sistema di unità gelose della propria indipendenza, l’egemonia è
una modalità precaria dell’equilibrio108. […]
Nell’America settentrionale, la pace egemonica che fanno regnare gli
Stati Uniti non è un aspetto, parziale e fuggitivo, di un sistema di equilibrio,
ma è il risultato duraturo della sproporzione, dovuta alla situazione geografica
e accentuata dalla storia, tra le forze della repubblica degli Stati Uniti e quelle
del Messico o del Canada. Nel secolo scorso gli Stati Uniti hanno avuto
107
L’Autore, al riguardo evidenzia alcuni esempi. La «pace dell’impero tedesco dopo il 1871, a parte i resti di sovranità
conservati dalla Baviera, col passare degli anni differiva sempre meno dalla pace interna della repubblica francese.
Invece le polis greche sottomesse da Filippo e trascinate da Alessandro alla conquista dell’Asia non avevano perduto
completamente la loro autonomia politico-amministrativa, non erano state private di tutti gli attributi che per noi sono
costitutivi della sovranità, disponevano immediatamente in caso di rivolta, di un embrione di forza armata. La guerra
degli ebrei - sempre secondo Aron - ci ricorderebbe, se fosse necessario, la precarietà della pace romana; i popoli
conquistati non venivano disarmati completamente. Alle antiche istituzioni ed ai sovrani, ormai protetti da Roma, si
sovrapponeva, senza eliminarli, l’ordine imperiale. In latri termini, la pace imperiale fa capo alla pace civile a mano a
mano che scompaiono i ricordi delle unità politiche un tempo indipendenti e che gli individui che popolano la zona
pacificata si sentono meno uniti alla comunità, tradizionale o locale, e più uniti allo stata conquistatore». Ancora,
secondo Aron, l’«impero che Bismarck forgiò con il ferro e con il fuoco diventò uno stato nazionale: l’impero romano
restò fino alla fine una zona pacificata. I re di Francia forgiarono la nazione francese: la Francia fece regnare per un
certo tempo la pace imperiale nell’Africa settentrionale».
108
«Il Reich tedesco deteneva, dopo il 1870, una specie di egemonia che Bismarck sperava di far accettare dagli altri
stati europei a forza di moderazione, placando i timori o i risentimenti. I successori del cancelliere furono meno
fortunati: non poterono prevenire la formazione di alleanze che ristabilivano l’equilibrio. Forse la Germania di
Bismarck non merita di essere detta egemonica perchè la sua egemonia era limitata la continente e quest’ultimo non
costituiva un sistema chiuso. Ora, se teniamo conto della Gran Bretagna e dei suoi prolungamenti marittimi, il Reich
non era francamente egemonico. Aveva una preponderanza sul continente come prima di esso la Francia nella prima
parte del regno di Luigi XIV o la Spagna nel secolo XVI. L’Inghilterra aveva sempre impedito che una simile
preponderanza si trasformasse in impero o anche soltanto in un’egemonia incontestata. La preponderanza tedesca
sarebbe diventata egemonia se il Reich, dopo aver battuto la Francia e la Russia, avesse potuto firmare una pace
vittoriosa o di compromesso con la Gran Bretagna. Il Reich guglielmino si sarebbe accontentato di una pace egemonica,
il Reich hitleriano avrebbe dettato una pace imperiale».
90
bisogno di una grande guerra non per allargare lo spazio sottoposto alla loro
sovranità, ma per far persistere la federazione. L’acquisto della Louisiana,
della Florida, della California e del Texas richiede soltanto dollari o operazioni
militari poco dispendiose. La rivendicazione del diritto di secessione avanzata
dagli stati del sud fu il motivo per il quale furono versati fiumi di sangue. Una
volta consolidata la federazione e conquistate o occupate le terre dell’ovest e
del sud, domati o espulsi gli indiani o gli altri europei, gli Stati Uniti erano
troppo forti perchè sul continente americano potesse costituirsi un sistema di
equilibrio, erano troppo indifferenti alla gloria di regnare e non avevano
abbastanza bisogno di terra per minacciare l’indipendenza degli stati vicini, a
nord ed a sud. La combinazione dell’egemonia e della politica di buon
vicinato si chiama la pace americana. […]
Nè l’antichità nè l’Asia nè
l’Europa moderna hanno mai conosciuto una fase duratura tra l’equilibrio e
l’impero. La civiltà greco-latina del Mediterraneo, dopo lunghi periodi di
disordini, ha adottato la pace imperiale. In Asia, le tre grandi civiltà3 hanno
conosciuto periodi alterni di pace di equilibrio e di pace imperiale. In
Giappone la pace di equilibrio è stata considerata retrospettivamente una
dispersione feudale della sovranità, perchè la pace imperiale di Tokugawa,
grazie all’omogeneità di cultura e di istituzioni, ha portato alla pace civile.
L’unità imperiale realizzata in Cina più di duemila anni or sono dalla vittoria
definitiva di uno stato sui suoi rivali permetteva soltanto che si alternassero
fasi di decomposizione e fasi di restaurazione, fasi di guerre civili e fasi di
pace imperiale e civile ad un tempo. Quanto alla politica estera, l’impero
esitava tra la difensiva dietro le grandi muraglie e le velleità di espansione.
Conquistato dai mongoli e poi dai manciù, non entro mai (prima del secolo
XIX) in un sistema permanente di relazioni internazionali tra uguali. Quanto
all’India, prima della preponderanza britannica essa non aveva mai conosciuto
in tutto il suo territorio l’equivalente della pace degli shogun o della pace
dell’impero di mezzo, senza per questo aver sviluppato un sistema di
equilibrio paragonabile a quello delle polis greche o degli stati europei.
3
Il termine è usato nel senso delle “culture” di Spengler o delle “società” di Toynbee.
91
Formalmente, uno spazio storico è o unificato sotto un’unica forza o un’unica
sovranità, o frazionato in centri autonomi di decisione e di azione. Nel primo
caso, si parlerà di impero universale, nel secondo, di stati battaglieri. Il sistema
di equilibrio a configurazione pluripolare tende a stabilizzare le relazioni tra
unità che si riconoscono reciprocamente ed a limitare i conflitti che
oppongono le unità le une alle altre. Di fatto, i conflitti hanno sempre assunto,
in qualsiasi epoca, una tale estensione ed una tale intensità, che gli alleatirivali della stessa civiltà paiono stati battaglieri, responsabili della rovina
comune a chi conosce i secoli trascorsi tra l’epoca degli attori e quella
dell’osservatore, e cioè l’avvenire di quelli ed il passato di quest’ultimo.
La classificazione ternaria delle paci ci fornisce nello stesso tempo una
classificazione, la più formale e la più generica, delle guerre: le guerre
“perfette”, conformi alla nozione politica della guerra, sono interstatali: in
esse si affrontano unità politiche che si riconoscono reciprocamente esistenza
e legittimità. Chiameremo soprastatali o imperiali le guerre il cui oggetto,
origine o conseguenza, sia l’eliminazione di certi belligeranti e la formazione
di un’unità al livello superiore. Chiameremo infrastatali o infraimperiali le
guerre la cui posta è il mantenimento o la decomposizione di un’unità politica,
nazionale o imperiale.
Le guerre interstatali diventano imperiali quando uno degli attori di un
sistema internazionale in caso di vittoria sarebbe portato ad estendere,
volontariamente o no, la propria egemonia o il proprio impero sui rivali. Le
guerre interstatali tendono ad ampliarsi in guerre iperboliche quando uno degli
attori rischia di acquistare una schiacciante superiorità di forze: fu questo il
caso della guerra del Peloponneso o della guerra del 1914-1918. La violenza
di un conflitto può non essere imputabile nè alla tecnica di combattimento nè
alle passioni dei belligeranti, bensì alla geometria dei rapporti delle forze.
L’importanza della posta in gioco – libertà delle polis greche o degli stati
europei – è ciò che rinfocola l’ardore guerriero. Le grandi guerre segnano
92
spesso il passaggio da una configurazione all’altra, da un sistema all’altro – e
questo passaggio ha, a sua volta, molte cause109. […]
Queste due tipologie formali110 richiedono entrambe un’analisi più
approfondita. Se il principio4 delle tre paci, di equilibrio, di egemonia e di
impero, è la potenza, ci si può chiedere se la pace possa avere un altro
principio che non sia la potenza. Se le guerre non sono concretamente definite
dal loro carattere interstatale, soprastatale e infrastatale, ci si può chiedere
quali altri appellativi si dovrebbero applicare per definirle.
Cominciamo da quest’ultimo problema. Molte classificazioni delle
guerre sono possibili e sono state proposte. Forse nessuna di esse ha
un’evidenza che le permetta di imporsi, forse molte classificazioni sono
parzialmente valide. Non è evidente che la diversità delle guerre si organizzi
spontaneamente in un quadro armonioso. Mi sembra tuttavia che alla tipologia
precedente, giustificata dal vincolo che stabilisce tra i tipi di pace e la struttura
del sistema internazionale, se ne possano aggiungere altre due, l’una fondata
sulla natura delle unità politiche e delle idee storiche che i belligeranti
incarnano, l’altra fondata sulla natura delle armi e dell’apparato militare. La
prima di queste due tipologie implica un riferimento ai fini e la seconda un
riferimento ai mezzi.
Si parla correntemente di guerre feudali, di guerre dinastiche, di guerre
nazionali, di guerre coloniali. Tutte queste espressioni suggeriscono che il
modo in cui si organizzano all’interno le collettività imprime il suo marchio,
conferisce il suo stile ai rapporti bellici delle unità politiche. Effettivamente il
modo di organizzarsi contribuisce a determinare – se non le determina
esclusivamente – le occasioni dei conflitti e le poste che essi mettono in gioco,
109
«In generale, non è possibile attribuire alle guerre di una determinata categoria questo o quel carattere concreto. Le
guerre infrastatali o infraimperiali – guerra degli ebrei contro Roma, dei chouans contro la rivoluzione, guerre di
secessione, guerre di liberazione dell’Algeria – che oppongono un potere organizzato a popolazioni che rifiutano di
abbedirgli, sono spesso guerre crudelissime; sotto certi aspetti sono guerre civili, soprattutto se prevale il potere
costituito. Analogamente, la guerra diventa imperiale quando uno dei belligeranti brandisce un principio transnazionale
ed il conflitto interstatale si carica di passioni partigiane. Il nemico, allora, è al tempo stesso lo straniero e l’avversario
(o l’eretico o il traditore). Sarebbe pur sempre pericoloso insistere su queste nozioni astratte. Non sempre interessa agli
uomini salvaguardare l’unità politica alla quale appartengono o l’idea storica che il loro stato incarna. Ci sono unità che
sopravvivono a loro stesse e idee vuote di senso. Anche se queste categorie determinassero la violenza dell’inimicizia,
questa da sola non determina nè la durata del combattimento nè la condotta dei combattenti».
110
Poste delle guerre e principi delle paci.
4
Ricordo che questo termine è usato qui nel senso che gli diede Montesquieu.
93
i giudizi che gli uomini di stato emettono su ciò che è legittimo e ciò che è
illegittimo, la loro concezione della diplomazia e della guerra. Il principio di
legittimità5,
per
riprendere
una
espressione
anteriore,
risponde
contemporaneamente alle due domande: chi comanda all’interno? A quale
unità devono appartenere un certo territorio o certe persone? Le guerre
somigliano al principio di legittimità che regna sullo spazio e nel tempo in cui
esse hanno luogo.
Il principio di legittimità crea l’occasione o la causa del conflitto. Le
relazioni tra vassallo e signore si intersecano al punto di dar luogo a certe
contraddizioni. La volontà di potenza spinge certi vassalli a mancare ai loro
obblighi. E’ difficile tracciare i limiti dell’azione legittima quando tanti
inferiori si riservano dei mezzi militari e rivendicano una certa libertà di
decisione. Finchè le terre o gli uomini appartengono alle famiglie regnanti, la
posta della guerra è una provincia che due sovrani si contendono,
scambiandosi argomentazioni giuridiche o colpi di mitragliatrice, o il trono al
quale pretendono due prìncipi. Il giorno in cui la coscienza collettiva riconosce
agli uomini il diritto di scegliere la propria unità politica, le guerre diventano
nazionali, sia quando due stati rivendicano la stessa provincia, sia quando
popolazioni divise tra unità tradizionali vogliono costituire un solo stato.
Infine, se domani l’opinione ammettesse che l’era delle nazionalità è passata e
che sulle preferenze dei governati devono prevalere le esigenze economiche o
militari dei grandi complessi, le guerre sarebbero imperiali come finora non lo
sono mai state: i conquistatori – romani nel Mediterraneo, europei in Asia ed
in Africa – non negavano l’idea nazionale, ma l’ignoravano o rifiutavano di
concederne il beneficio a popolazioni o a classi di uomini considerati inferiori
ed indegni, a titolo provvisorio o definitivo, della dignità di cittadini111. Questa
volta i conquistatori negherebbero l’idea in nome di necessità materiali»112.
5
Va da sè che qui “principio” è preso nel suo senso ordinario, e non già in quello di Montesquieu.
«Nè gli hitleriani nè i comunisti hanno allegato tali necessità. La vera giustificazione dell’avventura del Terzo Reich,
quale la pensavano sinceramente i dottrinari del nazismo, era la superiorità razziale del popolo tedesco. La vera
giustificazione della sovietizzazione del mondo, secondo i teorici del marxismo-leninismo, è la superiorità o la vittoria
inevitabile del regime battezzato da loro “socialista”. Nella nostra epoca – e forse anche in altre epoche – i conquistatori
provano il bisogno di giustificarsi, moralmente o storicamente, ai propri occhi. I principi di legittimità suscitano
conflitti di tre tipi: quelli che nascono dalla pluralità delle interpretazioni possibili, quelli che dipendono dalla
contraddizione tra lo statuto esistente ed il nuovo principio, quelli che risultano dall’applicazione stessa del principio e
111
94
.
COMMENTO
«Sono innumerevoli le forme e i tipi di pace di cui possiamo trarre notizia
dalla storia e non meno innumerevoli i criteri in base ai quali ne è stata tentata
da vari autori la classificazione. Aron distingue tre tipi di pace che chiama di
“potenza” , di “impotenza”, di “soddisfazione”.
A uno dei due estremi sta la pace di potenza di cui distingue tre sottospecie,
che chiama pace di “equilibrio”, di “egemonia”, di “impero”, secondoché i
gruppi politici siano in rapporto o di eguaglianza o di diseguaglianaza fondata
sulla preponderanza di uno su tutti gli altri (come avviene nel caso degli Stati
Uniti nei riguardi degli altri stati dell’America), o su un vero e proprio
dominio (come, ad esempio, la pax romana).
All’altro estremo sta la pace di soddisfazione, che ha luogo quando in un
gruppo di stati nessuno ha pretese territoriali o d’altro genere verso gli altri e i
loro rapporti sono fondati sulla fiducia reciproca (l’esempio attuale più
evidente è quello della pace che dopo la seconda guerra mondiale esiste fra gli
Stati dell’Europa occidentale).
In mezzo c’è la pace d’impotenza, un evento nuovo, secondo Aron, essendo
fondata sullo stato che dopo l’avvento della guerra atomica si chiama
dalle modificazioni che intervengono nel rapporto delle forze. I diritti rivendicati dal re d’Inghilterra al trono di Francia
appartengono alla prima categoria, come pure i diritti incompatibili accampati dalla Germania e dalla Francia
sull’Alsazia, terra dell’impero nel medioevo, di dialetto e di cultura germanica, conquistata da Luigi XIV, la cui
popolazione nel 1871 voleva restare francese. Nel 1914 lo statuto territoriale dell’Europa era un compromesso tra l’idea
nazionale e l’eredità dei diritti dinastici. La spartizione della Polonia, gli imperi plurinazionali dell’Austria-Ungheria e
della Turchia erano opera dei secoli passati».
112
R. Aron, Pace e guerra tra le nazioni, Edizioni di Comunità, 1962, pp. 187-193.
95
“equilibrio del terrore”, definito come quello che “regna tra le unità politiche,
se ciascuna di esse ha la capacità di colpire mortalmente l’altra”.
[... Secondo Bobbio questa] definizione è identica a quella che Hobbes ha dato
dato dello stato di natura, là dove osserva, proprio all’inizio della descrizione
di questo stato, che la sua estrema pericolosità deriva proprio dal fatto che in
esso tutti gl’individui sono eguali e sono eguali proprio perché ognuno può
recare all’altro il massimo dei mali, la morte.
Lo stato di natura hobbesiano è lo stato dell’equilibrio del terrore permanente,
fondato com’è esclusivamente sul “timore reciproco”: uno stato che, come
l’attuale equilibrio del terrore fra le potenze atomiche, quando non è una
guerra aperta, è una tregua in attesa di una guerra improbabile ma sempre
possibile.
Paradossalmente, la pace d’impotenza è l’effetto congiunto dell’antagonismo
di due enti eguali e contrari, in cui l’importanza di ognuno dei due deriva dalla
potenza dell’antagonista»113.
113
N. Bobbio, Teoria generale della politica, a cura di M. Bovero, Torino, 1999, p. 499.
96
BOBBIO*
La pace attraverso il diritto
97
_____________________
* «Norberto Bobbio (1909-2004), nel dopoguerra ha insegnato Filosofia del
diritto all’Università di Torino (1948-72) e Filosofia della politica, ancora a
Torino, dal 1972 al 1979. Dal 1979 è stato professore emeretito
dell’Università di Torino». Opere principali: L’indirizzo fenomenologico nella
filosofia sociale e giuridica, Torino, 1934; Scienza e tecnica del diritto,
Torino, 1934; L’analogia nella logica del diritto, Torino, 1938; La
consuetudine come fatto normativo, Padova, 1942; La filosofia del
decadentismo, Torino, 1945; Teoria della scienza giuridica, Torino, 1950; Il
terzo assente, Torino, 1988; Thomas Hobbes, Torino, 1989; L’età dei diritti,
Torino, 1989, Destra e sinistra, Roma 1994».
Il terzo assente
«Per “guerra” s’intende una specie particolare di conflitto, il conflitto fra
gruppi organizzati che tendono a sopraffarsi con la violenza114. Ma anche per
“pace” non s’intende soltanto la cessazione della guerra. Si usa, ad esempio,
sempre più spesso l’espressione “pace sociale” per indicare lo stato di
cessazione di conflitti, che non sono necessariamente guerre nel senso proprio
114
Bobbio precisa che, «quando nel 1966 […in occasione del] colloquio annuale [della disciplina] fu dedicato al
problema della guerra [egli] scels[e] il tema La guerra e il diritto (ora col titolo Per una teoria dei rapporti tra guerra e
diritto in AA.VV., Scritti in memoria di Antonio Giuffrè, Giuffrè, Milano 1967, pp. 89-98). Nel […] colloquio dedicato
al problema della pace, [oggetto di questa pubblicazione,] il tema [… da lui scelto] è La pece e il diritto. Come dire, il
tema simmetrico e opposto». Come aggiunge Bobbio, «la prima raffigurazione della guerra che ci viene incontro da una
tradizione di secoli è quella di causa efficiente di uno stato antigiuridico; la prima e più antica raffigurazione del diritto,
al contrario, è quella di causa efficiente di uno stato di pace. La guerra in altre parole – secondo Bobbio - viene
primariamente concepita come negazione del diritto; il diritto, a sua volta, come affermazione o riaffermazione della
pace. Questa antitesi è bene rappresentata da due celebri passi ciceroniani: Inter arma silent leges e Cedant arma togae.
Le armi fanno tacere le leggi; le leggi rendono vane le armi. Sulla base di questa antitesi è costruita – secondo l’Autore la teoria hobbesiana dello stato: lo stato di natura è uno stato di guerra in quanto è uno stato senza diritto, in cui le leggi
positive non esistono ancora e le leggi naturali esistono ma non sono efficaci; lo stato civile è quello stato in cui gli
uomini attraverso un accordo di ciascuno con tutti gli altri, istituiscono un sistema di leggi valide ed efficaci allo scopo
di far cessare la guerra di tutti contro tutti ed instaurare la pace. Si tratta quindi di uno stato pacifico proprio in quanto è
uno stato giuridico ed il passaggio da uno stato all’altro avviene attraverso un atto giuridico quale è il contratto;
pertanto, mentre lo stato di natura è uno stato di guerra a causa della mancanza di diritto, lo stato civile è uno stato di
pace in quanto è la conseguenza di un atto giuridico». Ancora, secondo Bobbio, «considerando il diritto dal punto di
vista della sua funzione, non c’è teoria del diritto che non comprenda tra le funzioni del diritto quella di dirimere i
conflitti. Anche per coloro per i quali il diritto, ha altre funzioni, quella funzione di dirimere i conflitti non è mai del
tutto omessa. Generalmente la soluzione dei conflitti è considerata lo scopo minimo del diritto, inteso come
Zwangsordnung (ordinamento coattivo), ovvero come ordinamento che si serve dell’uso legittimo della forza per
realizzare i suoi fini. Che il termine “conflitto” sia più ampio del termine “guerra” non implica alcuna differenza
rispetto al tema iniziale».
98
della parola, all’interno di un gruppo politico. Accanto alla coppia pace-guerra
soccorrono altre coppie, come ordine-disordine, concordia-discordia, unionedisunione, e all’origine, cosmo-caos: in tutte il diritto può essere variamente
coniugato col termine positivo mentre è in contrasto col termine negativo.
Nell’affresco della Sala della Pace del Palazzo comunale di Siena,
dipinto da Ambrogio Lorenzetti, raffigurante rispettivamente in Buongoverno
ed il Malgoverno, nella rappresentazione del primo campeggiano le figure
della Concordia e della Pace (la Pace, che affianca la figura del Bene Comune,
è collocata al centro dell’affresco), nella rappresentazione del secondo
compaiono soldati in atto di saccheggiare e combattere in una campagna
incolta e deserta.
La funzione di dirimere i conflitti, il diritto l’adempie in due modi: con
un’azione preventiva e con un’azione successiva, ovvero cercando d’impedire
che sorgano oppure ponendo a essi fine qualora siano sorti. Alla prevenzione
sono rivolte generalmente le norme primarie, le norme i cui destinatari sono
gli stessi membri della comunità tra i quali possono sorgere conflitti di varia
natura (non solo conflitti d’interesse); alla repressione generalmente le norme
secondarie, le norme i cui destinatari sono funzionari pubblici incaricati di far
rispettare, anche ricorrendo alla forza, le norme primarie.
Esempio delle prime sono le norme sui contratti che occupano una parte
cospicua del diritto civile, e stabiliscono le principali modalità che è
obbligatorio o conveniente siano seguite affinchè gli accordi destinati a
rendere compatibili interessi contrastanti sortiscano i loro effetti; esempio
delle seconde sono le norme del diritto penale qualora siano interpretate,
secondo una tradizione che va da Jhering a Kelsen, come norme rivolte non ai
cittadini ma ai giudici, ed a maggior ragione le norme del diritto processuale.
Che norme giuridiche siano soltanto le norme secondarie (Kelsen) oppure
tanto le norme primarie quanto le secondarie e la loro combinazione (Hart), è
una questione che qui si può lasciare impregiudicata. Ciò che importa per la
caratterizzazione di un ordinamento normativo giuridico distinti da un
ordinamento morale o sociale è la legittimità dell’uso della forza per ottenere
obbedienza alle norme dell’ordinamento, dove per “legittimo” s’intende il
99
riconoscimento della sua necessità da parte della stragrande maggioranza dei
membri del gruppo (ed è appunto questa legittimità che distingue la forza
lecita da quella illecita). […]
Consideriamo l’accordo (o contratto o patto, che considera qui come
sinonimi, pur avendo nel linguaggio tecnico spesso significati diversi) quali
l’atto (bilaterale o multilaterale) con cui due contendenti pongono fine a uno
stato di conflitto e stabiliscono fra loro uno stato di pace. Si può parlare
correttamente di pace attraverso il diritto o di stato giuridico di pace (e non di
stato di pace in generale) solo quando l’accordo avviene in un contesto
normativo in cui vi sono non soltanto regole che stabiliscono le modalità per la
istituzione di un accordo ma anche regole che stabiliscono quali sono le
modalità che debbono essere osservate nel caso in cui l’accordo non venga
osservato dall’uno o dall’altro dei due contraenti. Per usare espressioni
tecniche del linguaggio giuridico, il contesto normativo in cui si può parlare
correttamente di pace attraverso il diritto è quello in cui sono previste regole
non soltanto per la validità ma anche per l’efficacia dell’accordo. Accordi di
cui non è garantita l’efficacia, ovvero l’osservanza, non sono strumenti di
pace, ma sono spesso nuove occasioni di conflitto o di guerra.
Prova ne sia che ogni sistema di regole sulle modalità degli accordi si
presuppone si fondi, anche solo tacitamente, sulla regola generale che i patti
debbono essere osservati (pacta sunt servanda). Ma questa regola, di per se
stessa considerata, è una regola morale, una regola cioè la cui osservanza
dipende unicamente dalle buone ragioni che possono essere addotte dai due
contendenti per preferirne l’osservanza piuttosto che l’inosservanza. Fra
queste buone ragioni c’è certamente quella formulata da Kant con il suo
famoso principio della “universalizzabilità” dell’azione come criterio per
distinguere ciò che debbo fare da ciò che non debbo fare. Testualmente: “Non
debbo mai comportarmi in modo da non poter volere che la mia massima
divenga una legge universale”. Non bisogno di richiamare la vostra attenzione
sul fatto che per illustrare questo criterio Kant fa proprio l’esempio della
promessa, ponendo questa domanda: “Mi è lecito, non mantenerla?” Ma se
tutti facessero altrettanto che valore si potrebbe dare alla mia promessa? Che
100
senso ha stipulare dei patti se non si accetta preliminarmente il principio che i
patti debbono essere osservati? Del resto, anche la morale utilitaristica è in
grado di addurre i suoi buoni argomenti in favore dello stesso principio: quale
utilità posso trarre dal non mantenere le promesse quando ammetto, e non
posso non ammettere, che gli altri possano fare altrettanto? Ma se ammetto
che gli altri possano fare altrettanto che vantaggio posso trarre dal non
mantenere la mia promessa? Non ne dovremo trarre la conseguenza che il
mantenere le promesse ha senso soltanto in una società in cui il principio che
le promesse debbano essere mantenute venga rispettato?
Purtroppo bastano le buone ragioni per fondare razionalmente una
regola, ma non bastano per ottenerne con una certa sicurezza l’osservanza. Il
tema del fondamento razionale delle massime morali, che impegna
giustamente i filosofi, è tanto teoricamente appassionante quanto praticamente
irrilevante. Non c’è massima morale che venga osservata soltanto perchè sia
stata ben fondata. Il dibattito sul fondamento delle norme morali è un tipico
dibattito teorico, un mirabile gioco intellettuale, che ha scarsa o nessuna
incidenza sui reali comportamenti degli uomini, che seguono più la passione
che la ragione, più l’interesse immediato che l’interesse a lunga scadenza. Il
fondamento razionale di una massima può valere per quei pochissimi uomini
che si lasciano guidare dalla loro ragione e quindi persuadere dagli argomenti
razionali addotti dai filosofi. Si aggiunga che chiunque viola una massima
fondata razionalmente, conta sulla considerazione non meno razionalmente
plausibile che tutti gli altri la seguano e quindi non ne venga alcun danno a lui
ed alla società tutta intera. Se io rubo sul presupposto che tutti gli altri non
rubino, posso tranquillamente continuare a rubare. Se io non mantengo le
promesse in una società in cui gli altri le mantengono, posso continuare con
mio vantaggio e con poco danno della società, a non mantenerle.
Ma come?
Per ottenere l’osservanza dei principi morali occorre ben altro che l’averli
giustificati razionalmente. L’esperienza storica dimostra che occorre
minacciare pene tali o terrene o ultraterrene (ove quest’ultime siano credibili,
ma l’universo in cui le pene ultraterrene sono ancora credibili si va
101
restringendo sempre più) tali da costituire una remora per ogni potenziale
deviante. A questo punto entra in scena il diritto. Ma è chiaro che al punto in
cui entra in scena il diritto, il problema non è più quello della validità della
regola, qualunque essa sia, ma quello della sua efficacia, nel nostro caso
specifico, non più quello del fondamento razionale del principio pacta sunt
servanda ma della sua effettiva (quanto è più possibile) applicazione115. […]
Chi oggi consideri il modo con cui procedono, o meglio non procedono, le
trattative per il disarmo tra le due grandi potenze, le quali non riconoscono di
fatto alcuna potenza superiore, nonostante l’Organizzazione delle Nazioni
Unite, e pertanto possono essere considerate l’una nei riguardi dell’altra in uno
stato di natura hobbesiano, se pure a livello di relazioni non tra individui ma
tra gruppi (princeps principi lupus), non tarderà a riscontrare l’esattezza della
ipotesi hobbesiana: la ragione per cui le trattative del disarmo stentano a
procedere verso una conclusione positiva (e di fatto sono sinora sempre fallite,
si che la potenza delle armi è continuamente aumentata da entrambe le parti)
sta nel fatto che l’una non si fida dell’altra. Chi comincia per primo in una
situazione in cui non è sicuro che l’altro segua o faccia subito altrettanto si
mette nelle mani altrui. Ma allora nessuno dei due comincia; pertanto le
115
«La dimostrazione che il principio pacta sunt servanda è, in uno stato antigiuridico come lo stato di natura,
inefficace, è stata data una volta per sempre da Hobbes. Nessun può ritenersi obbligato a osservare i patti se non è
sicuro che l’altro farà altrettanto. Ma come può essere sicuro nello stato di natura in cui non esiste un potere superiore a
entrambi i contraenti, capace di costringere all’osservanza l’inadempiente? Con le parole stesse di Hobbes: “[Nello stato
di natura] chi adempie per primo non ha alcuna assicurazione che l’altro adempia in seguito, perchè i vincoli delle
parole sono stroppo deboli per imbrigliare l’ambizione, l’avarizia, l’ira e le altre passioni degli uomini, senza il timore
di qualche potere coercitivo, che non si può supporre vi sia nello stato di mera natura, dove tutti gli uomini sono eguali
e giudici della giustezza dei loro timori. Perciò chi adempie per primo non fa che consegnarsi al suo nemico contro il
diritto di difendere la propria vita” (Th. Hobbes, Leviatano, La Nuova Italia, Firenze 1976, p. 132). Un noto studioso di
Hobbes, J.W.N. Watkins, in un libro in cui affronta il tema delle decisioni razionali attraverso la teoria dei giochi,
trascrive in questi termini quello che, sulla scorta di Hobbes, chiama “il gioco dello stato di natura”. “Tizio e Caio sono
due uomini hobbesiani in un hobbesiano stato di natura. Entrambi portano con sè un armamento micidiale. Un
pomeriggio, mentre sono in cerca di ghiande, s’incontrano in una piccola radura in mezzo al bosco. Il sottobosco rende
la fuga impraticabile. Tizio grida: “Aspetta! Non facciamoci a pezzi”. Caio risponde: “Condivido il tuo stato d’animo.
Contiamo: quando arriveremo a dieci ciascuno di noi due getterà le armi alle proprie spalle tra gli alberi”. Ciascuno dei
due adesso comincia furiosamente a pensare: è il caso o non di gettare via le armi quando arriviamo a dieci?” (J.W.N.,
Watkins, Libertà e decisione, Armando, Roma 1981, p. 86). Ognuno considera che se nessuno le butta nel timore che
l’altro non le butti, ne verrà uno scontro all’ultimo sangue in cui ognuno rischia la morte. Ma considera anche all’ultimo
sangue in cui ognuno rischia la morte. Ma considera anche se lui le butta o l’altro no, la propria uccisione è sicura. E
allora? Delle quattro soluzioni possibili, che le butti il primo e non il secondo, il secondo e non il primo, che non le butti
nessuno dei due, che le buttino tutte e due, quest’ultima corrispondente all’osservanza del pacta sunt servanda è una
sola, e non è detto che sia la più probabile. Per Hobbes è tanto poco probabile che l’unica soluzione che egli propone è
quella che spinge entrambi non già a buttare dietro le spalle le loro armi, e quindi a mettere in atto una situazione di
disarmo bilaterale, ma di consegnarle a un terzo che sia garante d’ora innanzi del rispetto dei patti dei contraenti
disarmati, e quindi a porre in atto una situazione di monopolio della forza».
102
trattative, anche se condotte verbalmente a buon fine, alla stipulazione di un
trattato del disarmo, non è detto producano conseguenze pratiche. Altro è la
stipulazione di un patto, altro che la sua osservanza. I patti senza la spada,
ancora Hobbes, sono semplici flatus vocis.
Discorso non diverso deve essere fatto per l’altro principio fondamentale la
cui osservanza garantisce la conservazione della pace: “Le leggi debbono
essere ubbidite”. Anche questo principio è di per se stesso considerato un
principio morale, il cui fondamento deve essere cercato in qualche argomento
razionale come quello per cui nessun gruppo organizzato può sopravvivere
senza norme di carattere generale super partes (a differenza dei contratti che
sono inter partes) e senza che queste vengano per lo più osservate (se si tratta
di divieti) o eseguite (se si tratta di comandi). Ma anche questo principio
diventa giuridico soltanto là dove la disobbedienza alle leggi conduce potere
coattivo (cioè dall’uso della forza riconosciuto come legittimo). Ancora una
volta, se si vuole parlare correttamente della pace attraverso il diritto ci si deve
riferire non al principio in quanto tale ma al modo specifico con cui viene fatto
valere. Sorvolo sulla questione se tutti i contratti debbano essere osservati,
tutte le leggi debbano essere ubbidite. Siccome le fonti del diritto sono poste in
ordine gerarchico e i contratti in quanto norme individuali sono fonti inferiori
rispetto alle leggi in quanto norme generali, per i contratti la risposta è facile;
non sono vincolanti giuridicamente i contratti coi quali i contraenti
s’impegnano a compiere atti contrari alle leggi o in fronde alle leggi; per le
leggi la risposta è più difficile, perchè, anche là dove esiste il controllo
giurisdizionale della conformità delle leggi ordinarie rispetto a leggi
gerarchicamente superiori, come sono le leggi costituzionali, anche la legge
contraria alla costituzione deve essere ubbidita sino a che non ne viene
dichiarata l’illegittimità. Nei confronti delle leggi costituzionali al di sopra
delle quali non vi sono che leggi naturali, che sono norme dal punto di vista
della loro validità non giuridiche, l’obbligo che hanno le forze politiche di
osservarle non è strettamente giuridico ma morale o politico. Tanto è vero che
la costituzione materiale, quella che corrisponde alla prassi costituzionale, è
spesso molto diversa da quella formale. […]
103
Le considerazioni fatte sin qui ci permettono di definire con una
certa precisione quella corrente di pacifismo che prende il nome di pacifismo
giuridico. Le varie correnti di pacifismo si distinguono in base
all’interpretazione della causa determinante delle guerre e di conseguenza dei
rimedi necessari per attuare uno stato di pace. Di qua l’esistenza di vari
pacifismi: politico, sociale, economico, morale, religioso ecc. Il pacifismo
giuridico è quello che ritiene essere la guerra effetto di uno stato senza diritto,
di uno stato cioè in cui non esistono norme efficaci per la regolazione dei
conflitti. Siccome le varie correnti pacifistiche rivolgono la loro attenzione
soprattutto allo stato dei rapporti internazionali, rispetto ai quali la guerra è un
dato permanente, il pacifismo giuridico è quella forma di pacifismo che
concepisce il processo di formazione di una società internazionale in cui i
conflitti tra stati possano essere risolti senza il ricorso in ultima istanza alla
guerra, ad analogia del processo con sui si sarebbe formato, secondo l’ipotesi
contrattualistica, lo stato. E’ il processo consistente nel passaggio dallo stato di
natura, che è stato di guerra, alla società civile attraverso un comune accordo
degli individui interessati a uscire dallo stato di guerra permanente. La
maggiore o minore stabilità della società civile che nasce dalla eliminazione
dello stato di natura dipende dalla natura del patto di unione, se questo sia
soltanto un patto di associazione (pactum societatis) o anche un patto di
sottomissione (pactum subiectionis).
Secondo l’idea del diritto che qui ho sostenuto, per giungere a uno stato
di pace permanente non basta il primo genere di patto, occorre anche il
secondo. Un’unione fondata esclusivamente su un patto di associazione è alla
mercè della volontà di appartenervi dei singoli membri: in essa la regola pacta
sunt servanda ha lo status di principio unicamente morale, e pertanto può aver
efficacia soltanto in una società di esseri pienamente morali, di esseri cioè la
cui condotta non s’ispiri alla massima della morale politica: “Il fine giustifica i
mezzi”.
Riprendendo una nota distinzione di Kant, si può affermare che, volendo
chiamare stato giuridico anche lo stato nascente da un patto di associazione
per distinguerlo dallo stato di natura in cui l’individuo agisce per conto suo,
104
bisognerebbe avere l’avvertenza di definirlo stato di diritto provvisorio per
distinguerlo dallo stato di diritto perentorio che nasce soltanto quando i
membri del gruppo mettono in comune oltre l’uso di parte dei loro beni anche
l’uso della forza. Nel linguaggio tecnico dei giuristi il passaggio dallo stato di
diritto provvisorio a quello di diritto perentorio corrisponde al passaggio da
una confederazione di stati a uno stato federale. Sia però ben chiaro che uno
stato di diritto provvisorio, o comunque lo si voglia chiamare, non rappresenta
che una prima fase, ancora imperfettissima, nel percorso del processo della
pace attraverso il diritto. Le grandi unioni internazionali, come la Società delle
Nazioni dopo la prima guerra mondiale e l’Organizzazione delle Nazioni
Unite dopo la seconda, stanno a dimostrare quanto poco un semplice patto di
associazione sia in grado di garantire la “pace perpetua”. Se a circa
quarant’anni dalla fondazione dell’ONU non è scoppiata una terza guerra
mondiale (ne erano bastati venti per la seconda, nonostante la Società delle
Nazioni), non dipende certo dall’esistenza delle Nazioni Unite ma da un tacito
accordo fra le due superpotenze a non usare l’una contro l’altra le armi
nucleari che non potrebbero non essere impiegate in una guerra mondiale. La
fase finale del cammino della pace attraverso il diritto è lo stato di diritto
perentorio, ovvero quello stato in cui si è venuto costituendo un ordinamento
normativo in cui esiste, secondo coattivo capace di rendere efficaci le norme
dell’ordinamento.
Si può avere una riprova storica di questo processo se si prendono in
considerazione i tre principali progetti di pace attraverso il diritto sostenuti da
quando le guerre dell’equilibrio europeo prima e quelle napoleoniche poi,
sollevarono il problema della eliminazione della guerra come mezzo per
risolvere le controversie tra stati: il Projet pour rendre la paix perpetuelle
dell’Abbè de Saint-Pierre (1713), Zum ewigen Frieden di Kant (1795) e
Réorganisation de la Société européenne di Santi-Simon e Thierry (1814). Se
una linea di sviluppo si può designare in questi tre progetti, questa corre nella
direzione di un sempre maggiore rafforzamento del patto di unione, dal patto
di associazione al patto di sottomissione, dalla confederazione alla
federazione. L’abbè di Saint-Pierre si arresta all’alleanza perpetua fra gli stati,
105
tra i quali dovrebbe instaurarsi una condizione di “paix perpetuelle”, dove
l’elemento innovatore è la “perpetuità” che di fatto trasforma l’alleanza,
vincolo per sua natura labile e temporaneo, in una forma associativa diversa
come la confederazione. Il progetto kantiano è già esplicitamente confederale,
in quanto comprende un articolo fondamentale come il seguente: “Il diritto
internazionale deve fondarsi su una federazione di liberi stati”5, la quale
peraltro, come lo stesso Kant ha cura di avvertire, in quanto lega della pace
(foedus pacificum) deve essere tenuto ben distinta dal patto di pace (pactum
pacis), perchè quest’ultimo ha di mira di porre termine a una guerra
determinata, quello invece a tutte le guerre e per sempre. Santi-Simon e
Thierry, infine, ritengono insufficiente il semplice patto di associazione che
darebbe vita ad una mera confederazione, e presentano il progetto di un vero e
proprio stato federale, se pur all’inizio limitatamente all’unione della Francia
con l’Inghilterra, cioè di un vero e proprio stato nuovo che sorga al disopra dei
vecchi stati destinati a scomparire, in conformità del resto, al modello
costituzionale da cui erano nati gli Stati Uniti d’America con la costituzione
del 1787.
Da allora i progetti di unione federale di gruppi di stati e addirittura di
tutti gli stati del mondo si sono moltiplicati. Ed è perfettamente inutile
elencarli, una volta individuato il movimento progressivo verso il
rafforzamento dei vincoli federali, che è la caratteristica essenziale del
pacifismo giuridico (il cui fine ultimo è lo stato universale). Se questa meta sia
raggiungibile o meno nessuno è in grado di dire. Allo stato attuale della
coscienza civile e morale dell’umanità tutti i progetti di pace perpetua sono
egualmente utopistici, sia quello marxista (non il super-stato ma la fine dello
stato), sia quello illuminista (il trionfo della ragione), sia quello cristiano (se
tutti gli uomini seguissero i precetti del Vangelo...). A ogni modo, ciò che ci si
potrebbe aspettare dal pacifismo giuridico è la fine della guerra intesa come
uso sregolato della forza (“senza misura” per riprendere le riflessioni di Cotta
nel suo limpido scritto Perchè la violenza?)6, non la fine dell’uso della forza.
5
6
I. Kant, Per la pace perpetua, Editori Riuniti, Roma 1986, p. 13.
S. Cotta, Perchè la violenza?, Japadre, L’Aquila 1978, pp. 71 ss.
106
Il diritto, non può prescindere dall’uso della forza, e si fonda sempre in ultima
istanza sul diritto del più forte, il quale soltanto qualche volta coincide, ma
non necessariamente, col diritto del più giusto»116.
COMMENTO
Bobbio «consider[a] quattro tipi di rapporto tra guerra e diritto: la guerra come
mezzo per stabilire il diritto, la guerra come oggetto di regolamentazione
giuridica, la guerra come fonte di diritto, la guerra come antitesi del diritto.
Nonostante l’apparente disparità di queste quattro posizioni della guerra
rispetto al diritto, esiste un nesso tra l’una e l’altra […].
[… Bobbio precisa] che le prime due posizioni corrispondono al modo
tradizionale di considerare la guerra dal punto di vista del diritto
internazionale; le ultime due rappresentano per così dire il contraccolpo della
crisi delle dottrine tradizionali.
La teoria giuridica della guerra si è sempre occupata fondamentalmente di due
problemi: quello della iusta causa delle guerre che ha dato origine alle dispute
intorno alla guerra giusta, e quello della regolamentazione della condotta di
guerra, che ha dato origine al ius belli.
Bellum iustum e ius belli sono le due parti fondamentali in cui si divide la
trattazione giuridica della guerra: orbene la teoria del bellum iustum riguarda il
problema della giustificazione o ingiustificazione della guerra, quali siano i
motivi che rendono una guerra giusta, in altre parole quale sia il titolo in base
al quale una guerra può essere considerata giusta; il ius belli è la rivelazione e
lo studio delle regole che disciplinano la condotta di una guerra e che rendono
116
N. Bobbio, Il terzo assente. Saggi e discorsi sulla pace e la guerra, a cura di P. Polito, Torino, 1988, pp. 126-135.
107
possibile la distinzione tra ciò che è lecito e ciò che è illecito nei rapporti tra
belliggeranti.
L’oggetto della teoria del bellum iustum è il problema della legittimità della
guerra; l’oggetto del ius belli è il problema della legalità della guerra.
Questa distinzione è rilevante perché una guerra può essere legittima, cioè
avere una giusta causa, senza essere legale, in quanto il belligerante che ha
intrapreso la guerra in base ad una giusta causa, viola sistematicamente le
regole del ius belli; e può essere legale senza essere legittima, nel caso in cui il
belligerante che ha intrapreso una guerra ingiustamente rispetta le regole del
ius belli.
Questa distinzione ci permette di classificare le guerre, dal punto di vista dei
rapporti tra guerra e diritto in quattro tipi: a) legittime e legali; b) legittime e
illegali; c) illegittime e legali; d) illegittime e illegali»117.
Ancora alcune considerazioni.
Negare validità etica, secondo quella che può essere definita una “valutazione
morale degli eventi bellici”, disconoscendone l’impianto “etico-teologico” per
l’imprecisata convinzione di “dar ragione a chi vince”, in luogo di “far vincere
chi ha ragione”, induce Bobbio a ritenere che “la guerra moderna venga a
porsi al di fuori di ogni criterio di legittimazione e di legalizzazione, al di là di
ogni principio di legittimità e legalità”.
Quale la soluzione ?
Bobbio prospetta il “pacifismo giuridico” o “pacifismo istituzionale”,
pervenendo ad un “super stato o stato mondiale” che come “autorità superiore
ai singoli stati sia in grado di decidere chi ha ragione e chi torto o d’imporre la
propria decisione con la forza”.
Alcuni interrogativi, quanto alla premessa teorica.
Quale osservatore può, con un giudizio di valore tanto vero o tanto falso,
esprimere con “certezza assoluta” – accogliendo la stessa espressione teorica
“legibus soluta”, proposta da Bobbio con riferimento alla guerra moderna –
117
N. Bobbio, Teoria generale della politica, a cura di M. Bovero, Torino, 1999, p. 520 s.)
108
che, con il ristabilimento dell’ordine giuridico, la guerra abbia dato “ragione a
chi vince”, in luogo di “far vincere chi ha ragione” 118 ?
Ancora. Se nessuna considerazione di diritto divino, naturale o positivo,
può rendere giusta una guerra, come può, diversamente, la scelta giuridica
dello stato mondiale giustificare la pace ?
La scelta giuridica, che esprime un valore giuridico relativo e storico, non
può dismettere valori giuridici di diritto divino, naturale o positivo, senza
dovere scegliere a sua volta.
Il prefigurato equilibrio mondiale non è una condizione statica, ma un
equilibrio di forze sociali ed economiche per cui “non scegliere significa già
aver scelto”.
COTTA*
la pace e la coscienza giuridica
118
D. Zolo, I signori della pace. Una critica del globalismo giuridico, cit., p. 71 sgg.
109
_______________________
* «Sergio Cotta, nato a Firenze nel 1920, […] in una prima fase della sua
attività scientifica si è dedicato allo studio storico della filosofia giuridicopolitica, per poi rivolgersi ai problemi dell’età tecnologica. La sua personale
riflessione sul diritto ha trovato espressione in [varie] opere [… tra le quali
ricordiamo:] Itinerari esistenziali del diritto (Napoli, 1972), Perché la
violenza ? (L’Aquila 1978), Perché il diritto ? (Brescia 1979), Giustificazione
e obbligatorietà delle norme (Milano 1981), e Il diritto nell’esistenza. Linee di
ontofenomenologia giuridica (Milano 1985)».
Dalla guerra alla pace
«L’itinerario per giungere ad identificare il significato esistenziale della pace,
e quindi a giustificarne il valore, si è verificato assai più problematico di
quanto non appaia quando ci si arresta alla (ambigua) immediatezza emotiva
dei sentimenti o alla (presunta) evidenza del calcolo utilitario, ritenuti probanti
in modo indiscutibile. Ma lo spirito critico non può e non deve accontentarsi
d’una siffatta conclusione. Infatti, sia l’analisi spregiudicata di sentimenti,
ideali e teorie, sia un puntuale discernimento della realtà, sono in grado di
mettere in rilievo, come ho cercato di fare, che la pace costituisce tuttora un
problema non solo pratico ma anche teorico, che solo la semplificazione
permette di considerare risolto. E’ pertanto opportuno ripercorrere con uno
sguardo d’insieme il cammino percorso tanto nella prima parte quanto in
questo inizio della seconda.
Sul piano delle teorie ed anche delle ideologie, la dimostrazione del
valore della pace, tanto per la via negativa – assenza della guerra e
conseguente rimozione della paura (o terrore) da essa provocata – quanto per
la via positiva – utilità e benessere – si è rivelata insufficiente. Entrambe le vie
portano, infatti, a risultati parziali e talora, per giunta, implicanti
contraddizioni al proprio interno; perciò risultano in definitiva inconcludenti.
110
La ragione di tale inconcludenza va ravvisata nell’incapacità di eliminare per
quelle vie la causa profonda della guerra e della conseguente paura reciproca:
la differenza, e quindi la possibile inimicizia-ostilità, tra gli individui e tra gli
aggregati sociali. La paura della guerra non toglie l’inimicizia per quel
potenziale antagonista che è l’estraneo; così pure non la tolgono utilità e
benessere nei confronti del concorrente o rivale.
Sul piano pratico-operativo, i mezzi ritenuti adeguati per la realizzazione
della pace in conformità alle varie teorie – monopolio statale della forza,
disarmo, sviluppo – si sono rivelati bensì utili e forse anche necessari in parte,
ma non sufficienti. Ho già rilevato l’insufficienza dello sviluppo, per
l’ambivalenza pacifico-bellicosa di una grande quantità dei suoi artefatti
tecnici e l’irraggiungibilità dell’unico disarmo che potrebbe risultare efficace:
quello totale. Resta da fare un cenno sommario al monopolio statale della
forza, su cui si imperniava il modello hobbesiano di costruzione artificiale
della pace, cui ancor oggi autorevoli giuristi (per esempio Kelsen) continuano,
con monotona fedeltà a quel modello, ma scarso senso della realtà, a far
ricorso per determinare le proprietà essenziali dell’ordinamento giuridico.
Il monopolio statale della forza (ossia del potere costrittivo) poteva aver
senso ed efficacia quando si esercitava (e ancora si esercita) sui singoli
individui o su piccoli gruppi, poco o male armati. Ma già nel passato si è
scontrato, e non sempre con successo, con la guerra civile: il Behemoth, di cui
Hobbes stesso aveva avuto decisiva esperienza per orientarsi al suo opposto, il
Leviathan statale. Oggi, comunque, è una nozione del tutto obsoleta, poichè
codesto teorico monopolio non è in grado di contrastare con efficacia la forza
della guerriglia e del terrorismo, soprattutto se internazionalizzati, e tanto
meno di eliminarne la possibilità. La forza Stato non è neanche in grado di
imporsi alle grandi organizzazioni criminose, talvolta più sovranazionali che
internazionali, come è quella della droga per la sua complessa articolazione
che congiunge produzione, traffico, spaccio della droga nonchè persuasione al
suo uso.
Pertanto, sul piano teorico, le perentorie (ma inquietanti) domande
critiche del pensiero dialettico continuano a farsi valere nei confronti non solo
111
delle teorie che lo hanno preceduto, ma anche dell’odierna credenza
nell’indiscutibile valore della pace e del benessere. Quale pace e quale
benessere? Forse quelli d’una umanità ridotta alla deprecabile condizione
denunciata di volta in volta, o quale pasciuto sono del gregge pecorile di Kant,
o quale mare stagnante da Hegel, o quale rassegnazione d’un proletariato
disunito da Marx, o quale sottomissione pru sempre invidiosa degli schiavi da
Nietzsche? Se questa fosse la realtà (e il senso) della pace, allora sarebbe
difficile dar del tutto torto a codesti autori che le oppongono l’energica
coscienza attiva del proprio valore etico-culturale che anima individui, popoli
o classi e genera ostilità e guerra, ma al tempo stesso, si afferma, sempre
progresso e incivilimento (purchè la guerra si mantenga al di sotto del conflitto
nucleare...), ossia un benessere sempre crescente nel tempo.
Inoltre, sul piano pratico-operativo, non perdono ogni credibilità le
critiche mosse dai realisti seguaci della Realpolitik ai mezzi individuati per
assicurare la pace. Appaiono più efficaci a tal fine la discussione armata e
persino il deprecabile equilibrio del terrore, anzichè un disarmo incontrollato
ed in definitiva impossibile. D’altro canto i realisti non disprezzano affatto lo
sviluppo, anzi lo sollecitano, ma sono consapevoli che per la sua ambivalenza
esso permette di unire la minaccia dissuasiva delle sue armi potenziali al
pacificante effetto del benessere.
Ma codeste critiche, teoriche e pratiche, sono a loro volta criticabili. La
differenza non implica necessariamente inimicizia, antagonismo e conflitto,
poichè accanto alla tendenza aggressivo-agonistica va riconosciuta la presenza
nell’uomo della tendenza aggregativa, testimoniata dal linguaggio e dal
costituirsi della famiglia e degli stessi gruppi sociali. In questa linea di
tendenza il conflitto cessa di essere inevitabile e cede il passo al comprendersi
reciproco, che di per sè non ha limiti spaziali e culturali insuperabili. E la
tensione a comprendersi di là dalle differenze non permette più di identificare
la pace la stagnazione, la passività e l’impotenza, nè di considerare il
benessere quale fonte esclusiva di rivalità agonistica, bensì anche di
collaborazione pacifica. Quanto ai mezzi, quelli preferiti dai realisti possono
anche rivelarsi opportuni o più utili, ma solo in modo temporaneo, mentre la
112
tensione a comprendersi approfondisce il proprio compito e lo estende fino
all’orizzonte dell’intera umanità.
Questo gioco di critiche e controcritiche fa emergere l’insufficienza tanto
delle tragiche teorie celebranti la guerra quanto delle rassicuranti teorie
favorevoli alla pace. Questa insufficienza è dovuta, a mio avviso,
all’unilateralità dei loro rispettivi campi di esplorazione della condizione
umana e quindi ad una insoddisfacente considerazione del rapportarsi della
pace alla coscienza dell’uomo.
In questa direzione coscienziale della comprensione della pace sono di
rilevante importanza tanto l’individuazione del senso esistenziale della guerra
nella trasgressione, a partire dalla trasgressione primaria del divieto di
uccidere (c. 4), quanto l’esigenza dell’equità nella diffusione e spartizione dei
beni e, più in generale, della concreta determinazione del benessere per tutti
(c. 5). Le espressioni “trasgressione” ed “equità” riflettono infatti un modo di
sentire che ha le proprie radici nella coscienza umana, anzi, per meglio dire,
nella coscienza dell’individuo. Persino il bandito non tollera le trasgressioni
del proprio compagno alle regole della loro società ed esige equità nella
spartizione del bottino. Ciò significa che l’individuo, consapevole della
particolarità della personalità propria e altrui, avverte l’esigenza della
composizione delle rispettive differenze, secondo una misura oggettiva che le
rispetti, ma in un rapporto ordinato di convivenza intersoggettiva. L’individuo
esige dunque un rapporto regolare ed equo (regolare perchè equo) e perciò
pacifico.
Lascio qui da parte ogni approfondita distinzione semantica, oppure
tecnico-giuridica, tra regola comportamentale in generale e norma giuridica in
senso stresso, tra equità del giudice nel caso eccezionale ed equità del
legislatore nello stabilire le norme comuni. Regola ed equità, prese nel loro
senso generale, rinviano alla misura giuridica, sia intersoggettiva che sociale,
quale precisa esigenza della coscienza umana al fine di segnare i confini tra il
bene ed il male. Conviene pertanto esplorare il rapporto tra il diritto e la pace
per vedere se sia possibile trovare nella coscienza giuridica un fondamento
113
positivo della pace, capace di superare le parzialità unilaterali e le ambivalenze
delle concezioni criticate»119.
COMMENTO
In alcune sue riflessioni sul rapporto tra “pace e diritto”, nella prospettiva del
“pacifismo giuridico”, Bobbio, nel “riprendere le riflessioni di Cotta”, quanto
al volume Perché la violenza ? (1978), ammette la possibilità di dire fine alla
«guerra intesa come uso sregolato della forza “senza misura” […], non la fine
dell’uso della forza».
Come precisa Bobbio, il «diritto non può prescindere dall’uso della forza, e si
fonda sempre in ultima istanza sul diritto del più forte, il quale soltanto
qualche volta coincide, ma non necessariamente, col diritto del più giusto»120.
La domanda è immediata: è possibile scongiurare questa evidenza?
Cotta precisa - nel suo volume Dalla guerra alla pace (1989) - che «sul piano
pratico-applicativo, i mezzi ritenuti adeguati per la realizzazione della pace in
conformità alle varie teorie - monopolio statale della forza, disarmo, sviluppo si [… rivelano] bensì utili e forse anche necessari in parte, ma non sufficienti.
[…] Resta da fare - secondo Cotta - un cenno sommario al monopolio statale
della forza, su cui si imperniava il modello hobbesiano di costruzione
artificiale della pace, cui ancor oggi autorevoli giuristi (per esempio Kelsen)
119
120
S. Cotta, Dalla guerra alla pace. Un itinerario filosofico, Milano, Rusconi, 1989, pp. 136-141.
N. Bobbio, Teoria generale della politica, cit., p. 535.
114
continuano, con monotona fedeltà a quel modello, ma scarso senso della realtà
a far ricorso per determinare le proprietà essenziali dell’ordinamento giuridico.
Il monopolio statale della forza (ossia del potere costrittivo) poteva aver senso
ed efficacia quando si esercitava (e ancora si esercita) sui singoli individui o
su piccoli gruppi, poco o male armati. […] Oggi, comunque, è una nozione del
tutto obsoleta, poiché codesto teorico monopolio non è in grado di contrastare
con efficacia la forza della guerriglia e del terrorismo, soprattutto se
internazionalizzati, e tanto meno di eliminarne la possibilità. La forza dello
Stato non è neanche in grado di imporsi alle grandi organizzazioni criminose,
talvolta più sovranazionali che internazionali».
Quale la soluzione ?
Cotta non intende «mettere in dubbio il valore della pace, bensì quello di
ricercarne un fondamento che lo sottraesse tanto alla sua negazione […],
quanto alle scelte puramente soggettive o ideologiche […].. Un siffatto
fondamento può venir trovato […] - secondo Cotta - mediante il rigoroso
processo di autocoscienza dell’io, che lo porta a riconoscere la verità della
relazionalità ontologica dell’uomo. La raggiunta chiarezza di tale verità è il
presupposto e il supporto assolutamente necessarii per qualsiasi progetto di
pace. […]
E’ quella pace, propria della struttura dell’esser-uomo, che ispira e sorregge
nel profondo tutte le paci empiriche, particolari e contingenti, nelle quali gli
uomini di buona volontà manifestano, nell’impegno e nello sforzo di vincer se
stessi, la consapevolezza, sia pure imperfetta, del proprio dovere di essere
uomini»121.
Come precisa Savarese, «Cotta, profondo conoscitore di S. Agostino, è ben
consapevole che la pace è un frutto difficile da ottenere e da mantenere, ma se
che la pace non può essere ridotta ad un valore sovrimpresso ad una
convivenza di per sé conflittuale. Cotta è lucido nel sostenere la necessità, e la
possibilità chele ragioni della pace risiedano nella struttura profonda
dell’esistenza, di quella esistenza che è, appunto, coesistenza. Nel solco così
tracciato gli appelli alla pace dal punto i vista dei valori si dimostrano ambigui
121
S. Cotta, Dalla guerra alla pace. Un itinerario filosofico, Milano, 1989, p. 137 s., 183 s.
115
prima che inconcludenti, poiché riposano su una visione fondamentalmente
conflittuale della convivenza umana»122.
122
P. Savarese, Sergio Cotta: la pace al fondo del coesistere, in Rivista internazionale di Filosofia del diritto, 2003, 2,
p. 288.
116