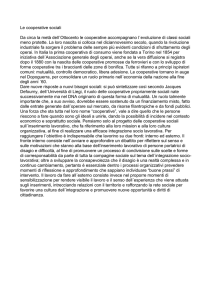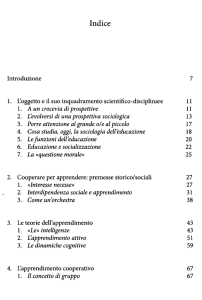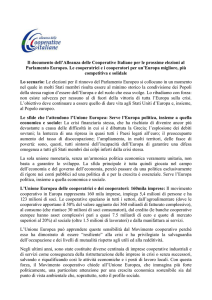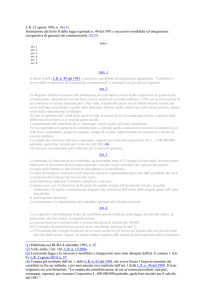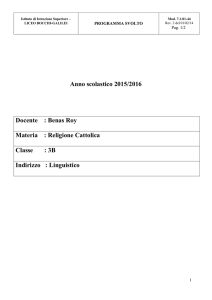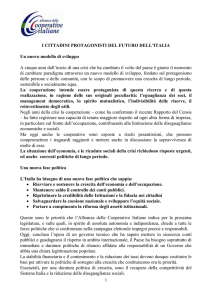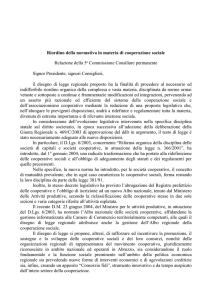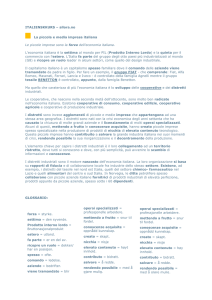Impresa sociale: una breve geografia
del contesto italiano
Vando Borghi
in J.L. Laville, M. La Rosa, a cura di (2010), Impresa sociale e capitalismo contemporaneo, Sapere 2000, Roma,
pp. 163-174
Impresa sociale: una breve geografia del contesto italiano
Vando Borghi
I confini di un fenomeno, nello scenario nazionale
Misure dell’economia sociale
Per ragionare di cosa sia l’impresa sociale e di come si configurino alcune delle sue principali
problematiche è utile premettere un po’ di dati che possano aiutarci a dare un profilo concreto cui
ancorare alcuni elementi di discussione. Vorrei subito chiarire, però, che il problema principale di
una riflessione sociologica su questo fenomeno – che cosa sia davvero impresa sociale e cosa
invece ne abbia soltanto, eventualmente, le forme o l’apparenza – non può essere risolto sul piano
dei dati e della contabilità. E’ per questo che, delineato sinteticamente il perimetro della figura (nel
contesto italiano) che abbiamo posto ad oggetto di questo volume, occorrerà poi indicare alcuni
terreni su cui la riflessione e l’indagine devono esercitarsi per evitare analisi che si fermino soltanto
alla superficie del fenomeno in questione.
La cornice in cui si inscrive, dal punto di vista della classificazione statistica, il fenomeno
dell’impresa sociale, vale a dire l’ambito dell’economia sociale, risulta da sempre complesso da
monitorare, con cifre e misure non sempre concordi a seconda delle diverse fonti da cui derivano.
Proviamo comunque a richiamare alcuni elementi principali. In primo luogo, va ricordato che,
stando ai dati del censimento ufficiale riportati nel “Primo Rapporto Cnel/Istat sull’economia
sociale” (Cnel/Istat, 2008), agli inizi del 20001 esistevano in Italia 221.412 organizzazioni senza
scopo di lucro (comprendendo in questa classificazione Fondazioni, Associazioni, Cooperative), il
51% delle quali localizzate nell’Italia settentrionale e in cui erano impiegate più di 4 milioni di
persone, delle quali 3 milioni e 200 mila a titolo volontario2 e 532 mila dipendenti. Da un punto di
vista economico, non è secondario rilevare che, mentre la gran parte (75%) delle organizzazioni non
profit si assesta su un ammontare annuo di entrate inferiore ai 50mila euro, una piccola minoranza
1
Anche se questi dati (così come quelli riportati nella Tab. successiva) sono tratti da pubblicazioni recenti (Alschelter,
Bruzzese, Perna 2005; Cnel/Istat, 2008), rimandano comunque – almeno per i dati generali – al Censimento delle
istituzioni nonprofit del 1999.
2
In effetti, l’80.2% utilizzava personale volontario e per il 70.1% questa figura rappresentava l’unica risorsa umana
utilizzata.
di esse (1.1%, cioè 373 organizzazioni) impiega il 42% del totale dei dipendenti (220 mila). Per tali
ragioni è difficile non concordare con chi afferma che la cosiddetta economia sociale in Italia sia
caratterizzata da “una grande concentrazione di risorse economiche in poche strutture” (Alschelter,
Bruzzese, Perna, 2005: 21). Che tipo di effetti abbia tutto ciò nella qualificazione del rapporto tra
problematiche sociali e dinamiche economiche – il nodo su cui lavora appunto l’impresa sociale –
costituisce di per se un terreno assai significativo di ricerca.
Tab. 1 – Organizzazioni nonprofit per forma giuridica, aree territoriali e principali settori di
intervento
FORMA GIURIDICA
Associazione
riconosciuta
Nord
Centro
Mezzogiorno
Italia
28.580
13.149
19.580
61.309
Cultura, sport e
ricreazione
Assistenza
sociale
Relazioni
sindacali e
rappresentanza
di interessi
Istruzione e
ricerca
37.245
Fondazione
Associazione Comitato
non
riconosciuta
AREE TERRITORIALI
1.737
74.292
2.196
699
29.648
941
572
36.812
695
3.008
140.752
3.832
PRINCIPALI SETTORI
865
97.725
2.334
Cooperativa
sociale
Altra
forma
Totale
2.286
792
1.573
4.651
7.861
1.736
2.044
7.861
113.172
46.965
61.275
221.412
476
1.747
140.391
6.575
773
8.073
322
2.397
1.204
19.344
3.608
0
11.863
75
0
105
15.651
2.631
714
5.676
202
135
2.294
11.652
Fonte: Cnel/Istat, 2008: 19 (parziale da Tab. 4.1)
La Tab. 1 ci fornisce una prima idea generale della mappatura (un po’ datata, per le ragioni sopra
accennate) della tipologia di organizzazioni nonprofit, della loro distribuzione territoriale e dei
principali settori di intervento Tra le diverse cose che si potrebbero sottolineare circa i dati sopra
richiamati – relativamente alla netta prevalenza delle organizzazioni che si dedicano ad attività
concernenti il legame sociale (nelle sue problematiche più o meno drammatiche, dal tempo libero e
la cultura all’assistenza sociale in senso stretto), nonché alla preminente collocazione di tali
organizzazioni nell’area settentrionale del paese (51,1%) – vale la pena rimarcare il dato
concernente il principale oggetto delle considerazioni seguenti. Infatti, se come ho già detto, risulta
difficile identificare a priori la natura di una effettiva impresa sociale, possiamo comunque provare
a lavorare per approssimazione, riferendo pertanto i nostri ragionamenti al dato che descrive,
nell’universo rappresentato nella Tab. 1, le cooperative sociali, che ammontano al 2,1% del totale
delle organizzazioni.
I territori della cooperazione sociale: una introduzione
La cooperazione sociale, almeno per come viene rilevata dall’Istat, fa riferimento ad una normativa
risalente al 1991 (Legge n. 381). Avente lo scopo, da statuto, di perseguire l‘integrazione sociale dei
cittadini e, ancora più in generale, la promozione umana in quanto interesse generale alla comunità,
la cooperazione sociale è articolata secondo la seguente tipologia:
-
coop. di tipo A: organizzazioni che svolgono attività finalizzate all’erogazione di servizi
socio-economici ed educativi;
-
coop. di tipo B: organizzazioni che lavorano all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate;
-
coop. di tipo misto (A + B): organizzazioni che svolgono entrambe le tipologie di attività
sopra richiamate;
-
consorzi sociali: organizzazioni cooperative con base sociale costituito almeno per il
settanta per cento di cooperative sociali.
Alla fine del 2005, l’universo delle cooperazione sociale risulta circoscrivibile attraverso alcuni dati
generali (Cnel/Istat, 2008):
a. le cooperative sociali attive sono 7.363 (la maggior parte delle quali, il 71.7%,
costituitasi dopo il 1991): 12,1 cooperative ogni 100mila abitanti;
b. il maggior numero di cooperative sociali ha sede in Lombardia (1.191 unità, pari al
16,2% del totale nazionale); seguono il Lazio (719), la Sicilia (589), l’EmiliaRomagna (584), il Veneto (564) e la Puglia (545)
c. l’insieme delle cooperative sociali è costituito per la maggior parte da cooperative di
tipo A (4.345 unità, pari al 59%), mentre le cooperative di tipo B ammontano a
2.419 unità (32,8%)
d. i soci delle cooperative sociali sono 262.389, di cui 255.583 persone fisiche e 6.806
persone giuridiche; nelle cooperative di tipo A risultano relativamente più frequenti
le unità con un’unica categoria di soci (21,5%), mentre tra le cooperative di tipo B e
ad oggetto misto si registrano quote percentuali più favorevoli alla molteplicità di
categorie di soci (il 94,1% delle cooperative di tipo B ed il 91,7% di quelle ad
oggetto misto è composta da almeno due categorie di soci);
e. il personale delle cooperative sociali nel 2005 è pari a 278.849 unità, di cui 211.307
dipendenti, 31.629 lavoratori con contratto di collaborazione, 30.478 volontari,
3.415 volontari del servizio civile, 1.287 lavoratori interinali e 733 religiosi;
complessivamente i lavoratori retribuiti (dipendenti, lavoratori con contratto di
collaborazione e interinali) sono 244.223, mentre le risorse umane non retribuite
sono 34.626; rispetto al 2003, il personale operante nelle cooperative sociali è
aumentato complessivamente del 26,2% e la crescita maggiore ha riguardato i
lavoratori interinali (+159%);
f.
nel 2005, le cooperative sociali dichiarano, nel complesso, un valore della
produzione di 6.381 milioni di euro, con un importo medio per cooperativa di circa
867 mila euro; la quota maggiore del valore della produzione si concentra nelle
cooperative di tipo A, che raccolgono il 64,7% dei ricavi e costituiscono il 59% delle
cooperative. Seguono, le cooperative di tipo B (21,2%), i consorzi (10,7%) e le
cooperative ad oggetto misto (3,4%);
g. per quanto concerne le cooperative di tipo A, il settore in cui esse operano
maggiormente è rappresentato dall’assistenza sociale (59.1%), mentre la tipologia di
servizio maggiormente erogato è l’assistenza domiciliare (36.5%) e, infine, il
destinarlo prevalente dei servizi di tale tipologia sono i minori (28.8%);
h. nelle cooperative di tipo B, invece, il servizio di inserimento lavorativo riguarda in
primo luogo i disabili (46.3%).
In termini di distribuzione territoriale (Tab. 2), la maggiore concentrazione di strutture cooperative
risulta essere nelle regioni meridionali, prese nel loro insieme; nel confronto interregionale, tuttavia,
la situazione risulta più eterogenea, con una rappresentanza significativa, tra le prime cinque regioni
per presenza di strutture di cooperazione sociale, di regioni collocate nell’area settentrionale del
paese: Lombardia (1191), Lazio (719), Sicilia (589), Emilia Romagna (584), Veneto (564).
Tab. 2 - Cooperative sociali per tipologia e regione - Anno 2005 (valori percentuali, totale=100)
Fonte: Istat, 2007
Un ulteriore elemento di dettaglio utile alla comprensione dell’universo della cooperazione sociale
(Tab. 3) rimanda al tema della fonte di finanziamento di queste organizzazioni. La maggior parte di
esso deriva da fonte pubblica (65.9%) e soltanto nelle aree del Nord-est risulta esserci un maggior
equilibrio tra fonte pubblica (56.3%) e fonte privata (43.7%).
Tab. 3 - Cooperative sociali per fonte prevalente di finanziamento, tipologia e ripartizione
territoriale – Anno 2005 (valori percentuali, totale=100)
Fonte: Istat, 2007
Altro tema rilevante è quello concernente la presenza di persone svantaggiate nelle cooperative. Per
cominciare a vedere il peso di questa presenza, può essere utile osservare due indicatori, vale a dire
il numero medio di persone svantaggiate per cooperativa (12) e il numero di svantaggiati ogni 10
unità di personale retribuito (6). Se prendiamo il primo dei due indicatori (numero medio persone
svantaggiate per cooperativa), emergono evidenti differenze territoriali: il Nord-est (14) e il Nordovest (17) mostrano una presenza di persone svantaggiate superiore alla media nazionale, mentre
nel Mezzogiorno la presenza di persone svantaggiate risulta inferiore alla media nazionale (8). Il
Centro presenta invece un dato in linea con quello nazionale. Infine, rispetto al secondo indicatore
(numero svantaggiati ogni 10 unità di personale retribuito), il rapporto che emerge nelle diverse
aree regionali si mantiene intorno a quello nazionale.
Tab. 4- Indicatori delle cooperative di tipo B per ripartizione territoriale - Anni 2003 e 2005
Fonte: Istat, 2007
Relativamente alla tipologia delle persone svantaggiate nelle cooperative di tipo B, emerge una
prevalenza della figura del disabile su tutto il territorio nazionale; nella maggior parte delle aree
regionali, tale figura è poi seguita da quella dei tossicodipendenti, con l’eccezione dell’area Nordest, che vede la figura del disabile seguita immediatamente da quella del paziente psichiatrico
Tab. 5 - Persone svantaggiate delle cooperative di tipo B per tipologia e ripartizione
territoriale - Anno 2005
Fonte: Istat, 2007
Un approfondimento, inoltre, di questi dati attinenti la presenza di persone svantaggiate all’interno
delle organizzazioni cooperative in questione (Tab. 6) ne mette bene in evidenza i limiti da un punto
di vista più qualitativo. Si tratta infatti di una presenza che si concentra sostanzialmente nei ruoli
operativi, mentre fatica ad incidere sul processo decisionale e di definizione strategica attraverso
l’accesso a posizioni dirigenziali.
Tab. 6 - Ruolo dei soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Dirigenti
Tecnici/Impiegati
Sv antaggiati
Capisquadra
Ope rai
Normodotati
Fonte: Mattioni - Ires-Fvg, 2003
I dati fin qui richiamati e commentati mostrano dunque un universo vasto, eterogeneo e con opacità
e contraddizioni. Da un lato, pare si tratti di un universo in espansione, in termini quantitativi;
dall’altro, questo dato apparentemente positivo presenta, visto da vicino, più di un lato oscuro (la
forte dipendenza dal finanziamento pubblico, la concentrazione delle risorse su alcune poche grandi
organizzazioni, etc.). Da una parte, questa crescente affermazione come interlocutore rilevante dei
decisori ha prodotto trasformazioni interessanti nell’ambito delle politiche e della legislazione
sociale; dall’altro proprio questo successo costituisce il terreno di snaturamento e di
strumentalizzazione di questo soggetto e delle istanze che veicola. In altre parole: “mentre infatti, le
organizzazioni che compongono il Terzo Settore (…) ne enfatizzavano il ruolo di creatore di
occupazione e di risolutore delle contraddizioni del tardo capitalismo al fine di ottenere
riconoscimenti e attenzioni pubbliche (in termini di leggi, defiscalizzazione, peso politico), gli stessi
argomenti venivano usati come cavallo di Troia per l’ingresso delle logiche neoliberiste nei modelli
europei di welfare (attaccati dalla nuova dea privatizzazione). Il risultato è che, accanto a misure
interessanti ottenute negli ultimi dieci anni (legge sul volontariato, sulla cooperazione sociale, sulle
associazioni di promozione sociale, la legge per la riforma dell’assistenza), si è osservata una
crescita impressionante del terzo settore che si occupa soprattutto di welfare e che stenta a
mantenere un ruolo propositivo e riformatore, ma anzi spesso cade nella dipendenza quasi totale dal
settore pubblico, unico rappresentante della domanda per queste ‘imprese’” (Alschelter, Bruzzese,
Perna, 2005: 23). Quello che è possibile dire, sulla base di questi ed altri dati di tipo quantitativo ci
riporta, quindi, esattamente alle considerazioni espresse all’inizio di questa breve ricognizione.
Come anche altri contributi al volume, per vie diverse (cfr. de Leonardis, infra), mi pare mostrino
con chiarezza, i dati introdotti ci descrivono lo sfondo sul quale l’impresa sociale, eventualmente, si
muove, ma i due piani non sono sovrapponibili e la messa a fuoco delle proprietà e degli orizzonti
problematici ed evolutivi di quest’ultima non sono sovrapponibili con quello stesso sfondo.
Le coordinate dell’impresa sociale
E’ sul terreno del rapporto con la società nel suo insieme, con il processo di alimentazione del
tessuto connettivo della società in cui la società civile stessa affonda le proprie radici - laddove essa
si configura, effettivamente, secondo modalità opposte al dilagante “particolarismo generalizzato”
(Innerarity, 2008: 52 e ss.) con il quale essa viene invece spesso confusa – che è possibile misurare
la messa all’opera (o meno) dell’impresa sociale. Ciò che conta, qui, non sono tanto le misure
strutturali (di qui l’opacità, l’ambiguità dei numeri e delle classificazioni solitamente adottate per
indagare i fenomeni in questione); piuttosto sono i processi, le proprietà emergenti entro sistemi
d’azione e progetti che prevedono quasi sempre l’interazione tra attori diversi (profit e noprofit;
pubblici e privati). Conta il modo con cui si costruisce la realtà sulla quale poi si andrà ad agire (il
sensemaking) e, a questo proposito, le definizioni, le rappresentazioni di cui ci si serve per osservare
e indagare, svolgono un ruolo determinante nel rapporto circolare con la realtà sociale cui si
riferiscono, partecipando esse stesse della sua produzione ed essendone, contemporaneamente,
l’esito.
Possiamo sforzarci di identificare diverse versioni alternative di terzo settore e di impresa sociale
ma, come ho già detto, credo che il discrimine decisivo si ponga in rapporto al nesso tra impresa
sociale e società nel suo insieme. Da un lato possiamo facilmente rintracciare definizioni (direi
senz’altro maggioritarie) che tendono a enfatizzare la natura “privatistica” di quel tipo di
organizzazioni e di processi. “Le materie sociali implicate – bisogni e beni relativi alla salute,
all’educazione, alla sicurezza e alla qualità della vita, al reddito e al lavoro, ecceetera – vengono
ricondotte all’interno della sfera privata, e considerate come problemi e domande dei singoli e delle
loro famiglie cui corrispondono, sul versante dell’offerta, capacità di iniziativa economica e virtù
morali altrettanto personali, private. Così privatizzate, queste materie smettono di essere un terreno
di discorso pubblico su questioni collettive e condivise, che riguardano la qualità e la tenuta del
legame sociale e che dunque chiamano in causa corresponsabilità, azioni e scelte su beni e fini
comuni” (de Leonardis, 1999: 246-7). Dall’altro, troviamo versioni (minoritarie) che insistono sul
registro argomentativo della cittadinanza, che riconnettono sistematicamente il teatro dell’azione di
queste organizzazioni allo spazio pubblico ed al senso che esse acquistano in esso, che ne
sottolineano la radice politica (nell’accezione arendtiana del termine). Lo schema seguente (Tab.7)
può fornire una rappresentazione grafica dei principali modelli dell’argomentazione che si
confrontano su questi temi e delle loro principali caratteristiche, così come emerge da quanto fin qui
discusso
Tab. 7 – Matrici di agency delle organizzazioni nonprofit
eterogeneit à dei soggetti coinvolti; strategie
deliberative e partecipative; creazione di
borderlands
Impresa
Sociale
efficienza/ redditività
come obbiettivo
efficienza/ redditività
come vincolo
strategie organizzative e relazionali di tipo dualistico /
privatismo
Su un asse, quello orizzontale, si dispongono le diverse rappresentazioni del rapporto tra significato
sociale delle organizzazioni e dei processi di cui stiamo parlando e processi economici, laddove su
un estremo sono collocabili quelle concezioni e quelle pratiche che Perrow (2002: 40-41) definisce
la “forma negativa di organizzazioni nonprofit” e che tendono in sostanza a sovvertire il rapporto
tra aspetti economici e dimensioni sociali, facendo dei primi l’obbiettivo effettivo (in termini di
vantaggi fiscali, di percezione di alti salari e gratifiche o anche soltanto assumendo i criteri di
efficienza economica come l’effettivo criterio di gerarchizzazione e di selezione delle priorità e
delle scelte strategiche) invece di considerarli come uno strumento e/o un vincolo della governo
delle organizzazioni. Mentre sull’estremo opposto troviamo la tensione a considerare i vincoli
economici e di mercato un vincolo, un dato non ignorabile ma che non impedisce tuttavia di esigere
obbiettivi di alta qualità concernenti i beni ed i servizi trattati, le relazioni coinvolte e così via (de
Leonardis, Mauri, Rotelli, 1994).
Sull’altro asse, quello verticale, si collocano invece le diverse concezioni concernenti l’agency delle
organizzazioni: su un estremo quelle di stampo fortemente privatistico (de Leonardis, 1997), cioè
alimentate da una concezione del rapporto tra organizzazioni e cittadini come rapporto privato (di
tipo familiare e/o mercantile) e dualistico3 oppure, per usare la terminologia di Perrow (2002),
caratterizzate da comportamenti egoistici, orientate a fornire servizi soltanto ai propri membri;
sull’estremo opposto, quelle organizzazioni e quei progetti orientati all’allargamento della
cittadinanza e delle condizioni per il suo effettivo esercizio attraverso la messa all’opera di attori
diversi, attraverso strategie borderlands, vale a dire, per usare la definizione di Piore (1995),
l’istituzione di percorsi di “intrapresa sociale” basati non sulla negoziazione, lo scambio, il
compromesso, bensì sulla costruzione di ponti, di terreni di incontro e di confronto, di un
vocabolario comune finalizzato ad una reciproca trasformazione. Se assumiamo questa prospettiva
di lettura, allora la definizione di impresa sociale propriamente detta – al di là delle misure e delle
contabilità su base strettamente amministrativa – dovrebbe indicare soltanto quelle organizzazioni
che si sforzano di muoversi nel quadrante in alto a destra.
Proprio perché le nostre sono sempre più intensamente “società di organizzazioni” (Perrow, 1991),
è indispensabile riflettere a fondo sulla natura ed il significato sociale dei modelli organizzativi e
delle matrici cognitive cui attingono per cercare di interpretare l’orizzonte delle trasformazioni in
corso. Vale dunque la pena concludere questa breve introduzione al contesto italiano, oltre che
rimandando agli approfondimenti di tali aspetti presenti negli altri contributi a questo volume, con il
richiamo della esortazione all’analisi critica dell’eterogeneo universo del nonprofit che, per quanto
riflettendo su uno scenario diverso come quello statunitense, l’autorevole studioso delle
organizzazioni complesse Charles Perrow (2002: 34) ha espresso alcuni anni fa:
3
La relazione duale, tipica dell’ambito clinico e/o mercantile, “fa incontrare due individui isolati e astratti dalla
socialità, sottratti al reticolo delle altre relazioni che costituiscono il mondo di ciascuno, e separati in uno spazio
artificiale, segreto e privatizzato, disegnato dal setting specialistico. La relazione duale recide legami, sottrae socialità
ed esclude altre relazioni dal campo delle azioni e delle scelte pertinenti su problemi e beni sociali”. Nel modello duale
di interazione, i due soggetti vengono implicitamente definiti in modo fortemente asimmetrico: “le competenze di uno
dei due attori in gioco si configurano come appropriazione e segretezza (...) delle risorse materiali e cognitive su cui si
svolge la relazione” mentre “le domande di cui l’altro attore è portatore vi vengono riconosciute e trattate come deficit,
bisogni e patologie personali; nel migliore dei casi come preferenze soggettive” (de Leonardis, 1997: 186-7). Inoltre, a
proposito del tema che indicavo come il terreno fondamentale su cui misurare l’impresa sociale, de Leonardis (1998:
91-2) mette a fuoco le conseguenze complessive di una tale logica d’interazione: “Questa cornice strumentale induce
comunque una disattivazione della ‘voce’ della domanda, della sua partecipazione attiva alla questione. Con il rischio
che si crei il deserto attorno ad essa e con ciò si riduca drasticamente la dotazione di risorse che il contesto sociale della
domanda può mettere in gioco. Passività, dipendenza, cronicità, privatizzazione delle questioni, deprivazione materiale,
culturale e politica finiscono per costituire il risvolto sistemico del trattamento del destinatario degli aiuti come cliente,
in definitiva come consumatore individuale con i suoi bisogni e le sue preferenze private. Viene da domandarsi quale
società civile potrebbero costruire, se così orientate, queste forme di autorganizzazione”.
“Le società moderne sono sempre più costellate di grandi organizzazioni, dal momento che un sempre maggior numero
di attività che vogliamo e dobbiamo svolgere sono gestite da queste ultime. Le organizzazioni, e in particolar modo
quelle di grandi dimensioni, offrono sempre più servizi che un tempo erano forniti dalle famiglie, dai gruppi di amici,
dal vicinato e dalle comunità locali. Ciò significa che sempre minore è la capacità della società civile di sussistere in
assenza delle grandi organizzazioni. Una prova dell’assorbimento della società da parte delle grandi organizzazioni è
costituita dall’organizzazione nonprofit. In teoria, essa è di piccole dimensioni, sensibile e orientata verso i bisogni della
società. Se la società civile deve essere rappresentata da un’entità organizzata, sembrerebbe che questa debba essere
l’organizzazione nonprofit. Ora, il numero delle organizzazioni nonprofit sta aumentando. Mi domando se questo
aumento debba significare un aumento delle aspettative di una società civile vitale. Il mio timore è che le abbia invece
ridotte. Fondamentalmente, ciò che sostengo è che i settori nonprofit che crescono più rapidamente sono caratterizzati
da comportamenti egoistici, mentre i settori le cui attività sono orientate in senso altruistico sono in declino. Un
argomento distinto, ma collegato a questo, è che le grandi organizzazioni, sia quelle a scopo di lucro che quelle
nonprofit, stanno trasformando i servizi che erano un diritto del cittadino in attività accessorie al contratto di impiego”.
Riferimenti bibliografici
Aschelter A., Bruzzese E., Perna L. (2005), Dove va il Terzo Settore?Rapporto sull’Economia
Sociale in Italia, Ricerca nell’ambito dell’Azione Sperimentale del Consorzio “Noicon”,
finanziamento FSE e Regione Emilia Romagna.
Cnel, Istat (2008), Primo Rapporto Cnel/Istat sull’economia sociale, Roma
de Leonardis O. (1997) Declino della sfera pubblica e privatismo, in “Rassegna Italiana di
Sociologia”, n. 2, pp. 169-193.
de Leonardis O. (1998), In un diverso welfare, Feltrinelli, Milano.
de Leonardis O. (1999), Terzo settore: la doppia embeddedness dell’azione economica, in J.L.
Laville, E. Mingione, a cura di, La nuova sociologia economica. Prospettive europee,
numero monografico di “Sociologia del lavoro”, n. 73, pp. 230-250.
de Leonardis O., Mauri D., Rotelli F. (1994), L'impresa sociale, Anabasi, Milano.
Istat (2007), Le cooperative sociali italiane in Italia. Anno 2005, 12 ottobre.
Mattioni F., Ires FVG (2004), La cooperazione di tipo B in Italia tra maturità e radicamento e
proposte per il suo sviluppo, Presentazione del rapporto di ricerca, 30 giugno, Roma.
Perrow C. (2002), L’ascesi delle organizzazioni nonprofit e il declino della società civile negli Stati
Uniti, in “Rivista di politiche pubbliche”, n. 2.
Perrow C. (1991), A Society of Organizations, in “Theory and Society”, vol. 20, n. 6., pp. 725-762.