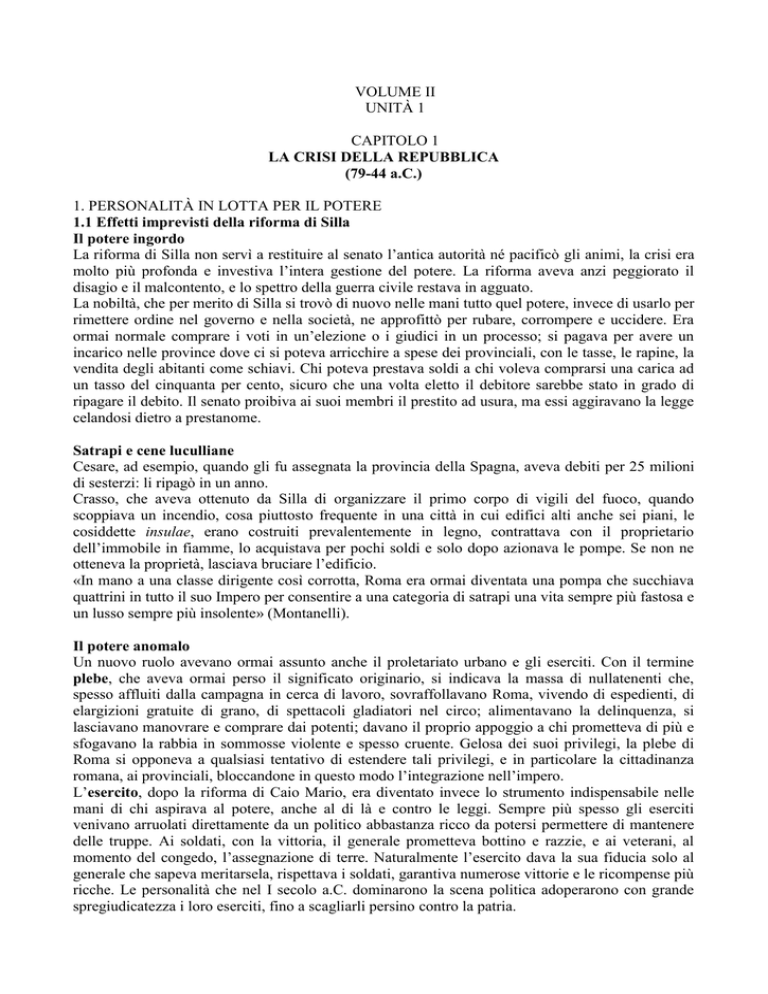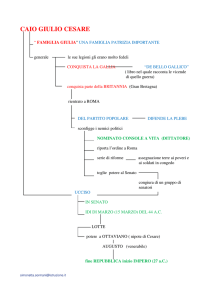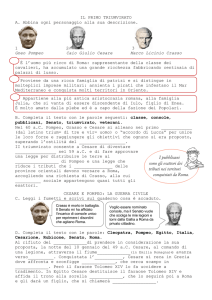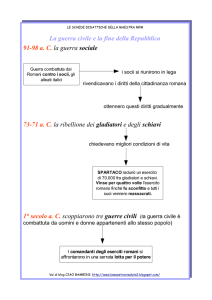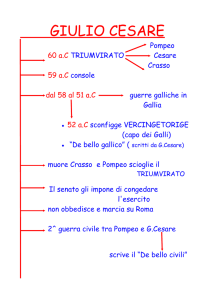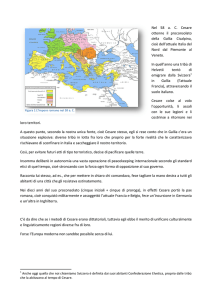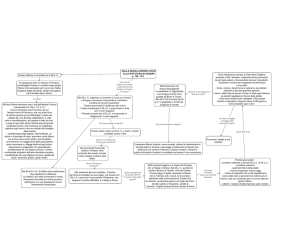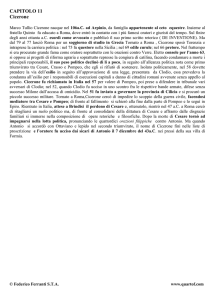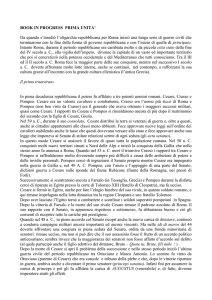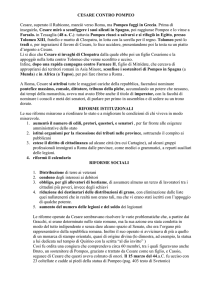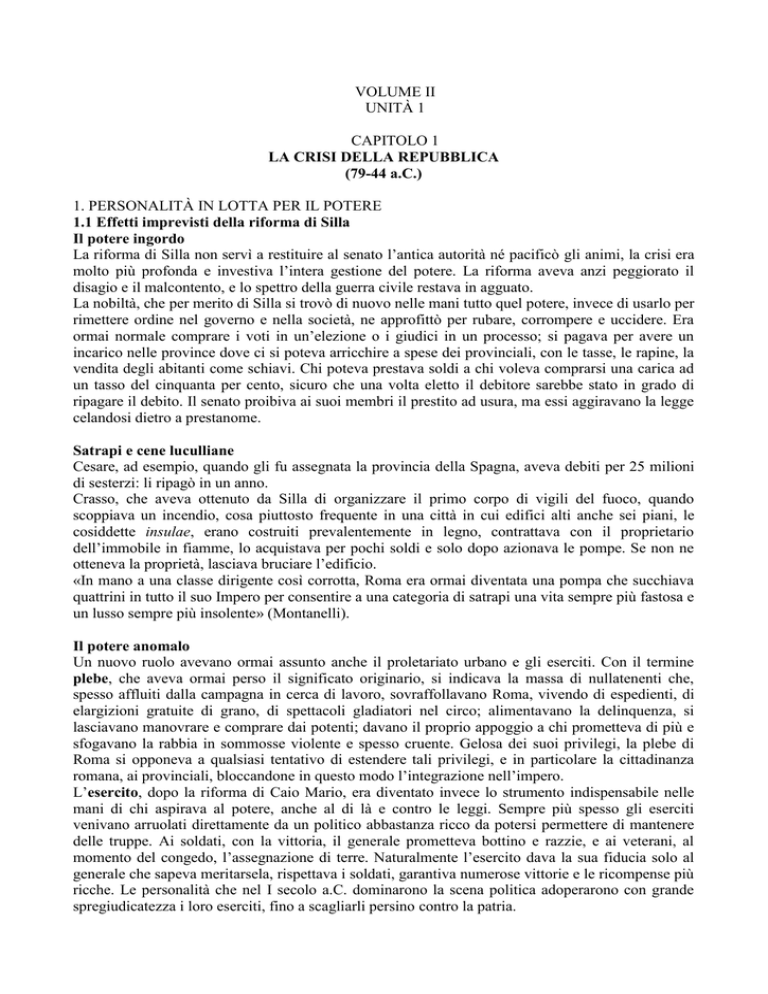
VOLUME II
UNITÀ 1
CAPITOLO 1
LA CRISI DELLA REPUBBLICA
(79-44 a.C.)
1. PERSONALITÀ IN LOTTA PER IL POTERE
1.1 Effetti imprevisti della riforma di Silla
Il potere ingordo
La riforma di Silla non servì a restituire al senato l’antica autorità né pacificò gli animi, la crisi era
molto più profonda e investiva l’intera gestione del potere. La riforma aveva anzi peggiorato il
disagio e il malcontento, e lo spettro della guerra civile restava in agguato.
La nobiltà, che per merito di Silla si trovò di nuovo nelle mani tutto quel potere, invece di usarlo per
rimettere ordine nel governo e nella società, ne approfittò per rubare, corrompere e uccidere. Era
ormai normale comprare i voti in un’elezione o i giudici in un processo; si pagava per avere un
incarico nelle province dove ci si poteva arricchire a spese dei provinciali, con le tasse, le rapine, la
vendita degli abitanti come schiavi. Chi poteva prestava soldi a chi voleva comprarsi una carica ad
un tasso del cinquanta per cento, sicuro che una volta eletto il debitore sarebbe stato in grado di
ripagare il debito. Il senato proibiva ai suoi membri il prestito ad usura, ma essi aggiravano la legge
celandosi dietro a prestanome.
Satrapi e cene luculliane
Cesare, ad esempio, quando gli fu assegnata la provincia della Spagna, aveva debiti per 25 milioni
di sesterzi: li ripagò in un anno.
Crasso, che aveva ottenuto da Silla di organizzare il primo corpo di vigili del fuoco, quando
scoppiava un incendio, cosa piuttosto frequente in una città in cui edifici alti anche sei piani, le
cosiddette insulae, erano costruiti prevalentemente in legno, contrattava con il proprietario
dell’immobile in fiamme, lo acquistava per pochi soldi e solo dopo azionava le pompe. Se non ne
otteneva la proprietà, lasciava bruciare l’edificio.
«In mano a una classe dirigente così corrotta, Roma era ormai diventata una pompa che succhiava
quattrini in tutto il suo Impero per consentire a una categoria di satrapi una vita sempre più fastosa e
un lusso sempre più insolente» (Montanelli).
Il potere anomalo
Un nuovo ruolo avevano ormai assunto anche il proletariato urbano e gli eserciti. Con il termine
plebe, che aveva ormai perso il significato originario, si indicava la massa di nullatenenti che,
spesso affluiti dalla campagna in cerca di lavoro, sovraffollavano Roma, vivendo di espedienti, di
elargizioni gratuite di grano, di spettacoli gladiatori nel circo; alimentavano la delinquenza, si
lasciavano manovrare e comprare dai potenti; davano il proprio appoggio a chi prometteva di più e
sfogavano la rabbia in sommosse violente e spesso cruente. Gelosa dei suoi privilegi, la plebe di
Roma si opponeva a qualsiasi tentativo di estendere tali privilegi, e in particolare la cittadinanza
romana, ai provinciali, bloccandone in questo modo l’integrazione nell’impero.
L’esercito, dopo la riforma di Caio Mario, era diventato invece lo strumento indispensabile nelle
mani di chi aspirava al potere, anche al di là e contro le leggi. Sempre più spesso gli eserciti
venivano arruolati direttamente da un politico abbastanza ricco da potersi permettere di mantenere
delle truppe. Ai soldati, con la vittoria, il generale prometteva bottino e razzie, e ai veterani, al
momento del congedo, l’assegnazione di terre. Naturalmente l’esercito dava la sua fiducia solo al
generale che sapeva meritarsela, rispettava i soldati, garantiva numerose vittorie e le ricompense più
ricche. Le personalità che nel I secolo a.C. dominarono la scena politica adoperarono con grande
spregiudicatezza i loro eserciti, fino a scagliarli persino contro la patria.
Fazioni o personalità in lotta
In conflitto erano due diversi modi di concepire la politica, rappresentati dalle due fazioni che si
contendevano il potere, gli optimates e i populares, espressione entrambe della nobilitas, ma con
due opposte visioni del potere. Però da tempo ormai erano singole personalità – dai Gracchi, a
Mario e Silla – spesso forti dei loro eserciti, ad assumersi il compito di tentare una riforma dello
Stato in un senso o nell’altro, tanto che le guerre civili che si scatenarono nel I secolo a.C., secondo
alcuni, furono dettate dalla brama di potere di singole personalità, quasi sempre esponenti della
nobiltà, che aderivano all’una o all’altra delle due fazioni solo per sfruttarne l’appoggio.
È anche vero però che, dietro le varie personalità, le vere protagoniste della storia erano le forze
sociali che premevano per un rinnovamento profondo dello Stato.
memo
Gli optimates, tradizionalisti e conservatori, contrari al rinnovamento della politica, intendevano
mantenere l’ordine costituito e i privilegi della classe al potere, basavano la loro forza sull’autorità
del senato e della tradizione, cioè del mos maiorum; i populares, riformisti e favorevoli alle
innovazioni politiche, economiche e sociali necessarie a governare un impero così ampio, volevano
adeguare le strutture ai tempi e riequilibrare le disparità sociali, esercitando maggiore controllo sulle
elezioni per evitare corruzione e brogli, migliorando le condizioni di vita dei ceti meno abbienti, per
evitare conflitti sociali, realizzando riforme. La fazione dei populares era una minoranza tra i nobili,
ma aveva spesso l’appoggio dei cavalieri e agiva attraverso i tribuni e i comizi, quindi sulla base
della volontà popolare, ormai poco propensa a riconoscere autorità al senato.
1.2 Pompeo Magno
L’ascesa di Pompeo (82-72 a.C.)
La personalità forse più emblematica, per le sue scelte ambigue e contraddittorie, della grande
confusione politica che regnava a Roma, è quella di Pompeo, il primo ad affacciarsi sulla scena
politica alla morte di Silla. Gneo Pompeo apparteneva a una famiglia italica di recente nobiltà. Il
padre aveva combattuto nella guerra sociale, dimostrando ambizione e brutalità, ed era riuscito a
costruirsi una ricchissima proprietà nel Piceno e ad assicurarsi vaste clientele, che lasciò in eredità
al figlio. Questi, quando Silla sbarcò a Brindisi, sfruttando le sue ricchezze poté addirittura
arruolare tre legioni per appoggiarlo nella lotta contro Mario il Giovane.
Nell’81 a.C., ad appena venticinque anni, senza aver ricoperto alcuna magistratura, ottenne il diritto
a celebrare il trionfo – che spettava in realtà solo a un console o a un pretore vittorioso –, e il titolo
onorifico di Magno. Sposò la figlia di Silla e durante la dittatura del suocero ebbe incarichi
importanti, ma il suo potere crebbe soprattutto dopo il ritiro del dittatore a vita privata.
Nel 76 a.C. fu inviato in Spagna, contro Quinto Sertorio, un seguace di Mario, governatore delle
due province iberiche (Hispania Ulterior e Hispania Citerior), dove si erano rifugiati i mariani.
Sertorio si era ingraziato le popolazioni iberiche in lotta contro Roma e ne appoggiava le
rivendicazioni. Non fu facile per Pompeo sconfiggere i ribelli che avevano il vantaggio di conoscere
i luoghi e attuavano la tattica della guerriglia. Il generale ricorse allora all’astuzia: approfittando del
fatto che molti uomini di Sertorio trattavano gli indigeni come “barbari” e suscitavano proteste e
defezioni, egli riuscì a sobillarli contro il governatore. Nel contempo corruppe anche gli uomini a
lui più fedeli, finché ottenne che uno di essi attirasse Sertorio e la sua guardia del corpo in un
tranello e li trucidasse (72 a.C.). Pompeo poté così tornare, dopo quattro anni, in Italia.
La rivolta di Spartaco (73-71 a.C.)
Ma intanto a Roma era scoppiata, nel 73 a.C., la più grave rivolta servile della storia romana. Tra il
II e il I secolo a.C., gli schiavi rappresentavano la metà di tutta la popolazione della penisola. Il loro
grande numero e il durissimo trattamento che subivano avevano provocato già molte rivolte. Già nel
136-132 a.C. in Sicilia era scoppiata una prima rivolta.
Qui erano presenti più che altrove numerosissimi schiavi, di origine per lo più siriaca, che si
impossessarono di Enna, proprio al centro dell’isola, e da lì estesero la rivolta ad Agrigento,
Tauromenio (Taormina), Catania, Messina e, forse, Siracusa. A comandarli era lo schiavo Euno,
eletto re dai suoi seguaci col nome di Antioco, come il re di Siria vinto dai romani. Gli insorti
sconfissero ripetutamente i reparti romani inviati per reprimere la rivolta, fecero strage dei
magistrati e di tutta la classe dirigente romana, mentre ottennero probabilmente l’appoggio delle
classi popolari. La rivolta servile divenne così la lotta della Sicilia contro la dominazione romana.
Lo storico Diodoro Siculo, un secolo dopo, parla di 200.000 insorti, mentre a provare il
coinvolgimento della popolazione siciliana, che le fonti non citano, sono i provvedimenti assunti dal
console che riuscì a reprimere la rivolta solo quando giunsero le truppe di rinforzo dalla Spagna,
dopo quattro anni di lotta. Egli, dopo aver crocefisso migliaia di ribelli nelle campagne intorno ad
Enna, concesse alla provincia della Sicilia larga autonomia nell’amministrazione della giustizia
Anche ora a Roma il numero degli schiavi e il loro sfruttamento inumano spinsero in alcuni casi gli
schiavi a ribellarsi per ottenere la libertà, a fuggire per darsi al brigantaggio nelle campagne e nei
boschi oppure ad impossessarsi, come accadde in Sicilia, di ampi territori per taglieggiare gli
abitanti, sicuri della protezione dei loro potenti padroni. Le pene per gli schiavi fuggitivi o ribelli
andavano dalle torture fino alla morte: i condannati erano inviati nell’arena per essere sbranati da
bestie feroci o venivano crocefissi: era questa una morte infamante riservata solo agli schiavi.
Spartaco, trace di origine, uomo intelligente e coraggioso, che aveva combattuto nell’esercito
romano, ma poi era stato fatto schiavo per diserzione e inviato nella famosa scuola di gladiatori di
Capua, insieme a poche decine di gladiatori era riuscito a fuggire e a rifugiarsi alle falde del
Vesuvio. Qui fu raggiunto da migliaia di altri schiavi fuggitivi e li guidò verso il nord, nella
speranza di valicare le Alpi, raggiungere i paesi di origine e riacquistare la libertà. Nella loro marcia
i ribelli raccolsero molti altri fuggitivi, tra cui gli schiavi pastori dell’Appennino e anche piccoli
contadini e braccianti ridotti in miseria, tanto che il numero dei fuggitivi arrivò in alcuni momenti a
150.000. Roma fu costretta a inviare entrambi gli eserciti consolari, che tuttavia Spartaco riuscì a
sconfiggere presso Modena, nel 72 a.C.
A questo punto gli schiavi, esaltati dal successo, costrinsero Spartaco a tornare indietro e a marciare
verso Roma. Ma Roma mise in campo ben dieci legioni, affidate al comando di Marco Licinio
Crasso. I fuggitivi si diressero allora verso l’estrema punta del Bruzio (l’attuale Calabria) dove
Crasso tentò di bloccarli con un vallo di 55 km che si estendeva dal Tirreno allo Ionio. Spartaco
riuscì tuttavia a rompere l’accerchiamento e a guidare le sue truppe verso la Puglia. Ma fu raggiunto
da Crasso e nel 71 a.C., in Lucania, avvenne la battaglia decisiva: 60.000 rivoltosi furono uccisi; dei
superstiti, 6000, con una pena infamante, furono crocefissi sulla via Appia, che congiungeva Capua
a Roma, altri 5000 riuscirono a raggiungere l’Etruria, dove si scontrarono con l’esercito di Pompeo
di ritorno dalla Spagna e furono massacrati.
La rivolta ebbe un effetto disastroso sulla schiavitù di Roma, non solo perché migliaia di schiavi
morirono, ma anche perché i padroni terrorizzati si fecero sempre più repressivi: se, ad esempio,
uno schiavo uccideva il padrone, venivano uccisi tutti gli schiavi della casa.
Il voltafaccia di Pompeo (71 a.C.)
Pompeo tornava a Roma carico di gloria e aspirava a diventare console, ma non aveva ancora
percorso il cursus honorum previsto dalla riforma di Silla. Si alleò pertanto con Crasso, divenuto
l’uomo più ricco di Roma grazie agli abusi compiuti durante le proscrizioni sillane. I due generali
non congedarono i loro eserciti e li accamparono minacciosamente nei dintorni della città per
forzare la mano al senato. Ma la mossa non bastò, occorreva l’appoggio dei cavalieri e del popolo.
Benché aristocratici, sostenitori della politica sillana e degli optimates, essi decisero allora di
cercare l’appoggio dei populares, promettendo loro lo smantellamento della costituzione di Silla se
fossero stati eletti consoli. Con l’appoggio popolare e gli eserciti schierati alle porte di Roma i due
ottennero il consolato per il 70 a.C. E mantennero le promesse:
restituirono ai tribuni i poteri originari: l’intercessio e la possibilità di accedere alle altre
magistrature;
nominarono nuovi censori che espulsero dal senato 64 (o 84?) senatori che avevano
appoggiato Silla o erano stati da lui nominati;
in un nuovo censimento inclusero nelle tribù mezzo milione di italici che avevano ottenuto
la cittadinanza con la guerra sociale: ora essi potevano finalmente votare;
restituirono ai cavalieri l’appalto della riscossione delle imposte nelle province asiatiche,
che era stato loro sottratto da Silla;
riformarono la composizione delle giurie dei tribunali che furono affidate in parti uguali a
senatori, cavalieri e a quei plebei che avevano un censo di poco inferiore ai cavalieri.
Lo scandalo di Verre (70 a.C.)
A rendere più che mai opportuna l’attribuzione ai cavalieri del tribunale de repetundis, che
giudicava i reati di concussione, fu il processo contro Verre. Contro l’aristocratico Caio Verre,
governatore della Sicilia, che in tre anni aveva depredato enormi ricchezze, soprattutto dalla
ricchissima colonia greca di Siracusa, avevano intentato causa gli stessi sicelioti, che avevano
chiesto il patrocinio legale di un giovane avvocato alle prime armi, Marco Tullio Cicerone.
Nel processo, Cicerone, appoggiato dall’ordine equestre a cui egli stesso apparteneva, rivelò
eccezionali qualità oratorie, mise in scacco l’avvocato della difesa, il celebre Quinto Ortensio
Ortalo, considerato il “principe” del foro, avvocato di fiducia degli optimates, e sostenne l’accusa
con tale veemenza da spingere l’accusato a fuggire in esilio a Marsiglia, in Gallia, già dopo la prima
seduta.
Cicerone pubblicò comunque le cinque orazioni, definite Verrine, che costituiscono ancora oggi
una prova non solo delle colpe dell’imputato, ma anche delle responsabilità dell’intero sistema di
governo delle province e della corruzione dell’oligarchia conservatrice.
Gli esordi di un grande oratore
Cicerone nacque nel 106 a.C. da un ricco agricoltore di Arpino, località del Lazio meridionale, che
aveva dato i natali anche a Mario. Ricevuta un’ottima educazione, iniziò al sua carriera di avvocato
nell’81 a.C., attaccando un liberto protetto da Silla. Nel 77 a.C. sposò Terenzia, da cui ebbe i figli
Tullia e Marco, e nel 76 fu questore a Lilibeo, nella Sicilia occidentale, dove si fece apprezzare per
la sua onestà. A Siracusa riscoprì la tomba di Archimede (ucciso nel 212 dai romani durante la
conquista della città). Da allora la sua presenza sulla scena politica fu, in alcuni momenti,
determinante.
Pompeo contro i pirati (67 a.C.)
A conclusione dell’anno di consolato, Pompeo non volle ricoprire il proconsolato in nessuna
provincia per non allontanasi da Roma, in attesa di una nuova possibilità per mettersi in luce e
acquisire sempre più potere. L’occasione gli si presentò tre anni dopo, quando un tribuno propose
una guerra contro i pirati.
La pirateria era considerata nel mondo antico una forma di concorrenza legittima tra le varie
potenze commerciali: secondo il mito, persino Ulisse la praticava. Roma aveva sempre avuto un
atteggiamento ambiguo nei confronti dei pirati: da un lato se ne era servita contro Cartagine,
dall’altro aveva combattuto contro i pirati dell’Illiria nel 228 a.C.
Ora a predominare erano i pirati orientali, stanziati soprattutto in Cilicia, in Asia Minore, una
regione dalle coste piene di anfratti e ripari, coperte alle spalle da montagne aspre e inaccessibili,
ricche di foreste che fornivano il legname necessario per la costruzione delle navi pirata.
Partendo dai loro covi, i pirati razziavano beni e persone, attaccavano navi e paesi sulle coste e
rifornivano di schiavi l’intero bacino mediterraneo. Avevano combattuto con le loro flotte al fianco
di Mitridate e, approfittando della guerra civile a Roma, avevano razziato persino le coste italiche,
arrivando perfino a Ostia, il porto di Roma. Si erano poi spinti fino in Spagna.
La situazione si era fatta difficile. La flotta dei pirati era costituita da oltre mille navi e i loro
attacchi insidiavano le rotte commerciali, ledendo gli interessi dei cavalieri, e mettevano in
pericolo l’approvvigionamento di Roma: bastava che una nave, con un carico di grano destinato
alla capitale, venisse depredata, per affamare la popolazione romana, che viveva in gran parte delle
elargizioni di grano. Per questo fu proprio un tribuno della plebe a proporre, con la legge de piratis
persequendis, la guerra contro i pirati e ad affidarne a Pompeo il comando con poteri
eccezionali.
Investito quindi, contro il parere del senato, dell’imperium proconsolare infinitum su tutti i mari e su
tutte le coste dell’impero fino a 80 km nell’interno, per la durata di tre anni, dotato di un’enorme
quantità di mezzi – 500 navi, 120.000 soldati, 5000 cavalieri e 150 milioni di sesterzi – Pompeo in
soli 49 giorni distrusse le basi dei pirati nel Mediterraneo occidentale e catturò centinaia di
imbarcazioni. Altrettanto tempo gli occorse per costringere i pirati che si erano rifugiati in Cilicia ad
arrendersi. Per debellare il problema alla radice, assegnò loro appezzamenti di terra in Asia Minore,
spingendoli così a cambiare le basi della loro economia.
Il commercio nel Mediterraneo orientale riprese, l’ordine equestre tirò un sospiro di sollievo,
crollò il prezzo del grano e allora furono le classi popolari a tirare un sospiro di sollievo, mentre
l’aristocrazia terriera, che sulla vendita del grano basava tradizionalmente la sua ricchezza, non ne
fu affatto contenta.
La seconda e la terza guerra mitridatica (83-81, 74-62 a.C.)
Fu ancora un tribuno della plebe a proporre una legge che affidava a Pompeo, appena tornato a
Roma al culmine della popolarità, la guerra contro Mitridate, l’antico nemico che Silla non aveva
potuto sconfiggere definitivamente, perché costretto a tornare a Roma.
Nell’83 a.C., i romani avevano tentato di invadere il regno del Ponto, scatenando la seconda
guerra mitridatica, ma nell’81 erano stati sconfitti al fiume Halys. Poi il re della Bitinia aveva
lasciato il proprio regno in eredità ai romani ed essi ne avevano approfittato per riprendere le ostilità
nel 74 a.C., ma non erano riusciti ancora a sconfiggere Mitridate che si era alleato con Tigrane, re
d’Armenia. Pompeo, che sostituiva il comandante in carica, il senatore Lucio Licinio Lucullo,
aveva a disposizione 60.000 legionari e assoluta libertà di iniziativa in guerra e in pace. Per vincere
la guerra egli usò non solo la sua abilità di stratega, ma anche quella di diplomatico. Riuscì, infatti,
a convincere Tigrane ad abbandonare l’alleato e persino Farnace, il figlio di Mitridate, a tradire il
padre. Mitridate si uccise nel 63 a.C.
Una personale sistemazione dell’Asia (63-62 a.C.)
Pompeo si fermò ancora qualche tempo in Oriente per intraprendere una vasta opera di sistemazione
dei possedimenti orientali di Roma, ampliati dopo la sua vittoria: lasciò Tigrane sul trono
d’Armenia, assegnò a Farnace il piccolo regno del Bosforo, nel nord del mar Nero, unificò il
Ponto e la Bitinia in una nuova provincia, ridusse in province la Cilicia e la Siria, dov’era stato
eliminato l’ultimo discendente della dinastia dei Seleucidi. Sottomise alla protezione di Roma la
Palestina e alcune città libere; lasciò indipendenti alcuni piccoli regni, facendone “stati
cuscinetto”, che però legò a sé con vincoli di dipendenza personale.
Quando nel 62 a.C. sbarcò a Brindisi carico di bottino e di gloria, il senato tremò all’idea che
volesse approfittare del suo enorme potere.
1.3 Catilina (64-62 a.C.)
Un nobile rovinato in ricerca di potere
Roma, infatti, stava vivendo un momento drammatico. Nel 64 a.C. un nobile ex sillano, il cui padre
si era rovinato finanziariamente nella competizione politica, Lucio Sergio Catilina, passò alla
fazione dei populares e propose la propria candidatura al consolato per l’anno 63. Ma la pressione
dei suoi ricchi creditori impose la candidatura di Marco Tullio Cicerone. Uomo politico e
avvocato ormai affermato, Cicerone mirava alla concordia ordinum, cioè all’alleanza tra gli
“ordini” della nobiltà e della classe imprenditoriale dei cavalieri, che, possedendo le leve del potere
politico ed economico, avrebbero potuto garantire la stabilità dello stato. La nobiltà però non voleva
accordare vantaggi ai cavalieri e anche l’ordine equestre preferiva conservare la libertà di allearsi
ora con il senato ora con i populares, a seconda dei propri interessi del momento.
Ma il momento richiedeva ora l’alleanza con i nobili, così Catilina fu battuto alle elezioni dal suo
avversario Cicerone. Per ottenere l’appoggio popolare e soprattutto quello dei nobili decaduti come
lui, Catilina propose allora la cancellazione dei debiti e nel 63 a.C. si ripresentò al consolato per
l’anno seguente, ma fu battuto ancora una volta. Organizzò allora, con i nobili suoi amici, una
congiura per eliminare il console in carica Cicerone, organizzando un esercito in Etruria per
marciare su Roma. Ma anche tutta l’Etruria era pronta all’insurrezione generale, perché, pur
essendo stata un tempo molto ricca, era ormai dissanguata dalla diffusione del latifondo e decimata
dalle proscrizioni sillane.
Fino a quando, Catilina? (63 a.C.)
Cicerone, che aveva promosso una legge per inasprire le disposizioni contro la corruzione elettorale
e impedire così a Catilina di ottenere il consolato per il 62, venne a conoscenza del piano e, pur non
disponendo di prove schiaccianti della congiura, chiese e ottenne i pieni poteri e la dichiarazione
dello stato di emergenza. Nella seduta del senato dell’8 novembre del 63 a.C., egli con una
orazione attaccò Catilina, esordendo con la celebre domanda: «Quo usque tandem, Catilina,
abuteris patientia nostra?» (“Fino a quando, Catilina, abuserai della nostra pazienza?”). Era la
prima famosissima Catilinaria. I toni di Cicerone furono così efficaci da indurre Catilina a fuggire
la stessa notte da Roma e a rifugiarsi in Etruria presso i ribelli. Cicerone continuò nella sua
denuncia con le altre tre Catilinarie, declamate nelle sedute del senato del 9 novembre, del 3 e del 5
dicembre. Le quattro orazioni costituiscono un documento storico di eccezionale importanza, sia
pure di parte e poco oggettivo, e un esempio altissimo dell’eloquenza ciceroniana.
La fine gloriosa di una carriera senza gloria
Il console trascinò poi in senato i congiurati rimasti a Roma e li fece condannare a morte, senza
concedere loro di appellarsi al popolo, come consentiva la legge in caso di pena capitale. Nella
seduta decisiva del 5 dicembre del 63, solo Caio Giulio Cesare fece sentire la propria voce per
difendere la legalità: il senato, infatti, non era un organo giudiziario e tanto meno aveva il potere di
impedire l’appello al popolo. L’intento di Cesare, che forse era coinvolto o almeno era a
conoscenza della congiura, era però soprattutto quello di mettersi in luce e ottenere il favore dei
populares.
I ribelli in Etruria furono battuti presso Pistoia nel gennaio del 62: nessuno di loro si arrese e lo
stesso Catilina cadde combattendo valorosamente. A Roma Cicerone divenne il “Padre della
Patria”.
Giudizi di parte
Il giudizio su Catilina passato alla storia è quello fornito dallo stesso Cicerone e dallo storico
Sallustio che dedicò un’opera alla congiura. Entrambi erano ostili al tentativo rivoluzionario di
Catilina e perciò è difficile dare oggi un giudizio definitivo su questo tentativo, che da un lato
sembra frutto di ambizione personale ed egoistica di un esponente della nobiltà in decadenza, ma
dall’altro potrebbe apparire necessario a imprimere una svolta alla politica romana.
D’altro canto, occorre dire che non furono mai trovate prove certe della congiura, mentre è certo
che Catilina aveva cercato di raggiungere il potere legalmente, presentandosi alle elezioni, e che i
suoi avversari avevano usato, invece, anche corruzione e mezzi illegali per escluderlo dalla
competizione. Il fatto, poi, che Catilina trovasse, sia tra i nobili sia tra il proletariato e il
sottoproletariato urbano, tanti seguaci disposti anche a morire per le loro idee rivela che il disagio
era molto profondo e Catilina se ne faceva portavoce.
Eppure neanche i populares, come lo stesso Sallustio, appoggiavano il suo piano, perché esso
coinvolgeva gli strati più umili ed emarginati della popolazione e persino gli schiavi, in un progetto
troppo rivoluzionario perché i popolari potessero accettarlo.
La reazione del senato, che violava la legge, mostra però che la classe al potere non era più in
grado di risolvere i problemi e di garantire la legalità e che un cambiamento radicale dello Stato era
ormai inevitabile.
2. CESARE
2. 1 La scalata al potere
L’ascesa di Cesare (oppure L’entrata in scena)
Caio Giulio Cesare, il nuovo personaggio che si affacciava a sua volta sulla scena politica,
apparteneva a un’antica gens romana, la gens Julia, che si vantava di discendere da Venere
attraverso Enea e suo figlio Julo, ma non aveva avuto fino a quel momento personaggi di rilievo.
Nipote della moglie di Mario, sposò in seconde nozze (ripudiando la prima moglie che gli era stata
imposta dal padre) Cornelia, figlia di Cinna, un mariano avversario di Silla, e non volle ripudiarla
quando il dittatore glielo chiese. Dovette perciò subire la confisca della dote di Cornelia e la
persecuzione di Silla, che tuttavia gli concesse di allontanarsi da Roma.
Quando rientrò in città, dopo la morte del dittatore, non volle prendere parte allo smantellamento
della costituzione sillana, preferì agire nell’ombra per accattivarsi le simpatie popolari con
elargizioni di denaro e di grano. Privo delle ricchezze necessarie alla carriera politica, seppe
sfruttare l’amicizia con Crasso che gli fornì i mezzi economici necessari a scalare il potere;
appoggiò la candidatura di Pompeo al consolato del 70 a.C. e lo attrasse verso la parte popolare;
favorì la legge che gli affidava la guerra contro i pirati e poi quella contro Mitridate e, mentre
Pompeo restava lontano da Roma per sette anni, ne approfittò per rafforzare la propria immagine
davanti al popolo con magnifici giochi ed elargizioni.
Box Dida
Ritratto di Cesare
La casa, in cui Cesare nacque il 12 o 13 luglio del 100 a.C. (o del 102), sorgeva nella Suburra, il
quartiere popolare e malfamato di Roma. Sin da ragazzo soffriva di mal di testa e di attacchi di
epilessia, che pare si siano aggravati col tempo, benché egli cercasse di nasconderli. Aveva ricevuto
una buona educazione e studiato l’arte retorica in Grecia. Non era bello, divenne quasi calvo molto
presto, ma era un uomo di mondo, elegante, galante, gran seduttore, spregiudicato e, ricco di
umorismo, sapeva ridere delle battute, come quelle che gli lanciavano, secondo la consuetudine
romana, i suoi soldati durante il trionfo: «Ehi, uomini, chiudete in casa le vostre mogli: è tornato il
seduttore zuccapelata». A quanto pare sulle donne esercitava un fascino irresistibile. Ebbe quattro
mogli.
Nato in un periodo di conflitti sociali e guerre civili, egli imparò presto a diffidare degli uomini, a
scrutare nella loro anima come nella realtà sociale e politica, a saper aspettare il momento per agire
e a cogliere al volo le occasioni propizie, agendo con rapidità e fermezza.
I primi gradini del cursus honorum
L’origine nobile, le amicizie influenti, tra cui soprattutto quella di Crasso, e un uso spregiudicato
della corruzione permisero a Cesare una rapida carriera politica:
nel 69 a.C. fu questore e nel 65 come edile a Roma, fece costruire magnifici edifici e
celebrare splendidi giochi, fece condannare alcuni personaggi che si erano segnalati
nell’uccisione di proscritti all’epoca di Silla e sostenne l’accusa contro Rabirio, che aveva
preso parte all’uccisione del tribuno della plebe Saturnino, ma Rabirio, difeso da Cicerone,
si salvò.
Nel 63 divenne pontefice massimo: a soli 37 anni, era la massima autorità religiosa di
Roma.
A quanto pare era a conoscenza della congiura di Catilina e si sospettava che ne facesse
parte; sicuramente difese il diritto dei congiurati ad appellarsi al popolo.
Nel 62 era pretore e il 61 come propretore in Spagna riuscì a domare le continue ribellioni
dei lusitani, stanziati nell’odierno Portogallo, migliorò l’amministrazione e le leggi sulle
imposte e sui debiti, ma ne approfittò, come tutti gli altri governatori, per arricchirsi e pagare
i suoi debiti.
Tornato a Roma nel 60 con la fama di grande condottiero, decise che era ormai giunto il
momento di presentarsi alle elezioni al consolato per l’anno successivo.
2.2 Il consolato
Un’alleanza privata (60 a.C.)
Nel 61 era rientrato a Roma anche Pompeo, carico di gloria e di bottino e forte di un esercito
vittorioso, con cui avrebbe potuto imporre il proprio potere e addirittura istituire un regime
monarchico a Roma, ma preferì rispettare la legge e sciolse le proprie legioni. Il senato commise un
errore imperdonabile: non comprese il pericolo rappresentato da Cesare, che aveva ormai il popolo
a sostenerlo, lasciò prevalere l’invidia nei confronti di Pompeo e, anziché tenerselo alleato, gli
rifiutò la ratifica dei provvedimenti con cui aveva sistemato le province in Asia e la distribuzione
delle terre ai suoi veterani, anche se gli concesse il trionfo più ricco e fastoso che si fosse mai visto.
Era giunta per Cesare l’occasione tanto attesa. Ancora una volta offrì il proprio sostegno a Pompeo
deluso dall’atteggiamento del senato, incapace di far leva sul popolo, inviso ai suoi stessi veterani ai
quali non era stato in grado di garantire la ricompensa abituale di terre. In cambio del suo aiuto per
ottenere quanto il senato negava, Pompeo doveva garantire a Cesare il proprio appoggio per
l’elezione al consolato. Per sostenere le enormi spese elettorali, a Cesare era poi indispensabile
avere a disposizione anche un finanziere ricchissimo qual era Crasso. Con loro, dunque, egli strinse
un patto privato e segreto, che passò alla storia come il primo triumvirato, quasi fosse una carica
pubblica (come in effetti sarebbe stato il secondo triumvirato).
L’accordo coalizzava i popolari nella figura di Cesare, i pubblicani e i cavalieri in quella di
Crasso e la forza militare nel grande generale Pompeo. In base all’accordo, Pompeo e Crasso
garantirono i voti dei loro sostenitori e clienti e misero la loro influenza, che era grande a Roma, e
le loro ricchezze, che erano immense, per fare eleggere Cesare al consolato per il 59. Una volta
console, Cesare stroncò la resistenza del senato alle sue proposte di legge portandole direttamente
davanti ai comizi tributi, in cui le minacce e le violenze dei veterani di Pompeo, che si presentarono
armati sulla piazza dei comizi, ridussero al silenzio ogni opposizione. Si ruppe così la concordia
ordinum auspicata da Cicerone: l’ottusità del senato e l’arroganza dell’aristocrazia, che credeva di
non aver bisogno dell’aiuto dei cavalieri e non voleva condividere i propri privilegi, avevano spinto
il ceto equestre dalla parte dei popolari.
Cesare fece, quindi, approvare una serie di leggi:
una riforma agraria che distribuiva terre ai veterani di Pompeo e alla plebe, per le quali
Cesare non espropriò terreni privati, come aveva fatto Silla, ma col bottino e le entrate
provenienti dalle province asiatiche fece acquistare dallo Stato nuove terre;
la convalida dei provvedimenti di Pompeo in Asia;
la riduzione di un terzo dei canoni che i publicani delle province orientali dovevano
versare allo Stato. Favorì così la classe equestre, che aveva il monopolio degli appalti, e
Crasso che la rappresentava.
Contro il potere occulto
Per garantire una maggiore trasparenza politica, Cesare impose che:
fosse abolita la consuetudine di prendere gli auspici prima delle assemblee legislative,
perché i responsi dei sacerdoti erano manovrati dall’aristocrazia che, per rimandare le
decisioni sgradite, accampava la scusa che gli auspici erano sfavorevoli alla riunione
dell’assemblea;
le discussioni che si svolgevano in senato fossero registrate, pubblicate e affisse in un luogo
pubblico, in modo che tutti i cittadini ne venissero a conoscenza. Il senato, che fino a quel
momento traeva il suo prestigio anche dalla segretezza delle sue riunioni, subì un altro duro
colpo.
Il potere e il carisma di Cesare erano così grandi da mettere a tacere l’altro console in carica, e
l’anno del suo consolato, il 59 a.C., venne definito ironicamente dalla gente “l’anno di Giulio e di
Cesare”.
2.3 Il proconsolato
Alla conquista di Roma passando per la Gallia
Alla fine dell’anno di carica, Cesare scelse inaspettatamente il proconsolato non in una ricca
provincia orientale, ma nell’Illirico e in Gallia Cisalpina, a cui il senato, per mostrarsi generoso e
impedire che lo facesse il popolo, aggiunse poi anche la Gallia Narbonense (l’odierna Provenza).
Erano province economicamente depresse e politicamente insignificanti, che non offrivano grandi
prospettive di arricchimento e apparentemente neppure di gloria.
Ma Cesare aveva un piano assai più ambizioso: al di là della Gallia meridionale, già sotto il
controllo romano, si estendevano gli immensi territori della Gallia centrale e settentrionale,
scarsamente popolati da tribù celtiche ancora arretrate e militarmente deboli. Una guerra di
conquista sarebbe stata per lui un vero trampolino di lancio: lo avrebbe posto su un piano di parità
con Pompeo, gli avrebbe procurato la gloria militare che gli mancava e rafforzato il suo rapporto
con l’esercito, sulla cui fedeltà avrebbe potuto contare nella sua scalata al potere.
A disposizione egli aveva però solo quattro legioni, per un territorio immenso.
Coprirsi le spalle
Cesare non voleva allontanarsi da Roma lasciando la possibilità ai suoi avversari politici di tramare
alle sue spalle.
In particolare doveva liberarsi di Cicerone, esponente degli optimates moderati, che probabilmente
conosceva il suo coinvolgimento nella congiura di Catilina e poteva usare contro di lui le notizie di
cui disponeva.
L’altro avversario era l’esponente della nobiltà senatoria più intransigente, Marco Porcio Catone il
Giovane (poi soprannominato l’Uticense), pronipote del censore ultraconservatore che a metà del II
secolo aveva tuonato perché Cartagine fosse distrutta. Uomo integerrimo, studioso di filosofia,
aveva collaborato alla condanna dei catilinari, scontrandosi con Cesare.
Per allontanare entrambi questi personaggi da Roma, Cesare preferì agire nell’ombra e si appoggiò
al tribuno della plebe Publio Clodio. Era costui un nobile passato dalla parte dei popolari e molto
amato dalla plebe, tanto che aveva cambiato il proprio nome dall’aristocratico Claudio a Clodio,
secondo la pronuncia popolare. Clodio si era fatto adottare da un plebeo per poter essere eletto
tribuno della plebe, proprio nel 58, l’anno in cui Cesare si accingeva a partire per la Gallia.
In qualità di tribuno Clodio ottenne che Catone fosse inviato come ambasciatore nell’isola di Cipro
e fece approvare una legge che condannava all’esilio chi avesse mandato a morte un cittadino
romano senza regolare processo: era proprio il caso di Cicerone. E così questi dovette lasciare
Roma, le sue proprietà vennero da Clodio saccheggiate e distrutte, la sua casa fu comprata dal
tribuno che ormai era quasi padrone di Roma.
Un po’ di gossip romano
Bello, giovane e senza scrupoli, Clodio era stato accusato di essersi introdotto, vestito da donna, nel
sacro recinto della dea Bona, per raggiungere la sua amante, la terza moglie di Cesare, Pompea, che
Cesare aveva sposato dopo la morte della giovane Cornelia. «Quando si celebrano i sacri misteri
della dea non è consentito che un uomo vi partecipi e neppure che sia nella casa […]. Quando
dunque viene il tempo della festa la moglie di colui che è console o pretore prende in mano la casa e
la prepara per il rito, mentre il marito ne esce e con lui tutti i maschi della casa. I riti più importanti
si celebrano durante la notte» (Plutarco, Vita di Cesare, 9). Quell’anno toccava a Pompea, in quanto
moglie del console, celebrare il rito e Clodio ne approfittò per entrare nella casa di nascosto. Una
volta scoperto, fu accusato pubblicamente da Cicerone. Cesare ripudiò la moglie, ma al processo
«disse di non sapere niente di quanto si riferiva contro Clodio. Il discorso appariva paradossale, e
l’accusatore gli chiese: “Come mai allora hai ripudiato tua moglie?”, ed egli: “Perché pensavo
giusto che di mia moglie neppure si sospettasse”» (Plutarco, Vita di Cesare, 10).
Poi mise in moto Crasso per comprare i giudici e l’assoluzione di Clodio. Evidentemente gli serviva
lasciare a Roma un tribuno che gli doveva un enorme favore. Ma l’episodio era anche una buona
scusa per ripudiare Pompea e permettergli di sposare la figlia di Pisone, che gli serviva fare
eleggere al consolato per averne l’appoggio mentre si trovava in Gallia. A Pompeo, invece, per
stringere l’alleanza, aveva dato in moglie la propria figlia Giulia, che poi morì di parto.
De bello Gallico
Gallia est omnis divisa in partes tres
L’esordio dei Commentarii de bello Gallico che Cesare scrisse sulla sua impresa in Gallia introduce
la descrizione della Gallia transalpina, divisa, com’egli dice, in tre parti abitate da altrettanti popoli
di stirpe celtica:
l’attuale Francia era abitata dai celti che i romani chiamavano galli, suddivisi nelle diverse
tribù degli edui, alleati dei romani, degli arverni, dei sequani, dei senoni ecc. Nell’attuale
Svizzera, erano stanziati gli elvezi;
a nord, al di là della Sequana (Senna) e della Matrona (Marna) nel Belgio e in una parte
dei Paesi Bassi, erano insediati i belgi, a cui si mescolavano anche gruppi di germani;
a sud-ovest, al di là del fiume Garonna, abitavano gli aquitani.
La Gallia centrale e settentrionale, percorsa da basse catene, era ricca di miniere d’oro, di rame, di
piombo e di ferro. Le campagne producevano varie specie di frutti e cereali. I popoli che la
abitavano in grossi villaggi, in assenza ancora di città vere e proprie, vivevano di agricoltura e
dell’allevamento di bovini. L’artigianato era sviluppato nella lavorazione del ferro, ma anche di
altri metalli. Il commercio scambiava i metalli, soprattutto lo stagno che proveniva dalle isole
britanniche e lungo il Rodano arrivava a Marsiglia e a Narbona, con i prodotti mediterranei (vino,
ceramica, tessuti).
Ai confini della Gallia
A sud la catena dei Pirenei divide la Gallia dalla penisola iberica, mentre ad est quella delle Alpi
segna il confine con l’Italia. Il confine orientale prosegue poi verso nord lungo il fiume Reno, oltre
il quale si erano stabiliti i germani. Il fiume rappresentò per i romani, dal momento in cui
assimilarono i galli, una frontiera che doveva restare invalicabile ai germani, come baluardo a difesa
del mondo romano. Fu proprio Cesare a cogliere l’importanza di un fiume che separa in due
l’Europa e che in alcuni momenti avrebbe costituito al contrario una via di collegamento e di
contatto tra le genti europee. Eppure il Reno era rimasto per secoli sconosciuto alla cultura greca e
romana, avvolto nel mistero: lo si immaginava scorrere tra foreste impenetrabili, abitate solo da lupi
e fiere di ogni tipo, in un clima intollerabile per i comuni mortali. Anche le popolazioni che
abitavano lungo le sue rive, galli e germani, spesso venivano confuse tra loro. Fu Cesare per primo,
basandosi sulla conoscenza diretta e sull’osservazione attenta, a distinguerle e a descriverne le
diverse caratteristiche, gli usi e i costumi.
Eppure la fascia costiera mediterranea della Gallia, affacciata sul Gallicus sinus (“golfo Gallico”) e
attraversata dal Rodano, era già dal 121 a.C. dominio romano col nome di Gallia Narbonense o
semplicemente di Provincia, da cui deriva il nome attuale di Provenza. La città di Narbona, di
origine celtica, nel 118 a.C. divenne la prima colonia romana fuori dall’Italia. Qui il commercio era
quasi esclusivamente nelle mani dei mercanti romani, che avevano contatti anche con la Gallia
ancora indipendente, di cui però conoscevano molto poco.
Più a est il territorio di Marsiglia, antica colonia greca, era indipendente, ma alleata dei romani. La
Gallia Cisalpina, “al di qua delle Alpi”, comprendeva invece tutta l’Italia settentrionale.
Un popolo bellicoso guidato da sacerdoti
I galli, per lo più ancora nomadi, erano forti e valorosi, ma suddivisi in un centinaio di tribù
indipendenti, che spesso si combattevano a vicenda. Le tribù più forti, circa una quarantina
all’epoca di Cesare, riuscivano a controllare abbastanza stabilmente il territorio e a dominare le
altre. A governare era un’aristocrazia, suddivisa in due classi, che dominavano sulle classi inferiori:
i cavalieri, che Cesare chiama principes, e i druidi.
I cavalieri costituivano l’aristocrazia, dedita solo alla guerra, frequente tra le varie tribù assai
bellicose dei galli. Fondavano il loro potere esclusivamente sul valore militare. A tutto il resto
pensavano i druidi.
I druidi costituivano la casta sacerdotale, ma di fatto tenevano in proprio potere tutta la Gallia:
infatti alla frammentazione politica delle varie popolazioni corrispondeva un’unità religiosa che
faceva capo a loro. Svolgevano anche la funzione di giudici, detenevano le conoscenze, che
trasmettevano ai giovani durante i riti iniziatici, o attraverso i canti che alcuni di loro, i bardi,
diffondevano per conservare la memoria storica della loro cultura, in mancanza della scrittura: solo
i druidi, infatti, usavano talvolta, e solo per necessità, l’alfabeto greco. I druidi erano anche maghi e
indovini, conoscevano le proprietà delle piante medicinali, curavano gli ammalati o esorcizzano
gli influssi funesti con riti magici. Come sacerdoti, praticavano sacrifici umani e credevano nella
reincarnazione. Si riunivano una volta all’anno in un bosco segreto, nei pressi dell’attuale
Chartres, nella Francia settentrionale, ed erano guidati da un sommo sacerdote, che restava in carica
a vita. Furono loro – che di fatto governavano i galli – a spingerli alla rivolta contro Cesare. Una
volta sconfitti, il generale romano li perseguitò, e molti finirono massacrati, distrusse i loro santuari
e vietò la loro religione.
Glossario
Il termine druidi, di etimologia incerta, potrebbe essere connesso con un’antica radice indoeuropea
che dovrebbe significare “molto saggio” o “esperto in cose sacre”; altri preferiscono riferirlo al
greco drys, “quercia”, perché i riti sacri erano celebrati nei boschi di querce.
Una guerra lampo (58-57 a.C.)
Fu proprio la divisione interna e l’instabilità delle tribù celtiche a favorire la penetrazione di Cesare
in territorio gallico.
Alcune tribù germaniche, infatti, premevano sugli elvezi, che dalla Svizzera occidentale
cominciarono a spostarsi verso ovest attraversando il territorio degli edui. Questi, alleati dei romani,
chiesero aiuto a Cesare, il quale arruolò altri soldati presso gli stessi galli, costituì quattro ulteriori
legioni, attaccò gli elvezi senza neppure attendere l’autorizzazione del senato e, malgrado
l’inferiorità numerica, in una sola battaglia, nell’estate del 58 a.C., li sterminò con mogli e bambini:
260.000 vittime su un totale di 370.000 elvezi partiti dai loro territori è la cifra dei morti, fornita
dallo stesso vincitore, che poi «radunò i barbari sfuggiti alla battaglia, che erano ancora più di
centomila, e li costrinse a riprendere la terra che avevano abbandonato e le città che avevano
distrutte. Questo fece perché temeva che i Germani passassero a conquistare la terra rimasta
inabitata.» (Plutarco, 18)
Altri germani, i suebi, guidati dal loro re Ariovisto, tentavano di oltrepassare il Reno e occupare i
territori dei galli: Cesare anche questa volta li attaccò e li massacrò, giungendo fino alla Manica e
provocando la reazione dei belgi.
Essi, temendo l’espansione dei romani, si coalizzarono con altre tribù per fermarli, ma furono
anch’essi sconfitti.
Nel 57 a.C. Cesare poteva proclamare, piuttosto prematuramente, di aver sottomesso tutta la Gallia.
A Roma il popolo esultò, il senato molto meno.
Erano trascorsi solo due anni dall’inizio del suo proconsolato. Per Cesare era però giunto il
momento di sospendere momentaneamente le operazioni in Gallia e riprendere i contatti con Roma,
in cui la situazione era andata degenerando.
Guerra di bande (57-56 a.C.)
A Roma il conflitto ormai cronico tra populares e optimates aveva preso la brutta piega di scontri
tra bande armate, guidate rispettivamente da Clodio, il tribuno lasciato opportunamente a Roma
da Cesare e controllato da Crasso, e da Annio Milone, manovrato dalla nobiltà e da Pompeo.
Questi, infatti, preoccupato delle vittorie di Cesare, si stava riavvicinando al senato e lo spinse a
richiamare Cicerone dall’esilio, entrando in contrasto con l’altro triumviro, Crasso. Nel 57 tornò in
patria da Cipro anche Catone il Giovane. Gli ottimati ripresero forza e qualcuno propose di
revocare il comando proconsolare a Cesare, prima della scadenza dei cinque anni previsti. Cesare
giunse al momento opportuno: nel 56 a.C. incontrò, alla presenza dei più potenti cittadini romani, i
triumviri a Lucca e rinsaldò con loro l’accordo triumvirale, con reciproci vantaggi:
Cesare ottenne di prolungare il proconsolato in Gallia per altri cinque anni;
Pompeo e Crasso ottennero il consolato per il 55 a.C.: i termini per la candidatura erano
scaduti, ma bastarono degli espedienti perché i due fossero comunque eletti consoli;
Crasso ottenne, al termine del mandato, il proconsolato in Siria, dove avrebbe potuto
guadagnarsi, conquistando il regno dei parti stanziato in Persia e in rapida ascesa, quella
gloria militare che gli mancava per raggiungere una posizione di parità con gli altri due
triumviri;
Pompeo ottenne il proconsolato in Spagna, che gli consentiva di disporre, oltre alle
numerose relazioni e amicizie contratte ai tempi della guerra contro Sertorio, anche di
alcune legioni e del comando militare.
Lo Stato romano e tutto l’esercito erano ormai totalmente nelle mani di tre personaggi che ne
disponevano a proprio piacimento. Le decisioni non erano più prese né nei comizi né in senato, ma
in riunioni private dei tre potenti cittadini, che con le loro amicizie influenti e le loro ricchezze
(Cesare le otteneva ormai dalla Gallia) si compravano i voti della maggioranza e intimidivano i
comizi e il senato con la violenza di piazza. Ma il loro accordo era destinato a sfasciarsi presto,
perché ognuno dei tre mirava al potere personale e assoluto.
Ciascuno scelse un diverso percorso per ottenerlo.
Cesare gioca la carta della Gallia (56 a.C.)
Tornato in Gallia, con la sua eccezionale abilità propagandistica, Cesare intraprese una serie di
azioni militari che non ebbero conseguenze pratiche, ma suscitarono una straordinaria meraviglia a
Roma e fecero salire la sua fama alle stelle. Tanto più che egli seppe usare un magnifico mezzo di
comunicazione che, in mancanza di internet, svolgeva perfettamente la stessa funzione: la
letteratura. Con la prosa limpida, essenziale e apparentemente oggettiva, con l’uso di un narratore
esterno che non dice mai “io”, neppure parlando di se stesso, Cesare racconta le sue imprese nei
Commentarii de bello gallico, in cui mette in luce la propria straordinaria abilità di generale ed
esalta il valore dei suoi soldati, di cui cita spesso anche il nome: quale strumento migliore per farsi
adorare dalle truppe? E a Roma la sua fama dilagò.
scheda tra storia e lett.
Imprese da propaganda (55-54 a.C.)
Cesare era infaticabile. «Dormiva per lo più in carri o in lettighe, utilizzando il riposo per l’azione,
di giorno andava a controllare i presidi, le città, le fortificazioni, e gli stava vicino uno schiavo di
quelli abituati a scrivere sotto dettatura anche durante il viaggio» (Plutarco).
Nel 55 a.C., dato che «aspirava alla gloria di essere il primo uomo ad attraversare il Reno con un
esercito» (Plutarco, 22), bloccò l’avanzata di due popoli germanici che tentavano di oltrepassare il
Reno, facendo costruire in soli dieci giorni un ponte di legno, su cui condusse le truppe in territorio
nemico, fece un’incursione poco più che dimostrativa e dopo 18 giorni tornò indietro e distrusse il
ponte.
Nel 55, una prima volta, e nel 54, una seconda, fece sbarchi esplorativi in Britannia, l’isola abitata
anch’essa da popolazioni celtiche, e raggiunse il Tamigi per punire una tribù guidata da
Cassivelauno che aveva aiutato i belgi nel 57. In realtà voleva soprattutto stupire i suoi concittadini,
avventurandosi in una terra del tutto sconosciuta e tanto a nord, da essere posta ai confini della
terra: alcuni ne negavano addirittura l’esistenza. «Mentre si accingeva a far la traversata [di ritorno]
lo raggiunse una lettera inviatagli dagli amici di Roma, che gi annunciava la morte di sua figlia: ella
era morta di parto in casa di Pompeo». Si sciolse così la relazione di parentela che sembrava
garantire la pace tra i due triumviri.
Lo scontro con un eroe (53-52 a.C.)
Cesare non aveva fatto i conti con l’orgoglio delle popolazioni celtiche e il senso di indipendenza
che le spinse a creare, nell’inverno del 53-52 a.C., una grande coalizione di popoli gallici, cui si
unirono persino gli edui, tradizionali alleati dei romani. A guidarla era una personalità di grande
valore, Vercingetorìge, un giovane nobile del popolo dei arverni, che si era assicurato l’appoggio
dei druidi. Malgrado il coraggio e l’intraprendenza di Vercingetorige, che diede a Cesare del filo da
torcere, alla fine egli fu costretto a rifugiarsi nella città fortificata di Alesia (vicino all’attuale
Digione). Mentre Cesare la cingeva d’assedio, giunsero 300.000 uomini da tutta la Gallia e Cesare
dovette combattere su due fronti per evitare che i due eserciti dei galli si congiungessero. Alla fine li
sconfisse e prese la città. «Il capo di tutta la guerra, Vercingetorige, indossò le sue armi migliori,
adornò il cavallo e uscì di gran carriera dal campo; compì un giro attorno a Cesare seduto e poi,
balzato di sella, si tolse l’armatura, si sedette ai piedi di Cesare e se ne stette tranquillo finché fu
dato da custodire per il trionfo» (Plutarco, 27).
Cesare si fermò in Gallia ancora un anno per liquidare i resti della rivolta: agì con un’insolita
severità nei confronti dei capi, che fece uccidere, ma con la sua abituale clemenza verso le
popolazioni. Ottenne così un’assoluta fedeltà dei galli anche per il futuro.
Il bilancio della guerra era di un milione di morti, di altrettanti prigionieri destinati alla schiavitù e
di una totale romanizzazione delle popolazioni celtiche della Gallia, che determinò la progressiva
scomparsa dell’identità originaria di un intero popolo.
L’opera di romanizzazione fu favorita dal fatto che Roma, in cambio del controllo politico e di una
contenuta pressione fiscale, garantiva la sicurezza dei fertili campi della Gallia sottoposti alla
costante minaccia di razzie di germani. I galli, che vivevano di agricoltura, trovarono quindi
vantaggioso non ribellarsi mai più al dominio romano.
2.4 La fine del triumvirato
Crasso mira all’Oriente (54-53 a.C.)
Proconsole in Siria, Crasso sperava di condurre una campagna vittoriosa contro il popolo dei parti.
Nella loro espansione i parti vennero inevitabilmente in contatto coi romani: Crasso avrebbe dovuto
fermare la loro marcia verso occidente. Ma il suo esercito fu sconfitto a Carre, in Mesopotamia, nel
53 a.C., ed egli stesso fu ucciso dal generale nemico mentre trattava la resa: la sua testa mozzata fu
inviata a decorare una scena teatrale. Il ricordo del gesto orrendo e della battaglia che era costata la
vita a 20.000 soldati romani rimase uno dei più dolorosi nella storia di Roma. Per di più le insegne
dei romani erano rimate in mano ai nemici, un’onta intollerabile per Roma.
Memo
Stanziati originariamente nella regione a nord del mar Caspio, i parti erano calati fino all’altopiano
iranico ed erano stati sottomessi agli assiri, poi ai medi e quindi ai persiani. Erano finiti sotto
Alessandro e poi inglobati nel regno ellenistico di Siria, da cui si erano resi indipendenti intorno al
250 a.C., espandendosi fino all’Indo a est e alla Mesopotamia a ovest e costituendo un impero, forse
come federazione di regni. In una posizione chiave, perché sul loro territorio passava la via della
seta e delle spezie, essi divennero intermediari insostituibili nel commercio tra la Cina, l’India e il
Mediterraneo e si arricchirono imponendo dazi sulle merci in transito e impedendo che greci e
romani entrassero in contatto diretto con i popoli orientali.
Dida su cavalieri parti
La forza dei parti erano le schiere di cavalieri corazzati, che montavano cavalli nisei di taglia
straordinaria e enorme potenza e velocità, affiancati dalla cavalleria leggera di arcieri abituati a
cavalcare e a tirare con l’arco nelle aride e sterminate pianure dell’altopiano iranico sin da bambini.
Pompeo gioca in casa (54-50 a.C.)
Pompeo si era fatto dare un esercito per governare la Spagna, ma invece era rimasto a Roma e la
sue province spagnole le governava tramite legati. La sua scelta era stata dettata dalla volontà di
avvicinarsi sempre di più al senato e si rivelava più che mai proficua ora che Cesare imperversava
con le sue imprese eroiche e Crasso era fuori gioco. I disordini in città si facevano sempre più
violenti, e sorge il dubbio che fossero alimentati proprio da Pompeo.
Per il 54 4 il 53 non fu neppure possibile eleggere i consoli. Nel 52 Clodio rimase ucciso in uno
scontro con le bande di Milone e i sostenitori di Clodio appiccarono il fuoco alla curia, la sede del
senato. Il senato nominò Pompeo console sine collega, con una scelta che violava un principio
fondamentale della costituzione romana, la collegialità, tesa a impedire la concentrazione del potere
nelle mani di uno solo. Di fatto Pompeo diventava un dittatore, ma la parola era impronunciabile e
odiosa, dopo l’esperienza di Silla.
Il senato non si fidava di Pompeo, però voleva battere Cesare a tutti i costi, così gli permise anche
di arruolare un esercito, con la scusa di ristabilire l’ordine in città, e gli prorogò la carica di
proconsole in Spagna per altri cinque anni, fino al 46 a.C.: la concentrazione di potere nelle mani di
Pompeo, console sine collega a Roma e proconsole in Spagna, era assolutamente fuori da ogni
regola.
Come bloccare Cesare (49 a.C.)
La forza di Cesare era immensa: un esercito forte di dieci legioni agguerrite e fedelissime, pronte
a tutto per un generale che sapeva apprezzare il valore persino dei soldati semplici, che prometteva
grandi vittorie e lasciava sperare in ricche ricompense; l’appoggio del popolo che vedeva in lui un
idolo; il sostegno dei populares, che speravano da lui un rinnovamento dello Stato, ne facevano
l’eroe del momento. Al termine del proconsolato, che cadeva il 1 marzo del 49 a.C., il generale
intendeva proporre la propria candidatura per un secondo consolato. Il senato poteva riporre la
speranza di evitare una simile sciagura solo in Pompeo. Su suo suggerimento emanò una legge che
stabiliva che per candidarsi occorreva essere presenti a Roma. Cesare avrebbe dovuto rinunciare al
proconsolato già nel 50, sciogliere le legioni, perché non si poteva superare il pomerium con un
esercito in armi, e a Roma si sarebbe quindi trovato in balia di Pompeo, che, invece, con la scusa
dell’ordine pubblico, poteva tenere un esercito accampato alle porte della città. La soluzione poteva
essere quella avanzata da un tribuno, che chiedeva a Pompeo di congedare anche lui le sue truppe e
il senato, che voleva evitare una prevedibile guerra civile, sembrava d’accordo. Ma l’esercito di
Pompeo era minacciosamente vicino a Roma. Il senato preferì allora cedere e ordinò solo a Cesare
di congedare il proprio esercito.
Come Cesare non si fece bloccare (49 a.C.)
La decisione che allora prese Cesare è passata alla storia con una frase, tramandata dalla tradizione,
e divenuta emblematica: alea iacta est, “il dado è tratto”, la decisione è presa, non si può tornare
indietro e niente può più essere come prima. La decisione era quella di oltrepassare con l’esercito in
armi il pomerium, fissato da Silla al Rubicone. Cesare, acquartierato con l’esercito presso Rimini,
aveva continuato ad avanzare proposte di accordo al senato, ma di fronte ai suoi ostinati rifiuti,
prese infine la decisione estrema. Era la notte tra il 10 e l’11 gennaio del 49 a.C. e scoppiava in
quel momento un’altra guerra civile. Anche su questa guerra Cesare scrisse, nei Commentarii de
bello civili, le sue memorie, assai più drammatiche di quelle della guerra gallica.
2.5 De bello civili (49-48 a.C.)
La fuga dei repubblicani
Pompeo si accorse di non avere a disposizione un esercito fedele quanto quello di Cesare, benché
potesse contare sul doppio delle truppe, e ancor prima che Cesare arrivasse preferì fuggire con la
gran parte degli ottimati. Lo seguirono anche alcuni sostenitori di Cesare colti dal panico; persino
«Labieno, uno dei più fidati amici di Cesare, che era stato suo legato e con estremo coraggio aveva
combattuto al suo fianco in tutte le guerre galliche, in quel momento lo abbandonò e fuggì presso
Pompeo; Cesare gli mandò dietro il denaro e il bagaglio» (Plutarco, 34).
Si imbarcarono da Brindisi verso la Grecia, dove Pompeo contava, per raccogliere un esercito, di
sfruttare le relazioni che aveva stabilito coi sovrani orientali all’epoca della guerra mitridatica.
Poteva contare anche su sette legioni stanziate in Spagna, la fedeltà della provincia d’Africa, dove si
era recato Catone, e l’alleanza con il re di Numidia Giuba. Il suo piano era quello di bloccare i
rifornimenti diretti a Roma, mettendo in seria difficoltà Cesare, ma la rapidità del nemico non gli
diede la possibilità di realizzarlo.
L’inseguimento
Cesare marciò verso sud, mentre «le città si aprono dinanzi a lui e lo salutano come un dio», scrisse
Cicerone, e Cesare le ripagava evitando epurazioni e saccheggi e promettendo ai suoi soldati una
ricompensa solo alla fine della guerra. Cercava in questo modo di evitare la guerra civile,
dimostrando che il conflitto non era tra Cesare e il popolo, ma contro Pompeo. Nel contempo
tentava ancora la via della riconciliazione.
Arrivato a Brindisi, la conquistò il 18 marzo del 49, ma non riuscì ad inseguire Pompeo, che era
salpato il giorno prima, perché non aveva navi a sufficienza.
Marciò quindi verso Roma e vi entrò il 31 marzo, lasciando l’esercito fuori dalla città: era fuori
legge, ma rispettava ancora le tradizioni, anche se poi si fece consegnare con le minacce il tesoro
pubblico per mantenere il suo esercito.
Quindi corse in Spagna, per assicurarsi il rifornimento di grano ed evitare che le sette legioni di
Pompeo accampate nella penisola diventassero l’altro braccio della tenaglia con cui il nemico
avrebbe potuto schiacciarlo. La campagna durò 40 giorni, tra aprile e agosto. Malgrado le numerose
difficoltà, alla fine Cesare sbaragliò i pompeiani e ancora una volta fu generoso: accolse la parte
dell’esercito pompeiano che si era arresa ed era passata dalla sua parte, congedò quelli che non
volevano seguirlo, riorganizzò le province e ripartì.
Nel novembre del 49, a Roma, si fece eleggere console per il 48, mise ordine nello stato, senza
processi, né confische, né bandi.
Poi radunò a Brindisi un centinaio di navi, 22.000 soldati e 1000 cavalieri e, benché fosse inverno e
il mare fosse pattugliato dalla flotta di Pompeo, il 4 gennaio del 48, li traghettò in Grecia.
Pompeo, che pure poteva contare su quasi 45.000 fanti e 7.000 cavalieri, evitò per mesi di
scontrarsi con Cesare, in attesa del momento e del luogo più propizi.
Cesare continuò invece a mostrarsi disponibile al dialogo e a tentare un accordo, ma i suoi legati
furono sempre rinviati indietro.
La battaglia di Farsalo (9 agosto 48 a.C.)
Giunto in Tessaglia, Pompeo era certo della vittoria e già tutti i suoi collaboratori «si
affaccendavano per accaparrarsi cariche o premi in denaro, o cercavano il modo di vendicarsi dei
propri nemici, e non pensavano ai mezzi per vincere, ma a come sfruttare la vittoria» (Cesare,
d.b.c., LXXXIII).
Lo scontro avvenne infine il 9 agosto del 48 a.C. a Farsàlo, in Tessaglia. La battaglia fu il
capolavoro di Cesare, che perse solo 200 uomini, uccise 15000 nemici, ne catturò 20.000, ma
ordinò di risparmiarli. Il suo intento era sempre quello di mostrarsi clemente verso il nemico vinto e
pronto alla pacificazione.
La morte di Pompeo
Pompeo fuggì in Egitto, stato vassallo di Roma, dove regnava il giovane Tolomeo XIV, di soli
tredici anni, sposato con la sorella ventenne Cleopatra. Il matrimonio tra fratelli era una
consuetudine della dinastia dei Lagidi, che, pur essendo ellenistica, aveva mutuato le tradizioni dei
faraoni egizi. I due fratelli, per testamento del padre, Tolomeo XIII Aulete, avrebbero dovuto
governare insieme, ma cercavano di sopraffarsi a vicenda. Il giovane Tolomeo, appoggiato e
sobillato dai suoi consiglieri, aveva cacciato Cleopatra dall’Egitto. Rifugiatasi in Siria, ella aveva
intrapreso una guerra contro il fratello.
Pompeo, che sperava nell’amicizia del re, ricevette invece una pessima accoglienza: fu accolto con
apparente benevolenza dai suoi consiglieri, ma, salito su una barca per raggiungere la corte del
sovrano, venne da loro assassinato. La sua testa imbalsamata fu poi presentata a Cesare, quando, a
settembre, raggiunse anch’egli Alessandria.
Nel 59 a.C., durante il consolato di Cesare, Roma aveva fatto un’alleanza con Tolomeo Aulete, che
era stato perciò dichiarato, con una legge e un decreto del senato, socius et amicus populi Romani.
Cacciato dal suo regno da una sedizione popolare, nel 57 Tolomeo aveva invocato l’aiuto di Roma e
Pompeo aveva fatto in modo che fosse ricollocato sul trono.
Cesare in Egitto
Cesare non gradì affatto che un romano fosse stato ucciso da uno straniero, tanto più che egli era
solito graziare i nemici. Fu forse per punire Tolomeo o forse perché fu immediatamente attratto, lui
cinquantaduenne, dalla ventenne Cleopatra, che affidò a lei il governo dell’Egitto. L’esercito di
Tolomeo però attaccò Cesare e scoppiò la guerra. Negli scontri un incendio devastò la famosissima
biblioteca di Alessandria e distrusse 400.000 volumi o, secondo altre fonti, 700.000. Cesare si
fermò nove mesi per sedare la rivolta e riprendere il controllo dell’Egitto. Fino al giugno del 47
a.C., rimase quindi presso Cleopatra ed ebbe da lei un figlio, chiamato ironicamente dalla gente
Cesarione (che in greco è un diminutivo e si potrebbe tradurre con “Cesarino”!).
Veni, vidi, vici
Poi fu costretto a lasciarla, per correre in Asia Minore dove il figlio di Mitridate e re del Bosforo,
Farnace, aveva approfittato dell’assenza di Cesare per tentare di riprendersi il regno del Ponto. Con
una campagna militare rapidissima lo sconfisse il 2 agosto del 47 a Zela e annunciò la vittoria al
suo amico Mazio, con una celebre frase, modello insuperabile di concisione: Veni, vidi, vici, “Sono
arrivato, ho visto, ho vinto”, con cui volle sottolineare orgogliosamente la fulmineità della propria
azione. Il motto fu poi trascritto su un cartello e portato in corteo durante il trionfo nel 46.
Cesare in Numidia
Intanto i pompeiani guidati da Catone il Giovane avevano organizzato la resistenza in Numidia
presso il re Giuba. Cesare li raggiunse e li massacrò nella battaglia di Tapso (46 a.C.). I pochi
superstiti, tra cui i figli di Pompeo, Gneo e Sestio, si rifugiarono in Spagna, Giuba si uccise e la
Numidia divenne provincia romana col nome di Africa Nova. Era una zona così vasta e fertile che
avrebbe fornito ogni anno all’erario milioni di chilogrammi di grano e di litri d’olio.
Catone cercò di resistere con un presidio a Utica, ma, quando vide che era impossibile, si uccise..
Passò alla storia come Catone l’Uticense e la sua figura divenne l’emblema della lotta a difesa
della libertà contro la dittatura, anche se la sua idea di libertà era quella dell’antica aristocrazia
romana. Dante, nella Divina Commedia, lo porrà come custode del Purgatorio, dove l’uomo si
libera dal peccato.
Cesare a Roma e in Spagna
In Spagna i figli di Pompeo, Gneo e Sesto, con i veterani del padre, che avevano ripreso le armi
dopo la sconfitta subita nel 49 e avevano costituito un nucleo di resistenza repubblicana,
impedivano nuovamente i rifornimenti di grano a Roma.
Ma prima di passare in Spagna, Cesare, nell’agosto del 46, tornò a Roma a celebrarvi ben quattro
trionfi: sui galli, sugli egiziani, su Farnace e su Giuba. Nel primo di essi sfilò, trascinato in catene
davanti al carro del vincitore, l’eroe della Gallia, Vercingetorìge, che subito dopo il trionfo fu
giustiziato o, come si diceva, sacrificato agli dei.
Dopo i trionfi Cesare organizzò per il popolo splendidi banchetti – in uno dei quali c’erano ben
22.000 triclini – spettacoli gladiatori e naumachie in ricordo della figlia Giulia.
Poi corse in Spagna a sconfiggere gli ultimi pompeiani, alleati con le popolazioni dei celtiberi e dei
lusitani, sempre ribelli al dominio di Roma. La loro resistenza pose non pochi problemi ai romani,
ma fu vinta infine nella battaglia di Munda nel 45 a.C.
2.6 Cesare padrone di Roma e… del mondo
Nuovi titoli e nuovi diritti
Completata in alcuni mesi la sottomissione della Spagna, Cesare tornò a Roma nel settembre del
45 a.C., in compagnia di Cleopatra, che, incurante delle critiche, egli trattenne a Roma fino alla
propria morte.
Aveva condotto la sua ascesa attraverso guerre e battaglie, rivelandosi un condottiero eccezionale,
ora doveva consolidare il suo potere, che lo rendeva padrone di Roma come un monarca, rientrando,
in un certo senso, nella legalità. Assommava già una serie di magistrature: dal 63 era pontefice
massimo, una carica che gli permetteva di controllare e manovrare gli auspici, quindi di indirizzare
le decisioni politiche della città; dal 49 al 45 a.C. si era fatto eleggere console quattro volte e dal 45
il senato gli concesse il consolato per altri 10 anni; dal 48 aveva assunto la dittatura, prima
annuale, poi decennale; ma fu anche censore per tre anni.
Una volta tornato a Roma, dopo la battaglia di Munda, ottenne:
il titolo di padre della patria (come Cicerone, dopo la scoperta della congiura di Catilina) e
di imperator e il diritto di indossare sempre la toga di porpora e la corona d’alloro, che i
generali vittoriosi potevano indossare solo il giorno del trionfo;
il diritto di sedere in senato su un seggio dorato, di presiedere i comizi e di scegliere le
province da assegnare ai propretori;
la tribunizia potestas, con il diritto di veto e l’inviolabilità prerogativa dei tribuni, per cui
la sua persona divenne sacra;
una statua tra quelle dei re di Roma e monete con la sua immagine;
la dedica del mese quintile, il quinto dall’inizio dell’anno secondo l’antico calendario
romano, che cominciava a marzo. Da allora il mese fu chiamato iulius (il nostro luglio).
Cesare provvide però a modificare radicalmente il calendario, che non coincideva più da molto
tempo con le cadenze delle stagioni. Con la consulenza di un astronomo greco di Alessandria,
Cesare creò un calendario di 365 giorni con un anno bisestile ogni quattro anni. Con le leggere
modifiche effettuate da papa Gregorio XIII nel 1582, il calendario giuliano è quello che usiamo
ancora oggi.
Un politico saggio (44 a.C.)
Oltre che ottimo stratega in guerra, Cesare si rivelò uomo di governo accorto, in grado di trovare
soluzione ai problemi ormai non più rinviabili e di avviare una politica di riforma dello Stato. Per
poter agire liberamente, nel 44 a.C. decise di farsi nominare dittatore a vita, ma diede alla parola
un diverso significato rispetto a quello che aveva assunto con Silla.
In politica estera:
volle avviare una più solida integrazione tra Roma e le province, che costituirà col
tempo la forza dell’Impero: concesse, infatti, la cittadinanza di diritto latino alla Sicilia,
la cittadinanza romana agli abitanti dell’antica colonia fenicia di Gades, in Spagna, e alla
Gallia Cisalpina, che si era rivelata alleata fedele e immise alcuni capi tribù in senato
(suscitando, ovviamente, scandalo tra i tradizionalisti);
pose sotto stretto controllo l’attività dei pubblicani, stabilendo con precisione
l’ammontare dei tributi che dovevano riscuotere, per evitare le ruberie e la vessazione
scandalosa delle province;
riprese con vigore la legge sui reati di concussione e, in molti casi, sostituì l’appalto
delle imposte con la riscossione diretta, eseguita dalla stessa comunità dei contribuenti,
sotto la sorveglianza di magistrati statali.
In politica interna:
richiamò dall’esilio e graziò gli esponenti dell’aristocrazia senatoria, che lo avevano
avversato, evitando inutili stragi, e li coinvolse nella gestione dello stato con
l’attribuzione di magistrature e incarichi importanti;
per garantire migliore efficienza alla burocrazia, ampliò il numero dei magistrati, edili,
pretori e questori che portò a 40;
rinnovò il senato: aumentò il numero dei senatori a 900 membri, immettendovi, oltre ai
galli, anche esponenti delle aristocrazie italiche e uomini di sua fiducia. Ne smorzò, in
questo modo, l’avversione alla sua politica e poté controllarlo meglio.
…e un saggio economo
In campo economico, Cesare affrontò il problema del proletariato urbano che sovraffollava Roma,
con gravi problemi di ordine pubblico e di spese a carico dello stato, con vari provvedimenti. Sin
dal 49 aveva ridotto i debiti, per arginare l’impoverimento delle classi più svantaggiate; ora, per
favorire il ripopolamento delle campagne e frenare l’afflusso di nullatenenti in città, elargì
contributi alle famiglie numerose; ridusse della metà il numero (da 320.000 a 150.000) di coloro
che avevano diritto alle distribuzioni di grano, per non appesantire il bilancio dello stato, ma, in
compenso, creò nuove fonti di guadagno per debellare la povertà: per arginare il problema delle
rivolte servili e garantire altri posti di lavoro ai nullatenenti, decretò che almeno un terzo dei
pastori alle dipendenze dei grandi proprietari dovesse essere rappresentato da uomini liberi. Poi
distribuì terre a 80.000 capifamiglia, di cui molti erano suoi veterani, ma, per evitare confische ai
danni dei proprietari terrieri, fondò diverse colonie: in Gallia, per consentire la romanizzazione
della nuova provincia e il suo ripopolamento dopo la guerra; in Spagna per estendere la
romanizzazione già avviata; nel sito dell’antica Cartagine e di Corinto, entrambe distrutte nel 146
a.C., e ricostruite entrambe contemporaneamente. A Corinto avviò il taglio dell’istmo per ridurre il
percorso delle navi verso l’Oriente e favorire i commerci, anche con la fondazione di altre colonie
in Macedonia e sul lontano mar Nero. L’assegnazione di terre ai veterani nelle colonie rientrava
in un preciso disegno politico di Cesare, che sapeva quanto i soldati, per la vita che avevano
condotto, erano insofferenti e poco disponibili a reinserirsi in una vita borghese, sempre pronti alla
ribellione.
Avviò inoltre una serie di lavori pubblici, come la deviazione del corso del Tevere, perché
sfociasse più a sud e facilitasse i commerci; il consolidamento degli argini del fiume per evitare
straripamenti; la bonifica delle paludi pontine a sud di Roma, per aumentare la disponibilità di
terra coltivabile; l’edificazione di porti lungo il litorale di Ostia e la costruzione di edifici pubblici,
tesa a rendere grandiosa soprattutto la zona di maggiore visibilità della città:
risistemò il Foro,
costruì la Basilica Giulia, con una grande sala destinata alle attività commerciali e
giudiziarie;
edificò una nuova curia per il senato,
avviò la costruzione di un nuovo Foro, accanto al Foro romano ormai inadeguato alle
nuove esigenze della capitale del mondo. Il Foro di Cesare sarà il primo dei Fori
imperiali: al centro vi sorgeva il tempio di Venere genitrice, madre di Enea, fondatore
di Roma, ma anche capostipite della gens Iulia.
Tra i vari incarichi che Cesare assegnò all’aristocrazia senatoria, ci fu quello di creare la prima
biblioteca pubblica di Roma: lo affidò al coltissimo Terenzio Varrone, benché fosse
anticesariano e fautore di Pompeo.
2.7 Gli idi di marzo
Contro il dittatore che non volle farsi re (44 a.C.)
In un solo anno Cesare aveva ristabilito la pace e l’ordine, aveva migliorato le condizioni di vita
dell’impero romano, il popolo lo adorava, ma l’aristocrazia non si rassegnava a perdere il proprio
potere. Alcuni erano, per altro, convinti repubblicani e credevano ancora, come Catone, che solo la
repubblica potesse garantire la libertà. Cesare veniva da più parti accusato di voler fare di Roma
una monarchia di tipo orientale, spinto da Cleopatra, il cui figlio sarebbe potuto diventare l’erede
del padre. Cesare smentì simili voci quando rifiutò, alle idi di febbraio del 44 a.C., il giorno dopo
che gli era stata conferita la dittatura a vita, la corona che gli offriva il suo luogotenente Marco
Antonio. La folla applaudì calorosamente il suo rifiuto di farsi re.
Ma egli stava anche preparando una gigantesca spedizione contro i parti, per vendicare la sconfitta
di Crasso e contro i daci, stanziati lungo il Danubio, nell’odierna Romania: 16 legioni e 10.000
cavalieri erano concentrati nella penisola balcanica per la nuova campagna che avrebbe dovuto
offuscare le glorie del passato e garantire a Roma il controllo delle vie per l’Oriente con una
frontiera in continua espansione ed enormi benefici per lo sviluppo economico. Il dubbio era su
quanto ulteriore potere il generale avrebbe acquistato dopo la assai probabile vittoria.
Cesare deve morire
Il senato non proponeva alcun programma politico alternativo a quello del dittatore, ma voleva
assolutamente liberarsi di lui.
La congiura per ucciderlo fu organizzata da Caio Cassio Longino, che nutriva rancore verso Cesare
e attirò nel suo piano Marco Giunio Bruto, facendo leva, tra l’altro, sul suo nome, che era lo stesso
del nobile che aveva provocato la cacciata di Tarquinio il Superbo e liberato Roma dalla monarchia.
Bruto e Cassio erano entrambi pompeiani e repubblicani convinti. Pure, dopo la morte di Pompeo,
Cesare li aveva graziati e aveva concesso loro anche incarichi di prestigio, tra cui la pretura.
La morte eroica (15 marzo 44 a.C.)
È assai probabile che Cesare avesse sentore della congiura e non sarebbe potuto essere
diversamente, visto che nasceva nel suo stesso ambiente. Le fonti parlano di profezie, prodigi e
sogni premonitori, cui egli non avrebbe dato ascolto, ma è pensabile che invece avesse
consapevolmente scelto di andare incontro alla morte.
Il 15 marzo del 44 a.C., le idi di marzo secondo il calendario romano, Cesare si recò dunque alla
seduta del senato, che si svolgeva eccezionalmente in una sala vicina al teatro costruito da Pompeo.
Marco Antonio, il suo luogotenente che lo accompagnava, fu trattenuto con una scusa fuori dalla
sala, mentre nel teatro una squadra di gladiatori era pronta a dare man forte ai congiurati. All’entrata
di Cesare, i senatori si alzarono in piedi in segno di omaggio, ma i congiurati in parte si posero
dietro il suo seggio, in parte gli si avvicinarono come per fargli delle richieste e poi gli si
avventarono addosso coi pugnali. Quei senatori che non sapevano nulla della congiura rimasero
paralizzati dalla sorpresa e «non osavano né fuggire, né difendersi e neppure aprir bocca. Quando
ognuno dei congiurati ebbe sguainato il pugnale, Cesare, circondato, e ovunque volgesse lo sguardo
incontrando solo colpi e il ferro sollevato contro il suo volto e i suoi occhi, inseguito come una
bestia, venne a trovarsi irretito nelle mani di tutti […] anche Bruto gli inferse un colpo all’inguine.
Dicono alcuni che mentre si difendeva contro gli altri e urlando si spostava qua e là, quando vide
che Bruto aveva estratto il pugnale si tirò la toga sul capo e si lasciò andare», proprio ai piedi della
statua di Pompeo che sorgeva nel suo teatro. Fu allora che, rivolgendosi a Bruto, avrebbe
pronunciato le famose parole: «Tu quoque, Brute, fili mi!», “Anche tu, Bruto, figlio mio!”.
Ritratto di Bruto
A Bruto il dittatore era particolarmente legato, perché figlio di Servilia, una delle sue amanti, sorella
di Catone l’Uticense, ma l’ipotesi, da qualcuno avanzata, che fosse anche suo figlio non è
attendibile, perché Cesare aveva solo 15 anni più di Bruto. Nella frase famosa, in cui lo chiama
“figlio mio”, l’espressione sarà da intendersi quindi come “ragazzo mio”, “caro”. Il giovane Bruto
aveva subito l’influenza dello zio Catone il Giovane, sia nell’intraprendere studi filosofici sia nelle
idee politiche: la sua scelta di aderire alla congiura per uccidere il “tiranno” nasceva dalla stessa
esigenza di salvare la libertà repubblicana che aveva spinto Catone al suicidio.
Il Ris, il male sacro e il divino dittatore
L’omicidio di Cesare è uno dei delitti più famosi e carichi di mistero della storia. Troppi particolari
lasciano supporre che il dittatore, dotato di un enorme potere e circondato da tanti sostenitori, non
poteva essere all’oscuro delle trame che si tessevano nel suo stesso ambiente ed è improbabile che
fosse così poco accorto e così fiducioso nel senato da non dare ascolto alle minacce di morte che
negli ultimi tempi gli arrivavano da più parti. Perché allora si recò in senato quella mattina del 15
marzo e per di più senza scorta armata? E perché non aprì neppure il biglietto che gli fu consegnato
mentre si recava in senato, in cui gli si annunciava la morte?
L’assassinio delle idi di marzo ha attirato l’attenzione anche di un detective d’eccezione, Luciano
Garofano, comandante del Reparto di indagini scientifiche dei Carabinieri (Ris) di Parma, che ha
condotto la sua indagine basandosi su un attento esame delle fonti storiche.
Sin da ragazzo Cesare soffriva di epilessia, una malattia che gli antichi chiamavano “male sacro”,
perché la ritenevano inviata dagli dei. Provoca vertigini, convulsioni, perdita di conoscenza e
spasmi muscolari. Cesare, come scrive Plutarco, «non prese questa sua debolezza a giustificazione
di vita molle, anzi considerò l’attività militare una cura di questa debolezza, contrastando i suoi
malanni con lunghissime marce, mangiando frugalmente, dormendo sempre all’aperto, faticando»
(Plutarco, 17).
Scelta di morte
Con l’avanzare dell’età e degli stress cui Cesare era sottoposto, la malattia si era però aggravata e, a
56 anni, il dittatore sentiva di non poterla più controllare. Del resto anche le cure lo avrebbero
debilitato gravemente ed egli le rifiutò. Ma gli attacchi epilettici determinavano situazioni assai
imbarazzanti. Un giorno del 44 a.C., in senato, dove gli avevano decretato onori eccezionali,
quando gli si avvicinarono consoli e pretori e tutto il senato, egli non si alzò, probabilmente in preda
a un attacco epilettico. Ma questo irritò i presenti. La situazione stava quindi precipitando e il
dittatore forse volle evitare di mostrare la propria decadenza fisica, uscendo di scena ancora nel
pieno del suo potere, adorato dalle folle come un dio.
Proprio la congiura poteva essere sfruttata per dare alla sua morte un’aura sacra, e farlo apparire un
capro espiatorio, com’egli sottolineò consacrandosi agli dei col gesto di tirarsi la veste sul capo. Ma,
nello stesso tempo, egli sapeva che l’odio popolare, che il suo assassinio avrebbe scatenato contro i
suoi avversari, li avrebbe eliminati dalla scena politica – e la storia gli diede ragione: essi morirono
tutti entro i successivi tre anni – e avrebbe lasciato campo libero al successore che Cesare aveva già
designato nella figura del nipote. Forse non è un caso che solo pochi mesi prima di essere
assassinato avesse appunto modificato il proprio testamento, adottando e nominando suo erede il
giovanissimo Caio Ottavio, ma senza annunciare ufficialmente la decisione, com’era consuetudine.
Fu forse con queste idee in mente che partecipò, il giorno prima della morte, al pranzo a cui lo
aveva invitato Marco Emilio Lepido. Durante il convito, «caduto il discorso su qual fosse la morte
migliore, anticipò l’intervento di tutti esclamando: “L’inattesa”» (Plutarco, 63).
Poi, quella mattina del 15 marzo, dopo un’ultima titubanza, decise di uscire di casa e si avviò, nel
tripudio del popolo che lo acclamava, alla sua ultima seduta in senato. Non gli serviva aprire il
biglietto che gli annunciava la morte e che gli fu trovato ancora in mano: sapeva quello che c’era
scritto.
Regista anche dopo la morte (44 a.C.)
Quel che accadde dopo la sua morte forse Cesare se l’era immaginato. Bastava conoscere la
situazione per prevedere che l’esercito sarebbe rimasto fedele ai suoi luogotenenti e, in particolare
ad Antonio, che, per altro, era parente di Cesare per parte di madre e condivideva con lui il
consolato del 44 a.C. Bruto fece l’errore di non eliminarlo, pensando che bastasse avere ucciso il
dittatore.
La folla del popolo e dei veterani piangeva la morte di colui che aveva dato loro nuove prospettive
di vita e minacciava di vendicarla con la violenza. I cesaricidi, che speravano di essere proclamati i
liberatori di Roma dalla tirannide, spaventati dalla reazione popolare, si rifugiarono in Campidoglio.
Il senato, in questo contesto, non osò abrogare le decisioni di Cesare già attuate o in fase di
realizzazione, ma non prese neppure provvedimenti contro i suoi uccisori.
I leaders dei cesariani, Marco Antonio, console, e Marco Emilio Lepido, governatore della
Spagna Citeriore e pontefice massimo, che detenevano ora il potere e pretendevano di essere gli
eredi della politica di Cesare, non osavano però rompere i rapporti col senato. Antonio, anzi, nella
seduta del senato del 17 marzo, lasciò che fosse concessa l’immunità ai cesaricidi e che essi
fossero celebrati con onori pubblici. Ma, nello stesso tempo, pretese che fosse data lettura pubblica
del testamento di Cesare, fossero rispettate le sue volontà e fossero tributati solenni onori funebri
al dittatore morto.
Il funerale di un dio (20 marzo 44 a.C.)
Quando, il 18 marzo, Antonio lesse pubblicamente il testamento in cui Cesare destinava 300
sesterzi a ogni proletario romano e a ogni legionario, e i suoi giardini, che si estendevano oltre il
Tevere, a tutto il popolo di Roma, la folla andò in delirio. Per di più si scoprì che Cesare aveva
adottato e nominato suo erede il nipote (nato nel 63 a.C. da una figlia di sua sorella Giulia). Il
ragazzo, Caio Ottavio, che con l’adozione, com’era consuetudine, modificò il suo nome in Caio
Giulio Cesare Ottaviano, aveva allora solo 19 anni, ma aveva già combattuto a fianco di Cesare
nella battaglia di Munda, e ora si trovava in Epiro pronto a partire con la spedizione che Cesare
aveva preparato contro i parti.
Quando il 20 marzo, la salma di Cesare fu portata nel Foro, per i solenni funerali di Stato e la sua
divinizzazione, Marco Antonio pronunciò l’elogio funebre e poi, «afferrate le vesti di Cesare, le
spiegò in alto, insanguinate com’erano, mostrò gli squarci prodotti dai pugnali, tutte ferite che
Cesare aveva ricevuto. La cerimonia degenerò in disordine aperto». Il popolo, in preda al dolore, si
diede ad atti di violenza: dal rogo su cui bruciava il corpo di Cesare afferrò tizzoni accesi e diede
fuoco alle case dei congiurati.
Sul luogo del rogo si avviò subito la costruzione di un tempio al Divo Giulio.
UNA NUOVA CULTURA
Lo stato di guerra civile quasi permanente, in cui a tenere le redini del potere erano singoli
comandanti militari che si dedicavano a tempo pieno alla politica e basavano la propria forza su
eserciti fedeli solo a loro, aveva escluso da tempo i comuni cittadini dalla politica attiva. Emarginati
dalla sfera pubblica essi sempre più si erano rifugiati nel privato.
La cultura risentiva pesantemente di questa situazione sociale: da un lato si sviluppò l’arte oratoria,
necessaria a chi si occupava di politica, dall’altro la poesia e la filosofia davano voce ai sentimenti,
al disagio, alla ricerca di consolazione per la frustrazione conseguente all’esclusione del cittadino
dalla vita politica. Ma anche i politici in realtà spesso cercarono nella letteratura e nella filosofia
l’espressione dei propri ideali e dei progetti che cercavano di realizzare. Lo stesso Cesare fu un
grande storico delle proprie imprese, come abbiamo visto, e Cicerone, il grande oratore, non poté
fare a meno della filosofia.
L’oratore più grande
La vita di Cicerone fu, infatti, amareggiata da profonde delusioni. Spinto dall’idea eroica di salvare
la gloriosa repubblica aristocratica di un tempo, era convinto che proprio un oratore dotato di
grande cultura, studioso di filosofia, esperto di diritto, impegnato politicamente rappresentasse
l’ideale del capo di stato. E in questa figura ideale Cicerone intendeva calarsi. La sua vita fu quindi
dedicata al bene pubblico, ma nello stesso guidata dall’aspirazione di affermare la propria
individualità. La sua sete di gloria fu però continuamente frustrata, a partire dalla denuncia della
congiura di Catilina, per la quale non ottenne i riconoscimenti sperati. Quando nel 60 a.C. i
triumviri cercarono poi di attrarlo nell’intesa che non condivideva, egli rifiutò e si ritrovò
politicamente isolato. Esiliato poco dopo, nel 58 a.C., dai populares, fu fatto rientrare dagli
optimates l’anno seguente su un carro dorato tra splendidi festeggiamenti, ma dovette lottare perché
gli fossero restituiti, almeno in parte, i beni confiscati con l’esilio. Durante la guerra civile tra
Cesare e Pompeo, parteggiò per quest’ultimo e solo la generosità di Cesare gli permise di salvarsi.
Nella vita privata, poi, il divorzio da Terenzia e da una seconda moglie e poi soprattutto la morte
dell’amata figlia Tullia, lo addolorarono tanto che si isolò dalla vita politica cercando conforto nella
filosofia. Ma dopo l’assassinio di Cesare volle compiere l’estremo tentativo di salvare la repubblica,
appoggiando il suo successore Ottaviano. Fallì anche quest’ultimo eroico sforzo che si concluse con
il suo assassinio nel 43 a.C.
Opere illuminanti
L’ampio epistolario, le numerose orazioni, le opere politiche e gli scritti filosofici di Cicerone non
solo ne fecero uno dei letterati più importanti di Roma, ma forniscono ancora oggi un quadro
dettagliatissimo della vita dell’ultima fase della repubblica romana, non solo nella sua sfera
pubblica. Soprattutto le numerosissime lettere all’amico Attico e ai familiari contengono
annotazioni di vita quotidiana e di avvenimenti che offrono uno spaccato di vita reale estremamente
interessante.
Catullo, i poetae novi
Di continui riferimenti alla vita sociale dell’epoca sono infarcite anche le opere dei poeti dell’età di
Cesare. Una generazione di poeti giovani, aristocratici, trasgressivi, impregnati di cultura ellenistica
che, al contrario di Cicerone, cantavano il disimpegno dalla politica e mettevano al primo posto il
mondo privato degli affetti, gli amori, i divertimenti, l’amicizia e la letteratura. Vivevano in una
cerchia ristretta in cui tutti si conoscevano, a cui partecipavano anche le donne come giudici delle
loro poesie, ma talvolta anche come poetesse esse stesse. Erano scelte di vita le loro che non
potevano piacere al modello del perfetto civis romanus qual era Cicerone, che per loro adottò
l’epiteto spregiativo di neóteroi in greco, poetae novi in latino.
Le poesie di questi poeti erano leggere, quasi scherzi, nugae, “poesiole”, come le definivano essi
stessi. Impregnati di raffinata cultura greca, i “poeti nuovi” amavano la brevità di contro
all’ampiezza dei poemi, l’erudizione mitologica, la rielaborazione di testi di antichi poeti greci,
come Saffo, l’estrema cura formale dello stile. I risultati più alti raggiunti da Catullo (84-54 a.C.), il
più grande dei neóteroi, morto a soli trent’anni, difficilmente sono stati eguagliati nei secoli, per la
capacità del giovane poeta latino di cantare l’amore come passione lacerante eppure espressa con
l’estrema raffinatezza della forma.
Come sopravvivere alla crisi
Spesso si ritiene che i poetae novi fossero influenzati dall’epicureismo, la filosofia ellenistica che
propugnava il disimpegno dalla vita pubblica e la chiusura nel proprio privato. Se non possiamo
essere certi di questa ipotesi, di sicuro sappiamo invece che ad essere influenzato dalle teorie di
Epicuro fu un altro grande poeta, Lucrezio. Egli seppe trasformare in grande poesia anche le fredde
teorie filosofiche e, se pure sosteneva che il saggio non deve lasciarsi sconvolgere dalle passioni,
dal dolore, dalla paura della morte – perché l’anima, come tutto il resto, è costituita da atomi, che si
disgregano insieme al corpo – Lucrezio diede voce all’ansia di un secolo tormentato da un profondo
pessimismo e insieme da un bisogno di verità e di pace. Secondo Lucrezio, l’uomo, abbandonato
dagli dei, che sono perfetti, ma vivono lontani dall’imperfezione della materia e si disinteressano
perciò degli uomini, deve ricercare il piacere, inteso come “assenza di dolore” e consapevolezza dei
beni che la vita offre e di cui deve godere con moderazione. Ma accanto all’esaltazione della vita
che il poeta canta descrivendo l’avvento della primavera nel bellissimo proemio dedicato a Venere,
dea della generazione ciclica degli esseri viventi, Lucrezio crea alla fine pagine indimenticabili e
drammatiche sugli orrori della peste di Atene del 430 a.C., come a preannunciare quanto avverrà
alla fine dei tempi.
La fine di Cicerone
Esiliato nel 58 dai populares, fu fatto rientrare dagli optimates l’anno seguente su un carro dorato
tra splendidi festeggiamenti e gli furono in parte restituiti i beni confiscati con l’esilio. Durante la
guerra civile tra Pompeo e Cesare, parteggiò per il primo, ma dopo la vittoria Cesare gli concesse il
perdono. Dopo il divorzio da Terenzia e la morte della figlia Tullia, si isolò dalla vita politica
cercando conforto nella filosofia, ma dopo l’assassinio di Cesare nel 44 a.C., ritornò alla politica
nell’estremo tentativo di salvare la repubblica contro le mire di Marco Antonio. Ma furono proprio i
suoi sicari che il 7 dicembre del 43 raggiunsero Cicerone che cercava di fuggire per mare dalla sua
villa di Gaeta. Ma per il timore della traversata in un mare in tempesta e della difficoltà della fuga
Cicerone sporse la testa fuori della lettiga per offrirla alla spada del sicario che lo uccise. La sua
tesa fu esposta sui rostri, la tribuna oratoria da cui aveva declamato tante volte le sue orazioni
insieme alle mani con cui aveva scritto le orazioni contro Antonio.