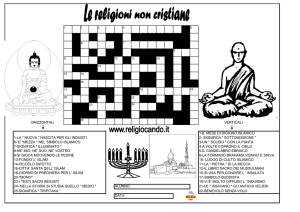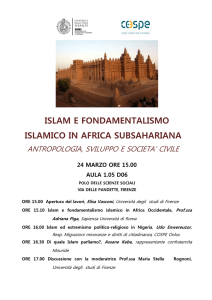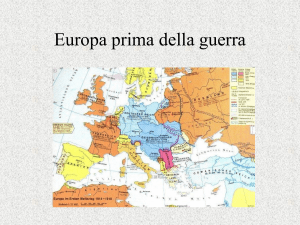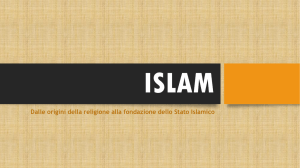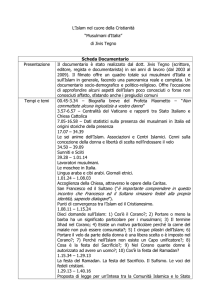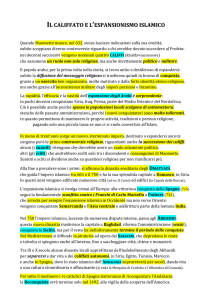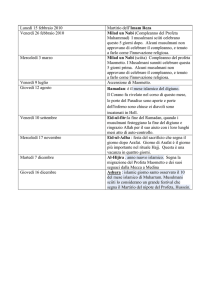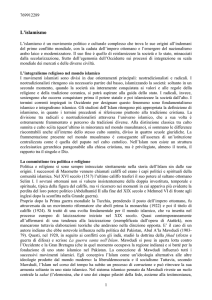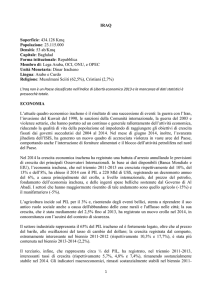DAESH
DOSSIER SULLO “STATO ISLAMICO”
© GSCATULLO
Daesh
Dossier sul sedicente “Stato Islamico”, sulla situazione culturale e storico -politica che ne ha
permesso la nascita.
Michela Loguercio – Erica Trotta – Paolo Franchi
Prefazione
Introduzione e struttura
Questo dossier è composto da oltre ventiduemila parole, disseminate in una quarantina di pagine, e cerca di
analizzare con completezza l’intera questione dello “Stato Islamico” e più in generale del fondamentalismo
islamico. Il lavoro è stato con dotto da tre ragazzi del quinto anno: Michela Loguercio, Erica Trotta e Paolo
Franchi, che si sono occupati di curare rispettivamente: un approfondimento sulla cultura islamica, un’analisi
della storia del Medioriente nel Novecento e l’analisi dei fatti recenti.
Sicuramente su Daesh e sul fenomeno dell’integralismo e del terrorismo islamista non si è detto tutto, e
questo documento non ha certo la pretesa di esaurire ogni informazione sull’argomento, più che altro di
essere una solida base di partenza, per la varietà delle fonti e dei temi, per iniziare a conoscere la questione
e così a riflettere. Dunque buona lettura e buon informazione!
Perché “Daesh”?
Il titolo di questo dossier, Daesh, potrebbe apparire certamente meno familiare di ISIS, ISIL o IS, ma c’è un
motivo che ha orientato la scelta del titolo e che è condiviso da alcuni giornalisti internazionali. “Ai piani alti”
dell’informazione c’è in effetti chi si è domandato con quale nome riferirsi all’organizzazione terroristica Stato
Islamico, di cui tratta il presente dossier.
Daesh è l’acronimo arabo di Stato Islamico dell’Iraq e del Levante, ma la sua pronuncia ha un suono simile a
quello del verbo arabo calpestare, schiacciare ed è utilizzato per questo in senso denigratorio. Inoltre il nome
Daesh non esplicita nella nostra lingua la dignità di stato che essi pretendono – e abbiamo cercato di utilizzare
il “virgolettato” quando ricorriamo al termine stato ad essi riferito – ed è più internazionale di ISIS che ha
invece origine anglofona.
La Cultura Islamica
L’Islam
Introduzione
L’islam, così come l’ebraismo e il cristianesimo, è una religione monoteista, professa cioè la fede in un Dio
unico. Islam (“sottomissione a Dio”) è la denominazione scelta da Maometto (Muhammad) per la religione
da lui fondata.
Gli aderenti alla religione islamica sono chiamati musulmani. Oggi i musulmani nel mondo sono circa un
miliardo e mezzo. Le comunità più numerose si trovano nel sub-continente indiano (Pakistan, India e
2
Bangladesh), nell’Africa sub-sahariana, nel Vicino e Medio Oriente. Nella Federazione Russa e nei Paesi
Balcani la presenza dei musulmani è significativa, mentre in America e in Europa è in costante aumento. In
Italia l’islam è la seconda religione dopo il cristianesimo.
Maometto e la nascita dell’Islam
Rimasto orfano di entrambi i genitori, fu allevato prima dal nonno e poi dallo zio, Abu Talib. Dopo alterne
vicende, intorno ai venticinque anni, sposò la vedova Khadijah. Fra i trenta e i quarant’anni Maometto
attraversò una profonda crisi religiosa, durante la quale si interrogò su Dio e sulla natura, appartandosi spesso
in ritiro. Nel 610, esattamente il giorno 27 del mese di ramadan (nono mese lunare del calendario
musulmano), sul monte Hira ebbe la prima visione, durante la quale, secondo la tradizione, l’arcangelo
Gabriele gli rivelò l’unicità di Allah, di cui Maometto divenne il portavoce (il Profeta). Secondo la tradizione
islamica, le visioni e le rivelazioni continuarono per ventidue anni, fino alla morte di Maometto.
Dopo un primo momento di smarrimento, Maometto cominciò ad annunciare pubblicamente il contenuto
delle visioni, intraprendendo una lotta senza quartiere contro il politeismo pagano. Ma La Mecca, oltre a
essere un nodo nevralgico dei traffici internazionali, era sede di culto e di importanti pellegrinaggi periodici
presso il santuario, all’interno del quale venivano conservati numerosi idoli, venerati dalle diverse tribù, e la
grande Pietra Nera, oggetto di culto molto diffuso, perciò il potentato della città, temendo ripercussioni
economiche, in un primo tempo ostacolò la predicazione del Profeta, poi passò a vere e proprie persecuzioni
contro Maometto e i suoi primi seguaci.
Maometto fu quindi costretto ad abbandonare la Mecca per rifugiarsi a Yathrib, l’attuale Medina (che
significa appunto “città del Profeta”). Questo trasferimento (egira) ebbe luogo il 16 luglio dell’anno 622 d.C.
e costituisce l’inizio del computo cronologico islamico.
A Yathrib venne redatto un documento, la Costituzione di Medina, che definiva, con successive modifiche, le
basi giuridiche di un potere riconosciuto dalle differenti tribù, che pur mantenendo un’autonomia per la
gestione dei vari problemi interni, accettavano l’arbitrato supremo del Profeta. Il documento sanciva l’unità
fra stato e religione: l’islam, “il retto sentiero”, era regola fondamentale sia per il rapporto religioso sia per il
contesto politico. Nella comunità musulmana, (ummah, letteralmente la comunità dei credenti), i seguaci di
Maometto erano chiamati al-muhajirum, cioè “coloro che sono migrati”, mentre gli altri, cioè gli ebrei e i
cristiani, erano chiamati dhimmi, cioè i “protetti”, sancendo una posizione non di parità, ma di sottomissione
di questi ultimi.
Dopo varie vicende e molti scontri con clan ostili, nel gennaio del 630 Maometto con i suoi seguaci entrò
trionfante a La Mecca e distrusse gli idoli presenti nella Ka’ba e la consacrò ad Allah. L’espansione – Dopo la
morte del Profeta, la guida politica e spirituale della comunità islamica fu assunta dapprima da una linea di
3
successione di califfi. Il termine califfo fu il nome dato ai primi successori di Maometto, che guidarono l’islam
in sua vece, sostituendolo in tutti i ruoli, tranne quello di profeta.
Il primo califfo fu Abu Bakr, che governò dal 632 al 634 e iniziò l’espansione militare verso la Persia. Nel 634
gli succedette ‘Omar, che governò dal 634 al 644, quando fu assassinato; conquistò la Siria, nel 638 entrò in
Gerusalemme, conquistò l’Egitto e la Nubia. Il terzo califfo, ‘Othman, fece curare la prima edizione integrale
del Corano, con lo scopo di preservare il testo da manipolazioni, creando così il testo ufficiale. Sotto il suo
califfato l’islam conquistò l’isola di Cipro, si espanse fino al Caucaso e all’India. Dopo il suo assassinio, nel 656,
gli succedette ‘Alì, cugino e genero di Maometto che aveva sposato Fatima, la figlia prediletta dal Profeta.
Sotto il suo califfato, che durò fino al 661, all’interno della comunità musulmana si formarono varie coalizioni
in contrasto fra di loro.
Il titolo di califfato fu ripreso dai turchi ottomani (cosiddetti da Othman, il nome del primo sultano); infatti i
loro sultani, dopo la conquista dell’Egitto nel 1517, si erano attribuiti tale titolo. Conquistati i Balcani, nel XIV
secolo invasero l’Europa, ponendo sotto assedio Vienna per ben due volte, nel 1529 e nel 1683. Il califfato fu
definitivamente abolito nel 1924 da Atatürk, fondatore e primo presidente della Turchia.
Tra il XVII e il XX secolo, con l’espandersi del fenomeno del colonialismo, si ebbe il lento ma inevitabile
restringersi del potere islamico, dopo la cacciata degli arabi dall’Europa occidentale, dei turchi dall’Europa
orientale, dei moghul (imperatori musulmani dal 1526 al 1858) dall’India
Terminologia di riferimento
Prima di parlare delle differenze, è bene premettere che sono tutti musulmani: credono nel Corano come
definitiva rivelazione di Dio all’umanità e in Muhammad (Maometto) come suo ultimo Profeta, pregano
cinque volte al giorno, digiunano nel mese di Ramadan, fanno l’elemosina, vanno in pellegrinaggio alla Mecca
etc. Ma hanno una diversa concezione dell’autorità religiosa. Per gli sciiti questa autorità, alla morte di
Muhammad, si è trasmessa al cugino e genero ‘Alî e di lì alla sua famiglia. Per i sunniti invece l’autorità è
rimasta nel Corano e nell’esempio del Profeta e dei suoi primi compagni (la sunna), interpretati dalla
comunità e dai suoi esperti religiosi.
I termini "islamico" ed "islamista" non hanno lo stesso significato! L'islamico è colui che è legato alla cultura
del proprio Paese, alla religione, alle tradizione, alle arti, e vive in pace con la cultura dell'occidente
rispettando il suo vicino, il suo prossimo e professando solo tolleranza e amore. L'islamista invece si rifà
all'Islamismo, un'ideologia che richiede l'adesione completa dell'uomo alla legge sacra dell'Islam e rifiuta il
più possibile influenze esterne, con alcune eccezioni (quali l'accesso ai militari e tecnologia medica). È intrisa
di un profondo antagonismo verso i non musulmani e ha una particolare ostilità verso l'Occidente.
Esso equivale ad un tentativo di trasformare l'Islam, una religione di civiltà, in un'ideologia insita nella propria
mente. La parola "islamismo" è appropriata, per questo termina in "-ismo", come il fascismo e il nazionalismo
(naturalmente è diverso da questi ultimi due, anche se lo scopo è simile). L'islamismo è, in altre parole, ancora
un altro schema utopico radicale del ventunesimo secolo. Come il marxismo-leninismo e il fascismo, offre un
modo per controllare lo stato, la società e "rifare" l'essere umano. Si tratta di una versione dal sapore islamico
del totalitarismo.
La Religione e la Politica1
Il rapporto tra islam e altre culture non può essere compreso senza fare riferimento alla politica. L'islam è
una realtà apparentemente omogenea, dato che la caratteristica essenziale di questa religione è di orientare
non solo la vita spirituale dell'uomo, ma anche quella culturale, economica e politica. Essa rifiuta fermamente
la distinzione tra condotta spirituale e condotta temporale e pretende di informare con un'unica legge, quella
1
4
Elaborato da http://www.corsodireligione.it/religioni/islam/islam_politica.htm
coranica, la globalità della vita di ogni credente. L'islam, insomma, nella sua forma più ortodossa, deve essere
din wa dawla, religione e stato.
Nei paesi islamici due sono gli scopi di chi ha responsabilità di governo:
-
in primo luogo quello di proteggere la religione musulmana, assicurarsi cioè che sia osservata, con
tutti i mezzi disponibili;
in secondo luogo quello di estendere l'islam a tutto il mondo.
Questa è la teoria classica dei giuristi musulmani, non è una novità; l'islam è "religione e società". Sotto
questo aspetto si comprende come sia fatto ogni sforzo, economico, culturale, politico, per estendere l'islam.
Caratteristica del mondo islamico è il prevalere della comunità sull'individuo, il che significa che la nozione di
libertà di coscienza o di diritti dell'uomo (due concetti che da due secoli contraddistinguono, nel bene e nel
male, il mondo occidentale) solo in minima parte sono stati accolti dalla cultura musulmana.
Musulmani liberali e musulmani fondamentalisti
Nei paesi musulmani c'è un'immediata identificazione fra religione e politica, che legittima lo stato di
inferiorità giuridica di chi non è di religione islamica. Il fondamento giuridico delle attuali discriminazioni fu
elaborato tra il I ed il IV secolo dell'era islamica (corrispondenti al periodo che va dal VII al X secolo dell'era
cristiana). In questo periodo fu elaborata tutta la giurisprudenza e tale dottrina è giunta fino ai nostri giorni.
L'islam nasce come progetto socio-politico ed anche militare: ciò è evidente sia nel Corano che nella sunna,
nella tradizione che include la vita e i detti di Maometto. Per un musulmano religione e politica sono
indissolubili. Coloro che invece propendono per una separazione dei due piani sono i cosiddetti musulmani
liberali, ma essi sono visti dalla maggioranza come musulmani solo di nome, il loro islam suscita dubbi, anche
perché molti non sono praticanti.
I liberali sostengono che nel Corano e nella Vita di Maometto vi sono state due tappe , la prima è quella del
periodo della Mecca (gli anni 610-622), la seconda è quella del periodo di Medina (gli anni che arrivano fino
al 632, data della morte di Maometto). Se si analizzano le fonti, secondo tale interpretazione, nel periodo
della Mecca si nota che il discorso è più spirituale che politico. Il discorso di Maometto appare fondato
sull'annuncio dell'unicità di Dio, su quello del giudizio finale che attende tutti dopo la morte (giudizio in base
al quale ciascuno sarà ricompensato con il cielo o punito con l'inferno) ed infine sul richiamo alla giustizia
sociale, alla solidarietà verso i poveri.
Questo sarebbe l'islam originario, il più autentico secondo i liberali, l'idea primaria così come appare rivelata
a Maometto. A Medina invece si sarebbe sviluppato un islam politico, perché le circostanze storiche hanno
condotto Maometto a creare un sistema sociale, ad organizzare l'esercito, fare guerre, ecc. La dottrina
relativa a tale periodo, per i liberali, sarebbe dunque secondaria, non necessaria, valida per quelle circostanze
storiche particolari e non universalmente.
Una simile interpretazione è contestata dagli - islamisti fondamentalisti, che dicono che proprio il secondo è
il vero islam, mentre il primo, quello della Mecca, era condizionato dal fatto che Maometto non era del tutto
libero di esprimere il suo progetto, aveva dovuto fare delle concessioni. Quando a Medina lui ha avuto pieno
potere, quando non era più attaccato dai Meccani, allora si è visto il vero progetto, che è un progetto sociopolitico, militare e religioso. Tra queste due tendenze è la seconda, come abbiamo visto, ad aver prevalso.
Quando gli islamisti oggi rivendicano questo progetto socio-politico sono fedeli alla tradizione islamica più
comune.
Nella cultura dei paesi arabi musulmani ha infine prevalso, al posto della categoria del cittadino, la divisione
tradizionale della società in
-
credenti (coloro che seguono l'islam),
5
-
protetti (cristiani ed ebrei),
miscredenti (la cui sorte può essere la morte o la conversione all'islam).
La realizzazione e la diffusione di quest'idea della società rimane il sogno della tendenza tradizionalista.
Bisogna anche dire che all'inizio del XX secolo la cultura islamica fu pervasa da un vasto movimento liberale,
suscitato anche dall'influsso dell'Occidente, che a tale movimento appariva come un modello auspicabile di
società. Vi sono stati grandi giuristi che nell'Egitto degli anni Trenta del nostro secolo hanno prodotto una
positiva integrazione tra codice napoleonico e legislazione tradizionale islamica. Tutto questo è stato
rimesso in discussione agli inizi degli anni Settanta con la guerra del 1973, la crisi del petrolio, ecc.
Il progetto politico della religione islamica
La shariah, il diritto musulmano divide i viventi secondo categorie religiose che permangono anche dopo la
morte. Innazitutto esiste la divisione tra le
-
Terre d'islam (dar al-islam) e le
Terre di Guerra (dar al-harb) o Terre di miscredenti (dar al-kufr).
Nelle Terre d'islam, la divisione è tra
- musulmani
- gente del libro (cristiani, ebrei, zorosatriani, sabatei induisti) (kafir) =miscredenti, ma con un librorivelazione(ahl al-kitab)
- politeisti (kafir) (mushrik)
- apostati. (murtad)
Ciò deriva dal fatto che nel 622 Maometto così aveva organizzato la città di Medina.
Corano 49,10- i credenti musulmani sono fratelli-appartengono alla UMMA
Corano 3,110 che è la migliore comunità per gli uomini.
Ciò significa secondo l'Islam che i musulmani formano una comunità-popolo eletto. Come Ebrei e cristiani.
La guerra e l'Islam
Le terre della guerra (Dar al Harb), sono quelle ancora governate dagli infedeli. Le Terre d'Islam sono quelle
sottoposte al potere islamico, siano esse abitate da tutti musulmani o no. Le altre terre oggi sono terre di
miscredenza, ma un giorno saranno musulmane.
Quali rapporti tra i due emisferi?
Prima dell'Egira, Maometto predicava di non ricorrere mai alla guerra anche in caso di aggressione.
(Corano16,127-13,22) Dopo l'Egira, a Medina, nella Umma, i musulmani vennero autorizzati a combattere gli
aggressori. (Corano 2,190.216-8,61-22,39) Alla fine fu loro permesso di intraprendere la guerra. (Corano 9,3)
In caso di trattato-armistizio senza limiti di tempo essi possono mettere fine alla guerra. Se l'armistizio è
limitato, la guerra non può essere ripresa se non alla fine dell'armistizio. Secondo la sharia non si può fare
l'armistizio se si è superiori in forze. (Corano 47,35). Ma se si vuole non è proibito usare il dialogo e anche la
dolcezza. Nel 1058 Il capo di stato aveva il dovere di combattere coloro che invitati a sottomettersi all'Islam
si erano rifiutati.
Il valore della guerra domina il Corano, che però vieta lo spargimento del sangue di un altro musulmano. La
guerra (harb) è lecita soltanto per espandere l'Islam. E' dovere del buon musulmano partecipare alla guerra
santa (jihad) per ricondurre le terre della guerra sotto il governo dei musulmani.
6
Il diffondersi del radicalismo islamico ha finito per far attribuire al termine jihad un unico e sinistro significato,
mentre nella cangiante realtà islamica il termine jihad può assumere tre significati diversi:
1) quello della guerra contro gli infedeli;
2) quello di scontro o polemica verso i musulmani tiepidi oppure traviati dalle mode occidentali;
3) quello di lotta o sforzo personale per adempiere al meglio i precetti coranici, nonostante le difficoltà
materiali e ambientali.
La guerra offensiva è legittima per i musulmani quando è intesa a estendere i diritti di Allah , la superiorità
della religione islamica sulle altre. I Musulmani sentono di avere la missione di sottomettere ad Allah tutti i
popoli, bon grè , mal grè.
Il governo dei musulmani fa capo al califfo, monarca assoluto rappresentante di Dio sulla terra, cui sono
sottoposti tutti i musulmani, indipendentemente dalla nazionalità. (Il califfato è stato abolito in Turchia da
Ataturk nel 1924, dopo la caduta dell'Impero Ottomano. Da allora L'Islam è privo di una guida e ogni deriva
è possibile). L'idea del proselitismo pacifico è estranea all'Islam, che infatti non ha missionari così come li
conosce il cristianesimo.
La conversione avviene con la spada, nel senso che le popolazioni sottomesse tendono a convertirsi
soprattutto per sfuggire all'inferiorità giuridica e materiale in cui vengono a trovarsi nello Stato islamico. Si
spiega così perché venga detta "santa" la guerra di conquista: essa è lo strumento del proselitismo islamico.
Questa distinzione in base alla fede tra i cittadini del medesimo stato islamico perdurò sino al XIX secolo, poi
cedette il passo a una concezione più vicina a quella occidentale.
Nel 1839 l'impero ottomano riconobbe l'uguaglianza dei propri cittadini in tutti i campi, meno quello militare.
Le concezioni parlamentari, più tardi, minarono la supremazia esclusiva della legge coranica. Nelle loro grandi
linee, tuttavia, le strutture dello stato islamico erano rimaste in vita per circa un millennio e oggi rivivono in
un numero crescente di stati.
L'uguaglianza laica tra i cittadini viene sempre più spesso sostituita da una legislazione che traccia una linea
di separazione tra credenti e non credenti: negli Stati dove è stato ripristinato il diritto penale islamico, ad
esempio, il non musulmano non può testimoniare in un processo contro un musulmano.
L'emigrazione dalle "terre di Islam".
Ogni musulmano che vive in terre di miscredenza è chiamato dal Corano a tornare nella terra d'Islam, appena
possibile. (Corano 4,97) a meno di poter vivere in quelle terre da vero musulmano, o di essere gravemente
malato, paralizzato, febbricitante. Ma dicono i giuristi, è sempre meglio tornare per aumentare il numero di
coloro che combattono lo sforzo contro la miscredenza. In ogni caso rimane il dovere di rientrare fino al
giorno della resurrezione.
Se un musulmano che si trova fuori dalle terre d'Islam domanda un aiuto in nome della religione, la comunità
musulamana deve soccorrerlo, fatto salvo quando si tratta di combattere un popolo con il quale la comunità
musulmana ha concluso una alleanza. (Corano 8,72).
Eguaglianza fra gli uomini nell'Islam.
Come si può notare da questi articoli di legge non esiste alcuna discriminazione razziale nell'Islam.
"...Dialogate con belle maniere con la Gente della Scrittura, eccetto quelli di loro che sono ingiusti. Dite (loro):
-Crediamo in quello che è stato fatto scendere su di noi ed in quello che è stato fatto scendere su di voi, il
nostro Dio e il vostro sono lo stesso Dio ed è a Lui che ci sottomettiamo-....." (Corano al-'Ankabut 29,46)
Il seguente versetto si riferisce a coloro che accusavano l'Inviato di Allah di discriminazione perché' il Corano
sarebbe stato rivelato solo ad una parte di famiglie di La Mecca, escludendo alcune tribù dell’Arabia (Tabari
25,65)
7
"...Sono forse loro i dispensatori della misericordia del tuo Signore? Siamo Noi che distribuiamo tra loro la
sussistenza in questa vita, che innalziamo alcuni di loro sugli altri, in modo che gli uni prendano gli altri a
loro servizio. La misericordia del tuo Signore è però (di gran lunga) migliore di quello che accumulano..."
(Corano az-Zukhruf 43,32)
"...E fan parte dei Suoi Segni, la creazione dei cieli e della terra, la varieta' dei vostri idiomi e dei vostri
colori. In ciò vi sono segni per coloro che sanno..."(Corano ar-Rum 30,22)
"...Oh gente, in verità il vostro Signore è Uno ed il vostro antenato è uno: voi discendente tutti da Adamo e
Adamo era (stato creato) di terra. Presso Allah il migliore di voi è colui che Lo teme di più. (Hadith Muhammad
632 d.C.)
"...Nessun arabo è superiore ad un non-arabo, se non nella devozione..." (Hadith Muhammad 632 d.C.)
L'unica "discriminazione" che può esser fatta nell'Islam è quella fra credenti e non-credenti anche se tale
"discriminazione" non giustifica un comportamento scorretto nei confronti di chiunque (anche non-credente)
conviva pacificamente con la comunità.
L'accordo costituzionale fra cristiani e comunità islamica (632 d.C)
Nel 632 d.C., il Profeta Muhammad ricevette una delegazione di rappresentanza dei cristiani di Najran, guidati
da un Vescovo, i quali, finora, erano stati legati all'Impero Bizantino ed ora volevano stipulare un accordo con
la comunità islamica di Medina.
Ebbero l'autorizzazione a celebrare messa nella Moschea, ma durante la loro permanenza a Medina vennero
fuori alcune divergenze sulla figura di Gesù. Gli ospiti cristiani appurarono che la posizione dell'Islam nei
confronti del Messiah era quella comune all'archimandrita di Costantinopoli Eutiche (378-454 d.C. circa), già
condannato dal concilio di Calcedonia (451 d.C.). Fu così che Allah rivelò il seguente versetto:
"...In verità, per Allah, Gesù è simile ad Adamo che Egli creò dalla polvere, poi disse: -Sii, ed egli fu- (Questa
è) la verità (che proviene) dal tuo Signore. Non essere tra i dubbiosi. A chi polemizza con te, ora che hai
ricevuto la scienza, di' solo: -Venite, chiamiamo i nostri figli ed i vostri, le nostre donne e le vostre, noi stessi
e voi stessi ed invochiamo la maledizione di Allah sui bugiardi..." (Corano al-Hashr 59,61)
"...A chi polemizza con te, ora che hai ricevuto la scienza, di' solo: -Venite, chiamiamo i nostri figli ed i vostri,
le nostre donne e le vostre, noi stessi e voi stessi ed invochiamo la maledizione di Allah sui bugiardi..." (Corano
al-'Imran 3,61)
La scienza della quale parla il Corano, riguarda la verità sulla storia della nascita di Maria, madre di Gesù.
Dopo aver citato il versetto, Muhammad invitò tutti a riunirsi in un'ordalia (mubahala) come prescritto da
Allah, ed il giorno seguente dissero che non intendevano spingere oltre la loro divergenza e stipularono,
quindi, un accordo, secondo cui, in cambio del pagamento di una tassa pro-capite (denominata "jazya", "tassa
di protezione") avrebbero goduto della protezione di loro stessi, dei loro beni e delle loro chiese da parte
dello stato islamico e garantisce il pieno rispetto e libertà di professare, internamente allo stato, la loro
religione.
Per i cristiani che non vogliono convertirsi all'Islam, non vi e' obbligo:
"...Non c’è costrizione nella religione. La retta via ben si distingue dall'errore. Chi dunque rifiuta l'idolo e crede
in Allah si aggrappa all'impugnatura più salda senza rischio di cedimenti. Allah è Audiente e Sapiente…"
(Corano al-Baqara 2,256)
8
Lo statuto di ebrei e cristiani e induisti nelle terre d'islam.
Nello stato islamico i credenti convivono con gli infedeli, tollerati se seguono una delle religioni che
Maometto considera rivelate, le cosiddette religioni del libro perché fondate, come l'Islam, su una Sacra
Scrittura: ebrei, cristiani, sabatei (=seguaci del Battista) zoroastriani e induisti.
(Corano 26,76) Abramo è il modello del credente (uswah); egli ha rotto con i parenti pur di seguire la via di
Allah.Così i legami religiosi sono superiori a quelli di sangue.(Lo stesso dirà Gesù a proposito dell'appartenere
a Lui e seguirlo).
Cio' che dà diritti alla persona è la sua appartenenza alla Umma di Allah. Cristiani ed ebrei non possono
avere gli stessi diritti dei musulmani. Cristiani ed ebrei possono vivere sulle terre d'Islam ma non come pari,
come dominati tra dominanti.
Cristiani ed ebrei (protetti=dhimmis) devono pagare una tassa per la protezione.
Il Patto di Omar, IX sec. a.C.
Il Patto di Omar è l’insieme di limitazioni e compromessi introdotti da un trattato fra i musulmani
conquistatori e i non-musulmani conquistati. Non abbiamo un trattato specifico per quanto riguarda gli ebrei,
ma dobbiamo ritenere che tutte le popolazioni conquistate – ebrei inclusi – lo abbiano sottoscritto.
Così, le leggi citate qui sotto, e rivolte contro le chiese cristiane, valgono anche per le sinagoghe.
Il Patto ebbe origine, probabilmente nel 637, dall’iniziativa di Omar I, dopo la conquista della Siria e della
Palestina. Attraverso l’aggiunta di nuove regole o di consuetudini precedenti, il testo si ampliò, ma
nonostante questi sviluppi l’intero Patto fu sempre attribuito a Omar.
Ne esistono molte versioni differenti e gli studiosi sono convinti che il testo che leggiamo oggi non possa
essere quello uscito dalla penna di Omar I; si è invece giunti alla conclusione che la sua forma attuale risalga
all’incirca all’inizio del IX secolo.
Il Patto di Omar è servito a governare fino ai nostri giorni i rapporti tra i musulmani e “le religioni del Libro”,
come cristiani e ebrei. Oltre alle condizioni del Patto elencate qui di seguito, gli ebrei, come i cristiani,
pagarono una tassa supplementare, in cambio di protezione e dell’esenzione dal servizio militare. A ebrei e
cristiani fu inoltre proibito di ricoprire cariche di governo.
Il Patto, come buona parte della legislazione medievale, fu stipulato più per essere infranto che per essere
effettivamente rispettato. Ciononostante, col passare del tempo il Patto divenne via via più rigoroso e, nel
XX secolo, ha ancora valore in paesi come lo Yemen.
Il Patto è scritto in arabo.
Nel nome di Dio, il Misericordioso, il Compassionevole. Questo è uno scritto rivolto a Omar dai Cristiani di
molte città. Quando voi [musulmani] vi siete mossi contro di noi [cristiani], vi abbiamo chiesto protezione per
noi stessi, i nostri successori e per coloro che credono in una religione simile alla nostra.
Abbiamo stipulato il seguente patto: non costruiremo nelle vostre città o fuori da esse nuovi monasteri,
chiese, o eremi; non ripareremo edifici religiosi caduti in rovina né restaureremo quelli che si trovano nei
quartieri musulmani delle città; non rifiuteremo l’ingresso ai musulmani nelle nostre chiese, giorno e notte;
apriremo le porte ai viaggiatori e ai pellegrini; ospiteremo ogni viaggiatore musulmano nelle nostre case, per
offrirgli vitto e alloggio per tre notti; non nasconderemo spie nelle nostre chiese e nelle nostre case, né
daremo asilo a nessun nemico dei musulmani.
[Almeno sei di queste regole erano tratte da precedenti leggi cristiane contro gli infedeli].
Noi non insegneremo il Corano ai nostri figli
9
[alcuni arabi avevano paura che gli infedeli avrebbero messo in ridicolo il Corano; altri non volevano neppure
che gli infedeli ne imparassero la lingua];
non faremo pubbliche dimostrazioni della religione cristiana, né inviteremo nessuno ad abbracciarla; non
impediremo, invece, ai nostri parenti di abbracciare l’Islam, se lo desiderano. Onoreremo i musulmani e gli
cederemo il posto nelle nostre assemblee quando loro vorranno intervenirvi; non li imiteremo
nell’abbigliamento, nei copricapi, nei turbanti, nelle calzature o nella pettinatura; non useremo i loro modi
di dire, né adotteremo i loro soprannomi
[gli infedeli non dovevano far uso di saluti o di frasi tipiche utilizzate solo dai musulmani];
non saliremo in sella, né porteremo spade, né indosseremo armi, né incideremo iscrizioni arabe sui nostri
anelli; non venderemo vino
[proibito ai musulmani];
ci raderemo il viso; continueremo a portare lo stesso tipo di vestiti, ovunque saremo; porteremo in vita delle
cinture
[gli infedeli indossavano cinture di pelle o di corda; i musulmani tessuti e sete].
Non esporremo la croce sopra le nostre chiese, né metteremo in mostra le nostre croci o i nostri libri sacri
nelle strade dei musulmani o nei loro mercati; batteremo le mani nelle nostre chiese in modo leggero
[sonagli di legno o campane convocavano la gente nelle chiese o nelle sinagoghe];
non reciteremo le nostre preghiere ad alta voce quando un musulmano è presente; non porteremo rami di
palma [la domenica delle Palme]
né le nostre immagini votive in processione lungo le strade; nel corso dei funerali non canteremo ad alta
voce, né porteremo candele per le strade dei musulmani o nei loro mercati; non prenderemo nessuno
schiavo che sia già stato di proprietà di un musulmano, né faremo le spie nelle loro case; non picchieremo
nessun musulmano.
Promettiamo di osservare tutte queste regole a vantaggio nostro e di tutti coloro che credono in una religione
simile alla nostra; in cambio riceveremo da voi protezione. Se violeremo qualche condizione di questo
accordo, allora perderemo la vostra protezione e avrete la libertà di trattarci come nemici e ribelli.
I musulmani potranno sposare le donne cristiane ed ebree ma non viceversa. (Corano 2,221-5,5-60,10). I
musulmani dovranno nutrire una diffidenza costante verso di loro (Corano 5,51-3,28-9,8).
In realtà il Corano è ondivago:
60,8 Allah non vi proibisce di essere buoni e giusti nei confronti di coloro che non vi hanno combattuto per
la vostra religione e che non vi hanno scacciato dalle vostre case, poiché Allah ama coloro che si comportano
con equità. 9 Allah vi proibisce soltanto di essere alleati di coloro che vi hanno combattuto per la vostra
religione, che vi hanno scacciato dalle vostre case, o che hanno contribuito alla vostra espulsione. Coloro che
li prendono per alleati, sono essi gli ingiusti.
Ma i giuristi musulmani hanno applicato la teoria della abrogazione: un versetto su un argomento può essere
abrogato da un versetto successivo sullo stesso argomento. Così i versetti di Medina abrogano quelli di La
Mecca.
I fedeli pagano annualmente la zakat, cioè l'imposta sul bestiame, raccolti, beni commerciali ecc. E' una
imposta coranica perciò legale destinata ai poveri, ai partecipanti alla guerra santa e alla liberazione degli
schiavi e dei debitori.
10
Il peso tributario gravava però soprattutto sugli infedeli cristiani ed ebrei, che pagavano due imposte: una
capitazione per ogni maschio e un tributo fondiario, che variava in funzione del modo di conquista del
territorio in cui si trovava il fondo e che era più elevato se esso era stato conquistato con la guerra, più
moderato se l'acquisizione era stata pacifica.
I proventi della guerra santa, invece, rappresentano un apporto moderato alle casse statali, poiché vengono
distribuiti quasi per intero tra i combattenti. Il bottino, d'altronde, è la forma più pratica per retribuire un
esercito senza costruire un complesso apparato amministrativo. Pare che la magnanimità religiosa degli arabi
e il rigore del loro fisco fossero le cause non ultime di conversioni in massa, che consentivano ai neofiti di
assoggettarsi al meno esoso tributo della zakat.
In seguito intervennero regole per evitare questo aumento di fedeli a scapito del gettito fiscale: si stabilì che
il mutamento di religione non comportasse un mutamento di regime tributario. Da allora il tributo fondiario
si applica ai fondi senza tenere conto della religione del loro proprietario.
Lo statuto dei non credenti e dei politeisti.
Non possono vivere sulle terre di Islam. O se ne vanno o subiscono la guerra fino alla morte.
9,29 Combattete coloro che non credono in Allah e nell'Ultimo Giorno, che non vietano quello che Allah e il
Suo Messaggero hanno vietato.
( Le modalità di predicazione prescritte da Francesco ai suoi frati. Esse tengono sicuramente conto
dell'esperienza del viaggio "per oltremare" di Francesco in Siria ed Egitto ; del suo soggiorno presso il sultano
al-Kamil. Da "Fratello lupo" di Franceso d'Assisi.
Dice il Signore : "Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi: siate dunque prudenti come serpi e saggi
come colombe". Perciò qualsiasi frate vorrà andare tra i saraceni a altri infedeli vada, con il permesso del suo
ministro e servo […] I frati poi che vanno fra gi infedeli possono comportarsi spiritualmente in mezzo a loro
in due modi.
Un modo è che non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio, e
confessino d'essere cristiani. L'altro modo è che, quando vedranno che piace al Signore, annunzino la parola
di Dio perché essi credano in Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo, Creatore di tutte le cose, e nel
Figlio Redentore e Salvatore, e siano battezzati, e si facciano cristiani, perché chiunque non sia rinato per
acqua e Spirito Santo non potrà entrare .
Regula non bullata, XVI, in Fonti francescane, Assisi 1986, pp.21-42. )
Lo statuto degli "apostati", coloro che lasciano l'Islam per altre religioni.
L'apostasia (kufr=rinnegamento -riddah=andare indietro) viene configurata come:
-
abbandono della religione
professione di dogmi eterodossi
insulti a Maometto o ai profeti riconosciuti dai musulmani
attitudine di opposizione al potere politico-...
L'apostasia può essere individuale o collettiva. Non sono previste dal Corano sanzioni precise; in 9,74 si parla
di punizioni dolorose in questo mondo senza precisare. Nei detti di Maometto si parla invece di ammazzarli.
Esplicitamente: uccideteli!
Sono tre i casi in cui si può attentare alla vita di un musulmano:
-
la miscredenza dopo la fede
l'adulterio dopo il matrimonio
l'omicidio senza una ragionevole causa
11
La Shariah prevede la messa a morte dell'apostata dopo un periodo di riflessione.
Questo tipo di lettura esiste e non si può negare che certe autorità religiose si siano attenute e/o si attengano
ancora al suo senso primario e letterale. Altri sapienti nel corso dei secoli hanno proposto un'interpretazione
diversa di questo hadith tramite il lavoro di contestualizzazione necessario alla sua comprensione.
Di che cosa si tratta dunque? Nel loro commento al testo, risalgono alla situazione di conflitto nella quale si
trovava la comunità musulmana a Medina. Alcuni individui si convertivano all'islam, si mescolavano alla
comunità dei credenti, raccoglievano informazioni e alla fine rinnegavano la loro religione, trasmettendo le
informazioni che avevano raccolto ai nemici dei musulmani. Si trattava, in effetti, di ipocriti che, per mezzo
della religione, praticavano il tradimento di guerra.
Il loro comportamento metteva in pericolo la sopravvivenza della comunità ed è in questo contesto che la
condanna a morte aveva senso per i traditori di guerra. Bisogna ricordare, inoltre, che intorno al Profeta si
muovevano alcuni ipocriti notori che non cessavano di disturbare l'equilibrio della nascente comunità
musulmana. Alcuni suoi compagni volevano affrontarli ed ucciderli per porre fine a questi intrighi ed è ciò
che proposero diverse volte a proposito di uno di nome Ubay.
Il Profeta lo proibì perché il tradimento non era stato manifestato dal cambiamento di religione e dall'alleanza
esplicita col nemico. In un'altra situazione il Profeta non era intervenuto contro coloro che lasciavano Medina
per unirsi agli abitanti di La Mecca.
Secondo il patto di al-Hudaybiyya, coloro che lasciavano Medina per La Mecca potevano restarvi. Da ciò si
capisce che colui o colei che lasciava Medina faceva causa comune con i Meccani e rinnegava la sua fede.
Era in tempo di pace e mai il Profeta ha cercato di colpirli, né quando sono fuggiti, né dopo, quando è tornato
vittorioso alla Mecca. Non è possibile render conto qui di tutti i dibattiti che ci sono stati tra i sapienti
sull'argomento ma, alla luce di queste due o tre situazioni e d'altre ancora, alcuni sapienti hanno messo in
evidenza il fatto che colui o colei che lascia la sua religione per convinzione personale senza cercare in seguito
di tradire l'islam ed i musulmani, in un modo o nell'altro, questo individuo non rientra nella categoria prevista
dal hadith suddetto.
Si appoggiano inoltre al versetto coranico che, su questo punto in particolare, rinvia il giudizio solo a Dio.
L'atteggiamento richiesto è quindi solo di un minimo di rispetto della religione che si lascia e della sensibilità
di quelli che continuano a valersene.
La divisione tra terre d'islam e di miscredenza oggi.
Oggi il criterio dei confini nazionali prevale su quello religioso. Dopo l'abolizione del califfato nel 1924, la
colonizzazione e la decolonizzazione, le nazioni islamiche si sono trasformate in stati.Questo statuto di statinazione ha rotto la concezione coranica del mondo.
Questi stati sono spesso in lotta tra loro, aderiscono all'Onu e, secondo il pensiero islamico, sottostanno ad
un potere, quello del Consiglio dell’ONU, parziale e tirannico. Pur essendo più di un miliardo i musulmani non
hanno diritto di veto sulle risoluzioni.
Da un punto di vista islamico, gli stati che aderiscono all'Onu fanno un trattato (adesione alla Carta dell'ONUDichiarazione dei diritti dell'Uomo) con gli altri stati ed il Corano esige che i trattati vadano rispettati per cui
gli stati aderenti all’ONU cessano di essere Terre di guerra e vanno considerati come stati di armistiziotrattato.
Secondo Al Zuhayli la divisione Coranica dell'emisfero era legata ad una situazione concreta di guerra:
cessando la guerra ed intervenendo un armistizio, la divisione cessa di essere giustificata. Ciò che conta oggi
di fatto come criterio di statuto per le Terre non è più l'adesione all'Islam ma la sicurezza (Consiglio di
sicurezza dell'ONU).
12
Secondo alcuni teologi musulmani gli stati islamici che aderiscono all'ONU (e riconoscono i diritti umani) non
possono più essere considerati terre d'Islam giacché non è più possibile applicare integralmente il diritto
coranico, ma solo quello che riguarda lo statuto individuale. (Vedi Turchia).
Gli islamisti (=integralisti) rivendicano il ritorno all'antica divisione dell'Emisfero in Terre d'Islam e Terre di
Guerra.La situazione dunque è tutt'altro che stabile. Il Consiglio Islamico d'Europa dice che lo stato saggio
adotta il modello costituzionale di Jarishah (1984) secondo il quale
-
La comunità islamica costituisce una sola comunità
La migliore entità tra quelle che la compongono è quella più osservante
tutte le barriere (frontiere, nazionalità spirito di clan) sono cadute.
Lo stato è una parte del mondo islamico ed i musulmani che si trovano in esso sono una parte della
Comunità islamica. L'unità della Comunità islamica è un compito che lo stato deve perseguire con tutti i
mezzi possibili.
L'emigrazione obbligatoria
Nessun musulmano può essere dispensato dall'emigrare quando il suo paese venisse occupato da
miscredenti a meno di malattia, paralisi o febbre grave o di intenzione di emigrare appena possibile. Esiste
una credenza radicale: L’Islam è superiore e nulla deve elevarsi al di sopra dell'Islam. La Dichiarazione
Universale dei diritti dell'Uomo nell'Islam (1981) dice all'art.23: La Dimora dell'Islam è Una. E' la Patria di tutti
i musulmani, nessuno è autorizzato a mettere ostacoli al suo dispiegarsi (barriere geografiche o frontiere
politiche) Tutti i paesi musulmani hanno il dovere di accogliere tutti i musulmani. (cf Corano 59,9)
Secondo alcuni tutti i paesi islamici dovrebbero avere frontiere aperte per qualsiasi musulmano soprattutto
per coloro che sono sotto migrazione obbligatoria. L'emigrazione obbligatoria è interdetta quando si tratta
di combattere lo jihad contro un invasore miscredente potendo contare su forze islamiche esterne. E' il caso
di una fatwa emessa dal Gran Muftì di Giordania verso i Palestinesi.
Tendenzialmente i musulmani sono restii ad adattarsi ad un potere e perciò ad un diritto che non è islamico.
E' probabile che spinte autonomiste come quelle emerse nei Balcani si manifestino in futuro nelle società
europee. Al momento la via intrapresa dai musulmani d'europa è quella di trattati con gli stati per ottenere
statuti speciali per la loro vita individuale e comunitaria negli aspetti religiosi di culto.
Nel 1930 negli Usa è nata una Organizzazione della Nazione Islamica con prospettive di uno Stato americano
islamico indipendente. Nel 1992 i musulmani di Inghilterra hanno formato un loro privato Parlamento. Il
fenomeno contemporaneo islamico è quello di una migrazione a pioggia nelle Terre di Trattato: e qui
attenzione, perché laddove le acque non vengono assorbite, esse formano laghi oppure danno luogo a
esondazioni. Chi vuole vivere come a Medina sceglie le terre d'Islam e chi si accontenta di vivere come a La
Mecca (minoranza senza potere ma musulmana pienamente nei rapporti con Allah) sceglie di restare nei
paesi di miscredenza o di emigrarvi.
Gli integralismi- fondamentalismi- integrismi
Gli islamici integralisti fondamentalisti tradizionalisti e integristi considerano gli stessi stati islamici come
Terre di miscredenza e si ritrovano nell’obbligo coranico di emigrare in paesi migliori. Sull'esempio di
Maometto essi ritengono di doversi ritirare sulle montagne per preparare la conquista all'Islam integrale dei
loro paesi .Così come Maometto fece con i Meccani essi si sentono chiamati dal Corano a fare con i loro
connazionali infedeli. Bin Laden è uno di questi islamisti.
Nella loro rivendicazione di un diritto islamico coranico e dunque divino in tutto il mondo tendono ad esaltare
lo Jihad come una guerra a tutto e a tutti. La radicalizzazione di una tale prospettiva li chiude ad ogni dialogo
con il mondo. Ecco che le suggestioni terroristiche possono prendere facilmente piede.
13
Vita del musulmano in terra di miscredenza secondo un manuale islamico libanese per l'emigrante in
terre di Guerra
l musulmano deve sentire ogni giorno tra lui e la società impura in cui vive una barriera .(Corano 9,28- I
politeisti non sono che impurità)
Questa barriera dovrebbe impedire al musulmano di integrarsi, fondersi con questa società. Deve avere il
sentimento di trovarsi in una società ingiusta, che non è la sua, che visi trova temporaneamente per
necessità fintantoché non sarà in grado di fuggirla. Il musulmano viene aiutato dalle fatua a mantenere la
sua integrità e purezza nei paesi di miscredenza.
1.
E' vietato ad un musulmano di andare in paesi di miscredenza se questo implica attentare alla propria
religione come tagliarsi la barba, stringere la mano ad una donna straniera, abbandonare la preghiera o il
digiuno, mangiare cibi impuri o bere alcolici.
2.
Se attentare alla religione riguardasse solo donne e bambini non deve portarli con sè
3.
Se si è costretti a quel viaggio è permesso che si prolunghi solo per le necessità del caso
4.
Non sedersi mai ad una tavola dove si consuma alcool
5.
Non voltarsi mai verso la Mecca per i bisogni corporali facendo attenzione all'orientamento di WC
occidentali
6.
Non toccare donne pagane. E' proibito sposarle come sposare musulmane apostate
7.
Il matrimonio con una ebrea o cristiana può essere solo temporaneo e se la donna è vergine bisogna
chiedere il permesso al padre
8.
In caso di malattia la donna si faccia curare solo da donne e l'uomo solo da uomini nel caso che la cura
implichi toccare le parti intime.
9.
E' vietato seppellire un musulmano in cimiteri miscredenti: vale la migrazione obbligatoria in paesi
islamici. Solo in caso di necessità tale norma è abrogata.
10. E' possibile lavorare nei supermercati solo se non si deve vendere carne di maiale o alcool.
11. E' vietato acquistare o vendere biglietti della lotteria e strumenti musicali.
12. E' vietato per gli studenti di medicina esercitarsi su un cadavere musulmano a meno che la vita di un
musulmano dipenda da ciò e non si trovano cadaveri miscredenti.
13. E' vietato ad uno studente musulmano abitare con una famiglia non musulmana
14. Alcuni considerano peccato che merita l'inferno l'acquisizione della cittadinanza di un paese non
islamico.
15. A meno di casi di necessità un musulmano che muore in terra di miscredenza non puo' essere sepolto
se non in un cimitero musulmano.
I Curdi
Chi sono i Curdi?
In generale sono un gruppo etnico indoeuropeo che abita nella parte settentrionale e nord-orientale della
Mesopotamia. Tale territorio è compreso in parti degli attuali stati di Iran, Iraq, Siria, Turchia e in misura
minore Armenia. L'area è a volte indicata col termine Kurdistan. Piccole comunità curde sono presenti anche
in Libano, Giordania, Georgia, Azerbaigian, Afghanistan e Pakistan. Inoltre, un certo flusso migratorio, si è
diretto verso gli Stati Uniti d'America e il Nord Europa (Scandinavia e Germania).
14
Si stima che i Curdi siano fra 35 e 40 milioni e che quindi costituiscano uno dei più grandi gruppi etnici privi
di unità nazionale. Per oltre un secolo molti Curdi hanno cercato di ottenere la creazione di un "Kurdistan"
indipendente o perlomeno autonomo, con mezzi sia politici sia militari. Tuttavia i governi degli stati che
ospitano un numero significativo di Curdi si sono sempre opposti attivamente all'idea di uno Stato curdo.
Le Origini
Nell’antichità essi erano i Medi (citati anche nella Bibbia), un’etnia di stirpe indoeuropea erano zoroastriani
islamizzati a forza nel VII secolo d.C. Storicamente schiacciati tra gli imperi turco, arabo e russo i Curdi sono
sopravvissuti alleandosi alternativamente con uno dei vicini a discapito di un altro (o turchi o arabi o russi).
Vivevano in tribù erano abili combattenti e obbedivano a diversi principi feudali spesso in conflitto tra loro.
Nel 16° secolo la maggior parte del Kurdistan fu inglobata nell'Impero ottomano, mentre una parte veniva
conquistata dalla Persia. Nonostante fosse stato assoggettato, il popolo curdo riuscì a mantenere una certa
autonomia conservando le sue divisioni interne in tribù patriarcali e un sistema economico-sociale di tipo
feudale. Nel corso dell'Ottocento iniziarono a manifestarsi le aspirazioni indipendentiste dei Curdi, ma le loro
rivolte furono tutte represse dagli Ottomani è proprio in quel periodo nacque il nazionalismo curdo (stiamo
parlando dei primi del ‘900 prima dell’inizio della grande guerra).
Novecento (XX secolo)
- Fine grande guerra: 10 agosto 1920 (trattato di Sevres): potenze vincitrici prima guerra mondiale firmano
un trattato con l’Impero ottomano che suggerisce la creazione di uno stato curdo.
- 1923 Losanna: nuovo accordo sancisce la spartizione del Kurdistan in 4 stati (Turchia, Iran, Siria e Iraq). I
governi in cui è spartito il popolo curdo cercano di cancellare l’identità (proibizione uso della lingua curda e
proibizione dell’uso di costumi e usanze curde). Movimenti armati di Curdi nascono in ognuno dei 4 paesi, e
agiscono limitatamente nelle zone dei paesi di appartenenza non danno vita ad azioni coordinate tra i vari
movimenti. I Curdi divengono minoranze instabili per tutti i governi che li devono amministrare.
In questo clima di oppressione i Curdi dei vari paesi danno vita a guerriglie contro i rispettivi governi dei paesi
di appartenenza, degno di nota è il movimento armato curdo in Iraq guidato dal leggendario Moustafà
Barzani, leader del partito democratico curdo, considerato da molti padre del Kurdistan iracheno.
Iraq 1958-1966 guerra civile irachena: guerriglieri (pashmargà che in curdo significa “coloro che si sono votati
alla morte”) guidati dal gen. Barzani combattono incessantemente contro le forze di sicurezza irachene al
fine di conquistare l’autonomia del kurdistan iracheno fino all’armistizio del 1966 in cui il governo iracheno
accetta di trattare con i Curdi per ascoltare le loro richieste. Le richieste effettuate al governo iracheno
vertono su 4 punti:
1)
2)
3)
4)
creazione di università e giornali in lingua curda
autonomia amministrativa del kurdistan
adeguata rappresentanza curda al parlamento e al governo
mantenimento di una forza armata curda…..richieste che verranno respinte dal governo iracheno.
-Iraq 1970 governo e Curdi giungono ad un accordo che garantisce l’utilizzo della lingua curda e l’autonomia
delle province del nord accordo mai applicato totalmente i Curdi si armano di nuovo.
-Maggio 1972 lo scià di persia chiede agli USA di armare i Curdi in Iraq, in cambio di appoggio alla CIA, per
indebolire il nemico iracheno che minaccia i suoi confini sul golfo persico. Gli USA armano i Curdi di Barzani
che insorgono contro il governo iracheno reo di non applicare gli accordi del 1970
-1974 Iran e Iraq giungono ad un accordo sui confini e lo scià di persia leva l’appoggio ai Curdi di conseguenza
gli USA smettono di armare l’esercito di Barzani che subisce ingenti sconfitte. Molti Curdi sono costretti a
lasciare le loro terre o ad essere deportati in campi di accoglienza in Iraq del sud, intellettuali e amministratori
15
Curdi vengono perseguitati dalla polizia irachena e iraniana si stima che oltre 300.000 Curdi siano emigrati in
quel periodo in altri paesi del medio oriente e anche in Europa è la prima grande diaspora del popolo curdo.
-1980-1988 Guerra Iraq-Iran per i confini sul golfo persico, l’Iran chiede aiuto di nuovo ai Curdi per respingere
l’offensiva dell’Iraq di Saddam Hussein. Al termine della guerra l’Iraq ammette la sconfitta e il governo di
Saddam incolpa i Curdi e da inizio ad una serie di operazioni di pulizia etnica, tra le tante spicca Attacco
chimico di Halabja in seguito al quale moriranno circa 100.000 Curdi.
-1990 Guerra del golfo: Iraq invade il Kuwait, una coalizione di 36 paesi guidati dagli USA respinge l’invasione
irachena e incita il popolo iracheno a ribellarsi contro il dittatore Saddam, i Curdi prendono alla lettera le
parole degli USA e avviano una delle più grandi offensive mai condotte dai peshmerga contro il governo
iracheno, gli USA però non si spingono oltre e non appoggiano militarmente i Curdi i quali vengono attaccati
nuovamente dal regime di Saddam. Più di 2 milioni di profughi Curdi si riversano sui confini tra Turchia e Iran
è la seconda diaspora del popolo curdo.
15 ottobre 2005(caduta Saddam Hussein nuova costituzione dell’Iraq). IL Kurdistan iracheno diventa
formalmente regione autonoma.
Ci sono kurdi anche in altri stati del medio oriente…ma perché parlare proprio dell’Iraq? Perché L’Iraq è
l’unico stato ad aver riconosciuto questa identità, i Curdi iracheni sono gli unici ad aver potuto sviluppare una
loro lingua e cultura.
I Curdi in altri paesi
In Iran
A partire dal secondo dopoguerra lo Scià dovette a lungo confrontarsi con la guerriglia dei Curdi, guidati dalla
famiglia Barzani, in particolare dallo sceicco Mustafa Barzani. Tale fenomeno durò fino al 1974, quando gli
iracheni si riappacificarono (temporaneamente e apparentemente) con gli iraniani e ritirarono l'appoggio al
leader della guerriglia.
Il governo di Teheran ha esercitato una dura repressione nei confronti dei Curdi iraniani. Il 14 settembre 1981
18 operai Curdi furono uccisi in una fabbrica di mattoni. I Curdi iraniani hanno subìto esecuzioni sommarie,
torture e processi iniqui.
In Turchia
I Curdi in Turchia formerebbero approssimativamente il 18% della popolazione (circa 14 milioni) nel 2008.
Nonostante la Turchia abbia approvato le due Convenzioni dell'Onu e del Consiglio d'Europa contro la tortura,
Amnesty International ritiene che la tortura in Turchia sia diffusa, seppur moderatamente, verso gli
oppositori politici e gli esponenti della comunità curda.
In Siria
I Curdi sono il 5% della popolazione in Siria, per un totale di 0,6 milioni Questo fa di loro la più grande
minoranza etnica del paese. Sono concentrati prevalentemente nel nord e nel nord-est, anche se anche ad
Aleppo e Damasco sono presenti significative popolazioni curde. I Curdi usano spesso parlare la loro lingua
in pubblico, sempre che le persone presenti facciano altrettanto. Gli attivisti per i diritti umani dei Curdi
vengono maltrattati e perseguitati. Non è permessa la formazione di nessun partito politico, Curdo o di altra
natura
La nascita del Medioriente nel suo assetto attuale
Situazione agli inizi del Novecento
Negli anni precedenti la Prima Guerra Mondiale, Gran Bretagna e Francia avevano zone di influenza nei
territori che allora appartenevano all'impero Turco e alla Persia. Come emerge dalla cartina, nel corso del
16
secolo XX, dopo la Grande Guerra, il Medio Oriente andò incontro ad un processo di decolonizzazione2. Al
termine della Prima Guerra mondiale, infatti, la Francia controllava parte della Turchia, la costa dell'odierna
Siria, ed esercitava influenze politico-economiche su parte dell'attuale Iraq e sul resto della Siria stessa. Oltre
i confini meridionali di queste sfere d'influenza, iniziava il dominio britannico, che controllava i territori che
giungevano fino all'odierna Arabia Saudita e al Golfo Persico. Nel frattempo, in Palestina si verificavano i primi
disordini tra gli Arabi, preoccupati dell'afflusso di ebrei in territorio palestinese, ed Ebrei, dal momento che
la Gran Bretagna si era dichiarata favorevole alla creazione di una 'national home' ebraica in territorio
palestinese.
Si ricordi, inoltre, che l'astio degli Arabi verso gli Inglesi era alimentato dalla delusione seguita alla spartizione
del Medioriente, nel 1915, senza tener conto delle aspirazioni nazionalistiche arabe, in precedenza istigati ad
una rivolta contro i Turchi, nemici degli alleati durante la guerra, e cui era stata promessa una nazione araba.
La rivolta (al-Thawra al-Arabiya) cui si fa riferimento è quella del 1916-18: durante la Grande Guerra, la
Turchia si era alleata con gli imperi centrali. Gli alleati, approfittando dell'insofferenza degli arabi del giogo
turco, stipularono con essi un accordo, che venne però differentemente interpretato: gli Arabi, infatti,
credevano che avrebbero ottenuto uno stato arabo indipendente; Gran Bretagna, Francia e Russia, invece,
negli accordi segreti di Sykes-Picot (1916) stabilirono di spartirsi i territori arabi. E' in questo contesto che
compare in scena Lawrence d'Arabia, ufficiale britannico posto dagli inglesi a controllo delle truppe arabe.
In teoria, gli stati occidentali, tramite dei mandati, avrebbero dovuto preparare gli stati, che formalmente
non erano colonie, a rendersi indipendenti, anche se, de facto, la loro presenza in Medio Oriente si risolse
nello sfruttamento economico delle risorse di quei territori. E' importante ricordare, a questo proposito, che
proprio nei primi anni del Novecento furono scoperti i primi giacimenti petroliferi in medio oriente.
2
La decolonizzazione è il processo politico, raramente pacifico e spesso conflittuale, attraverso il quale una nazione,
precedentemente sottoposta a un regime coloniale, ottiene la propria indipendenza. (Wikipedia)
17
L’Indipendenza degli stati mediorientali
Indipendenza della Turchia e della Giordania
Nel 1923, la Turchia seguì l'esempio dei paesi occidentali e si dichiarò indipendente, sotto la presidenza di
Mustafà Kemal Ataturk, che diede avvio ad una serie di riforme volte a modernizzare il paese.
Nello stesso anno, 1923, la Giordania (o Transgiordania) dell'hashemiro Absullah si separò dalla Palestina
(con disapprovazione dell'Arabia, che aveva perso dei territori in questo processo), cui apparteneva secondo
gli accordi inglesi, ma venne riconosciuta ufficialmente solo nel 1946.
Nascita dell'Arabia Saudita moderna
Nel 1926, il futuro re Abd-al Aziz Ibn Saud attuò un colpo di stato e, unificando due regni (quello dell'Higiaz,
conquistato nel 1925, e quello di Riad, attuale capitale dell'Arabia), prese il controllo del nuovo paese,
instaurando un regime integralista ed imponendo la sharia.
La tendenza fondamentalista si diffuse in tutto il Medio Oriente, tanto da dare origine ad organizzazioni
integraliste, quali i Fratelli Musulmani (1928) in Egitto o i membri di Hamas in Palestina (che si sarebbero poi
opposti al trattato di pace fra Israele e Palestina del 1993), autori di frequenti attentati verso gli Israeliani.
Nel 1932, il regno venne riconosciuto ufficialmente anche dalla Gran Bretagna ed assunse il nome di Arabia
Saudita. Nacque così uno stato economicamente potente (grazie ai giacimenti petroliferi), a maggioranza
sunnita wahhabita3, avente per governo una monarchia assoluta islamista.
Indipendenza dell’Iran e sviluppi
La Persia dello scià Reza Shah Pahlavi, che poi prenderà il nome di Iran, andò incontro ad una progressiva
occidentalizzazione su esempio di Kemal. Reza modernizzò l'economia, laicizzò l'istruzione e lo stato, tanto
che l'Iran divenne in poco tempo lo stato più 'occidentalizzato' del Medioriente. Ma proprio queste riforme
'moderniste' alienarono allo scià la simpatia della classe religiosa, e non ottennero gli esiti sperati in molti
campi dell'economia, che rimasero arretrati. Durante la seconda guerra mondiale, nonostante la dichiarata
neutralità, nel 1941, Gran Bretagna e URSS (da sempre 'protettori/custodi' dell'Iran) invasero il territorio
iraniano, costringendo lo scià ad abdicare in favore del figlio, per timore che la Germania nazista potesse
beneficiare delle risorse petrolifere iraniane in virtù delle relazioni amichevoli che intercorrevano fra i due
paesi. Nel 1942, gli Stati Uniti, ormai in guerra, contribuirono alla formazione del corridoio persico4, e tra il
'46 e il '53 tolsero progressivamente agli inglesi il controllo della regione.
Nel 1951, poi, fu eletto Primo Ministro Mohammad Mossadeq, che, nello stesso anno, attuò una serie di
riforme agrarie, processi di modernizzazione dell'industria, programmi per ampliare i diritti delle donne
(divorzio, voto, ecc.) e, soprattutto la nazionalizzazione dell'Anglo-Iranian Oil Company5. Questa operazione
fu ovviamente contrastata dagli Inglesi ma, all'inizio, non dagli Americani, che poi si schierarono però con i
Britannici quando questi ultimi accusarono l'Iran di tendere al comunismo. Gli USA, in piena Guerra fredda,
non potevano permettere che un paese come l'Iran cadesse sotto influenza sovietica. Inoltre, nonostante le
grandi perplessità e le opposizioni suscitate nella società dalle decisioni di Mossadeq (l'economia iraniana
non vide un'ascesa notevole), il Parlamento gli conferì sempre più poteri, tanto che, nel 1953, lo scià fu
costretto a lasciare il paese, andando in esilio a Roma. A questo punto, Servizi segreti USA e GB sostennero
un colpo di stato (Operazione Ajax) organizzato dagli oppositori di Mossadeq, costituiti soprattutto da sciiti.
3
Una forma di sunnismo austero e particolarmente severo, definito anche 'ortodosso'
Per 'corridoio perisoco' si intende la rotta logistica che gli alleati utilizzarono per trasportare il petrolio nell'URSS.
5
Compagnia petrolifera Anglo-Iraniana, fondata nel 1908, che conferiva benefici agli Inglesi sull'estrazione petrolifera
iraniana.
4
18
Nel 1954, tornò dunque al potere lo scià Mohammad Reza Pahlavi, che spese molto denaro per costose
celebrazioni della sua persona e della monarchia, di cui accentuò tra l'altro i caratteri nazionalistici e
assolutistici, fino a bandire, nel '71, tutti i partiti. La popolazione, vessata da anni di crisi economica, iniziava
intanto a mostrare il proprio malcontento, e Pahlavi rispose con la repressione (aveva speso molto denaro,
tra l'altro, per l'armamento dell'esercito).
Nel '78, quindi, la popolazione insorse, incitata anche dall'ayatollah tradizionalista in esilio Khomeini. Nel '79,
lo scià lasciò il paese in mano al primo ministro, democratico, che ne aveva richiesto l'esilio. Ma il potere
anche di quest'ultimo iniziò a scemare alla notizia del rimpatrio dell'ayatollah, che avvenne nello stesso anno.
Fu costituita così la Repubblica Islamica dell'Iran, basata sulla sharia, in cui il governo istituzionale (Primo
ministro, Parlamento, ecc.) non aveva che compiti gestionali, mentre gli organi di governo che si basavano
sulle leggi islamiche assunsero il potere esecutivo. In seguito a ciò, il fronte rivoluzionario si sciolse, dando
vita a numerosi gruppi indipendenti.
Intanto, l'ex scià si era recato negli USA per curare il cancro, ma il nuovo regime iraniano temette delle
trattative che avrebbero potuto portare ad un accordo simile a quello sfociato nell'operazione Ajax del '53.
Richiesero così l'estradizione di Pahlavi, che non venne però concessa. In Iran ci furono, pertanto, diverse
manifestazioni antiamericane, che degenerarono nella cosiddetta 'crisi degli ostaggi': degli studenti
penetrarono nell'ambasciata americana a Tehran, e restituirono gli ostaggi solo nel 1981, dopo che gli USA
(che già armavano l'Iraq) acconsentirono all'armamento dell'Iran, da un anno in guerra contro l'Iraq di
Saddam Hussein.
Indipendenza dell’Iraq e sviluppi:
Durante la Prima Guerra Mondiale, l'Iraq non si era schierato con gli inglesi contro l'impero ottomano; anzi,
gli iracheni avevano osteggiato i britannici in nome dell'Islam. Quando, alla fine della guerra, gli Inglesi vi
stabilirono un 'protettorato, quindi, il malcontento era talmente accentuato che una rivolta antibritannica
diede filo da torcere per diversi mesi. Ufficialmente, l'Iraq nacque come mandato britannico nel 1920, ma
nello stesso anno venne dichiarato regno. Visto l'astio degli iracheni, infatti, non conveniva assumere un
controllo diretto sulla regione, bensì istituire un governo locale gestito 'dietro le quinte' dagli inglesi. Fu così
che salì al trono d'Iraq l'hashemita6 Faysal I, fratello del re giordano Abdullah.
Fino agli anni '30, il paese rimase sotto controllo britannico, e solo nel '32 ottenne l'indipendenza (seppur de
facto gli inglesi continuassero ad avere il controllo); l'insofferenza degli iracheni a questa situazione portò,
tra gli anni '30 e '40, a una situazione instabile, in cui furono tentati molti golpi, che non ebbero tuttavia
successo. Nel '52, però, i 'Liberi ufficiali', un gruppo nazionalista egiziano, guidati da Gamāl ʿAbd al-Nāṣer
Ḥusayn e Muhammad Naguib, abbatterono la monarchia filo-britannica, proclamando la repubblica nel
1953, di cui Naguib divenne il Presidente. MA già l'anno seguente Nasser trasformò, tramite un colpo di
mano, la repubblica in dittatura, facendo imprgionare Naguib. Egli abbracciò l'ideologia del panarabismo,
tanto che nel '58 fondò la RAU, cui, però, aderì solo la Siria, e solo per due anni. Questi avvenimenti sono
fondamentali per numerosi paesi, che seguirono l'esempio di Nasser.
Nello stesso anno 1958, infatti, l'ufficiale Qassem disertò e proclamò la repubblica d'Iraq, il cui governo
riuniva tutti i partiti: PCI (Partito Comunista Iracheno), PDK (Partito Democratico Curdo) e quello di Baath
7
(nazionalsocialista). Ma si crearono subito tensioni: i baathisti sostenitori del Baath) premevano per entrare
6
Hashemita: gli hashemiti sono i membri di una dinastia originaria dell'Arabia saudita (in particolare dell'ex regno di
Higiaz, regione occidentale della penisola arabica), che governò, dopo la IGM, la Transgiordania e l'Iraq.
7
Baath (o Ba'th): lett. 'rinascita, risorgimento', è un partito fondato in Siria negli anni quaranta, la cui ideologia è un
misto di nazionalismo e socialismo moderato. Essa si fonda, infatti, sulla libertà della nazione araba, che deve liberarsi
dagli imperialisti e costituirsi indipendente, prendendo coscienza di nazione panaraba, al di là dei singoli stati. Il
socialismo che essa propone, è, come afferma Carlotta Stegagno, "una forma morbida di socialismo, che mette
l’individuo al centro del sistema economico rifiutando la concezione materialistica della storia e riconoscendo la
19
nella neonata RAU, poiché ne condividevano le vedute panarabiste, mentre comunisti, sciiti e Curdi si
opposero, poiché, se erano minoranze non da poco nel solo Iraq, nella RAU avrebbero costituito una presenza
insignificante. Nel 1963, Qassem, il cui potere andava scemando già da un po', venne deposto da Abdel Salam
Aref, che divenne presidente della repubblica irachena, dapprima sostenendo le idee nazionaliste del Baath,
ma poi orientandosi verso una politica più moderata. Alla sua morte salì al potere il fratello, moderato, fino
al '68, anno in cui presero il potere Ahmed al-Bakr e, in qualità di vice-presidente, Saddam Hussein.
Guerra Iran-Iraq8
Nel 1980 Saddam Hussein usò dei contrasti territoriali presso lo Shatt el-Arab (corso fluviale che consentiva
lo sbocco sul Golfo Persico) come pretesto per dichiarare guerra all'Iran. Le cause per questa guerra furono
essenzialmente due:
- la crisi economica politica in Iran susseguita alla rivoluzione del 79, di cui Saddam voleva approfittare per
guadagnare il dominio economico nell'area mediorientale;
- le incitazioni, da parte di Khomeini, a una rivoluzione sciita su modello di quella iraniana: Saddam temeva
una rivolta sciita, mentre una guerra contro il nemico Iran avrebbe unito il paese;
Nell'80, quindi, Saddam invase l'Iraq, supportato segretamente dagli USA, che si erano ufficialmente
dichiarati neutrali. Dal 1981, poi, nonostante appoggiassero l'Iraq, gli USA furono costretti ad armare anche
l'Iran, in cambio del rilascio degli ostaggi dell'ambasciata americana (crisi degli ostaggi). Alla fine, dopo otto
anni di scontri inconcludenti, l'ONU stipulò una tregua, che concluse la guerra con un nulla di fatto.
L'aggressione
Il 22 settembre 1980 l’Iraq, prendendo a pretesto un’improbabile sollevazione delle popolazioni arabe a Sud
dell’Iran, con una modalità non dissimile da quella che adotterà dieci anni dopo nei confronti del Kuwait,
attacca militarmente il vicino persiano sulla linea di confine dello Shatt al Arab. In realtà l’oggetto della guerra
è proprio il controllo di quell’estuario del Tigri e dell’Eufrate che immette nel Golfo Persico.
Si tratta di un’aggressione unilaterale, in violazione di qualsiasi norma di diritto internazionale, ma
nonostante ciò né l’ONU né alcuna grande potenza prende seriamente l’iniziativa per mettere fine alla
guerra.
Tutti guardano con favore a un ridimensionamento dell’Iran e vi sono buoni motivi per ritenere che Saddam
Hussein, prima di dare l’ordine dell’attacco, sia stato rassicurato sulla sostanziale neutralità degli USA e dei
loro alleati.
Il protrarsi della guerra e la politica dell'Occidente
La guerra, che doveva risolversi in una rapida e vittoriosa avanzata irachena, si trascina per otto anni facendo
centinaia di migliaia di morti (non se ne conosce la cifra esatta ma si pensa che non siano stati meno di 1
milione, equamente divisi fra i due contendenti) e provocando terribili sofferenze alla popolazione sia
dell’Iran sia dell’Iraq.
20
proprietà privata e i diritti di eredità. Secondo ‘Alfaq, l’obiettivo finale del socialismo deve essere la liberazione del
talento e delle abilità degli individui, in modo da renderli in grado di dirigere il proprio destino e ottenere così il
miglioramento degli standard di vita sia dei singoli sia della nazione araba nella sua interezza.
Dal punto di vista strettamente pratico è di nuovo la Costituzione del 1947 che specifica il contenuto del socialismo
baathista: la ricchezza economica (art. 26), i servizi pubblici, le risorse naturali e le grandi industrie sono di proprietà
della nazione; lo stato si riserva il diritto di controllarli direttamente e di abolire le compagnie private e le concessioni
straniere (art. 29). La proprietà immobiliare (art. 33), industriale (art. 31), agricola (art. 28) e i diritti di eredità sono
ammessi, ma limitati in base all’interesse nazionale (art. 34)."
8
Dal paragrafo l’aggressione l’intero capitolo Iran-Iraq è tratto da
http://www.presentepassato.it/Schede/Medioriente/guerra_Iraqiran_tx.htm consultato il 25/01/16.
Intanto l’interesse internazionale per la guerra, così basso fino a che sembrava trattarsi solo di un problema
fra musulmani, si riaccende quando il conflitto comincia a minacciare la circolazione navale nel Golfo Persico.
Gli USA e molte altre potenze occidentali, fra cui l’Italia, mandano allora la propria marina militare a difendere
le petroliere che vanno a caricare il greggio ai terminali dell’Arabia Saudita e dei vari emirati. Ma nel momento
in cui le sorti della guerra sembrano piegare a favore dell’Iran, questo intervento internazionale, formalmente
neutrale, si rivela un utile sostegno al Governo di Baghdad. A questo non sono d’altra parte mai mancate le
forniture militari dell’Italia, della Francia e degli USA i quali non cessano di rifornire il regime di Saddam
Hussein anche dopo che il 17 maggio 1987 un missile iracheno colpisce, ufficialmente per sbaglio,
l’incrociatore statunitense Stark, nelle acque del Golfo, uccidendo numerosi marinai.
Incidenti internazionali
L’episodio non può che far aumentare la tensione nell’area facendo tacere le critiche di coloro che, nel
Congresso USA, si oppongono a un’accentuazione della presenza militare nel Golfo. Il 20 luglio 1987 viene
approvata la risoluzione 598 del Consiglio di sicurezza dell’ONU che impone il cessate il fuoco senza peraltro
distinguere, come chiede l’Iran, fra la posizione dell’aggredito e quella dell’aggressore. Il Governo di Teheran
si dichiara disposto ad accettare la risoluzione ma chiede che venga istituita una commissione per
determinare le responsabilità nell’inizio della guerra. L’Iraq si oppone e nessuno si sforza di trovare una
mediazione.
Il 3 luglio 1988 un aereo di linea iraniano, con 290 passeggeri, tutti civili, viene abbattuto da un missile
lanciato dall’incrociatore americano Vincennes. Non vi sono superstiti. Il comando statunitense si scusa
attribuendo il fatto a un improbabile errore dei sofisticati sistemi di puntamento. Nonostante le insistenze
del Governo iraniano né l’ONU né alcun altro organismo internazionale pronuncia una esplicita condanna del
fatto. L’isolamento del Governo di Teheran non potrebbe essere maggiore. Il 18 luglio il ministro degli Esteri
iraniano Velayati scrive una lettera al segretario dell’ONU Perez de Cuellar, dichiarando che il suo Governo è
pronto a sottoscrivere la risoluzione 598. Il 20 agosto scatta il cessate il fuoco.
La Prima Guerra del Golfo9
Dopo la guerra contro l'Iran, l'Iraq di Saddam era in profonda crisi. Per risollevare le sorti del suo paese e
riguadagnare consensi, Saddam mosse guerra al Kuwait, piccolo star a sud-est dell'Iraq, ricco di risorse
petrolifere. Saddam ne invase i territori, dichiarandolo territorio annesso.
L'ONU si oppose a questo atto di guerra, e formò una coalizione di più di trenta stati (il numero esatto cambia
a seconda delle fonti) capeggiata dagli USA, che invece Saddam credeva lo avrebbero appoggiato. Dopo vari
tentativi diplomatici ignorati da Saddam, la coalizione passò all'azione, prima con bombardamenti ai pozzi
petroliferi e poi con l'offensiva di terra 'Desert storm'. Dopo qualche mese l'Iraq capitolò, e il 28/02 fu firmata
la pace.
L'occupazione: tra propaganda e ragioni economiche
Il conflitto oppose l'Iraq a una coalizione Onu di 36 Stati, di cui gli Usa furono il capofila. L'obiettivo dichiarato
dell'alleanza internazionale era quello di liberare l'emirato del Kuwait, che fu occupato dal paese guidato dal
rais Saddam Hussein. Quest'ultimo, il 2 agosto 1990, invase il piccolo Stato confinante, cercando un riscatto
economico dopo la guerra con l'Iran durata 8 anni.
La motivazione ufficiale del tentativo di "annessione", ribadita da Saddam in una famosa intervista rilasciata
al nostro Bruno Vespa, fu quella che il Kuwait e l'Iraq avevano una stessa identità etnica e storica. Inoltre, per
il governo iracheno, sebbene Baghdad avesse riconosciuto l'indipendenza dell'emirato, il sovrano kuwaitiano,
Jaber Al-Ahmed Al Sabah, era illegittimo perché messo al potere dalla Gran Bretagna.
9
Dal paragrafo l’occupazione… fino alla fine del capitolo La Prima Guerra del Golfo il testo è tratto da
http://www.polisblog.it/post/278080/prima-guerra-del-golfo consultato il 25/01/16.
21
In realtà, la causa scatenante della campagna militare, almeno secondo la visione irachena, fu espressa
compiutamente dal ministro degli Esteri di Saddam, Tareq Aziz. Quest'ultimo, in un messaggio alla Lega
Araba, lamentò l'estrazione illegittima di petrolio, da parte del Kuwait, lungo i 120 km di frontiera. Inoltre,
per Aziz, l'emirato avrebbe colpevolmente svalutato il prezzo del greggio sul mercato. Per questi motivi, si
rendeva necessario l'annullamento del credito di 10 miliardi di dollari che il Kuwait aveva nei confronti
dell'Iraq.
L'Opec, per parte sua, cercò di accogliere parzialmente le richieste di Baghdad, aumentando il prezzo del
barile da 18 a 21 dollari (il guadagno che derivò da tale operazione non riuscì comunque a coprire il
fabbisogno del paese). Dunque, le mediazioni non sortirono effetti e l'Iraq invase il Kuwait il 2 agosto 1990.
Il ruolo dell'Arabia Saudita
A stimolare un impegno diretto degli Stati Uniti non furono solo gli interessi nell'emirato, ma anche la
potenziale destabilizzazione che Saddam avrebbe potuto portare nell'area mediorientale. A tale riguardo,
ricordiamo che l'Arabia Saudita non solo si opponeva frontalmente all'invasione irachena, ma era
territorialmente minacciata dallo stesso Saddam, che andava ripetendo che la dinastia regnante in Asia
occidentale era guardiana illegittima delle città sante (La Mecca e Medina).
Fu a quel punto che l'allora presidente George W. Bush incominciò a sostenere che il suo paese avrebbe
intrapreso un'azione difensiva a sostegno di Riyad. E le prime truppe americane arrivarono in Arabia il 7
agosto del 1990.
La risoluzione Onu e la coalizione
Il 29 novembre, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite approva la risoluzione numero 678. Con tale
dispositivo si intimava all'Iraq il ritiro immediato, altrimenti, a partire dalle ore 08:00 am del 16 gennaio 1991,
sarebbero stati legittimati tutti i mezzi necessari per far recedere le truppe di Saddam. L'Urss votò a favore,
ci furono solo due no (di Cuba e Yemen) e un'astensione (della Cina).
Nella super-coalizione entrarono 35 Stati: Italia (che offrì una forza navale e dei tornado), Arabia Saudita,
Argentina, Australia, Bahrain, Bangladesh, Brasile, Canada, Cile, Cecoslovacchia, Colombia, Corea del Sud,
Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Grecia, Honduras, Kuwait, Marocco, Nuova
Zelanda, Niger, Norvegia, Pakistan, Paesi Bassi, Polonia, Oman, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Senegal, Siria,
Spagna, Sudafrica, Ungheria.
17 gennaio: Scatta l'Operazione Tempesta nel Deserto
Una delle operazioni militari, la più importante, diede il nome a tutta la spedizione: Desert Storm (Tempesta
nel Deserto). Questa scattò allo scadere dell'ultimatum, il 17 gennaio alle 2.38 a.m.
Poco più di un mese dopo, l'Iraq fu costretto a capitolare: contro l'imponente schieramento di forze, messo
in piedi dalla coalizione internazionale, Saddam non aveva possibilità di vittoria. Inoltre la strategia bellica
del rais si dimostrò inefficace. Il lancio di missili su Israele e Arabia Saudita, ad esempio, non sortì l'effetto
sperato. Attaccare Tel Aviv non portò ad un coinvolgimento nel conflitto dello Stato ebraico, cosa che
nell'ottica Iraquena avrebbe allontanato gli Stati arabi dalla coalizione.
Rimane dubbia, invece, la faccenda di 400 milioni di galloni di petrolio versati nel golfo Persico da parte
dell'Iraq. Secondo fonti occidentali, la più grande fuoriuscita di petrolio della storia fu orchestrata da Saddam
per bloccare lo sbarco dei marines, ma il governo di Baghdad ha sempre negato di essere il responsabile
dell'accaduto.
Della fase bellica, infine, ricordiamo il rapimento dei due ufficiali dell'aeronautica italiana, Maruzio
Cocciolone e Giammarco Bellini. I due furono liberati a fine conflitto, ma subirono, durante la prigionia, chiari
abusi di guerra. La loro immagine, trasmessa dalla tv irachena, mostrava palesi segni in tal senso. E violazioni
non dissimili subirono anche i prigionieri britannici.
22
Vittime e Sindrome della Guerra del Golfo
I soldati americani morti nella guerra furono 258, di cui 145 per incidenti non legati a combattimenti (cifre
del dipartimento di Stato). La Gran Bretagna registrò 38 perdite, la Francia 9 e le nazioni arabe 47 in totale. Il
numero di feriti dell'intera coalizione fu di 776 in combattimento. Più difficile stimare le perdite Iraquene.
Secondo il Project on Defense Alternatives study, furono 3.663 tra i civili e tra 20.000 e 26.000 tra i militari.
Segnaliamo, inoltre, che dai cannoni GAU-8 Avenger e dagli aerei da attacco al suolo A-10 Thunderbolt
partirono circa 300 tonnellate di uranio impoverito (incorporato in proiettili e munizioni). La cosa avrebbe
successivamente comportato conseguenze disastrose sui reduci e la popolazione civile (la comunità
scientifica, però, non si è mai pronunciata unanimemente sulla nocività dell'uranio impoverito).
A tale riguardo, si parla oggi di una vera e propria Sindrome della Guerra del Golfo, che comprenderebbe
anche gli effetti causati dalla sperimentazione di vaccini contro l'antrace. I vaccini sarebbero stati fatti
iniettare dal Pentagono su parte dei militari. E in seguito, i loro figli nacquero con gravi malformazioni e
malattie incurabili, che produssero paralisi, problemi respiratori e la mancanza di organi interni.
Le condizioni di Bush
Bush padre decise di attenersi al mandato Onu e non rovesciò il regime iracheno. Impose, però, a Saddam di
fermare i programmi sulla produzione di armi di distruzione di massa e impose al paese sconfitto
l'accettazione degli ispettori delle Nazioni Unite, che verificarono lo smantellamento delle armi biologiche,
chimiche e nucleari (fino al 1998, quando il rais li espulse dal paese).
Inoltre furono esatte due no fly zone nel sud e nel nord del paese. Tale disposizione favorì, nella zona
settentrionale, la formazione di un'entità curda autonoma da Baghdad. Tuttavia, dobbiamo rilevare che a
conflitto finito un'insurrezione dei Curdi fu repressa nel sangue e che le loro condizioni non migliorarono
successivamente: rimasero, infatti, oggetto di rappresaglie e discriminazioni.
Infine, gli Usa decisero di continuare l'embargo (nato nel 1990) nei confronti dell'Iraq. Ciò ebbe conseguenze
disastrose sulla popolazione civile e fu solo in parte attenuato nel 1995.
La Seconda Guerra del Golfo10
Premessa
Verso la fine degli anni novanta diversi intellettuali e politici americani (soprattutto i Neocons) cominciarono
a premere per un'invasione dell'Iraq. Molti di costoro erano vicini al Partito Repubblicano e la loro influenza
crebbe enormemente con l'elezione (novembre 2000) del figlio dell'ex presidente Bush. Nella nuova
Amministrazione entrarono diversi fautori dell'invasione, fra cui il vicepresidente Cheney, il Segretario alla
Difesa Rumsfeld e probabilmente lo stesso George Bush.
Inizialmente l'Iraq venne lasciato in disparte, forse perché la relativa debolezza politica del presidente non gli
permetteva di ignorare le ragioni dei "realisti" (che temevano le conseguenze negative dell'invasione),
rappresentati entro l'Amministrazione dal Segretario di Stato Colin Powell. Gli attentati dell'11 settembre
2001 gli permisero di uscire dall'impasse presentandosi come il presidente di una nazione già in guerra. Bush
proclamò dapprima la cosiddetta guerra al terrorismo e poi enunciò la dottrina della guerra preventiva
(dottrina Bush): gli USA non avrebbero atteso gli attacchi nemici, ma avrebbero usato la propria potenza
militare per prevenirli.
È stato riferito che Bush pensasse subito all'Iraq, cambiando però idea quando si rese conto che gli attentati
erano stati compiuti dal gruppo terrorista al-Qāʿida, capeggiato dal saudita Osāma bin Lāden. bin Lāden e i
10
Paragrafo tratto ed in parte rielaborato da
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerra_d%27Iraq&oldid=77747283
23
suoi avevano base in Afghanistan dove erano appoggiati dai Talebani, fazione che controllava gran parte del
Paese. Poiché questi rifiutarono di consegnare bin Lāden, gli USA si allearono con i loro nemici interni e li
rovesciarono, installando a Kabul un governo filo-occidentale (dicembre 2001); bin Lāden riuscì a fuggire.
Nonostante la campagna afghana non fosse conclusa, l'amministrazione Bush spostò rapidamente la propria
attenzione ad altri Stati che riteneva pericolosi per la sicurezza statunitense: nel discorso sullo stato
dell'Unione del gennaio 2002 Bush parlò del cosiddetto asse del male formato da stati canaglia quali Iran,
Iraq e Corea del Nord, cui occorreva contrapporsi. Nella pratica, gli sforzi dell'amministrazione si indirizzarono
soprattutto contro l'Iraq.
Il dibattito sulla guerra
Al prospettarsi di un intervento in Iraq l’opinione pubblica si divise tra interventisti e non, portando gli
argomenti di seguito illustrati.
Tesi favorevoli all’intervento
Tesi contrarie
Impedire la ricostruzione in Iraq dell’arsenale di L’attività di costruzione dell’arsenale atomico era
armi di distruzioni di massa.
dubbia.
I contatti del paese con i regimi terroristici.
Non vi erano indizi di un’effettiva collaborazione tra
l’Iraq e terroristi attivi in USA.
Il prestigio internazionale degli USA che sarebbe In caso di insuccesso il prestigio degli USA ne
uscito rafforzato dal conflitto.
avrebbe risentito, ed in ogni caso le reazioni di Iran
e Corea del Nord sarebbero state sfavorevoli con
l’intervento.
La possibilità di installare una democrazia in Iraq, L’instaurarsi di una democrazia in Iraq non era un
esempio per il Medio-Oriente.
dato certo.
La violazione dei diritti umani e della no fly zone.
La guerra preventiva era illegale, non avallata
dall’ONU e pericolosa.
Le vittime della guerra avrebbero potuto superare
quelle del regime.
Gli oppositori denunciarono come elementi che spinsero ad intraprendere la guerra anche:
Gli USA volevano rendere più sicuri i propri approvvigionamenti energetici, riducendo l'importanza
di Paesi come il Venezuela di Chávez, o della stessa Arabia Saudita;
Numerose compagnie americane desideravano partecipare allo sfruttamento delle risorse
petrolifere irachene (da cui erano escluse per via delle sanzioni), alla "ricostruzione" dell'Iraq, o anche
solo alla fornitura di armamenti per la guerra. Inoltre, si pensò che dopo la guerra un aumento della
produzione irachena avrebbe abbassato il prezzo del greggio, favorendo l'intera economia
occidentale; la "lobby del petrolio", però, si schierò contro la guerra.
Israele (stretto alleato degli USA con cui l'Iraq era formalmente in guerra da decenni) avrebbe
beneficiato dell'eliminazione di uno dei suoi più acerrimi avversari.
La diplomazia
L'11 ottobre 2002 Bush ottenne dal Congresso l'autorizzazione all'uso della forza per "difendere la sicurezza
nazionale degli USA contro la continua minaccia posta dall'Iraq; e per attuare tutte le risoluzioni del Consiglio
di Sicurezza dell'ONU a questo riguardo". Bush avrebbe dovuto spingere il Consiglio di Sicurezza a prendere
provvedimenti contro il mancato rispetto di 16 precedenti risoluzioni riguardanti l'Iraq; la forza sarebbe stata
ammissibile solo dopo che egli avesse determinato che ulteriori sforzi diplomatici non sarebbero valsi a
proteggere gli USA o ad attuare le risoluzioni. Tuttavia Bush non avrebbe avuto bisogno di ulteriori
autorizzazioni, né del Congresso né dell'ONU.
Dopo alcune settimane di negoziati in seno al Consiglio gli USA ottennero l'approvazione unanime della
risoluzione 1441 (8 novembre 2002), che offriva all'Iraq un'ultima possibilità di adempiere ai propri "obblighi
24
in materia di disarmo" e minacciava "serie conseguenze" in caso contrario, fissando una serie di scadenze
entro le quali il disarmo sarebbe dovuto procedere.
L'Iraq accettò la risoluzione, permettendo il ritorno degli ispettori e concedendo loro prerogative (come
l'accesso illimitato ai "siti presidenziali") che aveva sempre negato. I capi degli ispettori, Hans Blix e
Muḥammad al-Barādeʿī, presentarono diversi rapporti. Nel primo di questi (30 gennaio 2003) Blix sostenne
che l'Iraq non aveva del tutto accettato i propri obblighi, pur non ponendo ostacoli diretti alle ispezioni; alBarādeʿī (capo dell'AIEA e incaricato della distruzione del programma nucleare) sostenne che molto
probabilmente l'Iraq non aveva un programma atomico degno di nota. Entrambi chiesero più tempo prima
di dare un giudizio definitivo.
Il 5 febbraio il segretario di stato USA Colin Powell cercò di convincere il Consiglio ad autorizzare l'uso della
forza poiché, a suo dire, l'Iraq aveva ancora una volta dimostrato di non rispettare le risoluzioni ONU. Nel suo
discorso egli espose le "prove" dell'esistenza di WMD irachene. La sua tesi fu accolta freddamente e i suoi
argomenti furono considerati molto deboli.
I successivi rapporti di Blix e al-Barādeʿī (14 febbraio e 7 marzo) furono più favorevoli all'Iraq, poiché
parlavano di progressi, anche se diversi problemi restavano irrisolti, soprattutto nel campo delle armi
chimiche: secondo Blix, sarebbero stati necessari parecchi mesi di ispezioni per venirne a capo.
Questi rapporti, uniti all'annuncio francese di un probabile veto, furono deleteri per i tentativi angloamericani di ottenere un'ulteriore risoluzione che autorizzasse esplicitamente l'invasione. Nonostante forti
pressioni statunitensi solo 4 dei 15 Stati presenti nel Consiglio (USA, Regno Unito, Spagna e Bulgaria) erano
intenzionati ad approvare la risoluzione (Francia, Germania, Cina, Pakistan e Siria sembravano contrari,
mentre Messico, Cile, Camerun, Angola, Guinea e Russia avevano posizioni più sfumate). La nuova risoluzione
non fu quindi sottoposta al voto e Bush dichiarò che la diplomazia aveva fallito.
La guerra in Iraq
Per quanto il presidente statunitense Bush sostenesse che la decisione di invadere l'Iraq non fosse stata
ancora presa, il comando americano cominciò con largo anticipo a pianificare l'invasione, inviando grandi
forze in Kuwait. Nella primavera 2002 la stampa USA descrisse i probabili piani di attacco: una campagna
relativamente breve ma molto massiccia di bombardamenti aerei sarebbe stata combinata con la rapida
avanzata di un esercito relativamente piccolo ma molto mobile, dotato dei più moderni mezzi. Il principale
timore era che questa forza perdesse molti dei propri vantaggi se l'esercito iracheno si fosse asserragliato
nelle città. Parecchi militari ritenevano quindi inadeguata sia la forza di 70.000 uomini proposta dal segretario
alla difesa Donald Rumsfeld (per confronto, l'esercito che nel 1991 aveva riconquistato il Kuwait era di oltre
500.000 uomini), sia le stime che parlavano di un'occupazione di circa un anno: ad esempio, il capo di stato
maggiore dell'esercito USA, gen. Shinseki dichiarò di ritenere necessarie "diverse centinaia di migliaia di
uomini" "per diversi anni". Alla fine gli USA e i loro alleati schierarono circa 250.000 uomini, metà dei quali
marinai od aviatori.
Inoltre le incursioni aeree sulle no fly zones furono intensificate: già nel settembre 2002 furono condotte
incursioni che coinvolsero oltre 100 aerei. Alla fine dell'autunno le truppe americane erano pronte
all'invasione, prevista nei mesi relativamente freschi dell'inverno, ma che fu ritardata di alcuni mesi dal
protrarsi della controversia all'ONU (forse perché la loro presenza minacciosa aveva spinto Saddam a piegarsi
alle ispezioni).
La guerra iniziò la mattina del 20 marzo del 2003, poche ore dopo un ultimo rifiuto di Ṣaddām di abbandonare
il potere e andare in esilio. Al 2 maggio l'Iraq era già stato bombardato dalla coalizione con più di trentamila
bombe oltre a ventimila missili cruise ad alta precisione paralizzando il paese.La coalizione disponeva di un
25
esercito di circa 260.000 uomini, cui si aggiungevano alcune decine di migliaia di componenti della milizia
curda dei peshmerga. L'esercito iracheno contava invece poco meno di 400.000 uomini (di cui circa 60.000
guardie repubblicane), più circa 40.000 paramilitari dei Fedā'iyyīn Ṣaddām e ben 650.000 uomini
ufficialmente parte della riserva. L'esercito iracheno era però male armato e scarsamente motivato; anche i
reparti di élite della guardia repubblicana avevano mezzi piuttosto malconci (le sanzioni avevano impedito
l'importazione di pezzi di ricambio). In effetti, gran parte delle unità irachene si disintegrarono prima di
incontrare il nemico, per via dei bombardamenti, e dell'incompetenza o delle diserzioni dei loro comandanti
(spesso corrotti dalla CIA).
L'attacco di terra fu quasi contemporaneo a quello aereo. Poiché la Turchia aveva negato il transito alla
fanteria, quasi tutte le forze della coalizione partirono dal Kuwait, anche se nel nord una brigata di
paracadutisti e diverse unità di forze speciali si unirono ai peshmerga.
L'avanzata fu rapida: già nella serata del 20 marzo le forze britanniche e i Marines avevano occupato il porto
di Umm Qaṣr, impossessandosi dei giacimenti petroliferi del sud dell'Iraq, ed erano in prossimità di Basra
(che però fu presa solo il 6 aprile); il grosso degli americani avanzò invece verso ovest e verso nord, evitando
di prendere d'assalto le città salvo quando necessario per impossessarsi di ponti sul Tigri o sull'Eufrate. Gli
Iracheni opposero resistenza per alcuni giorni nei pressi di Hilla e Karbala, aiutati da una tempesta di sabbia
e dalla necessità americana di rifornire i propri mezzi. Tuttavia il 9 aprile, tre settimane dopo l'inizio
dell'invasione, gli americani entrarono a Baghdad e le rimanenti difese irachene crollarono: il 10 aprile i Curdi
entrarono a Kirkuk e infine il 15 aprile cadde anche la città natale del rais, Tikrīt.
Il 1º maggio 2003 il presidente Bush atterrò sulla portaerei Abraham Lincoln (che aveva partecipato alle
operazioni in Iraq e stava rientrando alla base) e vi tenne un discorso avendo alle spalle uno striscione che
diceva Missione Compiuta (Mission Accomplished).
Lo “Stato Islamico”
Situazione in Iraq
Sotto Saddam11
Il governo di Saddam, a capo del partito panarabo – che voleva l’unificazione cioè di tutto il mondo arabo
sotto una sola entità – di Ba’at, si improntò ad una politica laica ma che non poté far a meno di favorire, nel
11
26
Alcune parti tratte da https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Politica_dell%27Iraq&oldid=78359777
conflitto interno alla società irachena, la comunità sunnita (25% della popolazione) reprimendo invece gli
sciiti (50%) e i Curdi (20%).
Nel sud sciita tutti i tentativi di rivolta (ad es. subito dopo la Prima Guerra del Golfo) erano stati repressi dal
governo centrale e quasi tutti i leader politici erano dovuti fuggire in esilio. Fra questi erano particolarmente
importanti l'Ayatollah Sayyed Muhammad Bāqir al-Hakīm ed Ibrāhīm al-Jaʿfarī, rispettivamente a capo del
Consiglio Supremo per la Rivoluzione Islamica in Iraq (noto con l'acronimo inglese SCIRI) e del Partito Islamico
Da'wa (Daʿwa vuol dire "appello"), entrambi con forti legami con l'Iran.
L'unica autorità a cui il regime era obbligato a concedere una minima autonomia era quella ecclesiastica,
specialmente quella dei grandi ayatollah sciiti di Najaf (città santa dello Sciismo in quanto ospita la tomba di
ʿAlī ibn Abī Ṭālib, quarto califfo e primo Imam sciita). Ciò non impedì l'assassinio nel 1999 del grande ayatollah
Muhammad Sādiq al-Sadr (e di due suoi figli), fondatore di un movimento politico-religioso considerato
pericoloso da Saddam. Il suo assassinio non estinse il movimento sadrista, per quanto esso passasse in
clandestinità e subisse una scissione: la maggioranza dei suoi membri rimase fedele a Muqtada al-Sadr (un
altro figlio dell'ayatollah assassinato), mentre una consistente minoranza passò con lo sceicco Muhammad
Ya'qubi (amico del padre di Muqtada e appoggiato del Grande Ayatollah iraniano Kadhim al-Haeri), che
avrebbe successivamente fondato il partito Fadila (virtù).
I sunniti sono il blocco della popolazione irachena che ha visto la caduta del regime di Saddam nella luce
peggiore. Essi infatti hanno controllato lo stato iracheno fin dall'istituzione della monarchia negli anni venti,
spesso a spese degli altri gruppi etnico-religiosi iracheni: la caduta di Saddam ha segnato la fine di questo
predominio. Inoltre moltissimi di loro erano parte dell'apparato governativo, dell'esercito o del partito Baʿth
e l'epurazione o la dissoluzione di queste istituzioni li ha spesso lasciati senza lavoro. Tutto ciò si è sommato
ad un nazionalismo particolarmente forte ed alla convinzione di essere vittime di un sopruso (i sunniti
rifiutano di credere di non essere la maggioranza) ed ha creato un clima di ostilità diffusa nei confronti delle
truppe occupanti e delle nuove istituzioni irachene.
Questo clima, unito alle competenze militari dei sunniti (ad es. gli ex ufficiali dell'esercito potevano attingere
a depositi segreti di armi e munizioni disseminati da Saddam in tutto il Paese) ha portato alla formazione di
numerosi gruppi armati di tendenze sia laiche (ex baʿthisti) che islamiche.
Al-Zarkawi12
Le origini dello Stato Islamico possono essere rintracciate alla fine degli anni Novanta quando, Abu Musab alZarkawi fondò la Jamat al-Tawhid wa-l-Jihad, dopo essersi formato insieme a bin Laden in Afghanistan
durante gli anni Ottanta. Fu l’avvio dell’operazione Iraqi Freedom che offrì lo scenario tristemente “ideale”
per testare e provare l’efficacia della sua strategia. Inizialmente l’organizzazione si limitò ad operare nel nordovest dell’Iraq. In larga parte sconosciuta e principalmente composta da poche dozzine di militanti noniracheni, l’organizzazione di al-Zarkawi riuscì ben presto ad imporsi all’attenzione dei media e delle agenzie
di sicurezza occidentali per la sua aggressività e capacità operative sul campo. Nel 2004 si consumò un primo
importante passaggio. Limitato nelle risorse e nel numero dei suoi combattenti, al-Zarkawi comprese la
necessità di uscire dai limiti della sua organizzazione. Al-Qaida, da parte sua, era alla ricerca di un leader
carismatico sul campo capace di guidare le operazioni militari, riscattando il movimento dalle sconfitte subite
in Afghanistan. Il sodalizio si consumò e nacque al-Qaida nella Terra dei Due Fiumi (conosciuta anche come
al-Qaida in Iraq – Aqi). Già nel 2005, però, tale relazione iniziò a scricchiolare. La sconfitta nella battaglia di
Baghdad rappresentò il grande catalizzatore del più ampio dissenso strategico e dottrinale tra i sostenitori di
bin Laden e al-Zawahiri e quelli di al-Zarkawi. Quest’ultimo fu attaccato dai vertici di al-Qaida per l’eccessivo
12
Paragrafo tratto da http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/da-al-qaida-Iraq-aqi-al-califfato-una-storia-di-sangue11103 consultato il 24 gennaio 2016.
27
uso della violenza verso la popolazione irachena piuttosto che contro le truppe della Coalizione13, e per la
propensione eccessivamente radicale nell’imposizione dall’alto della shari‘a. Un’impasse interna che non
poté far altro che aggravarsi e ampliarsi nel 2006 con la morte di Abu Musab al-Zarkawi.
Da questi sviluppi nacquero prima l’organizzazione Majlis Shura al-Mujahedin e poi lo Stato Islamico in Iraq.
Quest’ultimo rappresenta idealmente il diretto predecessore dell’attuale califfato; un emirato che avrebbe
dovuto estendersi sulla maggior parte dell’Iraq centro-occidentale. In realtà il progetto politico-militare degli
eredi di al-Zarqawi non si sviluppò secondo le speranze dei suoi militanti, incontrando le resistenze e
l’opposizione dei leader delle tribù locali e della popolazione nelle regioni irachene a maggioranza sunnita.
Dall’AQI all’IS14
Dopo la morte di al Zarqawi, ucciso in un raid aereo americano il 7 giugno 2006, il movimento intensificò le
proprie attività incrementando il numero dei propri miliziani. Nell’ottobre di quello stesso anno, restando
sempre associato ad Al Qaeda, esso assunse un nuovo nome: “Stato islamico dell’Iraq” (Isi), sotto la guida di
Abu Ayyub al-Masri a cui si affiancò in seguito Abu Umar al-Baghdadi. È sotto questa nuova sigla che
l’organizza­zione iniziò allora a rivendicare un numero crescente di attentati, diventando presto il più vasto
e aggressivo gruppo terroristico operante nel paese. Nonostante l’efficace attività di controinsurrezione
messa in atto tra il 2007 e il 2008 dal generale americano David Petraeus, l’Isi riuscì a trarre infatti un forte
alimento dalla dissennata politica anti-sunnita del governo iracheno dello sciita Nuri al-Maliki.
Tra il 2010 e il 2011 due sviluppi importanti impressero una svolta ulteriore alla storia del movimento. Il primo
fu l’uccisione, nell’aprile del 2010, di al-Baghdadi e di al-Masri nel corso di un’operazione di controterrorismo
effettuata da forze irachene e americane. Ad essi subentrò alla guida dell’organizzazione l’attuale leader
dell’Isis, Abu Bakr al-Baghdadi, un personaggio dal forte richiamo carismatico. Il secondo sviluppo – messo in
moto dalle cosiddette “primavere arabe” – fu l’inizio della guerra civile in Siria tra il 2011 e il 2012, cui l’Isi
prese parte in misura sempre più significativa contro il presidente Bashr al Assad. Dapprima, stabilendo
strette anche se difficili relazioni con il Fronte al-Nusrah, anch’esso affiliato ad Al Qaeda e al suo nuovo leader
Ayman al-Zawahiri, subentrato alla guida del movimento dopo l’uccisione di Osama Bin Laden il 1° maggio
2011. E poi, nell’aprile del 2013, adottando il nome di Isil (“Stato islamico dell’Iraq e del Levante”) ovvero di
Isis (“Stato islamico dell’Iraq e della Siria”). Era un segno molto chiaro che il gruppo jihadista stava maturando
una strategia più ampia di quella sino ad allora di fatto circoscritta allo specifico contesto iracheno. La sua
sfida si stava proiettando oltre e contro la divisione del mondo arabo in stati-nazione, disegnati in modo
artificioso dalle grandi potenze vincitrici della prima guerra mondiale. Nella direzione, appunto, della
restaurazione del “califfato”.
Per il suo radicalismo estremo e per l’efferatezza delle sue operazioni militari e terroristiche nel corso del
2014 l’Isis è entrato progressivamente in collisione con gli altri gruppi jihadisti operanti in Iraq e in Siria,
alienandosi nel contempo le iniziali simpatie dello stesso mondo sunnita, che avevano conferito forza ed
efficacia alle sue azioni. Nel febbraio del 2014 esso è stato sconfessato addirittura dallo stesso al-Zawahiri, il
leader di Al Qaeda. E tuttavia, nonostante il suo isolamento, l’Isis ha continuato la sua marcia verso il
“califfato”, ufficialmente proclamato il 29 giugno 2014, scatenando nelle settimane successive una virulenta
offensiva militare e terroristica che ha impressionato il mondo intero.
13
28
Si fa riferimento alla coalizione multinazionale in Iraq, anche conosciuta come coalizione dei volenterosi (in inglese
coalition of the willing) raccolta dagli Stati Uniti nella fase preparatoria della guerra del golfo.
14
Tratto da un saggio di Francesco Tuccari, pubblicato su http://aulalettere.scuola.zanichelli.it/argomenti/isis-lo-statoislamico-settembre-2014/?id_tipo=401&pag=4
La Siria
La Primavera Araba15
Le proteste cominciarono il 18 dicembre 2010, in seguito alla protesta estrema del tunisino Mohamed
Bouazizi, che si diede fuoco in seguito a maltrattamenti subiti da parte della polizia, il cui gesto innescò
l'intero moto di rivolta tramutatosi nella cosiddetta Rivoluzione dei gelsomini. Per le stesse ragioni, un effetto
domino si propagò ad altri Paesi del mondo arabo e della regione del Nord Africa. In molti casi i giorni più
accesi, o quelli dai quali prese avvio la rivolta, sono stati chiamati giorni della rabbia o con nomi simili.
Nel 2011, quattro capi di Stato furono costretti alle dimissioni o alla fuga: in Tunisia Zine El-Abidine Ben Ali
(14 gennaio 2011), in Egitto Hosni Mubarak (11 febbraio 2011), in Libia Muhammar Gheddafi che, dopo una
lunga fuga da Tripoli a Sirte, fu catturato e ucciso dai ribelli il 20 ottobre 2011 e in Yemen Ali Abdullah Saleh
(27 febbraio 2012).
I sommovimenti in Tunisia portarono il presidente Ben Ali, dopo venticinque anni, alla fuga in Arabia Saudita.
In Egitto, le imponenti proteste iniziate il 25 gennaio 2011, dopo diciotto giorni di continue dimostrazioni,
accompagnate da vari episodi di violenza, costrinsero alle dimissioni (complici anche le pressioni esercitate
da Washington) il presidente Mubarak dopo trent'anni di potere. Nello stesso periodo, il re di Giordania ʿAbd
Allāh attuò un rimpasto ministeriale e nominò un nuovo primo ministro, con l’incarico di preparare un piano
di "vere riforme politiche". Sia l'instabilità portata dalle proteste nella regione mediorientale e nordafricana,
sia le loro profonde implicazioni geopolitiche, attirarono grande attenzione e preoccupazione in tutto il
mondo
Le proteste hanno colpito non solo paesi arabi, ma anche esterni alcuni Stati non arabi, come nel caso della
Repubblica Islamica dell'Iran, che ha in un certo senso anticipato la primavera araba con le proteste postelettorali del 2009-2010; i due casi hanno in comune l'uso di tecniche di resistenza civile, come scioperi,
manifestazioni, marce e cortei e talvolta anche atti estremi come suicidi, divenuti noti tra i media come autoimmolazioni, e l'autolesionismo. Anche l'utilizzo di social network come Facebook e Twitter per organizzare,
comunicare e divulgare determinati eventi è stato molto diffuso, a dispetto dei tentativi di repressione
statale. La Primavera araba ha avuto lo scopo di portare o riportare le tradizioni del mondo arabo al potere.
I social network tuttavia non sarebbero stati il vero motore della rivolta, secondo alcuni osservatori, per i
quali "il network della moschea, o del bazar, conta assai più dì Facebook, Google o delle email". Alcuni di
questi moti, in particolare in Tunisia ed Egitto, hanno portato a un cambiamento di governo, e sono stati
identificati come rivoluzioni.
I fattori che hanno portato alle proteste sono numerosi e comprendono la corruzione, l'assenza di libertà
individuali, la violazione dei diritti umani e la mancanza di interesse per le condizioni di vita, molto dure, che
in molti casi rasentano la povertà estrema. Anche la crescita del prezzo dei generi alimentari e la fame sono
da considerarsi tra le principali ragioni del malcontento; questi fattori hanno colpito larghe fasce della
popolazione nei Paesi più poveri nei quali si sono svolte le proteste, portando quasi a una crisi paragonabile
a quella osservata nella crisi alimentare mondiale nel 2007-2008. Tra le cause dell'aumento dei costi, secondo
Abdolreza Abbassian, capo economista alla FAO, vi fu la "siccità in Russia e Kazakistan, accompagnata dalle
inondazioni in Europa, Canada e Australia, associate a incertezza sulla produzione in Argentina", a causa della
quale i governi dei Paesi del Maghreb, costretti ad importare i generi commestibili, decisero per l'aumento
dei prezzi dei prodotti alimentari di largo consumo. Altri analisti hanno messo in risalto il ruolo della
speculazione finanziaria nel determinare la crescita del prezzo dei generi alimentari in tutto il mondo. Prezzi
più alti si registrarono anche in Asia e in particolare in India, dove vi furono rialzi nell'ordine del 18%, e in
Cina, con aumento dell'11,7% in un anno.
15
Tratto da https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Primavera_araba&oldid=78348408
29
Cause e scoppio della guerra civile sino a Ginevra 216
Sulla scia della primavera araba nel gennaio 2011 parte della popolazione siriana, organizzandosi sui social
network, decide di scendere in piazza a protestare contro il partito Ba’th unico partito al potere dal 1970,
capeggiato dalla famiglia di Al-Assad e guidato attualmente da Bashar al-Assad che è il presidente della Siria.
In risposta alle proteste Al-Assad censura Facebook, Twitter e Youtube revocando il bando pochi giorni dopo
dichiarandosi fiducioso nel corretto utilizzo della rete, viene qualche giorno più tardi arrestata una blogger
siriana con l’accusa di lavorare per la CIA.
Nel marzo 2011 le rivolte non si placano e, mentre vengono celebrati i funerali di alcune vittime degli scontri
nelle piazze, alcuni manifestanti danno fuoco ad una sede del partito di Ba’th. Nel tentativo di sedare i
rivoltosi il governo promette una più serrata lotta alla corruzione ed un imminente aumento dei salari, non
prima di aver accusato i media stranieri di fomentare la rivolta.
Il 15 marzo scoppiano a Dar’a, nella Siria meridionale, nuove rivolte che il governo ordina di reprimere
militarmente il 18 marzo, causando 400 morti e 500 arresti. Dopo questo episodio scoppiano rivolte in altre
città siriane: Latakia, Tartus, Aleppo e nella capitale Damasco. Tra le file dei rivoltosi appaiono per la prima
volta bandiere appartenenti alla fratellanza mussulmana. A maggio il bilancio delle proteste è di mille morti
e diecimila arresti.
Il 4 giugno, a Jisr ash-Shugur, nella provincia di Idlib, la protesta assume caratteristiche violente e i
manifestanti aggrediscono le forze di polizia uccidendo otto persone e prendono il controllo della stazione di
polizia locale, saccheggiandola e distribuendo le armi trovate al suo interno. Gli scontri continuano nella
settimana seguente, provocando la morte di centoventi poliziotti.
Il 3 luglio ad Hama si svolge la più grande manifestazione contro il governo, quest’ultimo mette in campo una
durissima repressione inviando l’esercito che riesce a riportare la calma mietendo più di duecento morti.
L’azione è criticata dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea. Dopo queste azioni efferate alcuni ufficiali disertori
dell’esercito governativo si riorganizzano contro il regime fondando l’Esercito Siriano Libero (ESL) che istruì i
ribelli per un’eventuale guerriglia armata.
Al-Assad decise di liberare 755 detenuti e di modificare la costituzione siriana, eliminando il monopartitismo
ed introducendo un massimo di anni di mandato per la carica del presidente, democratizzando così il paese.
Il 26 febbraio 2012 il popolo può votare un referendum per approvare queste disposizioni, ma i ribelli,
insoddisfatti, lo boicottano. Le rivolte si inaspriscono e tra le file ribelli appaiono le bandiere nere di Al-Qaeda.
Per contrastare i ribelli vengono impiegati dal governo combattenti shabīḥa, bande composte da siriani
alawiti legati alla criminalità, che nell’aprile 2012 si rendono colpevoli di due massacri: la strage di Hula, 108
persone uccise a sangue freddo, e quella di Al-Qubeir, 78 morti. Il governo cerca di negare un suo
coinvolgimento attribuendo invece la colpa ai ribelli. Molte nazioni prendono le distanze dal governo di AlAssad espellendo l’ambasciatore siriano e sostenendo alcune apertamente i ribelli. La Turchia fornisce armi
all’ESL, e dà rifugio ai vertici militari dell’opposizione, che hanno sede ad Istanbul; USA, Francia, Gran
Bretagna e gli Stati del Golfo Persico iniziano a finanziare i ribelli, mentre l’UE inasprisce l’embargo sulla Siria.
Russia, Iran e Corea del Nord appoggiano invece il governo siriano.
Nel luglio 2012 i Curdi che vivono nel nord della Siria si organizzano militarmente per chiedere l’indipendenza.
L’Iran per supportare Assad appoggia gli sciiti libanesi di Hezbollah che si uniscono nella guerra civile.
Nell’aprile 2013 il contingente jihadista, integralisti sunniti, è largamente finanziato dai Sauditi, destando la
preoccupazione dell’Iran, paese a maggioranza sciita. Secondo fonti interne il 21 agosto 2013 il governo
siriano avrebbe usato armi chimiche contro la popolazione: l’ONU manda degli ispettori che confermano
l’episodio. Nel frattempo David Cameron, primo ministro britannico, non riceve l’appoggio del Parlamento
16
30
Paragrafo elaborato dal video https://www.youtube.com/watch?v=cokQDfetJsk consultato il 24 gennaio 2016.
all’intervento in Siria, rimandando la discussione al G20 che si tiene nel settembre 2013. Durante il summit
la Russia si accorda con gli USA: l’intervento militare non avverrà ma la Siria dovrà distruggere
completamente l’arsenale chimico. USA e GB supportano apertamente l’ESL, ma la forte vicinanza dei gruppi
jihadisti ai ribelli costringe ad interrompere ogni supporto. A gennaio 2014 si apre Ginevra 2, conferenza di
pace che vede la partecipazione di tutte le parti in guerra tranne i fronti islamici estremisti.
La conferenza riesce a siglare una tregua tra le parti che permette ad una parte della popolazione di evacuare
le zone di confine. Tuttavia non si giunge ad un vero trattato di pace, ed il segretario generale dell’ONU
annuncia il fallimento del summit scusandosi con i siriani. Intanto sia il fronte ribelle che quello jihadista si
frazionano.
Dopo la conferenza17
Nella Conferenza di Pace Ginevra 2, che vede protagonisti il Governo siriano, la Coalizione Nazionale Siriana
e il fronte curdo, si riesce a siglare una tregua tra le parti, che permette, ad una parte della popolazione, di
evacuare dalle zone di conflitto. Dopo l'iniziale rischio di fallimento del negoziato, Ginevra 2 si chiude senza
altri accordi tra le delegazioni, tanto che l'inviato speciale dell'ONU ne annuncia il fallimento, scusandosi con
il popolo siriano.
Intanto sia il fronte ribelle che quello jihadista si frazionano. Alcuni membri siriani ed iracheni delle
organizzazioni islamiste, vedendo l'opportunità di rovesciare il governo di Assad, cercano di instaurare uno
Stato islamico basato sulla sharia. Il Fronte jihadista, appoggiato dai ribelli, attacca le basi dello Stato Islamico
dell'Iraq e Levante, noto alla stampa internazionale con l’acronimo ISIS. Per la prima volta si registrano scontri
significativi anche tra lo Stato Islamico e al-Nusra.
Nel giugno 2014 si svolgono le elezioni presidenziali, che, secondo la nuova costituzione siriana, permettono
la presenza di più candidati. I seggi elettorali vengono però installati solo nelle aree controllate dal governo.
I ribelli siriani, lo Stato islamico e i Curdi non partecipano al voto, definendolo una farsa. Si assiste ad una
forte presa di posizione dei governi internazionali: la maggior parte dei Paesi occidentali, tra cui Stati Uniti,
Canada, Belgio, Francia, Germania, e Arabia Saudita, Turchia, Egitto ed Emirati Arabi Uniti non permettono
ai residenti siriani di recarsi a votare nella loro ambasciata. Altre 30 nazioni, tra cui Russia, Iran e Venezuela
invece riconoscono la consultazione inviando osservatori per garantire il corretto svolgimento delle
operazioni di voto.
Il governo siriano comunica un'affluenza alle urne molto alta. Nelle zone di confine tra le aree controllate dai
ribelli e dai lealisti si registrano alcuni attacchi volti a scoraggiare il voto. Bashar al-Assad esce vincitore dalle
elezioni con l'88.7% di preferenze, distanziando di molto gli altri due candidati e riconfermandosi presidente
per la terza volta.
Contemporaneamente alle elezioni, lo Stato Islamico, già attivo nell'ovest dell'Iraq, ne occupa il nord e
rapidamente conquista Mossul, seconda città del Paese, provocando la fuga di 500.000 persone. Entrano in
possesso di molte armi di fabbricazione americana, abbandonate dall'esercito iracheno, e di mezzo milione
di dollari. Vengono rilasciati 2.400 detenuti, tutti si uniscono alla causa islamista. Lo Stato Islamico si spinge
fino alla periferia di Baghdad, e contemporaneamente cancella una lunga fascia di confine tra Iraq e Siria.
Verso la fine di Giugno, il leader dello Stato Islamico, Abu Bakr al-Baghdadi, annuncia l'instaurazione di un
califfato nei territori controllati tra Siria e Iraq e chiede a tutti i musulmani di aderirvi. L’obiettivo è quello di
sconfiggere le altre formazioni dissidenti siriane, in particolare il Fronte al-Nusra. Una volta rapidamente
eliminate, gli islamisti entrano in conflitto con il governo siriano.
L’Iraq invoca l'intervento internazionale e si rivolge direttamente agli Stati Uniti, chiedendo un immediato
supporto aereo. Nell’Agosto, lo Stato Islamico rompe le linee di difesa dei peshmerga Curdi nella Regione
17
Trascrizione del video https://www.youtube.com/watch?v=c262Z_d9tHE consultato il 24 gennaio 2016.
31
autonoma del Kurdistan Iracheno. Vengono conquistate alcune cittadine a maggioranza cristiana,
provocando la fuga di 200.000 persone che temono il massacro per motivi religiosi.
Viene organizzata una coalizione che raggruppa 11 paesi occidentali. L'intervento occidentale contro lo Stato
Islamico si limita all'Iraq. A Settembre, operano i primi bombardamenti sul territorio siriano. Il governo
siriano, informato con la mediazione dell'Iran, non viene consultato per coordinare gli attacchi o chiedere
l'autorizzazione. Tuttavia viene rilasciata una dichiarazione che afferma: "la Siria appoggia ogni iniziativa
internazionale nella lotta contro gli jihadisti". La coalizione guidata dagli Stati Uniti comprende 5 nazioni
arabe: Bahrein, Giordania, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Tra i primi obiettivi vi sono tutti i
principali centri urbani controllati dall'ISIS, tra cui Raqqa e, inaspettatamente, anche postazioni del Fronte alNusra. Nel giorno stesso dell'inizio dei bombardamenti, viene siglato un patto di non aggressione tra ISIS e le
altre formazioni ribelli.
Sul terreno, a metà settembre, l'ISIS scatena una imponente offensiva verso la regione di Kobane, confinante
con la Turchia e controllata dalle milizie curde YPG. L'attacco provoca il flusso di 300.000 profughi verso la
Turchia. La vicinanza degli scontri, spinge la Turchia a schierare le proprie truppe al confine. Tuttavia,
ignorando le richieste della minoranza curda e degli Stati Uniti, il presidente Erdogan si rifiuta di fornire aiuti
ai miliziani Curdi. Solo a inizio Novembre viene permesso l'ingresso in città di un piccolo contingente di Curdi
iracheni.
Il Fronte al-Nusra rompe l'alleanza con l'Esercito siriano libero ed attacca le sue postazioni nel il
governatorato di Idlib, sequestrando tutto l'armamento e costringendo i miliziani a scappare in Turchia o a
unirsi al Fronte.
A Gennaio 2015, le milizie curde annunciano che la città di Kobane è riconquistata. Con il fondamentale
appoggio dei peshmerga iracheni, dell'aviazione americana e di alcune unità dell'Esercito Siriano Libero,
riescono in un mese a riconquistare tutte le cittadine perse. Nel Febbraio 2015, l'esercito siriano scatena una
potente offensiva sul fronte meridionale. Per la prima volta partecipano in maniera diretta molte unità dei
pasdaran iraniani, oltre che molti miliziani Hezbollah e alcune milizie sciite afghane.
Compaiono i primi cedimenti politici nel governo: si verificano imprigionamenti, fughe e uccisioni di membri
interni al partito Baath, accusati di ordire un colpo di stato. Nel fronte jihadista, nasce Jaish al Fatah (Esercito
della Conquista). A Marzo, Jaish al Fatah prende il controllo della provincia di Idlib, annunciando
l'instaurazione della sharia.
A Giugno, un centinaio di miliziani islamisti penetra nella città di Kobane facendo esplodere tre autobomba
vicino al confine con la Turchia, attaccando i Curdi dalle retrovie. L'effetto sorpresa rende complessa la
risposta dei Curdi, che accusano la Turchia di aver permesso l'accesso dei combattenti islamisti attraverso il
suo territorio. Intanto, il Fronte al-Nusra compie un massacro nella provincia di Idlib, uccidendo 20 civili drusi
in un villaggio, i quali reagiscono con una dichiarazione in cui spingono la popolazione a sostenere il governo
e unirsi all'esercito regolare.
Sviluppi recenti
Gli ostaggi e la propaganda
L’organizzazione terroristica si è distinta per una grande attività di propaganda attraverso i social media,
elaborando video e materiale documentario destinati alla pubblicazione online e di qualità spesso
professionale. Alcuni dei video di Daesh a scopo esplicitamente intimidatorio ritraggono le barbare
esecuzioni dei prigionieri di guerra, talvolta giornalisti occidentali i cui paesi d’origine si sono rifiutati di
pagare il riscatto. Riportiamo un articolo pubblicato da Maurizio Molinari su lastampa.it il 07/02/15:
Mezzi di propaganda, scudi umani. Così il Califfo fa politica con gli ostaggi
32
Divulgare la brutalità del Califfato, scompaginare la coalizione guidata dagli Usa, portare la guerra in Europa,
moltiplicare i proseliti, irridere il nemico e ottenere vantaggi tattici: sono gli obiettivi che Abu Bakr al
Baghdadi, Califfo dello Stato Islamico (Isis), persegue con una gestione degli ostaggi che somma malvagità e
cinismo.
Mosse studiate a tavolino
L’americano James Foley è il primo ad essere decapitato, il 19 agosto, e l’intento è duplice. Primo: a 50 giorni
dalla nascita del Califfato, trasformare la jihad in un messaggio globale grazie alla miscela fra brutalità della
decapitazione ed efficienza delle produzioni video. Secondo: a due settimane dall’inizio dei raid Usa contro
Isis far capire a Obama che pagherà un prezzo alto di sangue. Il 2 settembre viene decapitato l’americano
Steven Satloff e poi identica sorte tocca ai britannici David Haines e Alan Henning. Scenografia e metodo delle
esecuzioni si ripetono per far capire che Isis punisce in ugual misura Usa e alleati. Vuole portare lo scompiglio
nella coalizione: nel «Messaggio agli alleati degli Usa» letto dal boia di Haines si esplicita l’intenzione di
«rispondere ai bombardamenti contro di noi». È la sintesi della guerra asimmetrica: voi bombardate, noi
decapitiamo.
La vendetta
A fine ottobre il Califfo sopravvive a un raid Usa e la reazione è brutale: l’americano Peter Kassig viene
decapitato in un video che mostra 18 soldati siriani sgozzati da altrettanti jihadisti, molti dei quali francesi e
inglesi a volto scoperto. Si svela così l’esistenza delle brigate europee a cui un audio del Califfo chiede di «far
esplodere i vulcani del jihad in terre nemiche». È l’annuncio di attacchi in Europa, retrovia della coalizione,
grazie a reclute jihadiste locali attirate dai video con esecuzioni cruente.
La conferma dell’uso di ostaggi a fini tattici viene dalle vicende parallele di 46 diplomatici turchi e 29 soldati
libanesi catturati. I turchi, presi a Mosul, vengono restituiti incolumi ad Ankara al termine di un negoziato
segreto reso possibile dalla scelta di Erdogan di resistere alle pressioni Usa per l’impiego di truppe di terra. I
libanesi, catturati nell’Arsal, sono a tutt’oggi oggetto di trattative con Beirut, a cui Isis chiede la liberazione
delle jihadiste detenute, inclusa l’ex moglie di al Baghdadi.
La richiesta di riscatti
Ancora in vita è John Cantlie, il britannico che diventa reporter pro-Isis in una serie di video in cui irride la
coalizione: dai falliti blitz ai milioni spesi. Cantlie è un’arma preziosa nella guerra di propaganda per reclutare,
anche qui sostenuto da tecnici video di grandi qualità. Già con Foley, Isis aveva provato a chiedere riscatti
economici ma in segreto. Con i giapponesi Haruna Yukawa e Kenji Goto la richiesta diventa pubblica - 200
milioni di dollari - tradendo la difficoltà nel reperire liquidi a seguito del crollo del greggio.
Poiché Tokyo non paga, Isis mette sul piatto un riscatto umano: la jihadista Sajida al Rishawi detenuta da
Amman, che però reagisce impiccandola. Il pilota giordano Muath Kasasbeh arso vivo è una sfida al re
Abdullah, alleato della coalizione, che si comprende meglio guardando il video dell’esecuzione: disseminato
di notizie top-segret. Nel caso dell’americana Kayla Jean Mueller l’obiettivo tattico è palese: annunciarne la
morte sotto le bombe giordane per innescare tensioni Washington-Amman.
Scudi umani
È un metodo che ricorda l’uso degli scudi umani da parte di Saddam nel 1991. D’altra parte un terzo dei 25
capi militari del Califfato vengono dal Baath iracheno. Sono questi veterani di Saddam, a cominciare dai
generali, al-Turkmani e al-Anbari, a spingere il Califfo all’uso più cinico degli ostaggi. Mentre la malvagità
viene da Omar al-Shishani, il caucasico dai modi spietati che guida i volontari stranieri ed è dunque il diretto
superiore di Jihadi John, il boia con accento di Oxford.
Gli attentati
Di seguito un elenco dei principali attacchi terroristici compiuti dall'ISIS nel mondo18.
18
Tratto da https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stato_Islamico&oldid=78422525 e fonti annesse.
33
34
24 maggio 2014, Bruxelles (Belgio): un uomo apre il fuoco all'interno del Museo ebraico della capitale
belga, uccidendo quattro persone.
18 settembre 2014, Sydney (Australia): un uomo viene arrestato durante una serie di incursioni
antiterroristiche, accusato di cospirare con un capo dell'ISIS in Siria.
23 settembre 2014, Melbourne (Australia): un diciottenne simpatizzante dell'ISIS fu ucciso dopo aver
accoltellato due poliziotti davanti alla stazione di polizia di Melbourne.
24 settembre 2014, Algeria: militanti rapiscono e decapitano un turista francese dopo la chiamata
dello Stato Islamico a danneggiare gli europei in rappresaglia per gli attacchi aerei in Iraq e in Siria.
20 ottobre 2014, Montreal (Canada): un venticinquenne che di recente aveva aderito all'Islam
radicale corre verso due soldati uccidendone uno.
22 ottobre 2014, Ottawa (Canada): un islamico convertito spara e uccide un soldato di guardia al
Memorial nazionale della guerra di Ottawa, prendendo poi d'assalto il parlamento del Canada e
sparando molte volte prima di essere ucciso.
23 ottobre 2014, New York (Stati Uniti): un uomo brandendo una scure attacca quattro poliziotti nel
quartiere Queens. L'Isis disse che l'attacco fu un risultato diretto della sua "chiamata" di settembre.
Novembre 2014, Hebron (Cisgiordania): I servizi segreti israeliani bloccano una cellula palestinese
identificata come facente parte dello stato islamico nella città di Hebron.
15 dicembre 2014, Sidney (Australia): un uomo entra in una cioccolateria e prende in ostaggio clienti
e dipendenti del locale. All'arrivo della polizia ne scaturisce una sparatoria che provoca due vittime
oltre al terrorista.
8-9 gennaio 2015, Parigi (Francia): un uomo uccide una poliziotta in centro e quattro persone in un
supermercato ebraico Kosher, sincronizzando i suoi attacchi con l'attentato alla sede di Charlie
Hebdo. Mentre quest'ultimo viene rivendicato da Al-Qāʿida nella Penisola Arabica, gli altri sono
attribuiti allo Stato Islamico.
14-15 febbraio 2015, Copenhagen (Danimarca): un giovane apre il fuoco in un locale dove si teneva
un convegno sulla libertà di espressione e uccide una persona ferendo tre poliziotti, poi si sposta nei
pressi della sinagoga dove ferisce gravemente un ebreo che morirà in seguito. Il terrorista viene
ucciso in seguito dalla polizia. (attentati di Copenaghen).
18 marzo 2015, Tunisi (Tunisia): attentato al museo nazionale del Bardo a Tunisi, tre terroristi
irrompono al Museo nazionale del Bardo sparando sui turisti all'interno e all'esterno del museo,
uccidendo ventidue persone e ferendone quarantacinque. Due dei tre terroristi vengono uccisi dalla
polizia.
18 aprile 2015, Jalalabad_ (Afghanistan): due esplosioni rivendicate dall'Isis provocano la morte di
oltre trentacinque persone.
3 maggio 2015, Dallas (Stati Uniti): due uomini aprono il fuoco con fucili d'assalto a un concorso di
vignette su Maometto ferendo un agente; la sicurezza risponde al fuoco e uccide gli attentatori.
26 giugno 2015, Susa (Tunisia): attentato di Susa, uomini armati sparano sui turisti in spiaggia
provocando trentanove morti.
26 giugno 2015, Kuwait City (Kuwait): nello stesso giorno dell'attacco sulla spiaggia tunisina, un
kamikaze dello Stato Islamico si fa esplodere in una moschea sciita, le vittime sono ventisette.
11 luglio 2015, Il Cairo (Egitto): una bomba scoppia sotto il consolato italiano nella capitale egiziana,
nessun ferito. L'Isis rivendica l'attentato.
20 luglio 2015, Turchia (confine con la Siria): una kamikaze si fa esplodere nella città di Suruç
provocando oltre trenta vittime.
21 agosto 2015, tratta ferroviaria Amsterdam-Parigi: sventato attentato sul treno, un uomo armato
di kalashnikov viene fermato da due militari in borghese prima che potesse compiere una strage.
Feriti un militare e un passeggero.
10 ottobre 2015, Ankara (Turchia): un attacco kamikaze dello Stato Islamico durante una marcia della
pace organizzata da filo-Curdi uccide almeno centoventotto persone.
31 ottobre 2015, Sinai (Egitto): un aereo passeggeri russo precipita nel deserto del Sinai uccidendo
tutte le 224 persone a bordo, l'ISIS dichiara sua la responsabilità nell'aver piazzato un ordigno che è
esploso durante il volo disintegrando l'aereo.
4 novembre 2015, Egitto: affiliati del califfato del Sinai in Egitto commettono un attacco suicida
uccidendo quattro poliziotti.
12 novembre 2015, Beirut (Libano): l'ISIS dichiara sua la responsabilità di un doppio attentato suicida
che uccide almeno qurantatre persone in un distretto dello shopping nell'ora di punta a Beirut.
13 novembre 2015, Parigi (Francia): attacco terroristico di Parigi, una serie di attacchi coordinati in
vari punti della città portati a termine da un commando dell'ISIS formato da nove esecutori materiali
e da fiancheggiatori uccidono centotrenta persone e ne feriscono trecentocinquanta. Vengono colpiti
da sparatorie a colpi di Kalasnikov il teatro Bataclan e vari ristoranti e locali nel centro parigino, tre
kamikaze si fanno saltare in aria all'esterno dello Stade de France durante l'amichevole di calcio
Francia-Germania. Si tratta del peggior attentato mai avvenuto in Francia e il secondo più grave in
Europa dopo quelli di Madrid del 2004.
14 novembre 2015, sud-est Turchia: in concomitanza con l'inizio del G20 nella città di Antalya, un
attacco suicida ferisce quattro agenti di polizia.
24 novembre 2015, El Arish (Egitto): autobomba davanti a un hotel provoca sei vittime, tra cui due
giudici. Un gruppo legato all'ISIS rivendica nelle ore immediatamente successive.
24 novembre 2015, Tunisi (Tunisia): lo stesso giorno dell'attacco in Egitto un kamikaze si fa esplodere
su un minibus di guardie presidenziali causando la morte di dodici persone, anche questo attentato
viene rivendicato dall'Isis.
2 dicembre 2015, San Bernardino (Stati Uniti): l'ISIS si attribuisce la responsabilità della strage
compiuta da un uomo e sua moglie all'interno di un centro disabili: le vittime sono quattordici.
6 dicembre 2015, Aden (Yemen): l'Isis rivendica un attacco in cui sono rimasti uccisi il governatore di
Aden e sei guardie del corpo.
1º gennaio 2016, Tel Aviv (Israele): un uomo israeliano di origine araba entra in un pub nel centro
della capitale israeliana e apre il fuoco uccidendo due persone e ferendone una decina, prima di
fuggire; nei giorni successivi verrà individuato e ucciso dalla polizia. In seguito l'ISIS dichiarerà che
l'attentatore era un proprio sostenitore.
7 gennaio 2016, Zliten (Libia): un camion bomba viene lanciato contro un centro di addestramento
di polizia, provocando 74 vittime. L'azione viene immediatamente rivendicata dal califfato islamico,
nel pieno di una nuova offensiva nel Paese nord-africano.
11 gennaio 2016, Baghdad (Iraq): una ventina di uomini armati fanno irruzione in un centro
commerciale aprendo il fuoco, dopo aver fatto esplodere un ordigno all'esterno. I morti sono 38, 18
civili, oltre ai 20 terroristi uccisi dalla polizia. Nello stesso giorno un uomo si fa saltare in aria in un
casinò nell'est del Paese a 80 km dalla capitale, all'arrivo dei soccorsi viene fatta esplodere un
autobomba all'esterno provocando una strage: almeno 23 le vittime. Lo Stato Islamico rivendica
entrambi gli attacchi in un comunicato.
12 gennaio 2016, Istanbul, (Turchia): un kamikaze si fa esplodere nel cuore della capitale in una zona
turistica, uccidendo 10 turisti tedeschi e ferendo altre 15 persone. L'ISIS ne rivendica anche in questo
caso la responsabilità.
14 gennaio 2016, Giacarta (Indonesia): un commando di terroristi tiene sotto assedio per ore la
capitale indonesiana, con esplosioni di bombe e sparatorie, provocando la morte di due persone e
diversi feriti. Cinque attentatori che si erano asserragliati in un edificio dove vi è situata una sede
dell'ONU vengono uccisi dalla polizia. L'ISIS rivendica nuovamente gli attentati terroristici. Il Paese
35
nel mirino dell'estremismo islamico da anni prevalentemente da parte di Al Qaeda, subisce così il
primo attacco dello Stato Islamico.
I Foreign Fighters
Riportiamo un articolo di Claudio Galzerano19 pubblicato su Poliziamoderna di marzo 2014.
Foreign fighters
Militanti islamisti europei vanno ad ingrossare le fila dei gruppi terroristici.
Tra le molteplici, drammatiche conseguenze connesse alla spiralizzazione del conflitto siriano, la comunità
internazionale della sicurezza ha da tempo richiamato l’attenzione su un fenomeno in particolare, quello dei
militanti islamici che dai Paesi dell’Unione Europea raggiungono il teatro delle operazioni per partecipare alle
ostilità.
Questi viaggi del jihad, compiuti cioè da militanti “europei” per combattere all’estero tra le fila di milizie che
utilizzano metodi terroristici in conflitti non convenzionali, non sono un fenomeno del tutto nuovo, anzi.
Già negli Anni ’80 e ’90, poi ancora nello scorso decennio, i Servizi antiterrorismo di mezza Europa
documentarono con le loro indagini l’esistenza di un vasta attività di reclutamento, spesso effettuata
all’ombra delle moschee più radicali stanziate nel vecchio continente, finalizzata a istradare giovani
mujahedin verso zone caratterizzate da conflitti interetnici e religiosi.
Dalla regione afgano-pakistana al Nord Africa, dal Caucaso all’Iraq, ovunque in pratica le fazioni islamiche
locali avessero impugnato le armi per abbattere le istituzioni sostituendole con emirati islamici fondati
sull’applicazione integrale della shari’a (legge islamica), si assistette già allora ad un consistente flusso di
aspiranti combattenti provenienti dall’Europa (vedi Poliziamoderna aprile 2012, ndr).
Quella che risulta veramente nuova, rispetto all’attuale conflitto siriano, è la dimensione numerica assunta
dal fenomeno.
Polarizzando i mai sopiti istinti ribellisti-jihadisti presenti nella quota più esasperata degli ambienti
integralisti islamici europei, la Siria ha finito per costituire un ampio canale di sfogo in cui sono confluiti non
solo vecchi protagonisti della scena islamista europea – spesso già indagati, processati, condannati ed espulsi
per le loro attività terroristiche – ma anche le nuovissime leve della cosiddetta inspire generation. Con questo
termine si individua una specifica categoria di militanti, in genere estranei agli ordinari circuiti delle moschee,
19
Direttore 2^ divisione del Servizio centrale antiterrorismo della Dcpp/Ucigos, presidente del Terrorism working
group del Consiglio Europeo durante il semestre di Presidenza italiana.
36
all’apparenza isolati, talvolta autoctoni, privi di connessioni evidenti con i network terroristici internazionali,
la cui adesione incondizionata ad una visione jihadista dell’Islam è conseguenza diretta della propaganda
radicale diffusa in Rete grazie a magazine esclusivamente online come Inspire.
Attraverso questa curatissima rivista web ideologi radicali del calibro di Anwar al-Awlaqi – il cittadino
americano di origine yemenita ucciso in Yemen da un drone statunitense nel settembre 2012 – sono riusciti
nell’intento di inoculare in tanti giovani musulmani residenti in Occidente rapidi processi di radicalizzazione,
trasformandoli in veri e propri mujahedin internauti e aprendo di fatto loro la strada verso scenari di conflitto,
come quello siriano, dove vanno ad ingrossare le fila dei gruppi qaedisti Jabhat al-Nusra e Stato islamico
dell’Iraq e del Levante (ISIL).
In una di queste organizzazioni sembrerebbe militare, dal settembre del 2013, un immigrato marocchino
21enne della provincia di Brescia, protagonista di un rapido percorso di radicalizzazione jihadista su Internet
che aveva attirato l’attenzione dell’Antiterrorismo.
Questo ragazzo – nom de guerre di Anas al Italy (Anas l’Italiano) – infatti aveva creato un blog, Sharia4Italy,
con cui manteneva contatti con i vertici del movimento islamico ultra radicale pan-europeo Sharia4, stanziati
in Belgio. Arrestato, nella sua abitazione a Vobarno, nel giugno dello scorso anno per addestramento con
finalità di terrorismo, Anas al Italy era stato rimesso in libertà dal tribunale del riesame dopo circa un mese
di detenzione. L’autorità giudiziaria, pur avendo riconosciuto le sue posizioni radicali, aveva infatti ritenuto
che questi non fosse in procinto di attuare concreti programmi di violenza.
In chiave di prevenzione, il fenomeno dell’afflusso verso la Siria di questa tipologia di militanti islamici desta
forti preoccupazioni per più di un motivo. Europol, nel suo rapporto sul terrorismo 2013, e il coordinatore
antiterrorismo dell’UE, Gilles De Kerchove, hanno già da tempo reso pubblico il timore delle istituzioni
europee circa il fatto che questa diaspora di combattenti abbia in sè il potenziale di creare una futura ondata
di terrorismo capace di minacciare gli Stati dell’Unione.
Le incognite connesse al fenomeno del ritorno dei reduci dalle zone di conflitto (cosiddetto reducismo)
risiedono soprattutto nella considerazione che questi ex combattenti, forti delle capacità operative e del
carisma acquisiti sul campo, possono contribuire al processo di radicalizzazione di individui più vulnerabili,
così come alla costituzione di reti attive nel reclutamento e nell’instradamento di volontari o, addirittura, alla
pianificazione di progettualità terroristiche autonome o dettate dai gruppi nei quali hanno militato.
Secondo cifre rese note nel dicembre del 2013 dalla presidenza lituana del Consiglio dell’Unione Europea, il
numero dei foreign fighters che hanno lasciato l’Europa alla volta della Siria ammonterebbe a circa 2.000
militanti.
Sempre il rapporto di EuropoI sul terrorismo 2013 evidenzia come importanti operazioni di polizia connesse
alla partenza o al ritorno di militanti islamisti dal quadrante siriano siano state condotte soprattutto in Belgio,
Francia, Olanda e Regno Unito, Paesi questi dove la problematica è fortemente preoccupante. Analogamente
ad altri Paesi dell’Europa meridionale, il fenomeno ha per il momento assunto in Italia dimensioni
numericamente piuttosto modeste..
Al netto della dozzina o poco più di militanti nazionalisti siriani oppositori del regime di Assad tornati in patria
per unirsi al Free Syrian Army, la presenza sul fronte siriano di jihadisti partiti, transitati o comunque, a vario
titolo, collegati all’Italia è da stimarsi intorno a poche unità.
Con l’eccezione della drammatica vicenda del ventiquattrenne genovese Giuliano Delnevo, convertitosi
all’Islam col nome di Ibrahim, rimasto ucciso nei pressi di Aleppo all’inizio del maggio 2013 in uno scontro
che vedeva impegnata la milizia a guida cecena in cui il giovane militava, si tratta per lo più di stranieri che
risiedono o hanno risieduto nel nostro Paese, alcuni dei quali già emersi in precedenti attività di settore.
37
Allo stato, le indagini non hanno confermato la presenza di filiere stabili attive nel nostro Paese
nell’instradamento di estremisti verso la Siria.
L’impegno del Servizio centrale antiterrorismo della Dcpp/Ucigos nel sistematico monitoraggio del
fenomeno, implementato anche grazie allo scambio informativo con il comparto nazionale intelligence e con
gli uffici antiterrorismo del Police working group on terrorism (Pwgt), ha consentito di individuare foreign
fighters che, partendo dagli altri Paesi europei, hanno utilizzato il territorio nazionale come hub per
raggiungere o ritornare dal conflitto siriano.
Su questo fronte, un importante risultato investigativo è stato colto con il rintraccio – operato dalla polizia
di frontiera il 16 gennaio scorso nel porto di Ancona – del foreign fighter franco-tunisino Abdelkader Tliba,
destinatario di un mandato di cattura europeo emesso dalla Francia per associazione con finalità di
terrorismo.
L’arresto dello straniero – estradato in Francia il 31 gennaio scorso, a sole due settimane dall’arresto – si
inserisce nel contesto di una vasta indagine da tempo sviluppata in Francia anche con la collaborazione del
Servizio centrale antiterrorismo della Dcpp/Ucigos in seguito allo smantellamento, nell’ottobre del 2012, di
una cellula radicale islamica stanziata tra le città di Strasburgo, Torcy e Cannes.
Il capo della cellula, l’antillano 33enne Jeremy Louos-sidney, responsabile tra l’altro di un attacco
dinamitardo perpetrato il 19 settembre 2012 contro una drogheria kosher di Sarcelles (periferia di Parigi),
era rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia il successivo 6 ottobre 2012.
Proprio al settembre del 2012 si deve far risalire la partenza di Abdelkader Tliba verso la Siria, avvenuta
grazie alla filiera di istradamento di combattenti jihadisti facente capo al defunto Jeremy Lous-Sidney.
Sulla scorta della dimensione paneuropea del fenomeno dei foreign fighters, Consiglio e Commissione
Europea hanno già segnalato la necessità di ampliare lo spettro delelle misure preventive per il loro
monitoraggio (rafforzamento dei controlli di frontiera, introduzione di un Pnr europeo ecc.) e di attuare
misure di dissuasione basate sul dialogo e sul contrasto della radicalizzazione.
In attesa della verifica di fattibilità circa l’introduzione nel quadro giuridico comunitario della
criminalizzazione dei viaggi effettuati con finalità di terrorismo, l’Italia ha dal canto suo intenzione di
contribuire fattivamente al potenziamento degli interventi di natura preventiva proponendo, nell’ambito del
prossimo semestre di presidenza italiana del Gruppo terrorismo (Twp), la costituzione di squadre
multinazionali ad hoc con il fine di mettere a disposizione degli Stati membri effettivamente interessati dal
fenomeno dei foreign fighters uno strumento specifico che consenta un più efficace scambio informativo con
finalità operative.
Dati
Membri noti20
Membri attuali
20
38
Abu Bakr al-Baghdadi ("Emiro" autoproclamato dello Stato Islamico dell'Iraq nel 2010 e califfo dello
Stato Islamico dal 29 giugno 2014)
Abū ʿAlī al-Anbārī (vice comandante in Siria)
Abū Muḥammad al-ʿAdnānī (portavoce ufficiale)
Abū ʿOmar al-Shishānī (comandante ceceno in Siria)
Abū Waḥib (guerrigliero nel governatorato di al-Anbar, Iraq)
Tratto da https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stato_Islamico&oldid=78422525
Jihadi John (membro dello Stato Islamico britannico, presente in alcuni video di decapitazioni.
Risulterebbe ucciso in un raid aereo americano il 13 novembre del 2015, notizia poi confermata
dallo stesso Stato Islamico il 19 gennaio 2016)
Abū Yūsuf (comandante superiore per la sicurezza)
Abū Sulaymān al-Nāṣir ("ministro" della guerra)
Ex comandanti
Abū Muṣʿab al-Zarqāwī (ucciso nel 2006)
Abū Ayyūb al-Maṣrī (ucciso nel 2010)
Abū ʿOmar al-Baghdādī, anche noto come Abū ʿAbd Allāh al-Rāshid al-Baghdādī (ucciso nel 2010)
Abū Muslim al-Turkmanī (vice comandante in Iraq, ucciso nel 2014)
Ex membri
Abū Anas al-Shāmī (ucciso nel 2004)
Abū ʿAzzām (ucciso nel 2005)
Abū ʿOmar al-Kurdī (catturato nel 2005)
ʿAbd al-Hādī al-'Irāqī (catturato nel 2006)
Shaykh ʿAbd al-Raḥmān (ucciso nel 2006)
Ḥāmid Jumʿa Fāris Jurī al-Saʿīdī (catturato nel 2006)
Abū Yaʿqūb al-Maṣrī (ucciso nel 2007)
Haytham al-Badrī (ucciso nel 2007)
Khālid al-Mashhadānī (catturato nel 2007)
Māhir al-Zubaydī (ucciso nel 2008)
Muḥammad Mūmū (ucciso nel 2008)
Huthayfa al-Batawī (ucciso nel 2011)
Modalità di finanziamento di Daesh21
Uno studio di duecento documenti (lettere personali, note spesa e registri dei membri) appartenenti ad alQaida in Iraq e all'ISIS stesso è stato effettuato dalla RAND Corporation nel 2014. Si è scoperto che tra il 2005
e il 2010 le donazioni dall'estero arrivavano solo al 5% del capitale a disposizione del gruppo, il resto veniva
raccolto in Iraq. Nel periodo di tempo studiato, alle cellule era richiesto d'inviare fino al 20% degli introiti
derivanti da rapimento, estorsione e altre attività, al livello superiore della gerarchia del gruppo. I comandanti
di grado più alto avrebbero poi distribuito i fondi alle celle provinciali o locali che si trovavano in difficoltà o
avevano bisogno di soldi per condurre gli attacchi. I dati mostrano che per il denaro liquido ISIS contava su
membri di Mossul, la cui dirigenza era usata per elargire ulteriori fondi ai miliziani di Diyāla, Ṣalāḥ al-Dīn
(Salahuddin) e Baghdād che si trovavano in difficoltà.
Nella metà del 2014 lo spionaggio iracheno ha ottenuto informazioni da un membro dell'ISIS, il quale ha
rivelato che le risorse del gruppo ammontano a due miliardi di dollari statunitensi. L'ISIS è così il più ricco
gruppo jihadista del mondo. Alcune voci dicono che circa tre quarti di questa somma è rappresentata da
risorse di cui il gruppo si è impadronito durante la presa di Mossul nel giugno del 2014; queste includono fino
a 429 milioni di dollari rubati dalla banca centrale di Mossul, assieme ad altri milioni e a una grande quantità
di lingotti d'oro rubati da altre banche di Mossul. È stato però messo in dubbio il fatto che l'ISIS abbia potuto
recuperare una somma così imponente dalla banca centrale e abbia realizzato le rapine in banca di cui è
accusata.
21
Fonte: testo Wikipedia (vedi nota precedente), immagine https://www.forexinfo.it/ISIS-tutte-le-fonti-di
39
L'ISIS ha regolarmente praticato l'estorsione, ad esempio domandando denaro ai camionisti, minacciandoli
di far esplodere il loro carico. Le rapine in banca e alle gioiellerie sono state altre fonti di guadagno. È risaputo,
inoltre, che il gruppo abbia ricevuto
fondi da donatori privati dagli Stati
del Golfo, e sia il primo ministro
iraniano sia quello iracheno Nuri alMaliki hanno accusato l'Arabia
Saudita e il Qatar di finanziare l'ISIS,
senza però fornire prove.
Si pensa che il gruppo riceva dei
considerevoli finanziamenti dalle
sue operazioni nella Siria orientale,
dove ha sequestrato campi
petroliferi
e
contrabbandato
materiali grezzi e beni archeologici.
ISIS guadagna denaro anche dalla
produzione di petrolio greggio e
vendendo energia elettrica nella
Siria settentrionale e al governo
siriano. Fin dal 2012 l'ISIS ha
prodotto rapporti annuali dando
informazioni numeriche sulle sue
operazioni in uno stile che ricorda i
report aziendali, incoraggiando
potenziali donatori.
Come si vive nel Califfato
Riportiamo un articolo comparso22 su lastampa.it che spiega come si vive nel Califfato islamico.
Cavi elettrici riparati, affitti calmierati, marciapiedi verniciati, norme per proteggere la pesca, partorire negli
ospedali ma anche sul bando di prodotti Apple, le punizioni feroci, la vendita di protesi, e il diktat ai cristiani:
ad un anno dalla proclamazione il Califfato si distingue non solo per l’efferato terrore imposto ai circa 12
milioni di sudditi ma anche per l’impegno logistico ed amministrativo teso a migliorare le strutture pubbliche,
cercando di cementare il consenso per il potere assoluto. Regolando in maniera capillare ogni aspetto della
vita quotidiana. Ecco alcuni esempi, frutto di testimonianze e documenti raccolti dal ricercatore britannico
Aymenn Jawad Al-Tamimi, che descrivono come il Califfo gestisce il proprio territorio.
Il costo per partorire negli ospedali
L’amministrazione medica del Wilayat (Provincia) al-Kheir, l’ex siriana Deir az-Zor, ha stabilito i costi da
sostenere per far nascere i bambini in ospedale: 80 dollari per il parto cesareo e 55 per quello naturale con
la possibilità di tenere, in entrambi i casi, i bebè ricoverati nelle 12 ore seguenti alla nascita.
Pesca senza fare uso di esplosivi
L’intento nel Wilayat dell’Eufrate è «garantire l’abbondanza di pesci» e dunque vengono vietati lungo i fiumi
«l’uso della corrente elettrica, di materiali esplosivi e di tossine chimiche» perché «uccidono troppi pesci e
22
http://www.lastampa.it/2015/06/28/esteri/regole-divieti-e-punizioni-cos-si-vive-nel-califfatopJtmaxHPfQk0MTuB8bGIxH/pagina.html
40
rischiano di avvelenare ciò che altri mangeranno». È inoltre vietato «pescare durante la riproduzione dei
pesci» perché «distruggere le uova significa nuocere alla futura abbondanza di pesce».
Marciapiedi verniciati e fognature
Nel Nord della Siria il Califfato assicura ai residenti del Wilayat di Raqqa il ripristino dell’elettricità, la
realizzazione di impianti fognari «nel sottosuolo» e la verniciatura dei marciapiedi «per migliorare la vita dei
residenti».
Limiti ai profitti dei farmacisti
Tutte le farmacie del Califfato devono far avere alle amministrazioni locali i titoli di studio dei farmacisti e
non possono imporre alla clientela «aumenti di prezzo superiori al 20 per cento dell’etichetta».
Le scuole dell’obbligo a Raqqa
Nella maggiore città del Califfato in Siria le scuole dell’obbligo durano 9 anni, divise in 5 di elementari e 4 di
superiori. Dopo avviene la «selezione per college e atenei». Gli insegnanti devono aver seguito «un corso
preparatorio di 10 mesi» che include «60 giorni di lezioni sulla Sharia» e la firma di un documento finale di
«pentimento» per quanto fatto in passato contravvenendo alle norme dell’Islam.
Memorizzazione del Corano
Il comitato per l’«Insegnamento del Nobile Corano» prevede che ogni insegnante frequenti un corso a due
livelli, memorizzando prima «5 parti» e poi «3 parti» dimostrando una «corretta recitazione del testo». Per
frequentare bisogna avere fra 18 e 40 anni, senza assentarsi «se non quando la Sharia prevede».
Offerte di lavoro «qualificato»
Nella provincia di Raqqa gli uffici di collocamento offrono lavoro a chi è «qualificato» in «Scienze della
Sharia», contabilità, computer, amministrazione d’affari, educazione scientifica ed umanistica, preparazione
di insegnanti. Inoltre, il «Centro Hisbah» della polizia islamica cerca veterinari, guardie, ispettori sanitari,
macellai, boia «per tagliare le gole» e «addetti alle pulizie».
Limiti al movimento delle donne
Le donne sotto i 50 anni non possono uscire dai confini di Raqqa senza permessi e documenti di transito
emessi dalla polizia islamica, gli è «proibito» recarsi «nelle terre degli infedeli eccetto assolute urgenze
mediche». Le donne anziane non sono obbligate ad indossare l’hijab. Le donne possono salire e scendere
dagli autobus solo nei garage delle apposite fermate.
Le donne mostrino solo un occhio
La fatwa numero 40 del Califfato prevede che «mogli, figlie e donne dei credenti devono indossare all’esterno
abiti che non le facciano riconoscere o violentare». Per questo «le donne devono coprire i loro volti sin da
sopra la testa, mostrando solo l’occhio sinistro».
I reclami dei cittadini per i risarcimenti
Il Wilayat della provincia di Aleppo prevede che «chi ha subito torti e danni, personali o nelle proprietà, da
soldati o dirigenti dello Stato Islamico» può sottomettere dei «reclami» per ottenere «risarcimenti». Di
conseguenza a «soldati e dirigenti» viene chiesto di «fare attenzione ad evitare oppressione e aggressione
nei confronti dei cittadini» perché «vi saranno conseguenze anche nella vita futura».
L’ultimatum ai cristiani di Mosul
Emesso a Mosul dal Wilayat di Ninawa, offre ai «fedeli del Nazareno» tre scelte: «Convertirsi all’Islam,
accettare il patto di sottomissione pagando la tassa annuale “jizya” o “se rifiutano andranno incontro alla
spada».
Il divieto ai prodotti Apple
41
Si tratta di una disposizione del Califfo «a tutte le province, le sotto province ed i comitati locali» perché
«nell’interesse pubblico di proteggere le anime dei credenti» e «combattere i crociati» viene decretato il
«bando di ogni dispositivo elettronico con il gps» a cominciare da «telefoni, tablet e computer di Apple»
capaci di «creare gravi rischi a tutti».
La sharia
Per chi viola le norme della Sharia le punizioni sono le più feroci. La blasfemia è punita con la morte e se
l’insulto è nei confronti del Profeta «neanche il pentimento può salvare». L’adulterio è punito con la
lapidazione, l’omosessualità con la morte «sia dell’attivo sia del passivo», il furto con l’amputazione della
mano, bere il vino con 80 frustate, uccidere e rubare con la morte per crocifissione e «diffondere paura» con
l’«espulsione dal territorio».
Niente autostop sui camion
Nella provincia di Ninawa, in Iraq, camion e furgoncini hanno il divieto di dare passaggi a soldati o esponenti
del Califfato. È una misura tesa ad evitare che diventino obiettivi dei droni.
Affitti calmierati
Nel Wilayat dell’Anbar in Iraq, il Califfato stabilisce un tetto massimo di 84 dollari al mese per gli affitti di
case, circa un terzo del valore precedente perché «tocca ad Allah occuparsi delle cose materiali» mentre i
mujaheddin devono combattere.
Marchi contraffatti
Vendere prodotti con etichette falsificate è «proibito dal legislatore Maometto» perché si tratta di «un
inganno»: «chi vende deve spiegare con cura di dettagli produzione e provenienza».
Riflessione
Ci abbiamo lavorato parecchio ad un dossier sullo “Stato Islamico”, destinato ad essere aggiornato con lo
sviluppo degli eventi, speriamo possa essere una guida di riferimento nell’intricata questione. Per concludere
questo breve percorso vorrei proporre una breve analisi, giornalistica, non sarei in grado di sostenerne una
di rigore scientifico, richiamandomi ad alcuni concetti di antropologia per inquadrare meglio la questione.
Infatti se le dinamiche che hanno portato alla formazione dell’entità “Stato Islamico” sono molte e vanno
ricercate nella storia del popolo iracheno e di quello siriano, non si può trascurare la riflessione sulla loro
cultura e sui meccanismi sociali-antropologici che si instaurano nei periodi di crisi. Non è infatti un caso che
l’organizzazione abbia scelto di richiamarsi al califfato e al salafismo, islam sunnita integralista che si rifà alle
prime generazioni mussulmane dopo Maometto, e che Ibrāhīm ʿAwwād Ibrāhīm ʿAlī al-Badrī al-Sāmarrāʾī si
faccia chiamare Abū Bakr al-Baghdādī, omaggio ad Abu Bakr, primo califfo dell’Islam: per l’antropologia una
società in crisi tende a riproporre modelli vincenti, sia a livello politico, che, soprattutto, a livello culturale là
dove la società in crisi si rivolge alla tradizione per trovare elementi vincenti (e per questo tramandati da
essa) che permettano di conservare l’identità del popolo, che è aggregante.
Non si pensi però che questo richiamo ai primi tempi dell’Islam sia un tentativo di ritorno ad una sorta di
“Medioevo islamico”, o che Daesh sia in qualche modo “antico”: è invece moderno, qualcuno azzarderebbe,
non a torto, per alcuni aspetti, postmoderno, basti pensare alla diffusione propagandistica tramite video
montati ad arte e alla presenza dell’organizzazione sui social media. Ma non può dirsi neppure pienamente
omologato alla civiltà moderno-occidentale con cui in effetti si pone in contrasto, anzitutto violando il
paradigma della convivenza multiculturale che vige nel nostro mondo globalizzato, per cui tutte le culture
coesistono pacificamente: l’Islamismo jihadista ha richiamato più di una volta ad uno scontro diretto,
ottenendo in cambio il biasimo dell’Islam moderato occidentale (e.g. il CAIM).
Ciò permette di considerare un altro aspetto interessante della questione: l’efferata violenza del gruppo
terroristico colpisce anche altri mussulmani, sia gli sciiti (e.g. attentato alla moschea di Najaf) per motivi
42
religiosi, che i ribelli sunniti siriani e i mussulmani moderati, vittime ad esempio di alcuni degli attentati in
Occidente. Daesh è infatti anzitutto un gruppo con una fortissima tendenza integralista, su quest’ultimo
punto e sul rapporto intransigenza-Islam dovrebbe sorgere una riflessione. L’Islam, in effetti, che non nasce
intransigente, ha delle predisposizioni a diventarlo più facilmente che la cultura Occidentale. Questo accade
perché nella cultura musulmana il concetto di laicità e di separazione della sfera civile da quella religiosa
(riassumibile nel Date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio) è del tutto assente. Ciò genera
un’idealizzazione della legge come precetto trascendente e dunque non contempla la possibilità di mutarla,
conducendo all’integralismo, oltre che all’identificazione delle istituzioni statali con organi religiosi
(teocrazia). Tuttavia quella dell’integralismo resta una scelta, e non una prassi.
Il sedicente Stato Islamico, il cui cambio di nome nel 2014 (da ISIS/ISIL) ne tradisce la volontà espansionistica
di “creazione di un califfato mondiale”, confinato in Medioriente non rappresenta una vera e propria
minaccia politica in Occidente: sia a livello locale, con l’Iran ed Israele, che internazionale vi sono una serie di
nazioni pronte ad intervenire un’eccessiva espansione territoriale oltre la Siria e l’Iraq. E questione minore
sarebbero le possibili discussioni al Consiglio di Sicurezza, soprattutto USA-Russia, sulle eventuali modalità di
intervento.
Ma il vero problema legato all’islamismo sunnita per l’Occidente sono i lupi solitari – in gergo giornalistico -,
i terroristi nati e/o cresciuti in Europa, spesso convertiti in moschee integraliste, pronti a commettere
attentati anche mortali in nome della causa islamista. Questo fatto si può spiegare con una delle
caratteristiche del già citato postmodernismo, la perdita dell’identità e del senso dell’esistenza stessa. A
sposare la causa di Daesh sono infatti persone disposte a rischiare la vita, ma non per disprezzo verso di essa,
ma per caricarla, con la morte, di senso: in qualche modo, per loro, dei martiri.
Resta ancora aperta la questione dello Stato Islamico, che è riuscito a cambiare in pochi anni gli equilibri –
precari – del mondo del terzo millennio, che colpisce per l’efferata violenza e che si dichiara anti-Occidentali,
pur utilizzando gli stessi linguaggi comunicativi. Si propone con questo fenomeno un’occasione (necessaria)
di riconciliazione dell’Occidente con sé stesso, alla ricerca, che potrebbe essere riscoperta, di un’identità che
ha visto sfumare negli ultimi decenni e che ha portato alla crisi del proprio modello culturale, di
interpretazione della realtà, tanto che qualcuno è arrivato a rifiutare il concetto stesso di modello, crisi anche
di valori e dell’umano.
Sommario e fonti
Fonti
Storia del Medioriente
http://doceo.pbworks.com/w/file/fetch/65728710/decolonizzazione.pdf
http://www.limesonline.com/i-confini-del-medio-oriente-dopo-la-prima-guerra-mondiale/66192
https://it.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita#Storia
https://it.wikipedia.org/wiki/Iran#Rivoluzione_costituzionale_e_Reza_Shah
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Golfo#Il_dopoguerra
http://www.fisicamente.net/ISR_PAL/index-1225.htm
http://www.ecn.org/reds/guerra/iraq/iraq0210storia.html
http://www.partitodialternativacomunista.org/dmdocuments/Marceca-%20Nazionalismo%20arabo.pdf
http://www.sirialibano.com/siria-2/unita-liberta-socialismo-il-pensiero-politico-di-michel-aflaq.html
http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/06/Nasserism.pdf
http://documentazione.altervista.org/usa_iraq_descret.htm
http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/08/HIST351-11.1.4-Iran-Iraq-War.pdf
http://www.treccani.it/scuola/lezioni/in_aula/storia/esame/12.html
43
Cultura
http://www.corsodireligione.it/religioni/islam/islam_politica.htm
Lo Stato Islamico
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerra_d%27Iraq&oldid=77747283
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Politica_dell%27Iraq&oldid=78359777
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/da-al-qaida-Iraq-aqi-al-califfato-una-storia-di-sangue-11103
http://www.lastampa.it/2015/06/28/esteri/regole-divieti-e-punizioni-cos-si-vive-nel-califfatopJtmaxHPfQk0MTuB8bGIxH/pagina.html
http://aulalettere.scuola.zanichelli.it/argomenti/isis-lo-stato-islamico-settembre2014/?id_tipo=401&pag=4
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Primavera_araba&oldid=78348408
https://www.youtube.com/watch?v=cokQDfetJsk
https://www.youtube.com/watch?v=c262Z_d9tHE
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stato_Islamico&oldid=78422525
https://www.forexinfo.it/ISIS-tutte-le-fonti-di
44
Sommario
Sommario
Prefazione .......................................................................................................................................................... 2
Introduzione e struttura ................................................................................................................................ 2
Perché “Daesh”? ............................................................................................................................................ 2
La Cultura Islamica............................................................................................................................................. 2
L’Islam ............................................................................................................................................................ 2
Introduzione .............................................................................................................................................. 2
Maometto e la nascita dell’Islam .............................................................................................................. 3
Terminologia di riferimento ...................................................................................................................... 4
La Religione e la Politica ................................................................................................................................ 4
Musulmani liberali e musulmani fondamentalisti ..................................................................................... 5
Il progetto politico della religione islamica ............................................................................................... 6
La guerra e l'Islam ...................................................................................................................................... 6
L'emigrazione dalle "terre di Islam". ......................................................................................................... 7
Eguaglianza fra gli uomini nell'Islam.......................................................................................................... 7
L'accordo costituzionale fra cristiani e comunità islamica (632 d.C)......................................................... 8
Lo statuto di ebrei e cristiani e induisti nelle terre d'islam. ...................................................................... 9
Il Patto di Omar, IX sec. a.C........................................................................................................................ 9
Lo statuto dei non credenti e dei politeisti. ............................................................................................ 11
Lo statuto degli "apostati", coloro che lasciano l'Islam per altre religioni. ............................................. 11
La divisione tra terre d'islam e di miscredenza oggi................................................................................ 12
L'emigrazione obbligatoria ...................................................................................................................... 13
Gli integralismi- fondamentalismi- integrismi ......................................................................................... 13
I Curdi .......................................................................................................................................................... 14
Chi sono i Curdi? ...................................................................................................................................... 14
Le Origini .................................................................................................................................................. 15
Novecento (XX secolo) ............................................................................................................................. 15
I Curdi in altri paesi .................................................................................................................................. 16
La nascita del Medioriente nel suo assetto attuale......................................................................................... 16
Situazione agli inizi del Novecento .............................................................................................................. 16
L’Indipendenza degli stati mediorientali ..................................................................................................... 18
Indipendenza della Turchia e della Giordania ......................................................................................... 18
Nascita dell'Arabia Saudita moderna ...................................................................................................... 18
Indipendenza dell’Iran e sviluppi ............................................................................................................. 18
Indipendenza dell’Iraq e sviluppi: ............................................................................................................ 19
45
Guerra Iran-Iraq ........................................................................................................................................... 20
L'aggressione ........................................................................................................................................... 20
Il protrarsi della guerra e la politica dell'Occidente ................................................................................ 20
Incidenti internazionali ............................................................................................................................ 21
La Prima Guerra del Golfo ........................................................................................................................... 21
L'occupazione: tra propaganda e ragioni economiche............................................................................ 21
Il ruolo dell'Arabia Saudita ...................................................................................................................... 22
La risoluzione Onu e la coalizione ........................................................................................................... 22
17 gennaio: Scatta l'Operazione Tempesta nel Deserto ......................................................................... 22
Vittime e Sindrome della Guerra del Golfo ............................................................................................. 23
Le condizioni di Bush ............................................................................................................................... 23
La Seconda Guerra del Golfo ....................................................................................................................... 23
Premessa ................................................................................................................................................. 23
Il dibattito sulla guerra ............................................................................................................................ 24
La diplomazia ........................................................................................................................................... 24
La guerra in Iraq....................................................................................................................................... 25
Lo “Stato Islamico” .......................................................................................................................................... 26
Situazione in Iraq ......................................................................................................................................... 26
Sotto Saddam .......................................................................................................................................... 26
Al-Zarkawi ................................................................................................................................................ 27
Dall’AQI all’IS ........................................................................................................................................... 28
La Siria.......................................................................................................................................................... 29
La Primavera Araba.................................................................................................................................. 29
Cause e scoppio della guerra civile sino a Ginevra 2 ............................................................................... 30
Dopo la conferenza.................................................................................................................................. 31
Sviluppi recenti ............................................................................................................................................ 32
Gli ostaggi e la propaganda ..................................................................................................................... 32
Gli attentati.............................................................................................................................................. 33
I Foreign Fighters ..................................................................................................................................... 36
Dati .............................................................................................................................................................. 38
Membri noti ............................................................................................................................................. 38
Modalità di finanziamento di Daesh........................................................................................................ 39
Come si vive nel Califfato ........................................................................................................................ 40
Riflessione.................................................................................................................................................... 42
Sommario e fonti ............................................................................................................................................. 43
Fonti ............................................................................................................................................................. 43
46
Sommario .................................................................................................................................................... 45
Realizzato da Michela Loguercio, Erica Trotta e Paolo Franchi.
V BC - Liceo G. Valerio Catullo - A.S. 2015/2016
gscatullo.altervista.org
47