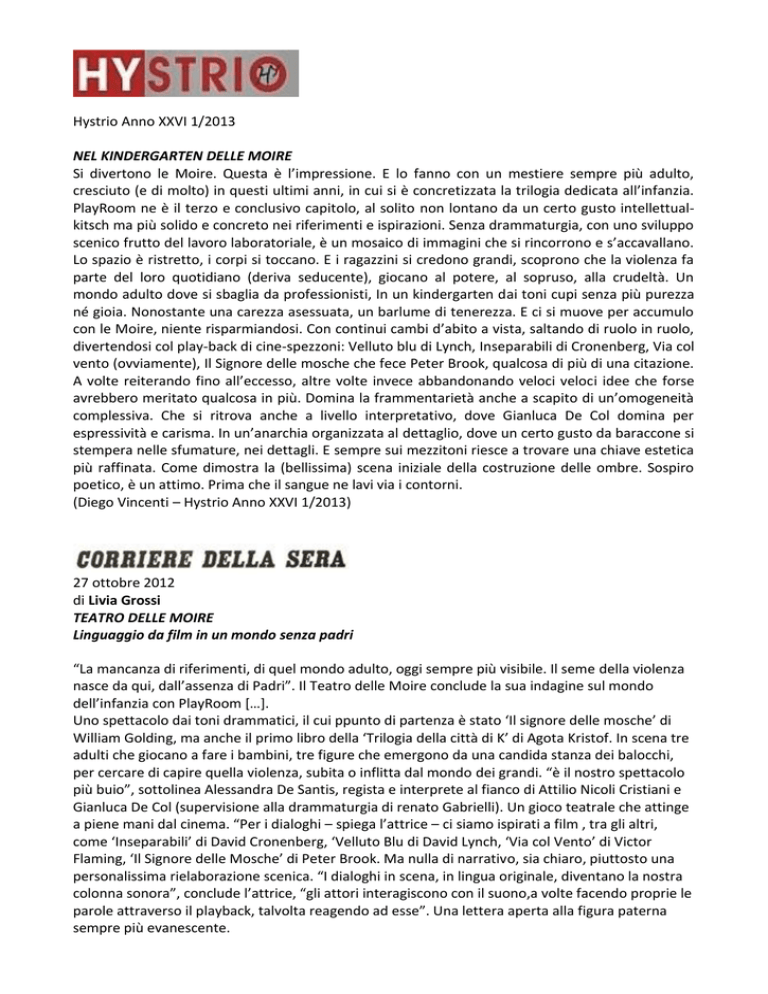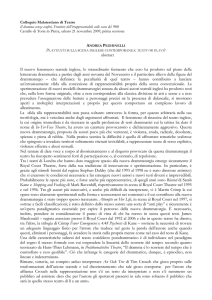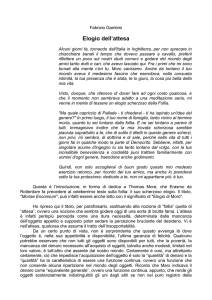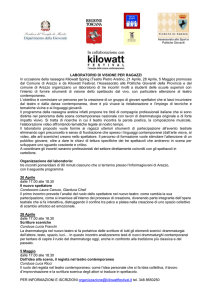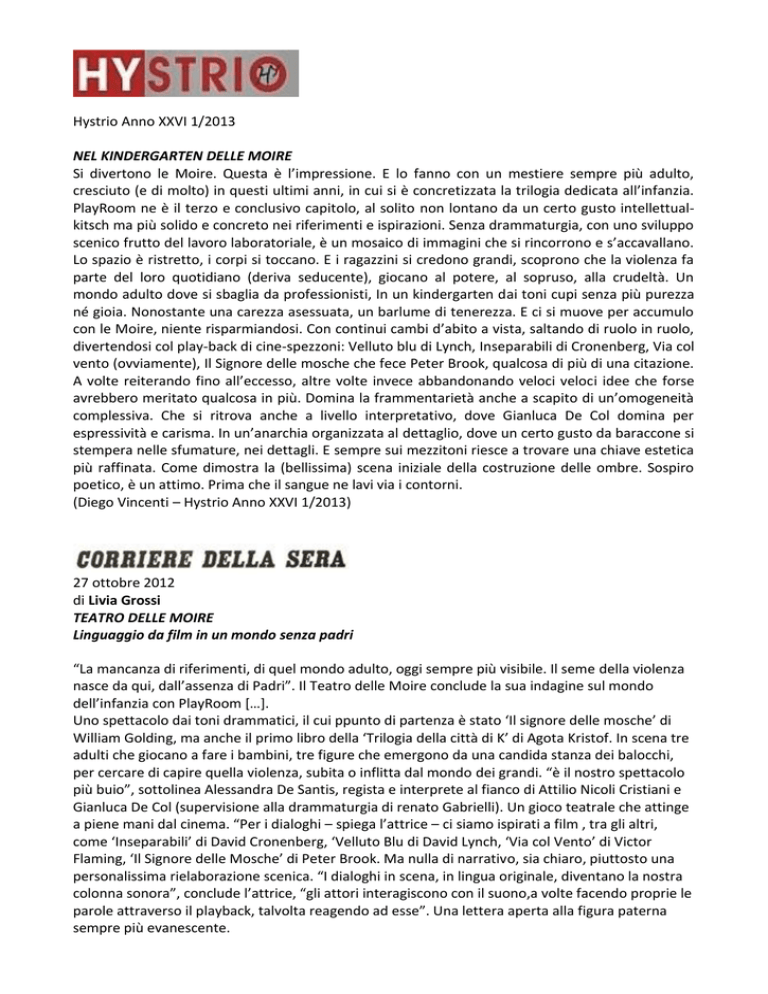
Hystrio Anno XXVI 1/2013
NEL KINDERGARTEN DELLE MOIRE
Si divertono le Moire. Questa è l’impressione. E lo fanno con un mestiere sempre più adulto,
cresciuto (e di molto) in questi ultimi anni, in cui si è concretizzata la trilogia dedicata all’infanzia.
PlayRoom ne è il terzo e conclusivo capitolo, al solito non lontano da un certo gusto intellettualkitsch ma più solido e concreto nei riferimenti e ispirazioni. Senza drammaturgia, con uno sviluppo
scenico frutto del lavoro laboratoriale, è un mosaico di immagini che si rincorrono e s’accavallano.
Lo spazio è ristretto, i corpi si toccano. E i ragazzini si credono grandi, scoprono che la violenza fa
parte del loro quotidiano (deriva seducente), giocano al potere, al sopruso, alla crudeltà. Un
mondo adulto dove si sbaglia da professionisti, In un kindergarten dai toni cupi senza più purezza
né gioia. Nonostante una carezza asessuata, un barlume di tenerezza. E ci si muove per accumulo
con le Moire, niente risparmiandosi. Con continui cambi d’abito a vista, saltando di ruolo in ruolo,
divertendosi col play-back di cine-spezzoni: Velluto blu di Lynch, Inseparabili di Cronenberg, Via col
vento (ovviamente), Il Signore delle mosche che fece Peter Brook, qualcosa di più di una citazione.
A volte reiterando fino all’eccesso, altre volte invece abbandonando veloci veloci idee che forse
avrebbero meritato qualcosa in più. Domina la frammentarietà anche a scapito di un’omogeneità
complessiva. Che si ritrova anche a livello interpretativo, dove Gianluca De Col domina per
espressività e carisma. In un’anarchia organizzata al dettaglio, dove un certo gusto da baraccone si
stempera nelle sfumature, nei dettagli. E sempre sui mezzitoni riesce a trovare una chiave estetica
più raffinata. Come dimostra la (bellissima) scena iniziale della costruzione delle ombre. Sospiro
poetico, è un attimo. Prima che il sangue ne lavi via i contorni.
(Diego Vincenti – Hystrio Anno XXVI 1/2013)
27 ottobre 2012
di Livia Grossi
TEATRO DELLE MOIRE
Linguaggio da film in un mondo senza padri
“La mancanza di riferimenti, di quel mondo adulto, oggi sempre più visibile. Il seme della violenza
nasce da qui, dall’assenza di Padri”. Il Teatro delle Moire conclude la sua indagine sul mondo
dell’infanzia con PlayRoom […].
Uno spettacolo dai toni drammatici, il cui ppunto di partenza è stato ‘Il signore delle mosche’ di
William Golding, ma anche il primo libro della ‘Trilogia della città di K’ di Agota Kristof. In scena tre
adulti che giocano a fare i bambini, tre figure che emergono da una candida stanza dei balocchi,
per cercare di capire quella violenza, subita o inflitta dal mondo dei grandi. “è il nostro spettacolo
più buio”, sottolinea Alessandra De Santis, regista e interprete al fianco di Attilio Nicoli Cristiani e
Gianluca De Col (supervisione alla drammaturgia di renato Gabrielli). Un gioco teatrale che attinge
a piene mani dal cinema. “Per i dialoghi – spiega l’attrice – ci siamo ispirati a film , tra gli altri,
come ‘Inseparabili’ di David Cronenberg, ‘Velluto Blu di David Lynch, ‘Via col Vento’ di Victor
Flaming, ‘Il Signore delle Mosche’ di Peter Brook. Ma nulla di narrativo, sia chiaro, piuttosto una
personalissima rielaborazione scenica. “I dialoghi in scena, in lingua originale, diventano la nostra
colonna sonora”, conclude l’attrice, “gli attori interagiscono con il suono,a volte facendo proprie le
parole attraverso il playback, talvolta reagendo ad esse”. Una lettera aperta alla figura paterna
sempre più evanescente.
Teatro delle Moire: un catalogo delle interazioni umane
L'infanzia è finita (per sempre): a cosa giocano gli adulti? Potere, soprusi e violenza,
nell'impossibilità di liberarsi di se stessi. È Playroom, ultima opera del Teatro delle Moire, al suo
debutto milanese.
Tende all’astrazione, la poetica del Teatro delle Moire. Le opere della compagnia rinunciano
all’uso della parola e si compongono di azioni che dapprima si accumulano, poi si elidono a
vicenda. Nella fase dell’accumulo, i gesti arrivano a un passo dallo sfociare in una coreografia, ma
anche questa aspirazione viene trattenuta. Si compone, proprio grazie a queste tensioni frustrate,
un catalogo delle dinamiche d’interazione tra gli esseri umani, come se si potesse osservarli da una
posizione decentrata. Da un luogo ulteriore, un confine del mondo di qualche genere; oppure da
un tempo ulteriore, dove tutto si è già compiuto. Rispetto al precedente It’s always tea time,
l’ultima opera, Playroom – al debutto nelle scorse settimane al Lachesi lab di Milano –, porta a un
livello più alto di efficacia la strategia appena descritta. Quella evocata dal titolo si rivela una
stanza di giochi crudeli: accoglie interazioni basate sul gioco di potere, sul sopruso, in ultimo sulla
violenza. I tre personaggi (maschere astratte e simboliche, appena caratterizzate) interagiscono
dapprima con diffidenza, poi con un piacere sadico che della tensione erotica ha solo il ricordo,
l’abitudine, il dovere stereotipato. E infine il piacere sfocia nella violenza, inferta agli altri oppure a
se stessi, ma sempre indotta dal dominio dell’altro (con un “terzo incomodo” come testimone
complice).
Ciò di cui soffrono le figure in scena è il limite invalicabile della propria pelle, l’impossibilità di
uscire da se stessi. Sono, per di più, imbrigliate da due o tre pelli: gli strati di vestiti di cui cercano
di liberarsi o con cui cercano di proteggersi sono metafora di una prigione ulteriore. L’unica
liberazione possibile è un urto: contro se stessi, il prossimo, gli oggetti. Punteggia le scene
(distribuite in maniera ciclica grazie a periodici, efficaci crescendo) l’audio di film come Il signore
delle mosche, Inseparabili, Via col vento, che gli attori scimmiottano seguendone i dialoghi con le
labbra. Un playback spettrale, che anche quando sfocia in burla non spezza la tensione, anzi la
alimenta in attesa della successiva scena tragica.
C’è qualche iniziale spunto beckettiano in Playroom: è come se ritrovassimo tre degli
intercambiabili personaggi dell’irlandese a qualche decennio di distanza, ormai definitivamente
dissennati a causa del prolungato patimento e della ripetizione annosa. Ma manca la rigorosità
dell’“ansia combinatoria” di Beckett, e in effetti vedendo le opere del Teatro delle Moire si
desidererebbe una dimensione più strutturata che è corteggiata e poi rifiutata. Viene spontaneo
immaginare i singoli gesti sistematizzati in un linguaggio complessivo, e ci si aspetterebbe che la
poetica sfociasse in qualcosa di simile, per esempio, alla pseudodanza statica che caratterizza
l’opera di artisti visivi come Keren Cytter.
Ma la mancanza di una struttura definita è probabilmente una scelta voluta, anche allo scopo di
spiazzare. Quella del Teatro delle Moire è programmaticamente una drammaturgia fatta di gesti e
azioni, che sembra ogni volta comporsi sul momento anche se preparata nei minimi dettagli come
un’improvvisazione trattenuta.