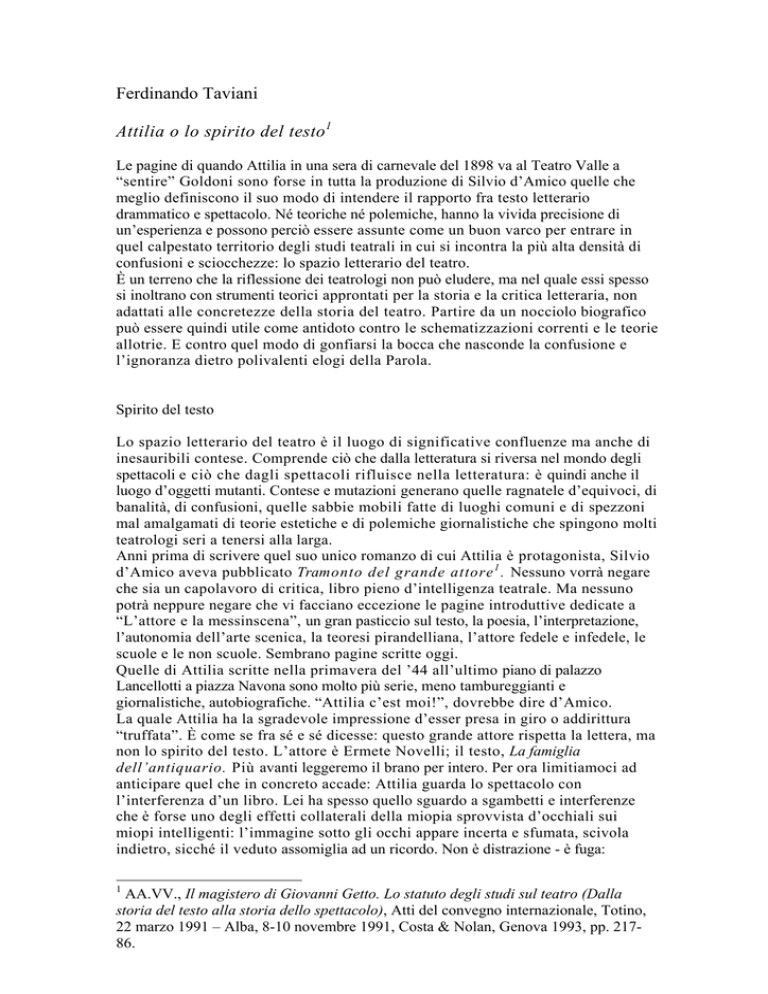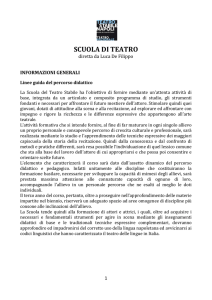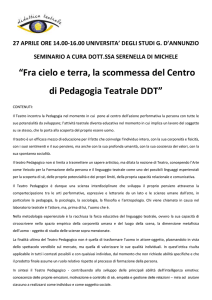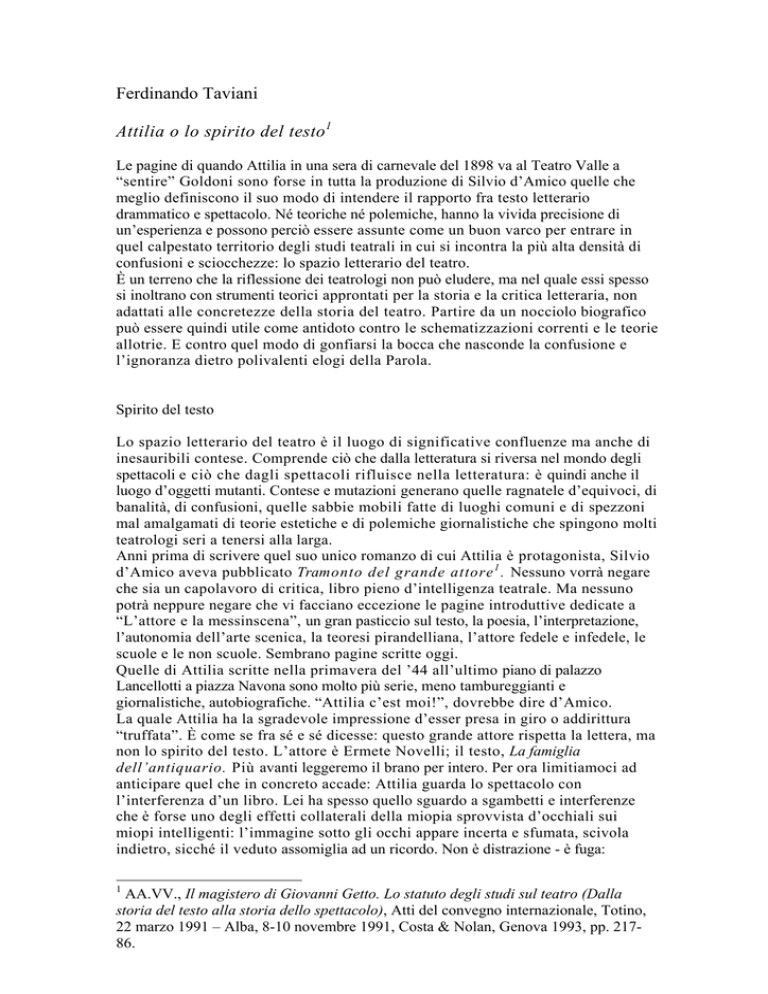
Ferdinando Taviani
Attilia o lo spirito del testo1
Le pagine di quando Attilia in una sera di carnevale del 1898 va al Teatro Valle a
“sentire” Goldoni sono forse in tutta la produzione di Silvio d’Amico quelle che
meglio definiscono il suo modo di intendere il rapporto fra testo letterario
drammatico e spettacolo. Né teoriche né polemiche, hanno la vivida precisione di
un’esperienza e possono perciò essere assunte come un buon varco per entrare in
quel calpestato territorio degli studi teatrali in cui si incontra la più alta densità di
confusioni e sciocchezze: lo spazio letterario del teatro.
È un terreno che la riflessione dei teatrologi non può eludere, ma nel quale essi spesso
si inoltrano con strumenti teorici approntati per la storia e la critica letteraria, non
adattati alle concretezze della storia del teatro. Partire da un nocciolo biografico
può essere quindi utile come antidoto contro le schematizzazioni correnti e le teorie
allotrie. E contro quel modo di gonfiarsi la bocca che nasconde la confusione e
l’ignoranza dietro polivalenti elogi della Parola.
Spirito del testo
Lo spazio letterario del teatro è il luogo di significative confluenze ma anche di
inesauribili contese. Comprende ciò che dalla letteratura si riversa nel mondo degli
spettacoli e ciò che dagli spettacoli rifluisce nella letteratura: è quindi anche il
luogo d’oggetti mutanti. Contese e mutazioni generano quelle ragnatele d’equivoci, di
banalità, di confusioni, quelle sabbie mobili fatte di luoghi comuni e di spezzoni
mal amalgamati di teorie estetiche e di polemiche giornalistiche che spingono molti
teatrologi seri a tenersi alla larga.
Anni prima di scrivere quel suo unico romanzo di cui Attilia è protagonista, Silvio
d’Amico aveva pubblicato Tramonto del grande attore 1 . Nessuno vorrà negare
che sia un capolavoro di critica, libro pieno d’intelligenza teatrale. Ma nessuno
potrà neppure negare che vi facciano eccezione le pagine introduttive dedicate a
“L’attore e la messinscena”, un gran pasticcio sul testo, la poesia, l’interpretazione,
l’autonomia dell’arte scenica, la teoresi pirandelliana, l’attore fedele e infedele, le
scuole e le non scuole. Sembrano pagine scritte oggi.
Quelle di Attilia scritte nella primavera del ’44 all’ultimo piano di palazzo
Lancellotti a piazza Navona sono molto più serie, meno tambureggianti e
giornalistiche, autobiografiche. “Attilia c’est moi!”, dovrebbe dire d’Amico.
La quale Attilia ha la sgradevole impressione d’esser presa in giro o addirittura
“truffata”. È come se fra sé e sé dicesse: questo grande attore rispetta la lettera, ma
non lo spirito del testo. L’attore è Ermete Novelli; il testo, La famiglia
dell’antiquario. Più avanti leggeremo il brano per intero. Per ora limitiamoci ad
anticipare quel che in concreto accade: Attilia guarda lo spettacolo con
l’interferenza d’un libro. Lei ha spesso quello sguardo a sgambetti e interferenze
che è forse uno degli effetti collaterali della miopia sprovvista d’occhiali sui
miopi intelligenti: l’immagine sotto gli occhi appare incerta e sfumata, scivola
indietro, sicché il veduto assomiglia ad un ricordo. Non è distrazione - è fuga:
1
AA.VV., Il magistero di Giovanni Getto. Lo statuto degli studi sul teatro (Dalla
storia del testo alla storia dello spettacolo), Atti del convegno internazionale, Totino,
22 marzo 1991 – Alba, 8-10 novembre 1991, Costa & Nolan, Genova 1993, pp. 21786.
particolarmente forte quando la vitalità della scena è tenuta a distanza da
un’intercapedine di buio e di silenzio. In quest’ottica un palco teatrale non è diverso da
una finestra notturna. Notte dell’Epifania, in un appartamento che affaccia su
piazza Navona:
nel vano dell’altra finestra, Attilia guardava e fantasticava per conto suo [...]. Appuntando di là dai
vetri i begli occhi miopi non distingueva gran che; ma si ricordava. Si ricordava la fiera dell’anno
avanti, il va e vieni notturno fra i bagliori della piazza in un’eccezionale libertà, quella d’andare a
braccetto, lei e le altre ragazze, con amici: tutte vigilate, s’intende, ma forse un poco meno del consueto,
dalle mamme che le seguivano [...]. E allora cos’era accaduto? a che aveva pensato? che le aveva
detto, nel frastornato delirio, il silenzio del suo cavaliere? e di quale cavaliere [...] 2
[...] Dalla sfasatura di sguardi con cui Attilia osserva lo spettacolo
nell’interferenza d’un libro deriva una particolare profondità di campo. Ne
derivano anche eclissi, oscuramenti per interposizione. Lo spettacolo può oscurare
il libro e viceversa. Non appena Attilia dimentica la materiale separazione degli
oggetti, non appena il gioco delle duplicità diventa inconsapevole e s’annebbia la
coscienza che lo spettacolo e il libro son due opere ben separate; non appena,
insomma, si crea l’illusione che l’opera scritta possa non semplicemente farsi a
pezzi e metamorfosarsi, ma addirittura reincarnarsi o rivivere in quella dell’attore
e della messinscena, allora la duplicità materiale delle “cose” (libro e
spettacolo), perduta sul piano della concretezza, si interiorizza e si mistifica in
una duplicità ideale: si materializza così, davanti agli occhi della mente, uno
“spirito” del testo distinto dalla sua “lettera”.
Silvio d’Amico quando racconta di Attilia ci fa assistere quasi in presa diretta al
formarsi d’un tale ectoplasma mentale che benché passi spesso inosservato ha poi
conseguenze numerose e gravi sul modo di pensare il teatro. Attilia infatti - come
vedremo quando leggeremo il brano per intero - fra sé e sé non protesta perché
l’attore operi mutamenti sul testo dell’autore, ma perché nella recitazione fa
risaltare elementi che alla lettura non risaltavano ed altri ne lascia in ombra che invece
luccicavano. La “truffa”, insomma, non si opererebbe sulla lettera del testo, ma su
qualcosa d’ulteriore, di meno verificabile, ma che Attilia ritiene oggettivo.
Silvio d’Amico in questo brano non adopera l’espressione “spirito del testo”, che per lui
oscillerà fra due sensi diversi ed apparentemente opposti: una comprensione un po’
grossolana (si veda ad esempio proprio nel saggio su Ermete Novelli in Maschere: “Il
nucleo della parte Novelli se lo rifà a suo modo [...] Pur avendo inteso il tipo, non sa
ridarlo in una paziente e diligente esecuzione del testo e si contenta d’averne assimilato
lo spirito [...] poi lo ricostruisce come gli va”); oppure il nucleo essenziale di un autore, la
poesia cui l’interprete dovrebbe restar fedele (lo vedremo in questo senso in una citazione
sempre da Maschere che ci capiterà più avanti). Oggi è tale seconda accezione a
prevalere e “spirito del testo” sta per “essenza”, “anima”, e invece di indicare il
soggetto d’un testo all’ingrosso ne designa i piani reconditi e profondi. Cito ad esempio
una frase dallo scritto recente di Gigi Livio La scrittura drammatica: “L’aderenza allo
spirito del testo non ha nulla a che fare con la fedeltà alla sua lettera”, tant’è che alle
volte “il rispetto dello spirito del testo scritto pretende, nell’economia del testo
spettacolare, il non rispetto della lettera del primo testo”.
Ed ecco - sempre seguendo Livio - un caso esemplare: “la Salomè di Oscar Wilde è una
‘tragedia’ che, bellissima alla lettura, risulta del tutto impraticabile (fino a prova contraria, ovviamente) sul palcoscenico. E la prova contraria arriva con Carmelo Bene
che proprio stravolgendone la lettera, mantiene lo spirito di quella scrittura
mirabile”4. Il capitolo V del libro di Livio5 sviluppa il tema delle rappresentazioni di
Salomè in Italia, da Fumagalli nel 1904 a Carmelo Bene sessant’anni dopo e
ribadisce (in particolare a p. 132) il principio della fedeltà allo spirito che implica
un’infedeltà alla lettera: “poco accettato è il criterio per cui la fedeltà al testo vuol dire
fedeltà allo spirito del testo; e questa fedeltà comporta spesso, per essere tale, proprio
che si cambino le parole di quel testo”. E poi: “fedeltà allo spirito del testo vuol dire
capacità del teatrante di entrare all’interno del nucleo poetico del testo, di
comprendere fino in fondo le intenzioni e il mondo poetico dell’autore”.
Conviene fare una pausa perché quest’ultima frase è ingannevole: sembra una
descrizione dei processi creativi dell’attore mentre in realtà traduce l’impressione
dello spettatore di fronte ai buoni risultati. L’impressione dello spettatore rovesciata
come se fosse la descrizione del criterio compositivo è una delle palle al piede del
pensiero teatrale, per questo mi permetto qui d’essere pignolo e di notare che espressioni
vaghissime come “entrare all’interno del nucleo poetico del testo” o “comprendere fino
in fondo le intenzioni e il mondo poetico dell’autore” traducono con la dovuta
imprecisione l’ammirazione di chi legge un’eccellente pagina di critica o assiste a una
recita eccellente, ma nulla dicono del metodo critico o dei procedimenti
interpretativi. La questione più interessante è però un’altra: a che cosa serve la
distinzione fra “spirito” e “lettera” del testo? Anche se Attilia l’espressione
“spirito del testo” non la usa, il suo modo di pensare non è sostanzialmente diverso da
quello di Livio. Ambedue distinguono nel testo un’identità di superficie e una
sotterranea, sicché Attilia giudica tradito lo spirito malgrado il rispetto della lettera,
mentre Livio - specularmente - vuole tradita la lettera per rispetto dello spirito. Sia
l’una che l’altro credono fermamente che la loro impressione di spettatore immerso nella
considerazione del testo scritto, del testo in libro, corrisponda ai procedimenti
ed alle intenzioni dell’attore, che pone il testo in spettacolo.
Che fra Attilia e Livio ci sia una sostanziale identità di vedute (malgrado le differenze
di interessi di tempi e di gusti) lo dimostra l’adesione di Livio (pp. 127-128) a quel
brano di Silvio d’Amico nell’introduzione al suo Tramonto del grande attore in cui si
rievocava un artista, infedele alla lettera e sostanzialmente fedele, alle prese con
Salomé di Oscar Wilde. Il grande attore d’allora era lo stesso del cui Goldoni resta
Attilia delusa, il figlio d’arte Ermete Novelli. Di lui come improvvisato Erode,
Silvio d’Amico scriveva:
Pescando a caso le battute dal suggeritore, biascicandone una metà, inventandosi l’altra metà,
borbottando, muggendo, mugolando, improvvisamente plasmò e creò, davanti al tremante stupore
dei suoi comici, un biblico mostro di lussuria, di cui nessuno, un momento innanzi, aveva immaginato la
presenza 6 .
Lo spirito di Erode
Nessuno l’aveva immaginata perché fino ad un istante prima l’attore-direttore aveva
aggiunto cancellature a cancellature, facendo quasi sparire ogni traccia dello stile di
Oscar Wilde. Anche Novelli riteneva, come quasi un secolo dopo ritiene Gigi Livio,
che Salomé fosse del tutto impraticabile in palcoscenico, e che per salvarne lo
“spirito” occorresse stravolgerne la “lettera”.
Nel presentare Tramonto del grande attore - la riedizione del libro di suo padre - in un
seminario di studio di fine estate di sette anni fa (Centro per la Sperimentazione e
la Ricerca Teatrale, Pontedera, 2 1 settembre 1985), Alessandro d’Amico sceglieva
proprio questa pagina su Novelli (accanto ad una pagina sulla Duse) per far risaltare
il modo in cui Silvio d’Amico aveva saputo evocare l’arte di quegli attori di cui non
lamentava il declino. Ed infatti, se davvero esiste un qualcosa che può dirsi lo
“spirito del testo”, bisogna allora riconoscere che Novelli, così come ce lo ritrae
d’Amico, tale spirito lo coglieva davvero, anche se era uno spirito molto diverso
(forse) da quello che coglierà, anni dopo, il citato Bene. [...]
È facile pensare alla pièce di Wilde come ad un dramma di naturalismo biblico
fasciato d’ornamenti lirici, oppure - con un’opposizione speculare - come ad
un’immersione fra i perversi profumi d’Oriente usurpata dal dilagante delirio del
vecchio Erode (“Costui è un vecchio porco”, spiegava Novelli). Così come
Novelli nella breve prova vista da d’Amico liberava la potenza archetipicopsicologica del dramma dalla per lui irritante esasperazione lirica delle battute di
contorno, Carmelo Bene dopo parecchi lustri liberava il dramma visionario e
grottesco dalla per lui irritante sensatezza narrativa. [...]
Il teatro di Ermete Novelli e quello di Carmelo Bene stanno oltre quello di Wilde per
delirio e potenza. L’uno è radicato nella coerenza realistica della rappresentazione.
L’altro in un’altrettanto radicale negazione della linearità narrativa. L’uno - Novelli
- scava nella verosimiglianza fino a rintracciare la verità d’una visione. L’altro Bene - scava nelle allucinazioni più grottesche ed apparentemente incongrue fino a
scorticare un nocciolo evidente e imprevisto di verosimile esattezza. Fra i due, il
teatro di Salomé non è né verosimile né surreale, ma “araldico” - sarebbe davvero
troppo vago dire “simbolista” o “decadente” - un teatro che rappresenta il valore
dell’ambiente e dell’azione in base ad un linguaggio geroglifico ed evocativo, in
campo viola con luna d’argento. [...]
Mi pare che sia comunque un po’ esagerato definire il testo di Wilde “del tutto
impraticabile sul palcoscenico” sia pure “fino a prova contraria”, perché le prove
contrarie sono talmente disparate e significative (benché il testo non sia mai
entrato in un repertorio), da rendere inoffensiva la drastica negazione. Basterebbe
appunto ricapitolare - al di là dei casi italiani ricordati da Livio - il progetto di
messinscena per la prima rappresentazione, quella londinese proibita dalla censura
nell’estate del 1892 (la censura, come è noto, approfittava d’una legge che inibiva a
qualsivoglia tema biblico l’approdo in palcoscenico). Sarah Bernhardt s’era preparata
a danzare lei stessa la danza dei sette veli, che voleva fosse una sorpresa anche per gli
amici, ed aveva perciò rifiutato l’intervento d’una danzatrice professionista come
controfigura. Aveva affittato alcune scene dal Lyceum di Irving, altre ne aveva
fatte progettare a Graham Robertson ed a Charles Ricketts de Sousy (che poi sarà lo
scenografo di Salomé nella messinscena al Covent Garden del 1906); aveva scelto i
costumi. Aveva, insomma, provato quel suo nuovo modo di far teatro che avrebbe
inaugurato l’anno seguente al Théàtre de la Renaissance di Parigi.
Oppure basterebbe pensare alla “prima” al Théàtre de l’Oeuvre di Lugné-Poe,
nel febbraio 1896, un successo che fu davvero utile a Wilde per gli echi che ebbe
sui giornali inglesi e per quel po’ di prestigio che il poeta prigioniero poté
ricavarne presso i sorveglianti e i compagni, mentre in tutti i teatri del Regno Unito
il suo nome era stato espunto dai cartelloni.
O basterebbe rievocare, magari con le parole-ragnatela di Ripellino10, la
messinscena di Tairov nell’ottobre del ’17. Perché, insomma, la Salomé dovrebbe
apparire “del tutto impraticabile sul palcoscenico”? Ricadremo mica in quel modo
di ragionare, così diffuso fra le chiacchiere di teatro, per cui vi sarebbero opere
“teatrabili” ed opere “non teatrabili”? Non ci sono forse decine e decine di fatti a
dimostrare - contro le idee preconcette - che Salomé è teatrabile, teatrabilissima, in
prospettive di volta in volta diverse e varie volte illuminanti? Anche la recita di
Novelli - se l’avesse fatta secondo gli spunti offerti in quella famosa
prova vista da d’Amico - benché lontana quant’è possibile dal teatro “araldico”
pensato da Wilde - sarebbe stata una memorabile Salomé. Anche Livio mi pare
d’accordo. Quando dice che si tratta d’una tragedia “bellissima alla lettura” ma
“del tutto impraticabile sul palcoscenico” egli nasconde dietro questa formula un
gran disprezzo per la scena teatrale “normale” cui non appartengono né Carmelo
Bene né Tairov, né Lugné-Poe né Ricketts, e neppure Sarah Bernhardt o Ermete
Novelli, dal momento che scena “normale” verrebbe semplicemente a significare
la scena corrente dei mediocri 11 . In questo senso ha ragione: perché mentre ci
sono opere drammatiche che empiricamente si dimostrano funzionanti anche nelle
recite più volgari, la Salomé di Wilde no, ha bisogno d’un’arte della recita che
l’accompagni, altrimenti lo spettacolo non potrà mai competere con il piacere della
lettura. In fondo quando si parla di opere teatrabili e d’altre no, si assume sempre
come misura del “teatrabile” la mediocrità quotidiana e l’incompetenza della
pletora professionistica.
La stessa pagina introduttiva di Silvio d’Amico su Novelli episodico Erode di
Oscar Wilde viene utilizzata da Mirella Schino nella premessa a quel suo libro che
attraverso la Duse affronta la problematica storica e di metodo oggi forse più
avanzata per lo studio dell’attore-creatore. “Poche immagini” dice la Schino “sono
più fuorvianti di quella, bellissima, che Silvio d’Amico ci ha lasciato su
Novelli”. E dopo aver riassunto il brano ribadisce l’ossimoro:
Un’immagine bella e fuorviante, un modo di pensare che ha suggerito per decenni una strada comoda:
recuperare gli aspetti contraddittori del mondo attorico di radici ottocentesche in base ad una genialità
personale, ad un’energia colossale ed “istintiva”12.
La contraddizione starebbe dunque nell’individuare un bel nodo e nel risolverlo poi
malamente con il passe-partout “istinto” o con sue varianti terminologiche
edulcorate: “intuito che supplisce all’incultura”, “genialità improvvisatrice”,
ecc.13
Il passe-partout
Nel teatro come in zoologia lo pseudoconcetto “istinto” ed i suoi surrogati sono usati
spessissimo: sembrano precisare, e invece si limitano ad indicare grossolanamente,
svalutandolo, un intreccio di reazioni saperi ed esperienze tanto fitto da non lasciarsi
capire. Sicché ricorrere all’ “istinto” è segno di fretta o d’incuria o d’ignoranza nei
confronti della cultura extra-letteraria dell’attore.
La domanda che il letterato - istintivamente - rivolge all’attore è sempre più o meno
la stessa: com’è possibile interpretare bene un testo, un personaggio, senza aver
ben capito l’indole letteraria del suo autore? Poiché il letterato conosce in genere
un solo modo di lavorare il testo, quello della critica letteraria, poiché ignora tutto o
quasi tutto dei procedimenti attorici basati sul mixaggio e il montaggio di linee e
piani diversi, identifica il lavoro mentale dell’attore con quello del critico,
immagina l’attore mediocre come un critico incurante o sciocco, e quando i risultati
gli sembrano invece tanto raffinati da superare le nozioni stesse che l’attore ha
della letteratura, allora il letterato non sa immaginarsi altro che raffinatissimi istinti.
È uno schema di pensiero sbrindellato ma ampio abbastanza da apparire un riparo
contro le miriadi di obiezioni che altrimenti vanificherebbero l’illusione che il
termine “interpretazione”, riferito all’attore, significhi cogliere - magari con mezzi
un po’ rabdomantici - un contenuto del testo, eventualmente nascosto lontano dalla
superficie, nel fondo del suo “spirito”. La distinzione fra lo spirito e la lettera cerca
infatti un’ulteriore mediazione all’interno di questo stesso schema di pensiero che
confonde il lavoro dell’attore con un lavoro di interpretazione in senso stretto. È
l’altra faccia di quell’altro schema, altrettanto scalcinato, che si figura il testo
drammatico come capace solo in scena di vivere e solo attraverso l’attore, sia che poi
se ne deduca la pretesa di subordinare l’attore al testo, o viceversa. Dedicheremo
alcune osservazioni a tali schemi. Torneremo infine ad Attilia e ad un’aria più fine.
Spirito del testo o sottotesto?
Esiste qualcosa come lo “spirito del testo”? Non credo, a meno che non si parli
d’un testo di legge o d’un testo sacro, dov’è importante soprattutto l’intenzione
dell’autore, o dell’Autore.
Un testo letterario, sia esso per la lettura o la recitazione, non legifera né
annuncia, quindi non prevede distinzioni fra intenzione e realizzazione, fra
“spirito” e “lettera” (proprio il tentativo di rendere impossibili tali distinzioni
definisce la fiction). Ne lascia prevedere altre, e fra le altre quella fra testo e
sottotesto, nozione anch’essa ingannevole se messa al singolare, perché non esiste
mai un sottotesto, ma pluralità di sottotesti possibili, alcuni dei quali (dell’autore o
di certi interpreti lettori o spettatori) possono a volte essere storicamente ricostruiti.
Pluralità di sottotesti possibili vuol dire che non tutti sono possibili. Se si scivola su
quest’ovvia precisazione, ovvia tanto da esser spessissimo dimenticata, si cade
nelle scipitezze del decostruzionismo volgare dannose anche per le rigidità che
determinano in reazione. Nei suoi scritti e nelle discussioni all’interno dell’ISTA
(International School of Theatre Anthropology) Marco De Marinis, per esempio,
tende spesso a estremizzare, facendole così diventare assurdità per poi smontarle, le
ipotesi e le tesi di chi si preoccupa soprattutto di studiare la sfasatura fra i diversi
“significati” o “contenuti” dell’azione teatrale (cioè in questo caso i “sottotesti”): lo
fa per una giusta insofferenza alle mode franco-americane di nichilismo
semantico. Ma a volte gli resta il riflesso che resta ad alcuni semiologi
intelligenti e perplessi anche dopo aver drasticamente ridimensionato le speranze e
le promesse della propria disciplina: ciò che non sarebbe comunque semiotizzabile e
che sfugge all’esattezza gli sembra per ciò stesso irrazionale14.
Dovrebbe essere evidente e sottinteso che la divergenza dei punti di vista (parlo
d’autore, attore, regista, spettatore) non è mai assoluta: i sottotesti ognuno se li
costruisce (quasi) sempre differenti ma il testo (letterario e/o spettacolare) è comune. È
la tenuta del tessuto (letterario e/o spettacolare), la sua precisione, a creare un’orbita
entro la quale i diversi sottotesti possono muoversi liberamente pur senza vagolare in
qualsivoglia direzione. Quando il testo (letterario e/o spettacolare) non tiene non c’è
più orbita né ci sono più sottotesti, ma solo assenza di rapporto. La precisione infatti
è “contenuto”, e lo spirito del testo è la lettera.
Pedantescamente, negli schemi della manualistica, si può contrapporre la credenza
in un’anarchia assoluta (che nega qualsiasi criterio per distinguere interpretazioni
soggettive da interpretazioni oggettive) alla credenza secondo la quale i significati
d’un testo, soprattutto i più reconditi, sono da esso contenuti e previsti e possono
essere scientificamente elucidati. Il limite grottesco di quest’ultima credenza viene
raggiunto quando si identifica il significato oggettivo con quello dell’autore, quasi
regalando al copyright una mente. Il grottesco dell’altra non c’è bisogno di dirlo:
l’abbiamo sotto gli occhi nella svagatezza non di rado tronfia di molti sedicenti saggi
d’interpretazione critica dei testi drammatici. Ma nella pratica l’esperienza mostra
ogni opera come composta di diversi strati: un primo livello governato
dall’evidenza del rapporto segno-significato, e poi livelli sottostanti, delle cavità
protette tenute in vita da quella solida architettura, dove l’immaginazione la
speculazione ed il commento possono aggirarsi con libertà tanto più spinta quanto
più la Forma tiene. Lo si vede benissimo ad uno degli estremi della questione:
l’estrema precisione della “massima” o dell’aforisma, il loro modo accorciato,
ridotto al minimo, e quindi la ferrea concisione della dicitura, fan sprizzare la
comprensione in direzioni molteplici e vaghe: scriptum angustum interpretatio latissima,
ricordava Folena citando Beroaldo il Vecchio15 . La lingua teatrale è sempre, in
qualche modo, una “lingua scorciata”, e quindi “lata” o “latissima”
d’interpretazione.
L’equilibrio fra costruzione e cavità, che in teoria sembra nient’altro che
un’immagine, nell’esperienza di ciascun critico o regista o attore è qualcosa di
fragile e concreto, è la lotta o la dinamica d’un’architettura che tende a schiacciare i
sottotesti liberi il cui empito tende a mandarla in pezzi. Nel dialogo sul Critico come
artista, Oscar Wilde parlava d’una dialettica fra Precisione e Oscurità. “Di fatto
un Amleto di Shakespeare non esiste [...]. Ci sono tanti Amleti quante malinconie”,
diceva con quel buon senso scorciato che pare paradosso, mentre ai suoi occhi
pareva ovvio che l’opera shakespeariana, avendo la precisione di un’opera d’arte,
avesse di conseguenza anche tutta l’oscurità che appartiene alla vita.
Dal punto di vista dell’attore, il termine “sottotesto” può risultare troppo stretto.
Stanislavskij aveva detto: “per quel che riguarda i movimenti la chiameremo
azione conduttrice, per quel che riguarda la parola la chiameremo sottotesto”16, ma è
evidente che si può usare un’“azione conduttrice” anche per le parole ed un
sottotesto fatto di parole anche per i movimenti. Nelle ultime sedute dell’ISTA,
International School of Theatre Anthropology (soprattutto in quella d’inizio marzo
’92 a Padova e in quella del mese successivo a Brecon, nel Galles) si è per
esempio preferito sostituire a “sottotesto” termini come “sottopartitura” o
“underscore”. Possono anch’essi divenir scivolosi se intesi come “tutto ciò che sta
sotto la partitura” invece di “quella partitura che sta sotto”.
Per l’attore è essenziale appoggiarsi alla partitura ulteriore, che non coincide con la
rappresentata. E il suo Drowndland, la sua Terrasommersa, in cui nuota e pesca
per il processo creativo (e a volte, come faceva Meercraft in The Devil is an Ass di
Ben Jonson, è anche ciò che viene spacciato come significato profondo attinto
dall’interpretazione). Questa necessità ricorrente e transculturale viene trascurata solo
dall’attore che recita a bocconi, nel modo che va bene per il cinematografo. La
sottopartitura - o “partitura che sta sotto” - può essere ricavata dal testo o no: è
pura superstizione che “faccia più senso” quand’essa è dedotta dal testo invece
d’esservi addotta magari di lontano, dalla pura danza o dalle composizioni
biomeccaniche. L’importante è che ci sia. Il testo è a sua volta una partitura, un
insieme organico di precisioni.
Poiché l’arte dell’attore presuppone l’intreccio di due partiture, crea volgarmente
l’illusione che si tratti di “interpretazione”, d’un modo cioè di spiegare il testo,
d’elucidarne i significati ombrosi o oscuri. In realtà l’attore intreccia e lo
spettatore spiega (si spiega).
Le differenti prospettive dell’attore o dell’autore (con le loro riposte intenzioni),
dello spettatore o del lettore (con le loro visioni), mostrano che il sottotesto non è e
non può essere qualcosa che il testo per così dire implica o contiene, ma solo il risultato
d’un ben concertato rapporto. Esistono diverse qualità di rapporto e quindi diverse
qualità di sottotesti. Esistono, soprattutto, differenti regole del gioco e differenti
competenze professionali, che implicano modi diversamente organizzati di dialogare
sensatamente con un testo. Un sottotesto plausibile dal punto di vista dell’attore e
del regista non è necessariamente plausibile anche dal punto di vista del critico o
dello storico letterario. E viceversa.
Nessun sottotesto è quello giusto. Tutti sono legittimi,quando rispettano la coerenza
di un determinato rapporto o d’un determinato dialogo con il testo. I sottotesti,
infatti, non sono discutibili alla luce del vero/falso, del dimostrato/indimostrato ma
alla luce del giustificato/arbitrario, dell’utile/inutile. Hanno a che vedere con
l’economia creativa non con l’analisi critica. Servono a procedere oltre il testo, non
certo a penetrarvi. E insomma: dicono pochissimo o quasi niente del testo, per il
semplice fatto che dicono qualcosa a partire da esso.
Dell’utilità e del danno dei sottotesti
Il fatto che a partire da un testo teatrale si possano intessere innumerevoli sottotesti
giustificati da prospettive molto diverse e si possano progettare o immaginare
molteplici realizzazioni sceniche, serve a volte da scusante per atteggiamenti critici
che in altri campi apparirebbero indecorosi. Nessun critico letterario o storico della
letteratura passerebbe oggi gran parte del suo tempo a riassumere e ricolorare gli
intrecci o si interrogherebbe seriamente su quel che faranno í personaggi d’un
romanzo o d’un racconto oltre i limiti del racconto o del romanzo, né si porrebbe
domande su quel che il tale o talaltro personaggio potrebbe fare al di là di quel che
l’autore dice o fa chiaramente intendere. Sono domande che a volte il lettore
fantasticando si pone, ma proprio mentre se le pone sa di star fantasticando: non
confonderebbe mai le sue personali fantasticherie (Natasa che si masturba o Renzo
che teme d’esser figlio naturale del padre di Don Rodrigo) con un approccio critico
al testo, tale cioè da coinvolgere altri in una discussione sensata. Se uno ama
raccontare i propri sogni o le proprie fantasticherie in genere è costretto a pagarsi chi
l’ascolti, oppure è costretto a tradurli in una forma di tale qualità da agganciare
l’attenzione degli altri. Da questo punto di vista, la critica letteraria teatrale offre
indubbiamente degli sconti.
Come mai, infatti, fantasticherie semplicistiche e senza costrutto del genere di quelle
sopra citate possono essere sciorinate con l’ingenuità e la petulanza delle
convenzioni accademiche in pagine e pagine di sedicente letteratura critica sulla
letteratura drammatica? Perché non c’è dubbio che quel tipo di affabulazioni
possano essere assai feconde per costruire il sottotesto d’un attore o d’un regista.
Con questa sottaciuta scusa le carte di plausibili premesse per un processo
creativo pretendono spesso d’essere storia e critica di un testo di letteratura
drammatica. Con risultati, inutile dirlo, pessimi. I testi drammatici continuano ad
essere letti come se fossero la provincia scugnizza della letteratura e il loro
appartenere anche al campo del teatro invece che di maggior densità diventa
ragione di minor rigore. Tanto che, alla fin fine, quel meticciato critico che alla
lettura tradizionalmente storico-letteraria aggiunge notizie contigue di messinscene
e fortune teatrali sembra essere il più assennato. Succede spesso che siano oggi gli
storici delle letterature o i filologi a lasciarsi meglio inquietare dalle turbolenze
teatrali individuando nuove domande per lo studio delle opere drammatiche, mentre
i teatrologi quasi si riposano soddisfatti in vecchissime poltrone quando
finalmente si confrontano con un testo scritto e accreditato che a loro pare dal
punto di vista del metodo il non plus ultra della calma piatta.
Senza precise regole del gioco non vi è né può esservi qualità degli studi. Credere
che leggere un testo da un punto di vista teatrale voglia dire parlarne come se se ne
progettasse la messinscena equivale a confondere le regole del gioco del Dramaturg
con quelle dello storico e del critico. Benché nell’aneddotica di questi ultimi anni
alcuni teatranti amino avere sui loro programmi di sala pagine firmate da qualche
professore, non c’è alcuna ragione per confondersi: un buon Dramaturg non è
necessariamente un buon critico o un buono storico del teatro. Né quest’ultimo - a
maggior ragione - è necessariamente un buon Dramaturg. Le due diverse funzioni
possono a volte congiungersi in una stessa persona, il che però non vuol dire che
siano fra loro coniugate. Differiscono per finalità, metodo e deontologia.
Sottotesti per Dramaturg e sottotesti critici
Permettetemi di ricapitolare alcune ovvietà. V’è differenza fra il sottotesto ed il
significato sotterraneo di un’opera? In ultima analisi non credo che vi sia: si tratta
sempre d’un dialogo fra fruitore e opera secondo precise regole del gioco, tacite o
formalmente definite. Ma la posizione dell’ultima analisi è una finzione logica, di
fatto è impraticabile, e nella pratica fra sottotesto e significato sotterraneo (o
meglio: fra sottotesti e significati sotterranei) è come se vi fosse una differenza
grandissima, che rimanda a differenti costellazioni di regole del gioco. Quando un
critico dice a se stesso che ciò di cui va a caccia è il significato o il contenuto
nascosto dell’opera usa una metafora per dire che le sue regole del gioco lo
impegnano ad accettare il controllo dei documenti. Le regole sono infatti del gioco,
non di un’ipotetica “verità”. E poiché sono del gioco con esse non si può scendere
a patti. Il gioco non è solo una convenzione, ma una vocazione.
“Nulla impedisce di pensare che...” è una frase molto feconda nel corso d’un lavoro
drammaturgico. Nel corso della narrazione critica o storiografica è invece indice di
spappolamento. La vocazione critico-storica obbliga a far passare ogni visione
attraverso un filtro di documenti, riscontri interni alla struttura, comparazioni
significative e pertinenti, indirette ed oggettive, che non possono essere
semplicemente l’affabulazione del lettore vivace o la similitudine o l’indagine alla
Sherlock Holmes. Passate attraverso i propri filtri, le visioni storico-critiche
possono ben essere attualizzanti, saranno sempre tendenziose e dipendenti dal
punto di vista dello storico, ma al loro modo, non al modo d’una libera riflessione
o fantasticheria a partire da un testo, che è un altro gioco, che segue anch’esso le
sue regole ed ha i suoi patti impliciti con il lettore.
Se la deontologia del lavoro storico-critico mette in guardia dall’attrazione della
lettura “feconda” e richiama sempre alla regole imposte dai documenti dalle
congetture dal senso delle proporzioni nel contesto, la deontologia d’un buon
Dramaturg dovrebbe invece metterlo in guardia dalla superstizione dell’aderenza
ai documenti (ciò che alcuni volgarmente chiamano “il vero”) e fargli preferire
sempre la fecondità d’una lettura alla sua attendibilità storiografica. Un Dramaturg
(sia esso attore o regista, faccia come altro mestiere il professore o il critico, lo
scrittore o l’organizzatore), adotta regole del gioco che consistono nello scegliere
(fra le innumerevoli cose che testo e documenti non impediscono di dire pensare e
sospettare) quel che conviene far dire al testo. Suo compito è la scoperta di quelle
chiavi che permettano di trasformare un testo letterario drammatico in materiali
per un processo creativo.
Il lavoro drammaturgico compiuto sul testo parte da una fuga mentre il lavoro dello
storico o del critico mira al ritorno, all’opera, al suo contesto, alla sua storia, alla
sua interna struttura e quindi ad una rilettura più complessa saporita ed enigmatica ma
pur sempre poggiata sull’opera considerata in sé, non trasformata in materiale per
un’altra creazione. Tutte queste distinzioni - mi si dirà - sono ovvie e non valgono.
Basta pensare a libri come Shakespeare nostro contemporaneo o Pirandello o la
stanza della tortura oppure alle lezioni di Ripellino su Cechov per rendersi conto
che il lavoro critico-storiografico può coincidere perfettamente con un’originale
operazione drammaturgica. Tant’è che da quegli scritti dipesero e dipendono molti
spettacoli.
È vero. Ma non è un buon modo di discutere. Contrapporre esempi alti al tentativo
di conoscere le cause della bassa qualità d’una pletora di lavori autoindulgenti non
serve a niente: gli esempi han da essere esemplificativi, non esemplari.
L’eccellenza dei risultati raggiunti da Jan Kott da Giovanni Macchia da Angelo
Maria Ripellino e da pochi altri simili a loro per qualità consiste proprio nell’aver
saputo rispettare contemporaneamente due voci, due diverse regole del gioco: quelle
del Dramaturg e quelle del critico o dello storico. Le mie distinzioni ovvie erano
invece contro la confusione di quando non ci si dà né si rispetta fino in fondo regola
o convenzione alcuna e si salta dall’una all’altra secondo pigrizia, rinnegando
ogni vocazione.
Le difficoltà che si oppongono ad uno studio dei testi teatrali in quanto teatrali
generano spesso quest’autoindulgenza spensierata, questa mollezza. Il rigore infatti
non ha a che vedere con una ferrea matematica del pensiero, come esige a
sproposito chi identifica scienza e scienza esatta: ha piuttosto a che vedere con la
pertinacia nel non cambiar gioco ad ogni mano. [...]
Sottotesti o contenuto latente?
Massimo Castri a volte lavora sui testi cercandone il profondo, come se fossero
sogni da cui estrarre la scena psicoanaliticamente primaria (così, ad esempio, nel
’79, gettava via gran parte della barocca e labirintica Fantastica visione di
Giuliano Scabia per isolarvi il nocciolo d’un incubo famigliare antropofagico).
L’uso della psicoanalisi applicata ad oggetti che per definizione non dovrebbero
prestarsi - come le pagine dei libri, i personaggi di drammi e romanzi - dà però a
volte l’illusione d’una metodologia più scientifica e oggettiva d’un normale sottotesto,
quasi che in questo caso il sottotesto non fosse fatto dalle vedute e dai bisogni di chi
utilizza il testo, ma fosse in esso un contenuto latente. È interessante notare come
Ettore Capriolo passi, nel commentare le note preparatorie di Massimo Castri, da
un’irriflessa pretesa d’oggettività del sottotesto ad una netta definizione del suo
carattere di ponte in una strategia creativa, fra l’oggettività del testo e la
soggettività del lettore-creatore dello spettacolo. Ripercorriamo brevemente l’arco
di questa palinodia sul sottotesto. Nel chiudere il volume dedicato a Pirandello,
Capriolo scriveva:
Nel corso di questo itinerario, c’è un’evoluzione assai significante, che concerne soprattutto il rapporto
stabilito dal regista-drammaturgo [Castri] con il sottotesto, inteso sia come deposito del passato nel
presente dell’azione scenica, sia come contenuto latente del dramma [...]. Ciò comporta in ogni caso
una programmata infedeltà alla struttura apparente dei testi presi in esame 21.
È ancora una volta l’idea della fedeltà allo “spirito” come necessaria infedeltà
alla “lettera”. Ma in alcune righe di raccordo a p. 114 Capriolo aveva annotato: “Il
concetto di sottotesto comincia a entrare in crisi, o almeno non appare più in grado
di render conto dei contenuti reali della commedia”. E la fase del “massimo
distacco dalla lettera del testo”, quando Castri cerca di ricostruire e riscrivere
Così è (se vi pare).
In realtà è però il concetto di “contenuto latente” che entra in crisi. Gerardo
Guerrieri aveva già suggerito a proposito di Stanislavskij che il lavoro sul
sottotesto non fosse - come poteva sembrare - un lavoro di interpretazione ed analisi:
popolava le ampie caverne create dall’involucro della sceneggiatura e della
dicitura. Per far questo - aggiungeva Guerrieri - l’attore (o il regista) si serve di
mezzi disparati in un artistico bric-à-brac che assomiglia “a certe opere
contemporanee dove il segno fantastico si sposa a oggetti reali, la pennellata alla
bottiglia di Coca-Cola: per es. in Rauschenberg” 22.
Nel volume su Ibsen, Capriolo sembra di nuovo far proprio il concetto di
sottotesto come “contenuto latente” nasco sto dalle strutture in crisi del dramma
borghese 23 , concetto che può essere un felice errore o una feconda illusione per il
Dramaturg al lavoro e che certo nello specifico è fomentato dall’illusoria
scientificità del placcare l’immaginario psicoanalitico sulla lettura del testo, ma
che ben presto si disfa ad un’osservazione più attenta:
Il concetto fondamentale, o se si preferisce l’oggetto misterioso da individuare, è ancora riconoscibile
nel sottotesto; ma appaiono ormai chiaramente insufficienti le metodologie applicate in precedenza. Il
sottotesto, in altre parole e semplificando molto [...] non è qualcosa di dato che esiste già nell’opera e
che può essere ricavato con una paziente operazione di scavo già a tavolino, ma un punto di arrivo cui è
possibile pervenire attraverso una messa in contatto delle intuizioni e delle scoperte compiute nella fase
dell’elaborazione drammaturgica con quelle che potremmo genericamente definire le macchine
sceniche.
E continua:
Dall’attrito e dal rapporto dialettico tra la lettura del testo e la macchina che dovrà tradurlo in
spettacolo possono quindi derivare non più un solo sottotesto, aprioristicamente fissato dal registadrammaturgo con funzioni demiurgiche, ma un ventaglio di soluzioni, ciascuna delle quali, se la fase di
analisi drammaturgica è stata condotta correttamente, può teoricamente portare a conclusioni anche
radicalmente diverse24.
Castri e Capriolo pongono in appendice al loro libro su Ibsen i due articoli o
conferenze di Georg Groddeck e Sigmund Freud su Rosmersholm 25. Scritti
fecondi, come quasi tutti quelli dedicati alle arti dai maestri della psicologia del
profondo, e perciò anche nidi d’equivoci. Approfittando delle vecchie convenzioni
della critica psicologica, sia Groddeck che Freud esemplificano la via psicoanalitica
servendosi di personaggi di teatro. E giungono a risultati fra loro opposti.
Sarebbe comunque fallace confondere tali brillanti esibizioni con altrettanti
tentativi d’analisi critica, sia pur secondo le convenzioni d’un’attardata critica
psicologica. Mentre, infatti, i princìpi psicologici di riferimento per la normale
critica psicologica sono in fondo strumenti convenzionali noti e condivisi pur nella
loro superficialità (o piuttosto proprio a causa di essa), e possono quindi essere
oggetto di discussioni che si basano su punti di senso comune, il funzionamento della
psiche cui sia Groddeck che Freud fanno riferimento non è né convenzionale né
semplicistico, non è pasticciato con preconcetti morali condivisi, implica percorsi
reconditi e dissimulati in cui una cosa può manifestarsi attraverso il suo contrario
secondo sistemi di segni che vanno ogni volta ridefiniti e la cui interpretazione
può quindi rivelarsi appropriata solo per una riprova esterna, un successo: che
per la psicoanalisi è l’evidenza soggettiva o l’eliminazione dei disturbi, così
come per la via indiziaria del detective è la confessione del colpevole. Senza
confessione evidenza soggettiva o “guarigione”, un discorso in questi casi vale
l’altro. Ogni buon lettore di letteratura poliziesca o di quella sua spesso mediocre
imitazione che sono le cronache nere sa che sulla base di indizi intelligentemente
connessi possono “dimostrarsi” colpevoli innumerevoli persone, anche quando una
soltanto è l’assassino. Similmente, ogni dilettante è in grado di tenere in piedi una
catena interpretativa di lapsus o sogni che abbia la necessaria coerenza e sia
sufficientemente sorprendente da parer “scientifica”. In questi casi, insomma, non
basta il nitore del metodo a garantirne l’appropriatezza, occorre la prova dei fatti.
Inutile aggiungere che se si parla d’un testo letterario tale riprova non c’è per
definizione. Ormai psicanalizzare un personaggio come se fosse una persona reale
non ha più nulla della spensierata novità che poteva avere tre o quattro decenni fa, ed
è solo qualcosa di criticamente insulso e culturalmente riprovevole. Ed infatti chi
usa questi sistemi sa benissimo di non interpretare affatto un testo, ma di seguire le
regole del ri-racconto, o dell’opera d’immaginazione che si serve del genere critico
come finzione, sul tipo del Portrait of Mr. W. H.
Astrazioni storiografiche come sottotesti liberi
[...] Intorno al 1968 Cesare Molinari, che allora insegnava all’Università di
Parma, sperimentò una didattica che metteva allo scoperto i processi mentali che
possono guidare storico del teatro: quei “se” e quei “ma” con i quali non si può
assolutamente scrivere storia, ma senza i quali è possibile pensarla. Molinari
proponeva un testo, un classico della letteratura drammatica, e provava poi ad come
sarebbe risultato nella messinscena di Stanislavskij o di Piscator, di Mejerchol’d o
d’Artaud, di Craig o di Brecht. Utilizzava cioè non messinscene reali, ma le
poetiche dei grandi riformatori - un’astrazione storiografica per sottoporre la
lettura del testo ad una serie di filtraggi stranianti, senza ricorrere a
metodologie di marca vagamente letteraria. Aveva l’ambizione d’essere l’opposta
critica stilistica o strutturale ”29, ma non so se per la didattica funzionasse veramente
dopo i primi effetti di attualizzazione e di sorpresa, o non diventasse invece una
costruzione un po’ meccanica di fantateatro ligio a storiografiche. Era certo però un
buon modo per circoscrivere e coltivare quel campo fluttuante fra critica storica ed
invenzione drammaturgica nel quale l’una e l’altra si nutrono no prima di
distinguersi. “Qui” diceva Molinari introducendo il libro in cui raccoglieva alcuni
risultati di quel modo di procedere, composto in collaborazione con Fernando
Mastropasqua “il testo è preso in esame nella sua integralità filologica: si tratta di
straniare questo testo dalla realizzazione scenica per la quale era stato inizialmente
previsto e di inserirlo in un’altra che, per il suo non essere necessaria,sia in
grado di illuminare in un determinato modo tutti gli elementi del testo a
chiarimento di una problematica reale; ma tendenziosamente sottolineata”30.
Straniare il testo dalla realizzazione scenica per la quale era stato originariamente
previsto vuol dire inventare dei sottotesti che non solo operano a partire dal contesto,
ma che Mondo che sta dietro il testo sostituiscono un Teatro. E’ una delle maniere
usate dalla regia critica per far emergere un senso imprevisto dai testi attraverso
una sostituzione di stile: Goldoni come Cechov o Shakespeare come Brecht. Eretto
a sistema, questo gusto dello spiazzare o dello spaesare può divenire uno
strumento molto sofisticato ed efficace per liberare il lettore dagli anacronismi
automatici attraverso anacronismi controllati e provocati.
Poiché i testi restano, e sbiadiscono invece le “strutture di soccorso” costituite dai
sistemi impliciti di rappresentazione,il disagio dell’intendere (male) appartiene
all’identità stessa dello spazio letterario del teatro e della sua storia, viva nella
sfasatura fra immaginazione del lettore e immaginabile messinscena. Il progetto di
Molinari si gettava a capofitto in questa sfasatura ricca di fantasime, oltre le quali
è forse pur possibile intravedere ciò che del testo resta costante nel mutamento.
Ripeto: probabilmente non è un etto buono per i risultati, ma indica un’ottima
matrice pensiero, che si regge sulla fluidità dei rapporti fra il mondo del teatro
in libro e quello del teatro in scena. Un buon antidoto contro certi veleni che
minacciano il pensiero teatrale.
Poiché dovrebbe essere ovvio ricordare - come dall’ Università di Santa Cruz in
California Thomas G. Pavel torna appunto a ricordarci31 - che la fiction non è
segregata e che i suoi significati si formano non soltanto per il sistema che la regola
all’interno, ma anche in relazione a “realtà” extratestuali, dovrebbe essere
altrettanto ovvio ricordare che nel caso della letteratura drammatica il sistema di
illazioni che mette in relazione le pagine del libro alla realtà culturale ed
effettuale extratestuale è un sistema à double face, l’una rivolta verso il mondo
cui il testo si riferisce, l’altro verso il teatro per il quale e nel quale la pièce fu
scritta. [...]
La letteratura drammatica è infatti soggetta al rischio d’una doppia rigidità: quella
in agguato per ogni testo letterario, derivante dalla superstizione secondo cui il
“contenuto profondo” starebbe davvero dentro l’opera ed il significato sommerso
sarebbe fisso e uno, il senso sarebbe stabilito; ed una fissità specifica e ulteriore per
cui il legame fra testo e rappresentazione andrebbe visto come un qualcosa di
intimo e d’indissolubile e non come il semplice provvisorio e non necessario
incontro fra letteratura e spettacolo in una normale vita di relazione.
L’illusione della pièce incinta
Uno slogan femminista un tempo diceva: “Una donna senza uomo è come un pesce
senza bicicletta”. Proporrei d’applicarlo anche alle pièces: “una pièce senza
messinscena è come un pesce senza bicicletta”, ed anche il contrario: “una
messinscena senza pièce ecc.”. Se mi è permesso, oserei anzi sospettare che per il
teatro sia più vero che per la donna e l’uomo.
All’inizio di quel suo scritto che come s’è visto costituisce il punto d’appoggio per
questa discussione (che è poi il prolungarsi di dialoghi che iniziarono al convegno
d’Alba nel novembre del 1991), Gigi Livio affronta prudentemente la teoria della
“scrittura drammatica” limitandosi alla realtà storica europea dell’Otto e
Novecento, senza cioè pretendere di far discorsi generali. È una scelta oculata sia
perché, come l’autore sente il bisogno di dire, “il materiale di studio muta col
mutare del tempo e pretende, pertanto, una continua messa a fuoco
dell’astrazione teorica”; sia, vorrei aggiungere, perché è proprio fra Otto e
Novecento che si creano le premesse per la “teoria” della scrittura drammatica
come indissolubile dalla scena, quella teoria di cui si nutrono - oltre tant’altri
pasticci - anche il pasticcio dell’introduzione a Tramonto del grande attore e la bella
pagina su Attilia al Valle.
Mentre in quegli anni di fine secolo XIX Adolphe Appia scalava solitario i suoi
Ottomila cercando di mostrare come la partitura degli spazi dei colori delle luci e
dei movimenti potesse essere dedotta con logica ferrea dalla partitura musicale
(wagneriana), nel pensiero andante, basato sul demone dell’analogia, saltava invece
agli occhi la somiglianza fra il supporto cartaceo in cui viene fissata la partitura
musicale ed il supporto cartaceo in cui vengono scritte le pièces, e si affermava
che un dramma scritto è come una musica in attesa d’esecuzione. Un confronto
falotico e sproporzionato che è poi rinverdito alla luce dell’applicazione generica
del concetto di codificazione, quasi che la scrittura della pièce, per il semplice fatto
d’essere in codice (come lo è sul nostro pianeta tutto ciò che riguarda la vita e il
pensiero) fosse anch’essa una forma di notazione.
Per quale mai ragione un testo letterario drammatico dovrebbe contenere le note
per la sua precisa esecuzione (messinscena)? Può sì esser considerato una partitura,
ma nel senso d’un insieme organico di precisioni letterali, non di notazioni per
l’esecuzione. Insistere a ripetere che il testo letterario teatrale è una partitura
debole e incompleta in paragone alla partitura musicale o coreografica vuol dire
perder tempo in qualcosa di verissimo e fuor di luogo. Certo: i testi letterari
drammatici hanno sistemi di notazione deboli se paragonati ad una partitura
musicale. Ma appunto perché sono testi letterari drammatici e non “sceneggiature di
ferro”: è una verità incontrovertibile e senza sugo. Ma la si ripete spesso, quasi
non fosse futile. E poiché le persone che la ripetono sono a volte intelligenti ed attente,
la cosa avrà pure qualche giustificazione. Niente infatti ha più giustificazioni d’un
equivoco.
E il nobile equivoco dell’ideologia teatrale moderna: partendo dalla connessione
storica fra i testi letterari drammatici e i “loro” spettacoli, ha preso il
sopravvento - malgrado la lezione aristotelica - l’idea che la cosa più interessante
da capire fosse l’intrinseca necessità del rapporto. Si è pensato insomma che la natura
specifica del testo letterario drammatico fosse la sua compenetrazione con la
messinscena: e così una congiuntura è stata interpretata come una natura. Fra Otto e
Novecento l’ideologia del rapporto indissolubile traduceva in teoria i postulati di
alcuni maestri della regia che vedevano la messinscena come se fosse la
trascrizione della partitura scenica implicita nel testo. Si opponeva inoltre ai
postulati d’altri maestri che affermavano essere il testo drammatico due diverse
cose: opera d’un genere indipendente quand’è libro da leggere, e “materiale” nelle
mani dell’autore dello spettacolo - o degli attori - quando monta in scena. Contro
quest’ultimo modo di vedere, che sembra così ovvio alla luce del buon senso, si alzò
ad ondate il senso comune dei critici o cronisti drammatici che quando leggevano
un’opera di teatro pretendevano trovarvi le tracce del palcoscenico a loro ben noto, e
quando vedevano uno spettacolo pretendevano di analizzarlo come esecuzione del
libro di partenza, della cui cultura e del cui valore si sentivano depositari e
difensori. I critici, col loro doppio ruolo di quasi teatranti fra i letterati e di letterati
in teatro, cercavano nel matrimonio fra testo e scena la legittimazione d’un ibrido
mestiere. Ricerca che benché abbia dato luogo a svariate e longeve sciocchezze
non va presa a ridere, perché molto spesso era una di quelle traveggole utili alla
buona causa, e teneva desta la nostalgia per un teatro di qualità fra le volgarità
del commercio e dello spaccio di spettacoli. [...]
Nell’alveo dell’ideologia del rapporto implicito e indissolubile fra testo e
messinscena si sono riversati tutti quei moniti professionali che dal Cinquecento in
poi raccomandavano allo scrittore di teatro di figurarsi nello scrivere la
rappresentazione; le glorificazioni della poesia drammatica; le svalutazioni o re
calunnie agli attori mercenari ed alla loro cultura. E han cambiato di senso,
divenendo puntelli alla teoria del primato della parola, cui fece da supporto anche
il paralogismo secondo cui ciò che più si conserva più vale: e in suo nome
gravemente si accennava - come si continua ad accennare - al conservarsi dei testi
ed allo sparire degli spettacoli.
Sono non innocenti improprietà di pensiero che hanno alla base anche un conflitto
d’interessi.
La pièce incinta come argomento corporativo
Quando si cerca di capire nei dettagli come si sia storicamente formata la
stranissima idea - che a molti oggi par ovvia - secondo cui un testo letterario
drammatico vive solo nella sua realizzazione scenica, non si può evitare di
collegarla al conflitto di interessi fra scrittori specializzati nel produrre pièces ed
uomini di teatro specializzati nel farne spettacoli. Si capisce che se la produzione
degli scrittori è sovrabbondante o sproporzionata alle esigenze della produzione di
spettacoli, se si crea un’eccedenza di testi che vorrebbero essere rappresentati e
non lo sono, è interesse dei produttori di testi e dei loro difensori convincersi affermare e far credere - cioè farne una teoria - che un testo letterario drammatico non può
vivere che sulla scena e non lo si comprende che in scena, sicché lo lascerebbero
morire coloro (gli attori) che non lo rappresentassero. E se non può vivere che sulla
scena, vuol dire che, la scena, esso in qualche modo già l’ha in sé come potenza.
Fino a prova contraria, questa non è teoria del testo drammatico, sia pure teoria
distorta. E propaganda. Il risultato d’un modo efficace d’impostare una vertenza.
L’ideologia dell’indissolubilità ha dunque le sue cime teoriche ed i suoi riscontri
pedestri; nasce dalla testa visionaria ma ha anche un ventre avido; si oppone alla
svalutazione estetica del teatro ma anche, nella pratica, all’antica supremazia degli
attori nelle cui mani stava il potere di scegliere o rifiutare i testi da rappresentare,
di imporre variazioni o correzioni. Gli “autori” non costruivano soltanto visioni di
teatro in cui lo spettacolo fosse al servizio della Poesia, ma si riunivano in società
per difendersi; si definivano depositari dell’alta cultura; non ammettevano d’esser
governati dai commercianti delle scene.
Da tutto ciò, un intreccio appiccicaticcio e confuso di teoria e propaganda, di
discussione scientifica e diatriba giornalistica che dura fino ad oggi e si ripete con gli
stessi argomenti e spesso con le stesse identiche parole e gli stessi esempi da un secolo
in qua in ogni convegno e convegnuccio sulla crisi e l’avvenire della drammaturgia,
in ispecie italiana. Dove è facile ascoltare - nei convegnucci italiani - scrittori che non
riuscirebbero a scrivere bene neppure le litigate condominiali inveire contro l’uso e
l’abuso dei classici in nome dei diritti d’autore loro, testimoni del nostro tempo.
Dicono e dicevano: “Basta con Shakespeare! Trattiamo in scena i problemi d’oggi!”.
E “Shakespeare nostro contemporaneo”? Chissà! E l’esempio di Brecht al Berliner?
Chissà! E la funzione del regista? della sua drammaturgia? della drammaturgia
dell’attore? Non sono anche queste opere contemporanee? immaginazioni e
problematiche contemporanee? Chissà.
Non appena ci si appresta a rispondere alla domanda sulle implicazioni fra testo
letterario drammatico e messinscena teatrale si è già belli e caduti nella
ragnatela. Accettata la prima mosca, accettata l’esistenza del problema come se
fosse un vero problema, accettata la domanda, e quindi implicitamente la sua
plausibilità, prima o poi viene fuori il paragone con la partitura musicale, la
distinzione fra “poeta di compagnia” e scrittore teatrale non legato ad una
compagnia precisa, la distinzione fra testi teatrali “teatrabili” e “non teatrabili”,
fino ad arrivare all’apoteosi del disorientamento con temi come quello dei deittici,
la cui presenza nel dialogo drammatico sarebbe nientemeno - scriveva Cesare Segre in
Teatro e romanzo - che “l’immanenza dello spettacolo in seno al testo” e “il preciso
supporto alla gestualità e alla messinscena” 32. Riassumeva una piccola tradizione di
studi semiotici legata soprattutto a Serpieri. Mi pare un esempio piccolo ma
particolarmente significativo di quell’arrampicarsi sugli specchi cui dànno luogo i
tentativi di definire i testi letterari drammatici come incinti di messinscena. E un
esempio apparentemente più attrezzato e aggiornato rispetto alle rivendicazioni di
letterati e critici teatrali d’inizio Novecento, ma non meno debole e pretestuoso.
Osserviamo da vicino che cosa nasconda: un’ovvietà da una parte, una falsità
dall’altra. [...]
Un’ecdotica col mal di mare
[...] Il testo teatrale può mettere in crisi la nozione stessa di “testo”. Forse è per questo visto che spesso viene considerato non un’opera a se stante, ma un insieme di
prescrizioni o istruzioni per l’uso - che non sembra strano distinguerne lo “spirito”
dalla “lettera”.
Dove le relazioni fra testo letterario drammatico e spettacolo sono immediate,
incontrovertibili e strette - e cioè in casi massimi come Shakespeare Molière Goldoni
- si scopre che non esiste ancora un solido abicì filologico. Non si sa, cioè, alla luce
di quale nozione di testo pensarne l’edizione. Quanto più forte è l’unione con la
scena tanto meno sicura sembra l’identità letteraria del testo. Anche in questo la
civiltà cinematografica aiuta ad escogitare una forma mentis adatta: basta pensare a
quanti andirivieni sarebbero oggi necessari per fondare una filologia del testo
drammatico cinematografico.
L’edizione shakespeariana di Wells e Taylor e soprattutto il loro William
Shakespeare - A Textual Companion 36 mostrano che le principali difficoltà non
derivano dallo stato dei documenti, ma dalle abitudini del nostro pensiero. Per
escogitare soluzioni ecdotiche accettabili per Shakespeare (o per Marlowe, ecc.)
occorre riuscire a pensare il testo teatrale secondo modelli assai lontani da quelli
cui ci ha abituati quella filologia del mischiaggio che ha sfornato testi compositi di
capolavori come il King Lear o il Doctor Faustus. Nella normale e corretta
filologia trova posto il concetto di plurivocità del testo, nella filologia drammatica si
impone invece l’assai più periglioso concetto di “testo mobile” o - per usare una
proposta di Luigi A. Santoro - di “turbolenza del testo”37. Concetto più
periglioso, cioè più acrobatico e contraddittorio perché non implica soltanto
l’idea di redazioni indipendenti, da trattare in edizioni separate, e quindi
l’abbandono dell’illusione d’approssimarsi ad un testo unico e definitivo, ma
implica quasi l’inesistenza d’un testo, d’un tessuto fissato dietro le sue
(aneddotiche) proiezioni sulla pagina.
La consistenza del testo, la sua identità, sarebbe qualcosa difficile da pensare, quasi
un’astrazione, una particolare struttura del mutamento, come l’identità d’un verbo
sotto le sue differenti coniugazioni. Non un solido participio passato ma un
“tessendo” piuttosto che un “testo”. Ritagliare nel “tessendo” i confini di
precise versioni d’un “testo” sembra a volte un’operazione difficile e arbitraria.
Ancora una volta - come regolarmente accade a partire dal Settecento - è il “caso
Shakespeare” che presiede ai mutamenti dell’epistemologia teatrale. Ed anche
questa volta la singolarità di Shakespeare non fa eccezione ma è guida. Il punto,
infatti, non sta nella lacuna shakespeariana, nell’assenza dell’autore dalla cura dei
suoi libri. Anzi: l’idea di testo che occorre modellarsi per risolvere degnamente i
problemi filologici posti dalle pagine shakespeariane si riverbera poi anche sui testi
di quegli autori che hanno provveduto loro stessi a trasformare i propri testi scenici
o le proprie sceneggiature in libri.
La recente silloge goldoniana curata da Marzia Pieri per la collezione “Il Teatro
italiano” diretta da Guido Davico Bonino per Einaudi è un buon esempio di come il
principio di “redazione ultima” e di “correzione d’autore” si faccia problematico
quando uno stesso testo sia destinato a forme di pubblicazione tanto diverse fra loro
come la pubblicazione tramite spettacolo e la pubblicazione a stampa38.
Autori recenti o recentissimi, strapubblicati in vita, i cui libri hanno avuto un corso
parallelo a spettacoli altrettanto numerosi - come Pirandello o Eduardo ...o Brecht potrebbero creare problemi filologici incommensurabilmente più complicati del più
sofferto dei romanzi.
Il problema dei problemi non consiste nel dover tener conto d’una pletora di varianti
“d’autore”, ora stampate ora recitate, ma nell’esigenza di definire un criterio che
permetta di decidere oculatamente di quale massa di varianti sia lecito non tener
conto.
Su questo punto non mi trovo d’accordo con Luigi Santoro. Egli ha ragione
quando dice che “l’assenza del testo ‘vero’ [cioè fissato una volta per tutte, almeno
come intenzione, dall’autore] coincide con la presenza di più testi e definisce una
zona di turbolenza che si autoalimenta” 39 ha ragione quando propone di “adottare
come ipotesi di lavoro la natura instabile del testo teatrale, il suo comportamento
analogo a quello di un organismo vivente, di una struttura dissipativa” 40, ma
credo che abbia torto quando pretende che “la filologia dei testi teatrali non [possa]
concentrarsi sul testo scritto, specialmente quando esso è a stampa” e che invece
debba “dilatarsi, visitare i`magazzini’ delle compagnie, le forme della scena, le
abitudini e i comportamenti degli spettatori, le concezioni del tempo e dello
spazio, le diverse forme della rappresentazione” 41 . Sono contrario sia per ragioni
teoriche che di metodo. Sul piano teorico mi pare che ripristini quella stessa
indissolubilità fra scrittura e messinscena che in posizione speculare (alla fin fine
equivalente) viene supposta quando si immagina il testo fisso una volta per tutte
gravido del suo potenziale spettacolo. Sul piano del metodo serve a rendere le cose
ancor più difficili di quanto già siano, anzi: talmente difficili da diventare quasi
impossibili giustificando così l’incuria.
Credo che occorra tracciare un contorno ideale, artificiale come tutti i contorni,
altrettanto brutale, fra il testo-in-quanto-libro ed il testo-in-quanto-materiale-dispettacolo. Solo in alcuni casi - più facili e fortunati - la distinzione riguarderà due
diverse “cose”, due diverse realizzazioni d’uno stesso nucleo di materia. La
maggior parte delle volte servirà a distinguere non due “cose”, ma due “idee” d’uno
stesso manufatto: il testo come libro potenziale e il testo - dice Franco Ruffini -
come “tecnica del teatro” 42.
Ciò che avviene con i testi letterari drammatici legati al cinema non è
sostanzialmente diverso da quel che accade con i testi legati al teatro: in alcuni casi
(come ad esempio Bergman o il Decalogo di Kieslowski e Piesiewicz) sono gli autori
stessi a provvedere alla trasformazione del testo per lo spettacolo in testo per la
lettura, conservando il carattere cinematografico come convenzione letteraria; ma
nella maggior parte dei casi, il testo che eventualmente si trasforma in manufatto
letterario non è stato distinto dall’autore dal testo d’uso per lo spettacolo, e la sua
autonomia letteraria coincide coi criteri dell’edizione.
Ma fra la storia breve della letteratura drammatica d’origine cinematografica e
quella lunga della letteratura teatrale vi è una differenza essenziale: mentre quella
sta fondando il suo genere e le sue convenzioni quasi esclusivamente per vie
interne, sviluppandosi cioè a partire dalla produzione cinematografica e dalle
prospettive editoriali ad essa connesse, questa, la letteratura drammatica d’origine
teatrale, s’è invece formata, in Occidente, sotto la luce di generi precostituiti
fondati dai classici. Non sempre, però, e non sempre con la stessa dipendenza. Si
ripropone qui un campo storiografico complesso ed attraente che riguarda uno
degli aspetti fondamentali della nostra civiltà teatrale: il doppio percorso dei
teatri-in-forma-di-libro e di quelli in forma di spettacolo (o d’evento). È
interessante vedere come questa importante prospettiva cominci ad emergere anche
in libri di buon taglio manualistico come l’introduzione allo studio del teatro
inglese di Roberta Mullini e Romana Zacchi 43, nella collana della casa Usher
diretta da De Marinis, al quale si deve in larga parte la novità dell’impostazione
dal punto di vista degli studi teatrali.
Benché la distinzione fra testo per la lettura e testo per lo spettacolo sia in molti
casi artificiale e materialmente imponderabile, essa è però concreta e spesso
necessaria. Si faccia il caso di autori-attori o di autori-registi o capocomici: i
mutamenti di volta in volta subìti da uno stesso testo nelle sue diverse
messinscene d’autore rischierebbero d’esser considerati tutti varianti adiafore!
Senza la possibilità di tagliar via le varianti in forma di messinscena, e quindi di
considerare il testo in quanto libro relativamente indipendentemente dal testo in
quanto spettacolo, un’edizione critica di testi letterari drammatici di Eduardo De
Filippo, per esempio, sarebbe non difficilissima, né semplicemente impossibile, ma
addirittura impensabile. Qualcuno tenterà di tagliare la testa al toro esclamando:
“ma i testi di Eduardo non è lecito chiamarli `testi letterari drammatici’! Sono
copioni, anche se pubblicati e ripubblicati!”. Sarebbe una doppia sciocchezza: una
petizione di principio giocata sulle sole parole, ed un tentativo confusionario
d’approfittare delle incertezze di molti circa il valore letterario dei testi
eduardiani. Ma le cose non cambierebbero con Brecht: basta pensare a quella busta
gualcita su cui l’autore buttò giù l’appunto per una differente battuta conclusiva
dell’Opera da tre soldi la notte della prima al Piccolo di Milano, nel febbraio del ‘56,
busta poi perduta, variante dimenticata sia da Brecht che da Strehler, come Strehler
stesso (ricordo ad esempio un convegno Brecht perché a Firenze nell’aprile del ‘71)
non mancava un tempo di raccontare in ogni occasione. D’altra parte, che la
traballante discriminazione fra testi letterari e copioni si fondi sullo sgomento del
filologo più che sul giudizio di valore poetico lo dimostra addirittura il caso di
Shakespeare. Dire che un testo è un copione (o non è che un copione) sembra a volte
voler dire che la sua natura è diversa da quella degli altri testi letterari, quasi che
- servendo esso anche ad altro - fosse per ciò altro. Un modo bizzarro di pensare
che non si spiegherebbe, tanto è lontano dal buon senso, se non si rivelasse un
espediente più o meno consapevole per sfuggire alla tormentosa posizione d’un
filologo costretto ad adattarsi alle conseguenze che la vita del teatro ha sulla
fissità del testo (su questo tema le pagine di Santoro sono belle ed efficaci). Alla
sicurezza del testo s’oppone quanto c’è di più affascinante a parole e di più
tormentoso in pratica: l’irrimediabile scorrere d’ogni cosa, l’esistenza e la
consistenza del “tessendo” e l’illusoria fissità del suo participio passato.
Questi pochi esempi stanno ad indicare una convinzione: che per impostare in maniera
nuova gli studi sui testi letterari drammatici la filologia applicata ad episodi ed
autori specifici sia assai più utile della teoria e della critica letteraria.
Un’inversione di 360 gradi
Giorgio Melchiori, in conclusione alla sua edizione del teatro completo di
Shakespeare, ha scritto:
Paradossalmente la nuova immagine di Shakespeare non più come poeta o addirittura come Bardo
nazionale, ma come mestierante di teatro, si fonda non tanto sulle scoperte delle recenti metodologie
della critica letteraria, quanto sul più arido e rigorosamente scientifico metodo di avvicinare la sua
opera: la critica testuale44.
D’accordo, ma che vuol dire “non più come poeta”? Questo di Melchiori è uno
scritto importante, più importante di quanto sarebbe una dichiarazione
prefatoria: è l’“Epilogo” d’un’opera monumentale e fortemente innovativa sia per
le conoscenze shakespeariane che per il modo di pensare e vedere in generale i
testi teatrali in quanto teatrali. L’“Epilogo” chiude il terzo volume dei Drammi
storici, nono e ultimo dell’intera raccolta, dove trova posto il te sto che per Giorgio
Melchiori è forse l’emblema del nuovo modo di interessarsi agli elisabettiani: quel
Sir Thomas More nel quale Shakespeare scrisse una o due sequenze e che “proprio
per le condizioni in cui è pervenuto sino a noi è un esempio unico e mirabile di
come nasca un dramma attraverso la collaborazione, il team work, di un gruppo di
uomini di teatro di alta qualità professionale”.
Il team work è in questo caso una mente collettiva che non aggrega specialismi ma
crea un organismo capace di produrre un vero processo creativo il cui risultato è
un “testo perfettamente costruito, basato su un sottile gioco di simmetrie
interne” 45 .
Quando Giorgio Melchiori dice “non più come poeta” vuol dunque riferirsi a
Shakespeare non più picco solitario? Oppure si lascia trascinare dalla foga? Già nelle
prime righe di questo “Epilogo” aveva sfiorato lo scandalo sùbito riprendendosi in
una parentesi:
Il primo dei nove volumi di questo Teatro Completo di Shakespeare apparve nel 1976; l’ultimo è del
1991: quindici anni che hanno visto una radicale revisione dell’atteggiamento critico verso l’opera di
Shakespeare, Non più (o non solo) il grande poeta universale da porre accanto a Dante e a Goethe,
l’indagatore dei più oscuri recessi dell’animo umano, o - secondo l’immagine costruita attraverso i
secoli - il Bardo della nazione e della lingua inglese; ma invece un uomo di teatro, dotato sia per
istinto, sia attraverso un’esperienza costante in quanto il teatro era il suo mezzo e la sua ragione
di vita, di uno straordinario mestiere 46 .
Insomma Shakespeare as Craftsman come diceva il titolo del libro di Muriel Bradbrook
che Melchiori riecheggia intitolando il suo “Epilogo” Shakespeare e il mestiere del
teatro. Cito queste pagine di Melchiori con qualche pignoleria sia perché
concludono una delle imprese più importanti degli studi teatrali italiani negli ultimi
decenni, sia perché in esse mi pare di ritrovare alcune scivolate che certo non guastano
il lavoro concluso ma lasciano presagire una mentalità letteraria che ha sì operato
un’inversione di tendenza rispetto ai preconcetti trascorsi, ma rischiando ora di
nutrire preconcetti altrettanto dannosi: cambiando apparentemente tutto nel modo
di pensare la relazione letteratura drammatica-spettacolo alla fin fine non
cambierebbe nulla.
Dunque, Shakespeare artigiano, uomo dallo straordinario mestiere. Melchiori
séguita precisando:
La grandezza di Shakespeare, quel che - per coloro che si ostinano a stabilire gerarchie di valori - lo
accomuna a Dante o a Goethe, a Cervantes o a Rabelais, sta piuttosto nel suo impegno totale nel
mestiere da lui intrapreso47.
Malgrado le precisazioni, permane quella strana alternativa: non poeta, ma uomo del
mestiere, o addirittura “mestierante”. Strana, stranissima alternativa: ogni poeta
non è forse anche un uomo di mestiere, un artigiano? Da dove salta fuori,
dunque, questo non del tutto confessato dilemma (che certo contrasta con il modo
in cui Melchiori usa pensare la letteratura e l’arte), secondo cui se Shakespeare va
visto come uomo di mestiere sembra quasi che non vada più considerato “grande
poeta”? E sintomatico che quella parentesi – “...non più (o, piuttosto, non solo) il
grande poeta” - si perda più avanti nel drastico “non più come poeta”. Ed è
sintomatico che la qualifica di “artigiano” e d’uomo di mestiere” si deformi in
quella di “mestierante”, come se alla base ci fosse, più o meno consapevole, l’idea
che un geniale creatore di spettacoli non è né può essere vero letterato e vero
poeta.
Sono alternative che riguardano quella sorta di infantile e potente mitologia
letteraria che ognuno di noi si porta dietro cercando di occultarla ogni volta che
scrive di letteratura. Il dilemma critico concreto, infatti, è quello che Melchiori
affronta implicitamente soprattutto attraverso l’analisi di Sir Thomas More: la
differenza fra un modo di pensare Shakespeare come poeta solitario e il pensarlo
invece come parte d’un team work. Ma nell’“Epilogo” tale concretezza si
sdilinquisce in un astratto contrapporsi di poeta e mestierante. Non stiamo qui
esaminando delle ipotesi critiche o storiografiche di Melchiori, stiamo anzi
trascurando gli aspetti più importanti del suo lavoro sui testi di Shakespeare e come s’è detto - su alcuni principi generalizzabili di critica drammaturgica. Quasi
che Melchiori fosse una cavia, stiamo osservando con una lente d’ingrandimento
un po’ maligna qualcosa di molto sfumato, una vaga mentalità, un’inclinazione
del pensiero che a volte dà alle parole un’eccessiva perentorietà o le lascia correre
verso posizioni insostenibili, come mosse da un’idea troppo in fieri per rivelare
l’inganno. Insomma stiamo trattando Melchiori con lo stesso eccesso di simpatia
che applicheremo ad Attilia.
Se avremo la pazienza di seguire passo passo il discorso di Melchiori avremo
anche la possibilità di vedere da vicino come agisca il veleno dell’idea sotterranea
secondo cui un geniale creatore di spettacoli non può essere un vero poeta.
“Shakespeare” scrive Melchiori “è soprattutto Teatro”. “Bella scoperta!”, sta per
esclamare il lettore. Ma Melchiori gli spegne sul nascere l’impressione d’un facile
truismo e prosegue:
del Teatro ha tutta l’impermanenza, in quanto lo spettacolo offerto varia continuamente a seconda
dell’interpretazione, dell’impegno degli attori, dell’atteggiamento del pubblico, del tempo e del luogo
in cui viene rappresentato 48.
Senza dubbio. Ma che c’entra? Non si tratta qui di presentare le registrazioni di
alcuni spettacoli, ma testi da leggere. “I cosiddetti ‘testi’ dei drammi
shakespeariani” replica Melchiori:
stampati nel tardo Cinquecento e Seicento non sono testi letterari, ossia opere pubblicate in una forma
che vuol essere definitiva e permanente, ma semplici documenti teatrali sopravvissuti casualmente alla
distruzione cui erano destinati” 49.
La punta velenosa si occulta in quell’“ossia”. D’accordo: sono sopravvissuti
casualmente. Non sono testi pubblicati come opere curate dall’autore nella loro
forma definitiva, ma perché mai ciò dovrebbe voler dire che non sono testi
letterari? Fino a prova contraria sono i lettori, le generazioni di lettori, che con la
forza dei fatti stabiliscono che cosa appartenga alla letteratura. Non c’è dubbio che
i testi shakespeariani siano anche documenti d’un teatro sparito, ma perché
dovrebbero essere null’altro che semplici documenti? Inoltre, è proprio la mèsse di
notizie che Melchiori organizza attorno a questi testi nei nove volumi della sua fatica
di tre lustri a mostrare - come lo mostra la bibliografia sull’editoria elisabettiana che le sceneggiature teatrali non erano proprio destinate senza appello - sia pur solo
nell’intenzione del loro autore - alla distruzione, e che la possibilità d’una loro
trasformazione in libro era sempre presente ed a volte pressante.
La causa di questa foga eccessiva nel ribadire le indubbie radici commercialteatrali delle opere shakespeariane, ciò che attrae questa giustissima
consapevolezza verso conseguenze ingiustificate è quell’idea della natura del testo
teatrale che ne avvelena la comprensione: “il cosiddetto ‘testo’ drammatico”
scrive Melchiori “è sempre null’altro che un pretesto per la rappresentazione, e si
realizza solo in quanto spettacolo” 50. Il che, se fosse vero, non c’è dubbio che
renderebbe tutto più semplice. Purtroppo, però, vero non è. È anzi una falsità che
contraddice l’esperienza personale di ognuno di noi lettori - oltre che spettatori - di
teatro, e che soprattutto contraddice una storia secolare che vede la diffusione dei
libri teatrali procedere parallela alla popolarità degli spettacoli.
Il testo drammatico è anche pretesto per la rappresentazione, ma è ben lungi
dall’essere null’altro che questo. Gli amici attori di Shakespeare che dopo la sua
morte curarono l’in-folio del Seicentoventitré sapevano benissimo che i testi fatti
per recitare possono facilmente trasformarsi in libri fatti per leggere. Operarono
loro, John Heminge ed Henry Condell, il passaggio dalla sceneggiatura alla
letteratura che in altri casi sarà lo stesso autore-teatrante a curare. Questo
passaggio non è qualcosa di naturale, implica una trasformazione che attivi la
faccia-libro che nella nostra tradizione ha ogni scrittura teatrale.
Il testo si realizza certamente anche nello spettacolo, ma nulla dimostra che si
realizzi solo nello spettacolo. E poiché la storia del teatro occidentale, almeno dal
Cinquecento in poi, cammina sui due piedi dello spettacolo e del libro di teatro,
non saranno certo le teorie sulla natura non letteraria dei testi a cambiare i
semplici fatti degli uomini di teatro divenuti classici delle letterature.
Le considerazioni di Stanley Wells 51 sui testi shakespeariani come corrispondenti
ognuno ad un preciso e differenziabile stadio di composizione, la sua immagine di questi
testi come di altrettante “istantanee” sopravvissute fra innumerevoli “scatti” perduti,
hanno a che vedere con il carattere particolarmente arduo della filologia buona per
questo tipo di testi, non con un loro non esser altro che pretesti per lo spettacolo.
Nel suo “Epilogo” Giorgio Melchiori si lascia insomma scappare uno di quei
perniciosi aut-aut nutriti dall’illusione che la descrizione della realtà sia
particolarmente precisa quand’è sottoposta ad una drastica deformazione chirurgica che
tagli dal discorso i “quasi”, gli “anche” e le “e”. A p. 976 torna ad associare l’
“impermanenza”, la “fluidità”, la “variabilità” del testo teatrale con l’affermazione
secondo cui esso “si realizza soltanto [sottolineatura mia] quando è tradotto
[sottolineatura dell’autore] in linguaggio scenico”. E al momento di concludere (p. 978)
ripete ancora una volta che “il testo teatrale è valido per quel che comunica sulla scena,
con la sola mediazione dell’attore”.
E interessante che questi luoghi comuni cui ci avevano abituato soprattutto le chiacchiere
di certi teatranti siano ora trasmigrati sulle labbra di un letterato finissimo, uno dei più
insigni fra gli studiosi di Shakespeare, il più insigne dei nostri. Una
trasmigrazione giustificabile in quanto unilateralità concepita come rimedio ad
un’altra unilateralità eguale e contraria (sulla bocca dei teatranti questi argomenti hanno
sempre avuto, infatti, il tono un po’ stridulo e arrabbiato delle ritorsioni); una
reazione, nello specifico, alle esagerazioni ignare di cultura teatrale di larga parte
della critica shakespeariana.
La questione ha fatto così un giro di 360 gradi: e si ritrova al punto di partenza. Ai
molti che per quasi tre secoli hanno negato l’evidenza storica sostenendo che i testi
di Shakespeare eran fatti per la pura lettura e non per la scena, rischiano ora di sostituirsi
coloro che negando anch’essi l’evidenza sostengono che si tratta di documenti di
spettacoli spariti da leggersi solo come documenti e non anche come opere autonome.
La solita contrapposizione di senso comune e buon senso
Un simile cambiar tutto per non cambiar niente caratterizza anche le basi
epistemologiche della storiografia teatrale, che dopo essersi affrancata
dall’identificazione con la storia della letteratura drammatica deve oggi affrancarsi
dall’estraneità alla problematica letteraria.
L’ostacolo più difficile da superare ha, tutto sommato, radici moralistiche: sembra infatti
impossibile che le regole (e le furbizie) del commercio possano contribuire a far poesia
non diversamente dalle regole (e dalle furbizie) della metrica. Questa incapacità a
valutare il valore della “metrica” materiale implicita nel commercio di teatro (che
essendo fatto di successi-insuccessi è stato un dialogo azioni-reazioni) rende ingiusto e un
po’ miope, per esempio, il giustissimo giudizio di Croce su Pirandello drammaturgo. La
metrica del mestiere scenico emergendo in tutta la sua materialità dall’indagine
filologica sui testi shakespeariani pareva offuscarne, agli occhi di Melchiori, la Poesia
tradizionalmente intesa. O forse è proprio la consapevolezza dell’esistenza di tale
“metrica” a farsi largo sgomitando fra le parole un po’ incerte di Melchiori. Qui è
davvero il caso di distinguere fra la lettera e lo spirito, proprio perché la lettera è
imprecisa, ma lascia trasparire un modo di leggere il testo letterario teatrale che supera
per fecondità e difficoltà di pensiero quanto di meglio ci giunga, a cavallo di
Shakespeare, da quel di Oxford o di Cambridge. E dunque con unilaterale malizia che
nelle pagine precedenti è stato estratto dalle parole di Melchiori l’esemplare d’un bacillo
difficile da isolare, tanto più potente quanto meno individuabile.
L’aut-aut che può essere maliziosamente distillato dalle righe di Melchiori si annida
invisibile e deleterio nella mentalità teatrale diffusa: se ieri screditava gli studi sulla
vita materiale dei teatri e sulla poesia scenica degli attori, oggi relega gli studi sulla
letteratura drammatica in una sorta di limbo, fra una critica letteraria troppo facile e con
la coda di paglia - perché il teatro poi è un’altra cosa e il testo “vive solo nello
spettacolo” - e una storiografia timorosa d’affrontare la concreta vita della cultura
teatrale con i suoi fitti scambi fra spettacoli e libri.
Le cose non sono molto cambiate dagli anni Venti, quando Silvio d’Amico alzava la
voce per farsi sentire da Croce e da Craig o rispondeva alla critiche di Gobetti.
Allora era Gobetti ad indicare nel concetto di “interpretazione” il seme degli
equivoci teorici di d’Amico 52, mentre quest’ultimo in un articolo su “Il Resto del
Carlino” dell’ 11 ottobre 1923 (ripubblicato quasi per intero da Andrea Mancini nel
numero di “Ariel” dedicato a d’Amico 53) cercava di riaffermare l’indissolubilità
testo-spettacolo e di conseguenza la necessità di giudicare l’arte dell’attore alla
luce della correttezza o della fedeltà della sua interpretazione. Piero Gobetti, a sua
volta, aveva reagito a Maschere, il libro nel quale d’Amico s’era illuso - com’egli
stesso dice di sé in terza persona - di “persuadere qualcuno fra i nostri attori ad
essere meno infedele allo spirito dei poeti che si recitano in teatro” 54.
Ringraziando per quel libro, Benedetto Croce non poteva fare a meno di precisare:
“Io sono stato da giovane gran frequentatore del teatro di prosa; ma ciò che allora
m’interessava era la personalità degli attori, e non la fedeltà al testo del poeta” 55.
Quando Croce assimilava gli attori ai “traduttori” intendeva appunto affermare,
nel suo particolarissimo gergo filosofico, la loro indipendente responsabilità
d’autori. Un’indipendenza che il filosofo ebbe sempre presente come un pregio,
ma che nella mentalità corrente faceva presto a trasformarsi in una svalutazione,
tant’è che il suo “traduttori” sembrerà poi significare, come significa
normalmente, un onesto artigianato al servizio dell’opera-madre, un qualche
(necessario o opportuno) degrado dell’energia originaria. Così l’intendeva
Pirandello, in senso nettamente anti-crociano, nel saggio del 1908 sulla “Nuova
Antologia” 56 o nell’articolo del ’18 sul “Messaggero della Domenica”57. Ma così
l’intende persino un pedissequo interprete del pensiero crociano sul teatro come
Federico Frascani 58 che quando passa dal riassunto al commento si sente in dovere
di scusare Croce, il quale non avrebbe potuto immaginare le finezze interpretative
della moderna regìa, la capacità d’incarnare la “poeticità” dell’autore dimostrate
per esempio da un Luchino Visconti. Mentre a dar ragione a Croce ci sarebbero sempre secondo Frascani - le masnade di attori che “falsano” e “sminuiscono” gli
autori rappresentati. Inutile aggiungere che Croce pensava a tutt’altro e che per
lui gli attori “traduttori” - cioè creatori d’opera autonoma rispetto al testo scritto non erano affatto i soliti guitti di cui si parla spesso a vanvera quando si parla di
mattatori o di teatro all’antica italiana. Ed anzi: se si rilegge bene il saggio
Comici (XXVIII del V volume della Letteratura della nuova Italia) e se si
penetra il senso della sua bizzarra andatura, che dall’iniziale teoria sembra si
lasci poi sviare passo passo dietro l’arte di Scarpetta, fino a riassumerne Miseria e
nobiltà ed a concludere il saggio al termine della commedia, quasi che per
esprimersi bastasse l’applauso senza più bisogno d’argomentazioni in stile critico,
se lo si rilegge bene ci si accorgerà di come anche lì s’adombri l’idea d’una
metrica che coincide con le esigenze e i trucchi del mestiere e che può condurre
al crescere d’un’opera letteraria di sia pur umile poesia. C’è del moralismo anche
in Croce, perché mentre il connubio commercio-poesia poteva accettarlo per l’umiltà,
appunto, dell’artista dialettale, esso gli appariva poi inammissibile quando la
materia in gioco era la pretesa “alta” di Pirandello. Nel biglietto di risposta al
giovane autore di Maschere Croce accennava alla propria esperienza di spettatore
senza l’imballaggio che la renderà spesso confondibile e confusa. E l’esperienza
d’uno spettatore semplice (nel senso di non doppio) che quando va a teatro pensa a
quel che vede senza sovrapporvi mentalmente quel che ha letto.
Vi sono spettatori, protestava d’Amico, che conoscono l’opera dell’autore solo
attraverso l’attore e credono che Spettri sian quelli di Zacconi, e le pochades
francesi siano quelle recitate della compagnia Galli-Guasti-Bracci: “delle
deformazioni e delle falsificazioni che troppo spesso l’opera subisce pel tramite
dell’esecutore essi non si avvedono” 59. Un argomento che certo non avrebbe
potuto applicarsi a spettatori come il giovane Croce e che comunque ha a che
vedere con la pubblica istruzione nel senso scolastico del termine e non dice gran
che sul valore e la qualità dello spettacolo. I problemi semmai cominciano quando lo
spettatore conosce Ibsen e Feydeau sia attraverso la lettura che attraverso gli
spettacoli e non sopporta di non riuscire a combinare le due immagini.
“È un fatto” scrive d’Amico nel ‘35
che a teatro si può andare in due modi. Uno è quello del gran pubblico, che vede avanti a sé la maschera,
o il volto dell’istrione, o dell’artista; e a quella maschera s’interessa e si commuove, di quella gioisce; il
cosiddetto dramma, per un tal pubblico, non è se non l’occasione alla mimica di quella maschera,
all’azione di quei muscoli; nasce insomma dagli attori, dalle loro personalità e capacità [...]. C’è poi
un altro modo, quello per cui si percorre il cammino inverso; per cui prima esiste il Poeta, la Parola, il
Dramma, e poi dal testo di questo dramma, materialmente realizzato, nasce il Teatro: quando, cioè, il
miracolo si compie, la Parola s’incarna, i fantasmi si trasformano in creature viventi di vita anche
sensibile, i personaggi si animano in altrettanti attori 60.
Confesso che ogni volta che mi trovo di fronte a discorsi di questo genere, recenti o
di un passato più o meno prossimo, dove ci si pone il problema se siano prioritari il
“testo” e la “parola”, o lo siano invece lo “spettacolo” e l’“attore”, o in cui ci
si interroga su come la pensi o la pensasse al riguardo questo o quel personaggio
(regista, critico, drammaturgo) non riesco a raccapezzarmi. Mi paiono di quelle
alternative del tipo “la gallina è un volatile o un animale domestico?”, che una
volta accettate nella loro assurdità non possono che dar luogo a bisticci da
giornale o dopo-teatro. Nel brano di d’Amico appena citato, per esempio, il
problema della consapevolezza storico-letteraria dello spettatore slitta in quello assai
diverso della gerarchia dei valori teatrali e nella ricerca della sua essenza che secondo un paralogismo diffusissimo - coinciderebbe con la sua origine. Sbocca,
infine, nel mito o miracolo del teatro come incarnazione. Persino le più semplici
notazioni sociologiche scivolano tranquillamente nel loro opposto, come se non ci
fosse ragionamento che conta e contasse solo la posizione in diatriba. Il modo
d’andare a teatro che d’Amico giudica riprovevole è prima quello del “gran
pubblico” ma sùbito dopo viene attribuito agli spettatori raffinati, come se a
Silvio d’Amico, fra nuovi “ottentotti” e nuovi “parigini”, toccasse porsi in mezzo,
nelle vesti d’un non più semiserio Crisostomo.
Per toccare qualcosa di solido dietro tutte queste diuturne confusioni occorre saltare
su un altro piano: capire cioè che cosa possano essere queste pasticciate domande,
queste pasticciate teorie quando non sono pura polemica o pura propaganda.
La sete di Attilia
Son pura nostalgia. E per accorgersene basta scontrarsi in un esempio di qualità.
Attilia non ha la testa ingombra di discussioni da giornali né la bocca piena di
filosofie alla moda. È miope. Ma se le manca qualcosa nel Goldoni di Novelli, se
qualcosa le vela il libero godimento della poesia dell’attore sarà magari anche nel
suo caso un errore, ma che conserva intatta una sete. Uso questa parola perché non m’è
facile dimenticare il modo in cui Roberto De Monticelli concludeva, su “Il
Giorno” del 4 febbraio 1966, la cronaca milanese della “spaventosa efficacia” di
Mysteries and smaller pieces a Palazzo Durini: “Da una serata così” diceva “si
esce, certo, turbati. Ma con una tal sete della parola, della parola che,
insostituibile, completa e risolve; una sete come d’una goccia d’acqua nel
deserto”.
Non m’è facile dimenticarlo perché è l’esempio del desiderio d’uno spettatore
concreto, affilato dalla frizione con uno spettacolo vivo e avverso, colto nel
momento della sua soggettività e verità, prima che tenti di farsi prepotente
servendosi della superiorità del critico, prima che pretenda d’imporsi come
desiderio doveroso per gli altri in nome d’una qualche scempia teoria.
Silvio d’Amico nel romanzo che lasciò senza titolo ci regala qualcosa d’equivalente.
Le finestre di piazza Navona è del tipo “un’autobiografia e non la mia”,
secondo la bella formula in cui Svevo condensa una delle tecniche auree della scienza
del romanzo. L’abbiamo visto: Attilia, come il suo autore, è gravemente miope, ma a
differenza del suo autore non pare che porti occhiali, come in genere tendevano a
non portarne le signorine del secolo scorso, che li sostituivano al massimo con le
lorgnettes. Ma nel romanzo non c’è traccia di lorgnettes come non ce n’è
d’occhiali. Nessuna traccia neppure nelle foto della sorella maggiore di Silvio
d’Amico, quella Rosina che di Attilia è il primo corrispondente reale. Rosina
diventò maestra, morì nubile a 52 anni nel 1930 e dalle fotografie (così come dal
sentito dire famigliare) non pare proprio che fosse miope. In realtà Silvio d’Amico
proiettò in Attilia, protagonista del suo unico romanzo, larga parte di sé, benché il
personaggio direttamente autobiografico fosse piuttosto il terzogenito Massimo, che
con Attilia ha lunghi segreti colloqui sull’arte di fabbricar versi: similmente,
Silvio d’Amico negli anni fra il 1900 ed il 1905 frequentava l’Accademia degli
Arcadi, “ragazzetto tenuto per mano da una brava e intelligente sorella
maggiore”.61
Ma quel dono pesante e prezioso, quella doppia vista che era la propria miopia,
Silvio d’Amico non la regalò a Massimo, la regalò ad Attilia.
Il romanzo è postumo, pubblicato da Mondadori nel 1961 con alcune pagine
mancanti e con il titolo apocrifo, Le finestre di piazza Navona, ripubblicato in
edizione completa trent’anni dopo per l’interessamento e la cura di Geno
Pampaloni. Impasta liberamente elementi autobiografici disparati, piegati ad un
ordine e ad una significazione autonoma. Mi pare, anzi, che nei diversi
contributi al numero monografico di “Ariel” dedicato a Silvio d’Amico ed alla
sua famiglia (è lì, per esempio, che si vedono le foto di Rosina già matura) l’aspetto
autobiografico e documentario di questo romanzo sia un po’ esagerato, come
spesso accade per le opere miste d’autobiografia e di finzione quando la figura
dell’autore incuriosisce a tutta prima più delle sue arti dissimulatorie.
La “Nota” alla prima edizione - non firmata ma di Fedele e Alessandro d’Amico spiegava il titolo: il manoscritto era intestato “Prologo, 1898” perché l’autore
pensava ad una tetralogia che avrebbe accompagnato i fratelli Alessandri (Attilia
Francesco Massimo e Orazio) dal 1898, attraverso il ’14-18 ed il ’36-37, fino al
’38-39, un tempo relativamente vicino a quello in cui d’Amico scriveva, nella
primavera del ’44, quando a Roma c’erano i tedeschi e lui, che pure non era stato
nemico del passato regime, era ora costretto a nascondersi. Viveva quindi fuori casa
in un appartamento all’ultimo piano di palazzo Lancellotti, l’appartamento in cui è
ambientato il romanzo, dove invece di Lancellotti si chiama Sanfilippo. Poiché
inizia con uno sguardo adolescente e miope da una finestra di palazzo LancellottiSanfilippo su piazza Navona, il titolo che i figli dettero al libro trovato nel cassetto
del padre è appropriato.
La miopia di Attilia è dunque un modo d’evadere dalla realtà nel momento
stesso in cui la osserva acutamente. Più che una debolezza della vista è uno
spostamento dell’attenzione, simile per gli effetti alla nebbia, quando si apre la
finestra e si vede d’improvviso un mondo opalescente e cambiato, più
immaginazione che panorama.
E nel capitolo II del romanzo che Silvio d’Amico osserva il suo sosia adolescente e
femminile mentre in un palco del teatro Valle assiste alla serata d’onore di Ermete
Novelli:
Si dava La famiglia dell’antiquario: e Attilia vi s’era preparata, oltre che con una congrua toletta,
col leggersi attentamente il testo della commedia, ripescata fra i volumi d’una collezione incompleta
nella piccola libreria di casa [...]. Non ne perdeva una parola, se le beveva tutte con un’avidità da
innamorata; ma ascoltandola, la sua attenzione si veniva come spostando. Ella conosceva Novelli per
avergli sentito recitare, l’anno avanti, Le miserie del signor Travetti; e n’aveva riportato un
entusiasmo rovente, come per un artista di vena straricca; d’un dominatore che, prima ancora
d’entrare in scena, solo col far sentire la sua voce di là dalle quinte, s’impadronisce del pubblico e
se lo porta dietro dove e come vuole, facendolo ridere e piangere a suo talento. Questa volta
invece, che è che non è, avendo letto da qualche ora la commedia, Attilia s’accorge che il portentoso
attore, mentre da un lato la seduce e la incanta, dall’altro le fa, sotto sotto, come chi dicesse una
truffa. Una quantità di battute, di trapassi, di sfumature, ch’ella poc’anzi ha gustato pienamente nel
testo, adesso alla recitazione non le ritrova, non le riconosce più. In compenso, Novelli le viene
scoprendo una quantità d’altre cose di cui alla lettura ella non s’era accorta; ottiene una quantità
d’effetti impensati; frasi che, leggendole, le erano parse insignificanti, qui assumono un improvviso
rilievo, suscitano fra il pubblico una ilarità piena, pigliano l’applauso a scena aperta62.
La “sete” d’Attila non è per la “parola”, ma per l’immutabilità della parola.
Vorrei sottolineare alcune espressioni: che è che non è (indica il carattere
inopinato della delusione, quasi un risveglio di colpo); s’era preparata; la sua
attenzione si veniva come spostando; avendo letto da qualche ora la commedia;
come chi dicesse una truffa; non le riconosce più. Entrano in collisione due sogni
ad occhi aperti: quello del lettore che immagina la commedia e quella dello
spettatore che la vede. Quello della lettrice e della spettatrice. Tutto si conclude
nel grande applauso a scena aperta, dove il sospetto d’una “truffa” s’acuisce nella
mente della spettatrice che si domanda:
ma a chi va, allora, il merito di quell’applauso? A Goldoni, o a Novelli? 63.
D’Amico è dentro quella mente, osserva in essa quel che per lui è forse il nascere di
un’idea diversa di teatro, ma che a noi, che possiamo osservare a distanza e col
senno di poi, non può che apparire come l’accavallarsi o l’intreccio di due teatri
diversi, come se Attilia e il suo autore non riuscissero a starsene seduti a teatro senza
correre con il pensiero ai loro beneamati libri. Non sono spettatori “semplici”. Ma
in questo caso la loro duplicità non è dovuta a ragioni ideologiche, ma ad un bisogno
di sovrappiù. Domandano al teatro una luce che li delude per la qualità stessa della
presenza dell’attore. Questo doppio legame, che in fondo è quel che rende
contraddittorie e pasticciate le diatribe sull’attore e la poesia del testo, si
manifesta qui nel suo momento sorgivo, il solo ad avere una qualche dignità di
pensiero:
Nella sua deliberata dedizione all’attore che imparruccato e splendido, passeggia per la scena come
in casa sua, baloccandosi con l’occhialetto fra le dita come col cuore del suo pubblico, Attilia sente
intrudersi un che di ritrosia, di resistenza, di segreta protesta 64
L’intrusione
Sarà bene sottolineare il verbo intrudersi (il cui participio passato è intruso). Indica
sì un introdursi quasi inavvertito, di soppiatto o a forza, ma soprattutto un’immissione
arbitraria o illecita. Quell’intrudersi, allora, è di d’Amico o di Attilia, dell’autore
o del personaggio? Dipende sintatticamente da sente, che lo denota come
un’emozione di Attilia, ma non per questo è meno significativo: ciò che Attilia sente
è un’interferenza innaturale e in qualche modo fuori posto, illecita e forzata.
L’autore, se glielo obiettassimo, probabilmente risponderebbe che ogni delusione,
ogni fenomeno che ci spinge ad aprire gli occhi, lo si sente sulle prime come una
violenza alla quiete del precedente piacere. Risponderebbe che Attilia (come lui,
lo scrittore) dell’amore e del piacere fisico del teatro non si sa contentare se non
lo vede vidimato da una superiore morale estetica, dall’accordo con un dover
essere che trascende il divertimento d’una buona serata. Infatti:
Bisogna che, finita la commedia e smesso l’abbigliamento goldoniano, Novelli si ripresenti alla ribalta
in frac, col suo faccione aperto e i folti capelli a spazzola, a recitare un monologo, perché Attilia si
senta riconquistata interamente, senza più riserve. Il monologo non consta d’altro che d’una serie
di freddure; ma lui, come le dice! come pare che via via, le cerchi, le insegua a volo, le imbrocchi e
scocchi li per lì, quasi conversasse alla buona, improvvisando, con le ottocento persone intorno a lui!
E che umanità riesce a infondervi! Scemenze, giochi di parole; e tutt’a un tratto pigliano una sorta
di significazione ironica, umuresca, patetica, insomma umana; diventano allusive, fanno quasi
pensare! Attilia sorride, ride, si lascia prender tutta dal contagio di quella virtù egocentrica,
prepotente, vittoriosa. Soltanto alla fine, quando la folla chiama e richiama fra strepitosi battimani
il suo beniamino, ella scendendo le scale coi suoi domanda a se stessa: “e dunque il teatro è
questo? il teatro non è l’opera del poeta, che prende carne e diventa un cosa reale? il teatro è
l’attore e basta?” 65
Noteremo qui l’astrattezza quasi da catechismo della domanda. La “ritrosia” la
“segreta protesta” che quasi di soppiatto o a forza s’è introdotta nella mente di
Attilia rovinandole il piacere della recita di Novelli non deriva da ciò che ha visto, e
neppure dalla sfasatura fra ciò che l’attore stava facendo e ciò che lei aveva
precedentemente letto, ma dall’idea (sia superstizione o dottrina) che nega la
liceità (ed il piacere) di tale sfasatura.
L’altra domanda - “ma a chi va dunque il merito di quell’applauso?” - che
potrebbe sembrare più da critico che da semplice spettatore (spettatrice) - è invece
anch’essa il risultato d’una mente fantasiosa e desiderosa d’ordine, che trova “la
poesia nella regola” e pensa l’ordine come libertà di non deviare da ciò cui la
propria natura inclina. Attilia, a p. 134, cita fra sé e sé Dante, ma in realtà il
suo è un modo di pensare più vicino al tomismo paradossale di Chesterton che non
a quello di diamante di Dante, quel Chesterton che d’Amico non si stancava di
citare e una cui frase da Ortodoxy aveva posto nel 1929 come esergo a Tramonto
del grande attore.
Nell’utile “Storia d’un libro” che fa da postfazione alla riproposta recente di
Tramonto, Andrea Mancini rileva giustamente l’importanza della pagina di Attilia
che abbiamo appena letto, ma non mantiene poi le sue promesse e non ci mostra
affatto come in questa pagina si condensino le contraddizioni e le polarità in cui com’egli dice - “si gioca tutta la carriera critica di Silvio d’Amico”. A meno
che tutto non si riduca alla pura e semplice constatazione che l’entusiasmo
d’Attilia (e di d’Amico) per la bravura del Grande attore fa contrasto con il fastidio
e il rifiuto (di d’Amico e d’Attilia) di un’arte scenica che pur essendo in
relazione a un testo non ne sia l’espressione la più fedele possibile. Ancora una
volta, insomma, ci troveremmo di fronte al comodo passe-partout secondo cui in
ogni teorico c’è un’incoerenza pratica. Né mi pare si possa consentire con l’altra
affermazione che viene avanzata - sempre in quella “Storia d’un libro” - a
proposito delle domande con le quali Attilia esce di teatro. Esse potranno essere
astratte, potranno avere una secchezza che nega le ondate emotive della recita, ma
non sono affatto “fuori luogo, così poco da romanzo”. Sono coerenti con il
comportamento intimo di Attilia, personaggio costruito sull’alternanza
d’intelligenza imperterrita, tendente all’astrazione, e turbamenti relegati in una
zona volutamente inesplorata dell’animo (tant’è che il suo pensiero oscilla via dal
teatro e dai suoi problemi e si rivolge, in chiusura di capitolo, ad un turbamento
che non sa ancora d’amore). Ma soprattutto sono domande perfettamente adattate al
carattere della sequenza narrativa cui appartengono. Di essa, anzi, costituiscono
l’acme, cui farà seguito una coda che riprende e varia tutti i temi del capitolo.
Il capitolo II de Le finestre di piazza Navona è ambientato di carnevale (siamo nel
1898) ed esplora la gamma degli spettacoli. È la tecnica narrativa che malgrado
l’apparenza frastagliata dà al romanzo la sua composta e novecentista geometria: il
nitido disegno delle vicende famigliari (la famiglia Alessandri) si coniuga con un
ben ripartito catalogo (i tempi i parenti i luoghi gli usi casalinghi e cittadini). In
quanto catalogo, il secondo capitolo è lo scomparto spettacoli: il cinematografo a
via del Mortaro (p. 74), l’“oratorio” alla basilica Santi Apostoli (p. 75), la recita
all’Istituto Massimo (pp. 75-78) e Novelli al Valle (pp. 78-81). E il campionario
dei divertimenti d’una famiglia borghese colta e cattolica nella Roma di fine secolo.
Ha un prologo ed un epilogo che completano, da un punto di vista l’uno intimistico e
l’altro romanesco-onirico, la qualità del tempo di carnevale. Per gli amanti delle
atmosfere e dei paralleli potremmo dire che il prologo fa molto Fanny e Alexander
e la conclusione fa molto Fellini.
Il prologo intimistico è una dolce malattia. Ed una porta finta. Quando Massimo
ha l’influenza (pp. 72-74) sprofonda con l’immaginazione fra le figure delle storie
sacre, legge un “volume grande” dove ci sono Giuseppe e Beniamino, David Saul
ed Elia, il quale ultimo sembra a volte aggirarsi in certe viuzze di Roma dove il
bambino ha degli “attoniti incontri” con un papas. “Massimo s’è sempre tenuto
istintivamente a tu per tu, se non col soprannaturale, col meraviglioso” 68 che egli
immagina come un teatro dell’anima nascosto dietro una porta finta:
Fra le quattro porte del salotto ce n’è una finta, messa lì per simmetria, con tanto di sovraporte
dorate e portiere pesanti, come le altre. Massimo sa bene che è finta, che dietro ha il muro e basta; pure,
da anni, tutte le volte che, nella penombra del vasto ambiente, si trattiene a guardarla, comincia a
fantasticare d’appartamenti misteriosi a cui, adoperando un’immaginaria chiave smarrita, essa darebbe
l’accesso. E si figura, lì dietro, file e file d’altri saloni, più grandi e più bui, pieni di mobili immensi, e
gigantesche armature, e monumentali scrigni di quercia e d’acciaio, come se n’intravedono
nelle illustrazioni di Doré alla fiaba di Barbablù [Il fratellino anch’esso influenzato dorme nel letto
accanto...]. A Massimo piacerebbe che il tempo, per un poco, si fermasse così 69.
Si è già visto che Massimo e Attilia sono in parte due versioni d’una stessa vita.
Ritroviamo nel brano che abbiamo appena letto la congiunzione di libro e spettacolo,
ma come purificata rispetto a quella che si verifica in teatro, senza strappi ed
intrusioni, senza duplicità e senza tensioni. Mentre lettura e sogno ad occhi aperti
vanno assieme in armonia, il teatro non s’accorda, si disaggrega. Ciò che nella
visione teatrale d’Attilia s’intrude disturbando l’abbandono con cui ella si lascia
assorbire dal palcoscenico è l’improvvisa e acre consapevolezza che il teatro pare
ma non è un sogno.
Et in Arcadia
Quasi in un sogno il capitolo si conclude: la carrozza di Attilia e dei suoi famigliari
percorre la Roma notturna e su un marciapiede si vedono marciare in fila una
dozzina di bimbi e bimbette col viso nero come il carbone e i denti lampeggianti:
“Semo li moretti de l’Aida” dicono in romanesco, e tornano a casa dopo aver
danzato nell’Opera. Ma anche stavolta la mente di Attilia è altrove, come alla
finestra nella notte dell’Epifania.
Fra i due sogni ad occhi aperti che aprono e chiudono la sequela degli spettacoli
in questo capitolo ad essi dedicato, il teatro, come si diceva, è un non-sogno. Dietro
la dottrina dell’attore fedele e della poesia incarnata c’è l’insoddisfazione per una
mancata identificazione fra la scena reale e la scena della propria mente, fra il
teatro pubblico e il teatro dell’anima. Il meraviglioso teatrale, quel mondo che per
Massimo per Attilia e per d’Amico assomiglia tanto al soprannaturale, o
dovrebbe assomigliargli, si rivela un meraviglioso che non riesce o non può
appartenere loro. Esaspera la sete, invece di placarla. Delude alla lettera, perché
fa uscire fuori dal gioco, dall’illusione che lo spirituale possa davvero farsi
materia e presenza sotto i loro occhi. Ciò che in realtà si manifesta è un’altra
cosa, uno strappo, una dissonanza che ad alcuni pare fastidio mentre ad altri sa
rivelare un varco ancor più prezioso della sospirata incarnazione della poesia. Ma
questo è già un altro discorso (il prossimo).
Parrà strano, ma credo che se volessimo trovare un brano che davvero stia bene
accanto a questo di Attilia non dovremmo cercare nel giro degli scritti sui rapporti
fra attori e testo , ma in tutt’altro orizzonte, in un libro, per esempio, di Emilio
Cecchi, Et in Arcadia ego 70 , pubblicato nella sua prima versione nel 1936, un
autore legato per sensibilità ed amicizia a Silvio d’Amico. Racconta un viaggio in
Grecia, nel ‘34 (nella sua seconda e definitiva edizione ingloberà anche un
viaggio del ‘57). Cecchi pernotta dalle parti di Delfo:
Una piega del monte celava il santuario. Più su o più giù, poco importa, di qui era passato Oreste, con a
fianco l’amico, prossimamente cognato, quando si recò a consultare l’oracolo d’Apollo [...]. Ma in
luogo d’un Oreste confacente, quello che sulla strada scura mi si veniva accostando era così ambiguo, e
tra serio e faceto, che da principio neanche capii di dove uscisse71.
Anche qui un’interferenza, un’intrusione, un’estraneità del teatro rispetto a quel
bisogno di qualcosa di “confacente” col proprio teatro dell’animo o della mente.
Rispetto ad Attilia accade qualcosa di speculare e d’identico: l’immagine scenica qui ricordata, là veduta - inibisce l’immaginazione personale, rende lo
“spettatore”, in qualche modo, straniero ai propri sogni. E se lo spettatore è molto
sicuro di sé, questo spaesarsi assume ai suoi occhi fattezze un po’ volgari. Di dove
esce, dunque, nella fantasia di Emilio Cecchi, quell’Oreste tra serio e faceto?
Trenta anni fa, ero stato ad una delle ultime recite del gran Salvini che, accompagnato dal figlio,
diceva addio al pubblico, col nobile Oreste alfieriano. A modo loro, sia padre che figlio, artistoni.
Tutt’e due grossi, con un po’ di pancia: succinta la tunica, magri gli stinchi. Si palleggiavano gli
endecasillabi, con virtuosismi portentosi. E il rimbombo, preciso e sostenuto, della botta e risposta,
faceva pensare alle partite a tamburello.
Come ora mi pentivo di non essere rimasto a casa, quella sera, trent’anni addietro. Ero perseguitato,
ossessionato, da quegli scocchi, da quelle pancette. Per un Oreste e Pilade da farsi vedere insieme a
Delfo, nemmeno pensarci. D’altra parte, trattarli sgarbatamente non volevo. Mi sforzai a distrarmi,
a scantonare col capo; come Dio volle mi lasciarono, e non ne ho più saputo niente72 .
La gentilezza di Emilio Cecchi, come la gentilezza di Attilia, non profanano il teatro
che tutto d’un colpo balena loro estraneo. Si limitano con più o meno ironia a
metterlo un po’ da parte. Ci rivelano quel che probabilmente c’è di serio sotto le
poco serie teorie dell’unità indissolubile testo-scena.
Lo spazio letterario del teatro comprende anche questo: il sogno d’una recita che
sia letteratura o poesia incarnata, una sorta di gioioso spiritismo dove le persone che sulla pagina compaiono senza volto, come fasci d’azioni e pensieri - acquistino
una faccia e proprio quella che noi con l’occhio della mente prevedevamo.
Un sogno che ha fatto molto male agli studi, quando s’è camuffato da teoria o ha
tentato di fecondare la lettura scientifica dei testi letterari drammatici, col soccorso
d’allegate autorità accademico-letterarie e di specialistici gerghi. Ma che
conserva il suo spirito, la forza della sua aspirazione, se ad esso possiamo
pervenire attraverso qualcosa di simile alla miopia d’una fanciulla.
NOTE
1 S. d’Amico, Tramonto del grande attore, Milano, Mondadori, 1929. Riedito recentemente con una
presentazione di L. Squarzina e un saggio di A. Mancini, Firenze, La casa Usher, 1985. Citerò da
questa edizione.
2 S. d’Amico, Le finestre di piazza Navona, Casale Monferrato, Edizioni Piemme, 1991, pp. 9-10.
3 S. d’Amico, Maschere. Note sull’interpretazione scenica, Roma-Milano,Mondadori, 1921, p. 66.
4 G. Livio, La scrittura drammatica. Civiltà letteraria del Novecento, Milano, Mursia, 1992, pp. 27-28.
5 Ivi, pp. 109-139.
6 S. d’Amico, Tramonto del grande attore, cit., p. 31.
7 A. Arbasino, Grazie per le magnifiche rose. Tutte le avventure della drammaturgia contemporanea,
Milano, Feltrinelli, 1965, pp. 371-373.
8 S. De Feo, In cerca di teatro, vol. II, Da Ibsen al teatro-pop, a cura di L.Lucignani, Milano,
Longanesi, 1972 (è una raccolta postuma delle recensioni dell’autore), pp. 839-842.
9
R. Hellmann, Oscar Wilde, London, Penguin Books, 1988, p. 350.
10 A.M. Ripellino, Il trucco e l’anima. I maestri della regia nel teatro russo del Novecento, Torino,
Einaudi, 1965, p. 357.
11 Che Livio la pensi così lo si evince anche da quanto scrive in op. cit., p. 117.
12 M. Schino, Il teatro di Eleonora Duse, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 10.
13 Cfr. S. d’Amico, Tramonto del grande attore, cit., p. 30.
14M. De Marinis, L’esperienza dello spettatore. Fondamenti per una semiotica della ricezione teatrale.
Documenti di lavoro e pre-pubblicazioni del Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica,
Università di Urbino, 138-139, novembre-dicembre 1984, in particolare pp. 29-30; Toward a
Cognitive Semiotic of theatrical Emotion, “Vs. Quaderni di studi semiotici” 41, maggio-agosto 1985,
in particolare pp. 7-8; Capire il teatro. Lineamenti di una nuova teatrologia, Firenze, La casa Usher,
1988, in particolare pp. 120-124.
15 G. Folena, Premessa a AA.VV., La lingua scorciata. Il detto, il motto, l’aforisma, Atti del XIV
Convegno Interuniversitario, Bressanone, “Quaderni di retorica e poetica”, 1986.
16 K.S. Stanislavskij, Il lavoro dell’attore, a cura di G. Guerrieri, Bari, Laterza, 1968 (seconda
edizione riveduta, con una nuova introduzione), p. 465. L’ultima ristampa di questa edizione è del
novembre 1992, in veste più lussuosa con un corredo di fotografie e con il titolo fedele all’originale:
Il lavoro dell’attore su di sé. Ma va anche detto che l’editore, pur rinnovando la stampa non ha
purtroppo provveduto a rinnovare l’edizione che - soprattutto nella seconda parte - è il frutto di un
assemblaggio lontano da ciò che compose Stanislavskij (cfr. F. Ruffini,
Romanzo pedagogico: uno studio sui libri di Stanislavskij, “Teatro e storia”, 10 (aprile 1991), pp.
3-55, in particolare pp. 4-5.
17 M. Castri, Pirandello Ottanta, a cura di E. Capriolo, pubblicato con la collaborazione del
Centro Teatrale Bresciano, Milano, Ubulibri, 1981, p. 96.
18 Ivi, p. 111.
19 M. Castri, Ibsen postborghese, a cura di E. Capriolo, pubblicato con la collaborazione del
Centro Teatrale Bresciano, Milano, Ubulibri, 1981, p. 9.
20 E. Barba, Alla ricerca del teatro perduto. Una proposta dell’avanguardia polacca, Padova,
Marsilio, 1965; e La canoa di carta. Trattato di antropologia teatrale, Bologna, Il Mulino, in
corso di pubblicazione, cap. VI, § “Pensiero e Pensieri”.
21 E. Capriolo, in M. Castri, Pirandello Ottanta, cit., p. 133.
22
G. Guerrieri, in K.S. Stanislavskij, Il lavoro dell’attore, cit., p. XXIII.
23
E. Capriolo, in M. Castri, Ibsen postborghese, cit., pp. 7 e 163.
25 Ivi, p. 164.
25 La discussione tra Freud e Groddeck su Rosmersholm è in due lettere rispettivamente del 28
ottobre e del novembre 1917, pubblicate in italiano in Carteggio Freud-Groddeck, Milano,
Adelphí, 1973.
26 G. Groddeck, Il teatro di Ibsen. Tragedia o commedia? (1910), “Testi e ricerche sullo
spettacolo del Dipartimento di Discipline Artistiche dell’Università di Torino”, Napoli,
Guida, 1985.
27
R. Alonge, Introduzione a E. Ibsen, Casa di bambola, Milano, Mondadori, 1986; Introduzione a
E. Ibsen, Spettri, Milano, Mondadori, 1988; Introduzione a E. Ibsen, L’anitra selvatica, Milano,
Mondadori, 1988; Per una riproposta dell’ “Innesto”, “Il castello di Elsinore”, 7, 1990;
“Ilgiuoco delle parti”, atto primo: un atto tabù, in AA.VV., Pirandello fra penombre e porte socchiuse.
La tradizione scenica del “Giuoco delle parti”, Torino, Rosenberg & Sellier, 1991; La Nora di
Bergman: ardori, afrori, disgusti e violenze, “Il castello di Elsinore”, 10, 1991; Approcci
goldoniani. Il sistema di Mirandolina, “Il castello di Elsinore”, 12, 1991; Provocazioni
Pirandelliane: “Enrico IV”, “Il castello di Elsinore”, 13, 1992; Ibsen, il custode degli arcani del
fiordo, in AA.VV., Miti e figure dell’immaginario simbolista, Genova, Costa & Nolan, 1992. Cfr.
anche le numerose introduzioni a testi teatrali pirandelliani nelle collane degli “Oscar”
Mondadori.
28 A. Pagliaro, Saggi di critica semantica, seconda edizione riveduta, Messina-Firenze, D’Anna,
1961 (in particolare p. XVI, preparazione alla prima edizione).
29 F. Mastropasqua, C. Molinari, Ruzante e Arlecchino. Tre saggi sul teatro popolare del
Cinquecento, Parma, Studium Parmense, (“Quaderni di ricerca” 2) s.a. (1970), p. 14.
30 Ivi, p. 15. La sottolineatura è mia.
31 T.G. Pavel, Mondi d’invenzione. Realtà e immaginario narrativo (1986), a cura di A.
Carosso, Torino, Einaudi, 1992.
32 C. Segre, Teatro e romanzo. Due tipi di comunicazione letteraria, Torino, Einaudi, 1984, p.
10.
33 U. Volli, Il teatro e i suoi segni, “Alfabeta”, I, 3/4, luglio-agosto 1979.
34 Questa grossolana confusione fra pratica della lettura e pratica della messinscena è stata più
volte oggetto del sarcasmo di Franco Ruffini.
35 C. Segre, Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del Novecento, Torino, Einaudi, 1991.
36 S. Wells, G. Taylor (with j. Jowett e W. Montgomery), William Shakespeare - A Textual
Companion, Oxford, Clarendon Press, 1987.
37 L.A. Santoro, Amleto e Don Chisciotte. Il teatro o il testo instabile, Firenze, La casa Usher,
1992.
38
C. Goldoni, Teatro, a cura di M. Pieri, 3 voll., Torino, Einaudi, 1991.
39 L.A. Santoro, op. cit., p. 15.
40 Ivi, p. 21.
41 Ivi, p. 26.
42 F. Ruffini, Pensare il testo drammatico: il testo come tecnica del teatro, in AA.VV., Il teatro
come pensiero teatrale, a cura di R. Meccia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1990.
43 R. Mullini, R. Zacchi, Introduzione allo studio del teatro inglese, Firenze, La casa Usher, 1992.
44 G. Melchiori, Shakespeare e il mestiere del teatro. Epilogo, in W. Shakespeare, I drammi storici,
vol. III (Teatro completo di William Shakespeare, IX), Milano, Mondadori, 1991, pp. 971-978.
45 Ivi, pp. 471.
46 Ibidem. Le sottolineature sono mie.
47 Ivi, p. 971.
48 Ivi, p. 972.
49 Ibidem.
50
Ivi, p. 974.
5 S. Wells
1
, G. Taylor, op. cit.
52 P. Gobetti, La frusta teatrale (1923) in Opere complete di Piero Gobetti, vol. III, Scritti di
critica teatrale, Torino, Einaudi, 1974. Cfr. pp. 10-13.
53 “
Ariel”, II, 3, settembre-dicembre 1987, p. 22-24: numero monografico dedicato a Silvio
d’Amico, alla sua opera, alla sua famiglia. Contiene una scelta di pagine del Diario di guerra
1916-1917 di Silvio d’Amico, una bibliografia dei suoi scritti, un’antologia dei suoi scritti,
un’antologia dei suoi articoli pubblicati nella rubrica Corriere romano sul “Resto del Carlino”
fra il 1923 ed il 1925, le riproduzioni di alcuni suoi acquerelli, fotografie inedite di vita
familiare, l’epistolario inedito di d’Amico-Martoglio, ricordi di famiglia di Fedele d’Amico e
Filomena Alfredo Barbina, Andrea Mancini, Lia Lapini, Mirella Schino.
54 S. d’Amico, Maschere, cít. La sottolineatura è mia.
55 Cito sempre dall’articolo di d’Amico su “Il resto del Carlino—.
56 L. Pirandello, Illustratori, attori, traduttori, “Nuova Antologia” 16 gennaio 1908.
57 L. Pirandello, Teatro e letteratura, “Messaggero della domenica”, 30 luglio 1918. Si trovano in Saggi,
poesie e scritti vari, vol. VI (a cura di M. Lo Vecchio-Musti) delle Opere di Luigi Pirandello, Milano,
Mondadori, 1960, pp. 207-224 e 984-990.
58 F. Frascani, Croce e il teatro, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966, p. 9.
59 S. d’Amico, Maschere, cit., p. 8. -1
60S. d’Amico, Invito al teatro, Brescia, Morcelliana, 1935, p. 102.
61 S. d’Amico, Bocca della verità, Brescia, Morcelliana, 1943, p. 99.
62 S. d’Amico, Le finestre di piazza Navona, cit., pp. 78-79.
63 Ibidem.
64 Ibidem.
65 Ivi, pp. 79-80.
66 A. Mancini, Storia d’un libro, in Tramonto del grande attore, cit., p. 181.
67 Ibidem.
68 S. d’Amico, Le finestre di piazza Navona, cit., p. 74.
69 Ibidem.
70 E. Cecchi, Et in Arcadia ego, Milano, Mondadori, 1960 (edizione definitiva con capitoli aggiunti).
71Ibidem.
72 Ivi, pp. 48-49.
73T. Guerra, A Pechino fa la neve. Una cosa teatrale, Rimini, Maggioli editore, 1992.