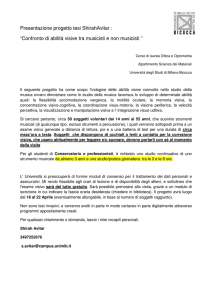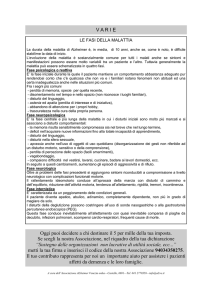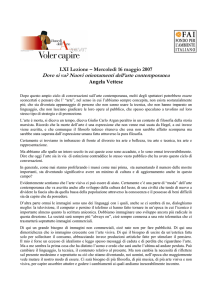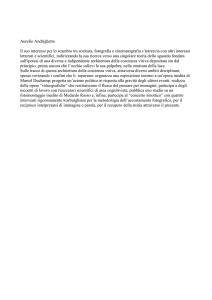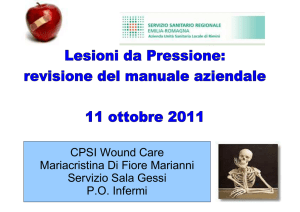caricato da
common.user17451
Eminattenzione Spaziale: Definizione, Valutazione e Trattamento

1 di 28 1. Eminattenzione spaziale. Si tratta di una condizione che viene definita come “la ridotta tendenza a rispondere a stimoli provenienti dal lato controlaterale alla lesione cerebrale”. È quindi una condizione per cui il soggetto lesionato presenta una scarsa capacità di esplorazione lo spazio controlaterale e si tratta di un disturbo multimodale e cioè non riscontrabile solo in ambito visuo-spaziale ma anche con informazioni di tipo uditive, tattili, ecc. Nella maggior parte dei casi, la lesione è di natura vascolare ischemica o emorragica e il disturbo si presenta nel 47% dei pazienti con lesione unilaterale destra e in fase acuta di malattia. In molti casi, si assiste ad una regressione spontanea del disturbo; attualmente non sono note le origini della variabilità interindividuale e non sembra esserci un legame con la gravità iniziale della sintomatologia. Dopo 4-8 settimane termina il periodo del recupero spontaneo e alcuni pazienti continua a manifestarsi il disturbo anche a distanza di anni dall’episodio acuto con una persistenza cronica in 1 paziente su 3. Per quanto riguarda la sintomatologia, i sintomi associati sono: - anosognosia; - deficit di moto o della sensibilità a carico dell’emisoma controlaterale alla lesione; - deficit del campo visivo (emianopsia o quadrantopsia); - aprassia costruttiva, si manifesta come ridotta capacità di copiare disegni ed eseguire una costruzione nello spazio; - disturbi del comportamento emozionale, sono tipici dei pazienti con lesioni emisferiche destre e si possono manifestare con indifferenza nei confronti della malattia. Tutti questi sintomi hanno poi un importante impatto nella vita quotidiana in ambito come l’alimentazione, la capacità di partecipare ad una conversazione, gli spostamenti in autonomia, lettura, ecc. 1.1 Classificazione. In base alla manifestazione, il neglect si divide in: - neglect personale: tendenza a trascurare l’emisoma controlaterale alla lesione; - neglect peripersonale: tendenza a trascurare semispazio controlaterale alla lesione all’interno di una distanza la cui unità di misura è un braccio teso; - neglect extrapersonale: tendenza a trascurare semispazio controlaterale alla lesione al di fuori dell’unità di misura di un braccio. Inoltre, il neglect può anche essere diviso in percettivo e immaginativo. Nel neglect immaginativo i pazienti presentano difficoltà e trascurano gli stimoli nella parte sinistra anche di immagini mentali. Nel neglect percettivo gioca un ruolo critico un deficit di orientamento automatico dell’attenzione spaziale verso semispazio controlaterale alla lesione. Tale deficit di orientamento dell’attenzione spaziale potrebbe derivare da diversi meccanismi: - “attrazione magnetica” patologica verso stimoli che si trovano nell’emispazio ipsilaterale; - difficoltà di disancoraggio da stimoli che si trovano nell’emispazio ipsilaterale; - difficoltà di spostamento dell’attenzione spaziale verso stimoli che si trovano nell’emispazio controlaterale; - difficoltà di ancoraggio ad un nuovo stimolo. 2 di 28 I pazienti solitamente presentano solo neglect percettivo, una piccola percentuale potrà presentare entrambi i disturbi contemporaneamente e solo in alcuni rari casi, invece, il paziente presenterà un disturbo esclusivamente immaginativo. In quest’ultimo caso, solitamente il disturbo si manifesta come esito percettivo-immaginativo insieme, in cui il deficit percettivo è regredito. 1.2 Aree neuroanatomiche coinvolte. L’eminattenzione è prodotta nella maggior parte dei casi da lesioni che coinvolgono il lobo parietale inferiore, la giunzione temporo-parietale, il lobo frontale, il talamo e/o il giro temporale superiore. Secondo uno studio di Committeri (2007), nel disturbo personale vengono coinvolte le strutture parietali inferiori (giro sovramarginale, giro post-centrale) e in particolare la sostanza bianca sottostante a queste strutture mentre in un disturbo extrapersonale c’è un coinvolgimento del circuito comprendente la corteccia pre-motoria ventrale, il giro frontale medio e la corteccia temporale superiore. 1.3 Valutazione. L’obiettivo della valutazione è quello di indagare il deficit di esplorazione; si utilizzano diverse prove quali: - Test di barrage (Albert, 1973); - Test di cancellazione di lettere; - Test di bisezione di linee orizzontali; - Test di lettura di frasi: il test presenta sei frasi di senso compiuto e il punteggio è dato dal numero di frasi lette senza omissioni. Non vengono presi in considerazione errori, inceppi, correzioni o paralessie; - Scala semi-strutturata per la valutazione del neglect extra-personale e personale (Zoccolotti, 1992): si chiede al paziente di eseguire una serie di azioni ricorrenti nella vita di tutti i giorni come distribuire le carte, descrivere un’immagini, ecc; - Protocollo di rilevamento dei sintomi da lesione destra: è un protocollo interno che viene utilizzato al Gemelli di Roma. Il test valuta il maggior numero di aspetti possibile con lettura di frasi, test dell’orologio, bisezione di linee, prove di neglect occupazionale; - Test di copia di figura; - Barrage di lettere e di linee. 1.4 Approccio in fase acuta. In questa prima fase è fondamentale stabilire una relazione, collocarsi nella porzione di spazio che il paziente considera e iniziare ad indagare la capacità di esplorazione dello spazio. Già durante il colloquio, infatti, possiamo iniziare a spostarci lentamente fino a giungere nella porzione di spazio che il paziente che non considera e osservare come risponde agli stimolo anche di natura tattile, uditiva controlaterali alla lesione. Per la valutazione del neglect personale, si può chiedere al paziente di toccarsi le guance, le orecchie, le spalle, ecc. 3 di 28 Per la valutazione del neglect peripersonale, si può far stendere il braccio del paziente e farlo seguire con lo sguardo. Tutto ciò che si osserva in questa prima fase, poi, va tenuto in considerazione e rivalutano progressivamente man mano che si va avanti con il trattamento. Per quanto riguarda la durata e l’intensità del trattamento, in una fase acuta si possono prevedere 5 sedute/settimana per otto settimane. Uno dei più grandi dubbi in merito al trattamento è la generalizzazione, talvolta i pazienti vanno bene durante le sedute di terapia e nell’esercizio ma continuano a manifestare difficoltà nella vita quotidiana. 1.5 Trattamento. Prima di cominciare qualsiasi trattamento bisogna valutare sempre la presenza di eventuale anosognosia; i pazienti con eminattenzione, infatti, presentano spesso una consapevolezza molto limitata del disturbo e attribuiscono le proprie difficoltà ad altre cause. La presenza di anosognosia ha una profonda influenza nel percorso riabilitativo poiché risulta estremamente difficile motivare un paziente a lavorare su un qualcosa che non sa di aver perduto. L’obiettivo principale del trattamento sarà quello di costringere il paziente a spostare la propria attenzione sulla porzione di spazio che non considera (ancoraggio). Dato che l’anosognosia e la scarsa collaborazione abbiamo detto che possono influenzare profondamente il trattamento, in tal senso la frustrazione può diventare uno strumento per stimolare il paziente. Infatti, possiamo sottolineare gli errori del paziente oppure chiedergli di fare una previsione prima di svolgere l’attività proposta. Per quanto riguarda l’ancoraggio, ci si può lavorare con l’uso di colori, richiami sistematici, sottolineare costantemente gli errori, evitare che la ricerca proceda da destra a sinistra, spingerlo all’esplorazione (toccando il bordo del tavolo, fornendo il numero complessivo degli stimoli da ricercare). Gli esercizi che verranno proposti, poi, sono molto simili a quelli che si utilizzano in fase di valutazione. In entrambe le fasi, è importante non utilizzare fogli A4 ma quantomeno unirne due in modo da avere un campo visivo più ampio. Il foglio va sempre bloccato. Uno degli aspetti che va tenuto in considerazione, in base a ciò che emerge in valutazione, l’importanza di elaborare un piano personalizzato e adatto alle esigenze del paziente. • Training di scanning visuo-spaziale. Si lavorerà attraverso la ricerca di numeri, lettere, disegni e altri stimoli all’interno di un ampio campo visivo (proiettore, per esempio). Si può pensare anche di utilizzare il tachistoscopio. • Training di lettura e copia. I parametri che possono variare nella selezione del materiale sono il numero di parole, numero delle righe, grandezza delle parole, tipo di carattere, inizio della frase, tipo di parola iniziale, presenza o meno del richiamo semantico nel ritorno a capo. • Training di copia di tracciati su matrici di punti. Una matrice al terapista e una al paziente e il paziente deve riprodurre ciò che il terapista disegna. Ovviamente, il terapista dovrà tracciare il modello da sinistra verso destra. I parametri che possono 4 di 28 variare per aumentare le difficoltà dell’esercizio sono il numero dei punti e il numero delle linee. • Training di cancellazione di figure geometriche/lettere con o senza elementi distrattori. Per aumentare la difficoltà dell’esercizio è possibile modificare parametri quali numero degli stimoli sul foglio, presenza di stimoli distrattori e/o dimensione del foglio. • Training di descrizione di figure. Anche in questo caso è possibile variare alcuni parametri come il numero degli elementi nel disegno, la presenza di elementi di collegamento tra la parte destra e sinistra del foglio e la dimensione delle immagini. • Training funzionale. In questo caso si lavora su aspetti pratici ed ecologici con attività quali risoluzione di giochi enigmistici, ricerca di numeri e indirizzi, utilizzo del computer. Durante il trattamento, come già detto prima, l’aspetto più difficile è la generalizzazione. • Adattamento prismatico. In alcuni centri di ricerca specializzati, si utilizzano speciali occhiali con lenti prismatiche che deviano il campo visivo di 10° verso destra. In questo modo, il paziente è costretto ad esplorare in modo più ampio verso sinistra. Solitamente un approccio di questo tipo viene utilizzato con una frequenza di due sedue/settimana e soprattutto nei pazienti cronici. • Altri esercizi. Altre attività che possono essere proposte possono essere esercizi in cui il paziente deve segnare il segnare di alcune forme geometriche oppure bisezione di linee segnano con una X o con dei colori l’inizio e la fine del segmento. Bisogna sempre tenere a mente che il primo obiettivo della riabilitazione è quello di avere un recupero funzionale e un impatto sulla vita quotidiana del paziente. Spesso chiedendo al paziente stesso o ascoltando le difficoltà riportate, il terapista ha la possibilità di modificare e/o ampliare il trattamento affinché questo sia il più funzionale possibile. 2. Afasia. Le afasie (o sindromi afasiche) sono disturbi delle funzioni linguistiche che compaiono in seguito a lesioni di strutture cerebrali che svolgono un ruolo critico nelle funzioni linguistiche e devono insorgere dopo la nascita (acquisite), in un periodo successivo allo sviluppo delle capacità linguistiche che si realizza durante l’età evolutiva. Le aree della corteccia cerebrale che sono tradizionalmente da tempo considerate più critiche nei processi cognitivi coinvolti nella produzione e comprensione del linguaggio si trovano sulla superficie laterale dell’emisfero dominante attorno alla scissura di Silvio, la quale separa il lobo temporale dal lobo frontale e da quello parietale. Queste aree, infatti, sono denominate aree peri-silviane; quindi queste aeree includono aree corticali del lobo frontale, temporale e parietale. Studi più recenti hanno dimostrato che è possibile osservare deficit di funzioni linguistiche anche in pazienti con lesioni: - di aree della corteccia cerebrale a livello dei lobi frontale, temprale e parietale situate anche a distanza dalla scissura di Silvio; - di strutture cerebrali sottocorticali (talamo e gangli della base). Le cause di lesione cerebrale in pazienti con afasia possono essere varie: lesioni ischemiche, lesioni emorragiche, lesioni neoplastiche (benigne o maligne), traumi cranioencefalici, lesioni infiammatorie (encefaliti, encefaliti erpetiche) e lesioni degenerative (afasia primaria progressiva). 5 di 28 2.1 Sindromi afasiche classiche. • Afasia di Broca. La sede della lesione è a livello del piede della terza circonvoluzione frontale dell’emisfero di sinistra (area 44 di Brodmann) con possibile coinvolgimento della sostanza bianca, dell’insula e dei nuclei della base. La comprensione è relativamente buona mentre in produzione ci sarà difficoltà non solo dal punto di vista articolatorio ma anche a livello grammaticale. L’eloquio spontaneo è ridotto, lento e faticoso, non fluente, non prosodico. Gli errori tipici che vengono commessi riguardano agrammatismo, sostantivi al singolare, verbi all’infinito, omissione di articoli, aggettivi e verbi. Le serie automatiche solitamente vengono mantenute. La lettura può essere compromessa, l’anosognosia è assente e la scrittura si riduce a firma e copia. I sintomi associati: aprassia bucco-facciale, aprassia ideomotoria, disturbo motorio (emtparesi, emiplegia destra). • Afasia di Wernicke. La lesione è a carico delle porzioni posteriori dei giri temporali superiore e medio dell’emisfero di sinistra (area 22 di Brodmann). La comprensione sia uditiva che visiva è compromessa sia a livello di singole parole, di frasi e anche contestuale. La produzione è caratterizzata da un eloquio spontaneo estremamente fluente ricco di numerose parafrasie. Le parafrasie possono essere fonemiche e semantiche e ci possono essere neologismi o linguaggio gergale. Il linguaggio è scarsamente comprensibile, la prosodia solitamente è conservata. Lettura e scrittura sono compromesse, è presente anosognosia e possono essere associati sintomi quali deficit di campo visivo (emianopsia o quadrantopsia destra). Sono rari deficit motori. Le parafrasie possono essere di tre tipi: - verbali: sostituzione di una parola con un’altra ad essa non correlata semanticamente o fonologicamente (“orologio” per “penna”); - fonemiche: i fonemi vengono sostituiti da altri ma la sostituzione non è sistematica (“talovo” per “tavolo”); - semantiche: una parola viene sostituita da un’altra semanticamente legata ad essa (“penna” per “matita”). Il gergo anche può essere di diverse tipologie in relazione alle caratteristiche di produzione del paziente: - verbale: detto anche “insalata di parole”, in cui le parole si susseguono l’una dietro l’altra; - neologistico: sequenza di fonemi che prendono la forma di non-parole; 6 di 28 - fonemico: suoni singoli o ripetuti come singoli fonemi o sillabe; - misto: in cui si alternano le diverse tipologie di gergo sopra elencate. • Afasia globale. È la più grave tra le sindromi afasiche dovuta a lesioni cerebrali estese che coinvolgono le aree corticali peri-silviane dell’emisfero dominante per il linguaggio. Sia la comprensione che la produzione sono compromesse. L’eloquio spontaneo è assente o ridotto a frammenti sillabici, stereotipie, neologismi, parole singole, qualche breve espressione verbale prodotta automaticamente, invocazioni, imprecazioni. Lettura e scrittura sono compromesse e i sintomi associati possono essere emiplegia o grave emiparesi destra, aprassia bucco-facciale, riduzione o assenza di sensibilità somatica in emisoma destro, deficit del campo visivo destro. • Afasia di conduzione. La lesione è localizzata a livello delle aree corticali situate presso la porzione posteriore della scissura di Silvio dell’emisfero dominante, solitamente parietali e spesso si tratta di una lesione del giro sopramarginale. La comprensione è solitamente preservata mentre in produzione il paziente presenza gravi difficoltà di ripetizione imputabili soprattutto a disturbi fonologici nella produzione orale. Il linguaggio spontaneo è caratterizzato soprattutto da anomie, latenze anomiche, parafrasie fonemiche (di cui spesso il paziente è consapevole). I pazienti cercano di correggere tali parafrasie mettendo in atto dei tentativi di autocorrezione definiti conduites d’approche. In lettura ci possono essere difficoltà (soprattutto se ad alta voce), la scrittura solitamente è adeguata, anosognosia assente. I sintomi associati possono riguardare aprassia bocco-facciale, aprassia ideo-motoria, deficit motori e disturbi del campo visivo. CIRCONVOLUZIONE SOPRAMARGINALE Si ipotizza che in questa arena siano localizzati anche i sistemi neurali che costituiscono il substrato del magazzino fonologico a breve termine. Questo si troverebbe in accordo con l’ipotesi secondo cui alcuni pazienti con afasia di conduzione presentino anche dei deficit di memoria a breve termine e spiegherebbe le gravi difficoltà di ripetizione di stimoli fonologici presentati per via uditiva (cifre, parole, non parole). • Afasia nominum. La lesione è localizzata a livello della porzione laterale del lobo temporale e in alcuni casi del lobo parietale. La comprensione solitamente è adeguata ma alcuni pazienti possono presentare difficoltà in test di comprensione uditiva e visiva di nomi. La produzione è caratterizzata dalla difficoltà di reperimento lessicale e ciò emerge nel linguaggio spontaneo e può essere ulteriormente evidenziata se si chiede al paziente di denominare degli stimoli. A tale difficoltà, il paziente può rispondere attraverso un inceppo anomico o una pausa anomica (interruzione o pausa del discorso) con l’uso di circomlocuzioni (giri di parole) oppure con l’utilizzo di parole passe-partout. Lettura e scrittura sono preservate, anosognosia assente. • Afasia transcorticale motoria. La lesione è solitamente a livello del lobo frontale dell’emisfero dominante per il linguaggio in aree corticali limitrofe all’area di Broca. La comprensione è relativamente preservata mentre la produzione presenta riduzione 7 di 28 del linguaggio spontaneo sia orale che scritto. L’eloquio non è fluente, le frasi sono brevi e caratterizzate da complessità sintattica ridotta, in assenza di agrammatismo. Molti pazienti presentano difficoltà di denominazione orale e scritta e la ripetizione è relativamente preservata. La lettura è preservata mentre la scrittura è compromessa, assente anosognosia e i sintomi associati possono essere emiparesi destra, aprassia ideativa. • Afasia transcorticale sensoriale. La lesione è a carico delle aree corticali parietali posteriori o temporali posteriori dell’emisfero dominante per il linguaggio, cioè a livello delle aree che interessano la giunzione temporo-parieto-occipitale (aree 37-39 di Brodmann). La comprensione è deficitaria e in produzione il linguaggio spontaneo è fluente ma poco comprensibile. L’eloquio è ricco di parafrasie verbali e di parole passepartout, sono presenti difficoltà di denominazione orale e scritta e la ripetizione solitamente è preservata. Il paziente, infatti, è in grado di ripetere anche frasi complesse che solitamente non comprende. Anche lettura e scrittura sono compromesse, è presente anosognosia e i sintomi associati possono riguardare deficit del campo visivo, aprassia ideativa e ideomotoria. La classificazione delle sindromi afasiche ha svolto un importante ruolo nella storia della neuropsicologia ma ne ha anche messo in risalto i limiti. Numerosi pazienti affetti da afasia non rientrano in nessuna delle sindromi afasiche tradizionali e ciò suggerisce che la classificazione non è in grado di tenere conto di tutti i possibili quadri di afasia osservabili nella pratica clinica. Nonostante molti pazienti venissero inquadrati nella medesima sindrome afasica tradizionale, questi erano comunque eterogenei tra di loro (stessa manifestazione ma differente causa oppure stessa sindrome afasica ma danni a carico di processi linguistici diversi). 3. Sistema semantico-lessicale. La neuropsicologia cognitiva ha fornito un importante contributo al progresso delle conoscenze sulle modalità di funzionamento dei meccanismi linguistici. In particolar modo, una serie di studi su singoli pazienti afasici ha portato all’elaborazione di un nuovo modello cognitiva e cioè il sistema semantico-lessicale (Caramazza, 1988). Si tratta del sistema preposto all’elaborazione di parole singole; esso presenta un’architettura funzionale articolata e complessa essendo costituito da una serie di componenti tra loro interconnesse ma funzionalmente indipendenti. Il modello proposto da Caramazza ipotizza l’esistenza di quattro lessici indipendenti tra loro, ciascuno dei quali è collegato al sistema semantico, dei meccanismi sublessicali di 8 di 28 conversione fonema-grafema e grafema-fonema e una struttura deputata alla rappresentazione visiva. 3.1 Sistema semantico. Nel sistema semantico sono immagazzinate le informazioni relative a: - concetti: ogni concetto è costituito da un insieme di informazioni semantiche che definiscono il concetto in questione. Per esempio, il concetto “gatto” corrisponderà ad una serie di informazioni quali animale, quattro zampe, pelo, ecc; - significato delle parole: sono infatti immagazzinate informazioni che ci permettono di comprendere che la parola “gatto” ha un determinato significato e determinate caratteristiche (ci permette di unire lessema e concetto in esso incluso). Quando un paziente presenta un danno selettivo del sistema semantico saranno presenti errori trasversali in tutte le prove. Le difficoltà saranno presenti in tutti i seguenti test: denominazione orale, denominazione scritta, comprensione uditiva e visiva di singole parole, test che valutazione le competenze semantiche. Nel caso in cui il paziente presentasse un danno non selettivo, avendo integri i lessici fonologico e ortografico di input, non presenterà difficoltà in: - test di decisione lessicale uditiva: riconoscere come appartenenti alla lingua italiana parole presentate per via uditiva; - test di decisione lessicale visiva: riconoscere come appartenenti alla lingua italiana parole presentate per via visiva. 3.2 Lessico fonologico di input. Nel lessico fonologico di input sono contenute le informazioni necessarie per riconoscere una parola udita. Entra in gioco nelle prove di decisione lessicale uditiva, le quali ci permettono di affermare se una parola è a noi familiare o meno. Quando un paziente presenta un danno selettivo del lessico fonologico di input, questo si manifesta con difficoltà nel riconoscimento di parole presentate per via uditiva. Ci saranno quindi difficoltà in prove di decisione lessicale uditiva (discriminazione tra parole e non parole) e prove di comprensione uditiva di singole parole. I pazienti con questo tipo di danno però non presenteranno difficoltà in prove di denominazione orale e scritta, decisione lessicale visiva, comprensione visiva di singole parole e prove che valutano le conoscenze semantiche. 3.3 Lessico ortografico di input. Nel lessico ortografico di input sono contenute le informazioni necessarie per riconoscere una parola scritta. Quando un paziente presenta un danno selettivo del lessico ortografico di input, questo si manifesta con difficoltà nel riconoscimento di parole presentate per via visiva. Ci saranno quindi difficoltà in prove di decisione lessicale visiva (discriminazione tra parole e non parole) e prove di comprensione visiva di singole parole. I pazienti con questo tipo di danno però non presenteranno difficoltà in prove di denominazione orale e scritta, prove di decisione lessicale uditiva, comprensione uditiva di singole parole e prove che valutano le conoscenze semantiche. 9 di 28 3.4 Lessico fonologico di output. Nel lessico fonologico di output sono immagazzinate le informazioni sui processi necessari per la produzione delle parole. Quando un paziente presenta un danno selettivo del lessico fonologico di output, questo si manifesta con difficoltà nella produzione orale di singole parole ed è osservabile in test di denominazione orale e di lettura di parole irregolari. I pazienti con questo tipo di danno però non presenteranno difficoltà in prove di denominazione scritta o scrittura sotto dettato, prove di decisione lessicale uditiva e visiva, comprensione uditiva e visiva e prove che valutano le conoscenze semantiche. Gli errori che maggiormente si riscontrano sono: omissioni, produzione di circonlocuzioni, produzione di parole passe-partout e parafrasie semantiche (“cane” al posto di “gatto”). Cosa succede in un paziente che presenta questo tipo di danno: quando si presenta uno stimolo visivo da denominare, nel paziente si attiva la corretta rappresentazione semantica ma tuttavia questa rappresentazione corretta non riesce ad attivare, all’interno del lessico fonologico di output, la rappresentazione fonologica corrispondente e attiva una strategia fonologica corrispondente ad un concetto simile. Questa ipotesi sembra spiegare i motivi per i quali i pazienti con un danno selettivo del lessico fonologico di output possono commettere errori semantici in test di denominazione orale. 3.5 Lessico ortografico di output. Nel lessico fonologico di output sono immagazzinate le informazioni sui processi necessari per la produzione scritta delle parole. Quando un paziente presenta un danno selettivo del lessico ortografico di output, questo si manifesta con difficoltà nella produzione scritta di singole parole ed è osservabile in test di denominazione scritta e scrittura sono dettato di parole irregolari. I pazienti con questo tipo di danno però non presentano difficoltà in prove di denominazione orale e di lettura, prove decisione lessicale uditiva e visiva, comprensione uditiva e visiva di singole parole e prove che valutano le conoscenze semantiche. 3.6 Riconoscimento di oggetti presentati visivamente. I pazienti con afasia non presentano difficoltà nell’analizzare e riconoscere visivamente un oggetto o una figura. Infatti, se gli viene mostrato un oggetto sono in grado di riconoscere tale oggetto e di dimostrare che ne comprende il significato e ne conosce l’uso. Tutto ciò a meno che non sia presente: - un disturbo della percezione visiva; - un’agnosia; - un danno del sistema semantico. I pazienti afasici con danno selettivo del sistema semantico possono invece avere difficoltà nell’identificare concettualmente un oggetto, non potendo accedere alle informazioni che lo caratterizzano. Allo stesso modo, possono avere difficoltà a comprenderne le modalità d’uso o possono identificare erroneamente l’oggetto. I pazienti che presentano agnosia, cioè la incapacità di riconoscere oggetti familiari, possono presentare difficoltà nel riconoscere gli oggetti. 10 di 28 I processi di percezione visiva si compongono di due fasi: - fasi precoci: in cui le caratteristiche di uno stimolo visivi come la forma, il colore, la dimensione sono analizzate in modo grossolano e separatamente, senza integrazione; - fasi tardive/appercettive: in cui le caratteristiche dell’oggetto vengono integrate tra di loro consentendo una percezione globale. Quindi, ciò che avviene è: stimolo visivo - fasi precoci - fasi tardive - sistema semantico. 3.6.1 Tipi di agnosie. Le agnosie possono essere di tre tipi e cioè appercettive, associative e miste. • Agnosie appercettive. Sono disturbi del riconoscimento visivo dovuti ad un’alterazione delle fasi tardive/appercettive. Quindi, considerando lo schema precedente: stimolo visivo - fasi precoci - fasi tardive - sistema semantico. I pazienti presenteranno difficoltà nel descrivere le caratteristiche visive di un oggetto, nel giudicare se un oggetto è uguale o diverso rispetto ad un altro e difficoltà nel copiare un disegno. Tali pazienti non avranno difficoltà a descrivere lo stesso oggetto nel caso in cui la richiesta fosse di natura verbale. • Agnosie associative. Le agnosie visive associative sono disturbi del riconoscimento visivo caratterizzate da una normale elaborazione percettiva visiva e un’alterata capacità di associare la rappresentazione visiva dello stimolo alle conoscenze concettuali che sono necessarie all’identificazione dello stimolo. Tali informazioni sono custodite nel sistema semantico. I pazienti possono descrivere lo stimolo, possono disegnarlo ma non sanno dire cos’è e a che cosa serve. Non avranno difficoltà a rispondere a qualsiasi richiesta di natura verbale. Quindi, considerando lo schema iniziale: stimolo visivo - fasi precoci - fasi tardive - sistema semantico. 3.7 Lettura e meccanismi semantico-lessicali. Nella lettura ad alta voce, oltre ai meccanismi semantico-lessicali, possono entrare in gioco anche i meccanismi sub-lessicali di conversione grafema-fonema. Questo accade nel momento in cui la parola che stiamo leggendo non ci è nota o è una non-parola. In un primo momento, interverrà nel processo di lettura il lessico ortografico di input ma qui troviamo informazioni relative a parole che per il soggetto sono familiari e quindi la parola non riuscirà ad attivare nessuna informazione. Successivamente si attiveranno alternativamente i meccanismi sub-lessicali di conversione grafema-fonema. In condizioni normali, nella lettura ad alta voce, si attivano entrambi i meccanismi. Tuttavia, i meccanismi semantico-lessicali sono più rapidi ed efficaci dei meccanismi sublessicali nel produrre una risposta. A seguito di una lesione cerebrale, si avranno dei disturbi di lettura a seconda che il danno sia: - a carico del meccanismi semantico-lessicali; - a carico dei meccanismi sub-lessicali di conversione grafema-fonema; - un danno di entrambi i meccanismi. Gli stimoli che ci troviamo di volta in volta a leggere possono essere di tre tipi: 1. parole regolari: leggibili attraverso i meccanismi semantico-lessicali e i processi sublessicali di conversione grafema-fonema (casa, panino); 11 di 28 2. parole irregolari: leggibili solo attraverso i meccanismi semantico-lessicali (sabato, zingaro); 3. non parole: leggibili solo attraverso i processi sublessicali di conversione grafemafonema (cirbusa, sirbolone). In pazienti con danno selettivo dei meccanismi sub-lessicali di conversione grafemafonema troveremo difficoltà nella lettura di non parole e una buona prestazione nella lettura di parole regolari e/o irregolari. In pazienti con danno selettivo dei meccanismi semantico-lessicali troveremo una buona prestazione nella lettura di non parole e di parole regolari ma difficoltà nella lettura di parole irregolari. In pazienti con entrambi i meccanismi danneggiati, si osserverà una difficoltà nella lettura di parole, non parole e parole irregolari. 3.8 Scrittura sotto dettato. Nella scrittura sotto dettato di una parola, lo stimolo uditivo attiva le informazioni sulla fonologia della parola stessa presenti nel lessico fonologico di input. Tali informazioni attivano a loro volta le informazioni semantiche legate alla parola in questione e che sono immagazzinate nel sistema semantico. A loro volta, le informazioni concettuali attiveranno la rappresentazione ortografica contenuta nel lessico ortografico di output. In seguito ad una rappresentazione ortografica della parola, questa verrà tradotta nei movimenti necessari alla mano per scrivere in successione ciascuna delle lettere che compongono la parola stessa. Nella scrittura sotto dettato, oltre ai meccanismi semantico-lessicali, si possono utilizzare anche i meccanismi sub-lessicali di conversione fonema-grafema. Quando ad essere presentata per via uditiva è una non parola, questa non attiva le informazioni contenute nel lessico fonologico di input ma vengono attivati alternativamente i meccanismi sub-lessicali di conversione fonema-grafema. In condizioni normali, nella scrittura sotto dettato si attivano entrambi i meccanismi ma quelli semantico-lessicali sono più rapidi ed efficaci dei sub-lessicali nel produrre una risposta. A seguito di una lesione cerebrale, si avranno disturbi di scrittura a seconda che il danno sia: - a carico dei meccanismi semantico-lessicali; - a carico dei meccanismi sub-lessicali di conversione fonema-grafema; - un danno di entrambi i meccanismi. Le parole si possono suddividere in tre categorie: 1. parole regolari: con corrispondenza fonema-grafema; 2. parole irregolari: la cui ortografia viene appresa e le cui regole vengono immagazzinate nel lessico ortografico di output; 3. non parole: le quali possono essere trascritte solo attraverso i processi di conversione fonema-grafema. In pazienti con danno selettivo dei meccanismi sub-lessicali di conversione fonemagrafema si osserverà una difficoltà nella scrittura sotto dettato di non parole e buone prestazioni nella scrittura sotto dettato di parole regolari e irregolari. 12 di 28 In pazienti con danno selettivo dei meccanismi semantico-lessicali troveremo buone prestazioni nella scrittura sotto dettato di non parole e parole regolari e difficoltà nella scrittura di parole irregolari. Infine, in pazienti con entrambi i meccanismi danneggiati si osserverà difficoltà nella scrittura sotto dettato di parole regolari e irregolari e non parole. 4. Organizzazione sistema semantico-lessicale. Il buon funzionamento del sistema semantico è indispensabile per la comprensione e la produzione di parole (sia scritte che orali). Il significato di una parola è organizzato nel sistema semantico in “tratti semantici”; quest’ultimi possono essere relativi alle caratteristiche percettive, sensoriali e funzionali dello stimolo in questione. I tratti percettivi sono generalmente forma, colore, dimensioni, consistenza interna o esterna mentre i tratti funzionali fanno invece riferimento al contesto (dove, quando e come si usa) e alle modalità di utilizzo. Gli stimoli sono organizzati in categorie semantiche e attualmente sono state evidenziate quattro categorie principali (umani, animali, frutta e vegetali, oggetti). Queste categorie, a seguito di una lesione, possono anche essere danneggiate in maniera selettiva e un’analisi qualitativa degli errori prodotti dal paziente può indicarci esattamente quale tra queste risulta essere deficitaria e quindi permetterci di lavorare su essa. Un’altra modalità di categorizzazione presente nel sistema tematico è quella che prevede la distinzione tra astratto e concreto. Ciò è teorizzato attraverso l’osservazione degli errori prodotti tra numerosi pazienti afasici i quali presentavano errori selettivi per le parole rappresentanti oggetti concreti o errori selettivi per le parole rappresentanti oggetti astratti. Un altro aspetto rilevante nell’organizzazione riguarda il ruolo svolto dalla struttura morfologica della parola. Sappiamo che le parole sono costituite da una radice (invariabile) e un affisso (prefisso o suffisso, variabile); queste componenti possono essere selettivamente danneggiate. Ulteriore aspetto da tenere in considerazione è quello che viene definito effetto frequenza; alcune parole ricorrono nella vita quotidiana con una frequenza altissima. Questo tipo di parole sembrano essere più resistenti in caso di afasia, a differenza delle parole a bassa frequenza d’uso, le quali sembrerebbero essere più soggette a deterioramento. 4.1 Organizzazione dei lessici. Ogni lessico comprende al suo interno un’ulteriore classificazione che distingue le parole nelle quattro categorie grammaticali e cioè nomi, verbi, aggettivi e funtori. Anche queste categorie possono essere selettivamente danneggiate e inoltre, essendo i lessici legati alla modalità di presentazione dello stimolo, potremmo avere difficoltà nella comprensione uditiva di verbi ma non nella comprensione visiva di verbi, per esempio. Come per il sistema lessicale, anche nei lessici, la radice e l’affisso sono distinti l’uno dall’altro e dunque possono essere danneggiati selettivamente. 13 di 28 4.2 Errori. L’interpretazione della tipologia di errore è fondamentale per l’elaborazione di un piano riabilitativo efficace. In questo senso, la valutazione qualitativa risulta essere imprenscindibile per comprendere la tipologia di afasia che si ha davanti. A tal fine è necessario conoscere, comprendere e interpretare ogni tipologia di errore. Gli errori che possiamo incontrare sono: - anomie: alla richiesta di denominazione, il paziente non produce nulla; - pause anomiche; - sostituzione di verbi: “correre” al posto di “saltare”; - parafrasie semantiche: “cane” al posto di “gatto”; - parafrasie fonemiche: “gane” al posto di “cane”; - circonlocuzioni: il paziente mette in atto dei giri di parole; - neologismi: il paziente utilizza una parola inventata come se fosse legata ad un concetto; - conduit d’approches: il paziente effettua una serie di tentativi che lo possono avvicinare o meno alla parola target; - errori di accordo: il paziente commette errori nell’accordo tra singolare e plurale. Per esempio, “cani” al posto “cane”; - omissioni di verbi, funtori o parole; - sostituzione di funtori: il paziente mantiene il funtore ma lo sostituisce con uno non adeguato al contesto. Per esempio, “con” al posto di “da”; - errore ortografico: possono essere diversi tipi di errori quali sostituzione (tatolo), delezione (taolo), inserzione (tanvolo), trasposizione (talovo) o ancora sostituzione che dà luogo ad una nuova parola (cavolo); - errore di accento: il paziente legge “sabàto” anziché “sabato”; - conversione: tipo di errore che si commette nella scrittura. Il paziente scrive “quore” anziché “cuore”; - lessicalizzazione: tipo di errore che si commette solo con le non parola e che consiste nel trasformare la non parola in una parola. Per esempio, “ride” anziché “rife”; - nominalizzazione: errore che consiste nel trasformare un verbo in sostantivo. Per esempio, “corsa” al posto di “correre”; - verbalizzazione: errore che consiste nel trasformare un sostantivo in un verbo semanticamente correlato. Per esempio, “mangiare” al posto di “piatto”; - frammento: il paziente produce/scrive solo la parola target in maniera incompleta, per esempio “tavo” al posto di “tavolo”; - sostituzione/inserzione; - errore visivo: sono errori riconducibili all’agnosia visiva. Per quanto riguarda le prove di numeri e calcolo, gli errori possono essere: - lessicale: il paziente scrive un altro numero rispetto a quello target; - sintattico: le cifre di un numero vengono invertite; - lessicale + sintattico; - segni aritmetici; - procedura. 14 di 28 5. Valutazione del paziente afasico. In fase di valutazione si prendono in considerazione diversi punti: - età: plasticità cerebrale, recupero obiettivi; - scolarità: risorse cognitive a disposizione; - professione; - distanza temporale dall’evento lesivo: il maggior potenziale di recupero si manifesta nel periodo successivo alla lesione e maggiore è la distanza dall’evento e minore è il potenziale di recupero; - eziologia: le cause possono essere varie tra cui lesioni ischemiche, emorragiche, neoplastiche, traumi cranici, lesioni infiammatorie, lesioni degenerative. Il tipo di lesione comporta un danno più o meno grave mentre alcun lesioni non permettono di ottenere un quadro stabile del paziente, come nel caso di lesioni degenerative in cui avremo un’oscillazione delle prestazioni. L’evento patologico poi si può manifestare nell’area della lesione, in aree distanti dalla zona della lesione ma ad essa collegate, lesione dei neuroni di diversa gravità, edema cerebrale e/o liberazione di sostanze neurotossiche; - deficit associati: possono essere motori, sensitivi e/o visivi. Un deficit motorio importante non ci permette di utilizzare la scrittura nella riabilitazione, un deficit visivo non ci permette di utilizzare la denominazione orale di immagini, ecc; - collaborazione: può essere definita adeguata, parziale o non adeguata. Senza un’adeguata collaborazione non possiamo valutare o trattare il paziente in alcun modo; - atteggiamento: può essere ansioso, depresso o anosognosico. Si dovrà modificare il proprio approccio in base alle esigenze e alla tipologia del paziente che si ha davanti; - orientamento spazio-temporale: nella valutazione dell’orientamento si può essere estremamente precisi per poi passare ad un minore grado di specificità se si osservano difficoltà di risposta. Il disorientamento è spesso presente subito dopo l’evento acuto e va monitorato costantemente e ogni volta che ci si presenta al paziente in acuto; - fenomeni perseverativi e non; - produzione orale spontanea: si valuta il volume di emissione, l’articolazione, la coordinazione pneumo-fono-respiratoria. L’esame del linguaggio spontaneo ci dà molte informazioni sulle capacità linguistiche del paziente. Gli si può chiedere di raccontare una giornata-tipo, come si è manifestata la malattia, come è composta la sua famiglia o di parlare della propria attività lavorativa. Si può così osservare l’eventuale presenza di disturbi dell’articolazione o della fonazione, la lunghezza delle frasi prodotte, la quantità di informazioni trasmesse, la fluenza. Inoltre, si può segnalare la presenza di inceppi, pause, circomlocuzioni, parafrasie, neologismi, ecc. Altro aspetto da tenere in considerazione è la struttura grammaticale delle proposizioni, se sono corrette, se ci sono errori grammaticali, errori morfologici; - indicazione: gli si chiede di indicare parti del corpo, oggetti, figure e ciò ci dà informazioni su comprensione, attenzione, memoria verbale, capacità visive; - denominazione orale: bisogna partire sempre da stimoli semplici per poi passare a richieste più complesse. Si può prendere come caratteristica di riferimento la frequenza d’uso di una parola. Una richiesta di denominazione orale ci dà informazioni sul sistema semantico, sul lessico fonologico di output, articolazione, capacità visive, ecc; - ripetizione di parole e non parole; 15 di 28 - comprensione di parole uditiva e visiva; comprensione di frasi uditiva e visiva; scrittura di parole e non parole; lettura di lettere singole, sillabe, parole, non parole e frasi; prassie bucco-facciali e ideomotorie; area del numero e del calcolo: si valuta il riconoscimento, la produzione orale e scritta, i fatti aritmetici, le operazioni. 5.1 Valutazione in fase acuta o sub-acuta. In questa primissima fase andremo a valutare diversi aspetti. • Consapevolezza del deficit e l’orientamento spazio-temporale. Chiederemo al paziente se sa dove si trova, in quale giorno/mese/anno ci troviamo, perché è qui con noi, ecc. • Comprensione. Si valuta sia quella contestuale (quindi limitata alle cose che si trovano nell’ambiente che di parole singole/frasi semplici. Per esempio, possiamo chiedere al paziente di indicarci alcune parti del corpo e ciò richiede il riconoscimento di un comando verbale semplice e dello schema corporeo. Laddove il paziente non dovesse riuscire, subentriamo in supporto con un comando verbale o richiedendogli di imitarci (tocca i capelli, il naso, la bocca, l’orecchio destro). • Prassie. Valutiamo le prassie chiedendo al paziente di aprire la bocca, tirare fuori la lingua, fare un sorriso, mandare un bacio, chiudere gli occhi, gonfiare le guance, soffiare. • Produzione. Andiamo a valutare la produzione di fonemi, parole, frasi, eventuali frammenti. Anche in questo caso è fondamentale procedere per gradi iniziando ad osservare dapprima l’articolazione e la coordinazione pneumo-fono-articolatoria. In alcuni casi, si può ricorrere alla ripetizione di parole, piccole frasi e/o serie automatiche. Una delle attività che può essere utilizzata è la denominazione di oggetti/immagini o chiedere al paziente di contare da 0 a 10. • Prove di riconoscimento visivo. Si propongono al paziente domande che prendono risposte si/no. Questa tipologia di prova include la comprensione (riconoscimento di input uditivo), la memoria verbale, l’attenzione e le capacità visive coinvolte nel confronto con l’immagine (input visivo). Quindi, per esempio con una penna in mano chiederemo al paziente “Questa è una penna?”. 5.2 Valutazione tramite test. I test che maggiormente vengono utilizzati sono: - ENPA; - BADA; - BDM. 5.2.1 Esame Neuropsicologico per l’Afasia (ENPA). L’ENPA comprende una serie di test che valutano la presenza, la gravità e le principali caratteristiche dell’afasia nel soggetto esaminato. Si tratta di un test che per semplicità e brevità può essere somministrato anche a soggetti gravi e/o con un livello di scolarità non elevato. 16 di 28 Per la somministrazione non c’è un ordine prefissato ad eccezione delle prove di fluenza che richiedono la generazione di liste di parole; queste vanno somministrate in momenti diversi e non una di seguito all’altra (c’è il rischio che il paziente vada in confusione con le diverse categorie indagate). Nei soggetti con specifiche difficoltà, è possibile stabilire arbitrariamente l’ordine delle prove con il fine di evitare una frustrazione eccessiva e alternando prive più facili (per il paziente) a prove più difficili. Sarebbe preferibile terminare la somministrazione della batteria in una sola volta ma non sempre questo è realizzabile; l’importante è che non si lascino prove a metà. Infatti, le prove andrebbero somministrate integralmente ma qualora le difficoltà del soggetto fossero troppo elevate si può anche decidere di interrompere la prova dopo cinque errori. Prima di somministrare le prove, poi, è necessario assicurarsi che il paziente abbia compreso la consegna facendo anche degli esempi. Al di là della valutazione quantitativa, è bene sempre effettuare una valutazione qualitativa della performance annotando il comportamento verbale ma anche quello non verbale. Gli stimoli proposti possono essere ripetuti una sola volta segnalandolo sempre sul protocollo con la sigla RIP. Per quanto riguarda la correzione, avremo: - fattori di correzione (FC): intersezione sulla griglia di scolarità ed età; - punteggio grezzo (PG): dato dalla somma delle risposte ottenute nella prova; - punteggio corretto (PC): si ottiene PG ±FC; In seguito, il PC va confrontato con il cut-off di ogni prova. 5.2.2 Batteria per l’Analisi dei Deficit Afasici (BADA). È un test di livello e non è adeguato a pazienti con afasia grave o con bassa scolarità. La batteria può essere suddivisa in quattro macro-aree: - prove di fonologia e ortografia sub-lessicale; - prove semantico-lessicali; - prove grammaticali; - prove di memoria verbale. All’interno, poi, troveremo diverse prove tra cui: - discriminazione fonemica: sono presenti 60 coppie di stimoli di tipo CV, metà uguali, metà diversi. Alcune differiscono per sonorità (sordo/sonoro), altre per punti di articolazione e altre per entrambi i parametri. Il paziente deve ascoltare le due sillabe che l’esaminatore pronuncia (in alcuni casi a bocca schermata) e il paziente deve rispondere si/no alla richiesta se gli stimoli sono uguali o meno. In questo caso, andremo a valutare il tipo di errore per indagare se il paziente presenta difficoltà con tratti specifici; - accoppiamento uditivo-visivo: il paziente ha davanti una sillaba scritta e gli viene chiesto se quella prodotta verbalmente dall’esaminatore è uguale o diversa; Altre prove che fanno parte della BADA sono: ripetizione di non parole (conversione fonema-fonema), lettura di non parole (conversione grafema-fonema), scrittura sotto dettato di non parole (conversione fonema-grafema), copia ritardata di non parole, 17 di 28 decisione lessicale uditiva e visiva, ripetizione di parole, lettura di parole, scrittura di parole sotto dettato, copia ritardata di parole, comprensione uditiva di nomi e di verbi, comprensione visiva di nomi e verbi, denominazione orale e scritta di nomi e verbi, denominazione di nomi descritti dall’esaminatore, giudizi di grammaticalità (udita e visiva), ripetizione e lettura di frasi, comprensione di frasi (uditiva e visiva), produzione orale e scritta di frasi, descrizione di immagini in sequenza, produzione controllata di frasi, riconoscimento di parole e non parole (4-6-8 stimoli), ripetizione e parole (2-3-4-6 stimoli) e di non parole (2-3-4 stimoli). 5.2.3.Batteria semantica. Vengono effettuate diverse tipologie di prove: - decisione di realtà 1: il paziente vede un oggetto rappresentato in una figura e deve dire se quell’oggetto esiste o meno; - decisione di realtà 2: il paziente deve scegliere quale stimolo corrisponde ad un oggetto reale tra quattro alternative che sono organizzate all’interno della stessa categoria semantica; - questionario semantico (Capitani): vengono poste al paziente sei domande riguardanti le caratteristiche fisiche, funzionali, ambientali e categoria delle varie parole-stimolo presentate; - associazione con il colore: il colore costituisce un tratto semantico dal momento che alcuni oggetti hanno un loro colore caratteristico. Si mostrano al paziente delle immagini e gli si chiede di denominare l bersaglio e di abbinargli il colore corrispondente. Il colore può essere denominato, gli si può chiedere di colorare o di prendere una matita del colore scelto. Esistono poi alcuni test che si possono utilizzare per approfondire la comprensione di frasi. Tra questi troviamo il Comprendo. Batteria per la comprensione di frasi negli adulti (Cecchetto e Di Domenico, 2012). Impaziente ascolta delle frasi che vengono proposte registrate e deve scegliere tra quattro opzioni mantenendo in memoria verbale lo stimolo appena ricevuto. Le frasi del test sono di tipologia diversa e danno molte informazioni riguardo le capacità di comprensione del paziente, in particolare modo attraverso l’analisi dell’errore si possono osservare quali sono le tipologie di strutture compromesse. 6. Riabilitazione dei disturbi afasici. Uno dei primi aspetti che si tiene in considerazione sono i fattori prognostici che possono influenzare il recupero di disturbi neuropsicologici e si distinguono in: - preesistenti alla lesione: età, dominanza manuale e grado di specializzazione emisferica, QI, livello di istruzione, livello socio-professionale; - dipendenti dalle caratteristiche dell’evento morboso: eziologia, dimensioni, localizzazione, modalità d’esordio; - successivi alla lesione: motivazione e consapevolezza, grado di stimolazione dell’ambiente familiare e sociale, presenza o assenza del trattamento riabilitativo. Una volta effettuata la valutazione e considerati i fattori prognostici, si prosegue con la formulazione degli obbietti a tre, a medio e a lungo termine. 18 di 28 Bisogna distinguere: - obiettivo della rieducazione: ripristinare un uso intenzionale del linguaggio. Talvolta i pazienti presentano un meccanismo di dissociazione automatico-volontaria mentre in terapia si punta solo all’intenzionalità; - obiettivo della seduta di riabilitazione: ciò che si vuole ottenere in quell’ora di terapia e ciò si determina in base alla gravità e al tipo di disturbo afasico. È importante evitare di proporre al paziente qualcosa che sia troppo al di sopra delle sue capacità per evitare frustrazione e scoraggiamento; - obiettivo insito in ogni esercizio: il linguaggio è un sistema complesso costituito da altri sistemi complessi, in base a ciò che abbiamo valutato come deficitario dobbiamo decidere la tipologia di esercizi da proporre e in base a questo si stabilisce anche il tipo di facilitazione che il terapista può fornire. Il primo obiettivo nella riabilitazione è il linguaggio orale (comprensione e produzione); la comprensione rappresenta il punto di partenza di ogni percorso riabilitativo. Aspetti come quelli della lettura e scrittura vengono costantemente esercitate ma vengono gerarchicamente dopo rispetto alla comprensione e alla produzione orale (fatta eccezione per i disturbi selettivi). La ripetizione e la copia servono come ausilio e strumento. 6.1 Trattamento del disturbo semantico. Il trattamento del disturbo semantico può riguardare due aspetti: - i campi semantici: si lavora sui rapporti tra i vari concetti (ad esempio, sulle differenze attraverso i giudizi di comparazione); - i tratti semantici: si lavora su singoli concetti, sulla singola parola, ampliando quella rappresentazione semantica nella quale mancano degli elementi che fanno sì che il paziente non riesca ad attivare la corretta etichetta lessicale. 6.1.1 Esercizi per i campi semantici. Possono essere proposte diverse tipologie di esercizio. • Comprensione verbale (extracategoriale). Si richiede al paziente di indicare uno stimolo tra più alternative di diversa categoria. La selezione di tale stimolo dovrebbe essere relativamente semplice perché extracategoriale e cioè l’elemento richiesto è da confrontare con elementi appartenenti ad altre categorie. Possono essere usati oggetti concreti, immagini, parole scritte, parole udite. Per esempio, “Mi indichi quale tra queste immagini rappresenta la mela” e tra le alternative abbiamo animali, mezzi di trasporto, utensili, ecc. • Comprensione verbale (intracategoriale). Si richiede al paziente di indicare uno stimolo tra più alternative appartenenti alla stessa categoria semantica. Possiamo passare dalla comprensione intra- a quella extracategoriale inserendo man mano stimoli graduali. Per esempio, viene chiesto al paziente di confrontare un mezzo di trasporto con altri e qui tutti gli elementi appartengono alla stessa categoria per cui hanno più tratti in comune (tutti sono mezzi di trasporto ma alcuni hanno le ruote, altri servono per spostarsi in mare, ecc). • Classificazioni. Si chiede al paziente di classificare o categorizzare una serie di figure, parole, oggetti secondo un criterio che sarà inizialmente generale (semplice) e man mano più specifico. In questo tipo di esercizio, è il logopedista a scegliere il criterio in 19 di 28 • • • • • • • base al quale effettuare la classificazione. Per esempio, si chiede al paziente di individuare tra una serie di stimoli soltanto gli animali e poi, tra questi, di individuare i quadrupedi o solo gli uccelli, pesci, ecc. Ordinamento per criterio. Si chiede al paziente di ordinare delle figure secondo un criterio (per esempio, dal più grande al più piccolo o dal più leggero al più pesante). Ovviamente le immagini in figura hanno tutte le stesse dimensioni e sarà quindi compito del paziente attivare le informazioni relative a quel bersaglio interrogandosi su quale sia la sua dimensione reale. Scelta per criterio. Tra le diverse alternative che appartengono alla stessa categoria, si sceglie uno stimolo che corrisponde al criterio dato. Per esempio, “Tra questi qual è quello che si mangia senza buccia?” Scelta per esclusione 1. Il paziente sceglie, tra una serie di figure, lo stimolo che deve essere escluso dal raggruppamento proposto. Si può chiedere al paziente di verbalizzare il motivo dell’esclusione. Qualora il paziente non individuasse correttamente l’oggetto da escludere, si registrerà la difficoltà presentata per quel tratto semantico specifico e si lavorerà anche su di esso. Scelta per esclusione 2. Non si lavora con le immagini ma con parole scritte o pronunciate oralmente (questo nel caso in cui il paziente presenti una buona memoria verbale). Anche in questo caso, è possibile aumentare gradualmente la difficoltà nella selezione del criterio. Raggruppamenti. Si richiede al paziente di raggruppare una serie di figure sulla base delle caratteristiche che vengono selezionate di volta in volta. Per esempio, raggruppare tutti gli oggetti di metallo o tutti i frutti che hanno i semi. Giudizi comparativi. Tra gli stimoli proposti il paziente deve selezionare quello a cui appartiene una determinata caratteristica. Per esempio, “Chi è più grande?” Definizione di concetti. Si richiede al paziente di definire dei concetti o la differenza tra concetti simili. Per esempio, “Da cosa differisce una sedia da un tavolo?” e si ricercano i tratti in comune e le differenze. 6.1.2 Esercizi per i tratti semantici. Il lavoro sul tratto non richiede il confronto tra stimoli; se dalla valutazione è emerso che le difficoltà semantiche sono relative soprattutto a determinati tratti, si lavora su quelli. • Uso dell’oggetto. Si richiede al paziente di mimare l’uso dell’oggetto che può anche avere davanti fisicamente ma che non può manipolare. Gli oggetti, a differenza delle immagini, forniscono maggiori informazioni. Infatti, quando il paziente manipola un oggetto, si attiva una componente automatica mentre quando il paziente deve mimare l’uso di un oggetto che vede ma che non può manipolare, allora si attiva il modello operativo del sistema semantico-lessicale. Il gesto è un tratto semantico. • Disegno su copia e a memoria. Si richiede al paziente di copiare l’oggetto e, in una seconda fase, di disegnarlo a memoria. Questo esercizio attiva le caratteristiche fisiche dell’oggetto che si richiede di disegnare. • Completamento di disegni. Viene presentato un disegno con delle parti mancanti. • Colorazione. Questo perché il colore anche è un tratto semantico. 20 di 28 • Vero/falso. Vengono presentate delle domande relative alle caratteristiche fisiche di un determinato oggetto e il paziente dovrà rispondere si/no a seconda che quella determinata caratteristica appartenga o meno a quello specifico oggetto. 6.1.3 Caso clinico. Il paziente è un ex professore universitario che presenta una lesione fronto-temporoparietale. Tra i sintomi associati vi è un problema visivo ma le sue difficoltà non sono strettamente correlate ad esso poiché anche utilizzando il solo input uditivo talvolta non è in grado di fornire risposte adeguate. Gli viene somministrato il questionario semantico: Lo stimolo è la parola naso: È un oggetto/un vegetale/una parte del corpo? È un viscere/un organo di senso/un arto? Ne abbiamo uno/due/ più di due? È più grande di un piede? “Più piccolo””quindi è più grande di un piede”? Serve per vedere/per gustare i sapori/sentire gli odori? Si trova sulla parte superiore del tronco/nella parte inferiore del tronco/a livello del capo? Lo stimolo è la parola tromba: È un oggetto/un animale/un vegetale? È un capo di abbigliamento/uno strumento musicale/un veicolo? È di legno/di pelle/di metallo? “Potrebbe essere pure di legno. Oppure di ferro…di…metallo” Quindi è di legno, di pelle o di metallo? “Di legno” Ha un suono più forte di un flauto? “Sì” Serve per produrre rulli/squilli/rintocchi? Si suona con la bocca/con l’archetto/con le bacchette? La parola stimolo è cigno: È un vegetale/un oggetto/un animale? È un animale a quattro zampe/un insetto/un uccello? Ha la cresta/le zampe palmate/gli artigli? È più grande di una gallina? “No” Si muove sott’acqua/sull’acqua/sulla terra? “Forse sott’acqua” Vive sulle montagne/vicino al mare/vicino ai laghi? In base a questa prima valutazione, in seguito si somministra la prova del disegno in cui si chiede al paziente di rappresentare ciò che gli viene richiesto attraverso la serie di domande del questionario semantico. Nel caso specifico, la tromba viene rappresentata dal paziente come un piffero, molto simile al flauto, e che può essere effettivamente di legno. Disegnando il paziente rappresenta l’immagine mentale che possiede rispetto a quel determinato stimolo. Infatti, anche il cigno viene rappresentato con quattro zampe. Nel trattamento saranno poi utilizzati gli esercizi sia per il campo semantico che per il tratto lavorando in contemporanea sulla comprensione verbale. 21 di 28 6.2 Trattamento dei disturbi morfologici e sintattici. Ciò che si va a valutare dal punto di vista morfo-sintattico è se rimane preservato: - maschile/femminile; - singolare/plurale; - presente/passato/futuro; - persone; - distinzione tra radice e flessione. Successivamente bisogna distinguere se il disturbo si colloca a livello del sistema semantico o dei lessici in produzione/comprensione: - deficit nella rappresentazione semantica: si riscontrano errori morfologici sia in comprensione che in produzione; - deficit della rappresentazione lessicale: gli errori vengono riscontrati in produzione. Tra gli esercizi per disturbi morfologici relativi a nomi. 1. il logopedista propone uno stimolo e il paziente deve dire se è maschile/femminile o singolare/plurale. Qualora il paziente commettesse errori, si può rafforzare la correzione avvalendosi di immagini; 2. il logopedista mostra al paziente due immagini in cui in una è rappresentata una sola mela e nell’altra più mele e il paziente deve denominare prima una e poi l’altra immagine. Lo stesso esercizio può essere effettuato usando immagini che differiscono per genere; 3. esercizi per il completamento: “Luca vuole mangiare una m….” e il paziente risponderà “mela”. Anche in questo caso si può supportare con l’uso di immagini; 4. se le capacità di lettura del paziente sono adeguate, lo stimolo può essere presentato per via visiva e si possono anche prendere esercizi di accoppiamento immagine e stimolo scritto; 5. se la scrittura è preservata, lo stimolo può essere prodotto per iscritto dal paziente e poi prodotto oralmente o viceversa; 6. se ci sono difficoltà sintattiche relative all’uso di articoli e preposizioni, si possono proporre gli stessi esercizi inserendo anche i funtori tra gli stimoli da produrre/ comprendere/ripetere/leggere/scrivere; 7. possono essere proposti esercizi con nomi derivati partendo da una radice data. Si può fornire quindi al paziente la radice e chiede di fornire più nomi possibili (è difficile) oppure fornirgli la radice e poi degli indizi affinché lui ci dica dei derivati. Quindi, per esempio con la radice pan- chiederemo “il posto in cui si produce il pane” oppure “come si chiama chi produce il pane” e il paziente ci dirà panificio prima e panettiere poi. Tra gli esercizi per i disturbi morfologici relativi a verbi. 1. comprensione della forma verbale utilizzata (numero di persone, presente/passato); 2. prendere in considerazione le tre diverse coniugazioni ed esercitarsi su tutte dato che hanno flessioni diverse; 3. esercizi di completamento e quindi “Io mangio, tu ….”; 4. utilizzare ieri/oggi/domani per formulare frasi qualora il paziente avesse bisogno di un supporto per i diversi tempi. Oppure utilizzare direttamente le categorie passato/ presente/futuro. Si può partire dall’infinito del verbo o si può utilizzare la prima persona dell’indicativo presente. 22 di 28 6.3 Trattamento dei disturbi sintattici. A seconda di quello che emerge dalla valutazione, si procederà con un livello di difficoltà adeguato. • Soggetto+verbo transitivo. Si può cominciare da proposizioni di base costituite da soggetto+verbo intransitivo. Il soggetto può essere selezionato dal paziente o dal logopedista, l’importante è che sia adeguato mentre il verbo può essere selezionato dal paziente attraverso l’uso di immagini, di video o attraverso richiami semantici. • Completamento. Il terapista dice il verbo e il paziente deve completare con un soggetto o al contrario il terapista dice un soggetto e il paziente completa con un verbo. In questa prima fase della terapia, si possono tralasciare gli accordi soggetto/ verbo o funtore/sostantivo. Quindi, qualora il terapista dicesse “cane” e il paziente rispondesse con “legge”, la risposta viene accettata ma facendo notare al paziente l’inadeguatezza dal punto di vista del contenuto. TRATTAMENTO DEI DISTURBI SINTATTICI Inoltre, si può anche pensare di lavorare con verbi opposti o complementari come • Si può lavorare con verbi opposti o complementari come entrare/uscire, entrare/uscire, comprare/vendere, spiegare/imparare; inanche questo modo, il paziente vienecomprare/vendere, spiegare/imparare. Soprattutto gli ultimi due esempi dovrebbero aiutare il paziente a fornire aiutato e indirizzato a utilizzare soggetti diversi e maggiormente adeguati al nel binomio soggetti diversi e maggiormente adeguati rispetto al rispetto contenuto. Ad esempio spiegare/imparare cerco di richiamare i due sostantivi insegnante/alunno. contenuto. Ad esempio, il binomio spiegare/imparare cerca di richiamare i due sostantivi insegnante/alunno. In ogni tipo di esercizio • Ci si aiuta sempre con un supporto visivo, nel quale è possibile anche fare uso dei colori/forme. che si propone è fondamentale sfruttare un SOGGETTO VERBO supporto visivo, nel quale è possibile anche fare uso dei colori/forme. Lo step successivo consiste nell’inserire negli esercizi i verbi transitivi supportando la TRATTAMENTO DEI DISTURBI SINTATTICI produzione con domande come “che cosa?” o “chi?”. • Successivamente si possono inserire nell’esercizio i VERBI TRANSITIVI. Qualora il paziente dovesse risponderci con “Luca legge sul divano”, la frase viene • Si può supportare la produzione con domande come “che cosa?”, “chi?”. accettata perché l’obiettivo non è tanto far oggetto ma un • Siprodurre possono accettareun anchecomplemento frasi come “Luca legge sul divano” perché l’obiettivo non è quello di far produrre al soggetto un complemento oggetto ma un argomento in più oltre al soggetto. argomento in più oltre al solo soggetto. Accetteremmo anche una semplice frase come Altrettanto accettata sarebbe la frase “Luca legge divano”, anche se si può sempre supportare il “Luca legge divano” sempre fornendo paziente attraverso la riformulazione. una riformulazione. Anche qui, supporto visivo. È importante, per creare una sorta di schema mentale, mantenere sempre gli stessi colori (rosso per il soggetto, verde per il verbo per esempio). Nel momento in cui il paziente inizia a seguirci in questo tipo di esercizio, procediamo TRATTAMENTO DISTURBI con un’ulteriore espansione della proposizione con tre argomenti. Quindi,DEI “Luca leggeSINTATTICI un • Una volta raggiunta un’espansione frasale di 3 argomenti si può cominciare a lavorare libro sul divano” e anche in questo caso sfruttiamo immagini e/o video di supporto. selettivamente sulla concordanza di genere e numero tra funtori e sostantivi. Una volta raggiunta l’espansione frasale di tre argomenti, si può cominciare a lavorare • Si può prevedere un lavoro selettivo e poi inserire questo tipo di esercizio all’interno delle fra selettivamente sulla concordanza di genere e numero tra funtori e sostantivi. Si può iniziare lavorando selettivamente su funtore+sostantivo e poi inserire il tutto all’interno del contesto frasale per favorire la generalizzazione. 6.4 Trattamento dei deficit di reperimento lessicale. Si inizia sempre partendo da ciò che si è osservato in fase di valutazione per avere ben chiaro quali sono le categorie/tipologie di parole con cui il paziente ha maggiori difficoltà. 23 di 28 Se il paziente ha maggiori difficoltà nel reperimento di verbi, per esempio, si possono utilizzare i sostantivi a cui il paziente deve poi associare dei verbi adeguati. Lo stesso vale per il contrario, cioè qualora la difficoltà maggiore sia relativa ai sostantivi, si parte da un verbo e si sfrutteranno gli argomenti del verbo per la ricerca lessicale. In questo tipo di disturbo, l’uso di immagini e video è ancora più importante. Si possono selezionare delle immagini per campi semantici o per frequenza d’uso che il paziente deve poi denominare; essendoci una difficoltà di reperimento, per il paziente sarà difficile trovare l’etichetta da associare allo stimolo. Sarà compito del terapista fornire al paziente, soprattutto nelle prime fasi, una serie di indizi o clue. Esistono due tipi di clue: - semantico: si forniscono al paziente dei tratti semantici relativi al target; - fonologico: si fornisce al paziente una porzione (solitamente la prima) della parola. La scelta del tipo di indizio dipende dal paziente che ci troviamo di fronte. Oltre agli esercizi di denominazione orale, si possono accostare degli esercizi di denominazione scritta. Se le difficoltà sono molto alte e il paziente non riesce a produrre la parola, si può prevedere di associare in un secondo tempo l’etichetta dell’immagine su cui si sta lavorando e inizialmente lasciare tutta la parola per iscritta. Anche la lettura può diventare uno strumento utile: se la lettura/scrittura sono sufficientemente preservate possiamo far leggere al paziente gli indizi o fornire dei clue fonologici scritti. Infine, si possono pensare anche dei compiti di definizione o degli esercizi di scrittura di frasi. Alcuni esempi di materiale per il reperimento lessicale: - individua la parola che corrisponde alle caratteristiche elencate: si forniscono al paziente degli indizi e gli si chiede di individuare una parola che combacia con gli indizi forniti. Per esempio, “è un liquido, inodore, insapore” e il soggetto ci dirà la parola “acqua” oppure “è giallo, è grande come una mela, ha un sapore aspro” e il soggetto ci dirà la parola “limone”; - individua il verbo adatto: forniamo delle liste di parole e gli chiediamo di associare un verbo che si adatti alle parole fornite. Per esempio, “libro, giornale, rivista” e il paziente potrebbe associare i verbi “leggere, comprare, acquistare” oppure “vino, acqua, champagne” e il paziente potrebbe associare i verbi “bere, versare, comprare”; - completa ogni verbo con tre elementi adeguati: si fornisce al paziente un verbo e gli si chiede si associare degli elementi coerenti. Per esempio, “mangiare” e il paziente ci potrà dire “pane, pasta, carne” oppure “bere” e il paziente ci potrà dire “acqua, latte, vino”. 6.5 Approccio pragmatica P.A.C.E. L’approccio pragmatico uso una serie di atti verbali, non verbali ed extra-verbali. Questo tipo di comunicazione è strettamente legata al contesto comunicativo ed è una competenza interna al sistema linguistico che ci permette di comprendere frasi come “Sai l’ora?”/“Fa molto caldo qui!”. Questo tipo di frasi sottintendono un’azione di conseguenza (o meglio, una richiesta implicita) che sarà guardare l’orologio e dire l’ora oppure aprire la finestra. 24 di 28 Gli studi di Holland degli anni ’80 hanno portato alla nascita di un nuovo approccio valutativo e riabilitativo basato sulle competenze pragmatiche del paziente afasico e cioè il Promoting Aphasics’ Comunicative Effectiveness (PACE). I primi studi si basarono su delle videoregistrazioni in cui si osservava la condotta linguistica e comunicativa del paziente afasico valutando tale comportamento secondo diversi parametri: - Il paziente fa spontaneamente domande? Tenta di prendere la parola? - Il paziente si autocorregge? - Rispetta l’argomento della conversazione o lo cambia? - Utilizza l’indicazione per cose, se stesso o gli altri? - Tenta di richiamare l’attenzione? - Quali sono le caratteristiche della sua mimica facciale e gestuale? Dallo studio è emerso che la maggior parte dei pazienti afasici era adeguato in tali situazioni pur avendo, in alcuni casi, un’afasia importante erano in grado di inviare messaggi con una buona percentuale di successo. In contesto domestico, gli argomenti di conversazione erano noti, conosciuti o piacevoli e questo facilitava notevolmente la loro comunicazione. Il messaggio veniva considerato “a buon fine” se veicolava un contenuto indipendentemente dal fatto che fosse formalmente corretto. Tale messaggio poteva essere anche costituito da un gesto, un suono, un grugnito, una parola onomatopeica. Un trattamento di questo tipo si è rivelato particolarmente utile anche nei casi di afasia grave o in quei casi in cui si deve potenziare altri tipi di canali comunicativi in vista di una degenerazione (come nell’Afasia Primaria Progressiva). Le caratteristiche che si devono rispettare nel set comunicativo sono: scambio di nuove informazioni, alternanza dei ruoli, libera scelta del canale comunicativo (a voce, con suoni, con indicazione, con gesti, disegni), costruzione del contesto e uso della ridondanza comunicativa. La seduta terapeutica viene strutturata scegliendo il materiale ritagliato sul paziente e anche il terapista deve essere in grado di modulare il proprio approccio in base a chi ha di fronte. Paziente e terapista, poi, a turno si scambiano il ruolo di locutore/mittente e interlocutore/destinatario proprio come avviene durante una conversazione “reale”. Ovviamente nella seduta la conversazione è “artificiale” ma si cerca di riprodurre uno scambio che sia il più naturale possibile. Esempio di attività che viene proposta: 1. Viene posto sul tavolo un leggio e su questo vengono poste alcune immagini che vengono date in doppia copia al paziente e al terapista. Le immagini in doppia copia costituiscono l’informazione condivisa. Per esempio, quattro immagini raffiguranti quattro donne diverse; 2. Il paziente sceglie una di queste immagini senza farla vedere al terapista ma cercando di veicolare l’informazione attraverso i canali di cui dispone. Nel nostro esempio, non è sufficiente l’informazione “donna” affinché il terapista comprenda di quale donna sta parlando il paziente. Ma comunque nel momento in cui il paziente mi veicola un’informazione, bisogna subito dare un feedback positivo se si è recepito il 25 di 28 messaggio puntando molto sulla formulazione, sulla ridondanza, sull’uso di più canali comunicativi e facendo seguire un feedback aperto del tipo “sì è una donna, ma poi?” in modo che il paziente capisca che abbiamo bisogno di altre informazioni; 3. Il paziente deve quindi veicolare una nuova informazione aggiuntiva. Per esempio, se la donna scelta nell’immagine è al telefono e lui ci mima il gesto di telefonare, il messaggio viene recepito e la terapista mostra l’immagine scelta. L’obiettivo del P.A.C.E. è il messaggio, la ricezione del messaggio: anche se il gesto è solo abbozzato, se la forma del messaggio non è corretta non ci interessa. A noi interessa che ci sia uno scambio. 7. Aprassie. Le aprassie sono difficoltà di esecuzione di movimenti volti ad un’azione finalizzata. Sono definite sindromi cerebrali post-lesionali che non riguardano i meccanismi elementari del movimenti ma la loro programmazione, organizzazione, sequenzialità e armonia. Si tratta di un’alterazione che viene definita come una dissociazione automaticovolontaria, condizione per cui il paziente non riesce a svolgere correttamente la sequenza su richiesta ma riesce a farlo se il movimento è spontaneo. Per esempio, se gli chiedo di soffiare non riesce ma se gli metto davanti una candelina o un accendino e senza effettuare alcuna richiesta, il paziente soffia. Esistono vari tipi di aprassia e quelle che maggiormente ci interessano sono: - aprassia ideativa (di utilizzo di oggetti): i pazienti eseguono movimenti anche complessi ma con alterata sequenza temporale dei singoli atti motori che li compongono e con prevalente tendenza ad anticipare gli atti motori che dovrebbero essere prodotti successivamente nella sequenza. Questi pazienti possono interrompere prematuramente la sequenza condensando due movimenti in uno, effettuare errate associazioni tra l’oggetto che deve essere utilizzato e la sequenza motoria prescelta e/o perseverare nell’esecuzione di uno o più movimenti di una sequenza motoria; - aprassia ideomotoria (di imitazione): si tratta di un’incapacità, una volta rievocata la rappresentazione mentale dell’evento richiesto, di attivare la corretta sequenza motoria per attuare il movimento. Quindi, è come se il paziente sapesse cosa fare ma non “come farlo”, non riuscendo quindi ad attivare lo schema motorio corretto; - aprassia bucco-facciale: difficoltà nel compiere, programmare, imitare gli atti motori che si compiono nel distretto bucco-facciale. Quindi, riassumendo schematicamente: - afasia: inerente al linguaggio; - aprassia articolatoria: riguarda la programmazione di movimenti articolatori ed è anche definita anartria; - aprassia bucco-facciale: riguarda la programmazione di movimenti del distretto linguobucco-facciale. A volte si può accompagnare ad un’aprassia dell’articolazione; - disartria: è un deficit periferico e quindi non c’è dissociazione automatico-volontaria. 7.1 Valutazione aprassia bucco-facciale. Nella valutazione si vanno a indagare le diverse prassie ed eventuali difficoltà del paziente. 26 di 28 Si richiedono quindi al paziente una serie di prassie quali sorridere, soffiare, fischiare, fare una pernacchia, dare un bacio, apertura e chiusura della bocca, movimenti ripetuti della lingua contro i denti, schioccare la lingua contro il palato. La richiesta deve avvenire dapprima solo verbalmente però laddove mi accorgo che il paziente non riesce allora possiamo supportarlo facendo noi da modello e proponendo la richiesta su imitazione. In questa primissima fase, e poi anche nel trattamento, può essere estremamente utile fare uso di uno specchio in modo che il paziente possa avere un feedback visivo dei suoi movimenti. 7.2 Trattamento dell’aprassia bucco-facciale. Nella primissima fase di trattamento, si lavora in assenza di articolazione perché il nostro obiettivo è quello di lavorare principalmente sui muscoli. Poniamo il paziente davanti allo specchio con il terapista alle sue spalle o al suo fianco e cominciamo a lavorare sull’esecuzione volontaria di movimenti semplici delle labbra, della mandibola e della lingua. Si può prima lavorare sulla posizione, su posture e sempre senza introdurre l’articolazione. In molti casi può essere utile aiutare il paziente attraverso il contatto fisico sia del terapista che del paziente stesso. Quando il paziente non riesce, come ultima possibilità, possono sfruttare la dissociazione a mio vantaggio e quindi, per esempio, gli metto un accendino davanti e lui soffia. Inizio con l’accendino acceso, poi tolgo la fiamma e man mano tolgo il supporto. Tra immagini, parte tattile, parte visiva e imitativa abbiamo tanti canali che possiamo sfruttare ed è fondamentale sfruttarli tutti al massimo. Anche le indicazioni che diamo al paziente devono essere le più chiare possibile; per esempio, se sto lavorando sulla lingua e devo far lavorare il paziente sul fonema /l/ non gli chiederò mai di produrmi /la/. Ma si chiede al paziente di posizionare la lingua sul palato, di iniziare a provare a produrre il fonema /l/ e solo quando è in grado di gestire questo fonema ci aggiungo una vocale vicino (/la/ oppure /le/). 7.3 Trattamento della disartria. È un deficit dell’articolazione dove il danno è di natura paretica che comporta una ridotta articolazione di suoni che appaiono impastati. Non essendo un’aprassia, non è presente una dissociazione automatico-volontaria; è un deficit in cui la difficoltà non è a livello di organizzazione e programmazione ma nell’esecuzione dei movimenti. Un disturbo di questo tipo solitamente si associa ad un disturbo complessivo della motilità bucco-faringo-laringea (può esserci una rima buccale deviata, un’ipomobilità). Si lavora sull’articolazione iperarticolando e a velocità/ritmo costante. Si fa una vera e propria fisioterapia dell’articolazione: si può creare una tabella articolatoria partendo da quei suoni che il paziente riesce a produrre (anche lievemente). Inizialmente si lavora con cra/cre/cri/cro/cru (lì dove il paziente ha già i fonemi di base) e si preferisce usare delle non parole in base alle caratteristiche che ci servono allenare. 27 di 28 La disartria interferisce molto con l’intelligibilità del parlato e si lavora molto in progressione spingendo sull’iperarticolazione (avremo un paziente che tende a ipoarticolare) e dandogli noi il ritmo. 7.4 Aprassia dell’articolazione. Si tratta di un disturbo di programmazione motoria articolatoria non conseguente a paresi dei muscoli necessaria alla realizzazione dei suoni del linguaggio. È contraddistinta dalla perdita delle capacità di integrare spazialmente e temporalmente l’attività dei singoli muscoli. Si possono osservare errori come: - fenomeni di assordamento a causa d una ritardata tensione e vibrazione delle CVV; - sostituzione di suoni fricativa con i corrispondenti suoni affricati o occlusivi a causa di una eccessiva contrazione muscolare; - complessiva sensazione da parte di chi ascolta di trovarsi davanti a un “accento straniero”. Se chiedo ad un paziente con aprassia articolatoria di produrre /pa/ probabilmente mi produrrà /ka/ oppure /ba/ oppure /ta/. Se faccio la stessa richiesta ad un paziente con disartria probabilmente mi produrrà un /pa/ ma distorto. Nell’aprassia dell’articolazione il paziente non riesce a coordinare sonorità e luogo di articolazione e quindi ci darà ba al posto di pa oppure sostituzione di suoni fricativi con i corrispondenti suoni affricati o occlusivi. Solitamente in questo ultimo caso, l’errore è dato da un’eccessiva contrazione muscolare. Per la valutazione, esistono dei test specifici ma in realtà ogni struttura adotta un proprio protocollo e la valutazione è più che altro ecologica. Tra i test che si possono utilizzare però abbiamo il FAST. 7.4.1 Trattamento aprassia articolatoria. Trattandosi di un’aprassia è presente la dissociazione automatico-volontaria e quindi dobbiamo lavorare sempre sulla volontarietà del movimento e interrompere l’automatismo. Quindi, se il paziente non riesce a dire /pa/, non gli associamo la parola palla perché a noi serve il suono singolo, dobbiamo lavorare sulla volontarietà. Inizieremo dai suoni delle vocali lavorando sempre davanti allo specchio e inizialmente senza emissione di suono. In questi casi è molto importante anche la ridondanza dell’informazione e quindi possiamo accompagnare la stimolazione con gesti, disegni, lettere scritte, ecc. Inizieremo con la vocale /a/, poi /o/ e /u/. Importante non proporre la vocale /e/ dopo la / a/ perché sono molto simili e potrebbero mandare in confusione il paziente. Una volta apprese le prime vocali, possiamo inserire le altre o combinare più vocali tra di loro sempre in iperarticolazione (per esempio /au/). Quando il paziente riesce a gestire le vocali, introduciamo le consonanti partendo da quelle a maggiore labiolessività 28 di 28 In molti casi, può essere utile fornire maggiori strumenti al paziente creando una vera e propria tabella articolatoria dove non solo scriviamo la vocale ma accanto inseriamo il disegno del movimento da fare così da lasciare un’informazione anche visiva.
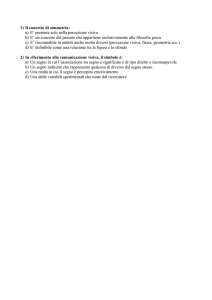
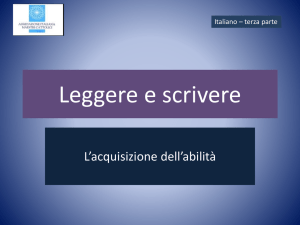
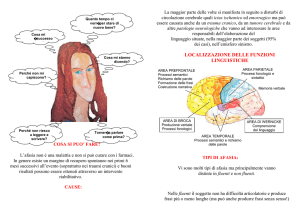
![Slide università 2017 [Sola lettura]](http://s1.studylibit.com/store/data/007266034_1-dd2d8df1f64d91529f0fa89179a4295b-300x300.png)