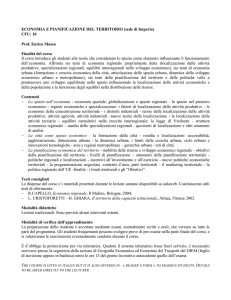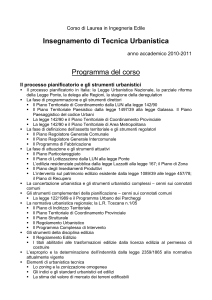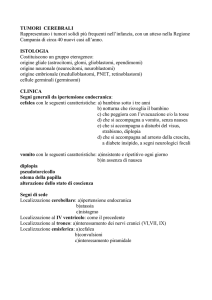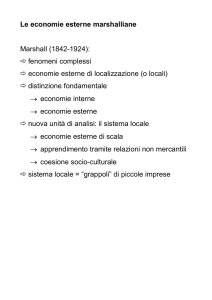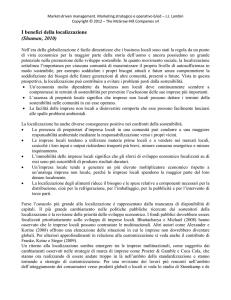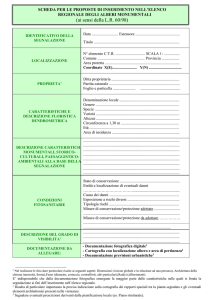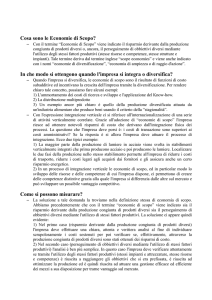caricato da
common.user2215
Localizzazione Industriale: Costi e Agglomerazione
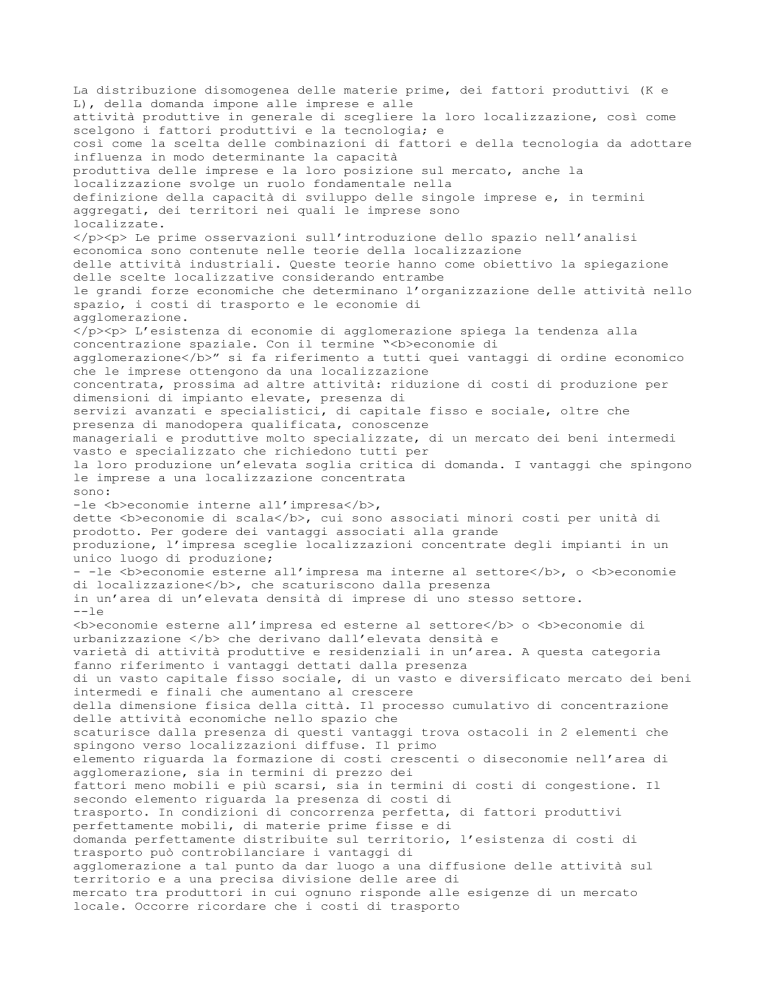
La distribuzione disomogenea delle materie prime, dei fattori produttivi (K e L), della domanda impone alle imprese e alle attività produttive in generale di scegliere la loro localizzazione, così come scelgono i fattori produttivi e la tecnologia; e così come la scelta delle combinazioni di fattori e della tecnologia da adottare influenza in modo determinante la capacità produttiva delle imprese e la loro posizione sul mercato, anche la localizzazione svolge un ruolo fondamentale nella definizione della capacità di sviluppo delle singole imprese e, in termini aggregati, dei territori nei quali le imprese sono localizzate. </p><p> Le prime osservazioni sull’introduzione dello spazio nell’analisi economica sono contenute nelle teorie della localizzazione delle attività industriali. Queste teorie hanno come obiettivo la spiegazione delle scelte localizzative considerando entrambe le grandi forze economiche che determinano l’organizzazione delle attività nello spazio, i costi di trasporto e le economie di agglomerazione. </p><p> L’esistenza di economie di agglomerazione spiega la tendenza alla concentrazione spaziale. Con il termine “<b>economie di agglomerazione</b>” si fa riferimento a tutti quei vantaggi di ordine economico che le imprese ottengono da una localizzazione concentrata, prossima ad altre attività: riduzione di costi di produzione per dimensioni di impianto elevate, presenza di servizi avanzati e specialistici, di capitale fisso e sociale, oltre che presenza di manodopera qualificata, conoscenze manageriali e produttive molto specializzate, di un mercato dei beni intermedi vasto e specializzato che richiedono tutti per la loro produzione un’elevata soglia critica di domanda. I vantaggi che spingono le imprese a una localizzazione concentrata sono: -le <b>economie interne all’impresa</b>, dette <b>economie di scala</b>, cui sono associati minori costi per unità di prodotto. Per godere dei vantaggi associati alla grande produzione, l’impresa sceglie localizzazioni concentrate degli impianti in un unico luogo di produzione; - -le <b>economie esterne all’impresa ma interne al settore</b>, o <b>economie di localizzazione</b>, che scaturiscono dalla presenza in un’area di un’elevata densità di imprese di uno stesso settore. --le <b>economie esterne all’impresa ed esterne al settore</b> o <b>economie di urbanizzazione </b> che derivano dall’elevata densità e varietà di attività produttive e residenziali in un’area. A questa categoria fanno riferimento i vantaggi dettati dalla presenza di un vasto capitale fisso sociale, di un vasto e diversificato mercato dei beni intermedi e finali che aumentano al crescere della dimensione fisica della città. Il processo cumulativo di concentrazione delle attività economiche nello spazio che scaturisce dalla presenza di questi vantaggi trova ostacoli in 2 elementi che spingono verso localizzazioni diffuse. Il primo elemento riguarda la formazione di costi crescenti o diseconomie nell’area di agglomerazione, sia in termini di prezzo dei fattori meno mobili e più scarsi, sia in termini di costi di congestione. Il secondo elemento riguarda la presenza di costi di trasporto. In condizioni di concorrenza perfetta, di fattori produttivi perfettamente mobili, di materie prime fisse e di domanda perfettamente distribuite sul territorio, l’esistenza di costi di trasporto può controbilanciare i vantaggi di agglomerazione a tal punto da dar luogo a una diffusione delle attività sul territorio e a una precisa divisione delle aree di mercato tra produttori in cui ognuno risponde alle esigenze di un mercato locale. Occorre ricordare che i costi di trasporto sono intesi come tutti quegli elementi di frizione spaziale i quali rendono più appetibile una localizzazione che permette una distanza ridotta tra due punti nello spazio. Sulla base degli obiettivi che si pongono e delle ipotesi che assumono circa la struttura spaziale del mercato due gruppi distinti di teorie della localizzazione delle attività industriali sono identificabili: </p><p>-le teorie orientate alla minimizzazione dei costi; </p><p> -le teorie orientate alla massimizzazione dei profitti. </p><p><b>2. ECONOMIE DI LOCALIZZAZIONE E COSTI DI TRASPORTO </b></p><p><b>2.1. IL CONTRIBUTO DI WEBER </b></p><p>L’economista Weber formula un elegante modello localizzativo in cui i costi di trasporto tra luoghi di produzione, mercati delle materie prime e mercato del bene finale sono messi direttamente a confronto con le economie di localizzazione. Il modello di Weber si fonda su queste ipotesi: </p><p>1. Un mercato del bene puntiforme (C); 2. Due mercati delle materie prime, anch’essi puntiformi, localizzati a una certa distanza uno dall’altro (M1 e M2); 3. Condizioni di perfetta concorrenza sul mercato, ossia nessuna possibilità per i produttori di derivare vantaggi monopolistici dalla scelta localizzativa; 4. Una domanda del bene finale rigida al prezzo; </p></div></div><div><div><p>5. Un’unica tecnica di produzione uguale in ogni possibile localizzazione; costi di produzione sono dati e costanti. La scelta localizzativa è il risultato di un calcolo in 2 stadi. Nel primo stadio l’impresa cerca la localizzazione che garantisce il costo minimo di trasporto tra il luogo di produzione e i mercati delle materie prime e del bene finale. Nel secondo stadio, l’impresa paragona i vantaggi di agglomerazione con i maggiori costi di trasporto in cui incorre qualora scelga la nuova localizzazione rispetto a quella a costo minimo. NOTA: il primo stadio evidenzia la localizzazione che garantisce costi di trasporto minimi. Siano x e y le tonnellate di materie prime rispettivamente presenti nei mercati M1 e M2 necessarie per produrre un’unità di prodotto, e z le tonnellate del bene finito da trasportare sul mercato finale C; i costi di trasporto totali CT sono espressi come funzione del peso della merce da trasportare e della distanza da coprire. CT= xa+yb+zc dove a,b,c sono rispettivamente le distanze in km tra i mercati delle materie prime e il luogo di produzione e tra quest’ultimo e il mercato finale; xa, yb, zc rappresentano le forze di attrazione che spingono l’impresa rispettivamente verso il punto M1, M2 e C. </p><p>La soluzione localizzativa a costo minimo può essere identificata: - in un punto interno al triangolo che si viene a formare dall’unione di M1, M2 e C, qualora nessuna delle forze di attrazione ecceda la somma delle altre due. Questa condizione è raggiunta quando il costo di spostare le z tonnellate di bene prodotto di un chilometro più lontano dal mercato di sbocco non eccede la somma dei costi per spostare le y e x tonnellate di materie prime di un chilometro più lontano dal loro mercato d’origine; - in C, cioè nel mercato finale quando la somma dei costi per spostare le y e x tonnellate di materie prime un chilometro più lontano dal loro mercato è inferiore al costo dello spostamento delle z tonnellate di bene finale prodotto per un chilometro in più. Questa localizzazione viene definita come “orientata al mercato”. – in un punto verso i mercati delle materie prime, qualora la somma dei costi di trasporto per un chilometro in più delle y e x tonnellate di materie prime ecceda il costo aggiuntivo di trasporto delle z tonnellate di bene finito. Questa localizzazione viene definita come “orientata alle materie prime”. </p><p>Nel secondo stadio che accompagna la scelta localizzativa, l’impresa mette a confronto la localizzazione a costo minimo con una localizzazione alternativa nella quale può godere di economie di localizzazione, quali la disponibilità di manodopera a prezzi relativamente meno elevati e/o di qualità superiore. Se si suppone che P in figura sia il punto di localizzazione a costi di trasporto minimo, Weber evidenzia le cosiddette isodapane, curve lungo le quali il costo di trasporto addizionale che l’impresa deve affrontare per coprire una certa distanza dalla localizzazione a costo minimo rimane costante. Se ci sono altre imprese operanti nello stesso settore, la scelta rilocalizzazone avverrà se e solo se le isodapane di ogni impresa che misurano un costo aggiuntivo di trasporto pari al vantaggio agglomerativo (v) si incrociano; all’interno dell’area di intersezione i costi di trasporto aggiuntivi sono inferiori ai vantaggi che la localizzazione concentrata genera. </p><p><b>3. DIMENSIONE DEL MERCATO E COSTI DI TRASPORTO </b></p><p>Nel modello di Weber la domanda assume una struttura spaziale puntiforme, priva di dimensione fisica o economica: questa ipotesi nega l’esistenza di luoghi di agglomerazione della popolazione, nega l’esistenza di grandi agglomerazioni urbane, che esistono grazie ai vantaggi che la densità abitativa comporta per attività residenziali e produttive. Qualora si ipotizzi l’esistenza di mercati finali di diversa dimensione è facilmente dimostrabile che le scelte localizzative delle attività industriali cambiano rispetto a quelle effettuate sia in un’ottica di mercati puntiformi, sia distribuiti omogeneamente sul territorio. </p><p><b>4.1. LE AREE DI MERCATO </b></p><p>Un secondo gruppo di modelli di localizzazione industriale si pone l’obiettivo di evidenziare come la coesistenza di economie di scala e costi di trasporto identifica la divisione spaziale del mercato tra i produttori; per raggiungere ciò, è necessario abbandonare l’ipotesi di una struttura di mercato puntiforme, per rifarsi a quella di una domanda distribuita omogeneamente sul territorio. IPOTESI: <i>1. Esiste una domanda omogeneamente distribuita lungo un mercato lineare, ed è una domanda completamente rigida al prezzo; 2. Esistono due produttori che offrono uno stesso prodotto con identiche funzioni di costo; 3. La localizzazione dei produttori è data; 4. Il costo di trasporto per unità di distanza è costante, così che quello totale sia proporzionale unicamente alla distanza percorsa; 5. Il costo di trasporto è a carico del consumatore. </i> Siano A e B i due produttori localizzati in due punti su un mercato lineare (fig. 1.2a). Il prezzo al quale i produttori vendono la merce sul mercato è ottenuto dalla somma del prezzo franco fabbrica, o prezzo di produzione della merce (p*), con il costo di trasporto: p= p*+πd </p></div></div><div><div><p>dove π è il costo di trasporto unitario per unità di distanza e d la distanza percorsa dal consumatore per recarsi ad acquistare il bene. MAN MANO CHE CI SI ALLONTANA DAL LUOGO DI PRODUZIONE, IL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO AUMENTA POICHE’ MAGGIORE E’ IL COSTO DI TRASPORTO CHE I CONSUMATORI DEVONO AFFRONTARE PER RECARSI AD ACQUISTARE IL PRODOTTO: LA LONTANANZA DAL LUOGO DI PRODUZIONE IMPONE AI CONSUMATORI LOCALIZZATI IN a DI ACQUISTARE IL BENE A UN PREZZO SUPERIORE, PARI A p1 nella figura 1.2a. ATTRATTI DA UN PREZZO INFERIORE, I CONSUMATORI SEGLIERANNO DI COMPERARE IL BENE DAL PRODUTTORE LOCALIZZATO PIU’ VICINO A LORO. Per esempio nella fig. 1.2° la differenza di prezzo tra p1 e p2 incentiva i consumatori localizzati in c ad acquistare il bene dal produttore A piuttosto che dal produttore B. Questa condizione vale per tutti i consumatori compresi tra i punti a e b. Lo stesso ragionamento vale per i consumatori localizzati da b in poi: essi troveranno conveniente rivolgersi al produttore B, che offre, a prezzi inferiori, lo stesso bene di A. Il punto b rappresenta la soglia delle 2 aree di mercato: in quel punto risulta indifferente al consumatore servirsi dal produttore A o da B, essendo uguali i prezzi di vendita del bene praticati dai 2 produttori. <i></i> Qualora uno dei due produttori (B) goda di economie di scala e abbia cioè un costo di produzione inferiore al produttore A, la soglia di separazione tra i mercati dei due produttori, rappresentata dal punto b, si sposta e delimita un’area di mercato maggiore per i produttore B (fig 1.2b). Il produttore A riesce a resistere sul mercato grazie alla distanza che lo separa da B. Nella figura 1.2c B gode sia di economie di scala (pB*&lt;pA*) sia di costi di trasporto inferiori (πB&lt;πA) e sottrae ad A gran parte del mercato; A riduce ancor di più il suo controllo a una piccola area (ab) vicina al suo luogo di produzione. </p><p>CONCLUSIONI SUL MODELLO: </p><p>1) i consumatori localizzati più vicino al luogo di produzione ottengono un vantaggio economico in termini di minori costi di trasporto e dunque di minore prezzo complessivo del bene di cui si avvantaggiano se il produttore non applica discriminazioni di prezzo; 2) il produttore può discriminare sul prezzo all’interno della sua area di mercato, nella quale opera in regime di monopolio, senza perdere quote di mercato. 3) dai punti 1 e 2 si evince che la distanza fisica svolge il ruolo di barriera all’entrata nei mercati locali: ogni impresa non compete con tutte le altre, ma con quelle più prossime. Il modello di competizione tra imprese in un mercato spaziale non può pertanto essere quello di concorrenza monopolistica. </p><p><b>5. LA DOMANDA SPAZIALE, L’EQUILIBRIO DEL MERCATO E LA LOCALIZZAZIONE DELL’IMPRESA </b></p><p>Ora occorre definire le diverse quantità del bene offerto dall’impresa che i consumatori sono disposti ad acquistare, al variare della distanza da percorrere per acquistarlo, dati un certo costo di produzione del bene e un certo costo di trasporto. Questo passo presuppone la costruzione della <b>curva di domanda spaziale individuale</b>, che evidenzia le diverse quantità del bene x che ogni individuo è disposto ad acquistare dall’impresa i, in funzione della sua distanza dall’impresa stessa e dal prezzo di produzione definito dal produttore in base alle condizioni di produzione. Una volta ottenuta la curva di domanda spaziale individuale è possibile ottenere la curva di domanda spaziale del mercato, come somma delle singole quantità domandate alle diverse distanze dagli n consumatori esistenti nel mercato, che, analizzata insieme alla tradizionale curva di offerta dell’impresa della teoria microeconomica, definisce l’equilibrio di mercato. La costruzione della domanda spaziale è riportata in fig. 1.5, composta da 4 grafici. - il grafico a rappresenta la relazione prezzo-distanza. Nel grafico b è costruita la curva di domanda individuale della microeconomia tradizionale, delineando una relazione negativa tra prezzo e quantità. Il grafico c ha la semplice funzione di trasposizione della variabile sugli assi. Il grafico d contiene la curva di domanda spaziale individuale. A una distanza pari a d1, l’impresa offre al consumatore il bene x al prezzo p1. A quel prezzo il consumatore è interessato ad acquistare la quantità x1 del bene. La quantità è facilmente trasferibile sul grafico d grazie alla trasposizione degli assi che si effettua nel grafico c. Unendo nel grafico d le combinazioni ottenute quantitàdistanza, si ottiene la curva di domanda spaziale individuale. LA DOMANDA DEL BENE COMPLESSIVAMENTE RICHIESTA ALL’IMPRESA PER OGNI DISTANZA E’ NELL’IPOTESI CHE TUTTI I CONSUMATORI ABBIANO IDENTICHE CURVE DI DOMANDA SPAZIALE INDIVIDUALE, LA SOMMA DELLE SINGOLE QUANTITA’ DOMANDATE ALLE DIVERSE DISTANZE DAGLI n CONSUMATORI ESISTENTI NEL MERCATO. Se si ipotizza una densità di consumatori uniforme per ogni unità di distanza, pari a q, la quantità complessivamente domandata del bene sarà pari all’area sottostante la curva di domanda individuale, moltiplicata per la densità q (area ODX 1.6a). Se si fa ruotare di 360° il triangolo formato dalla curva di domanda individuale intorno all’asse verticale, si viene a delineare un mercato circolare; il volume del cono che si ottiene, moltiplicato per la densità q, determina la quantità complessiva di bene domandata in un mercato circolare (1.6b). Le dimensioni delle aree di mercato che si delineano dal cono di domanda di Losch dipende dai costi di trasporto e dalle condizioni alle quali il bene è offerto. Un aumento dei costi di trasporto inclina la curva di domanda spaziale individuale, e restringe l’area di mercato dell’impresa (1.7 a); un prezzo di vendita più elevato diminuisce la quantità del bene richiesta dal consumatore, a parità di distanza e la curva spaziale individuale subisce pertanto uno spostamento parallelo verso il basso, che riduce l’area di mercato del produttore (1.7b). Una volta definita la curva di domanda, Losch evidenzia l’equilibrio economico-spaziale del mercato e la localizzazione dell’impresa. In ogni singola area, l’impresa si comporta da monopolista: la distanza protegge la sua area di mercato e il produttore produce in condizioni di massimizzazione del </p></div></div><div><div><p>profitto e extraprofitti. Il mercato a livello spaziale, è formato da molte aree di mercato, non sovrapposte una all’altra, con ampi spazi nei quali esiste una domanda non servita (1.8 a). Questo è però un equilibrio di breve periodo. Infatti l’esistenza di extraprofitti nella produzione del bene incentiva nuove imprese ad entrare nel mercato e a localizzarsi proprio nelle aree non ancora coperte da un’offerta. L’entrata di nuove imprese comporta due effetti: il mercato spaziale si satura e si erodono i margini di profitto delle singole imprese, a causa di una riduzione della domanda suddivisa tra più produttori. Ben presto si arriva a una condizione in cui le imprese non hanno più interesse a entrare nel mercato, in quanto gli extraprofitti sono riassorbiti dai costi di produzione crescenti; l’equilibrio di mercato di lungo periodo è cosi raggiunto. QUINDI DI FRONTE ALLA SOVRAPPOSIZIONE DI AREE DI MERCATO, E NELL’IPOTESI DI BENE OMOGENEO, I CONSUMATORI SCELGONO DI ACQUISTARE IL BENE AL MINOR PREZZO DI VENDITA OFFERTO, CHE SARA’ QUELLO DEFINITO DALLA DISTANZA INFERIORE CHE SEPARA IL CONSUMATORE DAL PRODUTTORE. IL RISULTATO DEL PROCESSO E’ UN EQUILIBRIO DI MERCATO DI LUNGO PERIODO, IN CUI SI VIENE A CONFIGURARE UN MERCATO SPAZIALE FORMATO DA ESAGONI REGOLARI, SENZA AREE DI SOVRAPPOSIZIONE. 6. IL MODELLO DI HOTELLING Nei modelli precedenti, data una certa localizzazione dei produttori e data una domanda omogeneamente distribuita sul territorio, il mercato viene suddiviso in aree, in ognuna delle quali opera un solo produttore. Non si è mai ipotizzato che, una volta spartito il mercato, i produttori prendano in considerazione di rilocalizzarsi. Occorre riflettere quindi sull’interdipendenza nelle scelte localizzative contenuta nel modello di duopolio di Hotelling. IPOTESI: 1. L’esistenza di due soli produttori (duopolio); 2. Un mercato lineare sul quale è omogeneamente distribuita la domanda del bene prodotto, anch’esso omogeneo; 3. Costi di rilocalizzazione nulli; 4. Una domanda completamente anelastica al prezzo (q.tà bene domandata consumatore che non cambia al variare del prezzo); Date le localizzazioni iniziali dei produttori in A e in B, se si ipotizza la rilocalizzazione di uno dei due produttori, ad esempio A in A’, la spartizione del mercato cambia a favore di A che conquista quote di mercato sottraendole al produttore B. Anche B avrà interesse a rilocalizzarsi, in B’ poiché così facendo ottiene quote di mercato di A. Questo processo ha termine quando i produttori si focalizzano al centro del mercato, spartendosi a metà il mercato spaziale (1.9b). </p><p>Si possono fare due considerazioni alle quali si giunge grazie a questo modello: 1. Anche in presenza di costi di trasporto, esiste una naturale tendenza delle attività produttive a concentrarsi nello spazio; 2. La soluzione competitiva ottenuta dalle forze di mercato non coincide con l’interesse pubblico: la distanza media che il consumatore deve percorrere per acquistare il bene una volta che i produttori hanno raggiunto l’equilibrio localizzativo è nell’ipotesi di una localizzazione di partenza pari a quella descritta in 1.9 a., maggiore di quella iniziale. Le critiche al modello di Hotelling si rifanno alla forte dipendenza dei risultati raggiunti dalle ipotesi di base. Se fosse ammessa una soluzione cooperativa, i due produttori potrebbero accordarsi per non cambiare la localizzazione iniziale, evitando i costi di delocalizzazione. In secondo luogo, qualora fosse ammessa la possibilità di nuovi entranti sul mercato, verrebbe meno la concentrazione spaziale; alla nuova impresa, infatti, converrebbe evitare la localizzazione centrale e invece sfruttare localizzazioni più periferiche. Qualora si eliminasse l’ipotesi di rigidità della curva di domanda, il risultato di una localizzazione centrale verrebbe di nuovo messo in discussione. Uno spostamento di entrambi i produttori da una localizzazione centrale verso una più periferica permetterebbe ricavi più elevati; infatti nelle nuove localizzazioni A’ e B’ nella fig 1.10, i consumatori avrebbero un risparmio in termini di costi di trasporto pari all’area grigio chiaro, che è superiore al risparmio reso possibile da una localizzazione centrale, definito dall’area grigio scuro della figura; la loro domanda del bene quindi aumenterebbe. </p></div></div><div><div><p>CAP. 4: STRUTTURA PRODUTTIVA E SVILUPPO 1. DIFFERENTI INTERPRETAZIONI DI CRESCITA/SVILUPPO REGIONALE Ci si occupa ora della teoria dello sviluppo regionale. Nonostante ci siano diversi approcci per il suo studio, tutte le teorie sono accomunate da un unico interesse, quello di identificare gli elementi e le determinanti che possono dare ragione del sentiero di sviluppo di un sistema locale e analizzarlo sia in termini di crescita assoluta, in un’ottica di efficiente allocazione delle risorse locali, sia in termini di crescita relativa (tra regioni) in modo da interpretare le disparità regionali e i sentieri di convergenza o divergenza nei livelli e nei tassi di crescita del reddito, in un’ottica di equità distributiva. L’oggetto principale di studio delle teorie e dei modelli che vedremo d’ora in poi, risiede nello “sviluppo regionale”, inteso come la capacità di una regione di trovare, e di ricreare continuamente, uno specifico e appropriato ruolo all’interno della divisione internazionale del lavoro, attraverso l’uso efficiente e creativo delle risorse che il sistema economico locale possiede. Spesso, nelle teorie e nei modelli che analizzeremo, gli elementi che compongono lo sviluppo di un sistema economico sono ricondotti a un unico indicatore, la crescita del prodotto o del reddito pro capite di una regione, con l’evidente perdita di informazioni qualitative, ma con l’innegabile pregio di una possibile modellizzazione analitica del sentiero di sviluppo. Quando questo è il caso, si è di fronte a <b>teorie della crescita regionale</b>, mentre, quando le teorie si occupano di analizzare elementi tangibili e intangibili, spesso di difficile formalizzazione, che definiscono il benessere della società e ne garantiscono il perdurare nel tempo, si parla di <b>teorie dello sviluppo locale</b>. Del concetto di crescita regionale esistono 3 grandi filosofie con le quali si è interpretata la dinamica economica: 1. In un gruppo di teorie l’obiettivo risiede nell’individuazione delle determinanti che, in un sistema locale, generano occupazione e reddito nel breve periodo, ipotizzando capacità produttiva (stock di capitale) non utilizzata e ampie riserve di lavoro. In queste condizioni, la crescita economica locale non dipende dalla struttura e dalla dinamica dell’offerta ma dallo sviluppo della domanda di beni prodotti localmente, che mette in moto processi moltiplicativi del reddito attraverso incrementi nei consumi e nell’occupazione. 2. In un secondo gruppo di teorie l’interesse è quello di evidenziare i meccanismi economici che permettono alla regione di uscire dalla povertà, di intraprendere un sentiero di crescita, di garantire un certo livello di benessere e di reddito pro capite agli individui. 3. Il terzo gruppo si rifà alla concezione più moderna di crescita, dove l’obiettivo risiede nel ricercare le condizioni locali che permettono al sistema economico di raggiungere elevati livelli di competitività e di innovatività che garantiscono di mantenere tali livelli di competitività nel tempo. </p><p>Dalle diverse interpretazioni di sviluppo emerge <b>l’elemento scatenante del processo di crescita</b>. Un aumento del reddito di breve periodo è facilmente raggiungibile attraverso una crescita della domanda di beni e servizi prodotti localmente, nella forma di una domanda settoriale effettiva, anche esterna all’economia locale e dinamica, che instaura un meccanismo cumulativo virtuoso “domanda-offerta” attraverso effetti moltiplicativi sul reddito di stampo keynesiano. Il motore dello sviluppo risiede in questo caso in <b>elementi di domanda</b>. Al contrario, in un’ottica attenta al benessere individuale e alla competitività di lungo periodo, il motore dello sviluppo deve spostarsi su <b>elementi di offerta</b>, nella forma di disponibilità di fattori produttivi, di vantaggi assoluti o comparati delle produzioni locali che determinano la capacità produttiva di un’area e la sua posizione sul mercato mondiale. </p><p><b>2. LE DIVERSE CONCEZIONI DI SPAZIO </b></p><p>Le prime teorie dello sviluppo regionale sono teorie della crescita volte a spiegare l’andamento del reddito e dell’occupazione, nel breve e medio-lungo periodo: per farlo, si abbandona il concetto di spazio fisico-metrico caro alla teoria della localizzazione per adottare una concezione di <b>spazio uniformeastratto</b>, uno spazio all’interno del quale le condizioni di offerta e di domanda sono ovunque identiche. Uno spazio di questo tipo permette di utilizzare modelli a carattere macroceconomico nell’interpretazione dei fenomeni di crescita locale; infatti nell’ipotesi di uno spazio uniformeastratto nel quale le variabili economiche assumono gli stessi valori in tutta la regione, è possibile stilizzare il comportamento economico della regione in teorie e modelli di matrice macroeconomica aggregata prevedendo l’andamento dell’economia attraverso l’interazione di alcune variabili. Queste sono le teorie della crescita regionale. Un secondo modo di interpretare lo spazio è contenuto nella concezione di <b>spazio diversificato-relazionale</b> che ipotizza l’esistenza di polarità ben precise nello spazio geografico e di specificità nei rapporti tra individui, società e territorio sulle quali lo sviluppo si basa. Questa concezione di spazio sposta l’analisi a un approccio microterritoriale e microcomportamentale e, teorie del genere sono definibili come teorie dello sviluppo, finalizzate a ricercare tutti quegli elementi tangibili e intangibili, esogeni o endogeni, che caratterizzano il processo di sviluppo. Questa interpretazione di spazio trova la sua massima espressione nelle teorie dei distretti industriali, dei milieux, delle learning regions, che si occupano di ricercare le determinanti endogene dello sviluppo. In queste teorie lo spazio diviene risorsa economica a fattore produttivo autonomo, generatore di vantaggi statici e dinamici per le imprese in esso insediate ed elemento fondamentale nella determinazione della competitività del sistema produttivo locale. Nelle trattazioni teoriche più recenti, il concetto di spazio diviene quello di <b>spazio diversificato-stilizzato</b>, uno spazio nel </p></div></div><div><div><p>quale esistono polarità, sulle quali si innesta lo sviluppo, ma alle quali è negata una dimensione territoriale, in quanto stilizzate in semplici punti nello spazio. </p><p><b>3. LA TEORIA DEGLI STADI E LE PRECONDIZIONI DELLO SVILUPPO </b></p><p>La teoria degli stadi di sviluppo nasce come il primo tentativo, da parte dei teorici della localizzazione, di affiancare a un’analisi di localizzazione delle attività produttive un’interpretazione delle implicazioni delle scelte localizzative sui meccanismi di sviluppo. Lo sviluppo regionale è rappresentato come un susseguirsi naturale di fasi, temporalmente una successiva all’altra, ognuna caratterizzata da una produttività fattoriale e da un rapporto capitale/lavoro crescenti, che spiegano il raggiungimento di livelli di benessere e di ricchezza pro capite sempre più elevati. Si possono individuare 5 fasi: 1. <i>Fase di autarchia</i>: il sistema economico locale è in condizioni di autosufficienza in un’economia di sussistenza dove tutto quanto prodotto localmente è utilizzato per il consumo locale; 2. <i>Fase di specializzazione</i>: si mette in moto grazie alla creazione di alcune infrastrutture di trasporto, che danno luogo alla possibilità di scambio di beni agricoli e alla specializzazione dell’economia locale nella produzione di alcuni beni primari; 3. <i>Fase di trasformazione</i>: da un’economia agricola si passa ad una industriale , grazie al decollo di attività industriali strettamente connesse alla lavorazione dei prodotti primari e alla necessità di una popolazione in crescita; 4. <i>Fase di diversificazione</i>: dell’attività manifatturiera grazie alla crescente richiesta di beni intermedi, alla crescita del reddito e alla conseguente comparsa di nuovi settori; 5. <i>Fase di terziarizzazione</i>: si ha un’espansione dell’attività terziaria, rispondente alle esigenze di un’industria ormai avanzata. Questa teoria sottolinea l’importanza di una crescita contemporanea di diversi settori e di diversi investimenti infrastrutturali, in un processo di sviluppo bilanciato. In uno sviluppo bilanciato risiedono una serie di vantaggi ed esternalità, come: -esternalità derivanti da meccanismi di interdipendenza tra diversi settori; -esternalità nei meccanismi di interdipendenza tra domanda e offerta; -esternalità che nascono dalla presenza di investimenti in infrastrutture differenti. Il sottosviluppo in questa teoria non può che essere interpretato come la permanenza forzata all’interno di una fase. Le cause di una simile situazione trovano origine in condizioni interne ed esterne all’area: qualora non esistesse nell’economia locale sufficiente risparmio da incanalare verso investimenti in capitale o in infrastrutture, o qualora non esistesse una sufficiente dimensione del mercato, il livello di produttività del sistema economico in analisi rimarrebbe basso e alimenterebbe il processo vizioso di sottosviluppo ( come ridotta espansione del mercato, basso risparmio e bassi consumi, ridotto stock di capitale, bassa produttività e basso reddito). Secondo i teorici dello sviluppo bilanciato, nelle prime fasi le politiche di sviluppo devono incanalare gli investimenti pubblici in pochi grandi e diversificati settori, presenti in modo ragguardevole a livello locale, per minimizzare le dispersioni verso aree avanzate e al contempo superare l’insufficiente formazione di risparmio tipica delle economie arretrate. In un secondo momento con l’espansione di risorse private grazie al decollo dei settori più forti, è possibile che una quota di investimenti pubblici sia destinata ad altri settori. Si possono quindi evidenziare quelli che sono gli ELEMENTI IMPORTANTI DEL PROCESSO DI SVILUPPO: il ruolo delle infrastrutture da sviluppare con particolare attenzione alle esigenze della domanda, il ruolo della specializzazione dei processi produttivi, alla base di rendimenti crescenti nella produttività fattoriale, l’importanza dei trasporti per ampliare la dimensione del mercato e della produzione. Ad ogni modo, risulta difficile che il processo di sviluppo possa avvenire seguendo fasi necessariamente identiche in tutte le regioni. </p><p><b>4. FASI DI SVILUPPO E DISPARITA’ </b></p><p>Williamson presenta una riflessione circa l’evoluzione dei divari regionali all’interno di un paese. Secondo lui, lo sviluppo si presenta, nelle prime fasi, concentrato e polarizzato nelle aree centrali del paese, e che solo successivamente si diffonde alle aree più periferiche e ai settori più deboli. La conseguenza di questo sviluppo a due velocità è che nelle prime fasi dello sviluppo economico di un paese, il divario regionale cresce, per poi decrescere quando il reddito nazionale raggiunge un certo livello, seguendo un andamento a U rovesciata (fig. 4.2). Le ragioni dell’aumento di divario tra regioni forti e deboli nelle prime fasi di sviluppo sono: - emigrazione di lavoro selettiva, cioè di forza lavoro più qualificata, da aree deboli ad aree forti; - flussi di capitale verso regioni più ricche; - allocazione di una quota elevata di investimenti pubblici nelle aree forti; - limitati scambi interregionali di risorse. Tutti questi elementi accentuano con il passare del tempo le disparità regionali all’interno di un paese, fino a che non entrano in gioco meccanismi opposti, tra i quali: - creazione di nuovi posti di lavoro anche in aree meno sviluppate, con la conseguenza di far diminuire o arrestare il processo migratorio; - minore attività delle aree più avanzate, per effetto di saturazione dei mercati e di congestione fisica, con conseguenti costi proibitivi del suolo e inevitabili riduzioni del saggio di profitto medio; crescita di investimenti pubblici in aree deboli; - nascita di effetti di trascinamento dell’area forte su quella debole. 5. STRUTTURA INDUSTRIALE E CRESCITA REGIONALE: L’ANALISI “SHIFT-SHARE” La composizione settoriale di una regione spiega il suo tasso di crescita. Regioni a prevalente attività agricola hanno produttività fattoriale più contenuta, un rapporto capitale/lavoro più basso, e pertanto un tasso di crescita più limitato, a differenza di regioni industrializzate che registrano, grazie a produttività fattoriali maggiori, tassi di sviluppo più elevati. Per far dipendere il tasso di crescita di una regione dalla sola composizionesettoriale, aggregata addirittura in sole 3 macrocategorie settoriali (agricoltura, industria, servizi) come nella teoria degli stadi di sviluppo, è necessario ipotizzare che ogni settore all’interno di una macrocategoria abbia la stessa produttività, e che quest’ultima non vari a seconda della regione nella quale il settore si trova a produrre. Entrambe le ipotesi sono irrealistiche, infatti i settori all’interno di una stessa macrocategoria hanno produttività molto differenti. Allo stesso modo un settore localizzato in due regioni che si differenziano per dotazione infrastrutturale, per qualità dei fattori produttivi, per conoscenze tecnologiche, può mostrare nelle due regioni livelli di produttività differenti. Venne quindi sviluppata un’analisi circa la relazione che esiste tra struttura produttiva e crescita regionale, che venne chiamata in seguito analisi “shift-share”, cioè una metodologia statistica di analisi del tasso di crescita relativo della regione. Secondo questa teoria, il tasso di crescita regionale è influenzato da 3 elementi: 1) la struttura industriale, 2) la produttività dei settori, 3) la dinamica della domanda e delle preferenze dei consumatori. Se i settori hanno uguale produttività e la regione ha la stessa composizione settoriale della nazione, il tasso di crescita della regione risulta uguale al tasso di crescita della nazione. Ma spesso, il tasso di crescita regionale si discosta dal valore che dovrebbe avere se la regione crescesse quanto la nazione. Questo tasso di crescita è uguale a: Yr=Y*+s ove y rappresenta il tasso di crescita del reddito, r la regione, s il differenziale tra il tasso di crescita nazionale e quello regionale, y* indica il tasso di crescita della nazione. Il differenziale tra il tasso di crescita nazionale e quello e quello regionale, detto shift (s) può dipendere da due effetti: dall’effetto di composizione della struttura settoriale della regione, detto anche effetto MIX, che nasce dalla presenza nella regione di settori che a livello nazionale mostrano una dinamica più accentuata, per effetto di una domanda crescente in quel settore. L’effetto di composizione è misurabile come: </p><p>dove E rappresenta la variabile settoriale analizzata, i definisce i settori, n e r identificano rispettivamente la nazione e la regione. ( termine tra parentesi= differenza tra l’incremento nel periodo di tempo da 0 a 1 dell’occupazione nel settore i a livello nazionale e l’incremento medio nazionale, moltiplicato per il peso relativo di quel settore nell’economia locale; - dall’<b>effetto di competizione della struttura settoriale regionale, o effetto DIF, che deriva da una maggior capacità dell’economia regionale di sviluppare in media ogni settore a tassi superiori a quelli dei corrispondenti settori nazionali. </p><p>Qui, il termine in parentesi misura l’incremento del settore i a livello regionale rispetto all’incremento dello stesso settore a livello nazionale. L’analisi shift-share permette di cogliere l’apporto di ciascun settore alla determinazione del differenziale di crescita regionale. La ricchezza di questo approccio risiede nella capacità di separare, all’interno del differenziale nella crescita regionale, gli effetti strutturali (MIX) da quelli congiunturali (DIF) ed evidenziare quelli che sono concepiti come i motori dello sviluppo regionale: elementi di domanda misurati dal MIX e gli elementi di offerta misurati dal DIF. Ponendo su un grafico i tassi di crescita dell’occupazione rispettivamente per il livello nazionale, sull’asse d elle ascisse, e per il livello regionale sull’asse delle ordinate, ogni settore è rappresentato da un punto sul grafico, che indica la sua crescita rispettivamente a livello nazionale e regionale. Evidenziando inoltre sul grafico il tasso di crescita medio nazionale e regionale, e la retta a 45° che parte dall’origine è possibile individuare diverse aree, che rappresentano condizioni di sviluppo differenti ( fig.4.3): - uno sviluppo favorevole alla regione è rappresentata da un elevato numero di settori che si collocano nelle aree al di sopra della retta a 45° (aree A,D,E,F): essi rappresentano una capacità di crescita locale superiore a quella nazionale, e pertanto un effetto DIF favorevole; - una crescita positiva è rappresentata da un numero elevato di settori che si collocano nelle aree a destra della retta che rappresenta l media settoriale nazionale (aree A, B, C): sono settori che registrano una crescita superiore al tasso di crescita medio nazionale. La specializzazione della regione in questi settori denota una crescita locale sorretta da un effetto MIX favorevole; - una condizione favorevole alla crescita di una regione è rappresentato da un numero elevato di settori nell’area A nel grafico, che registrano sia l’effetto MIX sia l’effetto DIF favorevoli, o nell’area B in cui la dinamica regionale è più debole, questi sono settori al di sopra della media regionale; un’altra condizione positiva per una regione è quella di un numero elevato di settori che si collocano nelle aree D o E, nelle quali la competitività dei settori locali è così elevata da compensare la condizione di crisi in cui i settori si trovano a livello </p></div></div><div><div><p>nazionale. Questo è il caso dei distretti industriali italiani. - una situazione di crisi per un’economia locale è invece rappresentata da un numero elevato di settori che si collocano nelle aree F e G; questi sono settori in crisi a livello nazionale, e che a livello locale mostrano tassi di crescita ancora più contenuti; - allo stesso modo , una situazione di crisi emerge dalla collocazione di un numero elevato di settori nelle aree C e H, dove la crescita della domanda nazionale non è sufficiente a compensare la scarsa competitività dei settori locali. </p><p>6. L’APPROCCIO CENTRALITA’-PERIFERICITA’ </p><p>Individua nella distanza dal centro delle attività economiche la causa del ritardato sviluppo. La semplicità di questo approccio è anche la sua forza: ricorda semplice che la centralità geografica rappresenta in sé un elemento a favore dello sviluppo, mentre la perifericità ne costituisce un ostacolo. L’accessibilità a informazioni, a conoscenze tecnologiche, a mercati dei fattori produttivi è una condizione necessaria per la crescita di un’economia locale , la perifericità intesa come distanza da un centro economico implica maggiori costi di trasporto dei beni finiti, delle materie prime, semilavorati, maggiori costi di acquisizione delle informazioni, ritardi nell’adozione di innovazioni, tutti elementi che giocano a sfavore di una crescita del reddito e della definizione di una competitività. Questa teoria richiama Weber: la migliore localizzazione risiede nel luogo che minimizza i costi di trasporto tra mercati dell’output e dell’input, ricordando che l’accessibilità al core dei diversi mercati si tramuta facilmente come un elemento, una precondizione, per lo sviluppo economico anche se rimane confinato a un tentativo assai limitato di concepire la localizzazione come una delle precondizioni affinché si innesti il processo di sviluppo economico di un’area. </p><p>CAP. 5: LA DOMANDA <b>1: DOMANDA E CRESCITA REGIONALE </b></p><p>Si parla ora delle <b>determinanti economiche dello sviluppo</b>, sui meccanismi che permettono a un sistema di crescere e di raggiungere tassi di incremento della produzione maggiori, livelli di reddito pro capite più elevati e tassi di disoccupazione più contenuti, livelli di ricchezza più alti. Sono modelli che individuano lo sviluppo attraverso la crescita del prodotto o del reddito pro capite di una regione, con la necessaria assunzione di uno <b>spazio uniforme-astratto</b>, dove le condizioni di offerta e di domanda ovunque identiche, sono rappresentabili in un vettore di caratteristiche macroeconomiche aggregate a carattere socio-economico-demografico. Queste teorie possono quindi essere chiamate come <b>teorie della crescita regionale</b>. In particolare si affronteranno le teorie e i modelli che concepiscono la crescita come il risultato di un’espansione della domanda di beni e servizi prodotti a livello locale dove lo sviluppo è inteso come crescita della produzione, del reddito, dell’occupazione, in un’ottica keynesiana. Infatti dall’aumento della domanda di un bene dipende l’occupazione e il reddito di chi lavora nel settore di produzione del bene ma anche per meccanismi di interdipendenza nella produzione e nei consumi. In questi modelli la domanda è dunque il motore dello sviluppo; questa visione ben si addice alle regioni, entità territoriali di piccole dimensioni, dove quello che si produce va oltre la domanda locale. Si può quindi capire che in questi modelli la domanda è spesso esterna, espressione di un interesse del mercato mondiale alla produzione del bene locale. Come insegna il modello della base d’esportazione, un’espansione nelle esportazioni del bene provoca un aumento della produzione locale, con effetti positivi anche sul reddito e sull’occupazione e, per effetto di meccanismi di interdipendenza nella produzione e nei consumi, sull’occupazione e sul reddito di attività collegate a monte e a valle della produzione del bene: considerando che di solito il consumo cresce all’aumentare del reddito, ogni spesa addizionale si trasforma in reddito, il cui aumento torna ad incrementare la spesa. Ragionare in termini di sviluppo sorretto da una domanda, anche esterna, in espansione, comporta una serie di implicazioni. Innanzitutto, un approccio di questo tipo è destinato a interpretare un processo di <b>breve periodo</b> poiché ipotizza una competitività della produzione e della struttura attuale, che può essere estrapolata solo per un periodo ridotto. Quindi lo sviluppo è associato al perseguimento di più elevati livelli di occupazione e reddito, estraendo da considerazioni riguardo al benessere individuale e alla competitività del sistema produttivo locale. </p><p><b>3. IL MODELLO DELLA BASE D’ESPORTAZIONE </b></p><p><b>3.1. IL MODELLO DI HOYT </b></p><p>Il più noto modello orientato all’identificazione del ruolo della domanda nei meccanismi di crescita e di sviluppo è il modello della base d’esportazione. L’intuito principale risiede nell’idea che se i sistemi economici di grandi dimensioni come le grandi nazioni, possono fare affidamento su forze interne al sistema stesso per il loro sviluppo, i sistemi economici di più piccola entità, siano essi regioni o città, spesso specializzati, non possono affidarsi esclusivamente alle capacità endogene di sviluppo: la crescita economica di questi sistemi resta fortemente condizionata da elementi esterni al sistema </p></div></div><div><div><p>locale. Vediamo l’origine di questo modello. Negli anni 30 Hoyt sviluppa a livello urbano, il primo modello della base d’esportazione. Egli distingue l’occupazione del settore di base (Lb) dall’occupazione del settore dei servizi (Ls), proponendo le seguenti relazioni: </p><p>LT = Lb+Ls Ls = aLT con 0&lt;a&lt;1 Lb =Lb </p><p>L’occupazione totale LT è la somma dell’occupazione nei due settori; l’occupazione nel settore di base è esogena al sistema, mentre l’occupazione nel settore dei servizi è una quota pari ad a dell’occupazione totale. Alla fine si ottiene: </p><p>La 5.3 indica che all’aumentare dell’occupazione nel settore di base l’occupazione totale aumenta di una quantità più che proporzionale, la cui entità è definita moltiplicatore urbano 1/(1-a), che assume valori maggiori all’unità. Ipotizzando una semplice proporzione pari a b, tra l’occupazione totale e la popolazione residente nell’area, è possibile scrivere: </p><p>P= bLT con b&gt;1 </p><p><b>3.2: IL MODELLO KEYNESIANO “EXPORT-LED” </b></p><p>Negli anni 50 venne formulata una versione a livello regionale del modello della base d’esportazione di natura prettamente economica, dove si lascia il posto a variabili macroeconomiche aggregate quali il reddito, e la domanda interna ed esterna alla regione, con lo scopo di determinare la crescita economica delle aree, piuttosto che il loro sviluppo fisico. Questa versione si basa su un modello tradizionale di domanda aggregata keynesiana, dove il reddito Y uguaglia le componenti della domanda aggregata, consumi C, esportazioni X e importazioni M; </p><p>Y= C+X-M </p><p>Dove: X= X C= cY M= mY </p><p>Mentre le esportazioni sono per ipotesi esogene al modello, i consumi e le importazioni dipendono dal livello del reddito e dalle rispettive propensioni a consumare c, e a importare m. la 5.6 può essere riscritta come: </p><p>e indica che all’aumentare delle esportazioni di un’area, la produzione e il reddito aumentano in modo più che proporzionale, purché la propensione marginale a spendere localmente (c-m) sia minore dell’unità. La 5.8 è uguale alla 5.5 del modello precedente dove entrambe arrivano alla conclusione che la domanda esterna, misurata in termini di esportazioni genera e determina l’ampiezza dello sviluppo locale, attraverso gli effetti moltiplicativi che essa provoca sul reddito locale. La 5.8 indica che le regioni a più rapido sviluppo sono quelle che riescono a mantenere nel tempo un surplus di esportazioni, a meno che l’espansione delle esportazioni iniziali non venga annullata da un volume ancora maggiore di importazioni indotte. Analizzando quelli che sono gli elementi importanti di questa teoria si può dire che: in primo luogo essa non evidenzia ne implica un tasso di crescita di equilibrio, infatti se le regioni hanno disponibilità di risorse e di capacità produttiva, un’espansione dell’attività del settore di base, genera un tasso di crescita regionale senza vincoli economici o fisici allo sviluppo. In secondo luogo, è una teoria che non si occupa di processi di convergenza o divergenza tra regioni, e pertanto di crescita relativa; la possibilità che si verifichi convergenza dipende solo dal fatto che le regioni a basso livello di reddito sono siano caratterizzate da maggior probabilità di aumentare le esportazioni. </p><p><b>4.1: VALUTAZIONI CRITICHE DEL MODELLO </b></p><p>Al modello della base d’esportazione, è riconosciuto il grande pregio di aver analizzato il problema dello sviluppo regionale dal punto di vista di un sistema economico di piccole dimensioni: esso riesce a evidenziare il ruolo decisivo delle relazioni </p></div></div><div><div><p>interregionali, nella forma di scambi commerciali, nello sviluppo di un sistema economico di piccole dimensioni. Il modello ci ricorda l’importanza della specializzazione produttiva come determinante della crescita economica: la definizione del ruolo che ogni regione assume all’interno della divisione internazionale del lavoro dipende dalla capacità della regione di definire i suoi asset produttivi specifici, con i quali riesce a offrire beni su un mercato molto vasto e a conquistare una domanda che va ben oltre le barriere locali. Inoltre questa teoria mette sull’avviso circa il rischio che un’accentuata specializzazione economica può provocare ai sistemi economici locali, se la domanda internazionale di prodotti specifici mostra considerevoli fluttuazioni nel lungo periodo. Il modello inoltre è in grado di evidenziare ma non di interpretare, le determinanti dello sviluppo locale; è una teoria che ben si adatta a descrivere lo sviluppo di aree storicamente specializzate in alcuni settori industriali, o nei beni connessi con la disponibilità di risorse naturali, nelle quali la specializzazione non richiede di essere spiegata, ma è assunta esogeneamente. In altri casi, il modo in cui la base d’esportazione si determina e si concretizza in una maggiore competitività vanno interpretati ed evidenziati necessariamente attraverso uno studio della struttura e della dinamica dell’offerta locale, che non trovano nel modello nessuna considerazione. Un secondo elemento critico afferma che non esiste distinzione tra attività produttive diverse e tra specializzazioni industriali differenti. Il modello lascia quindi intendere che gli effetti moltiplicativi delle esportazioni sul reddito abbiano la stessa portata indipendentemente dal settore di origine dei beni esportati. Inoltre il modello ipotizza che non vi sia nessun ostacolo all’ampliamento dell’offerta: di fronte a incrementi di una domanda esterna, il sistema ha in sé le risorse per aumentare la capacità produttiva. Se così non fosse l’aumento di domanda si scaricherebbe nel breve periodo in un aumento dei prezzi, piuttosto che in una reale espansione fisica dell’attività produttiva. </p><p><b>4.2: LA STIMA DELLA “BASE ECONOMICA” </b></p><p>L’interesse ad applicare il modello della base d’esportazione alla realtà ha spinto nel tempo all’individuazione di diversi metodi per distinguere i settori di base da quelli dei servizi di una regione. Il metodo più comunemente suggerito è quello del <b>quoziente di localizzazione</b>, dove si distinguono i settori in base alla quota occupazionale del settore a livello regionale rispetto alla quota dello stesso settore a livello nazionale: </p><p>In cui i, r e n, indicano il settore, la regione e la nazione di analisi, ed E rappresenta il numero di occupati: qualora il rapporto tra le quote superi l’unità, si considera che la proporzione eccedente sia espressiva di un surplus di produzione rispetto alle esigenze della domanda locale, e quindi di esportazioni nette. Stabilito in questo modo quali sono i settori che esportano, sommandone l’occupazione si ottiene una stima del dell’occupazione del settore di base. L’uso del quoziente di localizzazione presenta alcuni limiti: -innanzitutto esso assume uguali gusti e preferenze dei consumatori nello spazio, se così non fosse, la proporzione eccedente potrebbe essere espressiva non tanto di un di un surplus di produzione, quanto di una struttura della domanda locale diversa da quella nazionale. Inoltre la logica sulla quale è costruito il ragionamento è una logica di economia chiusa, irrealistica e quindi il metodo del quoziente di localizzazione sottostima il settore di base. Un altro metodo proposto per la stima del settore di base è quello della <b>tecnica dei requisiti minimi</b>, che parte dal presupposto che la quota di occupati più bassa esistente in un settore in tutte le regioni sia la quota minima per soddisfare le necessità di una regione, e che una quota di occupazione in quel settore in altre regioni più elevata sia espressiva di una capacità produttiva in eccesso rispetto alle esigenze di una regione. La somma dell’occupazione dei settori che mostrano una quota di occupazione superiore a quella minima determina l’occupazione nel settore di base. </p><p><b>4.3: LA STIMA DEL MOLTIPLICATORE REGIONALE </b></p><p>L’applicazione del modello della base d’esportazione per la previsione di sviluppo di una regione, richiede necessariamente la stima del moltiplicatore del reddito. Ci sono due metodi che si possono individuare e che stimano il moltiplicatore regionale. Il primo consiste nella stima empirica dei vari parametri del moltiplicatore, attraverso una stima diretta della propensione a ad acquistare beni localmente. Si identificano così i beni e i servizi che hanno un’elevata probabilità di essere acquistati a livello locale, calcolando la quota locale rispetto a quella nazionale e si aggrega la spesa totale per ognuno di essi. Ripetendo l’esercizio per un certo numero di anni, si ottiene una serie storica della spesa locale la quale, regredita sul reddito disponibile, produce una stima della propensione marginale a consumare il reddito a livello locale, vale a dire (cm). Una volta noto questo valore è facile ottenere il valore del moltiplicatore regionale. Il secondo metodo considera invece come proxy del moltiplicatore regionale l’inverso della quota di dispersioni, sul prodotto interno lordo di una regione. Si individuano 4 canali di dispersione dell’effetto moltiplicativo sul reddito: i risparmi, le importazioni interregionali, le importazioni dall’estero e le imposte, dirette e indirette. Calcolata la quota sul reddito, l’inverso non è altro che il valore del moltiplicatore. </p><p><b>5. L’ANALISI INPUT-OUTPUT</b></p></div></div><div><div><p> Esiste una tecnica che permette di considerare l’impatto che la crescita della domanda in un determinato settore genera sulla produzione di ogni singolo settore dell’economia locale e sul prodotto locale, definita analisi input-output. Può essere interpretata come una metodologia di previsione degli effetti che la crescita della domanda in un determinato settore genera sul resto dell’economia locale. L’analisi input-output si basa sulla costruzione di una matrice quadrata n x n nella quale vengono registrati tutti i flussi di vendite (sulle righe) e acquisti (sulle colonne) che si generano in un anno tra gli n settori produttivi locali, che altro non sono se non i flussi intermedi di merci tra i diversi settori. La matrice è completata da una serie di colonne nelle quali si registrano le vendite di ogni settore alla domanda finale, e da una serie di righe, nelle quali si inseriscono gli acquisti dei fattori produttivi originali, lavoro e capitale, e gli acquisti dall’estero e dall’esterno dell’area, qualora si parli di una matrice input-output sub nazionale. La somma di ogni riga rappresenta i ricavi di ogni settore nella vendita dei beni ad altri settori e alla domanda finale, mentre la somma di ogni colonna esprime i costi che ogni settore deve affrontare per la produzione, dati dagli acquisti dei beni intermedi, dei beni prodotti esternamente e dalle remunerazioni dei fattori produttivi, salari e profitti. Definiti Aij i valori dei flussi di merci che il settore i vende al settore j, C, G, I, X, R rispettivamente i consumi privati, la spesa pubblica, gli investimenti, le esportazioni e il valore della produzione, la somma per riga è data da: </p><p>la somma per colonna è data da: </p><p>il prodotto interno lordo della regione Y è dato da: </p><p>I flussi di merci tra il settore i e il settore j possono essere espressi attraverso i cosiddetti coefficienti tecnici aij che esprimono la relazione che esiste tra il valore della produzione del settore i e quella del settore j. </p><p>Sintetizzando la domanda finale in un’unica voce D, si ottiene, per ogni settore i: </p><p>questa relazione indica il valore della produzione, il ricavo, del settore i, ottenuto dalla vendita del prodotto in parte alla domanda finale D, e in parte agli altri settori. </p><p>La relazione può essere riscritta come: </p><p>bij è detta matrice inversa di Leontief o matrice dei moltiplicatori, che permette di calcolare il valore della produzione di ogni settore i attivata direttamente e indirettamente da un euro di domanda finale che si rivolge a ciascun settore j. </p><p><b>7. LA LEGGE DI THIRLWALL </b></p><p>Negli anni 80 si è sottolineata l’importanza delle esportazioni regionali per la crescita di un’area. Questa teoria, nota come legge di Thirlwall, le esportazioni hanno un chiaro e deciso ruolo nel processo di sviluppo perché sorreggono il saldo della bilancia commerciale permettendo, in assenza di altri meccanismi, il finanziamento delle importazioni necessarie a soddisfare la domanda interna. Qualora, le esportazioni fossero scarse e inferiori alle necessità di importazione dell’area, si produrrebbe uno squilibrio nella bilancia commerciale regionale, che limiterebbe, nel lungo periodo le importazioni. Così, l’equilibrio nella bilancia commerciale diviene il modo con il quale la regione riesce a mantenere un certo livello di crescita. Se il tasso di crescita delle esportazioni è dipendente dal tasso di crescita del reddito mondiale (yw), pesato per l’elasticità della domanda di esportazioni al reddito mondiale (α), e il tasso di crescita delle importazioni (m) , a sua volta, è dipendente dal tassodi crescita del reddito regionale (yr), pesato per l’elasticità della domanda di importazioni al reddito locale (β), perché vi sia l’equilibrio nella bilancia commerciale regionale deve valere l’uguaglianza: </p><p>yr = α/β yw</p></div></div><div><div><p>questa relazione indica che il tasso di crescita di una regione dipende dl tasso di crescita del reddito mondiale e dal rapporto tra le due elasticità della domanda al reddito. Essendo il reddito mondiale una variabile esogena all’economia locale, alla regione non rimane altro per incentivare lo sviluppo locale, che favorire una struttura industriale caratterizzata da settori con esportazioni a elevata elasticità della domanda al reddito (α) e, al tempo stesso, settori con importazioni a bassa elasticità della domanda al reddito (β). In questo senso dunque lo sviluppo locale altro non è che un problema di riconversione industriale verso settori caratterizzati da esportazioni e importazioni, rispettivamente a maggiore e minore elasticità della domanda al reddito. La legge di Thirlwall vale solo per il breve periodo. CAP. 6: LA DOTAZIONE FATTORIALE DOTAZIONE FATTORIALE E CRESCITA REGIONALE Nel capitolo precedente si sono trattate le teorie che interpretano lo sviluppo regionale come un processo di crescita di breve periodo dell’occupazione e del reddito, ottenuta grazie a un aumento della domanda. In questo capitolo e nelle parti successive si introducono le teorie che focalizzano l’attenzione solo sugli elementi di offerta nella spiegazione della dinamica regionale di lungo periodo. Ciò significa non solo evidenziare le esportazioni dei beni come motore dello sviluppo, ma individuare gli elementi che spiegano la maggiore capacità di esportazione, in cui risiedono le fonti della competitività di un sistema economico locale. Per esportare, un sistema economico deve necessariamente godere di qualche forma di vantaggio: deve essere in grado di produrre beni a prezzi relativamente più bassi, offrire prodotti di qualità più elevata, disporre di nuovi beni da introdurre nel mercato, tutti obiettivi raggiungibili grazie all’esistenza di processi produttivi più efficienti, di un’avanzata struttura produttiva locale ecc… Le fonti della competitività territoriale sono pertanto molte e non a caso costituiscono l’oggetto di studio di approcci assai diversi fra loro. Si presentano qui le teorie che si concentrano sulla dotazione fattoriale come fonte della competitività territoriale. Esse rappresentano un corpus molto ampio di modelli di pura matrice neoclassica che concepiscono la crescita in un’ottica resource based. Nello scambio di beni o di fattori trovano una spiegazione, in queste teorie, l’aggiustamento dei prezzi relativi dei beni e dei fattori stessi, l’aumento della capacità produttiva e il raggiungimento del pieno impiego; nella logica delle teorie che concepiscono la perfetta mobilità dei fattori produttivi tra regioni, le differenti remunerazioni dei fattori determinano una riallocazione delle risorse nello spazio, e un tasso più elevato di crescita, tipicamente neoclassico. Nelle teorie che concepiscono i beni come mobili (commercio interregionale), il diverso livello di produttività dei fattori determina un vantaggio comparato per la regione nella produzione di un determinato bene, che esporta sul mercato grazie al differenziale di prezzo. Qui, la crescita non è più intesa come aumento dell’occupazione e del reddito nel breve periodo; essa viene qui concepita come benessere individuale raggiunto o grazie a incrementi nella produttività fattoriale o grazie a processi di specializzazione che permettono commercio interregionale. Per quanto riguarda il primo gruppo di teorie classiche e neoclassiche, quelle della mobilità fattoriale, la peculiarità risiede nel fare riferimento a un concetto di crescita relativa, con l’obiettivo di individuare sentieri di convergenza e divergenza nei livelli e nei tassi di crescita del prodotto. Per quanto riguarda il secondo gruppo di teorie, classiche e neoclassiche, quelle del commercio interregionale, la peculiarità principale è di fare ricorso al concetto di vantaggio comparato sulla base del quale si identifica la specializzazione della regione: tra tutti i beni che possono essere offerti sul mercato esterno, la regione riesce a esportare quelli che produce a costi di produzione relativamente più bassi. Quindi anche se una regione produce tutti i beni a costi e prezzi più elevati, dimostrandosi più inefficiente in assoluto nella produzione di tutti i beni rispetto al resto del paese, essa può in realtà essere relativamente meno inefficiente nella produzione di un bene rispetto agli altri beni e ottenere così un ruolo all’interno della divisione internazionale del lavoro, specializzandosi nella produzione del bene nel quale è relativamente più efficiente. I modelli che ora si presentano richiamano le teorie classiche e neoclassiche della crescita e del commercio internazionale, dalle quali assorbono l’impianto teorico, quindi ci si confronta nuovamente con approcci alla crescita regionale, attenti a concepire uno spazio uniforme-astratto, che garantisce la trattabilità delle condizioni economiche in indicatori economici aggregati. 2. CRESCITA REGIONALE E MOBILITA’ FATTORIALE 2.1. IL MODELLO A UN SETTORE PRODUTTIVO Il modello presenta le tradizionali ipotesi di un modello di crescita neoclassico: <i>- perfetta concorrenza nel mercato dei beni; - perfetta concorrenza nel mercato dei fattori produttivi e quindi i fattori sono remunerati alla loro produttività marginale; - piena occupazione raggiunta grazie alla flessibilità nelle remunerazioni dei fattori; - perfetta mobilità dei fattori produttivi tra regioni; - totale immobilità dei beni prodotti; - variabilità del rapporto capitale/lavoro in dipendenza delle diverse dinamiche dei fattori produttivi; La sintesi di questi elementi è rappresentata dalla funzione di produzione aggregata a livello regionale, espressa da una Cobb-Douglas a rendimenti costanti: con 0&lt;α&lt;1, ove Y rappresenta il reddito, A il progresso tecnico, K il capitale, L il lavoro e α e 1-α l’efficienza rispettivamente del capitale e del lavoro. Una volta passati ai logaritmi, la variazione del reddito Y nel tempo diviene: ove y, a, k , l rappresentano i tassi di crescita nel tempo rispettivamente del reddito, del progresso tecnico, del capitale e del lavoro. Questa formula indica che la possibilità per il reddito di crescere nel tempo dipende dalla crescita del progresso tecnico e dalla crescita del capitale e del lavoro. La formula può essere anche riscritta come: che afferma la crescita della produttività del lavoro e/o del reddito pro capite è uguale alla crescita del progresso tecnico e alla crescita del rapporto K/L. In assenza di progresso tecnico, la produttività del lavoro può solo aumentare se la crescita del capitale eccede quella del lavoro. Secondo i neoclassici, la crescita è una questione di ottima allocazione delle risorse inter e intra-regionali. Una migliore allocazione interregionale delle risorse in un’economia aperta con perfetta mobilità dei fattori prevede che i fattori produttivi si spostino dove più elevata è la loro produttività, attratti da maggiori remunerazioni. Questo significa che in una regione il tasso di crescita del capitale (k) dipende dalla massa del risparmio interno (sY) che può finanziare l’investimento e dal differenziale di remunerazione del capitale nell’area (ir) rispetto alla remunerazione dello stesso fattore nel resto del mondo (im). In simboli si ha: Nell’ipotesi di esistenza di due regioni, un sud povero, maggiormente dotato di lavoro e di capitale, e un nord, caratterizzato da un’elevata incidenza di capitale rispetto al lavoro, si assisterebbe a una migrazione di capitale dall’area ricca a quella povera, e viceversa di lavoro dal sud al nord, come conseguenza delle più elevate remunerazioni nelle aree dove minore è la presenza del fattore, che nascono da livelli di produttività fattoriale differenti. Il deflusso di lavoratori dal sud permette all’area debole di aumentare la produttività; lo stesso effetto positivo accompagna il deflusso di capitali dal nord, e il processo di riallocazione delle risorse si arresta quando le regioni raggiungono la stessa produttività dei fattori, stesse remunerazioni, dotazione fattoriale e quindi stesso livello di reddito in piena occupazione. Nella fig. 6.2, la riallocazione delle risorse, generata dai differenziali di remunerazione fattoriale, comporta pertanto per il nord vantaggi netti in termini di aumento di produzione pari all’area grigia della fig. 6.2 a e per il sud pari all’area grigia della fig. 6.2b.Il modello raggiunge un equilibrio stazionario quando capitale e lavoro crescono esattamente nella stessa proporzione. 2.2 IL MODELLO A 2 SETTORI PRODUTTIVI Il modello a due settori introduce ipotesi più realistiche che permettono di enfatizzare il ruolo di un’efficiente allocazione delle risorse all’interno della stessa regione, come determinante dei flussi di fattori produttivi intra e interregionali. IPOTESI: - esistenza di due regioni, dove sono presenti due settori che producono due beni, uno per l’esportazione e uno a uso domestico. I settori sono spesso identificati come il settore manifatturiero, ad alta produttività, e il settore agricolo a bassa produttività. – presenza di squilibri nella bilancia commerciale; - esistenza di concorrenza perfetta nel mercato dei beni; - uso del fattore capitale solo nel settore industriale; - rendimenti costanti nella produzione dei beni; - remunerazione dei fattori produttivi alla loro produttività marginale; - uguaglianza tra costo dei fattori produttivi e valore del prodotto marginale dei fattori; -lo stock di capitale nel settore che produce per l’esportazione aumenta; - la domanda di lavoro da parte delle imprese locali aumenta per effetto dell’aumento del valore del prodotto marginale del lavoro; - l’aumento della domanda di lavoro attrae lavoratori sia dal settore agricolo locale sia dall’altra regione; - l’espansione della produzione e dell’occupazione nel settore che produce per l’esportazione si ripercuote sul settore agricolo che registra un aumento della domanda del bene e della produzione e dell’occupazione. La crescita dell’occupazione in questo modello è il risultato di un’allocazione delle risorse più efficiente verso il settore manifatturiero, a maggior produttività: partendo da uno stimolo iniziale generato dall’aumento della domanda del bene esportato, nel settore manifatturiero aumenta la dotazione di risorse produttive a seguito di investimenti provenienti dall’esterno e di migrazioni di lavoratori da altre regioni e dal settore agricolo. CONCLUSIONI: la prima risiede nel fatto che la mobilità di entrambi i fattori produttivi avviene ora verso la stessa regione, caratterizzata da elevati salari; la seconda conclusione afferma che il modello prevede una tendenza alla divergenza nei tassi di crescita del reddito tra regioni. Il ruolo del settore agricolo in questo modello è duplice: da un lato fornisce lavoro al settore esportatore, riducendo gli effetti divergenti dei tassi di crescita, dall’altro diviene, nel processo di crescita, un settore a domanda di lavoro crescente, catalizzatore di forza lavoro esterna. CAP. 7: COMPETITIVITA’ TERRITORIALE E SVILUPPO ESOGENO 1. GLI ELEMENTI DELLA COMPETITIVITA’ TERRITORIALE Uno degli elementi di discontinuità con le teorie fin ora presentate riguarda la concezione di spazio: se in precedenza con il termine spazio si identificavano entità territoriali considerate omogenee e uniformi al loro interno, con lo stesso termine si intende ora uno spazio diversificato, che permette di concepire una distribuzione spaziale disomogenea delle attività e dei fattori produttivi, della domanda, della struttura settoriale e di evidenziare nuove relazionalità territoriali. Questa concezione di spazio consente di recuperare uno dei principi ispiratori delle teorie della localizzazione, le economie di agglomerazione, e di considerarle la fonte del processo di sviluppo locale. Si assume una concezione più complessa dello spazio, basata sulle relazioni economiche e sociali che si instaurano in un territorio; da qui la definizione di spazio diversificato-relazionale. Inoltre si passa da un approccio macroeconomico e macroterritoriale a uno microterritoriale e microcomportamentale. Nelle teorie che si andranno ad analizzare si incontra una nuova concezione di sviluppo, abbandonando la concezione di breve periodo, di semplice aumento del reddito e dell’occupazione così come quella del benessere individuale, per assumere una concezione di più lungo periodo, identificando tutti quegli elementi tangibili e intangibili del contesto locale che ne definiscono la competitività nel lungo periodo e che permettono al sistema di conservare tale competitività nel tempo. Le teorie che qui si analizzano sono alla ricerca degli elementi che garantiscono processi produttivi a costi e a prezzi relativamente meno elevati; questi elementi sono identificati a volte in elementi esogeni al contesto locale, che nascono al di fuori dell’area e che sono trasferiti in loco casualmente o deliberatamente attraverso precise politiche a supporto dello sviluppo locale, e a volte in elementi endogeni, che si sviluppano nell’area stessa. Fanno parte degli elementi esogeni, la presenza in loco, casuale, di un’impresa dominante o di una multinazionale o la realizzazione di nuove infrastrutture decise da autorità esterne; fanno parte degli elementi endogeni la capacità imprenditoriale, le risorse produttive locali ecc.Parlando di sviluppo, mentre nelle teorie del modello neoclassico di crescita interregionale si prevede che il tasso di crescita nazionale sia determinato esogenamente, e il problema della teoria dello sviluppo regionale era quello di determinare come questo incremento andasse distribuito tra le regioni. Con le teorie che invece si trattano ora, si entra nell’ottica di uno sviluppo generativo, nel quale il tasso di crescita nazionale è il risultato della somma dei tassi di crescita realizzati dalle singole regioni: lo sviluppo economico nazionale può aumentare grazie a una crescita più elevata registrata in un particolare contesto territoriale, e questa crescita può anche avvenire in presenza di rendimenti crescenti, a parità di risorse. 2. LA TEORIA DEI POLI DI SVILUPPO 2.1. L’APPROCCIO ECONOMICO: IL CONTRIBUTO DI PERROUX La prima teoria che abbandona l’ottica di spazio uniforme-astratto per concepire uno spazio diversificato-relazionale è la teoria dei poli di sviluppo, presentata nel 1955 da Perroux. Egli disse che lo sviluppo non si verifica ovunque e simultaneamente, ma si manifesta in alcuni punti o poli di sviluppo con intensità variabile, e si diffonde per vari canali e con effetti finali variabili per il complesso dell’economia. Perroux elabora una teoria dello sviluppo locale che concepisce una crescita selettiva in alcuni punti dello spazio, nei quali è presente un elemento propulsivo che mette in moto il processo di sviluppo. Questo elemento è identificato nella presenza casuale nell’area di un’impresa dominante, detta industria motrice, chiamata così per la sua capacità di influenzare con le sue scelte di investimento, il livello di investimenti delle imprese a esse collegate. Di fronte a un’innovazione tecnologica dell’impresa motrice, che abbassa i prezzi del bene o ne aumenta la quantità, la domanda esterna del bene prodotto aumenta, stimolando un aumento della sua produzione, che a sua volta genera un polo di sviluppo, attraverso una serie di effetti positivi, quali: - un effetto moltiplicativo keynesiano sul reddito, dove l’aumento di produzione dell’impresa dominante genera un aumento dell’occupazione nella stessa e in altre imprese e un conseguente aumento del reddito e consumi; -un effetto moltiplicativo leontieviano, legato agli effetti input-output intersettoriali, dove le imprese e i settori a monte dell’impresa dominante vedono espandere la loro produzione e i loro mercati di sbocco; - un effetto di accelerazione sugli investimenti delle imprese; - un effetto di polarizzazione che genera il polo di sviluppo, dove l’aumento della domanda di beni intermedi e di servizi </p></div></div><div><div><p>che si genera dall’impresa motrice attrae impresa verso localizzazioni prossime all’impresa chiave con l’obiettivo di minimizzare i costi di trasporto , sfruttare infrastrutture e capitale fisso sociale attivati dal polo, migliorare la professionalità e capacità manageriali o imprenditoriali locali, sfruttare la maggior domanda degli occupati. Questa teoria ha quindi in sé degli elementi importanti per l’interpretazione dello sviluppo, come l’importanza nel processo di sviluppo, delle infrastrutture, dei servizi e delle relazioni input-output tra imprese e tra settori, gli effetti positivi di una crescita della domanda sul livello di investimenti e i meccanismi moltiplicativi keynesiani del reddito. Ciò che cambia è l’ottica con la quale questi elementi sono concepiti, passando a un’ottica microeconomica e microcomportamentale: lo sviluppo è generato dal dinamismo di un’impresa e dai suoi legami con altre imprese, e il processo cumulativo di crescita è il risultato di reazioni comportamentali razionali dei diversi soggetti coinvolti nell’attività dell’impresa dominante. 2.2. L’APPROCCIO TERRITORIALE: IL CONTRIBUTO DI BOUDEVILLE La teoria del polo di sviluppo manca di una dimensione territoriale. Nel 1968 Boudeville si pone l’obiettivo di enfatizzare all’interno della teoria dei poli di sviluppo, proprio l’elemento spaziale, territoriale, definendo chiari confini geografici agli effetti positivi generati dall’attività dell’industria motrice, alla base dello sviluppo. Egli identifica 3 modi di definizione dei confini geografici degli effetti di polarizzazione, attraverso differenti ipotesi sulla localizzazione geografica dei soggetti coinvolti nel processo di sviluppo o sulla geografia degli effetti positivi di trascinamento: - la prima ipotesi riguarda una localizzazione geograficamente clusterizzata dell’impresa motrice e delle imprese a essa collegate; - la seconda ipotesi suppone una localizzazione urbana dell’impresa motrice, dove le relazione input-output che generano sviluppo si attivano nell’area urbana stessa; - la terza ipotesi riguarda la ricaduta locale degli effetti positivi che si generano dal comportamento dell’impresa dominante, cioè il polo di sviluppo si genera quando gli effetti positivi della presenza di un’impresa dominante rimangono all’interno dell’area stessa. Le 3 interpretazioni hanno una caratteristica in comune: l’elemento fondamentale del processo di sviluppo non è più come in Perroux la sola interdipendenza settoriale, infatti perché vi sia sviluppo economico locale, a questa si deve aggiungere una concentrazione spaziale delle attività produttive sul territorio che determina l’effetto finale positivo della presenza dell’impresa dominante sullo sviluppo locale. 2.3. VALUTAZIONI CRITICHE Un primo limite riguarda la mancanza di una chiara interpretazione delle ragioni della presenza iniziale dell’impresa motrice nell’area, assunta esogenamente. La teoria del polo non è quindi in grado di distinguere tra gli effetti di un polo naturale e quelli di un polo pianificato. Perché si parli di polo è necessario che la grande impresa, o il complesso industriale, siano in realtà inseriti in una filiera produttiva molto ampia, con un forte indotto locale, tale per cui un investimento dell’impresa dominante sia in grado di generare effetti moltiplicativi molto consistenti, e in questo effetto addizionale è contenuta la definizione di polo. Un secondo limite della teoria dei poli di sviluppo è quello di aver volutamente ignorato gli aspetti negativi che accompagnano la realizzazione di un polo, e di aver posto l’accento solo sugli aspetti positivi, accentuando le aspettative di successo nella creazione di un polo. La localizzazione di una grande impresa in un’area causa prima un effetto di spiazzamento di attività produttive locali, spesso artigianali, con un sensibile effetto negativo sul livello di occupazione locale come risultato di uno shock della creazione della grande impresa sulla struttura dei prezzi e dei salari. Là dove avviene questo effetto di spiazzamento, la realizzazione della grande impresa è ben lungi dal creare reddito e occupazione, almeno nel breve-medio periodo. Osservando la fig.7.1 si può notare come gli effetti positivi tendono a generarsi nel lungo periodo, una volta superate le resistenze iniziali e instaurarsi i legami tra l’impresa dominante e le attività locali, mentre gli effetti negativi, che si presentano molto accentuati nel primo periodo, si attenuano successivamente, allorquando l’economia locale si riorganizza intorno alla grande impresa; il risultato si configura in un andamento degli effetti netti (i net spillover effects) dapprima molto negativo, per divenire positivo successivamente, quando il decollo degli effetti favorevoli allo sviluppo è in grado di assorbire gli elementi negativi. 4. LA DIFFUSIONE SPAZIALE DELL’INNOVAZIONE 4.1. IL MODELLO DI HAGERSTRAND: LA DISTANZA GEOGRAFICA L’innovazione si manifesta in tempi e modi del tutto diversi nelle diverse aree, divenendo un’importante fonte di spiegazione della diversa capacità di crescita di una regione, una fonte che riesce a spiegare il processo di crescita dell’output che non può essere direttamente attribuito a un aumento dei fattori della produzione, in presenza di equilibrio e rendimenti di scala costanti. L’innovazione ha un ruolo importante nella spiegazione della crescita. In un primo approccio si concepisce l’innovazione come fattore esogeno di sviluppo che attraverso canali e percorsi territoriali specifici, arriva in un territorio e in esso genera gli effetti positivi. L’interesse dell’analisi si concentra quindi sui modelli di diffusione spaziale dell’innovazione. Il più noto è quello di Hagerstrand , il quale contiene l’idea di fondo che lo sviluppo temporale di un’innovazione segua un andamento sigmoide, ad S, ben rappresentato da una funzione logistica e che le fasi del ciclo temporale debbano essere unite a quelle spaziali, dando vita a una diffusione spazio-temporale dell’innovazione in 3 stadi: - lo stadio primario di adozione, dove l’innovazione si diffonde lungo la gerarchia urbana; - il secondo stadio della diffusione, dove agiscono contemporaneamente con pesi diversi, a seconda del momento temporale, l’effetto gerarchico e l’effetto a macchia d’olio; - lo stadio di saturazione, dove la diffusione spaziale dell’innovazione è casuale. Nel modello i meccanismi che guidano la diffusione sono a carattere epidemico: la pura probabilità di contatto tra i soggetti che hanno già adottato l’innovazione e i potenziali adottatori spiega la diffusione dell’innovazione, assumendo che ogni potenziale adottatore abbia la stessa opportunità di adozione. L’uso di una funzione logistica è accettabile solo nell’ipotesi di uguale probabilità che i potenziali adottanti adottino effettivamente l’innovazione. L’elemento che rende inaccettabile quest’assunzione è l’elemento spaziale: esso infatti non trova in questo modello un ruolo significativo se non quello della pura distanza geografica tra adottatori reali e potenziali. 4.2. GRILICHES E MANSFIELD: LA DISTANZA ECONOMICA Griliches e Mansfield pongono l’attenzione sulle caratteristiche spaziali che determinano il processo di adozione, introducendo all’interno del modello di Hagerstrand l’idea che la diffusione spaziale dell’innovazione sia influenzata non tanto dalla distanza geografica tra gli adottatori quanto dalla distanza economica: livello di attività produttive presenti nell’area, livello di reddito, di consumi, di investimento possono spiegare facilmente la maggiore ricettività di un’area di adozione. Essi formulano una metodologia di analisi empirica della diffusione dell’innovazione in 2 stadi. Il primo stadio prevede la stima della funzione logistica: dove D rappresenta la densità di adozione, a il momento temporale in cui avviene la prima adozione, b la velocità di adozione, e K l’asintoto al quale la curva tende, cioè il numero potenziale di adottatori che l’innovazione può raggiungere. Il secondo stadio prevede attraverso un’analisi cross section interregionali, la stima dell’incidenza delle principali caratteristiche strutturali dell’economia locale sul momento storico di adozione, sulla velocità di penetrazione e sul livello di saturazione dell’innovazione, restituendo una chiara fotografia dei differenti sentieri spaziali di adozione dell’innovazione. CAP. 8: COMPETITIVITA’ TERRITORIALE ESVILUPPO ENDOGENO: LE ECONOMIE DI AGGLOMERAZIONE 1. LE ECONOMIE DI AGGLOMERAZIONE Fino ad ora lo spazio ha assunto due ruoli distinti all’interno dei modelli e delle teorie: da un lato un ruolo di barriera fisica e dall’altro lato un ruolo di contenitore fisico dello sviluppo, di semplice area geografica, spesso associata alla regione amministrativa. In entrambi i casi lo spazio risulta del tutto passivo nella determinazione del sentiero di crescita dell’economia locale. In questo capitolo la concezione dello spazio cambia radicalmente, infatti non è più semplice contenitore geografico dello sviluppo, ma risorsa economica e fattore produttivo autonomo, generatore di vantaggi statici e dinamici per le imprese ed elemento fondamentale nella determinazione della competitività del sistema produttivo locale. Lo spazio diviene fonte di rendimenti crescenti, di esternalità positive, nella forma di economie di agglomerazione e di localizzazione. Questa nuova concezione di spazio porta delle implicazioni: in primo luogo lo spazio non può che essere uno <b>spazio diversificato</b>, nel quale sia facile distinguere l distribuzione disomogenea delle attività. Al contempo è uno spazio relazionale, in quanto le relazioni economiche e sociali che si instaurano in un territorio assumono un ruolo strategico a supporto di un funzionamento più efficace dei meccanismi di mercato, di produzione più efficienti e meno costosi, di sedimentazione di conoscenze nel mercato locale. Inoltre con la nuova concezione di spazio risulta impossibile restare ancorati a una visione di sviluppo esogeno, infatti lo sviluppo è per definizione endogeno, dipendente da un’organizzazione concentrata sul territorio, sulla quale si sviluppa un sistema socio-economico e culturale a supporto del successo dell’economia locale, come capacità imprenditoriale, risorse produttive locali, capacità relazionali degli attori locali che danno luogo a processi cumulativi di conoscenze locali ecc. 2.1 IL DISTRETTO INDUSTRIALE MARSHALLIANO Negli anni 70 si impone il miracolo della Terza Italia, in cui le regioni nordorientali e centrali italiane inaspettatamente presentarono tassi di crescita elevati in un periodo caratterizzato da una crisi economica generalizzata. Numerose indagini di studio, conducono a una teorizzazione degli elementi sui quali si innesta il successo economico di queste aree, tutte accomunate da un’elevata concentrazione di imprese di piccole dimensioni, da imprenditorialità locale, e sistema agricolo. Studi sui fattori di successo sono stati affiancati da indagini sulla flessibilità dei mercati del lavoro locale, che consentono una rapida e facile mobilità del lavoro tra imprese. Quest’importante teoria è quella del distretto industriale marshalliano: a esso ci si riferisce quando in una determinata località è presente una concentrazione di piccole e medie imprese, ciascuna delle quali è specializzata sia in una o poche fasi del processo produttivo di uno stesso settore, sia in attività a queste sussidiarie, ovvero rivolte alla produzione di beni e servizi che soddisfano le necessità del settore principale che opera nell’area. L’organizzazione economico-produttiva del distretto basa le sue radici in un sistema sociale e culturale di valori comuni che penetra e struttura il funzionamento del mercato. Le condizioni genetiche affinché un territorio possa essere definito un distretto industriale si identificano in: - prossimità spaziale, cioè vicinanza geografica tra imprese; -prossimità sociale, cioè la presenza di un sistema di istituzioni, codici e regole condivisi dall’intera comunità che intervengono e agiscono sul modo di funzionamento del mercato; - concentrazioni di piccole imprese, caratterizzate da flessibilità produttiva; - marcata specializzazione industriale dell’intera area, nella quale sono presenti le fasi della filiera produttiva. 2.2. LE ECONOMIE DI DISTRETTO Dalla compresenza delle condizioni economico-territoriali che sono state descritte si generano rendimenti nella forma di economie di agglomerazione, dette anche economie di localizzazione o economie di distretto, definite come quei vantaggi che le imprese ottengono dalla prossimità con altre attività appartenenti allo stesso settore in termini di riduzione dei costi o aumento di efficienza produttiva. Le economie di distretto si manifestano e si concretizzano attraverso: - la riduzione dei costi di produzione: nelle aree industriali, l’esistenza di numerosi fornitori, altamente specializzati, riduce i costi di trasporto per l’acquisto di beni intermedi; un mercato del lavoro locale con elevati livelli di elasticità, cioè rapidi e agevoli aggiustamenti della forza lavoro che agisce anch’esso sui costi di produzione, riducendoli. Inoltre anche il ricorso al mercato, permette di attingere a manodopera esterna all’impresa e soprattutto assicura l’esternalizzazione delle fasi di produzione più complesse e costose, riducendo così i costi. - la riduzione dei costi di transazione, cioè quelli che accompagnano le transazioni economiche. La prossimità geografica che caratterizza il mercato distrettuale facilita l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ma ancor più agisce la prossimità sociale, ossia il sistema di regole di comportamento comune. La prossimità sociale riduce in modo sensibile il costo delle transazioni e del ricorso al mercato. Dal senso di appartenenza a una comunità specifica e dall’identità sociale che pervadono la società nel distretto scaturiscono rapporti di fiducia e di stima, che alimentano la cooperazione interindustriale nella forma di contratti informali. Infine, la forte specializzazione delle imprese garantisce a queste ultime il know-how tecnico-scientifico per un efficiente ed efficace valutazione delle prestazioni della vasta gamma di fornitori presenti nell’area; - l’aumento dell’efficienza dei fattori produttivi, cioè, a parità di risorse produttive, il sistema di valori sociali comuni, la concentrazione spaziale di imprese specializzate e la ridotta dimensione agiscono sulla capacità di produzione delle imprese, facendo registrare, a parità di risorse, un aumento dell’efficienza dei fattori produttivi. La prossimità sociale è fonte di quella che è stata definita da Marshall “l’atmosfera industriale”, una cultura industriale diffusa, costituita dall’insieme di quegli elementi intangibili indivisibili, appartenenti al sistema produttivo nel suo complesso, come lo spirito imprenditoriale, di cooperazione, conoscenze tecniche locali sul ciclo produttivo, che rendono le imprese a parità di altre condizioni, maggiormente produttive, conducendole ad un aumento di efficienza complessiva, che si manifesta in un aumento dei ricavi e dei profitti. – l’aumento dell’efficienza dinamica, intesa nel senso della capacità innovativa delle imprese del distretto, dove si sottolinea l’importanza della conoscenza cumulata a livello locale come elemento determinante il livello di capacità innovativa delle imprese. 2.3. OLTRE LE ECONOMIE DI DISTRETTO Le economie di distretto sono generate e rafforzate da elementi di contesto, economico e sociale. 1) il primo è il legame tra aspetti economici, territoriali e sociali. Infatti un semplice cluster di piccole imprese non costituisce di per se un distretto industriale ed inoltre, la prossimità sociale, si presenta come elemento tipico del distretto; essa penetra e struttura il mercato intorno a regole ben precise favorendone il buon funzionamento e garantendone l’efficienza. 2) il secondo elemento si riferisce al reciproco integrarsi di forme di cooperazione e di concorrenza, infatti nonostante la cooperazione, forme di accesa concorrenza sono presenti tra le imprese del distretto; essa infatti è la forza vitale delle imprese distrettuali, obbligate a mantenere elevati livelli qualitativi dei beni, a innovare le tecniche produttive e a rinnovare la quantità dei prodotti nel tempo. Al contempo forme di cooperazione esplicita caratterizzano il mercato, regolate da norme sanzioni sociali che bandiscono comportamenti opportunistici: nelle transazioni che avvengono tra soggetti economici, la reputazione diviene un capitale personale, a tutela della sopravvivenza dell’attività sul mercato. Infine, la presenza di una struttura di governance, ossia di agenti locali e di istituzioni, a supporto del sistema di regolazione delle transazioni agisce a salvaguardia del buon funzionamento del mercato comunitario, esercitando un sostegno esplicito alle forme di cooperazione e concorrenza. 2.4. ALCUNE CONSIDERAZIONI CRITICHE Il grande pregio della teoria del distretto industriale risiede nell’aver concettualizzato un ruolo attivo dello spazio all’interno dello sviluppo economico a di aver arricchito il puro concetto di economie di agglomerazione attraverso elementi a carattere sociale, psicologico e culturale. Occorre però richiamare alcuni elementi di debolezza presenti nell’impianto logico-concettuale della teoria distrettuale. In primo luogo, questo approccio è caratterizzato da un’evidente tendenza a far prevalere gli elementi di novità e discontinuità e sottovalutare quanto già evidenziato in precedenti teorie. Si allude qui alla forte enfasi posta sugli aspetti endogeni della teoria dei distretti industriali e alla tendenza a trascurare del tutto gli elementi esogeni e oggettivi che accompagnano il sentiero di sviluppo, come le condizioni macroeconomiche e macroterritoriali in cui l’economia delle singole aree si trova inserita. Un secondo limite della teoria dei distretti è riferito al quadro statico e alla tendenza al descrittivismo ex post dei fenomeni spaziali di cui è permeata. Se infatti essa è riuscita in modo soddisfacente ad individuare il vantaggio relativo della Terza Italia non altrettanto è riuscita a fare per le determinanti della crescita e della dinamica di queste aree, della loro capacità di affrontare la crescente concorrenza mondiale, i rapidi cambiamenti tecnologici, i feedback negativi, nella forma di scarsità di manodopera, di crescita del costo del lavoro e dei fattori produttivi, di congestione fisica e infrastrutturale che il successo economico genera. Un ulteriore elemento di debolezza è l’eccessiva enfasi posta sul concetto di specializzazione e di flessibilità, la flessibilità, caratteristica della piccola impresa e di un modello di organizzazione della produzione postfordista, si presenta oggi come elemento caratterizzante anche della grande impresa; inoltre, allo stesso modo le economie esterne che si addicono all’interpretazione dei rendimenti crescenti delle imprese distrettuali, nascono e si sviluppano anche in contesti metropolitani, sedi delle grandi imprese. 3. LA STRUTTURA URBANA E LO SVILUPPO REGIONALE Negli anni 90 si pose enfasi sull’idea che un’efficiente, moderna e avanzata struttura urbana, capace di crescere in modo equilibrato rispettando obiettivi di equità, competitività e sostenibilità, determini il successo economico di un territorio. Secondo questa visione, lo sviluppo regionale scaturisce in modo sostanziale da un’equilibrata crescita delle singole città, fonti di rendimenti crescenti per chi vi opera e vi risiede, e del sistema di città nel quale ogni singola città è inserita. Ogni città deve trovare un sentiero di crescita che rafforzi gli elementi dai quali scaturisce la sua efficienza statica e dinamica; questa crescita deve innestarsi in un sistema di città, a sua volta in grado di svilupparsi in modo armonioso e bilanciato, con un’equa distribuzione di centri urbani ben collegati. La città è un cluster spaziale di attività produttive e residenziali: la concentrazione delle attività, la densità di contatti che in essa si sviluppano, il facile accesso a informazione e conoscenza avanzata, si pongono come elementi di vantaggio che scaturiscono da una localizzazione urbana, e che si contrappongono alle economie di localizzazione, o di distretto, in quanto si rivolgono ad un mix di settori. Un’altra interpretazione è stata di recente data alle città come un luogo che svolge la cruciale funzione di riduzione di incertezza dinamica e di creazione di processi di apprendimento collettivo, a vantaggio degli attori locali. Tuttavia non è solo nell’efficienza della singola città che si coglie l’effetto del sistema urbano sullo sviluppo economico regionale; così come ci insegnano i padri dell’equilibrio spaziale generale e della struttura dei sistemi di città, un sistema urbano ben bilanciato, con un’equilibrata presenza di città grandi, medie e piccole, armoniosamente dotate di reti di trasporto efficienti, diviene un sistema territoriale ideale in termini di efficienza e benessere. Sempre restando nella logica dei sistemi di città, un importante contributo teorico all’efficienza dinamica che da esso scaturisce è facilmente individuabile nella teoria delle reti di città. Un’organizzazione a rete dei centri, ordinati gerarchicamente o di simile dimensione, è fonte di evidenti vantaggi dinamici associati, tra l’altro, alla cooperazione innovativa, necessaria alla realizzazione dei progetti innovativi. 4. ECONOMIE DI AGGLOMERAZIONE: DIMENSIONE, PRODUTTIVITA’ E CRESCITA URBANA 4.1. LA DIMENSIONE OTTIMA DELLA CITTA’ Le città sono per definizione fonti di economie di agglomerazione per imprese e famiglie, nella forma di economie di urbanizzazione. In città le attività produttive godono di vantaggi dettati dalla presenza di capitale fisso sociale, di servizi avanzati per le imprese, di un vasto e diversificato mercato dei beni intermedi e finali, che aumentano al crescere della dimensione fisica della città. I vantaggi aumentano con l’aumentare della dimensione della città; come effetto della presenza di questi vantaggi, i fattori produttivi capitale e lavoro registrano livelli di produttività più elevati, a parità di rapporto capitale/lavoro, in città grandi rispetto alle piccole. La presenza di città in grado di ottimizzare l’efficienza statica, di sfruttare le economie di agglomerazione che generano e di crescere lungo percorsi virtuosi cumulativi risulta di grande importanza per la dinamica della regione stessa. La teoria della dimensione ottima della città (Alonso) studia l’andamento dei vantaggi e dei costi di localizzazione per diverse dimensioni della città: essa sottolinea che le economie di agglomerazione esistono fino a una certa soglia dimensionale della città, oltre la quale si mettono in moto meccanismi opposti che tramutano gli elementi da positivi a negativi, da economie a diseconomie. A questi si aggiungono, da una certa soglia dimensionale in poi, costi di localizzazione crescenti che diminuiscono così ulteriormente il vantaggio netto della grande dimensione. Secondo questa teoria le curve dei benefici e costi medi di localizzazione urbana, hanno un andamento ad U: le curve di beneficio prima crescono per poi decrescere, le curve di costo diminuiscono per poi aumentare. È possibile identificare molte dimensioni critiche della città, tra le quali le più significative riguardano: - una dimensione minima per l’esistenza della città (A), allorquando i costi medi di localizzazione uguagliano i benefici medi di localizzazione; - una dimensione ottima per chi già abita in città (B), in corrispondenza della massima distanza tra benefici e costi medi; - una dimensione ottima per l’intera collettività (C), quando i benefici marginali e dunque il vantaggio di un’ulteriore espansione è esattamente bilanciato dai nuovi costi; - una dimensione massima della città (D), dove i benefici medi sono inferiori ai costi medi. Ricordiamo in breve i tre metodi con i quali si verifica l’esistenza di economie di agglomerazione: a) la stima di una funzione di produzione urbana aggregata, sulla quale verificare l’esistenza di economie di scala, attraverso un’analisi econometrica che stimi l’esistenza di una costante moltiplicativa legata alla dimensione urbana; b) la stima di una funzione di produzione urbana per singolo settore, con l’obiettivo di verificare l’esistenza di una maggiore produttività fattoriale in settori localizzati in città a più alta concentrazione industriale; c) l’analisi diretta dei differenziali di reddito e di salario, corretti per le differenze nel costo della vita, fra grandi e piccole città. La grande città dovrebbe mostrare più alti salari reali, per effetto di più elevate produttività. CRITICHE ALLA DIMENSIONE OTTIMA DELLA CITTA’: - Le città sono diverse tra loro, svolgono produzioni differenti, a diverso livello di complessità e specializzazione. Esistono quindi diversi livelli di ottimo a seconda delle caratteristiche delle città; - le città producono in un contesto interurbano che ne influenza l’efficienza; - le città generano esternalità legate in larga misura alle caratteristiche qualitative del tessuto produttivo urbano più che alla mera dimensione, e quindi, il maggior potenziale di crescita delle città scaturisce da una struttura maggiormente concorrenziale e diversificata, adatta a generare esternalità alle piccole imprese, rispetto a una struttura oligopolizzata e specializzata nella quale i processi di internalizzazione delle funzioni di servizio operate dalle grandi imprese impoveriscono l’ambiente urbano. 4.3. ECONOMIE DI AGGLOMERAZIONE E CONTESTO SPAZIALE: L’APPROCCIO GEOGRAFICO Qualora si ipotizzi che a dimensioni urbane maggiori siano associati livelli di produttività e di efficienza più elevati, non si spiega come le città di piccole dimensioni possano registrare tassi di crescita più elevati di quelli delle città grandi. Quando il fenomeno della maggior crescita delle città mediopiccole rispetto alle grandi è interpretato attraverso l’esistenza di diseconomie di agglomerazione associate alle città grandi, come vuole la teoria della dimensione ottima della città, nuove perplessità emergono circa la mancanza di una spiegazione teorica forte del perché in un preciso momento temporale le città grandi entrino in fase di rendimenti decrescenti. Nella metà degli anni 2000 un approccio a carattere geografico suggerisce nella prossimità spaziale tra città la spiegazione dell’incremento di produttività delle città piccole; esse si avvantaggiano di economie di agglomerazione delle grandi città a loro prossime, o della massa critica di tante città piccole a loro prossime, raggiungendo anche con dimensioni ridotte, livelli di produttività associati a dimensioni urbane maggiori. Anche nel caso opposto, grazie alla vicinanza geografica con grandi città, le città di dimensione ridotta si trovano limitate nelle possibilità di creare nuove funzioni e pertanto di crescere, perdendo vantaggi agglomerativi piuttosto che acquisirli. Definiti effetti ombra, gli svantaggi di vicinanza ad altre agglomerazioni, sono interpretati come gli elementi regolatori della formazione dei sistemi di città; per evitare il rischio di elevata competizione, le nuove aree urbane vengono a formarsi a una distanza tale da evitare competizione con città già esistenti, di simile o più grande dimensione, riprendendo la logica del modello di Christaller. L’approccio geografico ipotizza l’assenza di una soglia oltre la quale le economie di agglomerazione si traducono in diseconomie; qualsiasi dimensione la città raggiunga, essa gode di rendimenti crescenti. Eppure, la città è soggetta a rendimenti decrescenti, una situazione che trova una spiegazione teorica quando il vero motore dello sviluppo urbano è identificato non tanto nei benefici lordi di localizzazione, ottenuti una volta scontati i costi di localizzazione, che gli individui e le imprese basano le loro scelte localizzative, e un pianificatore benevolente le sue scelte di pianificazione. 4.4. ECONOMIE DI AGGLOMERAZIONE DINAMICHE E CRESCITA URBANA: L’APPROCCIO MACROTERRITORIALE Un recente approccio a carattere aggregato (macroterritoriale) riconduce l’analisi teorica della dinamica urbana alla ricerca delle determinanti che possono spiegare le economie di agglomerazione dinamiche, intese come la crescita nel tempo della produttività legata alla dimensione urbana. La crescita urbana avviene quando si presentano incrementi nei vantaggi di localizzazione, ossia quando la produttività urbana aumenta nel tempo, rendendo la città realmente più attrattiva. L’interpretazione della dinamica urbana si sposta quindi sull’interpretazione della dinamica della produttività che, nella logica dell’approccio, non dipende dalla sola dimensione urbana. Ragionando sulla base di una gerarchia urbana semplificata per 3,4 classi dimensionali, si può ritenere che le città, indipendentemente dalla loro classe dimensionale, possano sperimentare una battuta d’arresto nel loro processo di crescita e persino un calo, in assenza di fattori condizionanti l’incremento di efficienza urbana. Ogni città può avere un processo regolare di crescita, e gli elementi che permettono alla città di evitare di entrare in un regime di diseconomie di scala devono essere ricercati nella capacità della città di saltare su nuove e più avanzate attività e funzioni, di collaborare con altre città e sfruttare il loro sistema urbano, se dinamico ed efficiente. Analisi empiriche dimostrano come la pura dimensione fisica della città non sia capace di spiegare la dinamica della produttività e pertanto la crescita urbana. Ciò dimostra come non sono le grandi o piccole città a crescere di più ma le città in grado di innovare nelle loro funzioni e rinnovare la loro cooperazione con il sistema urbano nel quale sono inserite. 4.5. ECONOMIE DI URBANIZZAZIONE VS ECONOMIE DI LOCALIZZAZIONE Le città sono per definizione fonti di economie dettate dalla varietà e dalla ricchezza di vasti mercati di beni e servizi, di numerose opportunità di lavoro, di diversi stili di vita, di servizi avanzati per imprese e famiglie, tutti vantaggi definiti come economie di urbanizzazione. Tuttavia a partire dagli anni 70, si è sviluppato un dibattito circa la comprensione dell’importanza relativa della diversificazione rispetto alla specializzazione settoriale come fonti di maggiori rendimenti per una città. I vantaggi che scaturiscono da economie fortemente specializzate, in cui il settore di base, così chiamato da Hoyt, è facilmente identificabile e fonte di economie di localizzazione di tipica tradizione marshalliana vengono misurati e paragonati con i vantaggi che nascono in città diversificate, nelle quali le imprese possono godere della presenza di un mix di settori, di un ampio mercato dei beni finali e di fattori produttivi, di servizi avanzati, di quelle pertanto note come economie di diversificazione o di urbanizzazione. Secondo la tradizione marshalliana, le imprese localizzate in città specializzate possono avvantaggiarsi di riduzione dei costi di produzione grazie all’aumentare della dimensione del settore presente nell’area: le fonti di vantaggio, che aumenta all’aumentare del settore, risiedono in un mercato degli input specializzato