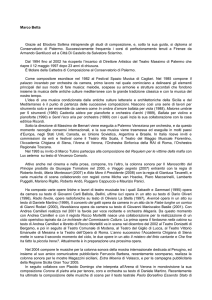caricato da
serrachiaraletizia
L'Opera Italiana del Novecento: Saggio di Piero Mioli

PIERO MIOLI L'OPERA ITALIANA DEL NOVECENTO MANZONI MILANO, 2018 PREMESSA Cento anni: così Giuseppe Rovani volle intitolare il suo grande romanzo storico-ciclico, narrando vicende comprese fra il 1750 e il 1849 e fra l’altro largheggiando di curiose situazioni e riflessioni musicali (l’edizione definitiva del libro è del 1868-69); e così dovrebbe pur chiamarsi questo sommario panorama del '900 teatro-musicale italiano, nonostante tutti gli imbarazzi che presiedono a tali quadrature cronologiche e tutti i rischi che esso corre fornendo forse più dati che idee. Cent’anni, un secolo, un lungo segmento temporale tutto sommato finito da poco: ma se la fine di questo fatidico '900 si trova a sfumare nell’inizio del secolo seguente, il '100 del Duemila che è in corso, altrettanto si deve riconoscere oggi e si sarà asserito allora del suo inizio sfumato dalla fine del secolo precedente. Nell’impossibilità, dunque, di fissare un avvio riferibile a un preciso fattore di carattere sociale, civile, culturale, per non dire artistico e musicale, sarà provvedimento modesto e rassegnato ma almeno utile e chiaro quello che accetta di dare l'inizio al semplicissimo 1901 e la fine all'altrettanto schietto 2000, permettendosi il credibile lusso di procedere qualche anno ancora. L’imbarazzo non viene a mancare, s’intende, né s’abbassa il rischio, ma da parte sua, almeno, la matematica non ammette né repliche né sfumature. Prima di pervenire al corpo del discorso diacronico, descrittivo, impostato insomma come una giusta suddivisione in periodi, è però sembrato bene fornire degli schizzi storico-culturali che sappiano inquadrare degnamente, si spera, le fasi storiche del genere, un genere significativo ma assai esigente come il teatro d’opera italiano: dunque il diverso “panorama” sincronico promesso dall’indice comprende gli elementi generali, alcuni fenomeni particolari, i luoghi teatrali nel loro complesso e qualche teatro in vista più di altri, ovviamente e principalmente le prime culle della nuova produzione operistica. Ma ecco l’attesa serie degli autori e delle opere, cioè la parte più tradizionale, sostanziosa, importante della trattazione. Dal vecchio Puccini ai giovani compositori che hanno appena fatto capolino sulle finestre del palcoscenico, la serie vuole essere semplicemente temporale, determinata soprattutto dall’anno di nascita, con tutti gli andirivieni voluti dalla varia maturità e operosità dell’uno e dell’altro. Sono quattro le parti del discorso centrale, molto all’incirca corrispondenti a quarti di secolo, che si presentano tutte come segue: un folto notiziario prima storico e poi cultural-artistico, una cronologia operistica nuda e cruda (nascite e morti, premières e riprese, fatti ed eventi diversi), alcune monografie sui grandi compositori, alcuni schizzi su altri compositori. In un percorso così lungo e prevedibilmente ricco, complesso, accidentato, va da sé che si riproponga il problema insolubile della suddivisione, dell’inizio e della fine delle singole parti e particelle, né le brevi somme di due o tre decenni corrispondenti alle generazioni vanno esenti dalle incertezze delle somme maggiori costrette nei limiti del secolo. Per cominciare a tirare le somme, un'altra parte di carattere generale riguarda quei tanti “personaggi” del mondo dell'opera che sono i mediatori, gli interpreti, gli esecutori, dai direttori ai cantanti, dai registi alle case discografiche eventualmente devote all’opera del '900. Per finire sul serio, una doppia bibliografia: una, che costituisce la settima e ultima parte del libro, è commentata, resa essenziale dallo schiacciante cumulo di informazioni oggi usuale che comporrebbe da sé un volume, e dopo un saggio panoramico si sofferma a lungo su Puccini (per sfumare poi in una discografia quanto mai essenziale, in fortunata linea con tutto quanto sia postverdiano e non pucciniano); e un'altra tradizionale, lunghetta sì ma non ragionata. E ora qualche riserva. Si dice sempre che la materia contemporanea sia la più vissuta e quindi anche la più scottante di tutte, da trattare: è verissimo, e tanto più in un ambito teorico, poetico, artistico come quello della musica classica che però è sempre anche pratico, quotidiano, inevitabilmente spettacolare. Inoltre, mentre la corrente storiografia musicale, più o meno vaga di antichità e barocchismi, si ritiene già meritoria se raggiunge il '900 pieno, storico, viennese, francese, russo e altro senza procedere oltre, un'esposizione più specifica come questa, ridotta di spazio (all’Italia) e di genere (al teatro), un tale lusso non se lo può permettere affatto e deve oltrepassare Stravinskij e Webern (dopo averli geograficamente aggirati) per raggiungere capisaldi chiamati Maderna, Nono, Berio, Manzoni, Bussotti, Sciarrino e Tutino; e siccome Nono è scomparso, prematuramente, nel 1990, nemmeno Nono deve considerarlo fra gli ultimi (nel tempo) e quindi procedere ancora, aggirandosi fra i compositori delle generazioni seguenti, quelle apparse fra gli anni '40 e '70. Sui musicisti del secondo e specie del tardo '900 il materiale informativo è molto, si sa, addirittura troppo e quindi disorientante: abbondano notizie biografiche, con nomi e date, luoghi e iniziative, ma scarseggiano le riflessioni critiche, e gli stessi compositori, chiamati a esprimersi a parole, sono spesso più generosi o fascinosi di parole allusive e generiche che di utili dati tecnico-estetici (per tacere di certi teatri, editori, rassegne concertistiche, festival, associazioni, gruppi che non diffondono capillarmente i loro cataloghi o programmi né corrispondono facilmente alle legittime aspettative di pubblico e critica) Cresciuto sopra una prima e diversa edizione del 2006 non abbastanza divulgata, questo libro, giova ripeterlo e precisarlo, è un testo che racconta la storia di un genere d’arte e (perché no?) d’uso lungo tutto un secolo in un paese piuttosto produttivo: nulla di meno e nulla di più. Come ha confini ideali coatti, così ha obbiettivi limiti di spessore, dicasi pur di pagine, onde cerca, perlustra, tratta, descrive ciò che ha trovato più chiaro e creduto più significativo (certo prendendo qualche cantonata, al positivo e al negativo); inoltre tenta anche dei collegamenti, delle suddivisioni, delle scelte, anche se qui deve arrendersi all’ardua sentenza dei posteri (non sulla qualità, effimera, ma sulla varia quantità del suo operato). Una soddisfazione? quella di aver compreso in un unico volume Puccini e Malipiero, Mascagni e Togni, Guarnieri e Battistelli, l’Adriana Lecouvreur di Cilea e l’Ulisse di Dallapiccola. Tanto, è sempre teatro, sempre musica, sempre Italia, sempre Novecento. P. M. Indice PREMESSA PRIMA PARTE. PANORAMA I. Qual risorta fenice novella 1. Un’espressione d’Italia 2. Mezzi di massa 3. Una fiammella tra vecchio e nuovo II. Locations 1. Quasi mille teatri 2. Tredici enti 3. E fondazioni 4. Alla Scala 5. Molto repertorio e un esempio 6. Teatri di tradizione III. Premières 1. Firenze a Maggio 2. Novità a Bergamo 3. Il faro della Biennale 4. Evviva Spoleto IV. Due RAI 1. Opera radiofonica 2. L’isola del tesoro 3. Passato d’oggi SECONDA PARTE. TRA VERO E SIMBOLO I. Dalla nebbia alla tempesta (1901-1922) 1. Due decenni d’Italia 2. Giolitti, Croce, le riviste 3. La prima guerra mondiale 4. Drammatiche conseguenze 5. Annales 1 II. Sinfonico Smareglia 1. Uno fra i tanti 2. Dal secolo prima 3. Oceana 4. Abisso 5. I pittori fiamminghi III. Puccini novellatore 1. Colleganza e poetica 2. Un abbozzo di biografia 3. Da Madama Butterfly a Turandot 4. Drammaticamente 5. Musicalmente IV. Il resto di Mascagni 1. Uomo di teatro 2. Le maschere 3. Isabeau 4. Parisina 5. Lodoletta 6. Il piccolo Marat 7. Nerone V. La tenacia di Alfano 1. Una vita operosa 2. Risurrezione 3. L’ombra di don Giovanni e Sakùntala 4. Cyrano di Bergerac VI. Il Medioevo per Zandonai 1. Una vita a sé 2. Conchita 3. Francesca da Rimini 4. Giulietta e Romeo 5. I cavalieri di Ekebù VII. Con il capolavoro 1. Cilea e Adriana Lecouvreur 2. Franchetti e Germania 3. Mancinelli e Paolo e Francesca 4. Montemezzi e L’amore dei tre re 5. Wolf Ferrari e I quatro rusteghi TERZA PARTE. PER UN MODERNISMO I. Ventennio (1923-1945) 1. Molte ombre e qualche luce 2. La seconda guerra mondiale 3. Annales II II. Le fiabe di Busoni 1. Le utopie di una vita 2. Arlecchino 3. Turandot III. L’altro Respighi 1. Primus inter pares 2. Re Enzo 3. Semirâma 4. Belfagor 5. La campana sommersa 6. Lauda e mistero 7. La fiamma 8. Lucrezia IV. Pizzetti drammaturgo 1. Longevità 2. Fedra 3. Dèbora e Jaéle 4. Lo straniero 5. Fra Gherardo 6. Orsèolo e altro 7. Ifigenia 8. La figlia di Iorio e dintorni 9. Assassinio nella cattedrale 10. Clitennestra V. Le metamorfosi di Malipiero 1. Novantun’anni 2. L’Orfeide 3. Goldoni e Venezia 4. Merlino mastro d’organi 5. Torneo notturno 6. La favola del figlio cambiato 7. Quattro opere serie 8. Quattro opere comiche 9. Teatro e autobiografia VI. Il lustro di Casella 1. Pianista e operista 2. La donna serpente 3. La favola d’Orfeo e Il deserto tentato VII. Antichi e moderni 1. Mito e dialetto 2. Ancora burle 3. Ancora drammi QUARTA PARTE. AVANGUARDIA D’ITALIA I. Miracolata e contestata (1946-1968) 1. Nazione e liberazione 2. Vie nuove 3. Annales III II. Ghedini o dell’equilibrio 1. Non solo operista 2. Maria d’Alessandria 3. Re Hassan 4. La pulce d’oro 5. Le baccanti 6. Billy Budd 7. L’ipocrita felice III. I folli voli di Dallapiccola 1. Il tempo e la figura 2. Volo di notte 3. Il prigioniero 4. Job 5. Ulisse IV. Due volte Petrassi 1. Musica secolare 2. Il cordovano 3. Morte dell’aria V. La satura di Maderna 1. La persona 2. Don Perlimplin e Hyperion 4. Ages e Satyricon VI. Nono il messaggero 1. Un'azione 2. Intolleranza 1960 3. Al gran sole carico d’amore 4. Prometeo, tragedia dell’ascolto VII. La dilogia di Togni 1. Camillo e Anton 2. Blaubart e Barrabas VIII. Operisti in scena 1. Frammenti di Realismo 2. Fecondità e promiscuità 3. Grotteschi 4. Commedie? 5. Sempre eroi 6. Liviabella 7. Mannino 8. Hazon 9. Testi QUINTA PARTE. TEATRI D’IDEA E DI VITA I. Il paese per moto contrario (1969-2000) 1. Disagi e disordini 2. Voglia di pace 3. Giro di boa 4. Annales IV II. Berio come Proteo 1. Omnia musica 2. Passaggio 3. Opera 4. La vera storia 5. Un re in ascolto 6. Outis III. Manzoni da Marx a Max 1. L’uomo e il compositore 2. La sentenza 3. Atomtod 4. Per Massimiliano Robespierre 5. Doktor Faustus IV. Bussotti e il suo dramma 1. Verso la Passion selon Sade 2. Lorenzaccio 3. Nottetempo 4. Phèdre 5. L’ispirazione V. Musicisti in scena 1. Clementi 2. Donatoni 3. Macchi 4. Castiglioni 5. Pennisi 6. Corghi 7. Bologna 2014-16 VI. Quadrilatero e triangolo 1. Sciarrino 2. Guarnieri 3. Vacchi 4. Battistelli 5. Ferrero 6. Tutino 7. Galante VII. Nel mezzo del cammin 1. Quasi impossibile 2. Venti e trenta 3. Quaranta 4. Per fortuna senza fine SESTA PARTE. IN SCENA I. Maestria concertante 1. Podio e bacchetta 2. Direttori compositori 3. Interpreti ed esecutori 4. Anche modernisti 5. Toscanini il primo 6. Gavazzeni il generoso II. Cantanti tutto 1. Attorno al Verismo 2. Ripescaggi e specialismi 3. Ricompare il belcanto 4. Rivive il belcanto 5. Callas 6. Per l’opera contemporanea III. Contesti 1. Bozzetti d’arte e d’immagine 2. Quadretti e follie 3. A cavallo dei secoli 4. Qual piuma al vento 5. Un esagono di teatri SETTIMA PARTE. PAGINE I. Mediante 1. Solo in Italia 2. Anche in Europa 3. Oltre l'opera 4. Postazioni speciali 5. Qua e là II. King James 1. L'amico e il nemico 2. Carteggi 3. Qualche pioniere 4. Verso l'internazionale 5. Dall'albero alla scuola 6. A più mani 7. Opere e libretti 8. Donne fatali? 9. Critica Butterfly 10. E Lucca III. Discobolìa 1. Una riserva e una fonte 2. Prodigalità 3. Avarizia Bibliografia essenziale Quarta di copertina Checché se ne creda o dica, il teatro d'opera gode ottima salute, in Italia e fuori. Una ragione sta sotto gli occhi di tutti: il repertorio ottocentesco, quello che salpa da Rossini e approda a Puccini facendo scalo presso Bellini, Donizetti e Verdi, popola le stagioni di tutto il mondo, dalla Scala al Metropolitan in giù; ed è, abbiano pazienza Wagner, Gounod e Musorgskij, soprattutto italiano. Un'altra merita un pensierino: dopo Puccini, gli operisti italiani non sono stati una dozzina di compositori nostalgici, ma centinaia e centinaia di compositori moderni e vivaci, immersi nella loro attualità storico-estetica; e dunque è una ragione pienamente valida anch'essa. Pensierino con constatazione, ancora doppia: si tratta di autori che il repertorio corrente per i teatri propone con enorme cautela, dovendo fare i conti con i gusti di un pubblico affezionatissimo ad arie e romanze della più bell'acqua romantica, e che la bibliografia complessivamente trascura o ignora. Come dire: con la Turandot di Puccini (peraltro postuma), basta così; è finita, gli autori sono troppi ed eterogenei; accontentiamoci di un libro, un saggio, un testo, un programma di sala su questo o quell'altro. Invece no, perché da quel 1926 è passato quasi un secolo e il tanto materiale accumulato piange, o forse, meglio, reclama considerazione larga, assiemistica, veramente o anche semplicemente storiografica. Si prova a consolarlo e onorarlo questo libro, che i cent'anni li introduce, incornicia, suddivide e riassume; e mentre li sospende fra estetica e cronaca ma anche fra dischi e libri, li percorre con molti nomi e cognomi, titoli e personaggi, compositori e librettisti, direttori e orchestre, registi e scenografi, critici e cantanti. Troppi? Sarà breve per certi motivi arcinoti, il Novecento, ma per la quantità dei prodotti e delle testimonianze d'arte e di musica è lungo, lunghissimo, inevitabilmente finito e tuttavia reso quasi infinito da giovani musicisti comparsi verso la sua fine e ben proiettati a lavorare e produrre nel Duemila. Ecco gli autori principali: Smareglia, Puccini, Mascagni, Alfano, Zandonai, Busoni, Respighi, Pizzetti, Malipiero, Casella, Ghedini, Dallapiccola, Petrassi, Maderna, Nono, Togni, Berio, Manzoni, Bussotti, Sciarrino, Guarnieri, Vacchi, Battistelli, Ferrero, Tutino, Galante. I direttori? Da Toscanini, con De Sabata e Karajan, fino ad Abbado e passa: se Claudio coltivava il contemporaneo e Arturo no, non importa nulla, perché il secondo è vissuto durante mezzo Novecento e ne ha fatto la storia, esattamente come altri classici quali Fedele D'Amico, Luchino Visconti e Maria Callas. Per puro esempio, in questo o quell'altro dei duecento paragrafi della trattazione. L'autore Professore di Storia della musica, Piero Mioli è presidente della Cappella dei Servi e consigliere dell'Accademia Filarmonica di Bologna, collabora con l'Istituto di Studi verdiani di Parma e con varie riviste fra cui la «Nuova informazione bibliografica», tiene corsi e conferenze, cura l'organizzazione di convegni e volumi a più mani, ha pubblicato dizionari e integrali librettistiche, ha scritto articoli e monografie su numerosi compositori europei e in particolare sugli operisti italiani. QUARTA PARTE AVANGUARDIA D’ITALIA I. Miracolata e contestata (1945-1968) 1. Nazione e liberazione Il 25 aprile del 1945 si liberano Milano e Genova, e da allora il 25 aprile è la festa nazionale della liberazione. Il ministero Bonomi, in carica da un anno, cede a un governo presieduto da Parri e subito dopo a un ministero di coalizione guidato da Alcide De Gasperi esponente della Democrazia Cristiana (il partito politico fondato nel 1942 da antifascisti e cattolici sulla memoria del Partito Popolare sorto nel 1919). Nel ’46 si vota l’Assemblea Costituente, onde 2.076 seggi vanno ai democristiani, 115 ai comunisti, 104 ai socialisti; e si svolge il referendum istituzionale, onde gli italiani scelgono la Repubblica con 12.700.000 voti (10.700.000 alla monarchia, nella persona di Umberto II in favore del quale Vittorio Emanuele III aveva abdicato), primo presidente Enrico De Nicola. Nel ’47 si firma un trattato di pace che cede alla Francia Briga e Tenda, restituisce alla Grecia il Dodecaneso, fa di Trieste “territorio libero” (tornerà all’Italia nel ’54, mentre l’Istria si unirà alla Dalmazia e a parte della Venezia Giulia già assegnate alla Jugoslavia), libera tutte le colonie; e alla fine dell’anno si elabora e approva la nuova costituzione della repubblica, che entra in vigore il 1° gennaio del 1948 assicurando i diritti dell’uomo, il fondamento sul lavoro, il principio della libertà, le autonomie locali, lo sviluppo della cultura, la negazione della guerra. Intanto nel resto del mondo tramonta il colonialismo, comincia la cosiddetta guerra fredda fra le due superpotenze di URSS (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche) e USA (Stati Uniti d’America), nasce l’ONU. ovvero Organizzazione delle Nazioni Unite (1945). Molto accade nel 1949: la Germania viene divisa in Repubblica Federale Tedesca (a Ovest, in alleanza con l’Occidente) e Repubblica Democratica Tedesca (a Est, sotto l’influenza dell’URSS), si firma il Patto Atlantico (premessa della NATO) fra USA e paesi appunto atlantici come l’Italia riconoscenti quell’influenza, si proclama la Repubblica Popolare Cinese. Morto Stalin nel ‘52, il nuovo segretario centrale del partito Nikita Krusciov procede a una revisione dello stalinismo denunciandone gli errori e i misfatti, avvia caute riforme e favorisce il disgelo della guerra fredda, quivi in almeno parziale sintonia con il nuovo presidente degli USA, il democratico John Fitzgerald Kennedy che sale al potere nel 1960 (e verrà ucciso in un attentato tre anni dopo). Altri avvenimenti fondamentali fra il 1948 e il ‘68 sono la formazione dello stato d’Israele, la guerra di Corea, la lunghissima guerra del Viet-Nam terminata ad onta degli USA, le repressioni sovietiche in Ungheria e Cecoslovacchia, l’avvento del comunismo di Castro a Cuba, la raggiunta indipendenza di moltissimi stati africani (ben 17 nel ’60), la costituzione dell’OLP ovvero Organizzazione per la liberazione della Palestina, la “rivoluzione culturale” in Cina. Al timone presidenziale della Repubblica italiana, dopo De Nicola, per un’abbondante ventina d’anni stanno Luigi Einaudi (1948-55), Giovanni Gronchi (1955-62), Antonio Segni (1962-64) e Giuseppe Saragat (1964-71), il quale ultimo assiste agli avvenimenti del ’68; e come presidenti del consiglio dei ministri, dopo otto governi di De Gasperi dal ’45 al ’53 (nel ’50 si approva la legge della Cassa per il Mezzogiorno) ecco Giuseppe Pella, Amintore Fanfani, Mario Scelba, Antonio Segni, Adone Zoli, Fernando Tambroni, Giovanni Leone, Aldo Moro, Mariano Rumor, alcuni più volte, abbastanza spesso in esclusiva compagine democristiana e talvolta in compagnia di solcialisti e socialdemocratici, più raramente di liberali e repubblicani. Nel 1958 sale al soglio pontificio Giovanni XXIII, che nel ’62 apre il Concilio Vaticano II e nel ‘63 pubblica l’enciclica Pacem in terris, veramente universale, e poi muore. Nuovo papa è Paolo VI, eletto nello stesso ’63 in cui Moro costituisce un governo di centro-sinistra con la partecipazione dei socialisti e una riforma scolastica eleva ai 14 anni l’istruzione obbligatoria con un’unica scuola media inferiore. Dai pieni anni ’50 ai tardi anni ’60, infine, l’Italia dà luogo al cosiddetto boom economico, un entusiasmante periodo di crescita, sviluppo, autofiducia che verso il ‘66 comincia a dar cenni di crisi e terminerà clamorosamente a cavallo del 1970. 2. Vie nuove Anche nel costume e nello spettacolo, nelle arti e nelle lettere, nella civiltà e nella cultura in genere la fine del regime e della guerra comportano fervidi moti di rivalsa, di impegno, di rinnovamento, da chi ne è raggiunto in età adolescenziale e adulta a chi si trova a venire al mondo proprio in quegli anni e decenni. Dal 1945 al ’47 ha luogo la pubblicazione del “Politecnico”, rivista fondata da Vittorini con la collaborazione di Fortini, Ferrara, Calvino, Preti, Del Buono; nel solo 1946 comincia la pubblicazione del voluminoso Dizionario letterario Bompiani, che si occupa “delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e di tutte le letterature” (per terminare nel ’66), si pubblicano i manifesti del Realismo in arte e della Nuova Secessione Artistica Italiana, l’italianista Luigi Russo fonda la rivista letteraria “Belfagor”, due leoni della regia cinematografica come De Sica e Rossellini si impongono sempre più come maestri del Neorealismo l’uno con Sciuscià e l’altro con Paisà, il maggior concertatore e direttore italiano del presente (e del passato) ovvero Arturo Toscanini apre la Scala ricostruita con un concerto memorabile; mentre altrove fa passi da gigante la critica letteraria di Erich Auerbach (con Mimesis) e György Lukács (con i Saggi sul realismo). Lungo il ’47 s’affollano romanzi di Pavese, Calvino, Berto, Moravia, Marotta, Pratolini, Levi, Rea, Quarantotti Gambini destinati a varia e spesso grande popolarità, magari degni di stare a fianco del coevo Doktor Faust di Mann, e intanto, mentre si rendono pubbliche le drammatiche Lettere dal carcere di Gramsci, si pubblica il manifesto artistico del Gruppo Forma 1 (formalisti e marxisti, dalla Accardi a Turcato), si termina il monumento alle Fosse Ardeatine (a Roma, per la firma di cinque artisti), come eventi ricchissimi di futuro e di gloria a Milano si fonda il Piccolo Teatro e a Roma si istituisce il Premio Strega. Nel 1948 muore Umberto Giordano, il popolare autore di Andrea Chénier che almeno come persona rappresentava ormai tempi e modi sorpassati, mentre continuano i successi cinematografici di De Sica e Visconti; e il ’49 dona all’Italia l’avvio della prodigiosamente economica Biblioteca Universale Rizzoli (BUR) e del settimanale di politica, economia e cultura “Il mondo”. Nel 1951 la storia della musica registra la morte di Schönberg, a New York, e a Venezia la prima rappresentazione della Carriera d’un libertino di Stravinskij, mentre la RAI (Radio Audizioni Italia) celebra il cinquantenario della morte di Verdi con grande, benefico dispiego di forze sconosciuto anche ai teatri maggiori italiani e stranieri. Intanto, fra un colosso della narrativa novecentesca come le storiche Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar e un fortunatissimo romanzo d’attualità come Il giovane Holden di David Salinger, le ferite italiane sanguinano ancora con i Quaderni del carcere di Gramsci. Morto Croce nel 1952 (e non certo nell’inerzia critico-civile), negli anni a venire prospera il romanzo di Cassola, Rigoni Stern, Tobino, Pasolini, Moravia, Parise, Pratolini, Gadda, Morante, Mastronardi, Arpino, Ottieri (mentre Tolkien pubblica Il signore degli anelli e Nabokov Lolita): su altri settori l’Italia galoppa con la regolarità delle trasmissioni televisive (fatidico il 1954), la fondazione della rivista “Il Verri” di Luciano Anceschi, la nascita delle edizioni Feltrinelli e dell’“Espresso”, l’avvio della vasta Enciclopedia dello spettacolo da parte delle Maschere di Roma, la produzione di film come La strada di Fellini e Il ferroviere di Germi, l’apertura a Spoleto del Festival dei Due Mondi, il completamento della modernissima e imponente Torre Velasca di Ernesto Nathan Rogers (a Milano), una curiosità artistica come l’Orfeo di Ettore Colla costruito assemblando ferri di recupero rielaborati e saldati. Nel 1958 esce il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, nel ’59 Quasimodo vince il premio Nobel per la letteratura (mentre muore Cardarelli), nel ’60 il paese registra un aumento del reddito nazionale del 47 per cento (nel giro dell’intero decennio): il “miracolo” economico si coniuga brillantemente con le virtù e le capacità creative, i successi e le fortune internazionali degli altri settori della vita pubblica. Non ultimo il teatro d’opera, quello militante sulla tradizione nazionale dove il tipico repertorio ottocentesco compreso fra Rossini e Puccini si amplia notevolmente e comunque s’avvale di cantanti giovani, forti entusiasti, dotatissimi dalla natura e di registi intelligenti, innovativi, spesso condivisi con il cinema e la prosa contemporanea. Alla rinascita di un paese dalle sue ceneri contribuisce anche questo augusto genere di musica classica, nonostante la concorrenza della musica leggera, della canzone, della relativa attività radiofonica e di festival specifici come quello di Sanremo che lanciano messaggi di maggior semplicità (spesso anche di evidente semplicismo). Sono 50.624.000 gli italiani censiti nel 1961, il primo anno di un decennio destinato a rafforzare ancora l’economia ma attraverso disagi e disgrazie determinanti per il resto del secolo. Mentre Giovanni XXIII promulga l’enciclica Mater et Magistra sulla necessità della giustizia sociale, comincia a uscire il benemerito Grande Dizionario della lingua italiana diretto da Salvatore Battaglia, Leonardo Sciascia pubblica Il giorno della civetta che denuncia la prepotenza della mafia siciliana e la corruzione di certa “incredibile” Italia, l’architetto Giovanni Michelucci progetta la chiesa di S. Giovanni Battista che spiccherà di modernismo sull’autostrada del Sole presso Firenze, si comincia a produrre la registrazione sonora su nastro magnetico in cassetta. Come il romanzo di Tomasi di Lampedusa, così Il giardino dei Finzi-Contini di Bassani sa sposare la storia con il presente (tanto da diventare film entrambi, l’uno grazie a Visconti e l’altro a De Sica), nello stesso 1962 che porta anche la pubblicazione di “Panorama”, settimanale parallelo e opposto all’“Espresso” (oltre alla nazionalizzazione dell’industria elettrica, leggi ENEL). Il ’63 del Centro-sinistra guidato da Aldo Moro brilla altrove per La cognizione del dolore di Gadda, per il Lessico famigliare della Ginzbug, per la Vita di Galileo di Brecht messa in scena al Piccolo di Milano da Strehler, per l’istituzione del premio Campiello a Venezia (riservato alla narrativa); in particolare per il movimento letterario d’avanguardia che si fonda a Palermo col nome dell’anno stesso, il Gruppo 63 rappresentato da Eco, Sanguineti, Anceschi, Barilli, Pagliarani, Balestrini e altri (unito fino alla fine del decennio). Nel ’64, mentre scompare un pittore grande e isolato come Giorgio Morandi e si pubblica un romanzo psicologico come Il male oscuro di Giuseppe Berto, lo strutturalismo si impone con gli Elementi di semiologia di Roland Barthes e i Saggi di linguistica generale di Roman Jakobson. Via col cinema, poi, grazie a I pugni in tasca di Bellocchio, Uccellacci e uccellini di Pasolini, Blow-up di Antonioni (accanto a capolavori stranieri di Buñuel e Kubrick), e alla narrativa, grazie per esempio alla Macchina mondiale di Volponi, nonché all’italianistica, con l’attesa edizione critica della Divina commedia curata dal Petrocchi. Ma nel 1968, l’anno in cui si verifica il terribile terremoto del Belice (Sicilia) e dello scomparso Beppe Fenoglio si fa la conoscenza con Il partigiano Johnny, il 31 gennaio comincia all’Università di Trento la contestazione giovanile, che caratterizza un’intera annata consegnandola alla storia proprio col suo numero fatidico. 3. Annales III Ancora: prime esecuzioni di opere italiane, morti e nascite di musicisti italiani, avvenimenti diversi, pubblicazioni storiche, incisioni discografiche si succedono in questa terza cronologia operistica (i nomi di battesimo sono citati una volta per tutte; altrimenti si trovano nell’indice). 1946 Nascono a Venezia Giuseppe Sinopoli (che morirà a Berlino nel 2001), a Milano Riccardo Bianchini (che morirà a Roma nel 2003), a Roma Luca Lombardi. Ricostruita, riapre i battenti la Scala. Prima di Guerra e pace di Prokofiev a Leningrado. Casella pubblica La musica in Italia dopo il 1944 su «La revue musicale». 1947 L’oro di Pizzetti a Milano e Raggio di sole di Martini a Brescia. Muore a Roma Alfredo Casella (nato a Torino nel 1883). Nascono a Sustinente (Mantova) Adriano Guarnieri e a Palermo Salvatore Sciarrino. Prima italiana del Peter Grimes di Britten a Milano. Maria Callas canta nella Gioconda di Ponchielli all’Arena di Verona. Don Luigi Sturzo pubblica su «Musica» l’articolo Andare verso il popolo. A Roma comincia a uscire la rivista «Musica». 1948 Gli incatenati di Bianchi a Milano, L’incubo di Nielsen a Venezia. Muoiono a Milano Umberto Giordano (nato a Foggia nel 1867), a Venezia Ermanno Wolf Ferrari (ivi nato nel 1876), a Pavia Franco Vittadini (ivi nato nel 1884), a Lucca Gaetano Luporini (ivi nato nel 1865). Nasce a Roma Alessandro Sbordoni. Antonio Ghiringhelli sovrintendente della Scala di Milano (fino al ’72). Prima della Commedia sul ponte di Martinů a Ostrava. Prime italiane del Cardillac di Hindemith e Les malheurs d’Orphhée di Milhaud a Venezia. Pizzetti presiede un Congresso di Musica al Maggio. I Convegno internazionale di arte radiofonica a Capri. Nascono la «Rivista musicale Curci», «Strumenti e musica», il «Bollettino dell’Accademia musicale Chigiana». Armand Machabey pubblica Le” bel canto” (poi tradotto in italiano nel 1965). 1949 Il dottor Antonio di Alfano a Roma, Il prigioniero di Dallapiccola alla RAI di Torino (composto nel 1943-48), Il cordovano di Petrassi a Milano, Malìa di Langella a Napoli. Muoiono a Milano Riccardo Pick Mangiagalli (nato a Strakonice [Boemia] nel 1882), a Londra Franco Leoni (nato a Milano nel 1864), a Pesaro Amilcare Zanella (nato a Ponticelli d’Ongina [Piacenza] nel 1873). Nasce a Bologna Fabio Vacchi. La musica di Maderna comincia a comparire nei programmi di Darmstadt. Rinasce a Firenze L’assedio di Corinto di Rossini. Prima italiana della Lulu di Berg a Venezia. Franco Abbiati fonda «La Scala», mensile che uscirà fino al 1963. 1950 Morte dell’aria di Petrassi e Orfeo vedovo di Savinio a Roma, Il prigioniero di Dallapiccola a Firenze (prima scenica) e Job dello stesso a Roma, L’allegra brigata di Malipiero a Milano, Ifigenia di Pizzetti (1° Premio Italia) e Il mio cuore è nel sud di Maderna alla RAI, Un curioso accidente di Napoli a Bergamo, Zelia (op. postuma) di Neglia a Catania. Muore a Varazze (Savona) Francesco Cilea (nato a Palmi [Reggio Calabria] nel 1866). Nono esegue a Darmstadt la sua prima composizione, Variazioni canoniche sulla serie dell’op. 41 di A. Schönberg per orchestra. Riprende il Teatro delle Novità di Bergamo. Comincia a uscire la rivista «Il diapason», a cura del Centro internazionale di musica di Milano (fino al ’53). Massimo Mila pubblica La linea Nono (a proposito de “Il canto sospeso”) sulla «Rassegna musicale». 1951 Storia di una mamma di Vlad a Venezia, Prometeo di Cortese e Il sistema della dolcezza di Tosatti a Bergamo, Cristoforo Colombo di Savinio alla Rai, The Rake’s progress di Stravinskij a Venezia. Muore a Roma G. Mulè (nato a Termini Imerese [Palermo] nel 1885). Nasce a Torino Lorenzo Ferrero. Il telefono e Il console di Menotti a Milano (prime italiane). Vlad si trasferisce a Roma. Prima del Billy Budd di Britten a Londra. «Il diapason» pubblica lo speciale Verdi oggi con scritti di Pizzetti, Ghedini, Honegger, Poulenc, Vogel, Peragallo, Petrassi, Turchi, Dallapiccola, Copland, Scherchen, Damerini, Barblan, Mompellio e altri studiosi. 1952 Sakùntala di Alfano a Roma (nuova versione della Leggenda di Sakùntala del 1921), L’uragano di Rocca a Milano, L’incantesimo di Montemezzi a Verona (composto nel 1943), Lord Inferno di Ghedini alla RAI. Muoiono a Vigasio (Verona) I. Montemezzi (ivi nato nel 1875), a Roma Bruno Barilli (nato a Fano nel 1880) e Alberto Savinio (nato ad Atene nel 1891). La Columbia incide La Gioconda di Ponchielli, protagonista Maria Callas. Rinascono a Firenze la Armida e il Tancredi di Rossini. «The score» pubblica Schönberg è morto di P. Boulez. «Il diapason» pubblica Invito al “Wozzeck” di Berio e La lezione di Berg. “Wozzeck” di Malipiero. Domenico De Paoli pubblica La musica contemporanea. 1953 Partita a pugni di Tosatti a Venezia, Il figliuol prodigo di Malipiero a Torino, Don Ciccio di Ottorino Gentilucci a Bergamo, La via di Colombo di Nielsen alla RAI (1° Premio Italia). Nasce ad Albano Laziale (Roma) Giorgio Battistelli. La Columbia incide la Lucia di Lammermoor di Donizetti e la Tosca di Puccini, Callas protagonista. Rinasce alla RAI di Milano la Elisabetta regina d’Inghilterra di Rossini. Henze si trasferisce in Italia. Fernando Previtali direttore stabile dell’Accademia di S. Cecilia (fino ’72). 1954 La figlia di Iorio di Pizzetti a Napoli, La gita in campagna di Peragallo e La figlia del diavolo di Mortari a Milano, Il contrabbasso di Bucchi a Firenze, Allamistakeo di Viozzi a Bergamo, The turn of screw di Britten a Venezia. Muoiono a Rio de Janeiro Licinio Refice (nato a Patrica [Frosinone] nel 1885) e a Sanremo Franco Alfano (nato a Napoli nel 1875). Nasce a Milano Marco Tutino. La Columbia incide la Norma di Bellini, Callas protagonista. A New York l’Otello di Rossini. A Firenze Thomas Mann fa visita a Dallapiccola, che aveva conosciuto a New York nel 1952. A Roma si svolge il convegno internazionale sulla “Situazione della musica nel XX secolo”. Prima di Troilus and Cressida di Walton a Londra. Gavazzeni pubblica il saggio La morte dell’opera. 1955 Ferrovia sopraelevata di Chailly e Mimusique n. 2 di Berio a Bergamo, Il cappello di paglia di Firenze di Rota a Palermo, Burlesca di Veretti a Roma, Madame Bovary di Pannain a Milano, Ritratto di città di Berio-Maderna-Leydi alla RAI (fuori concorso al Premio Italia), L’angelo di fuoco di Prokofiev a Venezia, Lord Byron’s love letter di De Banfield a New Orleans. Muore a Ravenna Francesco Balilla Pratella (nato a Lugo di Romagna nel 1880). Alla Scala una memorabile Traviata di Verdi: Callas protagonista, Giulini direttore, Visconti regista. Savinio pubblica i saggi di Scatola sonora. 1956 La guerra di Rossellini a Napoli, Mario e il mago di Mannino a Milano, Il furore d’Oreste di Testi e La panchina di S. Liberovici a Bergamo, Il giuoco del barone di Bucchi alla RAI (1° premio RAI). Prima di König Hirsch (Re cervo) di Henze a Berlino. Malipiero pubblica all’Insegna del pesce d’oro di Milano Ti co mi e mi co ti. Soliloqui di un veneziano. Berio si dichiara pubblicando Aspetti di artigianato formale in «Incontri musicali». Nasce la rivista «Il Verri» (pubblicata fino al ’74). 1957 Una domanda di matrimonio di Chailly e I dialoghi delle Carmelitane di Poulenc a Milano, Vivì di Mannino a Napoli, Requiem per Elisa di Hazon a Bergamo. La Columbia incide La sonnambula di Bellini, Callas protagonista. Alla Scala va in scena l’Anna Bolena di Donizetti, Callas protagonista. Prime di Moses und Aron (postuma) di Schönberg a Zurigo, West side story di Bernstein a Washington, Die Harmonie der Welt di Hindemith a Monaco. Luigi Pestalozza pubblica La musica di scena sulla «Rassegna musicale». 1958 Il vortice e La piovra di Rossellini a Napoli, Assassinio nella cattedrale di Pizzetti a Milano, Cappuccia ovvero Della libertà di Ferrari e San Giovanni decollato di Sangiorgi a Bergamo, Maria Golovin di Menotti a Bruxelles. Rinasce a Firenze La donna del lago di Rossini. L’Unesco entra nel Premio Italia della RAI. Bernd Alois Zimmermann comincia a lavorare a Die Soldaten, opera che terminerà nel 1964 e rappresenterà l’anno dopo. Prima della Vanessa di Barber a New York. Umberto Eco pubblica su «Incontri musicali» il lungo saggio L’opera in movimento e la coscienza dell’epoca. Porena descrive L’avanguardia musicale di Darmstadt sulla «Rassegna musicale». Alberto Mantelli fonda «L’approdo musicale» (resistente fino alla morte 1967). Mosco Carner pubblica Puccini. A critical biography, valente monografia destinata a una notevole fortuna anche in Italia. 1959 La smorfia di Bettinelli a Torino, Procedura penale di Chailly a Como, Lo scoiattolo in gamba di Rota a Venezia, La scuola delle mogli di Mortari a Milano, La notte di un nevrastenico di Rota alla RAI (1° Premio Italia). Nasce a Trento Carlo Galante. Il Requiem di Fellegara alla RAI di Torino. Nasce a Palermo il Gruppo Universitario per la nuova musica. Prima della Voix humaine di Poulenc a Parigi. Nono legge a Darmstadt il testo Presenza storica nella musica d’oggi. La Decca incide la Tosca di Puccini, Tebaldi protagonista. 1960 La sentenza di Manzoni a Bergamo, Mayerling di Giuranna a Napoli, La notte di un nevrastenico di Rota e Il dottore di vetro di Vlad alla RAI. Dallapiccola comincia a lavorare a Ulisse. Nascono a Palermo le Settimane internazionali della nuova musica. Fedele D’Amico pubblica su «Incontri musicali» il lungo saggio Dell’opera aperta ossia dell’avanguardia, in risposta a quello di Eco del 1958 (a sua volta ne riceve una riposta nello stesso numero). H.K. Metzger critica l’atto di indipendenza di Nono dal verbo di Darmstadt. La Decca incide l’Otello di Verdi, Del Monaco protagonista e Karajan direttore. 1961 Il calzare d’argento di Pizzetti a Milano, Intolleranza 1960 di Nono a Venezia, Aeroporto di Giuffré a Bergamo, Attraverso lo specchio di Castiglioni alla RAI (1° Premio Italia), Amleto di Zafred a Roma, Il mercante di Venezia di Castelnuovo Tedesco a Firenze. Nasce a Roma l’associazione Nuova Consonanza. Prima italiana di Moses und Aron di Schönberg a Milano. Prima di Revelation in the Courthouse park di Partch a Urbana. 1962 Don Perlimplin di Maderna e Confessione di Fuga alla RAI, Agenzia matrimoniale di Hazon a Parma, Il rosario di Napoli a Brescia, Il buon soldato Švejk di Turchi a Milano. Muoiono a Milano Felice Lattuada (nato a Caselle di Morimondo [Milano] nel 1882) e a Merano Alfredo Sangiorgi (nato a Catania nel 1894). Nasce a Torino Andrea Liberovici. Alla Scala trionfa la Semiramide di Rossini, protagonista Joan Sutherland, e si rappresenta Atlántida (cantata scenica postuma) di Falla. Prima del King Priam di Tippett a Coventry. Nono pubblica sulla «Rassegna musicale» Alcune precisazioni su “Intolleranza 1960”. La Decca incide l’Aida di Verdi, Tebaldi protagonista e Karajan direttore. 1963 Passaggio di Berio a Milano, Il diavolo in giardino di Mannino a Palermo, Esculapio al neon di Porrino e Il testamento di Euridice di Lualdi alla RAI, La Celestina di Testi a Firenze, La fiera delle meraviglie di Tosatti a Roma, Madame Landru di Hazon a Palma di Maiorca. Roberto Benaglio maestro del coro della Scala (fino al ’71). Katerina Izmajlova (seconda versione di Una lady Macbeth del distretto di Mcensk) di Šostakovič a Mosca. Prima di The flood di Stravinskij ad Amburgo. Esce presso il Saggiatore di Milano il Manuale d’armonia di Schönberg tradotto da Manzoni. Nuova edizione, postuma, del Paese del melodramma di B. Barilli. La Decca incide La fanciulla del West di Puccini, Tebaldi protagonista 1964 Hyperion di Maderna a Venezia, Il contratto di Mortari a Roma, Il Dio di oro di Paccagnini alla RAI (1° Premio Italia). Muoiono a Bologna L. Liviabella e a Roma Luigi Ferrari Trecate (nato ad Alessandria nel 1884). Carlo Maria Badini sovrintendente del Comunale di Bologna (fino al 1977). Paolo Emilio Carapezza pubblica su «Aut-Aut» il saggio La costituzione della nuova musica. Nasce la rivista di cultura «Il marcatrè» (fino al ’66). 1965 Clitennestra di Pizzetti e Atomtod di Manzoni a Milano, La passion selon Sade di Bussotti a Palermo, Wallenstein di Zafred a Roma; Die Soldaten di Zimmermann a Colonia, Amore e morte di Luporini a Lucca (composta nel 1921-22). Muoiono a Nervi (Genova) Giorgio Federico Ghedini (nato a Cuneo nel 1892), a Milano Renzo Bossi (nato a Como nel 1883), a Genova Carmine Guarino (nato a Rovigo nel 1893). Remigio Paone sovrintendente del Comunale di Firenze (fino al ’69). Rinasce a Napoli la Zelmira di Rossini. Prima di Der junge Lord di Henze a Berlino. Guaccero pubblica sul «Convegno musicale» La “conversione” delle avanguardie musicali. 1966 La leggenda del ritorno di Rossellini e L’albergo dei poveri di Testi a Milano, Tutti la vogliono, tutti la spogliano di Paccagnini a Bergamo, Un treno di Squadroni a Civitanova Marche. Muoiono a Torino Luigi Perrachio (ivi nato nel 1883) e a New York V. Giannini. La Lucrezia Borgia di Donizetti al S. Carlo di Napoli, protagonista Leyla Gencer. Prima di Anthony and Cleopatra di Barber a New York. M. Morini fonda a Milano e dirige la rivista trimestrale «L’opera» (uscirà fino al 1969). 1967 Il gattopardo di Musco a Palermo, Una donna uccisa con dolcezza di Hazon a Parma, La giacca dannata di Viozzi a Trieste, Il pozzo e il pendolo di Bettinelli a Bergamo, Vassiliev di Chailly a Genova, Giovanni Sebastiano di Negri alla RAI (1° Premio Italia), La valanga di O. Gentilucci a Bergamo. Muore a Buenos Aires Ettore Panizza (ivi nato nel 1875). La Legge n. 233 (Corona) disciplina i 13 Enti Autonomi italiani. Alla Fenice Floris Luigi Ammannati è sovrintendente (fino al ’75) e Mario Labroca direttore artistico (fino al ’74). Trionfano a Firenze la Maria Stuarda di Donizetti (Gencer protagonista) e Il pirata di Bellini (Caballé primo soprano). 1968 Ulisse di Dallapiccola a Berlino, Allez-Hop di Berio a Bologna. Muoiono a Roma Ildebrando Pizzetti (nato a Parma nel 1880) e Tullio Serafin (nato a Rottanova di Cavarzere nel 1878), a Los Angeles Mario Castelnuovo Tedesco (nato a Firenze nel 1895), a Torino Andrea Della Corte (nato a Napoli nel 1993), a Palermo A. Musco. Maderna trascrive e mette in scena l’Orfeo dolente di Domenico Belli. Guaccero compone Rappresentazione et esercizio (azione sacra per 12 esecutori). Claudio Abbado direttore stabile della Scala (fino al ’74). Zafred direttore artistico dell’Opera di Roma. II. Ghedini o dell’equilibrio 1. Non solo operista Un bel po’ di graziosi vagiti musicali dovette registrare l’anagrafe di Francia nel 1892: di Darius Milhaud ad Aix-en Provence, di Arthur Honegger a Le Havre e di Germaine Tailleferre nei pressi di Parigi, quattro anni dopo quelli di Louis Durey e sette anni prima di quelli di Francis Poulenc e Georges Auric. Nel 1920, fattisi grandi o grandicelli, costoro furono gabellati come “les Six”, i Sei modernisti della musica francese che s’erano stancati di Debussy e del debussysmo (ma non di Satie, né di Ravel). In Italia, all’epoca, i musicisti cosiddetti dell’80 erano più che grandicelli, e continuavano le loro determinate battaglie contro sia il Romanticismo che il Verismo, mentre una generazione, un assieme nuovo e pienamente modernista non era affatto destinato a sorgere, né presto né tardi, perché i due grandi e fondamentali maestri dell’intero ‘900, Dallapiccola e Petrassi, allora erano poco più che adolescenti, essendo nati nel 1904, e soprattutto perché, nonostante la felice coincidenza dell’anno, non erano numericamente sufficienti a formare un gruppo. Ma intanto, mentre nascevano in Russia Sergeij Prokofiev (1891) e in America George Gershwin (1898), in Italia vedeva la luce Giorgio Federico Ghedini (Cuneo 1892 – Nervi [Genova] 1965), egregio rappresentante di un accorto equilibrio fra i meno giovani e i più giovani compositori italiani. Diplomatosi in composizione nel 1911, Ghedini insegnò a Torino, Parma e Milano, e del “Verdi” di Milano fu illustre direttore dal 1951 al ’62. Compositore fertile e versatile, non dimenticò mai il messaggio della tradizione, che fosse quella romantica dei primi tempi o quella classicheggiante degli ultimi, ma dalla maturità in poi riuscì sempre a calarsi nella viva attualità dei linguaggi, per esempio esprimendosi anche nell’ambito della politonalità, e della sua arte volle coltivare una concezione classicistica, formalistica, poco sensibile a suggestioni extra-musicali (in maniera non molto diversa da Stravinskij e in parte anche dai Sei) e tributaria solo alla melodia, all’armonia, al ritmo, al contrappunto, alla timbrica, cioè ai parametri veri e specifici della musica. Dal nutrito catalogo orchestrale spiccano l’energica Partita del 1926, le possenti Architetture del ‘40, la cupa e tormentosa Musica notturna del ’47, i raffinati Studi per un affresco di battaglia del ‘62. Fra i tanti concerti per uno o più strumenti trova posto un capolavoro della musica del ‘900: è il Concerto dell’albatro (1945) per pianoforte, violino, violoncello, voce recitante e orchestra che interpreta un testo del Moby Dick di Melville con tutti i crismi di una strumentazione elegante, distaccata, neoclassica. Non meno corposi i contributi alla musica sacra e di scena, cameristica vocale e strumentale; e pregevoli anche le amorose trascrizioni di musiche antiche. Quanto al teatro, le sei opere rappresentate fra il 1937 e il 1956 partecipano alla folta stagione di Pizzetti, Malipiero, Dallapiccola, Rossellini, Rota, Tosatti e alcuni altri senza dubbio figurandone ai vertici. 2. Maria d’Alessandria Se le musiche di scena per l’Ifigenia in Tauride (1938) e la Medea (1949) di Euripide sono la degna cornice di un’opera come Le baccanti del 1948 (fino a quelle per I persiani di Eschilo, composte nel 1950 ma non eseguite), a incorniciare degnamente la prima opera di Ghedini saranno le varie musiche religiose degli anni ’20-30, a cappella, per coro e orchestra, per soli e coro con orchestra come Il pianto della Madonna (1921) e le due serie di litanie (1926, 1933). Opera in tre atti per quattro quadri di Cesare Meano, Maria d’Alessandria fu rappresentata a Bergamo nel 1937, quando il compositore aveva già 45 anni e dopo un paio di tentativi giovanili aveva rinunciato a genere dell’opera. Non è che fosse già cominciata quella forma di diffidenza verso il teatro che avrebbe attanagliato i musicisti italiani nel secondo dopoguerra: solo, a fare più lucidi e responsabili i compositori erano una nobile concezione della musica largamente intesa, anche o soprattutto sinfonica e cameristica e religiosa, una franca avversione per la pur trionfante Giovane Scuola di Leoncavallo e Mascagni e compagni, forse anche la consapevolezza di un passato irripetibile e inimitabile fatto di Monteverdi, Mozart, Rossini e Verdi. Per cui Casella produsse la prima Donna serpente a 49 anni, Petrassi il primo Cordovano a 45, e se Togni doveva mettere in scena il suo primo Blaubart a 56 anni, in fondo l’annosa cautela di Ghedini non deve meravigliare affatto; né deve contare il fatto che a quell’età Rossini avesse già smesso da otto anni e Donizetti fosse in procinto di interrompere un catalogo di una settantina di lavori. Dalle latine Vitae patrum Domenico Cavalca, scrittore domenicano vissuto fra il ‘200 e il ‘300, aveva tratto materia per la Vita di Santa Maria Egiziaca, una delle sue edificanti Vite dei Santi Padri: l’argomento, scabrosetto e piissimo insieme, doveva piacere all’oratorio barocco, nei nomi di Flavio Carlo Lanciani, Baldassarre Sartori, Francesco Magini, Francesco Gasparini, e saltando tutto l’800 profano attirare Respighi, la cui Maria Egiziaca fu eseguita alla Carnegie Hall di New York nel 1932 per quel “mistero”, non opera che era; pochi anni dopo, ecco impegnati sul tema Meano e Ghedini, ma stavolta per un’opera (opera era anche la Thaïs di Massenet che, derivata dagli Acta Sanctorum e data nel 1894, raccontava una storia identica, ambientata nello stesso luogo e allo stesso tempo); ed era un argomento storico, ché quella donna vissuta fra il 345 circa e il 421 aveva veramente scontato la dissolutezza della gioventù con 47 anni di eremitaggio nel deserto, onde era stata proclamata santa (da festeggiare il 2 aprile). Dalla storia al libretto. Nel porto di Faro, presso Alessandria d’Egitto, Dimo (bs.) si accinge a imbarcare sulla sua nave dei pellegrini diretti in Palestina, e accoglie anche Maria (s.), la cortigiana che cantava sfacciata sopra i lamenti degli schiavi frustati e ora si dichiara desiderosa di viaggiare e conoscere altri lidi; mentre gli uomini di Faro protestano contro il suo allontanamento, fra i penitenti giungono il Padre (br.) e il Figlio (t.), e il primo rivela di essere stato sul punto di uccidere il figlio ma di esserne stato impedito da un’improvvisa visione di Cristo; il Figlio mostra la ferita sul costato, vede Maria che lo guarda e ne rimane ammaliato; ma è ora di salpare, non senza una preghiera d’assieme a Cristo. Durante il viaggio parecchi marinai e perfino diversi pellegrini si sollazzano con Maria, mentre gli altri pellegrini invitano Silverio (t.) a raccogliersi in preghiera con loro; Maria continua la sua opera di seduzione e incitamento al piacere, fino a che, notando la reazione interessata del Figlio, il Padre le si avventa contro per essere fermato dal Dimo coi marinai e chiuso nella stiva; nella notte, il Figlio incontra Maria, che cerca di convertire a un sentimento puro e non effimero, ma capisce di non essere riuscito quando apprende che la donna vuole convincere Dimo a far rotta verso Bisanzio, la città della corruzione; scoppia una tempesta, il Padre si libera, imbraccia un arco, minaccia e poi punta Maria, ma la freccia colpisce il Figlio intanto intromessosi; sconvolta, Maria abbraccia il corpo morto del Figlio scongiurando Gesù di aiutarla a cambiare vita; la tempesta infuria sempre più. Sulla spiaggia della Galilea i pastori e Zosimo (br.) sanno di un naufragio e pregano devotamente, quando compare Maria che regge ancora il cadavere: lei perde i sensi, i pietosi danno sepoltura al Figlio; rinvenuta, Maria grida e dispera, ma sente dal cielo la voce del Figlio che le indica la salvezza nella penitenza del deserto per cui, trasfigurata, prende la via dell’eremitaggio mentre un coro celeste glorifica Dio. Una tempesta e un’alba, la spiaggia e il mare, un porto e una nave brulicanti di gente: sono elementi, luoghi propizi a un’ispirazione musicale descrittiva in veste specialmente sinfonica, a tratti impressionistica (nel paesaggio naturale) ma anche un po’ espressionistica (in certo paesaggio umano, portuale, a suo modo veristico); ma l’assunto religioso aggiunge alla partitura una nota ulteriore, e forse complessivamente prioritaria, che è quella di un canto e un melodismo leggero, virgineo, orientaleggiante o modaleggiante, sia a una voce (nella ‘cavatina’ della protagonista) sia a più voci. Senza dubbio eclettica (e comunque mai disomogenea), l’opera esibisce già il connotato fondamentale della musica di Ghedini ovvero la cura della timbrica, il culto di una veste preziosa, calibrata, sfumata dei portati formali capace di passare da momenti massicci e brutali ad altri trasparenti, sognanti, improntati al singolare spiritualismo della vicenda. Certo quell’anonimo Padre che cerca di uccidere il figlio e poi lo uccide davvero dopo aver attentato due volte alla vita di Maria è un bell’assassino, che come figlio si meriterebbe magari il protagonista dello Straniero di Pizzetti (1930); com’è certo che Ghedini, se non proprio i remoti Lombardi alla prima crociata di Verdi dove un tenore muore al terz’atto per cantare dal cielo nel quarto, conoscesse il vecchio Parsifal di Wagner, le lance di Klingsor, le ferite di Amfortas e soprattutto la completa metamorfosi di Kundry. 3. Re Hassan A scrivere il libretto di Maria d’Alessandria era stato Cesare Meano (1899 - 1957), corregionale e amico di Ghedini, fondatore nonché direttore del Teatro del Nuovo Spirito a Torino, regista anche cinematografico e critico drammatico, che solo nel 1934 aveva esordito come autore con la Nascita di Salomè (film nel ’41). A scrivere tre degli altri cinque doveva essere Tullio Pinelli (1908), altro torinese che si sarebbe imposto come fecondo sceneggiatore di alcuni film di Fellini, per esempio La strada del 1954, e altri, drammaturgo specialista di vibranti tematiche etico-religiose e valoroso sperimentatore di linguaggi. La collaborazione con Ghedini cominciò con Re Hassan, tre atti per quattro quadri messi in scena alla Fenice di Venezia nel 1939, qualche mese prima che l’Italia mussoliniana occupasse l’Albania e la Germania hitleriana invadesse la Polonia (insomma, poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale determinata da quest’ultima aggressione); la partitura soggiacque ai bombardamenti, il librettista rivide il suo testo e il musicista riscrisse lo strumentale, l’opera rinacque a Napoli nel 1961 ma senza troppa convinzione dell’ipercritico autore. La Spagna moresca, già prodiga di soggetti a vari operisti come Cherubini e specialmente Donizetti, diede materia a Pinelli: nella Granata del ‘400 re Hassan (bs.) regna ma sotto l’incombenza del regno di Castiglia (che sta terminando la secolare reconquista) e diffidando del figlio Hussein (t.) che sa ambire al trono; rifiuta le proposte del conte Fernán Gonzáles (t.) e accetta di combattere ma senza successo; Hussein è fatto prigioniero con la moglie Moraima (s.) e la madre Jàrifa (c.), che è stata ripudiata da Hussen in favore della giovane Thoreya (s.), e lascia in ostaggio il figlioletto neonato per avere il trono del padre da parte dalla Spagna; Moraima muore dal dolore, Hussein vince col tradimento, Hassan è sconfitto, solo e disperato (o si uccide nella seconda versione). Soggetto squallido, triste, scorato, Re Hassan è un’opera che getta buona luce soltanto su Moraima e il figlioletto, e non ha nulla da spartire con le tante più o meno precedenti che contrappongono oppressi e oppressori a tutto vantaggio morale o anche materiale dei secondi: i pochi momenti lirici, anche se molto belli, si riducono all’intimità del duetto d’amore, preludiato dal liuto del soprano e alleggerito dai fiati, e al lamento di Hussein alla notizia della morte di Moraima (“Mi pareva naturale che fosse viva come è naturale che ci sia il sole”, in “molto calmo”); il resto è cupo, disadorno, sia che descriva albe e notti o che ritragga sensi e passioni, dalla desolazione dell’alba iniziale all’angoscia della morte finale non senza la frenesia polifonica di qualche scena di massa. Ricca di strumenti gravi (timpani, tamburi, tromboni) e magari squillante di trombe, irta di cromatismi bruschi e violenti, percorsa da alcuni temi anch’essi pochi ma caratteristici (quello di Hassan su accordi pesanti e vibranti, quello di Moraima alto e melodico), all’occorrenza la partitura fa scattare il canto con un’enfasi quasi wagneriana, per esempio là dove Hussein cede alla proposta sapendola disonorevole e grida “Maledizione su di me!”, in terzine acute, sforzate e fortissime sul crescendo del coro maschile dietro le quinte (e non sa che l’ignara mogliettina sta per entrare in scena col bimbo fra le braccia). “Ghedini non strumenta: pensa strumentalmente”, è stato scritto dell’opera (Carlo Pinelli); e l’osservazione non vale solo per quest’opera. 4. La pulce d’oro Fu il Teatro Sperimentale dei GUF, a Firenze, che mise in scena La pulce d’oro di Tullio Pinelli nel 1935; e il “Carlo Felice” di Genova che cinque anni dopo rappresentò l’omonima operina tratta da quella commedia, per mano dell’autore, e musicata da Giorgio Federico Ghedini, musicista dal catalogo ormai abbastanza ricco, operista recente ma impegnato su tre lavori in pochi anni e orientato, in questo 1940, a evolvere verso uno stile pienamente novecentesco sul lontano esempio di Bartók e Stravinskij. Operina, commediola, farsetta non definita se non come “un atto in tre quadri” e dall’entusiasmo della critica accodata alla discendenza del Falstaff di Verdi, La pulce d’oro ha quasi lo spirito mordace dei vecchi intermezzi (che però erano in due, non tre scene), anche se è percorsa e conclusa dalle ventate di uno scetticismo piuttosto moderno; e in una bella prosa appena interrotta dal terzettino “L’uomo più ricco / di tutta la terra”, racconta una storiella originale e maliziosa. Durante una tempesta il giovane Lupo Fiorino (t.) ripara in una locanda e mostra ai presenti, in una gabbia, una grossa pulce di provenienza asiatica che tramuta in oro tutto quanto tocca o meglio pizzica (fuorché il cibo, guardacaso); mentre monta la curiosità di tutti, la pulce mattacchiona e ballerina vola via, e Lucilla (s.) figlia dell’oste lamenta di esserne stata punta; bisognerà scovare la pulce, ma Lupo che mettendosene alla ricerca deve frugare fra le vesti della fanciulla viene subito fermato dagli scandalizzati genitori di lei, Olimpio (br.) e Fortuna (c.). Lupo teme di perdere la sua miniera d’oro e loro temono che lui s’approfitti della situazione per darsela poi a gambe. In verità avrebbero piacere che il caso fosse galeotto, come pensano anche il merciaio Daghe (t.) e il carrettiere Mirtillo (bs.). I due giovani vengono chiusi in una stanza e ben controllati dall’oste; e Lupo che vorrebbe uscirne alla chetichella viene bastonato a morte e cacciato fuori dalla porta da Olimpio al punto che il vecchio Verna (bs.) dichiara di voler denunciare l’accaduto. Il mattino seguente Lupo bussa, si presenta malconcio ma vivo e chiede la mano di Lucilla, la quale assicura d’aver dormito della grossa e si dice favorevolissima alla proposta. I genitori sono d’accordo e i fidanzati vanno per la loro strada, lasciando esattamente insoluta la questione dell’insetto. Se proprio Lucilla non era d’accordo con Lupo, molto probabilmente la pulcetta era un’invenzione bella e buona, e certo a metà della notte Lupo voleva scappare, evidentemente non senz’aver combinato qualcosa lassù nella camera con Lucilla. Opera non corale ma assiemistica, certo memore della commedia musicale del ‘700 e, più indietro, del madrigale dialogico (o commedia armonica) dell’ultimo ‘500, nel suo andamento rapido e brillante La pulce d’oro ha presenti anche il Belfagor di Respighi e il Gianni Schicchi di Puccini, fors’anche il Campanello di notte di Donizetti e L’occasione fa il ladro di Rossini (che comincia con un temporale, un’osteria e un avventore lestofante); e lo stesso Respighi e Pizzetti sono i referenti di una partitura così scintillante di strumentazione, così svelta di ritmo e così ‘parlante’ di canto. Non mancano gli episodi liricheggianti, certi passi dei ragazzi smaniosi (l’assolo di Lucilla, “Piccola mamma, di che cosa hai paura?”) o anche degli anziani preoccupati, ma lo stile vocale prevalente è quello di una declamazione sillabica devota alla parola, nella fattispecie quindi non seriosa bensì vivace; e l’orchestra, che lievita alcuni temi personali come quello baldanzoso e quasi danzistico di Lupo, quello guizzante e quanto meno pungente della pulce, quello umoristico dei locandieri dubbiosi, altrove sa limitarsi alla batteria (onde sottolineare il pentimento di un Olimpio troppo manesco), sa servirsi a perfezione della celesta e degli ottoni, sa rumoreggiare com’è giusto che faccia un tempaccio notturno. Non c’è dubbio, se mai fosse vera l’ipotesi che vuole defunta l’opera comica prima dopo il Don Pasquale di Donizetti e poi dopo il Falstaff di Verdi, a dissipare ogni continuità di lutto nel pieno ‘900 La pulce d’oro di Ghedini contribuirebbe egregiamente; e non da sola, ma in compagnia di Wolf Ferrari, Malipiero, Petrassi, Rota, Negri e diversi altri. 5. Le baccanti Durante la guerra, poco prima di produrre un lavoro fondamentale come il Concerto dell’albatro del 1945, Ghedini era pronto per elaborare un’opera seria, lunga, ambiziosa, d’argomento classico, greco, tragico e ispirato nientemeno che a Euripide: dopo la liberazione, in contemporanea con un altro capolavoro come il Concerto funebre per Duccio Galimberti del 1948, rappresentò alla Scala di Milano Le baccanti, opera in un prologo e tre atti per cinque quadri di Tullio Pinelli che aveva composto nel 1941-43 subito dopo La pulce d’oro. Fra i drammi di Euripide Le baccanti (406 a.C.) è opera estrema, dell’ultimo anno di vita dell’autore e difatti rappresentata postuma: non è la più frequentata dal melodramma, che ha sempre preferito personaggi guidati o posseduti dall’amore come Alcesti, Antigone o Medea (a dire il vero anche la povera Ifigenia, più figlia e sorella che amante); ma quando, nella sua complessità, ha interessato gli operisti, non l’ha certo fatto nell’ambito del ‘700 classico, cortigiano e decorativo bensì nelle lande aspre e desolate del ‘900 espressionistico o neoclassico (o pressappoco). Dunque fra Die Bacchantinen di Egon Wellesz (1931) e Die Bassariden di Henze (1966), un po’ dopo le musiche di scena composte da Giuseppe Mulè per il Teatro Greco di Siracusa (1922), ecco quello che è probabilmente il frutto più sostanzioso dell’incontro fra il soggetto euripideo e la musica drammatica. A Tebe, davanti alla reggia: giunto dall’Asia, il dio Dioniso (br.) figlio di Zeus annuncia di voler impiantare il suo culto nella regione ed esorta i cittadini a seguirlo sul monte Citerone dove si svolgeranno i riti di iniziazione. I sacerdoti del tradizionale culto olimpico sono sgomenti, l’indovino Tiresia (bs.) vaticina il successo di una nuova divinità, il giovane Penteo (t.) rimprovera gli anziani di non aver protetto la città ma suo nonno Cadmo (bs), primo re di Tebe, risponde d’aver ceduto a una forza irresistibile. Molti tebani prendono la via del Citerone, guidati dalla madre del re Agave (s.) che s’è già convertita; ma altri trascinano al cospetto di Penteo un mago asiatico (Dioniso travestito) che ha persuaso prepotentemente la folla, e Penteo, inorridito davanti a un culto di corruzione, lo fa arrestare. Le donne furiose, cioè quelle già irretite e dette Baccanti o Menadi, si radunano davanti alla reggia per assistere alla vendetta del dio, che difatti si libera dalle catene grazie a una scossa di terremoto con tanto di fuoco e fiamme. Penteo, appena informato da un bifolco (bs.) che le donne e la madre stanno ammazzando le pecore del gregge e mangiando le loro carni, è avvicinato da Dioniso, che in maniera melliflua e ambigua lo invita a travestirsi da menade e a salire sul monte per verificare e intervenire, non senza alludere vagamente alla sua ora estrema. Penteo accetta, va con Dioniso, assiste ai riti, e le menadi, cui Dioniso comunica l’intollerabile presenza di un essere estraneo, lo aggrediscono e uccidono come bestia da sacrificare, essendo la stessa Agave che gli mozza la testa credendolo un giovane leone. Di notte, a Tebe, in piazza (dove intanto Cadmo è riuscito a ricomporre il corpo del nipote), le Baccanti scorrazzano e impazzano, e Agave mostra un tirso su cui ha piantato la testa di Penteo; Cadmo la raggiunge, le schiarisce la mente e la rende consapevole dell’orrore compiuto. Sconvolta, Agave si rivolge al dio chiedendo pietà, ma in risposta ottiene solo la malvagia condanna a errare per il mondo piangendo il figlicidio (mentre Cadmo sarà trasformato in drago). Fra le più vistose differenze con la fonte e altre versioni musicali: in Euripide si insiste sulla natura divina di Dioniso (figlio di Giove e Semele che era sorella di Agave e quindi zio di Penteo), negare la quale significa irritare il dio e istigarlo alla violenza; nel libretto per l’opera di Henze, firmato da Auden e Kallman (gli stessi del Rake’s progress di Stravinskij), se il tenore è Dioniso, il baritono è Penteo, personaggio dalle fantasie sessuali represse e riflesse in uno specchio durante Il giudizio di Calliope ovvero l’intermezzo fra il terzo e l’ultimo dei quattro movimenti del lungo atto unico. Barbaramente classico l’intreccio, modernissimo e postespressionistico il suo trattamento musicale, con più d’un riferimento a Strauss e Bartók. Ma attorno al 1940, mentre Malipiero e Pizzetti perseguivano le loro poetiche consolidate, l’uno con canzoni e l’altro con declamati ed entrambi con episodi sinfonici, mentre Dallapiccola decideva di applicare la sua visione italiana della dodecafonia e Petrassi cominciava solo a pensare al suo teatro poi così parsimonioso, solo un musicista ferrato e determinato come Ghedini era in grado di concepire una drammaturgia così nuova e vasta, uno stile così eclettico e amalgamato, una scrittura così equilibrata fra tonalità e paraggi di atonalità (nonché dodecafonia), con le armi sue principali ovvero la ritmica, implacabile anche nei passi lenti contrapposti o giustapposti ad arte a quelli veloci, e la strumentazione, violenta e massiccia nei passi d’azione e furore, statica e raggelata in quelli contemplativi o riflessivi, capace di ritrarre orge, sacrifici, deliri, uccisioni, gesti volgari e disumani in luoghi squallidi e tempi tenebrosi. Nessun affetto dolce e gentile, nessun sentimento d’amore allenta l’atmosfera dell’opera, che nonostante certe pause sommesse e quasi sospese (per esempio il finale primo, dopo la cattura) rimane potentemente unitaria e poetica: in una parola, tragica, alla maniera meno aggraziata e forse più autentica della grecità, e paragonabile, oltre che con l’Elektra vecchiotta di Strauss (1909), con l’Alceste vecchissima di Gluck (1767). 6. Billy Budd Pelléas? Wozzeck? il misterioso straniero di Pizzetti? il figlio “cambiato” di Malipiero? il pilota invisibile di Dallapiccola? Protagonisti di opere del ‘900 che non sono eroi ma antieroi, contro ogni mitologia settecentesca o epica ottocentesca, e che accolgono di buon grado la colleganza di Billy Budd, il protagonista e titolare della penultima opera di Ghedini. Billy Budd, atto unico di Salvatore Quasimodo dal racconto lungo di Melville, nacque alla Fenice di Venezia nel 1949, sul precetto dell’opera breve, da camera, facile da allestire; e nello spirito dell’opera-oratorio (qui al diminutivo) che ispirava il giovane Festival di Musica Contemporanea (correva appena il XII) ed era nell’aria da tempo, in un periodo che voleva reagire alla platealità del Verismo e conosceva già lavori del genere a firma di Stravinskij, dei francesi, di Britten. Proprio Benjamin Britten (1913 - 1976), nel 1951 al Covent Garden di Londra, doveva produrre la sua versione del soggetto, in un prologo, quattro (poi due) atti e un epilogo che conta molti personaggi e dà voce di narrante al primo tenore (ovviamente anche cantante; pertanto, e perché il protagonista è sempre baritono, l’antagonista diviene basso). Herman Melville (1819 - 1891) scrisse Billy Budd, sailor. An inside Narrative poco prima di morire, ma il singolare “racconto interiore” fu pubblicato solo nel 1924. Interiore, senza dubbio, nel senso di svolto nei recessi della psiche e del sentimento (anche del Tristan und Isolde di Wagner, definito Handlung cioè azione, s’è detto “azione interiore”), ma non per questo privo di scena, gesti, personaggi, addirittura spettacolarità, ché anzi è un gesto come un pugno fatale a far precipitare l’intreccio. Limpido e intenso come s’addice alla scrittura di un grande poeta lirico, il libretto di Quasimodo seleziona così la vicenda raccontata dal Corifeo (r.): sul vascello inglese Indomitable, nel 1797 (cioè mentre infuria la guerra fra l’Inghilterra e la Francia rivoluzionaria e bisogna stroncare o prevenire ogni ammutinamento dovuto alle circolanti idee libertarie), il giovane e ingenuo Billy (br.), un gabbiere (cioè marinaio addetto alle manovre alte sugli alberi e sui pennoni) appena reclutato, è tranquillo e operoso, ma ha destato prima l’antipatia e poi l’odio del maestro d’armi Claggart (t.), il quale lo accusa -falsamente- di ammutinamento al nobile capitano Vere (bs.); chiamato dal superiore, che invece l’ha in forte simpatia, Billy ascolta l’accusa, si confonde e innervosisce, secondo una sua caratteristica balbetta invece di rispondere, e non si trattiene dal tirare un pugno mortale a Claggart; costernato, pur convinto dell’infondatezza dell’accusa, Vere deve lasciar condannare Billy all’impiccagione per omicidio. Nel testo di Melville e nell’opera di Britten Vere comincia ricordando l’episodio cinquant’anni dopo e morirà col nome di Billy sulla bocca, e a proposito dello stesso Billy si fa anche il nome di Cristo (l’albero dove è stato impiccato come una croce simbolica per la gente di mare). Nulla di ciò nell’opera di Quasimodo e Ghedini, che anzi occulta o sfuma le implicazioni omosessuali fra l’introverso Claggart, il bellissimo Billy, il protettivo Vere (ancora una volta soccorre il capolavoro di Wagner, fra Melot, Tristan e Marke quasi quasi senza Isolde), commenta la storia come un esempio dei “misteri dell’iniquità” o del “disprezzo dell’innocenza” e di fatto riduce un po’ il solismo dei personaggi (tutti marinai, ovvio, e quindi maschi). Nel corso di undici scene, a volte brevissime, sono assidui il coro e la voce del corifeo, sopra l’assiduità tipicamente ghediniana dell’orchestra, e ai tre personaggi del dramma s’aggiungono appena il vecchio marinaio Abbordafumo (bs.), tre ufficiali incaricati del giudizio (t. br. bs.), un marinaio senza nome (t.). A cinque voci soliste (2 t. 2 br. e bs.), il coro comincia e finisce l’opera: comincia in Andante calmo, sugli archi in sordina, con un abbozzo di canzone marinara in 6/8 non immemore del Pilota di Tristano, e finisce in Lentamente-Andante, prima e poi citando l’“angelo Billy” capace di cantare ma non di parlare sul quale “s’è oscurato il mare” (le ultime battute, per violino); inoltre canta l’Allegro pesante “Ecco il giorno”, pieno di acciaccature e trilli, e la Ballata per Billy, un “corale” in Andante che compiange la sorte del giovane, muovendosi sempre in maniera omoritmica, con frequenti cambi di battuta (4/8, 5/8, 6/8) e diversi spunti melismatici. Da parte sua il Corifeo recita, come l’antico storico dell’oratorio, ma parecchio all’inizio, sul vuoto dell’orchestra, e sempre meno nel prosieguo, anzi sovrapponendosi all’orchestra nello stile del melologo e addirittura inserendosi fra le battute del canto. Quanto ai solisti, il duettino fra Billy e Abbordafumo che lo mette in guardia è un Andante misurato che sfocia in una chiassosa Scozzese con orchestra turca (flauto, ottavino, timpani, triangolo); il Canto di Billy “Lontana è Molly Bristol” (anche il Pilota di Tristan lamentava la lontananza dell’amata) parte sul pedale del corno dopo un tema di clarinetto; l’entrata muta del capitano prevede appena qualche accordo d’accompagnamento, ma timpani, grancassa in orchestra e grancassa sul palco; l’assolo di Claggart si concede vezzi vocalistici con la complicità dell’ottavino e del flauto; la scena dell’accusa è un Movimento di ciaccona che comincia con quattro violini soli e sotto al pugno improvviso che colpisce nel buio “come la fiamma di un cannone” pone rapide terzine di bassi (corno, fagotto, timpani, violoncello, contrabbasso); l’entrata dei tre ufficiali-giudici è una marcia per trombone, fagotto e corno. Quando poi Billy sta per cominciare il suo bel canto nostalgico di ritmo trocaico, il clarinetto suona il tema di ritmo giambico che poi risuonerà ancora, quasi subito nel momento in cui un marinaio informa un Billy assonnato e sbalordito della realtà di un ammutinamento. Billy un rivoltoso? No nel comportamento o nella parola; ma sì nell’anima, nella persona, nell’assurda conforma di bellezza e innocenza (come quel nome e cognome semplicissimi e allitterati) che al cospetto della volgarità del mondo è proprio come un pugno in faccia. 7. L’ipocrita felice Ancora un atto, comico stavolta, per chiudere il ventennio dell’impegno operistico di un autore vissuto 72 anni. Veramente L’ipocrita felice, opera in un atto di Franco Antonicelli, fu rappresentata alla Piccola Scala di Milano nel 1956, 19 anni dopo la prima Maria d’Alessandria, ma era già stata eseguita alla RAI nel ’52, in quanto opera appunto radiofonica vincitrice del Premio Italia col titolo di Lord Inferno, e questo restringe ancora di più il periodo di applicazione alla scena del maggior musicista italiano comparso fra Malipiero-Casella e Dallapiccola-Petrassi. Il librettista trasse l’intreccio da The happy Hypocrite di sir Max Beerbohm (1872 - 1956), scrittore inglese e umorista e caricaturista (a penna o acquerello) che aveva pubblicato il racconto nel 1897 (ma aveva visto tradurre in italiano solo nel 1947). E il musicista prima rispettò il mezzo radiofonico con un narratore recitante, altri passi parlati, musiche di scena atte a spaziare una vicenda solo da ascoltare, poi il nuovo mezzo teatrale e spettacolare, tramutando il narratore in tenore e ricolorando la timbrica dell’orchestra (una sua nota specificità). L’opera è una favola dichiarata: oppressa dallo squallore della vita, l’umanità vuole ascoltare una bella favola e il narratore (t.) racconta di Lord Inferno (br.) che, colpito dalla freccia del nano Garble (s.) alla maniera di Cupido, s’innamora della cara attrice Jenny Mere (s.), ma verrà ricambiato solo se avrà una faccia da santo; il giovane londinese si mette alla ricerca e nel negozio di Mr. Aeneas (bs.) trova la maschera giusta, indossando la quale diventa Lord Paradiso per la gioia e l’amore di Jenny; sopraggiunge la Gambogi (ms.), l’ex-amante che non fatica a sconfessarlo, ma la brava Jenny resiste alla perplessità e si tiene il suo lord che l’amore ha veramente trasformato in volto da paradiso. Il nanetto canta da capriccioso soprano di coloratura, la fanciulla da gentile soprano lirico, il protagonista non da tenore appassionato ma da baritono un po’ problematico, il narratore da tenore sentenzioso e non certo amoroso, e così via, nel corso di una favola divertente e moraleggiante già detta, nella prima versione radiofonica, “commedia armonica” in omaggio all’Amfiparnaso di Orazio Vecchi (una collana di madrigali del 1597) che al solito vive di brillantezza ritmica e timbrica (vedansi certi violini che guizzano con il Cupido nano, o i colori tenui e acuti dell’ottavino e dell’oboe che commentano il duettino d’amore). Ma Aeneas ricorda un po’ il coprotagonista del Dido and Aeneas di Purcell e il fatto che disponga di una maschera da santo allude forse all’antica pietas di cui lo dotava Virgilio; e più d’un caso ricorda Wilde. Se la maschera del protagonista infernale e paradisiaco sembra capovolgere quella di Dorian Gray (bello e giovane davanti, corrotto e decrepito dietro), la richiesta della faccia da santo non ricorda l’esigenza della signorina Gwendolen di amare solo uno che si chiami Ernesto in quanto sia earnest cioè serio e leale? Il ritratto di Dorian Gray è un romanzo del 1890, L’importanza di chiamarsi Ernesto una commedia del 1895. III. I folli voli di Dallapiccola 1. Il tempo e la figura Non era più tempo, attorno alla metà del secolo, di sfornare opere a dozzine e manciate di dozzine, alla maniera degli disinvolti maestri del ‘700 napoletano o veneziano, né di produrne in misurata quantità otto-novecentesca, alla maniera dei giovani maestri delle generazioni successive a Verdi; e mentre alcuni rappresentanti della vecchia guardia -Pizzetti e Malipiero fra i primi- continuavano come costoro, i compositori nati già dentro il ‘900 addirittura rischiavano spesso di mettere da parte, ignorare, misconoscere o disprezzare il teatro d’opera. Buon per il vecchio genere, dunque, se i maggiori musicisti italiani del secolo rispondenti ai nomi di Dallapiccola e Petrassi lo alimentarono l’uno con tre e l’altro con due titoli: poco di numero, certo, ma molto di qualità, e da parte, si badi bene, non di operisti senz’altro bensì di compositori attivi su tutti i fronti possibili dalla camera alla chiesa. Studioso e scrittore ricco di intuizioni (per esempio su Verdi), revisore di musiche lontane e vicine nel tempo (Monteverdi, Vivaldi, i Quadri di un’esposizione di Musorgskij), veramente Luigi Dallapiccola (Pisino d’Istria 1904 – Firenze 1975) ha coltivato tutti i generi: la musica da camera, per esempio con il prezioso e originale Quaderno di Annalibera per pianoforte (dedicato alla figlia nata nel ’44 poco dopo la liberazione di Firenze); la musica vocale per soli e pochi strumenti, con diversi canti di Alceo, Saffo, Anacreonte, Goethe, dell’anonimo ed epico Kalevala finlandese; la musica per orchestra, con il singolare capolavoro della Piccola musica notturna, e quella con solista, con le due Tartiniane per violino. Dalle giovanili Canzoni di Grado al presago Commiato del ’72 si stende poi il più folto catalogo per voce e/o coro con orchestra o notevole gruppo strumentale: l’organico varia sempre, fra coro maschile e femminile, soprano e baritono, grande e piccola orchestra, canto a cappella o su vario assieme strumentale; latini o italiani o altro, i testi provengono da poeti antichi e anonimi, Saffo, San Paolo, Sant’Agostino, Jacopone da Todi, Buonarroti il Giovane, D’Annunzio, Machado. Nei sorprendenti Canti di liberazione del ’55 (fondati sulla stessa serie del quaderno) i contenuti non divergono molto da quelli dei precedenti Canti di prigionia del ’38-41 che per coro misto, due pianoforti, due arpe, xilofono, vibrafono e percussioni leggevano il testo del Dies irae, la venerabile sequenza mediante un’impeccabile serie dodecafonica Questi canti di prigionieri condannati a morte (cioè di Maria Stuarda, Severino Boezio e Girolamo Savonarola) videro la luce a Roma il 1° dicembre del 1941, lo stesso giorno in cui l’Italia dichiarò guerra agli Stati Uniti d’America; e doveva essere una guerra particolarmente incisiva nella vita e nell’arte del maestro. Di buona famiglia d’origine trentina, Dallapiccola studiò musica privatamente a Pisino, Graz e Trieste mentre frequentava il liceo; nel 1922 era già a Firenze, pronto a iscriversi alla classe di pianoforte e poi di composizione del Conservatorio, e lo stesso anno compose un primo pezzo; nel ’26 cominciò a suonare in duo con il violinista amico Sandro Materassi, proseguendo tale carriera per una quarantina d’anni; nel ’34 ebbe la cattedra di pianoforte complementare al Conservatorio, che tenne fino al ’67 (senza ambire mai a incarichi direttivi né organizzativi, didattici o concertistici). Nel frattempo aveva avvicinato i maggiori musicisti dell’epoca, da Casella a Webern; aveva studiato i capolavori di Monteverdi, Verdi, Wagner, Mahler, di tanti altri dimostrando forti simpatie e anche alcune antipatie (Strauss) o indifferenze (Brahms); fin dalla trentina aveva potuto assumere una posizione preminente nell’ambito della musica italiana ed europea, come compositore sempre più eseguito, insegnante sempre più richiesto, personaggio sempre più onorato. L’attività artistica di Dallapiccola ha attraversato una quarantina d’anni essenziale per la musica italiana: iniziata verso la fine di quella di Respighi e nella pienezza di quella dei maestri dell’80 (Pizzetti, Malipiero, Casella), si doveva concludere nella maturità di Maderna, Nono, Berio e Manzoni, trovando un confronto legittimo qualitativo soltanto con Petrassi (peraltro esatto coetaneo). E partecipando autorevolmente al maggior contesto europeo (composto prima da Ravel, Schönberg, Berg, poi da Šostakovič, Messiaen, Britten), un maestro che non si è mai dato arie magistrali ha avuto sia la volontà di acquisire un linguaggio del tutto moderno come la dodecafonia (per primo nel paese, almeno compiutamente) che il coraggio di non rinnegare affatto la tradizione nazionale e internazionale (nemmeno quella romantica invisa ai più), sul fondamento cristiano-umanistico di considerare l’arte della musica elemento tanto dello spirito quanto della realtà, sia ferrea disciplina manuale che altissimo magistero etico. Nel complesso, oltre all’adesione sistematica della dodecafonia caratterizzano un catalogo particolarmente ponderato che ammonta a 71 numeri una melodia vicina alla modalità, un’armonia preferibilmente diatonica, una timbrica pura e squillante, un robusto contrappunto all’antica, una padronanza formale di ascendenza classica, infine una volontà comunicativa particolarmente attenta al canto e al palcoscenico. Donde i tre lavori accennati, Volo di notte, Il prigioniero, Ulisse, cui è opportuno aggiungere Job. 2. Volo di notte Dopo alcuni tentativi insoddisfacenti e quindi distrutti dall’autore, fu con Volo di notte, un atto da Vol de nuit di Antoine de Saint-Exupéry composto nel 1937-38 e dato alla Pergola di Firenze nel 1940, che Dallapiccola esordì nel teatro, in veste anche di librettista oltre che di musicista, insomma di vero drammaturgo musicale. “Nel concetto di dramma -ebbe a scrivere durante il lavoro- vidi soprattutto la soluzione artistica di un problema di crescendo: un crescendo di emozione che di solito si placa in una catarsi risolutiva. E va da sé che, nel dramma musicale, questa catarsi non può non spettare alla musica”. Certo questa convinzione era mutuata dall’estetica romantica e postromantica, ma da tali modelli Dallapiccola si distolse vistosamente nella scelta del soggetto, che doveva essere immediato e contemporaneo, magari alla maniera di Malipiero o di Milhaud, senza tracce della fiaba medievale di Casella o della mitologia greca di Pizzetti; e contemporaneo a tutti gli effetti era il romanzo di SaintExupéry, scritto nel 1931 e ambientato l’anno precedente in un aeroporto presso Buenos Aires. Il libretto consta di sei scene, che come intreccio (e quindi come musica) si corrispondono specularmente: la prima si specchia nell’ultima, la seconda nella quinta, la terza nella quarta; e più chiaramente la solitudine del direttore si pone all’inizio e alla fine, il racconto dei piloti subito dopo e subito prima, l’assieme delle discussioni sulla vicenda in mezzo. Il signor Rivière (bs.), direttore di una compagnia aerea che ha istituito dei voli notturni per migliorare il servizio postale, aspetta, di sera, il rientro di tre corrieri conversando col vecchio caposquadra Leroux (bs.); rientra quello del Cile, il pilota Pellerin (t.) alla cui amicizia il direttore impone all’ispettore Robineau (bs.) di essere indifferente, mentre di quello che è in viaggio dalla Patagonia, Fabien, s’apprende che sta incontrando gravissime difficoltà (dalla scarsità di carburante alla furia scatenata degli elementi); quattro impiegati (t. t. br. bs.) si pongono domande sull’opportunità di questi voli notturni, ma l’impassibile direttore conferma un altro volo, imminente, per l’Europa; a chiedere notizie viene la signora Fabien (s.), che disgustata dal cinismo di Rivière lo accusa apertamente ma non tarda a essere congedata; il radiotelegrafista (t.) comunica via radio le fasi del disastro e la fine del pilota, del quale riproduce le tragiche, esterrefatte, sublimi parole ultime; s’annuncia il rientro del terzo corriere, da Asunción nel Paraguay, ma gli operai e le maestranze (coro) dell’aeroporto pretendono che non si facciano più esperimenti così pericolosi; imperterrito, Rivière ordina invece la partenza del corriere d’Europa, entro cinque minuti; e dopo un ultimo colloquio con l’ispettore rimane solo, nella notte, con la sua ferrea determinazione. Ha fatto bene, Rivière, o ha fatto male? è un malvagio, un folle, un idealista? si comporta da essere umano o da macchinetta? Se il problema generale del teatro di Dallapiccola riguarda la lotta fra l’uomo che agisce e le forze che gli sono superiori, questo problema particolare di Volo di notte insiste sulla misura, sul limite, sul punto d’arresto dell’azione stessa: che è sempre difficilissimo, forse impossibile individuare. Certo è grande la compassione dell’autore sulla sorte dei deboli e dei vinti, qui il pilota, la moglie, gli altri personaggi, ma anche sul protagonista cade uno spesso velo di pietà se non di misericordia, su colui che facendo un mestiere così moderno e lavorando in un ambito di sviluppo tecnologico non può lasciarsi distrarre da incidenti di percorso. Si disse allora che Rivière dava volto a un despota come Mussolini, ed era falso, come sarebbe assurdo immaginare che dietro quella figura stesse un tiranno dell’arte musicale come Schönberg, amato da Dallapiccola anche se secondo alcuni già colpevole d’aver condizionato il cammino del contemporaneo (l’accusa di Pierre Boulez, del resto, doveva scattare una decina d’anni dopo, nel 1952, l’anno seguente la morte del maestro). Ma se sul povero Rivière cade la prosa dell’agire umano, sul poverissimo Fabien aleggia tutta la poesia relativa, in lui che appressandosi alla morte vede una luce speciale, sembra rapito in estasi, dice di essere ormai “senza essenza” (col colpo di genio di esprimersi mediante la voce di un altro). Dunque è lui che vince? in Volo di notte vince chi perde? diversamente, perdono e vincono tutti e due, Rivière e Fabien: vincono perché operano, provano, si cimentano; e perdono perché osano, perché ambiscono, perché presumono, alla maniera degli eroi greci che si macchiano del peccato di hybris e vengono regolarmente puniti dalla superba e perfino invidiosa onnipotenza degli dei. Unico rimedio, quello di Job e di Ulisse cui Dallapiccola perverrà più tardi, a mo’ di avanzamento e conclusione di un ciclo ideale: la cecità e l’illuminazione della fede. Appunto più tardi, perché al suo singolare eroe associò anche sé stesso: “e non si voglia dare un’interpretazione troppo malevola se affermo di avere, come il Signor Rivière, una fede illimitata nel futuro”. Partitura diretta, rapida, precipitosa, Volo di notte disdegna ogni forma di lirismo e quindi di staticità, ma nel suo stringente decorso si costruisce sopra modi e comportamenti musicali diversi fra diatonismo e cromatismo, modalità e dodecafonia, sul fondamento di un’“attenzione per il suono puro, adamantino, stellare, quasi riconquistato alla musica del nostro tempo nella sua primordiale essenza” (Sablich): elabora spesso temi e serie delle Tre laudi per voce acuta e 13 strumenti, lavoro composto nel 1936-37 e cioè immediatamente prima; assume frequenti forme prestabilite, si direbbe classicheggianti nella loro schiettezza; ogni tanto si apre volentieri a parentesi stilisticamente diverse ed eventualmente anche polari; e nel canto spazia dal parlato puro al parlato ritmico, dal declamato ritmico “con un po’ di suono” al declamato ritmico “quasi senza timbro”, ovviamente dal solismo all’assieme vocale grazie con tanto di condotta melodica ariosa e cantabile. Infatti la prima scena comincia citando la lauda I (“Altissima luce”), comprende la canzonetta “Amore, gioia del mondo” e finisce con un movimento di blues; la seconda cita la lauda II (“Ciascun s’allegri”); la terza comprende un “pezzo ritmico”; la quarta cita la lauda III (“Madonna sancta Maria”); la quinta è un corale con variazioni e finale e cita la lauda I (“Stella marina”); la sesta è un coro con inno e termina con la stessa citazione laudistica dell’inizio. In linea generale la perfezione della struttura ricorda la bravura tecnica di due compositori amati da Dallapiccola come Busoni e Berg (Lulu è evidente nel “pezzo ritmico”, Wozzeck nel pezzo jazzistico) e la pur libera adozione della dodecafonia, accolta a scopi più espressivi (coloristici e melodici) che formali, testimonia la profonda devozione alla Scuola di Vienna. In particolare merita il sottile, sempre mirato trattamento della musica delle laudi: il tema iniziale di queste che consta di una serie di dodici note (e procede sulla sua retrogradazione, cioè all’indietro, dall’ultima alla prima), per esempio, compare nell’introduzione alla prima scena (La - Do# - Do - Si - Re# - Re - Sol# - La# - Fa# - Sol - Mi - Fa), ritorna nella descrizione della caduta dell’aereo e sotto le parole “Scorgo le stelle!”, e ricompare nell’ultima scena, appunto sempre per sottolineare il testo, per “fare il dramma” (secondo il significato della drammaturgia); e per altri esempi l’atterraggio del corriere del Cile sollecita una lauda di allegria e la domanda della donna “Ritornerà? potrà tornare?” quella lauda, invece, che chiede a Maria “recevi chi vol tornare”. 3. Il prigioniero Un’altra donna straziata dal dolore, un’altra vittima delle convenzioni umane, un altro protagonista dell’autoritarismo ma probabilmente gravato dalla slealtà più nera si trovano nel successivo lavoro teatrale di Dallapiccola, ancora in veste di librettista e musicista: Il prigioniero, un prologo e un atto tratti da due fonti, La torture per l’espérance di Philippe Auguste Villiers de l’Isle-Adam e La légende d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak di Charles de Coster, eseguito alla RAI di Torino nel 1949 e rappresentato al Comunale di Firenze nel 1950. Nella Spagna della seconda metà del ‘500: una povera Madre (s.) lamenta la sorte del figlio che si appresta a visitare in carcere, e intanto si dice perseguitata da un sogno consistente nell’immagine del tiranno Filippo II che si trasforma in quella della morte; il figlio Prigioniero (br.), di notte nei sotterranei dell’Official di Saragozza, riceve la madre, cui narra come il carceriere l’abbia chiamato fratello riaccendendo in lui la speranza della libertà; rimasto solo, il prigioniero è raggiunto proprio dal Carceriere (t.), che lo chiama ancora fratello e lo esorta a sperare sul serio, giacché le Fiandre si sono ribellate alla dominazione spagnola e a Gand s’è verificata la sollevazione dei Pezzenti; lui riprende fiducia, s’avvicina alla porta, la trova aperta e se ne precipita fuori; quindi attraversa un lunghissimo corridoio, dove incontra un certo fra Redemptor (m.) che maneggia uno strumento di tortura e due Sacerdoti (t. br.); finalmente esce, guarda le stelle che lo abbagliano, si accosta a un grande cedro e allarga le braccia per cingerlo amorosamente ma da dietro l’albero vede spuntare altre due braccia umane che lo cingono a loro volta, mentre l’uomo lo chiama fratello; è il Grande Inquisitore (t.), nessun altro che il carceriere di prima, il quale si appresta a condurre al rogo, dicendosi certo di salvare così l’anima sua, chi allora, impotente a fare altro, si chiede cosa sia la libertà. Secondo la precisa dichiarazione dell’autore (che nel libretto a stampa pone note, citazioni, testi), la fonte primaria del testo è uno dei Nouveaux contes cruels del conte De l’Isle Adam (con la geniale novità del personaggio della madre), e la fonte secondaria l’altra citata, relativa all’epopea fiamminga; ma con qualche altra aggiunta e cioè La rose de l’infante di Victor Hugo circa la figura di Filippo II, l’Implorazione (poesia) di Lisa Pevarello per l’assolo “Signore, aiutami a camminare” del prigioniero appena fuggito, alcuni versetti salmodici. Tale complesso e pur organico Prigioniero comparve alla mente di Dallapiccola nel 1939, fu elaborato come testo nel ’43 e dopo tutti i disagi del regime e della guerra (a loro volta molto influenti sulla scelta dell’argomento e anche sulla visione generale) fu composto come musica dal ’45 al ’48: dopo le prime esecuzioni accese sì vivaci discussioni di interpretazione ideologica ma ebbe anche grande fortuna, passando ad altri teatri e profilandosi subito come uno dei capolavori del teatro musicale italiano ed europeo del ‘900. Le sette parti dell’opera sono simmetriche quasi come le sei di Volo di notte e certo come le tredici parti di Ulisse: il prologo visionario corrisponde all’epilogo tragicamente realistico, il primo intermezzo corale che sta nella seconda parte corrisponde al secondo della sesta parte, la terza parte ovvero prima scena corrisponde alla quinta parte ovvero terza scena come sospirata espressione della speranza, la seconda scena ovvero parte centrale rimane irrelata ed è il vero centro dell’opera, quel momento, quella incredibile parentesi che inneggia alla libertà (da parte di un personaggio il cui appellativo la nega immediatamente, il prigioniero). Perfetta anche la forma musicale: il coro è sempre interno, si fa sentire nelle sue due parti e un po’ nell’ultima, canta in latino (“Fiat misericordia tua” e “Domine, labia mea aperies”, seguiti da “Languendo, gemendo et genuflectendo…” dei Canti di prigionia composti nel 1938-41); la madre canta la ballata “Vedo! lo riconosco” e il carceriere l’aria in tre strofe “Sull’Oceano, sulla Schelda”; l’orchestra suona tre ricercari durante l’angoscioso passaggio nel corridoio. E completa la padronanza e la disinvoltura dell’impiego della tecnica dodecafonica, che applicandosi tanto al solismo quanto alla polifonia salda tutta la partitura nell’aspetto sia di serie complete sia di “combinazioni dodecafoniche variate”: le serie fondamentali sono tre (la prima constante di Sol# - Si Re - Sol - Fa - Si bem. - La - Re# - Mi - Do - Do# - Fa#); i tre accordi iniziali in Fortissimo intonano, anzi dissonano (con le loro settime maggiori parallele) un segnale di morte poi ricorrente; dal primo dei tre deriva la serie della “preghiera” che con quelle del “fratello” e della “libertà” è la fondamentale dell’opera; dal gruppo deriva anche un tema che dà voce alla campana di Gand (la leggendaria Roelandt, al servizio dei pezzenti rivoltosi); i ricercari si ispirano a un contrappunto dodecafonico non immemore della tripla fuga del Wozzeck di Berg; un inciso speciale musica l’ambigua parola ‘fratello’ (tre note su tre sillabe con intervalli sempre minori, di seconda o di terza, ascendente o discendente). Ma che fratello sia per il Prigioniero quel sinistro Grande Inquisitore che si svela irremovibile dopo essersi presentato come Carceriere mite e sodale, non è poi chiarissimo: è vero che gli infligge l’ultima tortura, quella della speranza da vanificare spietatamente, ma è anche vero che lo tratta con “sincera pietà”, gli dice “coraggio”, gli promette la salvezza (mediante il rogo della purificazione): è un carnefice particolarmente malvagio, addirittura sadico oppure un triste alfiere della regola, della convenzione, dell’ortodossia davvero interessato a salvare, nell’aldilà, il suo prigioniero? Certo questo antagonista ha qualcosa del signor Rivière; e forse lui e il prigioniero hanno qualcosa del Grande Inquisitore e del Cristo che campeggiano nell’episodio dei Fratelli Karamazov di Dostoevskij poi musicalmente trattato, oltre che da un oratorio di Boris Blacher (Der Grossinquisitor del 1942), da un’opera di Renzo Rossellini, La leggenda del ritorno del 1966: anche qui, come là, si affastellano ideali di segno opposto, conclusioni piuttosto libere (Cristo redivivo condannato nel narratore russo, liberato nel musicista italiano), perfino baci e abbracci, e sempre la perenne, inquietante domanda sull’essenza della libertà. 4. Job Fra le due prime del Prigioniero Dallapiccola fece eseguire i Tre poemi per voce e orchestra da camera dedicati al 75° compleanno di Schönberg (nel 1949, nemmeno due anni prima della morte); e subito dopo produsse Job, una sacra rappresentazione tratta dal Libro di Giobbe che fece rappresentare al Teatro Eliseo di Roma nel 1950. Da qualche tempo Guido M. Gatti gli aveva proposto di scrivere per l’associazione romana dell’Anfiparnaso che intendeva incoraggiare l’opera cosiddetta da camera sul modello di generi antichi come i misteri medievali; e lui aderì con questo Job d’ispirazione biblicooratoriale, che intanto gli permetteva anche di continuare il discorso aperto con Volo di notte e Il prigioniero, di dare una risposta ai quesiti messi in campo, di reagire alle aspre critiche di anticlericalismo e irreligiosità mosse contro il suo Grande Inquisitore. Consultò una, due, tre, ben 34 edizioni del Libro di Giobbe, diverse di lingua, traduzione e commento, e ne costruì un libretto di lingua dura, arcaica, rituale (come già il latino dell’Oedipus rex di Cocteau-Daniélou e Stravinskij), in sette parti per dieci personaggi-coro. Orbene: Job (bs.-br.), che lo Storico (r.) definisce uomo giusto e timorato, si vede privato da Dio (coro) dei suoi beni, che quindi passeranno a Satana (coro); difatti quattro messaggeri (s. c. t. br.) gli comunicano la distruzione di casa, greggi, servi, figli, ma lui benedice ugualmente il nome di Dio; Dio consegna a Satana anche la persona di Job, che quindi viene aggredito dalla lebbra e, visitato dai tre amici Elifàz, Baldad e Zofàr (idem), viene invitato a pentirsi di qualcosa che gli abbia provocato la malattia; solo e incattivito, Job chiede a Dio la ragione di tale destino; Dio risponde, alteramente, e lui, che ha capito, si pente; alla fine, lo Storico riferisce che Dio ha restituito Job alla sua prima condizione. Ma pentirsi di che? ecco la nuova domanda di Dallapiccola che musica uno dei miti prediletti dall’oratorio a cominciare dal capolavoro secentesco di Carissimi: pentirsi di non essersi fidato, di non aver creduto ciecamente, di non essersi esentato dall’avvicinare e interrogare la Divinità con la sua volontà imperscrutabile, infine di aver osato confrontarsi, piccolo uomo qual era, con Chi aveva creato tutte le cose. Così Dallapiccola scioglie certi enigmi posti con le opere precedenti, risponde agli attacchi di carattere personale, conferma la sua intatta fede religiosa; e coglie anche l’occasione di mettere a tacere i censori della sua arte (per un attimo assurgendo a immagine di artista superiore, quasi divino, e forse ricordando il Wagner autobiografico di Lohengrin). Dio e Satana, in Job, si esprimono coralmente, a quattro voci non affatto cantate bensì parlate su qualche indicazione diastematica o meglio intonate su serie di note spesso uguali d’altezza e di valore, e stereofonicamente in punti diversi della “scena”; ma quando Dio si degna di rispondere alla domanda di Job, allora le sue parole corali sono cantate con grande dispiego d’intervallistica, prima alternate all’organo e poi accompagnate dallo stesso, mentre dietro la scena due corni, due trombe, un trombone intonano la melodia del Te Deum gregoriano, ed è un canto statuario, energico, soggiogante, “impetuoso”, “tumultuoso”, perfino “furioso”, che pone il suo autore a fianco di artisti esegeti della Divinità come Dante e Michelangelo. Lo Storico racconta come nell’antica tradizione oratoriale e recita come in certa produzione contemporanea promiscua di opera e oratorio (il citato Stravinskij, Il castello del principe Barbablù di Bartók, Le roi David di Honegger, A survivor from Warsaw di Schönberg, Paradise lost di Penderecki); e gli altri personaggi, specie il protagonista, cantano, declamano, recitano intonati con la massima varietà ed efficacia, anche là dove si raccolgono in terzetto di amici o quartetto di messaggeri. Agli strumenti citati e a quelli tradizionali s’aggiungono poi celesta, pianoforte, arpa, xilofono e vibrafono: tutti invitati, gli strumenti e i canti con tutti gli accorgimenti contrappuntistici possibili, a onorare un’unica serie dodecafonica, quella che unisce lo Storico e Dio (il descrittore, effettivamente, e l’artefice della vicenda) e che diventa quella di Job retrogradando (cioè leggendosi dall’ultima alla prima nota). Alla fine, dopo il gigantesco fugato del rimprovero di Dio, la pace fatta si esprime con due flauti che si intrecciano nella loro limpida serialità, su linee che sono una diretta e una retrograda ma non più trasposte o interrotte come prima, alla maniera, quasi, dello “stretto” di una lunga e “divertita” fuga bachiana. 5. Ulisse Un’unica serie dodecafonica innervava Job, per la prima volta in una partitura dallapiccoliana di una certa ampiezza; e correva il 1950. Dopo, gli anni ’50 registrarono una bella impennata di notorietà, per un autore che continuava a comporre incessantemente e sfornava canti, variazioni, dialoghi, preghiere, liriche, divertimenti, e sebbene da decenni si sentisse girellare e ronzare in testa un magnifico protagonista d’opera solo verso il 1959-60 cominciò a dedicarsi alla sua terza e ultima opera, assai più complessa delle precedenti e altrettanto più serialmente sistematica. Ulisse, opera in un prologo e due atti rappresentata (in versione tedesca) alla Deutsche Oper di Berlino nel 1968 (in versione italiana alla Scala di Milano nel 1970), fu veramente il risultato di un’intera vita artistica e culturale, come ebbe a dire l’autore poeta e musicista, perché lavoro a lungo impegnativo, lavoro della piena (e pressoché ultima) maturità, lavoro scaturito da letture e riflessioni assidue e lontane nel tempo (primo lampo d’interesse era stato un film muto visto nel 1912). Fonte e modello venerato l’Odissea di Omero, con passi e spunti da opere di Eschilo, Ovidio, Orazio, Virgilio, Cicerone, Seneca, Stazio, Tennyson, Dante, Pascoli, Proust, Joyce, Cavafis, Mann, Hauptmann, Machado, ma non secondo la prassi del mero collage tipica del tardo ‘900 bensì secondo una stesura scenico-discorsiva esistente ed evidente (fatto estraneo all’incollaggio disparato di citazioni) oltre che capace di assimilare e sfumare impercettibilmente tanta varietà di suggestioni. Primo provvedimento fu il sacrificio della lunga telemachia, quella serie di libri omerici (I-IV) che raccontano le azioni di Telemaco alla ricerca, sì, del padre Ulisse ma in assenza dell’eroe, e quindi inutili al suo massiccio protagonismo; altra difficoltà il lunghissimo racconto (VII-XII) che Ulisse fa ad Alcinoo e alla sua corte, diéghesis cioè comoda narrazione da trasformare in mímesis cioè rappresentazione e quindi sciogliere, mostrare in episodi reali. Come sempre sensibile al fascino della numerologia e all’imperativo dell’organicità, Dallapiccola scrisse il libretto ordinandolo in tredici scene, dove le prime sei e le seconde sei si corrispondessero lasciando sola e irrelata la settima, quella mediana, nell’arco esatto di tre giornate. Il prologo ovvero prima scena spetta a Calypso (s.) sola e abbandonata davanti al mare, come l’ultima scena che fa da epilogo spetta a Ulisse (br.) solo e di nuovo in mare; la seconda scena, per orchestra sola alla presenza del furioso Poseidone, corrisponde alla dodicesima, con Ulisse e Penelope (s.) tacenti e sospesi su orchestra sola; la terza, con la danza del gioco della palla (coro), la leggiadria dell’ammirata Nausicaa (s. leggero) e l’apparizione finale di Ulisse, corrisponde all’undicesima, con il volgare banchetto dei Proci, la danza della morte dell’allarmata Melanto (ms.-c.), la comparsa finale e la vendetta di Ulisse; la quarta, con Ulisse che teme davvero di essere Nessuno presso la reggia di Alcinoo (bs.-br.), corrisponde alla decima, con Antinoo (br.) che definisce Nessuno il reduce travestito da mendicante davanti alla reggia di Ulisse; la quinta mette in scena la rivolta dei compagni di Ulisse e la serenità dei Lotofagi come la nona la serenità del paesaggio di Itaca presso il porcaro Eumeo (t.) e il presentimento della vendetta, la sesta separa Ulisse da Circe (ms.-c.) che graverà sempre sulla sua memoria come l’ottava separa Ulisse da Nausicaa che chiede soltanto di non essere dimenticata; la settima, posta nell’esatta metà, riguarda la discesa di Ulisse agli inferi e il regno dei Cimmerii (coro parlato) ovvero dei defunti. Altri personaggi dell’intreccio -qui molto riassunto per mettere in rilievo le corrispondenze- sono il cantore Demodoco (t.), l’indovino Tiresia (t.), la madre Anticlea (s. drammatico), i proci Pisandro (br. leggero) ed Eurimaco (t. leggero), Telemaco (ct.), due ancelle (s. c.), in una cornice corale molto frequente e specie nella prima metà. Per precisa volontà dell’autore certi personaggi paralleli vanno affidati allo stesso interprete, e sono le coppie Calypso-Penelope (dea e donna eroica), Circe-Melanto (maga e donna corrotta), Demodoco-Tiresia (cantore del passato e profeta del futuro). Se le Ombre mormorano solo pianto, lacrime, dolore, rimorso e orrore, a Ulisse la madre dice di essere morta di dolore per lui per dileguarsi rapidamente e Tiresia vaticina la vendetta ma anche l’eterna inquietudine che lo riporterà al mare: un messaggio d’assieme disperato, opposto a quello positivo, fiero, raggiante di Omero che congiungeva l’eroe alla patria, alla casa, alla famiglia e diverso, nella sua disperazione, anche da quello di Dante, che nel XXVI canto dell’Inferno condannava Ulisse alla pena dei mali consiglieri (colpa l'espediente del cavallo di Troia) dopo averlo fatto naufragare in faccia al Purgatorio. Ma la varietà delle soluzioni tipica della mitologia prevedeva per Ulisse altri viaggi, altre mogli, altri figli, altre morti, ben oltre la linearità di Omero; ed era quanto meno prevedibile anche che l’eroe dinamico e motorio per eccellenza sentisse così forte il richiamo del mare da imbarcarsi di nuovo. Una volta imbarcato, l’Ulisse di Dallapiccola che ha incontrato e poi lasciato tante donne, che con Penelope non ha nemmeno duettato d’amore, è ancora una volta solo: canuto come il mare, sempre circondato dall’ignoranza o meglio dal mistero del mondo, ossessionato dall’incapacità di capire quanto vede e continua a vedere pur con meraviglia, incapace di pronunciare parole sensate e in grado solo di articolare sillabe assurde, guardando le stelle e sembrandogli di guardarle diversamente dal solito (non solo geograficamente, per lui viaggiatore), di colpo, “quasi per improvvisa illuminazione, ha la sensazione della scoperta di Dio, e questa scoperta lo libera dalla solitudine” (Dallapiccola). “Son soli, un’altra volta, il tuo cuore e il mare” aveva detto Calypso pensando al fuggitivo e certa che la sua meta non fosse quella placidamente domestica che dichiarava; e “Signore! Non più soli sono il mio cuore e il mare” dirà Ulisse alla fine, altrettanto riflessivo ma più umile di quello di Dante e quindi di lui molto, molto più meritevole (e appena sfiorato, forse, dal peccato di hybris nell’ostinata ricerca di un’altra meta). Dirà e getterà la maschera, ché quel Signore non è mica lo Zeus dei Greci (del quale il figlio di Laerte sarebbe anche discendente) bensì il Dio dei Cristiani, onde dietro la figura di Ulisse si staglia evidentemente la persona di un uomo moderno, anzi un vero e proprio simbolo dell’uomo moderno. Ecco dunque che nel volto di un personaggio, come dire? sintetico come questo Ulisse dal percorso precedente dell’autore fanno capolino e occhieggiano qua e là Fabien, il Prigioniero e Job (non certo Rivière o l’Inquisitore; né Marsia, il cantore protagonista del balletto omonimo che finisce scorticato dallo sfidato Apollo). E con loro, ovviamente da altre direzioni, anche altri personaggi: Faust, il grande deluso dalla vita; Mosè, il profeta privilegiato dal dialogo con Dio; e Andrej Bolkonskij, il singolare, apparentemente inconciliabile personaggio di Guerra e pace di Tolstòj. Irrequieto e cangiante più di Ulisse (magari più sfumato e meno amante), dopo numerose esperienze l’ambizioso principe Bolkonskij capisce a fondo l’essenza della vita e incontra l’inattesa divinità soltanto quando, ferito dopo la battaglia di Austerlitz perduta dai suoi russi contro i francesi di Napoleone, è costretto a guardare in alto, scruta nel cielo e vede tutte le cose dell’universo raccolte in uno, tutta la creazione intrinsecamente coesa e quindi facilissimamente interpretabile: proprio come lui fa l’Ulisse di Dallapiccola, e diversamente da parecchie personificazioni del Faust di Goethe (quello di Gounod redento dal sacrificio di Margherita, quello di Berlioz irrimediabilmente dannato, quello di Boito perso in un sogno di regale filantropia, quello di Busoni tolto di mezzo nonostante la rinascita del figlioletto) e soprattutto dal Moses dell’ammiratissimo Schönberg che chiude il secondo atto di Moses und Aron (1930-32, ma incompiuto) invocando la parola, la parola che gli manca. Il poeticissimo verso finale, “Signore! Non più soli sono il mio cuore e il mare” (tratto da una lirica del diletto poeta spagnolo Antonio Machado), affiora nella veste musicale poco dopo lo scoppio dell’orchestra pressoché al completo, in Fortissimo (FFF), sulla nota Sol# (simbolo di rivelazione confermato in due lavori successivi, Tempus destruendi / Tempus aedificandi e Commiato); per l’invocazione a Dio esige uno Sprechgesang in Pianissimo (PPP) e poi alterna canto e parlato (questo su “sono il mio cuore”, cinque asterischi d’intonazione generica, tre bassi e due centrali); sull’ultima, fatale parola ‘mare’ si apre a un breve disegno cromatico in quintina; quindi confluisce nel suono della celesta, dell’arpa e degli archi che chiudono dissolvendosi “come una parentesi”. Senza vocativo e senza negazione così aveva detto Calypso, all’inizio dell’opera, con un disegno uguale prima nel ritmo e poi nella melodia; ed è, questo, appena un esempio dell’assoluta organicità di una partitura condotta con la tecnica del serialismo integrale o serializzazione totale, quella che estende il principio di non ripetibilità della nota (fondato da Schönberg con la dodecafonia) agli altri parametri del suono ovvero al timbro, alla durata, all’intensità, alla dinamica, al modo d’attacco ed era stata ideata da Webern (per essere poi codificata da Boulez e Stockhausen). Evidente nelle due versioni sonore del verso citato, un “ritmo principale” stranamente impostato sulla pausa tesse l’orditura musicale dell’opera, campeggiando nella “quasi aria” di Anticlea posta al centro suo e del percorso protagonistico; ma ad assicurare l’organicità della partitura deve essere soprattutto il sistema delle serie dodecafoniche: fondamentale è la serie detta del Mare I, che si muove ondeggiando all’interno di un’ottava sopra le note Re bem. - Do - Re - Mi bem. - La - La bem. - Fa - Mi - Sol - Fa# - La# - Si, dove spicca la frequenza degli intervalli di seconda minore e seconda maggiore, e ovviamente si dispone al modo retrogrado (dalla fine all’inizio, cioè dal Si al Re bem.), all’inverso (con intervalli capovolti, dal Re bem./Do# al Re ecc), all’inverso retrogrado (Re# - Mi ecc.); poi, con artifici di trasposizioni, divisioni in esacordi (o mezze serie), accorpamenti di esacordi in nuove serie, deformazioni e così via si hanno le serie dette del Mare II, di Ulisse (dove il primo esacordo è l’inverso del primo di Mare I e il secondo il retrogrado del secondo di Mare II), di Calypso, di Nausicaa, di Demodoco, dei Lotofagi, di Circe, dei Cimmerii, di Antinoo. Al folto sistema seriale discendente dalla prima serie e agli altri aspetti del serialismo s’aggiunge infine il reticolo di autocitazioni, di frammenti tematici ricorrenti, di singole parole-suono ricorrenti anch’esse (come ‘mare’, ‘nessuno’, ‘meravigliarsi’). “Fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te” (Ci hai fatto per te e il nostro cuore è inquieto fino a che non riposi in te), aveva scritto Sant’Agostino nelle Confessioni, e così Dallapiccola trascrisse in calce alla partitura, artista ed esegeta qual era della sua opera, della sua idea del mondo, della visione del mondo dell’uomo moderno. Così moderno, questo Ulisse riassunto e rigenerato da Dallapiccola, da diventare un altro rispetto alle precedenti e numerose intonazioni del suo splendido mito: a parte alcune opere dedicate a Telemaco (Campra, Gluck), Circe (Anfossi, Egk) e Penelope (Cimarosa, Fauré), i melodrammi, le cantate, le serenate, i balletti intitolati a Ulisse lambiscono la quarantina, fin dal lontano ed eccellente Ritorno di Ulisse in patria di Claudio Monteverdi (1640). Nella cui partitura manoscritta compaiono solo il canto, il basso continuo per l’accompagnamento e cinque parti per le brevi sinfonie e i ritornelli senza veruna indicazione di strumento (da individuare grazie alla chiave dell’armatura e all’espressione del brano). Questa, invece, l’orchestra straordinaria voluta da Dallapiccola, particolarmente filopercussiva anche se non poi tanto sonora: ottavino, 3 flauti, 2 oboi, corno inglese, clarinetto piccolo in Mi bem., 2 clarinetti in Si bem., clarinetto basso in Si bem., sax contralto in Mi bem., sax tenore in Si bem., 2 fagotti, controfagotto, 4 corni in Fa, 3 trombe in Do, tromba bassa in Do, 3 tromboni, tuba contrabbassa, 2 arpe, celesta, glockenspiel, pianoforte, vibrafono, xilomarimba, xilofono, organo, timpani, 3 campane, 2 piatti ordinari, 3 piatti, 3 tam-tam, 3 temple blocks, 3 tom tom, 3 tamburi di piccolo formato, 5 tamburi (ordinario, piccolo, di legno, militare, basco), grancassa, maracas piccola, triangolo, frusta, violini I, violini II, viole, violoncelli, contrabbassi. IV. Due volte Petrassi 1. Musica secolare Più musicista, più maestro, più mente e mano musicale di così è impossibile. Forse Schönberg nello stesso ‘900, forse Liszt nell’800, forse il vecchio organista Claudio Merulo nel ‘500 hanno fatto, lavorato e costruito tanto, nel corso di vite piuttosto lunghe, fra composizione e insegnamento, varie altre forme di attività personale e di partecipazione alla vita pubblica. Dopo qualche lezione privata, solo a ventiquattro anni Goffredo Petrassi (Zagarolo [Roma] 1904 – Roma 2003) doveva iscriversi al Conservatorio di S. Cecilia, per diplomarsi rapidamente in composizione nel 1932 e subito dopo, nel ’33, in organo. Da allora in poi ha svolto una vastissima attività didattica, organizzativa, artisticodirettiva e direttoriale tra S. Cecilia (1934-74), la Fenice di Venezia (1937-40), l’Accademia Filarmonica Romana (1947-50), la Società internazionale di musica da camera (1954-56), l’Accademia Musicale Chigiana (1966-68), il Mozarteum, diverse istituzioni americane e giapponesi e così via, meritando onorificenze, aggregazioni accademiche, titoli di ogni sorta da ogni dove. Instancabile, intanto, procedeva però l’attività produttiva: infatti il ricco catalogo, pur privilegiando la musica orchestrale, corale e vocale con strumenti, numera anche pezzi pianistici e vocali da camera (in verità piuttosto indietro nel tempo), pezzi strumentali da camera (avanti nel tempo) e scenici (nella maturità degli anni ’40-50). Del resto l’arte di Petrassi, musicista che condivide con Dallapiccola il primato del ‘900 italiano e nel ‘900 internazionale fa parte della corte dei maggiori, è riuscita a equilibrarsi fra tutte le influenze stilistiche possibili e a realizzare una profonda autonomia cui nel complesso può spettare la definizione del Neoclassicismo più libero ed eclettico. E lo stesso equilibrio, in termini ancora di presenza e creazione artistica, è verificabile tra l’assolutezza poetica e la militanza professionale, tra la sensibilità religiosa e la laicità dell’intelligenza, tra un’intima fermezza morale e un costante senso di crisi dovuto alla storia drammatica di un secolo interamente vissuto. Fra le prime opere degli anni ’20, esattamente contemporanee ai primi successi della dodecafonia viennese e ancora ispirate ai modelli neobarocchi o neoclassici di Casella, Stravinskij, Hindemith, del ‘600-700 italiano in genere, e opere della pienissima maturità come i cinque Nonsense e i tre Cori sacri a cappella, il Tre per sette da suonarsi su sette fiati da parte di tre esecutori e il Grand septuor con clarinetto concertante, la Sestina d’autunno “Veni, creator Igor” (Stravinskij, va da sé) per corde e percussioni e gli ammirevoli Frammenti per orchestra del 1983, si pone un periodo mediano di particolare impegno sia strumentale che teatrale. Dopo l’impressionante Noche oscura, cantata per coro e orchestra del 1951, ecco infatti rafforzarsi l’interesse per lo strumentalismo: il primo concerto era del ’34, il secondo è dello stesso ’51, il terzo sarà del ‘53 e l’ottavo ovvero ultimo nascerà nel ’72, lungo un audace cammino neoclassico, bartokiano, dodecafonico, postweberniano, avanguardistico, ancora una volta attento ai contributi di tutti e non debitore a nessuno. Nel 1941, appena scoppiata la seconda guerra mondiale, il maestro produsse il Coro di morti, che musicava un eccellente testo poetico delle Operette morali di Leopardi per colori e registri scuri fra l’altro pronunciando il pancromatismo già evidente nel Magnificat; e poco dopo, nonostante la lucida certezza di una sua “mancata vocazione teatrale” (in senso puramente rappresentativo), si rivolse alle lusinghe e ai tranelli dello spettacolo. Mentre produceva musiche da film e da scena, compose i due balletti limitrofi, La follia d’Orlando del 1943 e il Ritratto di don Chisciotte del ’45, e poco dopo le due opere ancora più vicine nel tempo, il comico Cordovano del ‘49) e la tragica Morte dell’aria del ‘50). Due, tanto poche quanto significative. 2. Il cordovano È un tappeto di Cordova il protagonista della prima opera di Petrassi, che contraddice la vecchia abitudine di intitolare le opere con i nomi propri o a volte comuni dei protagonisti e la contraddice doppiamente perché non si riferisce a un’idea, un sentimento, un fatto bensì a un oggetto. Se lo stesso Berg si era limitato a intitolare le sue opere Wozzeck e Lulu, veramente le occasioni ‘oggettistiche’ non dovevano essere né essere mai state molte: Il flauto magico di Mozart, La scala di seta di Rossini, L’oro del Reno di Wagner, Il tabarro di Puccini, I gioielli della Madonna di Wolf Ferrari, Il calzare d’argento di Pizzetti, in fondo poco d’altro. Infatti la fonte del libretto ha un titolo di persona, El viejo celoso (1615), che elegge a protagonista il “vecchio geloso” dell’entremés di Miguel de Cervantes Saavedra (1547 - 1616): però che dire, per restare in ambito spagnolo di fonte e italiano di musica, dell’astuzia di Maderna? Il suo tragicomico Don Perlimplin Bruno Maderna lo compose sul testo, tradotto, di Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín di García Lorca, ma se nel titolo, di fatto, mantenne il nome dell’uomo protagonista, nella realtà della musica volle poi che il personaggio non cantasse ma risuonasse da un flauto (non titolare ma protagonista). Opera in un atto di Eugenio Montale (poeta e traduttore), Il cordovano fu composto a Roma fra il 1944 e il ’48, dedicato a Giorgio Federico Ghedini, rappresentato alla Scala nel 1949, rivisto e così rappresentato nuovamente nel 1959 (alla Piccola Scala): era nato per reazione alle brutture della guerra, confessò l’autore, ma in fondo doveva anche rivelarsi come parodia, se non proprio reazione al comico tradizionale (D’Amico). La giovane Donna Lorenza (s.) chiacchiera con la vivace nipote Cristina (s.) e la vicina di casa Hortigosa (c.) dicendo di essere stanca della gelosia e dell’orsaggine del vecchio marito, al che l’amica mezzana le consiglia di prendersi un amante; ci penserà lei, e qualcosa salterà fuori anche per Cristina. Hortigosa non tarda molto a portare in casa un grande tappeto di Cordova, che cerca di vendere al signor Cannizares (bs.): lui non lo compera, giacché vi trova delle immagini maschili che potrebbero influenzare la moglie, ma intanto da dietro al tappeto alzato a bella posta passa un giovanotto (m.) che si infila accortamente nella camera di Lorenza; finalmente Hortigosa esce, chissà perché assicurando la signora di poterla assistere nell’eventualità di un parto, e Lorenza si ritira. Dalla camera si sentono presto le vive e sfacciate espressioni di gaudio di lei, che prima divertono l’ignaro Cannizares ma poi lo insospettiscono. Vuole entrare, il padrone, e si fa aprire la porta, ma viene subito investito da una secchiata d’acqua che gli toglie la vista per un attimo, quanto basta perché il giovane riesca a sgattaiolar via. Cannizares non capisce ma protesta ugualmente, Lorenza affetta meraviglia e sdegno, nasce un gran baccano che attira anche una guardia (br.). Fuori passa un manipolo di musici e ballerini che canta “La pioggia di San Giovanni”, un fenomeno meteorologico al quale s’associano sempre le liti fra marito e moglie così destinate, però, a tacere per tutto il corso dell’anno. Tutto bene, allora, e a lagnarsi è solo Cristina ai cui pruriti Hortigosa non ha ancora trovato la cosiddetta soluzione. Due tenori cantano nel Cordovano, un compare e un musico comprimari, cioè nessun primo personaggio, nessun amoroso, nessun eroe della parola e del canto: sarà perché anticamente l’amoroso dell’opera buffa combinava così poco, nelle sue continue ed eleganti elegie, da meritare la definizione di “mezzo carattere” (appunto quasi serio), e quindi il personaggino dell’opera di Petrassi che entra in scena senza esser visibile, che scivola dentro e fuori (dalla stanza), che morde e fugge, che insomma combina tutto quello che prometteva presentandosi in buona forma di tappeto arrotolato, merita davvero di essere un attore e non un cantante. Sugli altri personaggi cade invece la tipologia vocale dell’eterna commedia per musica del ‘700-800, dal vecchietto acido e geloso (tutore o marito che sia, il don Bartolo del rossiniano Barbiere di Siviglia o il don Asdrubale del donizettiano Campanello) alla giovincella spiritosa e smaniosa (dunque Rosina, Serafina e via dicendo) non senza la matura mezzana e qualche amica compiacente: basso comico (esteso dal Mi grave al La bem. acuto in falsetto), soprano lirico, contralto, soprano leggero, più qualche comprimario, in una vocalità vivace, brillante, virtuosistica come un tempo ma anche moderna, aggiornata, in linea con il consueto stile petrassiano. Certo in una pochade del genere non avrebbe senso la maestà corale, la monumentalità cinque-secentesca di certe altre opere di Petrassi, anche se nella sua ricchezza di “assonanze folcloriche e madrigalistiche delicatissime” (Tempo) il coro maschile del finale che racconta, sentenzia e assolve può sembrare imprevedibile, dopo la sveltezza mimico-solistica dell’operina. Ma la scrittura sospesa fra politonalità, atonalità e dodecafonia è quella delle coeve partiture vocali e strumentali, fra l’altro soccorsa da una vitalità ritmica che, melismatica (su parole come “affamata”, “stracci”, “galante”, “giovane”, “folletto”, “vivo”, “grazioso” e così via) o meno (anche in “recitativo libero”), in terzetto o in canone, non può non appellarsi a modelli storici (Mozart, Rossini, ma anche i maestro del Classicismo napoletano), e da una perizia timbrica fuori dal comune in quanto assolutamente personale. Quanto all’azione, alla scena, alla teatralità, le due prime edizioni milanesi si avvalsero della regia l’una di Giorgio Strehler e l’altra di Franco Enriquez: a risolvere non poco, in particolare la singolare divaricazione fra il dentro e il fuori, fra quello che si vede e quello che sta nascosto, insomma fra quanto avviene sul palcoscenico e quanto avviene dietro la porta (dopo aver cominciato dietro al tappeto). Una divaricazione che non a caso s’accentuerà nell’opera successiva. 3. Morte dell’aria L’aria e il vuoto, la possibilità di volare, la civiltà dell’aeroplano non possono essere che fenomeni novecenteschi, per il teatro d’opera: e difatti dopo L’aviatore Dro di Francesco Balilla Pratella (1920) e il Volo di notte di Dallapiccola (1940) la seconda e ultima opera di Goffredo Petrassi è Morte dell’aria, tragedia in un atto di Toti Scialoja data all’Eliseo di Roma nel 1950 (e dedicata a Mariuccia e Gianandrea Gavazzeni). Artista assai versatile, Toti Scialoja (Roma 1914 - 1998) si impose presto nei ranghi della pittura italiana, inserendosi nella vivace scuola romana del primo ‘900, ma prima di cimentarsi anche con la scrittura ed esordire come poeta nel 1961 ebbe modo di esprimersi come singolare, moderno librettista. Risultava che a Parigi, nei primi anni del secolo, avesse avuto luogo un tentativo di volo dalla torre Eiffel, e risultava da un vecchio, tristissimo documento cinematografico francese: l’ideatore dell’assurdità portava un vestito a mo’ di paracadute che non funzionò punto e lo uccise sul colpo. Una materia che sembrò ideale per un’opera contemporanea, per una breve tragedia che seguisse la breve commedia del Cordovano e nel giro di pochi anni concludesse in bellezza la fulminea esperienza teatrale del grande maestro. Dunque davanti a un’“alta torre metallica scheletrica”, in una capitale europea all’inizio del ‘900, s’è radunata parecchia gente: è fissato che un tale si getti nel vuoto indossando l’abito-paracadute che ha inventato: il custode della torre (bs.) è dubbioso e ritiene che l’inventore sia un pazzoide, quattro cronisti (t. t. br. br.) conversano e commentano, si vedono il questore (br.), un fotografo (t.), un operatore cinematografico (bs.), due agenti (m.) e un fattorino (m.). Presto compare l’inventore (t.) attesissimo, che prima ascolta le parole di approvazione e incoraggiamento dei presenti e in particolare dell’Osservatore del Collegio degli inventori (br.), e poi prende la parola: s’è convinto della fallosità dell’invenzione, ormai, e sa di andare incontro alla morte, ma lo farà ugualmente per la fiducia dovuta a un ideale, per il dovere di “morire di fedeltà”. Quindi si lancia nel vuoto, precipita, si sfracella al suolo. Un coro interno di diciotto voci femminili contrappunta la scena esterna di dieci voci maschili: anche per questo, non solo per il finale cruentissimo, annunciato e verificato in scena, l’opera è una tragedia, divisa fra l’azione invero stolta dei personaggi e la riflessione saggia del coro (che si provi, con franchi argomenti umani, a sottrarre l’uomo da una morte sicura); e anche per l’adesione assoluta, cieca anche se evidentemente molto lucida a un’idea primigenia. I giornalisti chiacchierano e discutono, la folla freme e aspetta solo di vedere come andrà a finire (del resto lo apprende anche prima), tutto è cinismo, volgarità, sadismo, ma l’inventore è un piccolo Prometeo, un piccolo Edipo, un piccolo Oreste che anche senza più l’avallo di Eschilo, Sofocle ed Euripide va avanti per la sua strada, o sapendo o intuendo il disastro di un progetto, di un comportamento, di un’invenzione. E il tenore che lo interpreta canta, declama, recita, sfuma senza parere dalla voce impostata allo Sprechgesang, imponendosi nella scena del discorso agli spettatori con un arioso di straordinaria efficacia drammatica (sopra il suono odioso delle percussioni) e inserendosi così fra i passi lirici e drammatici, solistici e assiemistici, declamatori e concertati del custode, dell’osservatore, della folla, e fra gli interventi pietosi e sgomenti di un coro fatto di madri, di spose, di figlie, di donne molto meno razionali e tanto più ragionevoli dell’inventore folle e ahilui incapace. All’incessante circolarità ritmica del Cordovano succede qui una quadratura netta e fredda, cupa e grave, che mentre stringe nei lacci della stessa polifonia le voci e gli strumenti (24, senza violini) non disdegna certe forme antiche come la passacaglia barocca o il madrigale rinascimentale, parecchio tempo dopo il disperato Wozzeck di Berg e qualche mese prima dell’ironico Rake’s progress di Stravinskij. A proposito del titolo: appunto sul basso ostinato della passacaglia l’osservatore grida all’inventore “E vincerete l’aria, e darete agli uomini il dono dell’aria”; non questo, come fra l’altro Prometeo credeva di poter dare agli uomini il dono del fuoco e cioè della civiltà, né un altro dono qualsiasi, ma la morte, la morte dell’aria. Strano complemento di denominazione, ora l’aria coincide con la morte, è la morte stessa (onde un’eventuale “morte nell’aria” sarebbe d’un semplicismo avvilente). A proposito della carriera: a 44 anni Petrassi era già pronto per divorziare dal teatro propriamente inteso, dopo aver prodotto due balletti e due opere, ma non dalla scena, e solo nel 1954 compose musiche appunto di scena per il consentaneo Prometeo di Eschilo. V. La satura di Maderna 1. La persona Il più umile e generoso, il più umano e versatile, il più disinteressato (alla politica, alla tasca, all’affermazione personale) musicista della generazione del ’20 è anche quello che visse meno, che meno sorvegliò, difese e divulgò la sua musica: Bruno Maderna (Venezia 1920 - Darmstadt 1973), italiano, anzi smaccatamente e simpaticamente veneto naturalizzato tedesco, è stato attivissimo su tutti i fronti della militanza. Allievo di Malipiero, il più modernista della generazione dell’80, e di direttori d’orchestra come Guarnieri e Scherchen, ha operato e insegnato a Venezia, Milano, Devon, Rotterdam, Salisburgo, Darmstadt, l’isola felice del serialismo integrale avvicinata appena diciannovenne e amata fino alla fine. Nel 1955 ha fondato lo studio di Fonologia della RAI di Milano, in sodalizio con un collega del valore di Luciano Berio; inoltre per diversi anni ha diretto una piccola orchestra di Darmstadt e per un po’ la classica orchestra di Milano della RAI, ovviamente privilegiando la musica contemporanea; infine ha fatto trascrizioni (invero disparate), lavorato per il cinema, revisionato molte partiture vocali e strumentali del ‘500-600 veneziano e napoletano (e non solo). Come autore ha esordito prima della guerra con un paio di pezzi per voce e orchestra, poi si è dedicato alla musica da camera, quindi ha accostato l’orchestra e la scena, infine ha esaltato l’elettronica, con le armi personali di un gusto per la melodia profondamente italiano e della precisa volontà di fondere il suono dal vivo col suono sintetico. A una musica drammatica largamente intesa ha dato molto, radiodrammi, musiche di scena, balletti (tutto in viva collaborazione testuale e teatrale con Patroni Griffi, Berio, Leydi, altri); e almeno tre o quattro lavori di genere chiaramente operistico (mentre rimangono cameristici lavori pur significativi come L’augellin Belvedere col suo flauto onnipresente e quell’Amor di violino dove l’arco protagonista corteggia una chitarra). Una musica drammatica che ha l’aspetto dell’antica satura latina, della farcitura di elementi diversi e spesso strambi, capricciosi, satirici appunto (Satyricon docet). 2. Don Perlimplin e Hyperion Opera radiofonica come destinazione e “ballata amorosa” come definizione, il Don Perlimplin ovvero il Trionfo dell’amore e dell’immaginazione di Federico García Lorca partecipò al Premio Italia -bella tradizione della vecchia RAI- nel 1962, e appunto radiofonica doveva restare, se non per altro perché l’autore quel montaggio e quella registrazione produsse e avallò, lasciando la partitura cartacea allo stadio intermedio di infida somma di appunti. Tradotta in italiano da Vittorio Bodini, la vispa e crudele commediola del grande drammaturgo spagnolo scritta per le marionette nel 1931 fa agire la governante Marcolfa (voce recitante), due folletti (recitanti), la giovane Belisa (soprano), il vecchio don Perlimplin (flauto), la suocera (quartetto di sassofoni), coordinandoli con uno speaker (voce recitante). Espongono l’intreccio un’introduzione strumentale, un prologo e quattro quadri: malconsigliato dalla governante, il vecchietto tranquillo e riservato prende moglie, ma la giovane è mossa solo dall’interesse e lo tradisce; allora lui le fa recapitare una lettera, dove uno spasimante dal mantello rosso già notato passare sotto la finestra la invita a un abboccamento, e si presenta lui stesso travestito, scompare alla caccia del rivale e torna ferito a morte facendosi finalmente riconoscere; l’inganno, dice, era l’unico modo per dare un’anima, un senso di vita a un’ingrata tutta e solo corpo. Lavoro breve (allungato però nella versione operistica di Vittorio Rieti risalente al 1952), testo divertente e chiaro (a parte magari questa storia dell’anima), musica complessa e anzi complicata: musicista a tutto tondo, Maderna cita altre musiche sue come Honeygrêves e Divertimento per orchestra, imita movenze d’uso e stili conosciuti (il ballabile, la canzonetta, lo swing, il madrigale), fa un montaggio elettronico di suoni preregistrati (mescendoli e sfasandoli), soprattutto improvvisa su semplici abbozzi dando forma e timbro strumentale agli interventi di certi personaggi. Se la suocera, appunto, borbotta con i sassofoni, il protagonista discorre, protesta, lamenta con la chiarezza gentile e all’uopo senile del flauto: e se le parole si intendono dal tono delle risposte, i loro sensi s’intendono benone anche solo così. La partitura di Don Perlimplin sarà un canovaccio da interpretare (con l’esperienza sempiterna del teatro e ogni modernità di mezzi tecnici), ma quella di Hyperion è una polipartitura, un comma prismatica di partiture tutte possibili di fronte alla quale impallidisce perfino (in tal senso) un’opera plurima come il Don Carlos di Verdi. Questo è francese e italiano, in quattro o cinque atti, con ballo o senza, e quello spazia fra tre versioni teatrali, sei versioni sinfoniche (quattro da concerto, per esempio come concerto per flauto e orchestra, e due suites orchestrali con voce recitante) e una versione radiofonica, nell’arco appena di sei anni. Lirica in forma di spettacolo in otto scene, su testo del musicista e di Virginio Puecher con un passo di Hölderlin e fonemi di Hans G. Helms, il primo Hyperion nacque alla Fenice di Venezia nel 1964, come manifestazione del XXVII Festival di musica contemporanea della Biennale: sul palcoscenico di un teatro lirico occupato da operai entrava un uomo in frac, un Poeta che più volte cominciava a suonare il suo flauto (scelto fra alcuni altri in suo possesso), ma prima o poi veniva distratto e impedito (da rumoracci, suoni sgarbati, strane risate, parole senza senso), intrappolato in una gabbia di lamiera, aggredito da una mostruosa Macchina-puttana elettrica da luna-park (disegnata dal Puecher), sorpreso e cacciato da una pantomima di figure identiche in pose diverse; ma poi entrava una Donna, che cantava un’aria su testo di Hölderlin, e al canto di lei s’univa il suono del Poeta; di nuovo solo, il Poeta deponeva il flauto e prendeva in mano l’ottavino, suonando il quale s’allontanava lentamente. Dunque un flauto (come Perlimplin), un soprano e una macchina erano i personaggi dell’opera, destinata alle citate e drastiche variazioni delle quali una in tedesco su nuovo libretto tratto dai Morituri di Hugo Claus (Bruxelles 1968) e una ancora italiana che sceglieva episodi della prima alternandola con intermezzi del secentesco Orfeo dolente di Domenico Belli (Bologna 1969). Il poeta-strumentista, in sostanza, deve resistere alla prepotenza della società (impersonata nell’orchestra che disturba) e della materialità (nella macchina) per ascoltare soltanto l’altra espressione della poesia, la musica, la voce della donna che canta parole sublimi. Quasi come era capitato al giovane protagonista dell’Hyperion di Friedrich Hölderlin che aveva combattuto per la libertà della Grecia (anche se inutilmente), aveva perduto l’amatissima sua musa Diotima, aveva disperato ma si era poi ripreso davanti allo spettacolo della natura: se l’immaginoso romanzo epistolare elaborato dal grande rappresentante del Classicismo tedesco in parecchi anni e più versioni (quella definitiva in due volumi nel 1797 e ‘99) era di “confessione” e “formazione” insieme, la complessa opera metaforica di Maderna è di aspra denuncia, contro l’orrore e lo squallore del mondo contemporaneo, e in fondo anche di fiducia almeno in una parte dell’umanità, nella presenza della donna e dell’amore, nel potere dell’arte o meglio della musica (qui una “costruzione monodica all’interno di un contesto linguistico post-seriale”, secondo Montecchi). 4. Ages e Satyricon Invenzione radiofonica di Giorgio Pressburger da un passo di As you like (Come vi piace) di Shakespeare, Ages (Età) risale al 1972, quando, ancora una volta, Maderna concorse al Premio Italia: Jaques, il personaggio della fonte inglese (II, 7), raccontava la vita dell’uomo articolandola in sette età o momenti assimilabili ai brevi atti di un commediola, coincidenti con il bambinello che miagola, lo scolaro che protesta, l’amante che s’esalta, il soldato che imperversa, il giudice che sentenzia tronfiamente, un Pantalone rimbambito e pantofolaio, un vecchio “senza denti, senza vista, sena gusto, senza nulla” e ridotto a vivere una “seconda infanzia”. Ages è partitura che la musica di Maderna riduce a un prologo elettronico e quattro parti, la prima ancora elettronica (e ancora fatta di voci infantili filtrate ed echeggiate), la seconda recitata da una donna sopra un vago tappeto di flauti, la terza composta di voci varie (virili, femminili, senili), la quarta cantata a cappella da un coro di donne sulle parole “Tutto il mondo è palcoscenico” (riprese dall’inizio). Poco da rappresentare, evidentemente, e molto da significare, con minor tenacia e maggior sapienza da parte di un artista non vecchio ma purtroppo ormai prossimo a un’ottava età. Libero, sperimentale, talvolta capriccioso e un po’ vanesio nel darsi un titolo (come del resto la relativa musica non teatrale), il teatro musicale del ‘900 rifugge dalle definizioni tradizionali che sembrerebbero circoscriverlo troppo; onde il Satyricon di Maderna, su testo dell’autore e di Ian Strasfogel, è detto opera e basta, anche se meriterebbe tranquillamente la qualifica di opera comica, buffa, magari grottesca. Come il romanzo del latino Petronio Arbitro vissuto nel I secolo donde deriva (in particolare da quella sua parte residua che si chiama Cena Trimalcionis), mette in scena (e alla berlina) alcuni momenti della volgarissima cena di un plebeo romano che s’è arricchito con speculazioni e sfruttamenti: una coppia di ospiti non nasconde di star facendo del sesso, Habinnas (t.) racconta la storia boccaccesca della vedova di Efeso (che un soldato consola dal lutto recentissimo), Fortunata (s.) irrita suo marito Trimalcione (t.) che l’ha tolta dalla strada, tutti gli ospiti si uniscono in un’orgia abominevole, Trimalcione descrive l’ambiziosissimo monumento funerario che s’è fatto costruire e detta il suo testamento. Unico l’atto, otto i personaggi, ben 141 i frammenti del testo originario a volte lasciati in latino ma più spesso tradotti (in inglese, francese, tedesco) e mescolati liberamente; e venti i pezzi dell’opera rappresentata ad Amsterdam (per il festival d’Olanda) nel 1973 e l’anno dopo alla Piccola Scala di Milano. Ma la stampa, avvenuta postuma anche se già curata dall’autore, consta di fascicoli staccati, tali da permettere e anzi imporre agli esecutori ordini sempre nuovi, non coercitivi, sempre in linea con il concetto di work in progress così caro a Maderna (né solo a lui) e intanto teorizzato da Eco come “opera aperta”; e se in fondo vale sempre l’ordine della prima, messo assieme dall’autore, un problema ulteriore è rappresentato dai cinque nastri magnetici che aprono, intercalano e chiudono l’opera ma sono reperibili ciascuno in più versioni. I nastri s’intitolano Introduzione, Erotica, Trimalcione e le flatulenze (o Il risveglio), Trimalcione e gli animali, Scintilla 1 e s’alternano a scenette come Estasi d’amore, Macchina da cibo e Carriera di Trimalcione. Chiaro il messaggio dell’opera, ricalcante un testo parodistico della corrotta Roma imperiale e fra l’altro concepita proprio in concomitanza con la crisi economica italiana succeduta al boom degli anni ’60; e chiarissima la sua facciata musicale, che tutto sceglie, ammassa, deforma, irride (e in fondo gode e ama), in una maniera che l’autore stesso volle assimilare al collage della Pop-Art. Gluck, Mozart, Verdi, Wagner, Offenbach, Bizet, Strauss, Stravinskij, Weill fanno capolino nel Satyricon di Maderna insieme al jazz, al folk, al cabaret, ora cantati, ora suonati, ora recitati, ora irrigiditi nello Sprechgesang; e mentre l’armonia tonale dà il passo alla disinvoltura dell’alea, i tenori e i soprani risuonano (a volte acutissimamente) insieme ai grugniti dei maiali e ai canti degli uccelli. Ma i maiali, secondo Maderna, non esistono mica solo per insozzare il quarto nastro magnetico, e per fortuna gli uccellini canori non cinguettano soltanto nell’ultimo. VI. Nono il messaggero 1. Un'azione Con i maestri che ha avuto, era impossibile che Luigi Nono (Venezia 1924 – 1990) ignorasse il teatro; e difatti l’ha avvicinato, affrontato, coltivato con tre lavori fondamentali per la storia dell’opera del secondo ‘900. Del resto l’idea del rapporto con il mondo, della comunicazione con la società, del messaggio da lanciare all’uomo o meglio da condividere con l’umanità era insopprimibile, in lui, e se a interporsi fra il musicista e la scena c’era ancora qualche diffidenza con tutto quanto fosse convenzionale, anche la negazione del teatro all’epoca tanto sbandierata da tutti per lui dovette essere uno sprone all’interessamento. Artista colto e antiaccademico, originale e combattivo, Nono ha studiato prima con Malipiero e poi, laureatosi in Giurisprudenza, si è formato nuovamente con Maderna, concittadino maggiore di appena quattro anni, e con direttori e docenti come Scherchen e Rosbaud. Quindi ha studiato e anche insegnato a Darmstadt, ha insegnato a Darlington (Gran Bretagna), ha lavorato all’istituto di fonologia di Friburgo (nel 1955, inoltre, ha sposato Nuria Schönberg figlia di Arnold, che dal 1993 presiede l’archivio specifico di Venezia). Con lo stesso Maderna, Berio, Manzoni e Bussotti è stato il maggior compositore storico del secondo dopoguerra italiano, e con alcuni colleghi stranieri ha partecipato alla rosa dell’eccellenza internazionale. Avviato al serialismo e pratico dell’alea, di entrambe le correnti ha sempre respinto gli aspetti più radicali; educato al culto della polifonia antica, ha sempre tenuto fede assidua al parametro della melodia; animato da una incrollabile ideologia marxista, della sua arte ha fatto lo strumento assiduo della lampante e vibrante comunicazione di cui sopra (almeno nel testo, la musica rimanendo sempre modernamente ostica e ardua). Già negli anni ’50 Nono ha sperimentato con successo molte tecniche: il serialismo integrale (cioè esteso dalle singole note agli altri parametri), i movimenti transitori del suono, la matericità dello strumentalismo, l’elettroacustica, la stereofonia. Si è pronunciato contro il Franchismo e il Nazismo, l’arma nucleare e la discriminazione razziale, in difesa di tutte le rivoluzioni (in particolare a onore delle tante donne che vi hanno contribuito) e a ricordo di tutta la resistenza europea. Ma non di meno ha prodotto musiche intimistiche e quasi umanistiche come i Cori di Didone e il quartetto d’archi Fragmente-Stille, An Diotima (a proposito dell’amato Hölderlin). In un contesto tanto sensibile alla poesia e al canto quanto attento ai live electronics e alla loro audacia, nel corso di un’attività tanto coerente quanto impaziente, in virtù di una poetica ricchissima di riferimenti e citazioni, Nono è stato un compositore ora drammatico e ora lirico, felicemente diviso fra di un “lirismo teso e sofferto” e una “violenta agitazione dinamica e fonica” (Santi), pregno di passione politica ma anche capace di una musicalità assoluta. Cornice legittima dei portati più forti e manifesti dell’arte di Nono è il teatro, alimentato tre volte negli anni 1961, 1975 e nel 1984. 2. Intolleranza 1960 A comporre tutto il testo, se si vuole il libretto di Intolleranza 1960 sono testi svariati di Henri Alleg, Bertold Brecht, Aimé Césaire, Paul Éluard (cinque strofe dal poema La liberté), Julius Fučík, Vladimir Majakovskij, Jean-Paul Sartre, alcuni frammenti di interrogatori effettuati dalla Gestapo e dalla polizia francese in Algeria, diversi slogan come No pasarán e Libertà ai popoli!. La prima dell’azione scenica in due atti, germinata da un’“idea” dello scrittore e slavista palermitano Angelo Maria Ripellino (19231978) che aveva preparato dei Materiali per un’opera appunto da integrare, ebbe luogo alla Fenice di Venezia nel 1961, per il XXIV Festival di musica contemporanea con la direzione di Maderna (un’altra edizione ridotta a un atto, Intolleranza 1970, alla Pergola di Firenze nel 1974). Triste, squallida, allucinata la storia: un Emigrante (t.) che lavora come minatore non regge più allo straniamento e decide di rimpatriare, lasciando la sua compagna (s.) che non è d’accordo; passando per una città assiste a una manifestazione di protesta e per errore viene arrestato, torturato e imprigionato; tuttavia riesce a fuggire, insieme a un ribelle; libero ma colpito e oppresso dall’assurdità del mondo, fra la folla allarmata da una grande esplosione incontra una donna (s.), una nuova compagna alla quale si unisce nel proposito di resistere al regime di persecuzione che grava sull’umanità, ma più tardi, trovandosi fuori città vicino a un fiume in piena, con lei e con altri soccombe miseramente allo straripamento alluvionale. Clamorosi, e dolorosissimi i riferimenti all’attualità: il disastro minerario di Marcinelle, in Belgio, dove nel 1956 persero la vita 262 minatori di cui 136 italiani; la guerra d’indipendenza dell’Algeria dalla Francia, durata dal 1958 al ’64; l’alluvione del Polesine dello stesso 1958. Vissuta da poveri personaggi anonimi che compiono gesti tra il realistico e il simbolico (nominati sono invece Alleg e Sartre, recitanti), popolata da cori disparati (minatori, dimostranti, torturati, prigionieri, emigranti, algerini, contadini), Intolleranza 1960 è pur sempre un’opera che rappresenta raccontando, e mentre sembra preparare il passo verso due opere in questo senso diverse e ulteriori, costituisce anche uno dei primi casi di risposta o addirittura di reazione ai veti antiteatrali della Nuova Musica di Darmstadt, insieme alla Sentenza di Manzoni messa in scena l’anno prima al Teatro delle Novità di Bergamo. Dunque è teatro, teatro di uomini e azioni, ma anche e soprattutto teatro di idee, misurato sulla drammaturgia di prosa avviata da rivoluzionatori della scena contemporanea come Mejerchol’d, Brecht e Piscator: infatti, oltre a squadrare e agitare anime e corpi come in precedenti lavori non scenici quali Il canto sospeso (che peraltro cita) e i Cori di Didone, lancia un veemente messaggio di pietà e solidarietà a tutte le vittime dell’intolleranza (certo ricordandosi anche dell’esempio sommo del Wozzeck di Berg) e di accusa contro i loro carnefici (magari anche contro l’ambiguo Inquisitore del Prigioniero di Dallapiccola). E lo fa con i vistosi mezzi poetico-verbali suddetti: non meno forti, tuttavia, sono i mezzi musicali, per esempio il canto acuto del tenore e del soprano, l’assolo del soprano, l’assidua coralità quasi snaturata da nastri magnetici e altoparlanti, gli scrosci dell’orchestra, i rimbombi delle percussioni, gli accordi e i contrasti tra scena e fuori scena; e numerosi anche i mezzi scenotecnici, elettronici, visivi, sussunti in una forma di collaborazione con il regista, lo scenografo, il tecnico del suono, i singoli interpreti che non è semplice suddivisione del lavoro ma autentica democrazia di idee e di scelte. “Io entro nello studio di Friburgo sempre ‘senza idee’”, disse un giorno Nono, che poi definì Intolleranza 1960 come la ricerca angosciosa e fiduciosa dell’uomo da parte dell’uomo: “simbolo? cronaca? fantasia? tutto insieme in una storia del nostro tempo”. La prima veneziana ebbe luogo il 13 aprile del 1961, quasi quattro anni dopo la famosa battaglia di Algeri (ritratta nel magnifico e così intitolato film di Pontecorvo del 1966, Leone d’oro a Venezia) e pochi giorni prima il tentativo (21 aprile) di un colpo di stato reazionario (in verità, bisogna aggiungere, anche cinque anni dopo l’innominata repressione sovietica in Ungheria). 3. Al gran sole carico d’amore “Au grand soleil d’amour chargé” aveva scritto Rimbaud nella poesia Les mains de Jeanne Marie, e così, in italiano, Nono intitolò la sua seconda opera, come la prima definita azione scenica in due parti e ascrivibile al genere del teatro di idee (con i suoi modelli tedeschi e russo-sovietici) ma diversamente da quella ormai priva di intenti e nessi narrativi: Al gran sole carico d’amore, libretto del musicista e di Jurij Ljubimov, nacque al Lirico di Milano nel 1975 (una seconda versione tre anni dopo), regista Ljubimov, scenografo David Borovskij, concertatore e direttore Claudio Abbado (tutti, non solo il primo regista del Teatro alla Taganka di Mosca allora non ancora esiliato, coinvolti a fondo nell’elaborazione dello spettacolo). Il libretto è un testo-collage che raccoglie stralci storici, massime politiche, frammenti poetici e spezzoni prosastici di Brecht, Gorkij, Gramsci, Lenin, Marx, Pavese e Rimbaud in compagnia di Clémence-Louise Michel, Che Guevara, Celia Sánchez, Haydée Santamaría e canzoni rivoluzionarie di mezzo mondo come l’Internazionale, Bandiera rossa, Non siam più la Comune di Parigi, il 26 luglio e la Dubinuša. La prima parte s’incentra sull’esaltante episodio della Comune di Parigi nel 1871, sul massacro degli oltre 20.000 comunardi guidato dal pur liberale Louis-Adolphe Thiers (t.), sull’indomito personaggio della scrittrice anarchico-rivoluzionaria Michel (4 s.) messa in relazione con la boliviana Tanja Bunke (s.) e la protagonista (c.) della Madre di Gorkij simboleggiante la tentata rivoluzione russa del 1905. Insistendo sull’episodio del 1905, la seconda parte passa alla Torino degli anni ’50, fra le lotte operaie e la prostituta Deola (4 s.) che compare in Lavorare stanca (poesie di Pavese) e all’episodio della caserma cubana Moncada. Attorno a questi citati prendono la parola altri “personaggi” come il politico Favre (bs.), Bismarck (bs.), Pavel (br.), Gramsci (br.), Dimitrov ( bs.), Castro (bs.) e vari anonimi fra cui una madre e donne vietnamite (s.), quindi molti cori di francesi, cubani, siciliani e così via. Significativo il messaggio, evidente l’elogio della donna impegnata nella lotta di classe, ampio lo spettro delle situazioni politiche (ma “accuratamente esclusa restandone, beninteso, ‘nel quadro’ d’un asse GiudeccaMosca, la Cina”, scrive lucidamente D’Amico). Libera di svariare e inverarsi mediante allestimenti diversi, la musica è rigorosamente e logicamente fissata sulla pagina. La compongono numerose “unità”, duranti dai due ai cinque minuti ciascuna, che possono consistere in pezzi per nastro magnetico solo, passi vocali solistici accompagnati da nastro o qualche strumento, assiemi risultanti da cori (grandi o piccoli, cantanti o parlanti), solisti (cantanti o parlanti), orchestra e nastro, regolarmente inframmezzate da interludi orchestrali ed eventualmente potenziati da un altoparlante. L’organico svolge funzioni lampanti: gli strumenti tradizionali (8 flauti, 4 oboi, 5 clarinetti, 4 fagotti, 4 corni, 4 trombe, 4 tromboni, 2 timpani, percussioni e archi) esprimono e suonano la repressione, la brutalità, la ferocia, specie con la forza di clusters (grappoli di semitoni) richiesti a gruppi timbricamente omogenei; il nastro magnetico a 4 tracce interviene a sottolineare i momenti di ansia, angoscia, tragedia; le 17 voci (5 s. [2 quadrupli], 5 t., c., 2 br., 4 bs. [1 doppio], coro grande e coro piccolo) percorrono la partitura incarnando sia l’entusiasmo e l’audacia che i patimenti e le sconfitte, con aneliti e slanci melodici tosto vanificati (doppiamente, se purtroppo “novantanove parole su cento non raggiungono lo spettatore e innumerevoli ‘voci’, estrapolate come sono da personaggi visibili, risultano materialmente irrelate ad alcunché”, scrive D’Amico). Ad aprire la composita partitura è un suggestivo “Come preludio”, e a chiuderla è il battagliero “Non siam più servi né padroni”, tema tratto dall’Internazionale che Nono aveva già usato altrove e avrebbe riusato in … sofferte onde serene… per pianoforte e nastro del 1976. 4. Prometeo, tragedia dell’ascolto Dopo due azioni sceniche, una tragedia, per di più dedicata a un personaggio mitologico. Ma questo Prometeo di Nono è una singolare e plurisemantica “tragedia dell’ascolto”, l’opera di un artista che, dopo aver rinunciato con Al gran sole carico d’amore alla rappresentazione di un intreccio nel senso di Intolleranza 1960, rinuncia anche all’evidenza della rappresentazione e della personificazione, e soprattutto, cosa in lui incredibile ma vera, alla chiarezza, per lo meno all’univocità del messaggio. Una tragedia dell’ascolto, infatti, può aver luogo quando il suo tragico senso prescinde dallo spettacolo ed è puramente sonoro; quando ascoltare, connettere e capire si fa troppo difficile, quasi impossibile; quando voler ascoltare significa dover prendere atto di fatti tragici in quanto o assolutamente negativi o talmente complessi e sfumati da negarsi a un’interpretazione sicura. Prometeo, tragedia dell’ascolto in undici parti su testi a cura di Massimo Cacciari cominciata nel 1980, fu eseguita nel 1984 a Venezia, nella chiesa sconsacrata di S. Lorenzo con un apparato effimero degno della bella cornice barocca: una grande pedana lignea ideata dall’architetto Renzo Piano e posta nel centro di una chiesa pressoché quadrata ospitava 400 spettatori; tre gallerie circolari addossate alle pareti contenevano cinque cantanti, sette strumentisti, un coretto di solisti e quattro cori ciascuno composto da 12-14 cantori; un imponente complesso di apparecchi elettronici era posto vicino all’altare con molti microfoni e moltissimi altoparlanti erano disposti attorno al pubblico. Nella sceneggiatura, numerosi testi in greco, italiano e tedesco tratti da Esiodo, Eschilo, Goethe, Hölderlin, Nietzsche, Benjamin e montati all’uopo dal filosofo e scrittore veneziano (1944) si distribuiscono su nove “isole” successivamente visitate dal protagonista che sembrano mansioni d’oratorio o stazioni di “via crucis”: Prometeo, l’antico iddio figlio di un titano (come del resto Zeus) che nelle varie versioni del suo mito plasmò la creatura dell’uomo oppure sottrasse agli dei il fuoco per darlo agli uomini come simbolo di civiltà, qui incarna invece l’uomo contemporaneo, più che a dare generosamente pronto a chiedere e cercare, trasgredendo la legge nella brama di una legge nuova (anch’essa da trasgredire), e mentre annuncia il crepuscolo degli dei tiranni è anche in grado di descrivere a Io, vittima di Era (la moglie di Zeus che la ama), le sue future sofferenze. Cercare, trovare, criticare, scartare, cercare di nuovo e sempre è il messaggio laicamente umile e coraggioso dell’opera, da associare al “pensiero debole” teorizzato nel 1983 da Gianni Vattimo che alla filosofia assegna non la proposta di sistemi forti bensì un’interpretazione dei fenomeni parziale e suscettibile di mutamenti. Se la nuova filosofia o almeno una sua parte consiste in questo, la musica può ben destinarsi a un ascolto debole, disorientante e imbarazzante, insomma tragico. Ed eroe tragico è senza dubbio Prometeo, a suo tempo eternato da Eschilo e più tardi musicato da Beethoven (il musicista titanico, prometeico per eccellenza), Liszt, Fauré, Skrjabin, Leoncavallo, Orff, Cortese: un profeta, fra l’altro, qui ridotto a più a porsi domande affannose che a dar risposte positive; e certo per questo da Nono preferito a Ulisse, eroe errabondo sì ma destinato a un’avventura che è anche conquista e conoscenza, e poi troppo amante, troppo borghese, troppo paterno (oltre che a rischio di fede cristiana, come aveva deciso l’opera di Dallapiccola nel 1968). Le undici parti del Prometeo di Nono, che durano ciascuna dai due ai trenta minuti, comprendono e assortiscono un prologo, cinque “isole” (la terza, quarta e quinta accorpate in una parte sola), due stasimi, due interludi, due selezioni del Maestro del gioco di Cacciari, un finale; e in ossequio (parola invero per nulla noniana) all’assunto e alla definizione dell’opera vivono all’insegna del frammento o microstruttura musicale, del continuo cambiamento d’organico, di una dinamica che scende perfino a dieci indicazioni di “piano”. Tre i settori dell’organico: gli strumenti tradizionali, soli e a gruppi; le voci cantanti, a solo o in assieme, e parlanti; il live electronics per trasformare, selezionare e regolare i suoni (rispettivamente modulatore ad anello, harmonizer, voice coding system; serie di filtri; gate, halaphon, rallentatore). Immane la differenza fra le varie parti: il prologo, che cita uomini e dei nel caos primordiale, prevede tre voci cantate, una voce parlata, archi e fiati gravi (nessun violino, per esempio, ma un clarinetto contrabbasso), sette vetri; la seconda metà della terza parte (la seconda isola) è l’adattamento di un brano dello Schicksalslied (Canto del destino) di Hölderlin già presentato come Io. Frammento dal Prometeo nel 1981 (oltre che già musicato da Brahms); la quarta impone agli strumentisti di suonare e anche di cantare; l’ottava, scritta per coro a cappella, nata come lenta (semiminima al 30) e appena udibile, vuole rapida (semiminima 120) e forte; la nona è sottotitolata A sonar e cantar, sulla memoria del ‘500 veneziano che aggiungeva gli strumenti alle voci tradizionali della polifonia. Né basta, perché l’adozione dello stasimo dall’antica tragedia per nominare il coro, l’esigenza del tempo reale nell’elettronica, un perfezionismo compositivo indubbio che però si dispone a cambiamenti anche radicali (tagli e ricomposizioni, durante le prove, in altre esecuzioni a Milano e Parigi), sono alcune delle disparate facce ulteriori di questo prisma inafferrabile, letteralmente ‘inascoltabile’. “Per me, bello è qualcosa che mette in moto il mio pensiero”, disse un giorno Nono, e se il pensiero era debole come la musica era tragica all’ascolto non aveva importanza: importante era l’altra parola, il moto delle idee in testa come quello delle parti nella musica, armonicamente o disarmonicamente. VII. La dilogia di Togni 1. Camillo e Anton Casella fece rappresentare la sua prima opera teatrale, La donna serpente del 1932, a 49 anni; e Togni, suo allievo per la composizione, ha messo in scena la prima opera a 55 anni (invero dopo lunga gestazione), per produrne poi solo un’altra laddove il maestro ne aveva prodotte altre due. Se contano i maestri, se il magistero ha il giusto senso didattico che deve avere, ecco almeno in parte spiegato l’atteggiamento verso la musica drammatica di Camillo Togni (Gussago [Brescia] 1922 – Brescia 1993). Il quale, dopo aver studiato composizione con Margola e Casella (pianoforte con Casella stesso, Anfossi e Benedetti Michelangeli, questi suo quasi coetaneo e concittadino), dopo essersi laureato in Filosofia, si è lestamente aggiornato al linguaggio prima di Schönberg e poi di Webern, ha frequentato con particolare assiduità i corsi di Darmstadt, è stato fra i primi compositori italiani ad appropriarsi del serialismo, ha insegnato al Conservatorio di Parma. Colto artefice di musiche raffinate, concentrate, stilizzate sulla linea di Webern eletto a maestro ideale, ha lavorato con rigore e impegno assoluto su diversi organici vocali e strumentali: ad esempio per strumenti diversi (Aubade), per clavicembalo (Préludes et rondeaux), per pianoforte (La guirlande de Blois), per canto e pianoforte su testi antichi del trovatore Peire Vidal e del francese Charles d’Orléans, e pressoché contemporanei come quelli di JeanPaul Sartre e sopra tutti di Georg Trakl, il suo singolare “librettista” postumo. 2. Blaubart e Barrabas Blaubart è un’opera in un atto nata alla Fenice di Venezia nel 1978, che Togni aveva musicato con la consueta dedizione e larghezza di tempi adottando come testo la sua traduzione del breve dramma di Trakl. Georg Trakl (1887-1914), poeta salisburghese morto suicida a Cracovia durante la Grande Guerra, era un po’ più giovane di Rilke, Schönberg, Hofmannsthal, Webern e Berg, scrisse testi lirici e teatrali sospesi fra il Simbolismo e l’Espressionismo, ossessionati dalla cosiddetta “finis Austriae” e affidati a uno stile disarticolato, molto originale e spesso oscuro. Una sua versione della vicenda di Barbablù (il sinistro personaggio dalla barba azzurra che fa fuori le mogli) tratta dalla fiaba di Perrault, gravata da elementi di un simbolismo allucinato e stesa come dramma per marionette, fu il libretto fedelmente adoperato da Togni: dopo un prologo corale, la prima scena sfocia in una rapsodia e la seconda nel rondeau “Si vous pensez que je vous ame” (lirica prelevata da Vaillant, poeta del Quattrocento francese), e la terza s’allunga in preludio, canzone, postludio, Liebeslied, transizione, delirando e finale; appena quattro i personaggi, Blaubart (br.), Elisabeth (s.), il vecchio (bs.) e il bambino Herbert (r.); e addirittura un centinaio di strumenti d’orchestra. Se all’orchestra capita spesso di selezionarsi in maniera cameristica, i cantanti sono richiesti di più maniere, il canto ben definito di altezze e durate, il recitato-intonato (uno Sprechgesang aspro e metallico ma appunto intonato con precisione), il recitativo-parlato intonato liberamente, il vero-parlato recitato liberamente ma su registri diversi (più o meno chiari o scuri). Perfetto il serialismo, tutta la composizione muovendosi sopra questa tecnica elaborata dalla Scuola di Vienna che vieta la ricomparsa di un suono prima della comparsa di tutti gli altri undici della serie (dodici sono infatti i suoni della scala cromatica). E notevole anche la teatralità, sia per il gusto della parola, del lirismo, della comunicazione che l’autore possedeva in misura maggiore di parecchi colleghi della Neoavanguardia europea, sia per una speciale sensibilità luministica minuziosamente calata e anzi descritta (proprio come prescrizione dell’uso delle luci) nella complessità della partitura. La fiaba di Perrault risale al 1697, ma era destinata a un’enorme e svariante fortuna letteraria, teatrale, cinematografica (quivi dall’Ottava moglie di Barbablù di Lubitsch al Blaubart di Zanussi non senza il Monsieur Verdoux di Chaplin e il Landru di Chabrol), musicale: casi speciali di teatro in musica sono l’operetta di Offenbach, l’Ariane et Barbe-Bleue di Dukas, Il castello del principe Barbablù di Bartók che è uno straordinario “mistero” simbolico-espressionistico composto nel 1911 e rappresentato nel 1918, infine il Blaubart di Franz Hummel definito opera da camera e rappresentato nel 1984. Ancora un atto, ancora un testo trakliano, ancora una gestazione lunga per la seconda e ultima opera di Togni, quel Barrabas che doveva essere il secondo numero di una trilogia seguito da una Maria Magdalena (sempre di Trakl): opera in forma di fantasia (a detta dell’autore) composta fra il 1981 e il 1985 sopra un libretto che Togni aveva attentamente ridotto dall’originale, vide la luce postuma al Palafenice di Venezia nel 1996. E di Barabba, il bandito ebreo condannato per omicidio e sedizione ma liberato da Ponzio Pilato al posto di Gesù per volere del popolo, racconta non questo momento cruciale della vita, bensì il seguito, un episodio apparentemente meno significativo. Mentre passa trionfante tra le feste della gente, l’uomo viene invitato da un giovane e ricco ammiratore a spassarsela un po’ nel suo palazzo, bevendo e amoreggiando, ma quando poi si trova a brindare spettacolarmente in mezzo ai convitati ecco che all’intorno la natura cambia faccia, la terra trema, il terrore invade il mondo: Cristo è spirato, l’umanità ha compiuto un altro e infinitamente più grave delitto ma si è già salvata grazie al sacrificio della vittima (e il sacrificio potrà salvare anche Barabba, questo strano “figlio di padre”). Cinque scene per un solo cantante, il Giovane (t.) che esulta in quella centrale, per un grande coro, per un organico orchestrale amplissimo, per un protagonista eponimo dell’opera che non canta, non parla, non danza, ma è solo un imponente mimo. Esemplare, ancora una volta, il serialismo, che dell’onoratissimo Webern ha tradito la negazione al teatro ma accoglie e perfeziona il metodo: quello per cui la prassi della non-ripetizione non si limita alle note (alle 12 note già impugnate dalla dodecafonia) ma si estende agli altri parametri compositivi, i valori ritmici, i segni dinamici, i timbri strumentali. “Teatro dell’assenza” è stato definito questo così parsimonioso di Togni, in quanto antioperistico e certo non teatrale nel senso corrente: ma a cominciare era stato Debussy, con il Pelléas et Mélisande del 1902, e a continuare avevano provveduto Ravel, Schönberg, Malipiero, molti musicisti del ‘900 una volta interessati o rassegnati al teatro, con grandi risultati ma occasionalmente come Petrassi e tardivamente come Messiaen. Nel 1983, a metà dell’ultimo lavoro di Togni, a 75 anni Olivier Messiaen licenziava e rappresentava Saint François d’Assise, la sua prima e ultima opera colossale: ben poco da spartire con questa ridotta e quasi cameristica di Togni se non l’ispirazione religiosa, che invece è una caratteristica piuttosto rilevante dell’arte di Togni (già autore di varie musiche religiose, addirittura sacre) e un suo onorevole distintivo nel contesto di tanto teatro musicale esclusivamente profano per non dir ateo. VIII. Operisti in scena 1. Frammenti di Realismo Sperimentazione e conservazione, svecchiamento e continuità, progresso e tradizione: ambigue e rischiose, sono però parole utili a ordinare e distinguere; non sono in grado, o meglio non dovrebbero essere in grado di qualificare, pregiare o censurare l’autore o il lavoro che vanno avanti o restano fermi, che inventano il nuovo o coltivano il consueto, che si spazientiscono davanti alla tradizione o si irritano davanti alla sperimentazione. Infatti la storia delle arti e quella della musica in particolare sono piene di innovatori efficienti e inefficienti come di tradizionalisti capaci e incapaci. Quando il professor Adorno sentenziò che tra Schönberg l’avanguardista e Stravinskij il neoclassico la palma spettava indubitabilmente al primo, e per il semplice motivo che aveva avuto il coraggio di spiare e fondare il futuro mentre il secondo aveva preferito ricordare e alimentare il passato, faceva un gran bel ragionamento filosofico che non aveva alcun valore né estetico né artistico: la musica vale o non vale, o vale nelle mille sfumature che sono umanamente possibili fra il valore grande e il valore nullo; quando ha un valore, maggiore o minore che risulti, è sempre parte del tempo e del luogo, della storia e della cronaca come della scuola e della civiltà che l’ha prodotta, e come tale è sempre interessante, per quanto in maniera varia; ogni età e periodo, ogni movimento e corrente ha i suoi poli estremi e certi punti intermedi che servono tutti alla causa dell’arte e della funzionalità del suono (all’occorrenza anche del rumore). Del resto, a definire Schönberg come “il progressivo”, assai prima di Adorno e della sua peraltro fondamentale Filosofia della nuova musica (1949), era stato Brahms, che da Liszt, Wagner e compagni dell’avvenire era considerato un conservatore puro; e chissà mai che cosa avrebbe detto Brahms di Stravinskij. Ma riecco l’opera italiana. Poco prima della seconda guerra mondiale Renzo Rossellini (Roma 1908 Montecarlo 1982) esordì nella musica da film, settore nel quale doveva a lungo collaborare col fratello Roberto in capolavori come Roma città aperta, Paisà e Il generale Della Rovere; e questa esperienza, avvalorata dalle numerose musiche di scena fra (l'altro per Dostoevskij, Čechov, De Filippo), ebbe poi modo di associarla alla casuale ma decisiva conoscenza di un’opera di Menotti, alla Scala nel 1955, per avviarsi l’anno dopo verso il teatro d’opera (appena saggiato nel 1930). Delle undici opere musicate spesso su testo proprio fino al ‘73 La guerra, Il vortice, Uno sguardo dal ponte e Le campane sono forse le più valenti, ispirate a un linguaggio tradizionale sospeso fra la tradizione verista, la funzionalità della colonna sonora e la conoscenza del cinema maturata nel felice sodalizio col fratello regista. Dramma in un atto dato a Napoli nel 1956, La guerra applicò gradevole lirismo melodico ed efficace pittura orchestrale a una vicenda all’epoca ancora scottante (e quindi meritevole anche di spunti rumoristici, dissonanti, politonali): durante un conflitto, l’anziana paralitica Marta (ms.) vive in un sotterraneo con la figlia Maria (s.) e aspetta ansiosamente il ritorno dal fronte del figlio Marco (r.); alla fine questi ritorna, ma privato della vista, mentre la figlia scappa con l’ufficiale Erik (t.) che ama, e la povera madre cade morta. Indubbia la matrice dell’opera, ma non per questo datata la sua drammaturgia: a parte l’evidenza di un messaggio scorato ma almeno diretto, la trattengono da certa piattezza conformistica la presenza di una voce recitante, il suono di una sirena, il comprimariato di personaggi anonimi (postino, prete, inquilini, folla), l’anonimato della cornice e in particolare la suggestiva, quasi biblica allitterazione dei nomi dei tre personaggi. Fra il 1939 e il 1982 furono ben dodici le opere composte da Jacopo Napoli (Napoli 1911 - Ascea [Salerno] 1994), su testi spesso di Mario Ghisalberti (librettista anche di Wolf Ferrari) e Vittorio Viviani derivati da teatranti del calibro di Molière, Puškin e Di Giacomo. Pregevoli il brillante Curioso accidente (1950) da Goldoni, il patetico Rosario (1962) da De Roberto, la versione operistica di Miseria e nobiltà di Eduardo Scarpetta che nei tre lunghi atti rappresentati al S. Carlo (1946) raccoglie dodici personaggi, undici cantanti (fra gli altri tre soprani, tre tenori, un baritono per il funambolico don Felice) e un “ragazzo”. Direttore dei Conservatori di Napoli, Milano e Roma, dichiaratamente ma non polemicamente estraneo al radicale rinnovamento del linguaggio del suo tempo, Napoli ha sempre scritto musica ispirata a un tardo, gentile, spesso comico e farsesco Verismo innervato da sicuro color locale e fresca vena melodica. Ma per Rossellini e per Napoli Realismo andrà meglio di Verismo, se non per altro per via del parallelo e non ininfluente Neorealismo cinematografico. 2. Fecondità e promiscuità Coetanei e corregionali, Rota e Menotti hanno percorso notevole parte del ‘900 italiano sicuramente onorando lo spettacolo in musica e facendosi apprezzare anche all’estero: l’uno specialmente grazie al linguaggio internazionale della musica da film, l’altro grazie al “nuovo” mondo d’America praticato con frequenza forse maggiore. Nino Rota (Milano 1911 - Roma 1979) è stato il musicista per antonomasia del cinema italiano: i suoi 46 contributi decorano pellicole disparate, dal vecchio melodramma di Raffaello Matarazzo alla nuova commedia popolare di Lina Wertmüller, ma ben quindici fanno parte della sgargiante filmografia di Federico Fellini, e se rappresentano la piena funzionalità di un’arte lucidamente ancillare, dimostrano anche l’autonomia di un’inventiva melodica capace di ingemmare La strada con il famoso tema di Gelsomina e I vitelloni con il triste assolo di tromba che dà corpo al fallimento esistenziale del protagonista. Fra le dieci opere, di cui una radiofonica, si trovano parecchie partiture impostate su fonti e testi autorevoli di Ariosto, Hugo, Soldati, Bacchelli, De Filippo, complessivamente tradizionali e certamente godibili: l’adolescenziale Principe porcaro del 1925 è una limpida fiaba di Andersen (eseguita postuma soltanto nel 2003), La notte di un nevrastenico del 1950 è una burla vistosa (forse non immemore del Campanello di Donizetti), La visita meravigliosa del ’70 una candida allegoria, la Napoli milionaria del ‘77 uno amaro squarcio di vita. E Il cappello di paglia di Firenze è un piccolo gioiello che meritava veramente di entrare nel repertorio dei teatri. Farsa musicale in quattro atti che Rota stesso ed Ernesta Rinaldi trassero da una pochade di Eugène Labiche e Marc Michel già intitolata Le châpeau de paille d’Italie, l’opera fu cominciata nel 1945, sospesa e terminata soltanto in previsione della prima, che ebbe luogo al Massimo di Palermo nel 1955 e presentì subito la fortuna successiva. A Parigi, parlando il giorno del suo matrimonio con lo zio sordo Venizet (t.), il giovane Fadinard (t.) si trova a dover ricomperare un cappello che il cavallo del suo calesse ha acchiappato e mangiato alla mortificata signora Anaide (s.), la quale era con l’amante Emilio (br.) e senza cappello non può assolutamente tornare dal geloso consorte; cominciando dunque l’affannosa ricerca di un cappello uguale, una modista (s.) manda Fadinard, seguito dai curiosi invitati alla sua cerimonia, dalla baronessa di Campigny (ms.), che un cappello del genere l’aveva ma l’ha dato alla nipote, moglie del signor Beaupertuis (br.); Fadinard trova costei, che però è la solita Anaide, e seguito dai soliti invitati subisce anche le minacce del suocero Nonancourt (bs.); Fadinard è al colmo della disperazione, quando lo zio gli porge il suo regalo di nozze che è un cappello di paglia di Firenze tale e quale, onde Anaide torna a casa rassicurata ed Elena (s.) può finalmente sposare l’irrequieto ma incolpevole fidanzato. Opéra-comique in versione italiana? operetta? colonna sonora? parodia mozartiana o rossiniana? parafrasi verbo-scenico-musicale del ‘700-800 buffo, giocoso, brillante? Il cappello di paglia di Firenze è un po’ tutto questo, e negli anni della musica d’avanguardia, della cultura impegnata, del cinema neorealista e della guerra fredda rappresentò soltanto la certezza e la bellezza del divertissement. Il dubbio maritale ha qualcosa del Ford del verdiano Falstaff, il temporale del quarto atto ricorderà Il barbiere di Siviglia, il coro cantante “Schiocchi la frusta” ricalca la canzone baritonale della Cavalleria rusticana di Mascagni, il canto della sposina delusa è agile e lirico come quello di Norina nel Don Pasquale di Donizetti; e nella folle giornata pressoché matrimoniale che non può non alludere anche alla “folle journée” delle Nozze di Figaro, fanno capolino e anzi abbondano anche allusive imitazioni e lampanti citazioni, incredibile a dirsi, di Mozart e Rossini. Gian Carlo Menotti (Cadegliano [Varese] 1911) ha studiato a Milano e a Filadelfia, subito divaricandosi fra Italia e USA: nel 1937 ha avviato una lunga carriera di operista che l’ha visto attivo per almeno mezzo secolo, nel 1958 ha fondato a Spoleto il festival dei Due Mondi, ha lavorato come librettista per la sua musica e come regista d’opera per sé e per altri, ha composto parecchia musica d’altro genere. Forte di una vasta conoscenza dell’opera tradizionale, di una fantasia melodica fresca e accattivante, di un acuto senso del teatro (a proposito di intrecci, personaggi, colpi di scena, finali e così via), di una tecnica compositiva d’ordine classico-romantico ma non per questo impenetrabile da qualche spunto modernista, ha composto e rappresentato opere (in inglese e italiano) di definizione, soggetto, destinazione diversa. Fra le altre ecco la brillante Amelia al ballo del 1937, la radiofonica The old maid and the thief (Il ladro e la zitella) del ’39, lo spiritoso e brevissimo Telephone (Telefono) del ’47, l’articolato e drammatico Consul del ’50, la cruenta Saint of Bleecker street (Santa di B. S.) del ’54, fino a qualche opera “da chiesa” o storica come il Goya dell’86. Longevo e infaticabile, eclettico ed esperto, sensibile a una sorta di sinfonismo hollywoodiano a volte criticato ma anche per questo baciato da una popolarità insolita per i tempi, Menotti rimane uno degli operisti più rappresentati del secolo. Rappresentata in prima a New York (come molte delle opere sorelle), la tragica e sinistra Medium del ’46 diede la misura della versatilità di un autore già apprezzato con la commediola del ’37 (dove la frivola Amelia tutto dimentica e disprezza pur di recarsi al ballo): Madame Flora detta Baba (c.) presiede a una seduta spiritica dove la giovane figlia Monica (s.) e lo zingarello muto Toby (m.), come sempre, sono incaricati di aiutarla a ingannare i clienti; ma mentre parla ispirata alla signora Nolan e ai signori Gobineau (pateticamente bramosi di mettersi in contatto con i figli morti), sente una mano che la tocca e si spaventa oltremodo; nel corso di un’altra seduta, non reggendo più, confessa la sua disonestà e discaccia i clienti increduli; fuori di sé, chiede perdono a Dio ma quando vede muoversi una tenda si spaventa ancora, afferra la pistola e spara un colpo che ferisce o uccide il povero Toby là nascosto per paura. Il canto declamatorio della protagonista, l’espressione lirica della figlia, l’attenzione per l’assieme polivocale, il consueto melodismo postpucciniano si contendono felicemente il campo nell’abile partitura cameristica (comprensiva anche di pianoforte), che nel 1947-48 ebbe un seconda versione americana, nel 1949 una prima italiana (a Genova) e nel 1951 anche una versione cinematografica. Se l’opera di Menotti partecipa alla storia della musica sia italiana che americana, quella di Hans Werner Henze (Gütersloh [Vestfalia] 1926) è senza dubbio un robusto tassello della storia della musica tedesca, nonostante la passione dell’autore per l’Italia (scelta come luogo di vita fin dal 1953). Appunto naturalizzato italiano, fondatore del Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano (1976), Henze ha composto numerose opere, musicate tutte in lingua tedesca e quasi tutte rappresentate in Germania:: Boulevard Solitude (1952) revisiona la vicenda massenettiana e pucciniana di Manon Lescaut; König Hirsch (Re Cervo; 1956) proviene da una fiaba di Gozzi e squaderna tutti i colori di un’orchestra smagliante; Der Prinz von Homburg (Il principe di Homburg; 1960) deriva da Kleist e tratta il problema del rapporto fra uomo e potere con tanto melodismo quanto contrappunto; Elegy for young Lovers (Elegia per giovani amanti; 1961) è un testo di Auden e Kallmann che fluisce con la verosimile mobilità di un film; Der junge Lord (Il giovane Lord; 1965) accampa una vivacità e squisitezza canora da antico belcanto; Die Bassariden (Le Bassaridi; 1966) riprendono il tema delle Baccanti di Euripide calandolo in atmosfere quasi straussiane; La zattera della medusa (1968) è un “oratorio volgare e militare” dedicato a Che Guevara (che alla prima amburghese provocò disordini e arresti); El Cimarrón (1970) è la coraggiosa autobiografia di uno “schiavo evaso” destinata a quattro musicisti (cantante, flautista, chitarrista, percussionista); We come to the river (Andiamo al fiume; 1976) affronta un momento cruciale della storia contemporanea come la guerra del Vietnam (mentre la tarda Upupa del 2003 si rifugerà nella favolistica araba). 3. Grotteschi A proposito di figure di librettisti, il ‘900 italiano ha squadernato le firme di D’Annunzio, Pirandello, Montale, Quasimodo, Savinio, Moravia, Buzzati e altri che questa qualifica l’avrebbero certo preferita fra virgolette. Fra gli altri ecco Massimo Bontempelli (1878 - 1960), scrittore e musicista che diede un paio di testi a Riccardo Malipiero jr. (Milano 1914 - 2003). Figlio del violoncellista Riccardo sr. e nipote di Gian Francesco, chi con Dallapiccola è stato fra i primi musicisti italiani interessati alla dodecafonia, ha coltivato molti generi e scritto molta musica; al teatro contemporaneo ha dato un valido contributo con i due soli testi in questione, Minnie la candida e La donna è mobile. Questa è un’opera buffa di Guglielmo Zucconi (da Nostra dea, la commedia di Bontempelli del 1925) che mentre fa la parodia della tradizione opera anche una sorta di sincretismo stilistico della stessa e delle novità ulteriori, e mette in scena una donna stravagante che cambia umore a seconda dell’abito; e quella è una specie di tragedia moderna. Opera in tre atti presentata a Parma nel 1942 (la commedia omonima era del ’27), è ben più che stravagante: Minnie (s.), fidanzata di Egeo (br.) crede alla burla di Tirreno (t.), secondo la quale come certi pesci rossi di una vasca così sono artificiali anche certi esseri dall’apparenza umana; e ci crede tanto da uscir di senno, barricarsi in casa, persuaderne i due e cacciarli fuori, infine da buttarsi dalla finestra. A parte la singolarità dei nomi maschili che sono quelli di due mari, l’assurdità della storiella è perfettamente riflessa dalla musica: un tango, un ricercare, un corale, delle imitazioni e delle variazioni formano la calibratissima partitura, che la tenacia del diatonismo e dell’atonalità finiscono per irrigidire in perfetta linea con il surrealismo del testo. Non è meno surreale il più significativo lavoro drammatico di Valentino Bucchi (Firenze 1916 - Roma 1976), autore oltre che di un bel Concerto grottesco per contrabbasso e archi (1967) di un’opera direttamente intitolata Il contrabbasso e propriamente definita “grottesco”: infatti è questa la vena principale dell’uomo anticonformista, dell’artista pronto al collage, del musicista capace di ricorrere a scale difettive, dissonanze, clusters, microintervalli e brandelli di polifonia dotta e di canzoni popolari (autore anche di un Coccodrillo tratto da Dostoevskij e inscenato nel 1970 che solo nel ventre del bestione sembra poter dare pace e sicurezza a un funzionario statale frustrato). Mario Mattolini e Mauro Pezzati trassero la bizzarra vicenda dal Romanzo del contrabbasso di Čechov: un contrabbassista sfiduciato (bs.-br.) cammina presso un fiume, vi vede una principessa (s.) bagnarsi nuda e si immerge anche lui; ma un ladro (m.) e una ladra (m.) rubano le vesti di entrambi, al che lui s’impietosisce di lei al punto da vestirla della custodia del suo strumento; la custodia viene raccolta da quattro suonatori (t. t. br. bs.) che la portano al castello, e quivi aperta dal sorpreso fidanzato della principessa (t.) al cospetto del padre di lei (bs.) e a della corte; la giovane accusa un certo satiro, che un gendarme (bs.), un prete (t.) e dei popolani vanno a cercare nel fiume; ma quando il contrabbassista affiora dalle acque tutti scappano dalla paura, e lui riprende il suo triste cammino. Nudo? almeno col suo contrabbasso, ma con quale futuro di musicista? Chiaro il messaggio di Bucchi, che nel suo titolare e protagonista d’opera addita il triste destino dell’arte e dell’arte musicale in un secolo così avaro, distratto e complicato. Né tronfia o retorica è la sua musica, che traccia fili melodici e trame polifoniche di tanta semplicità quanta bravura: la principessa canta sulla mazurca e il fidanzato sul valzer (lento), i due ladri non cantano ma mimano e danzano sopra un minuetto (“quasi” tale), i suonatori suonano a dovere, il contrabbasso suona e quasi canta in assoli di goffo e malinconico virtuosismo (anche là dove gli altri strumenti lo imitano e forse sbeffeggiano). Con diverse opere ispirate sia a Čechov e Dostoevskij (ancora) che a Pirandello e Ionesco, e capaci di conciliare modernità di linguaggio con evidenza rappresentativa, Luciano Chailly (Ferrara 1920 Milano 2002) ha cadenzato una presenza professionale assai incisiva sul costume nazionale (dalla RAI alla Scala): notevole la serie di musiche su testi di Dino Buzzati, come Ferrovia sopraelevata (1955), Il mantello (1960), Era proibito (1963); e notevolissima quella Procedura penale che, data a Como nel 1958, sotto l’apparenza della scenicità e addirittura della commedia borghese celava tendenze oniriche, surreali, antinarrative degnissime dell’imminente stagione degli anni ’60. Il capo d’accusa riguarda la contessa Mauritia Delormes (s.), che partecipa a una riunione di bella gente e in seguito a un serrato interrogatorio viene accusata di un enorme delitto: prima, donna Titti (s.), Giandomenico (br.), Paola (c.), Polcevera (t.) e altri chiacchieravano con superficiale disinvoltura; e dopo, una volta l’interrogatorio giunto al parossismo, faranno altrettanto, come se non fosse accaduto nulla. Nulla, appunto, se non un drammetto che toglie il fiato e una sagace partiturina che nella sua amara leggerezza distribuisce variamente gli strumenti dell’orchestra, il flauto alla contessa e agli altri, in successione, il sassofono, il trio di violoncello-contrabbasso-timpani, il clarinetto. 4. Commedie? Sebbene stia per finire, oltre che nell’opera omonima di Rossellini la guerra imperversa anche nella Gita in campagna di Peragallo, opera in un atto di Alberto Moravia (da un suo racconto, Andare verso il popolo) rappresentata alla Scala nel 1954: nella Roma del 1945 Ornella (s.) e Mario (t.) viaggiano in macchina fuori porta, ma debbono fermarsi per via del surriscaldamento del motore; in un vicino casolare conoscono Leonia (ms.) e Alfredo (bs.-br.), contadini ridotti alla misera dal conflitto e dalle razzie dei tedeschi e quindi costretti a derubare i passanti; sicché derubano anche i due cari fidanzatini, lasciando lui in mutande (lei, almeno, vestita); con l’augurio di un buon viaggio, i due ripartono sulla macchina rimessa in sesto da Alfredo, ma faticano ad allontanarsi a causa della folla di altri miseri questuanti. La morale disfattista del testo, ostile sia alla borghesia che al proletariato, provocò uno scandalo alla prima, complici scenici la scarsa nobiltà di un’automobile e una sorta di spogliarello sottolineato dal pianoforte e dalla batteria in odore di jazz. Ma proprio con la brevissima operina Mario Peragallo (Roma 1910 - 1996), allievo di Casella già autore di una Ginevra degli Almieri (1937), sospesa fra l’ultimo Puccini e certo medievismo imperante (Giordano, Zandonai, Montemezzi), aveva saputo aggiornare il suo linguaggio, disegnando una versione personale e ragionata della dodecafonia non ostile, questa, né all’eleganza del valzer né all’umiltà della fisarmonica. Tre “mani” si succedono in Jeu de cartes di Stravinski, balletto rappresentato a New York nel 1937; ma come questo vivace “gioco di carte” così è bene che la Partita a pugni di Vieri Tosatti (Roma 1920 1999) si componga di un’introduzione e tre rounds: in una palestra l’arbitro (r.) fa combattere due pugili, uno smargiasso (br.) acclamato dal pubblico e un povero spilungone (t.), ma Palletta ha sempre la meglio fuori che alla fine, quando un attimo di distrazione lo perde e scaraventa a terra; e il pubblico se la prende con lui e con l’arbitro. “Dramma da concerto” su libretto proprio dato a Venezia nel 1953, la seconda delle sette opere dell’autore (la quarta è la più narrativa Isola del tesoro tratta dal popolare romanzo di Stevenson) è sia schietta, veloce, sbrigativa che caricaturale, rumorosa, volutamente brutale: un’opera senza dubbio ‘sportiva’, antimelodrammatica, vicina a certa umoristica secchezza dei Sei francesi e di Honegger in particolare. All’epoca stava per tornare al teatro Virgilio Mortari (1902 1993), già autore di Secchi e Sberlecchi (1927) e pronto a sorridere con Molière e la sua moraleggiante Scuola delle mogli (1959); e nel 1954 avrebbe visto la luce Allamistakeo di Giulio Viozzi (1912 – 1984), un bell’atto unico tratto da Poe e impostato sulla vicenda stralunata di una mummia viva e circolante. Qualche parentela questo primo teatro di Tosatti (il secondo avrà dunque un carattere più tradizionale) la manifesta con quello di Gino Negri (Perledo [Como] 1919 - Milano 1991), che è stato insegnante, scrittore, librettista (di se stesso), giornalista, critico, collaboratore della RAI (il Giovanni Sebastiano del ’67, omaggio a Bach che vinse il premio Italia, è un’opera radiofonica e La fine del mondo del ’70 un’opera televisiva), musicista da cabaret, autore di canzoni. In un ambiente come quello di Milano diviso fra il tenace culto della tradizione e la volitiva ricerca della novità Negri si è ritagliato uno spazio forse intermedio, esiguo ma caparbio, grazie a un linguaggio musicale semplice (certo debitore al duo Brecht-Weill) e a una vocazione teatrale disinvolta e graffiante ma anche simpatica e affettuosa. Fra le numerose opere sceniche gli assurdi Divertimenti di Palazzeschi del 1948 furono un annuncio curioso, tosto seguito da Vieni qui, Carla (dagli Indifferenti di Moravia), Il tè delle tre, Il circo Max, È l’abito che fa il flauto (per flautista, ballerina, sarta e voce recitante), Abbasso Carmelo Bene, Craxi anno due, titoli tutti abbastanza significativi di una vena asciutta, umoristica e stravagante. Pubblicità, ninfa gentile è un’operina in un atto data alla Piccola Scala nel 1970 che nel titolo fa la parodia della famosa arietta di Bellini su versi del Pindemonte (“Malinconia, ninfa gentile”): due pubblicitari convinti e capaci, Jingle (br.) e Slogan (s.), si conoscono e si sposano, ma alla morte del figlioletto perdono l’ispirazione professionale, e le medicine a lungo pubblicizzate non salvano lui dalla malattia mortale né la pistola anch’essa tanto pubblicizzata aiuta lei nel suicidio (l’arma, cioè, fa cilecca). Polivoca anche la presenza di Roman Vlad (Cernăuţi oggi Černovtzy [Bucovina] 1919 - Roma 2013), artista romeno naturalizzato italiano e impegnato come pianista, critico, musicologo, conferenziere, consulente, direttore artistico e presidente di istituzioni e associazioni. In uno stile perfettamente aggiornato ma mai drastico e scostante, Vlad ha composto molta musica d’ogni genere e forma: in ambito spettacolare balletti, musiche di scena (per Plauto, Shakespeare, Alfieri, Giraudoux, Pirandello, Betti) e da film (per Clair, Castellani, Zeffirelli), opere. Il dottore di vetro è un’opera radiofonica in un atto che Maria Luisa Spaziani trasse da un testo secentesco di Philippe Quinault e Vlad fece eseguire alla RAI nel 1960 e rappresentare a Berlino nel 1961. L’intreccio: a Toledo, Panfilo (bs.) promette la figlia Isabella (s.) al ricco Dottore (br.), ma Tersandro (t.) che ama riamato la fanciulla persuade il rivale che la passione d’amore abbia bruciato e quindi solidificato il suo corpo fino a renderlo di vetro; allora il vecchietto si presenta da Panfilo in una cesta, per la paura di rompersi perde i sensi e quindi crede di trovarsi nell’altro mondo in mezzo ai diavoli; al che Panfilo si ricrede e fa ricredere anche il dottore, onde Isabella sposerà Tersandro. Un intelligente pizzico di dodecafonia e una profonda conoscenza delle forme classiche governano la partitura, che l’anno dell’audace Sentenza di Manzoni riusciva ancora a comunicare e divertire. 5. Sempre eroi Un po’ a Weill ma soprattutto a Bartók, Berg e Hindemith tende la seconda delle due sole opere di Guido Turchi (Roma 1916): Il buon soldato Švejk, sarcastico testo di Gerardo Guerrieri tratto dal romanzo incompiuto del cecoslovacco Jaroslav Hašek, è un’opera commissionata dalla Scala per la stagione 1953-54 ma ottenuta e rappresentata solo nel 1962 in quanto il progetto di un atto unico si estese a un prodotto di tre atti (la prima opera, risalente al 1949, è La sera del grande silenzio). Una musica eclettica e sapiente (degna di chi, all’occorrenza, era ben in grado di recepire la dodecafonia) non esita a mescolarvi il valzer e la cabaletta, la recitazione e lo Sprechgesang, la berceuse e la canzonetta, la solida conoscenza delle forme classicamente chiuse e l’accorta deformazione delle stesse grazie a uno strisciante cromatismo. È un’esplosione nuda e cruda, secca e quasi immotivata a chiudere la storia: Joseph Švejk (br.) viene imprigionato perché in una birreria di Praga, all’indomani dell’attentato di Sarajevo, si è sbilanciato a parlar di politica prevedendo una guerra; ma presto si decide di arruolarlo nell’esercito, dove è volgarmente sfruttato dal capitano medico (bs.-br.), che lo ipnotizza per convincerlo di essere un buon soldato, e dal capitano Pelikan (t.), tutto impegnato in faccende amorose; in direzione del fronte, Svejk è prima arrestato da un maresciallo (br.) che ha la fissazione di trovar spie dappertutto, poi spedito a combattere e in particolare a tagliare un reticolato; là dove subisce appunto l’esplosione fatale. Buono, questo Švejk, troppo buono anche come uomo, e quindi destinato a diventare uno zimbello all’incirca come il Wozzeck di Berg: ancora un antieroe, dunque, cui la presenza di una fidanzata normale come Katja (s.) e non fedifraga come Maria aggiunge un’amara punta di quotidianità e forse squallore. Del resto Berg compose il suo Wozzeck fra il 1914 e il ’22, e Hašek il suo Švejk nel 1920-21; e Turchi non conosceva le musiche di scena che Kurt Weill aveva composto per Schweyk alla seconda guerra mondiale, il dramma di Bertold Brecht scritto nel ’41-43, messo in scena a Varsavia nel ’57 e giunto in Italia nel ’61. Anche Bruno Bettinelli (Milano 1913 - 2004), maestro di mezzo mondo italiano e meneghino in particolare, si è cimentato su tutti i fronti formali possibili; e intanto ha maturato la sua arte da inizi neoclassici a sviluppi liberamente seriali. La smorfia del 1959, Il pozzo e il pendolo del ’67 e il Count down del ’70 rappresentano il suo impegno scenico, modico di quantità ma denso di qualità: la seconda opera vide la luce del palcoscenico al “Donizetti” di Bergamo dieci anni dopo la composizione, a causa del veto imposto da un autore forse bonario con gli altri ma severissimo con sé stesso. Clemente Crispolti ne aveva tratto il soggetto da un racconto “del terrore” di Edgar Allan Poe, o meglio aveva tratto dal narratore americano uno spunto pauroso che seppe rivestire di essenziali colori civili e anche svariare con la tecnica del flashback (di per sé ben più agevole nel racconto che sulla scena). Azione mimo-drammatica in un atto, Il pozzo e il pendolo non ha intreccio né cornice, non cambia mai luogo d’azione, si limita a due personaggi cantanti (si direbbe quasi un personaggio e mezzo) con un mimo e a un coro lontano: prigioniero politico dell’Inquisizione, Edgar (t.) langue in prigione e attende la morte; nel dormiveglia rivà ai tempi felici della sua vita, trascorsi da bambino con la madre e da adulto con l’amata Ellen (s.), ma non tarda a riprendere coscienza, nel buio della segreta vede un pozzo dal cui fondo sente salire voci misteriose e una falce tagliente che gli oscilla sul capo come un pendolo, ha l’impressione che il luogo gli si stringa addosso soffocandolo e addirittura arroventandolo; ma da fuori lo raggiunge un coro di popolo che grida “morte ai tiranni” e la cella si rischiara, s’allarga, s’illumina, si apre e lo apre alla libertà. Il secolare Fidelio di Beethoven e il recente Prigioniero di Dallapiccola sembrano assieparsi dietro la partitura di Bettinelli, agile anche se corrusca, svolta con i mezzi di una scrittura politonale e totalcromatica, di un’orchestra sgargiante e raffinata insieme, di una coralità onnipresente (sospesa fra la tragedia greca e la drammaturgia milanese e contemporanea di Giovanni Testori), di una vocalità molto spesso declamatoria ma anche lirica e appassionata (attorno alla memoria di Edgar e al duettino d’amore). In tema d’eroi, infine, vanno citati alcuni altri singolari personaggi usciti dalla penna operistica di musicisti variamente impegnati: Gli Orazi (1941) di Ennio Porrino (1910 - 1959), il Villon (1941) di Alberto Bruni Tedeschi (1916 - 1996), l’originale Maurizio della Confessione di Sandro Fuga (1906 1994), una bella figura di uomo e partigiano che passò dall’esecuzione radiofonica del 1962 a quella scenica del 1971 (al Nuovo di Torino). 6. Liviabella Docente e direttore di vari Conservatori italiani, Lino Liviabella (Macerata 1902 - Bologna 1964) si è spesso ispirato a un limpido descrittivismo di carattere tardoromantico, ma ha comunque aggiornato lo stile di Respighi (suo maestro a S. Cecilia) con le moderne risorse del cromatismo e della politonalità. In un catalogo fecondo di oltre 270 numeri, il sinfonismo s’ispira anche al canto popolare ( La mia terra), una composizione cameristica particolarmente originale è Riderella per due pianoforti e voce recitante (snodata attraverso Il ruscello, La fuga dal mare, La città azzurra, Il pianto di Riderella, La pietà del sole e ancora Il ruscello), l’opera teatrale più importante è Antigone. Non nuovo alle scene operistiche, anzi assai gradito nel tempo dall’Antigona di Coltellini-Traetta (1772) all’Antigonae di Hölderlin-Orff (1949) e oltre, il soggetto del grande dramma sofocleo, che con l’Edipo tiranno condivide la nomea del capolavoro dell’autore, balenò a Liviabella nel 1938, allorquando il giovane maestro ebbe occasione, mediante l’amico e collega Ennio Porrino, di conoscere lo scrittore e poeta per musica Emidio Mucci. Con il quale si accordò abbastanza presto: frutto della collaborazione doveva essere un’opera tratta dall’Antigone di Sofocle, tragedia rappresentata ad Atene nel 441 a.C.; e Antigone fu, dopo diverse difficoltà di carattere generale (la guerra imminente e imperversante) e personale (l’insegnamento disceso fino a Palermo), al Regio di Parma il 29 dicembre del 1942 per la stagione del Teatro delle Novità che s’era dovuto allontanare, pur temporaneamente, dalla natìa sede di Bergamo. Parecchi anni dopo, per la precisione il 28 maggio del 1960, la partitura in tre atti fu rappresentata al Comunale di Bologna, ridotta in un atto solo. Da Opera e dramma, il famoso trattato di Wagner, Mucci prese lo spunto per il libretto, ma la fabula di Sofocle ivi ammirata la trattò a piacer suo, come un intreccio che desse posto anche ad altro e cioè, nientemeno, ai Sette a Tebe di Eschilo: il lungo finale della tragedia del 467 a.C. divenne materia di un primo atto, il secondo e il terzo rimanendo allineati o meglio ispirati allo svolgimento della prima fonte. Altri spunti Mucci li trasse dall’Antigone di Alfieri e addirittura del Critone di Platone, ma nel complesso lavorò con tanta elasticità di sceneggiatura quanta personalità di pensiero. Il pensiero fondamentale, eccolo: interpretare l’antichissimo mito in prospettiva cristiana, nella protagonista vedendo addirittura un’ombra del Protagonista del Cristianesimo, Gesù Cristo stesso. Già Wagner, certo senza pervenire a tanto, aveva gemellato l’eroina di Sofocle alle sue creature dilette, quelle figure femminili che, Senta nel Fliegende Holländer o Elisabeth nel Tannhäuser, si sacrificano per amore. E Antigone (soprano), che dopo la guerra civile dei Sette a Tebe dà sepoltura al fratello Polinice (ucciso dall’altro fratello, Eteocle, durante l’assalto alla città patria) contravvenendo agli ordini regali o meglio “statali” di Creonte (baritono), soccombe ma con ogni successo morale (e poetico): obbedisce a un ordine universale che è la pietas per i defunti (tanto più se della famiglia), nello scontro con Creonte provoca il suicidio di Emone (tenore) figlio di lui e a lei fidanzato dando luogo a un altro e purtroppo doppio sacrificio, colpendo al cuore Creonte e annientando la sua legge innaturale restituisce il re alla sua dolentissima umanità. Al dramma Liviabella perviene con una triplice professione di fede (Pecci): etico-religiosa indubbiamente, ma anche musicale ed estetica. Perché musicale? perché la sua partitura conosce e assimila i portati del Modernismo, con elementi di aspra dissonanza ed evidenza politonale (fino all'atonalità), con ritmi ossessionanti e di proposito esenti da disegni nonché slanci melodici, con scelte e mescolanze timbriche dure e violente, con una forte rete di temi conduttori donde spiccano quelli definibili come “disperazione di Antigone”, “patimento di Antigone”, “pietà religiosa”, “inesorabilità di Creonte”, “legge” e “redenzione”. Ma nel duetto d’amore e nel concertato del secondo atto la musica di Liviabella smette di infuriare e tormentare cominciando, anzi ricominciando a calmarsi, a farsi lirica, insomma a cantare. E così riafferma le tipiche qualità melodiche, armoniche, insomma romantiche dell’ispirazione e della tecnica appresa alla scuola di Respighi e poi alimentata da una vita vissuta nei ranghi della virtù, dell’arte, di una musica classicamente eterna, di una professione di fede che è anche inequivocabilmente estetica. 7. Mannino Negli anni ’50 del ‘900, mentre certi grandi vecchi d’oltralpe producevano gli ultimi loro capolavori operistici, ed eventualmente in teatri italiani (valga The Rake’s progress di Stravinskij alla Fenice nel 1951) o in versione prima e italiana (Les dialogues des Carmélites di Poulenc alla Scala nel 1957), mentre certi italiani sulla trentina formati in uggia al teatro cominciavano a ripensare acutamente al genere, non taceva affatto quella placida tradizione che solo o già in precedenza aveva ispirato Lattuada e Lualdi come Rossellini o Menotti. E nati negli stessi anni di Vlad, Chailly, Clementi e Donatoni esordirono con successo Mannino, Hazon e Testi. Vivì (1957), La stirpe di Davide (1962), Le notti della paura (1963), Il diavolo in giardino (1963), Il quadro delle meraviglie (1963), Luisella (1969), La speranza (1970), Il ritratto di Dorian Gray (1982), Il principe felice (1987) sono opere che, su libretti derivati da Mann o Wilde e scritti da Vittorio Viviani o Luchino Visconti, si trovano a cadenzare regolarmente una cronologia compositiva generosa come poche altre, effettivamente in tutti i generi possibili nonostante la fiducia commessa alla colonna sonora (per la regia di Visconti stesso). E il solo fatto che tre di esse si facciano ressa nel 1963 (l’anno clamoroso di Berio e del suo Passaggio) è riprova della personalità dell’autore: Franco Mannino (Palermo 1924 - Roma 2005) è stato notevole direttore d’orchestra, pianista di vaglia, compositore disponibile ed eclettico. Dramma in quattro atti e sei quadri di Bindo Missiroli e Paola Masino, Vivì nacque al S. Carlo di Napoli un anno dopo il balletto Mario e il mago (1956), ebbe fortuna e quindi fu in grado di visitare altri teatri nazionali e stranieri: una popolarità assicurata fin dall’intreccio, dove la protagonista (s.) è una vivace soubrette di tabarin che non ricambia l’impresario George (t.), si innamora dell’aviatore inglese Sinclair Mac Lean (br.), trascorre una breve stagione d’amore con lui, lascia partire l’amato, capisce di essere stata abbandonata, scopre che lui ha sposato un’altra e quando lo rivede in sala durante uno spettacolo lo affronta e gli spara uccidendolo. Molto melodramma e molti melodrammi presiedono all’opera, specie sul corpo sempre patetico della donna bella, sentimentale e più o meno mortalmente delusa: la Gioconda di Ponchielli, la Adriana di Cilea, la Butterfly di Puccini, la Zazà di Leoncavallo, con qualche pizzico della Violetta di Verdi (nella Traviata) e della Madga di Puccini (nella Rondine); e anche qualche accorto spruzzo di modernità come il disinvolto luogo dell’azione, la virilissima professione dell’uomo, lo spettacolare colpo di pistola, lo stesso spostamento dell’oggetto della passione dal tenore al baritono. Vistosi passi di danza, melodie liriche o squillanti, qualche spunto sinfonico (Strauss) e parecchi echi canzonettistici (Gershwin) allietano la fresca partitura che potrebbe risalire anche a un paio di decenni prima; e tuttavia assegna agli strumenti aerofoni, idiofoni e membranofoni uno spazio simpaticamente offensivo dei cordofoni. 8. Hazon Aveva appena 22 anni, Roberto Hazon (Milano 1930 - San Remo 2006), quando compose L’amante cubista, che rappresentò poco dopo, nel 1954, al Centre Français di Milano. Diplomato a Parma e Milano, ha composto molta musica da camera, da chiesa, da teatro: se il primo genere, puntualmente ordinato per strumenti numerosi e diversi (fino a una sonata per spinetta), sembra ispirarsi al modello neoclassico o meglio neobarocco di Hindemith, il terzo si bilancia piuttosto fra gli esempi di Puccini, Menotti, Negri, dello stesso Mannino tanto è svelta, spiritosa, sentimentale, comunicativa. Palese l’ironia dell’Amante cubista, opera buffa da camera in tre quadri: prima è Amanda (s.) che risulta innamorata della figura maschile effigiata in un ritratto di casa, poi è il marito Gottardo (br.) che, dopo essersi liberato del rivale travestendosi da lui e comparendo a picchiare la donna, si innamora della figura femminile effigiata nel nuovo dipinto (intitolato come l’operina); quindi sono i due sposini che finalmente si ritrovano, ché Amanda getta dalla finestra anche il secondo quadro; infine è Wagner, il Wagner del Fliegende Holländer, a finir messo alla berlina, o alla gogna che dir si voglia, con quel quadro incombente su tutto il secondo atto dell’Olandese volante e la relativa, meravigliosamente fanatica ballata di Senta. Oltre trecento recite hanno segnato la sorte della partitura, in Europa e America; e buona fortuna hanno avuto anche le partiture operistiche seguenti, il buffo Week-end, il drammatico Requiem per Elisa, la cameristica Madame Landru (per soprano e due pianoforti), Una donna uccisa con dolcezza che è opera tragica e La Teresina che è opera per interpreti bambini, quell’Eureka Stockade che nel 1988 ha festeggiato il secondo centenario della nascita della nazione australiana (spesso il musicista ha scritto i testi in perfetto sodalizio con la moglie Ida Vallardi e firmato la regia delle messinscene). Parecchie di queste opere sono state tradotte in altre lingue, persino in svedese e in greco, per numerosi allestimenti fuori d’Italia e d’Europa. Piccolo capolavoro è Agenzia matrimoniale, opera buffa in un atto rappresentata al Regio di Parma nel 1962 con grande successo e quindi proposta frequentemente anche altrove, dall’Ungheria agli USA. Il simpatico libretto, scritto sia in prosa che in versi dalla Vallardi (anche responsabile dello spettacolo parmigiano), mette in scena Argia (s.), Adolfo (br.) e la Barbona (ms.), a Milano nel 1912 e cioè all’epoca del cinema muto, verso la fine della civiltà del Liberty, alla caduta degli ultimi romanticismi: dopo un’introduzione in cui la Barbona canta una canzoncina mista di lingua e milanese (“Cansun che l’è fada de nient”), capita che la matura Argia risponda a un’inserzione matrimoniale, si incontri con l’intraprendente Adolfo e ne venga abbandonata, quindi lo ritrovi per caso e s’unisca con lui per sempre. Lieto fine con qualche intoppo, però, ché lei non è proprio quell’ingenua e illibata infraquarantenne che si chiedeva, né quella sublime attrice che ha millantato davanti all’inserzionista, e lui sarà anche distinto e giovanile ma rimane un assicuratore non giovane e di estrazione alquanto modesta. “Uniamo le nostre due solitudini! / Io chiedo la tua mano”, recita l’uomo alla fine, e lei conclude “Assicurami contro gli incendi: / io brucio di passione!” (ancora recitando). È una musica deliziosa e sensibile quella che accompagna e interpreta il testo, fresca di melodia, linda e ariosa di canto, fluida di ritmo, lievitante sopra un’orchestra selettiva di ottavino, clarinetto, tromba, trombone, arpa, archi, pianoforte e fisarmonica ma non per questo avara o semplicistica. Con qualche fugace allusione a un passato sì vissuto con nostalgia (quante le donne maltrattate della letteratura! Arianna, Medea, Rosmonda, Didone, Giunone, Ermengarda, anche Ifigenia che rima con Argia) ma anche ricordato con tanto umorismo quanta sicurezza di mezzi tecnici. “Lei è un gran seduttore”, dice infatti Argia ad Adolfo che ha elogiato gli “occhi suoi profondi”, tra il Falstaff di Verdi e la Manon Lescaut di Puccini. E quando ancora Argia, personaggio in fondo non meno lirico che comico, canta l’assolo “Sola, disprezzata e derisa! / Addio, mondo”, è difficile che nella sua condizione ‘drammatica’ rifacciano capolino la povera Manon (“Sola, perduta, abbandonata”) e il saggio sir John (“ Mondo reo. Non c’è più virtù”). 9. Testi Le fonti del teatro di Flavio Testi (Firenze 1923) sono dotte e raffinate in giusta linea con la profonda cultura umanistica del musicista. Insegnante di Conservatorio, critico e musicologo, compositore fecondo di musica sacra e profana, vocale e strumentale, come drammaturgo autore di parole e musiche mira all’espressione realistica, diretta e immediatamente comunicativa di profonde tematiche moderne e contemporanee: titoli e lavori lampanti sono Il furore di Oreste del 1956, La Celestina del 1963, L’albergo dei poveri del 1966, Il sosia del 1981, Le chat del 1982, il Riccardo III del 1987, La brocca rotta del 1997, il Saül del 2003 derivano rispettivamente da Eschilo, De Rojas, Gorki, Dostoevskij, Baudelaire, Shakespeare, Kleist e Gide (artisti di orientamento diverso, spesso lontano, e come si vede scrittori in molte lingue diverse). Nell’opera di Testi la storia, l’intreccio, lo scenario, il personaggio hanno sempre grande evidenza, nella consapevolezza della loro precisa funzione scenica, propriamente drammaturgica; ma non per questo manca l’idea, il messaggio, il riferimento al mondo circostante. Lo dimostra Riccardo III, che nacque alla Scala di Milano nel 1987 dopo il lavoro di quattro anni e seppe servirsi dell’attacco di Shakespeare agli orrori del potere e alla realtà della tirannide denunciandone la strisciante resistenza e probabile ubiquità. Tratta e liberamente tradotta da The tragedy of King Richard the third (scritta e rappresentata nel 1591 o poco dopo), l’opera in tre atti racconta una storia variamente e altrimenti raccolta dalla musica, dal poema sinfonico di Smetana al balletto di Tutino, dalle musiche di scena che Walton compose nel 1955 per Shakespeare a una sinfonia-colonna sonora che Morricone compose per un film muto del 1912: Riccardo di Gloucester (t.) detto il Gobbo (1452 - 1485), che eredita il regno d’Inghilterra dal fratello Edoardo IV (t.) per diventare Riccardo III, sopprime il fratello Giorgio di Clarence (br.), seduce e sposa Anna (s.) vedova del vecchio re Enrico VI, fa uccidere i figlioletti del fratello e Anna stessa, sparge il terrore a corte e nel paese, diventa così impopolare da scatenare la reazione e morire in battaglia. Un mostro, insomma, così perduto nella notte del crimine da non essere degno di uno svolgimento credibile né in Shakespeare né in Testi. Infatti il protagonista di Testi canta da tenore nei pezzi d’assieme, ma nei monologhi si trova a cantare mediante un coro madrigalistico, come un assurdo assieme, un’innaturale ridda di voci brutali e senza volto; molti i personaggi attorno a lui, anche sua madre Cecilia (c.) e Margherita vedova di Enrico VI (ms.), meritevoli, questi sì, di espressioni a una, due, tre, più voci (per altrettanti di loro) fino ai tre grandi concertati che governano l’uccisione del fratello, l’incoronazione e la morte cruenta. Se è grande, quasi espressionistica, la forza della vocalità, non meno vigorosa e aggressiva è l’orchestra, che attorno agli archi esige legni a tre parti, ottoni a quattro parti, molte percussioni, arpa, cembalo e pianoforte. Modelli? i più diversi e opportuni, Schönberg, Bartók, Stravinskij, Dallapiccola non senza qualche tocco di Prokofiev e Hindemith.

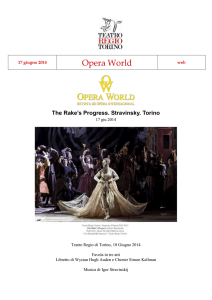


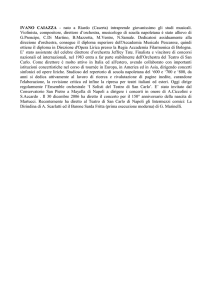
![Musica_e_immagine.pps [modalità compatibilità]](http://s1.studylibit.com/store/data/007566322_1-58d70b56b536a079f8882415348ab4fa-300x300.png)