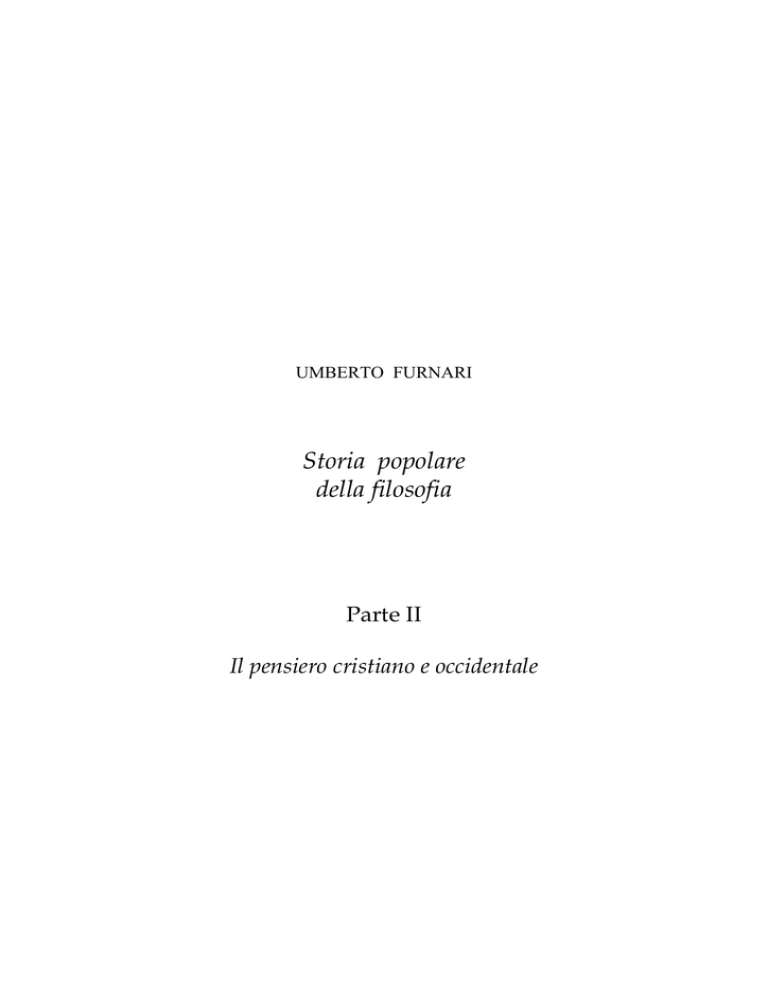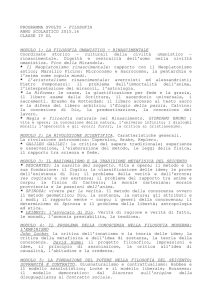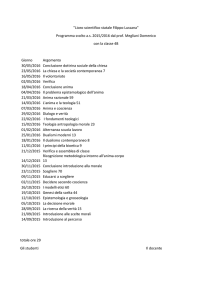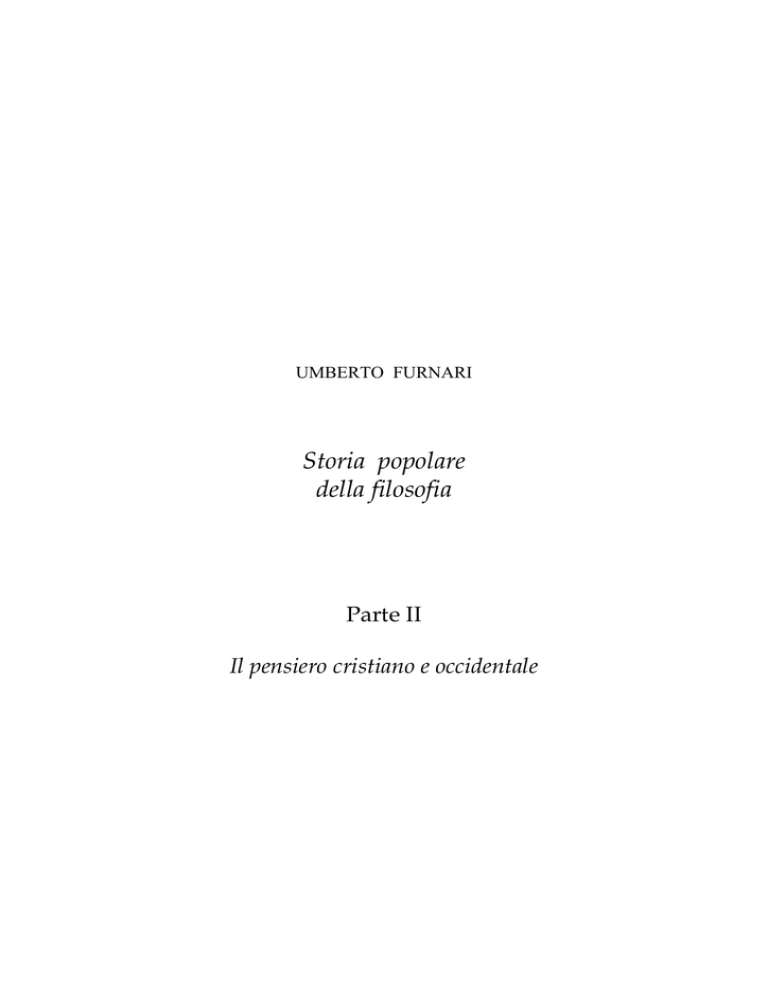
UMBERTO FURNARI
Storia popolare
della filosofia
Parte II
Il pensiero cristiano e occidentale
Presso l’Autore
2009
Parte II
Il pensiero occidentale
INTRODUZIONE
L’Europa, sintesi dell’Occidente
Attraverso la mediazione dell’impero romano il mondo greco è diventato il nucleo culturale
dell’Occidente, mentre il cristianesimo si profilava come il modello dell’umanità nuova, segnata dalla fede
religiosa, ereditata dall’antico ebraismo. Diversi fattori convergevano in una grande sintesi, aggiornata
secondo le esigenze dei tempi: la razionalità filosofica greca, la costituzione politica secondo le norme del
“ius gentium”, il patto religioso rinnovato sulla base del Nuovo Testamento. Con tali linee direttive
venivano gettate le fondamenta di una civiltà nuova, destinata a comprendere l’intera Europa (articolata
secondo le diverse nazioni). L’asse culturale fondamentale era costituito dal pensiero greco, che agiva e
permeava di sé l’intera articolazione del “logos” e attribuiva a ogni manifestazione spirituale i caratteri della
ragione dialettica (perciò atta a declinare le forme dell’argomentazione e del discorso). In virtù di tale
influsso, la comprensione della realtà continuava ad assumere la specifica caratteristica del “rendere
ragione”, cioè della dimostrazione logica e della sintesi dialettica. L’impero romano, d’altra parte,
rappresentava la nuova realtà politica capace di raccogliere entro di sé le molteplici comunità (popoli,
nazioni, città), garantendo il governo unitario e (nello stesso tempo) le specifiche connotazioni autonome
nel campo del diritto. L’eredità nuova e particolare, però, era costituita dal cristianesimo, la fede
miracolosamente alimentata dalla figura del Messia annunciato dai libri sacri degli Ebrei e presentato nella
forma del Dio incarnato. La nuova religione (di una portata mai vista prima e perciò recante i segni del
soprannaturale) si è delineata come l’evento spirituale più straordinario e inaudito: la forza con la quale si
andò affermando superava ogni resistenza, assumeva i caratteri della insopprimibile testimonianza. Si può
dire che mai una manifestazione della vita spirituale si era affermata in modo così potente e perentorio.
Quali che siano gli elementi della professione di fede, si deve ammettere che il cristianesimo rappresenta la
forma di religiosità che ha la dimensione storica più ampia e rappresentativa. Del resto, proprio in virtù di
questa religiosità, l’Occidente ha assunto un’espansione di livello mondiale. L’Europa, comunque, si è
formata attraverso il concorso delle componenti che abbiamo rilevato e che, per altro, nel segno di questa
realtà storica, si sono unite e sintetizzate mirabilmente. Per effetto dello “spirito apollineo”, la cultura
europea, ha potuto sostenere la lotta più significativa per l’affermazione della razionalità e della scienza,
nonché le più alte manifestazioni del libero pensiero. In virtù della prassi romana del diritto, l’Europa è
stata la sede stessa dello sviluppo storico di quelle istituzioni che oggi sono in grado di declinare, come nella
città democratica antica, la libertà personale e il rispetto del potere legittimo. L’Europa come sintesi
dell’Occidente si è formata nei secoli del medioevo, allorché, sul piano culturale, emerge il grande motivo
cristiano della unità di ragione e fede. La fede religiosa non rifiuta, anzi reclama e ricerca, l’attività della
ragione e, dunque, il lavoro della scienza; e d’altra parte la conoscenza razionale riconosce i suoi limiti e
cerca di trovare vie e percorsi alternativi per compensare in qualche modo il deficit della ragione.
Il mito
Il mito parla di Europa come di fanciulla di straordinaria bellezza, tanto da fare innamorare lo stesso
Zeus, che, avendola vista mentre giocava sulla spiaggia di Tiro, decise di rapirla, dopo avere preso le
sembianze di un toro bianchissimo. Era figlia di Agenore, signore di quella città; e venne trasportata da Zeus
a Creta, dove andò in sposa al re dell’isola Asterione e generò al sovrano degli dèi tre figli (Minosse,
Torpedone e Radamanto), adottati da quel re. Il toro personificato da Zeus si mutò quindi in costellazione e
venne posto tra i segni dello zodiaco. Europea rappresenterebbe l’unificazione di popoli diversi: il ceppo
fenicio, quello cretese e quello greco, attraverso l’ordine divino imposto da Zeus. In questo modo era
individuata la vasta regione occidentale, comprendente una varietà di stirpi e di popoli, tra di loro uniti sulla
base di “nozze sacre”, fondanti legami di parentela. In particolare, il mito esprimeva la consapevolezza dei
greci di costituire il grande fattore aggregativo dell’Occidente.
Le basi storiche dell’Europa
Roma ebbe il merito di avvicinare le varie realtà umane che costellavano il territorio europeo,
specialmente le città-stato mediterranee (caratterizzate da un’economia dello scambio) e le popolazioni
continentali (germani, celti, sciti, illiri) per lungo tempo legate a un’economia arretrata, primitiva. Creta (a
partire dal 2000 a. C.) fu la sede del primo sviluppo della civiltà urbana e commerciale, basata su una
stratificazione della società e sulla produzione manifatturiera. L’invasione dorica rappresentò il passaggio
alla civiltà greca, caratterizzata dallo straordinario sviluppo delle città-stato, con particolare riguardo
all’organizzazione della vita civile e all’espressione delle più complesse manifestazioni della vita spirituale.
Nel mondo greco ebbe modo di svilupparsi la cultura scientifica. Roma, che in origine era una delle città del
sistema mediterraneo (come Cartagine), si assunse il compito di unificare l’area europea attraverso la
“federazione” di popoli e di città variamente ordinati. Essa elaborò un modello unitario di ordinamento
civile e politico, secondo il quale le diverse popolazioni denominate “barbare” trovarono un nuovo
assestamento. Ma alla configurazione dell’Europa come realtà politica, economica, sociale, culturale concorse
principalmente il cristianesimo, in quanto forma comune di religiosità (e anche di concezione della vita e di
costume etico). Fu la dissoluzione della civiltà urbana antica, ma anche il sorgere di una civiltà nuova
imperniata sul concetto di “comunità” e tale che presto favorì il fiorire di una costellazione di centri
cittadini, il cui simbolo erano i campanili e la cui autorità si organizzava intorno ai vescovi e alle loro chiese e
cattedrali. Nei nuovi centri cittadini si conservò l’eredità romana delle istituzioni autonome, che erano un
lontano ricordo delle città-stato fiorite nel mondo mediterraneo. Questa prima fioritura era stato la prima
organizzazione di una società basata sul potere esercitato dal ceto produttivo, artigiano e mercantile, che era
una specie di prefigurazione del moderno potere borghese. Roma estese questo modello politico ed
economico all’Europa continentale. La compagine statale romana in realtà era un tentativo di dare una forma
unitaria allo sviluppo del mondo europeo. La crisi del modello mercantile esplosa, come è noto, nell’impero
romano ai tempi di Diocleziano, allorché si ebbero forme caotiche di ritorno all’economia agricola di
sussistenza (o semplice sopravvivenza). In quella occasione il conflitto tra la classe agricola e quella
mercantile raggiunse il suo culmine, quando la prima si trovò a dovere soddisfare le esigenze della secondo
attraverso una pratica di vero e proprio sfruttamento servile. La “borghesia” di quell’epoca mise le mani sui
latifondi, ponendo le premesse di quello che sarà il sistema feudale. L’egemonia delle città sulle campagne
nella civiltà pre-europea (ancora in gran parte mediterranea) fu imposta per legge più che costituire un
fenomeno economico dovuto al dinamismo stesso della produzione e dello scambio. Il modello economico
che allora si impose fu, appunto, quello aristocratico-servile, divenuto dominante nell’intero medioevo e
basato sul predominio di una classe nobiliare che riuscì a conservare il potere nelle condizioni di una società
essenzialmente agricola. L’impero romano rifletteva questa crisi e, nello stesso tempo, si configurava come lo
strumento di una interna trasformazione. Si può dire che quel modello doveva recare in sé tutti i fattori della
formazione dell’Europa medievale. La città di Roma era un simbolo di quella trasformazione: la megalopoli
di un milione di abitanti ospitava la nobiltà terriera dell’impero, che asserviva la classe artigiana e mercantile
e manteneva un vasto proletariato parassitario, troppo costoso e improduttivo. Queste contraddizioni
hanno finito per determinare la crisi del mondo antico, facendo saltare l’equilibrio sul quale esso poggiava. I
bisogni crescevano, la richiesta di manufatti aumentava, ma venivano a mancare i mezzi per mantenere in
vita una macchina produttiva complessa. Si andò delineando allora una contrapposizione crescente tra la
classe che, in definitiva, era arbitra e detentrice dei mezzi economici, e la classe addetta alla manodopera,
costretta a operare in condizioni disumane di stretta sopravvivenza. Il sistema statale pubblico andò
disgregandosi passando nelle mani di quella stessa aristocrazia che monopolizzava il potere. La nobiltà
terriera rifiutava in certi casi la sua collaborazione con lo stato e rivendicava per sé, ad esempio, il diritto o
privilegio di essere esonerata dai tributi.
La configurazione dell’Occidente come entità politica autonoma e separata dall’Oriente si profilò
chiaramente con la divisione dell’impero operata da Teodosio. Oriente e Occidente seguirono vie e percorsi
storici diversi. L’Occidente assunse allora caratteri peculiari, dovuti specialmente al modo in cui la Chiesa
cristiana riuscì a organizzare una forma di potere alternativo (e sostitutivo) a quello politico, di cui le città
continuarono a costituire le sedi geografiche. Fu così che l’Occidente poté conservare le istituzioni ereditate
da Roma, pur attraverso vicende complesse come, ad esempio, le invasioni germaniche. Specialmente il
patrimonio culturale, che affondava le sue radici nella sessa filosofia greca, venne conservato per l’opera del
clero monastico.
La Chiesa si fece interprete della conservazione di quel patrimonio civile e culturale (ma anche economico
e produttivo) che così passava a costituire l’impalcatura della nuova civiltà europea. Si può parlare della
costituzione dell’Europa come matrice comune delle varie nazioni. La complessa costellazione di popoli,
etnie, comunità che formano l’Europa si trovò legata da vincoli di varia funzione e natura. Quei popoli erano
in maggioranza germani, franchi, goti, avari, slavi, vandali, unni e così via: ma ciò che appare straordinario è
il fatto che una così vasta congerie di popoli poté, di volta in volta, attingere dallo “spirito europeo” le
condizioni (le istituzioni) della loro organizzazione e del loro sviluppo storico.
La pressione di popolazioni rimaste fino ad allora ai margini del mondo classico (l’Europa delle origini)
provocò un cambiamento nel disegno dell’Occidente, poiché le popolazioni germaniche lasciarono le
originarie sedi scandinave a nuovi nuclei e con la loro presenza si candidarono a guidare le nuove
trasformazioni nel continente europeo. Quando nel 476 fu deposto l’ultimo imperatore romano
d’Occidente, si erano formati già regni romano-barbarici in tutta la parte occidentale dell’impero. In quel
tempo la Chiesa si assunse l’incarico di conservare il patrimonio letterario fondamentale dell’antichità
classica. Carlo Magno successivamente si propose di unificare il potere romano-germanico, conducendo una
estenuante campagna repressiva contro i sassoni e gli avari, lasciando poi che nell’area estesa tra la Russia
meridionale e l’Europa centrale si riversassero gli slavi (slavi occidentali, polacchi, boemi, moravi, slovacchi,
russi e altri), che hanno concorso a completare la costellazione delle popolazioni europee. L’espansione
dell’Islam nel corso del secolo VII contribuì a ricacciare verso nord e verso occidente lo stesso confine
dell’Europa, costringendo (si può dire) il mondo occidentale a guardare verso l’Atlantico come nuova
frontiera di civiltà.
L’Europa feudale fu la realtà politica ed economica che prese il posto del mondo antico delle comunità. In
particolare, rispose alle esigenze di difesa del territorio in un’epoca di sconvolgimenti e di movimenti di
popoli in marcia. La difesa del territorio era affidata alla stessa comunità costituita e incardinata nella
proprietà del suolo. I comuni nascevano dall’organizzazione feudale, ne erano una diretta espressione. Il
mondo feudale si adattò alle nuove esigenze di produzione, di cultura, di reggimento.
Ciò autorizza a parlare di uno “spirito europeo” come di una forza interna all’Europa come forma
unitaria della comunità politica dei popoli. E’, del resto, l’idea medievale dell’Impero cristiano a
rappresentare questa realtà. Pur quando questa idea si è dissolta, essa ha continuato ad accompagnare il
progetto, diversamente configurato nella storia, di un’Europa spirituale, sede del pensiero scientifico e della
libertà laica e protagonista del processo di secolarizzazione moderna. Eventi come l’illuminismo hanno
potuto aver luogo solo in Europa e in virtù dello spirito europeo. Tale spirito ha presieduto via via al
molteplice processo di trasformazione e di assimilazione di una cultura essenzialmente razionalistica,
propria dell’umanità razionale, che ricerca in sé i percorsi della sua realizzazione ed espansione.
Il pensiero europeo o occidentale è lo stesso sviluppo e la medesima prosecuzione del pensiero antico. Là,
dunque, continueremo a ricercare tematiche e problemi, con riferimento ai modelli teorici e alle proposte
discorsive più appropriate e coerenti
La tradizione ebraica
Una componente fondamentale della civiltà europea (dunque dell’Occidente) è la tradizione biblica. Gli
ebrei, del resto, nella loro condizione della diaspora, cioè sparsi un po’ dappertutto nel mondo (e
specialmente in Occidente), conservarono la loro identità, rimanendo specialmente fedeli alla loro religione e
avendo come fondamento assoluto della loro fede il corpo della Sacra Scrittura (l’Antico Testamento) e,
dunque, uniformando continuamente i loro costumi e le loro regole di vita ai comandamenti divini. In primo
luogo per gli Ebrei c’era la Legge, i comandamenti dati da Dio a Mosè. Il Dio unico si rivelava come la fonte
diretta di ogni prescrizione relativa alla vita quotidiana. Anche se gli Ebrei avevano la consapevolezza che
ogni istituzione era stabilita dagli uomini nel tempo e aveva, pertanto, un carattere storico, essi avevano la
convinzione di potere attingere, di volta in volta, alle radici della rivelazione. La Legge poteva essere sempre
interpretata attraverso la parola stessa di Dio, continuamente operante. Gli Ebrei ebbero, così, la certezza di
essere in continua relazione con la Trascendenza, cioè con una realtà che oltrepassava la storia, anche se
agiva e si rivelava nella storia. Ciò che è eterno, infinito, assoluto costituisce un punto di riferimento per
ogni questione per quanto finita e temporale essa fosse. Gli Ebrei ebbero la convinzione che attraverso la
Scrittura la Parola divina fosse in continua partecipazione. La Legge era intimamente radicata nello spirito
vivo della tradizione e nella stessa coscienza individuale e collettiva. Il Dio unico non poteva, perciò, avere
un carattere storico: non poteva neppure appartenere a un popolo, bensì doveva essere il Principio
ordinatore per ogni evento. La creazione, del resto, aveva i caratteri dell’ordine unitario del mondo: unico
era il mondo creato, unico era l’ordine del mondo. L’uomo, creato a immagine di Dio, aveva gli stessi
caratteri dell’identità. Una era, pertanto, l’umanità. Tuttavia gli Ebrei ebbero la consapevolezza che nella
storia operano popoli diversi, soggetti al tempo e ai cambiamenti; e conservavano la fede di costituire in
qualche modo il popolo eletto, destinato a unificare l’umanità in un solo ordinamento civile. Un
fondamentale universalismo attraversa, pertanto, la tradizione biblica. Si possono individuare, in questo
modo, i caratteri di un fondamentale cosmopolitismo. Per gli Ebrei, Cristo non è il Messia annunciato per la
fine dei tempi, bensì è l’ultimo profeta che opera in un tempo storico. Ciò non vuol dire, tuttavia, che la
religione ebraica non possa dialogare col cristianesimo, dato che la stessa tradizione biblica è accolta e
riconosciuta come parte della rivelazione. E, d’altra parte, il dialogo che investe tutte le religioni è condotto
da una parte secondo la costituzione universale dell’umanità e d’altra parte si riporta alle radici misteriose
della religiosità.
L’ebraismo rappresenta un motivo essenziale del più ampio discorso sull’attuale progetto dell’umanità
universale. In particolare, esso è in grado di dire qualcosa di decisivo intorno alle forme nuove in cui sta per
essere vissuto il rapporto fra tradizione religiosa e innovazione temporale, tra eternità e secolarità. Per
l’Occidente lo spirito dell’ebraismo continua a costituire un fecondo elemento di sviluppo.
Gli Ebrei hanno avuto il destino di essere un popolo votato a testimoniare la sofferenza e l’infelicità
connessa alla sottomissione, alla diaspora, alla persecuzione. Di fronte a un corso storico segnato dal dolore,
dal limite e dalla schiavitù, essi sono riusciti comunque a sopravvivere, mediante il dono di una fede
potentissima e l’adesione sempre convinta alla Legge divina.1 Tutto ciò che riguarda la fede costituisce per
gli Ebrei un patrimonio incrollabile.2 Si tratta di un patrimonio indubbiamente significativo per la stessa
costruzione dell’umanità storica.
Un altro motivo della religiosità ebraica è la percezione di Dio come lontano e inaccessibile. E ogni
tentativo di mitigare quella lontananza fallì ripetutamente: ogni volta che gli Ebrei diedero al loro Dio
un’immagine umana e lo introdussero nelle loro feste come presente nel mistero, dovettero sentire quelle
esperienze come un allentamento da Dio, come un tradimento e un abbandono della Legge. Gli Ebrei hanno
sviluppato così il senso della incommensurabile distanza che separa sempre l’uomo da Dio. La stessa figura
di Dio divenne sempre più inimmaginabile e spirituale.3
A questo punto troviamo la massima tensione della religiosità ebraica: e possiamo dire che questo
estremo confine della spiritualità coincide con il messaggio di Cristo, espressione del sovrannaturale
incontro di Dio e dell’umanità, di Dio e il mondo. Ma per gli Ebrei ciò poteva essere comprensibile come
rimandato alla lontananza abissale della fine dei tempi.4
La religione ebraica tendeva a stabilire una condizione di equilibrio tra la rinuncia al mondo e il
padroneggiamento del mondo. La convinzione di essere pronti a rimandare all’infinito il compimento della
stessa umanità coincide con la certezza che la fede in Dio è sufficiente a consentire il conseguimento della
1
“Attraverso tutte le situazioni, in tutte le trasformazioni della loro fede, rimase tra questi uomini sempre quella
ininterrotta e incrollabile coesione di rapporti, dovuta a quella verità, che su tutto dominava: la verità della fede nel loro
Dio, unico e solo. Sempre rimase vivo in loro qualche cosa della Legge di Dio, della alleanza con Dio e dell’appello e
della preghiera a Dio” (K. Jaspers, Della religione biblica e della necessità di una sua riforma, in “Atti del Congresso
Internazionale di Filosofia” Roma 1946, Milano 1948, pp. 249-50).
2
“Da allora fino a oggi essi hanno avuto sempre la persuasione, non ancora vinta e superata, a derivare dalla fede in
Dio e dalle sue conseguenze tutto ciò che fanno, la maniera di regolare il loro mondo, di costituire i loro stati, di
ordinarli e governarli. […] Quello che ebbe luogo per questi uomini nel loro stato di dura impotenza e abiezione, cioè la
possibilità di ascoltare la parola del loro Dio, negli stati cristiani dell’occidente, venne intesa, pur con notevoli
limitazioni, come una forza capace di dare un assetto e una regola a tutto il mondo” (l. cit., p. 250).
3
“Per il fatto che ora era stato staccato da ogni cosa nel mondo, Jehova diventò ormai, in piena e perfetta coscienza,
il Dio universale, il Dio di tutta l’umanità, l’unico Dio, trascendente, creatore dell’universo” (l. cit., p. 251).
4
“Nella religione degli apostoli, Gesù venne ritenuto il Messia. Nel mondo era stata raggiunta la pienezza dei tempi
ormai connessa con la convinzione della imminente fine del mondo. Di nuovo fu possibile una deviazione con la
tendenza a cercare l’appagamento nel presente. Gesù, ritenuto il Cristo, veniva a significare addirittura la presenza di
Dio nel mondo, in carne ed ossa. Da ciò non derivò soltanto la presenza di Dio nel mondo, nel sacramento
dell’Eucarestia, ma anche una presenza di Dio nella Chiesa, ritenuta essa stessa come il corpus Christi” (l. cit., pp. 25152).
felicità. La certezza coincide così con l’estrema incertezza. Ciò che è l’uomo stesso non è chiaro, ma è certo
che egli è una creatura di Dio.5
Gli Ebrei sono vissuti (e tuttora vivono) in uno stato d’attesa, sempre pronti a rispondere a una chiamata,
disponibili per qualsiasi compito Dio voglia affidare nella storia. Gli Ebrei, in questo senso, vivono
nell’”apertura”, in un orizzonte mobile e modificabile, pronti a sostenere le prove più difficili e i sacrifici più
pesanti. Che cosa vuol dire ciò per una comunità politica che si trova al centro degli avvenimenti del
mondo? Che cosa, cioè, significa un tale impegno per l’Europa? Vuol dire che l’Europa eredita dalla storia
degli Ebrei la coscienza critica del “non sapere” e della disposizione a impegnarsi a fondo per la conoscenza.
Tutti i sentieri vanno percorsi, nessun tentativo deve essere tralasciato. In questo senso, la cultura
dell’Europa accetta e accoglie ogni proposta, da qualsiasi parte venga. Nessuna umanità va esclusa.6
Ogni amicizia, pertanto, va difesa e conservata.
Il destino della tecnica
Secondo il racconto della creazione, Dio ha disposto ogni cosa per il bene dell’uomo: perciò spetta
all’umanità inserirla nel piano del suo sviluppo, farne un elemento della sua prassi quotidiana. Ogni cosa ha
un senso in quanto serve al progetto di sostentamento e miglioramento dell’umanità. Già gli Ebrei
dell’antichità hanno ampiamente parlato di questo destino delle cose. Dio ha deliberato di offrire all’uomo in
dono l’intero universo; e l’uomo ha accettato tale dono facendolo crescere e svilupparsi secondo le esigenze
interne della sua natura. Nello stesso tempo Dio ha obbligato l’uomo all’apprezzamento positivo di tale
dono, alle cure più sollecite per l’esaltazione dell’universo.
In realtà, il comandamento relativo alla contemplazione della bellezza del creato è stato rispettato solo in
parte e per aspetti limitati. Sono da ricordare, specialmente, gli episodi di sfruttamento incondizionato
dell’ordine delle cose, gli stravolgimenti a vantaggio della umana utilità, i numerosi esempi di
mercificazione, la riduzione dello spettacolo meraviglioso dell’universo a motivo di consolazione della
umana felicità. Parlando dell’uomo, ogni tema si converte nel suo contrario. Ciò che appare maggiormente
certo è il carattere di questa vicenda, che concorre ad allontanare Dio dal mondo e a caratterizzare l’esistenza
come un fallimento.
Da tale situazione complessiva deriva la domanda radicale intorno al carattere dello sviluppo storico
dell’umanità. Dal dibattito più recente emerge che lo svolgimento del pensiero ha favorito questa linea di
sviluppo, che, cioè, la concezione del mondo prevalente in Occidente si configura come la più vicina a uno
stato conflittuale dell’uomo con la natura e, dunque, al diritto proprio di una civiltà a garantire la più ampia
difesa possibile dal male, dall’ignoranza, da ciò che provoca distruzione, male, infelicità. Epicuro,
nell’antichità, intendeva tracciare la via della migliore ricerca della felicità: conformarsi piuttosto alle
esigenze della natura, non cercare di travalicarne i confini, attuare una vita secondo la profonda radice
dell’umanità.tutto ciò sarebbe da ricercare e perseguire. Nell’età moderna, Leopardi ha suggerito all’umanità
minacciata da catastrofi naturali una reazione dignitosa e coerente, la solidarietà come argine di difesa,
dunque la conoscenza come terapia e medicina efficace. L’uomo avrebbe disposto quella medicina contro
una malattia procurata da se stesso.
Oggi la condizione umana appare come quella dell’ente più fragile e problematico. Ciò è una
conseguenza dello sviluppo del pensiero? La linea della civiltà in Occidente è coerente con una determinata
visione del mondo? Vedremo che una tale ipotesi contiene motivi notevoli di riscontro. D’altra parte,
tuttavia, una linea opposta evocherebbe una situazione esistenziale non meno problematica e segnata dalla
fragilità e dalla sofferenza.
Platone nell’antichità ha individuato il carattere e lo scopo della filosofia nel configurarsi come una
“medicina dell’anima”, come un “thes psyches farmakon”. Dobbiamo tornare a questa definizione? E in che
senso “anima” e “rimedio” e “malattia”?
5
“Ovvero si è venuto a chiarire che l’uomo è uomo, che cioè non è un essere ben riuscito nella sua specie, e
prederminato fin da principio nella sua evoluzione, ma un essere fragile, che tuttavia è destinato a mirare a quel che ci
possa essere di più alto, a osare e rischiare in base alla sua libertà, un essere che appunto per questo non può trovare
nessuna forma dove adagiarvisi in modo definitivo, ma sempre, attraverso nuove specie di fallimenti e insuccessi, va
per la sua strada, nel corso dei tempi, senza sapere dove vada a riuscire” (l. cit., p. 253).
6
“E’ come se il destino dell’occidente fosse quello di trovare, prefigurate attraverso la memorabile autorità del libro
santo su cui si basa la sua civiltà, tutte le contraddizioni della vita stessa, e quello di diventare e sentirsi libero di fronte
a tutte le possibilità nella lotta interminabile per l’ascesa e il trionfo dell’uomo, che si riconosce in sé come un dono di
Dio la facoltà di agire affatto liberamente” (l. cit., p. 257.
La filosofia come “medicina dell’anima”
Lo studio del filosofo somiglia al laboratorio del farmacista: il filosofo e il farmacista avrebbero l’identico
compito di preparare medicine, l’uno rivolte alle cure del corpo, l’altro farmaci rivolti ad alleviare i
patimenti dello spirito. In che consistono le malattie dell’anima?
Platone stesso ci indica che le malattie dello spirito sono i vizi, quelle pratiche di comportamento che sono
gli opposti delle virtù. Fra i vizi enumeriamo l’ignoranza, l’ingiustizia, la violenza morale, la cupidigia, la
lussuria e così via (i vizi impersonati dalle tre fiere dantesche).
La filosofia è, dunque, lotta dello spirito per il trionfo della virtù.
Essa può dirsi un rimedio contro le malattie dell’anima.
Il nostro problema, ora, consiste nel riconoscere le malattie alle quali è maggiormente esposta l’anima nel
nostro tempo.
La gerarchia: celeste, terrestre, sacra
Propria della cultura medievale è la concezione gerarchica del mondo. La gerarchia s’instaura già a
partire dal fondamento (o principio), da Dio, al quale si attribuisce una costituzione trinitaria, in cui le
Persone sono gerarchicamente ordinate e dipendenti. Tutto avviene e si sviluppa sulla base di questo ordine,
attraverso la rispettiva gerarchia delle sostanze e dei simboli. Le cose comunicano tra loro mediante il
riferimento al loro ordine gerarchico: dunque le meno spirituali non direttamente con le più spirituali bensì
attraverso la mediazione di sostanze intermedie. L’ordine sociale riflette la gerarchia tra le sostanze. Non si
dà struttura in cui non vi sia ordine gerarchico di gradi o valori (ad esempio tra i gradi di una corporazione o
di una scuola; così lo scolaro è subordinato al maestro).
Particolare significato hanno le gerarchie celesti, poiché in esse sono incardinate le sfere astronomiche.
Il dionisiaco come demoniaco: angeli e demoni
Il dionisiaco nel medioevo assume l’aspetto del demoniaco, dunque si rappresenta come una mescolanza
di principi e forme tra il bestiale e l’umano. La vita del cristiano è considerata una lotta per il trionfo sul
male, con la sconfitta e la cacciata delle schiere di demoni.
Macrocosmo e microcosmo
L’universo medievale è concepito come un’unica immensa sfera costituita gerarchicamente da sfere celesti
concentriche e ruotanti intorno alla Terra. Gli influssi dei cieli si riflettono, dunque, sulla Terra, passando
attraverso le diverse sfere. Da ogni sfera provengono influssi specifici, in modo che i caratteri delle singole
sfere vengono a determinare la natura degli enti che vivono sulla Terra. Così si stabiliscono i caratteri astrali.
La forma in cui questi caratteri influiscono direttamente gli enti è quella che essi assumono nella sfera
immediatamente esterna, cioè nella sfera della Luna. In questa concezione si riflette ancora una visone
animistica, per cui il principio di raccordo tra le parti dell’universo è l’anima del mondo. L’età moderna ha
visto poi l’elaborazione di una visione meccanicistica, dove l’unico criterio di valutazione è l’ordine
matematico dello spazio e del tempo.
L’ordine naturale assume, comunque, una dimensione autonoma: esso è uniforme e dovunque regolato
da leggi precise. La tendenza a spiegare tutti i fenomeni mediante i principi della natura stessa è radicata
nella mentalità occidentale. La matematica consiste nell’ordine della natura stessa. Secondo la tradizione
pitagorica, le figure geometriche si identificano con le strutture matematiche della natura. In questo senso, il
fuoco, l’aria, l’acqua, l’aria costituiscono i fondamentali poliedri; e le modificazioni geometriche con la
formazione degli altri solidi corrispondono alle trasformazioni dei corpi e delle sostanze.
Il canto delle sirene
Piuttosto che tapparsi le orecchie, come i suoi compagni, Ulisse si fece legare all’albero della nave, per
potere ascoltare il canto delle sirene, tanto egli era curioso e desiderava andare incontro a quella esperienza.
Quel canto, infatti, doveva comprendere in sé qualcosa di estremamente meraviglioso, doveva racchiudere
qualcosa del mistero che sta alla base dell’espressione per via del canto. Quale doveva essere la struttura di
quel canto? Doveva trattarsi, principalmente, di una via di mezzo tra la musica e la parola: di qualcosa che
avesse la sua forma propria nella musicalità e che fosse, nello stesso tempo, linguaggio articolato in discorso.
Una sintesi a priori, direbbe Croce, di suono e di sentimento, di impressione ed espressione. In quel canto
doveva trovare dimora il mistero originario, primordiale, del ritmo della parola. Ulisse non poteva sottrarsi a
quell’esperienza, in quanto non poteva rinunciare a qualcosa che apparteneva al mistero originario
dell’esperienza umana. Non poteva fare a meno di qualcosa di così essenziale e fondamentale per l’uomo.
Ma il canto delle sirene è presentato da Omero come qualcosa di rischioso, di pericoloso. Chiunque avesse
ascoltato quel canto non sarebbe trattenuto dal desiderio di prendere dimora presso di esso medesimo (o
delle sirene). Dunque doveva trattarsi di un “luogo” originario, avvertito da chiunque come la propria patria
e dimora essenziale. Quel canto si presentava come l’invito a prendere dimora presso di esso. Il pericolo
consisteva in questo: dunque dal distogliere l’uomo dalle sue cure e dai suoi affetti “storici”, per restituirlo
alla sua natura essenziale e originaria (lo stesso abisso del mare?).
Il canto delle sirene è presentato, in secondo luogo, come rivelatorio, come l’epifania del mistero.
Chiunque lo avesse ascoltato avrebbe conosciuto qualcosa di fondamentale, sarebbe pervenuto a un sapere
assoluto.
Il canto delle sirene come sapere assoluto. Ma che vuol dire ciò? Vuol dire qualcosa che, ovviamente, non
può esprimersi che nella forma del misterioso. Il sapere è il mistero nel corso della sua rivelazione. E’
potenza di rivelazione.
In terzo luogo, il canto delle sirene ha il carattere della musica. E ciò vuol dire che la musica è
l’espressività radicale, l’uomo in quanto si esprime, rivelando se stesso. Ulisse sa così che sta per toccare il
fondo del mistero umano in cui egli radicato e che, in certo senso, egli medesimo è.
Il canto delle sirene è ciò e, insieme, tante altre cose. In quanto appartiene alla poesia, poi, indica la
condizione radicale dell’esistenza, la forma misteriosa e problematica dell’umanità.
Attraversando quel canto, l’uomo viene a conoscenza della sua natura, compie perciò l’esperienza più
propria e radicale che è connessa al suo destino.
La filosofia dell’esistenza come filosofia del finito
La filosofia dell’esistenza si pone come filosofia del finito. Essa muove da un presupposto: che la realtà nella
sua totalità e nella sua costituzione radicale (dunque come essere) è finita e che proprio in quanto tale essa
risulta comprensibile, in qualche modo racchiusa dalla mente (misurabile). Dunque alla base vi è una specie
di precomprensione della realtà, un orizzonte in cui s’intende racchiuso il reale nella sua dimensione assoluta,
cioè in quanto reale o essere.
L’infinito sarebbe, da questo punto di vista, incomprensibile, incommensurabile. Solo adottando il criterio
della finitezza, si può supporre il reale come comprensibile. Solo il finito è misurabile, dunque afferrabile
dalla mente.
Che ne è, allora, dell’infinito? Un modo immediato in cui si ipotizza l’infinito è quello relativo al concetto
di indeterminato: questo era il significato attribuito all’apeiron da Anassimandro: l’assolutamente
indeterminato di Hegel, il nulla di determinato, tanto da potere essere chiamato anche nulla, l’assenza di ogni
determinazione. In realtà è questo il significato in cui generalmente è stato inteso l’essere infinito nella
storia della filosofia.
Quando poi si fa coincidere il concetto di “infinito” col concetto di Dio, si ammette che di tale concetto
non può aversi nessuna conoscenza razionale. Dunque solo del finito si può avere una conoscenza propria,
che sia a portata dell’uomo. La ragione comprende solo il finito; solo il finito è razionale. La filosofia
dell’esistenza, in questo senso, si costituisce come sapere razionale, indagine per la ragione.
L’esistenzialismo è anche razionalismo. Una conoscenza razionale si può avere solo del finito. La ragione,
infatti, per definizione è comprensione del misurabile, dell’ordinabile, del determinabile. Laddove non
abbiamo misura (e cose misurate), determinazioni, esistenze, fatti circoscritti, orizzonti limitati, e così via,
non abbiamo neppure qualcosa che possa dirsi reale.
Anassimandro, come ha osservato Haidegger, ha colto per primo l’essere come maniera determinata della
sua manifestazione. Non possiamo cogliere l’essere che nel modo della sua determinazione.
Ogni essere, ogni verità, ogni idea, ogni sostanza ha il modo della determinazione, tanto che possiamo
dire che solo del determinato si può avere comprensione.
Che ne è, dunque, ancora, dell’essere?
Evidentemente dell’essere si continuerà a parlare: solo che se ne parlerà come finito, come esistenza.
Ma il finito può avere i caratteri del fondamento? E’ finito, ad esempio, l’Uno di Plotino? Ma proprio
l’Uno è il principio di ogni determinazione e non è concepibile ad di fuori delle sue determinazioni
medesime.
L’Uno esige il suo compimento: solo nell’unità compiuta del suo svolgimento esso è pienamente se stesso.
L’Uno non sarebbe tale se non fosse anche la negazione di sé, il limite, la materia, l’assenza di essere. Perciò
la concezione di Plotino è quella che più pienamente comprende la finitezza dell’infinito.
Le forme del finito: pensiero ed esperienza
Nel corso della filosofia moderna sono emerse le due dimensioni fondamentali della comprensione del
finito: l’esperienza e il pensiero. Nello svolgimento di questa filosofia è emersa la tendenza spontanea dello
spirito umano (della coscienza) al sapere. Lo spirito (il momento soggettivo) non può fare a meno dell’altro.
Esso deve trovare, posto di fronte a sé, il suo opposto. Perciò l’idealismo, volendo tutto risolvere nell’istanza
del pensiero, si pone fuori del processo della conoscenza, rischia di dover trarre da sé il suo oggetto. D’altra
parte il realismo, negando ogni trascendenza, non trova poi le condizioni del sapere. Realismo e idealismo si
precludono la via dell’intelligibilità del reale. Perciò giustamente la filosofia moderna (nel suo culmine in
Kant) ha rilevato la funzione risolutiva delle due strutture fondamentali del reale, il soggetto (il pensiero) e
l’esperienza (il dato). Ma il reale non è altro che la dimensione trascendentale dell’esperienza; e similmente il
soggetto rappresenta la condizione trascendentale del reale. Il soggetto è il reale stesso nel suo trascendersi.
Il reale è il soggetto in quanto si va trascendendo. Il pensiero nel processo del suo trascendimento si fa realtà,
dato, conosciuto. Il reale, in quanto trascendersi, diventa soggetto, esperienza, storia.
La filosofia dell’esistenza supera entrambi i presupposti: il realismo e l’idealismo. Essa porta a
compimento il processo del pensiero moderno. Cartesio con l’istanza dell’idealismo è contrapposto a
Francesco Bacone con l’istanza dell’esperienza. Ma solo con Spinoza, Leibniz, Kant si perviene alla
comprensione del trascendentale e si risolve il problema della conoscenza. Ma l’equilibrio di pensiero ed
esperienza è durato fino all’affermazione dell’idealismo. Questo ha riproposto l’istanza soggettivistica,
disperdendo l’esigenza trascendentale. La restaurazione dell’equilibrio moderno a questo punto appare
come un’esigenza insopprimibile. La diade di pensiero ed esperienza torna ad apparire fondamentale. La
filosofia dell’esistenza è la posizione di questa istanza.
Protagora e la duplice fonte del reale
Platone aveva già avvertito questa istanza, allorché nel “Teeteto” aveva presentato Protagora come un
sostenitore di una “doppia dottrina”, per la quale il celebre sofista, comunemente conosciuto per il suo
relativismo, avrebbe professato la teoria della duplice fonte dell’esperienza, la fonte “interna” e quella
“esterna”. Da una parte, cioè, si pone la realtà (ad esempio questo che io conoscerò come “vino” ma che
intanto non distinguo e non so che cosa sia) e dall’altra parte il soggetto (prima di compiere una qualsiasi
esperienza). Si parla di realtà in rapporto a questi due elementi. La realtà emerge in seguito allo sviluppo
dell’esperienza. Trovandosi a contatto, i due principi si manifestano per ciò che sono: il vino e io che ne ho
esperienza. Protagora, riferisce Platone, sapeva che il contatto o rapporto tra i due elementi concorre a
manifestare la realtà duplice, da una parte gli oggetti, le cose, dall’altra parte il soggetto. Non si possono
scindere, pertanto, il soggetto dalla sua esperienza; non si può separare l’esperienza dal suo oggetto. Questa
dottrina rappresentava come uno sviluppo e una conseguenza dell’eraclitismo. La realtà è divenire continuo,
rapporto di due termini originari nel loro sviluppo. Prima di ogni esperienza il vino non si sa che cosa sia, fa
parte di un “indeterminato”, di un generico “qualcosa”, a cui non si può attribuire una specifica identità.
Allorché si costituisce l’esperienza, il vino si rivela per ciò che è. Sul piano dell’esperienza io distinguo
l’oggetto e il soggetto, il reale e il pensiero, e il loro rapporto.
L’esperienza è, dunque, la base e il presupposto di ogni reale.
Il realismo, invece, tende a presupporre il reale dome “dato”, prima e indipendentemente da ogni “altro”,
fuori di ogni trascendenza o trascendimento.
L’idealismo risolve ogni dato nel pensiero.
Bisogna, dunque, eliminare reale e pensiero come “dati” indipendenti dai principi che reciprocamente li
sostengono.
Il reale è propriamente nell’ambito (nell’orizzonte e sulla base) del pensiero; e non si dà pensiero se non
nella declinazione del pensiero.
L’equivoco del reale in sé accompagna l’intera storia del pensiero. Protagora ha rilevato l’incongruenza
fondamentale, ciò per cui ci si preclude l’accesso al senso della realtà, al campo dell’esperienza. Non esistono
le “cose”, avvertì il celebre sofista; esistono le esperienze.
“Ta pragmata”: la costituzione paradossale delle cose consiste nell’attività del pensiero; e le “cose” hanno
una consistenza originaria in una condizione che è trascendimento continuo. Il reale si pone sul piano
dell’esperienza.
Non è possibile sopprimere né l’istanza del reale né l’istanza del pensiero.
Queste due istanze stanno insieme, appartengono a un nesso fondamentale. Né sarà mai possibile
scinderle e separarle.
Perciò Parmenide avvertiva: non sarà mai separato l’essere dall’essere, la sostanza da se stesso. Protagora
non fece altro che continuare Parmenide: il sofista approfondiva l’eleatismo. Eraclitismo, eleatismo,
protagonismo potevano saldarsi insieme in una concezione che si profilava come il nucleo di ogni
metafisica.
Esistenzialismo, decadentismo, nichilismo
Esistenzialismo, decadentismo, nichilismo hanno una medesima radice: appartengono alla
matrice
culturale degli ultimi decenni dell’Ottocento e si sviluppano come elementi di una sintesi unitaria,
caratterizzata, in definitiva, da una “crisi della ragione”, da un “indebolimento” del pensiero razionale, da
un ripiegamento verso le sorgenti irrazionali e mistiche del discorso.
Dunque si tratta di aspetti della crisi del razionalismo. La ragione (facoltà del “logos”) è considerata, nella
tradizione dell’Occidente, la facoltà fondamentale, lo strumento infallibile dello spirito, la misura (il criterio)
di ogni costruzione spirituale. In questo modo la cultura occidentale ha curato poco di cimentarsi con
l’ineffabile.
La scoperta dell’ineffabile avviene proprio nel clima culturale di fine Ottocento. Si scoprono, nello stesso
tempo, l’insufficienza del “logos”, i limiti espressivi della ragione.
I poeti “decadenti” si sono rivolti disperatamente alla ricerca di strumenti mentali idonei a una qualche
accessibilità al dominio del mistero, del sovrarazionale. Pensarono che ciò potesse avvenire al margine della
parola comune, in quella zona dell’esperienza in cui si costituiscono i significati. Si cercò, pertanto, di
sondare certe profondità dell’intuizione, per promuovere lo sviluppo dell’immaginazione e ottenere
“illuminazioni”, “folgorazioni” di alto contenuto mistico. Infatti si trattava di abbattere ogni residuo muro
che separava le sfere del pensiero e della realtà, in modo che si avesse l’identificazione della creatività
soggettiva e dello sviluppo del reale. La via mistica della diretta comunicazione tra la natura e la parola
appariva come il nuovo modo di cogliere il senso della realtà. Era il superamento di ogni naturalismo: le cose
diventavano “simboli”, forme di rimando alle esperienze più segrete e profonde della realtà.
Le cose hanno incominciato a vivere nella sfera dell’immaginazione, cioè hanno avuto una vita diversa da
quella che comunemente vi si attribuisce. Non la pesantezza dell’”essere” e della “coralità”, bensì la
leggerezza del “non essere” e della “possibilità”, dell’immaginario e del luminoso.
L’esistenzialismo considera la realtà nel luogo dell’esistenza, dove essere e non-essere non sono categorie
immutabili di una costituzione definita ma rappresentano i modi secondo cui si costruisce la vita
dell’esistenza. La realtà passa attraverso l’esperienza dell’esistenza.
Infatti proprio a partire dall’esperienza assume consistenza il non-essere, che coincide con l’attività
nullificante dell’esistenza. L’esistenza ha a che fare con l’essere e il non-essere. E ciò aveva già visto Platone,
quando aveva connesso essere e non-essere allo sviluppo del pensiero.
L’esistenzialismo dice “esistenza” al posto di “pensiero”, per sottolineare che qui ci si pone dal punto
di vista del finito e che a essere coinvolta è l’intera esistenza umana.
L’essere è strettamente congiunto all’esistenza, tanto che solo a partire da questa (nell’orizzonte di essa) è
possibile pensare.
Quando Platone, nel celebre passo scelto a epigrafe di “Essere e tempo”, metteva in rilievo che ancora
nessuno è pervenuto a chiarezza intorno al significato del termine “essere”, si riferiva una tale questione.
L’esistenzialismo ha inteso riportare la questione dell’essere alla sua sede propria, cioè all’orizzonte
dell’esistenza. Solo a partire dall’esistenza ha senso parlare dell’essere e del non-essere.
Protagora e Gorgia hanno visto bene. Il primo ha messo in rilievo il primato dell’esperienza umana,
dichiarando che questa è il punto di partenza per ogni conoscenza. Il secondo ha riportato al pensiero e alla
sua comunicabilità (dunque al modo dell’esistenza) la medesima questione. In particolare, egli ha voluto dire
che la questione in definitiva si riporta all’esistenza umana come esperienza comunicabile. “Essere” e “non
essere” sono termini il cui significato si gioca (si decide) al livello dell’esistenza.
Che la sfera della comunicazione non possa restringersi alla semplice razionalità è un’altra questione,
esplosa con la crisi generale della razionalità. I poeti decadenti e i simbolisti hanno scavato nell’interiorità
della coscienza e nelle profondità dell’esistenza, per tradurre ai margini della parola le illuminazioni
simboliche colte e costruite dall’immaginazione.
Gorgia si riferiva al discorso come “logos” cioè come espressione della ragione. Protagora faceva
riferimento alla più ampia sfera dell’esperienza dell’esistenza umana. I due sofisti, con una reciproca
integrazione di prospettiva, coglievano la dimensione dell’esistenza.
Si deve ammettere che il pensiero come “logos” abbia avuto un indiscusso primato nell’intera storia della
cultura occidentale. Ma ciò non vuol dire che generalmente si sia avuta una riduzione dell’esperienza totale
al discorso razionale. L’interiorità è stata vista sempre come una risorsa molteplice di un discorso più
profondo.
Gli antichi chiamarono “sublime” l’immaginario, il simbolico, ciò che sta al limite del razionale e che ha
a che fare con l’esperienza nella sua totalità.
L’esistenzialismo, nella sua storia complessa, ha affrontato la questione dell’essere da una molteplicità di
punti di vista: ad esempio, secondo il criterio classico della filosofia trascendentale (Heidegger); secondo il
concetto agostiniano dell’interiorità spirituale e agostiniana (Le Senne, Lavelle); oppure sotto il profilo
dell’esperienza dell’”inverificabile”; o dal punto di vista della prospettiva della “rivoluzione totale” (Sartre);
o secondo una versione “positiva” e in fondo problematicistica e neorazionalistica. Il punto di vista
dell’umanesimo assoluto si richiama a Protagora e Gorgia (e quindi a Platone). Esso adotta il criterio del
finito come ciò che coincide con l’esistenza come misura di ogni esperienza. Non semplicemente “mens”
come “misura” (la mente, l’intelletto, la ragione, il “logos”), ma lo “spirito”, l’esistenza.
Si tratta di aspetti e problematiche che riguardano la complessità del pensiero occidentale come una
molteplicità di vie e sentieri che convergono verso una medesima questione (il problema dell’essere).
L’umanismo costituisce uno di questi sentieri, per il quale non si pretende giungere a nessuna soluzione
bensì s’intende mantenere aperta una questione.
Il sistema del sapere
L’Occidente ha ereditato dall’antichità il sistema enciclopedico delle scienze, secondo il quale gli aspetti
della realtà universale erano chiaramente definiti e fatti oggetto di discipline basate su teorie suffragate
dall’esperienza. La conferma nell’esperienza era il criterio sufficiente per lo sviluppo di ipotesi razionali di
spiegazione degli eventi. Il sistema della natura era quello aristotelico, con l’universo distinto in due parti,
quella dei corpi incorruttibili (gli astri e i pianeti) e quella dei corpi corruttibili (la terra, l’universo
sublunare). Il principio di causalità (articolato nella triplice struttura efficiente, formale, finale) costituisce il
criterio per cui si stabilisce la conoscenza: conoscere è scire per causas. Si ha conoscenza allorché di qualcosa si
conoscono le cause: da che cosa è prodotto, a quale scopo è ordinato, qual è la struttura interna che lo
identifica e lo distingue da tutti gli altri enti. L’edificio della conoscenza si costruisce attraverso le
determinazioni dei generi di appartenenza e delle differenze specifiche. La definizione esprime l’identità
dell’ente. E il principio di identità stabilisce ciò per cui un ente è se stesso e si pone come “altro” rispetto
all’universo degli enti. In tal modo si stabiliva un edificio rigorosamente uniforme, in cui tutte le parti erano
connesse e in cui era possibile passare da una regione all’altra attraverso la determinazione dei nessi causali.
L’edificio del sapere risulta così come un’espressione della logica. Esso è impiantato sul principio di noncontraddizione, per cui la determinazione di modalità specifiche di connessione esclude la determinazione
di modalità contrarie. Il sapere è come un grandioso edificio in cui ogni parte è connessa al tutto in forme e
strutture determinate. Il sistema antico del sapere è quello maggiormente definito e che non lascia nulla
all’indeterminato, al caso, al non definito. L’essere è principio di determinazione. Questo principio abbraccia
la totalità dell’esperienza. Ogni sfera del reale costituisce una regione rigorosamente definita, nella quale non
vi sono residui di incertezza, di problematicità. Il sistema causale concorre a eliminare tali residui. Se si
hanno proposizioni affermative, non è possibile avere per gli stessi oggetti proposizioni negative. Il sapere
antico è basato sul possesso di certezze, su principi e strutture immodificabili. Per Aristotele è possibile
tracciare le linee di un sapere enciclopedico riguardante la totalità degli enti e dei fenomeni. Per prima
abbiamo la teologia, che è la scienza dell’ente sommo: si tratta di una scienza esclusivamente razionale,
fondata sul puro ragionamento. L’esperienza, tuttavia, vi concorre con la sua stessa problematicità. Noi
cerchiamo una scienza assoluta e fondamentale dell’ente totale in quanto con la nostra mente abbracciamo
l’infinito. Poi abbiamo la cosmologia, che è la scienza della natura come sistema dell’universo. L’universo
aristotelico è unitario, unico e perfetto, compiuto. E’ uniforme, tale cioè che gli stessi principi e le stesse leggi
ne regolano lo sviluppo in ogni sua parte. La fisica riguarda il sistema della natura come sfera dei processi di
generazione e di corruzione. Il sistema cosmologico è dotato di movimento autonomo. Tutto si muove
nell’universo. Lo stesso universo è principio di movimento; anzi tale principio è Dio stesso. Il sistema
cosmologico è il sistema del movimento dei corpi che costituiscono l’universo. I movimenti degli astri sono
di semplice traslazione; i movimenti terrestri, invece, implicano trasformazioni interne e strutturali.
Sapere e virtù: il sistema dell’Etica
Fanno parte della conoscenza anche i principi dell’etica, che riguardano la sfera del dover-essere.
L’universo etico è fondato dagli uomini, dai loro comportamenti e dalle regole o leggi alle quali
sottomettono il comportamento. Vi sono principi universali del comportamento. L’uomo è l’unico ente
razionale ed è pertanto l’unico e solo che può esprimere un mondo della possibilità.
Aristotele ha tracciato le linee di un’etica scientifica. Il mondo morale, infatti, è sottoposto alle leggi che lo
giustificano e lo fanno essere. Esso ha una sua logica e sottostà a determinati principi. Si muove dalla
constatazione della natura dell’uomo, dalla perfezione umana. Infatti è conforme all’etica ciò che concorre
alla perfezione dell’uomo. L’uomo, infatti, non è un ente compiuto e definito in ogni suo aspetto, è, piuttosto,
un ente incompiuto che attende di darsi una costituzione perfetta. Si tratta di partire da questa constatazione
per definire i principi dell’etica.
L’etica riguarda la conoscenza dei principi del fare, dell’agire. Noi ci domandiamo: che cosa è possibile
fare per esprimere compiutamente l’essere proprio dell’uomo? Che cosa un ente umano deve fare perché
esprima compiutamente se stesso? Socrate è il fondatore dell’etica come scienza dell’uomo. La conoscenza
nel suo insieme deve riguardare l’uomo in quanto responsabile del suo essere. Aristotele distingue le virtù
etiche e dianoetiche: quelle che riguardano la conoscenza e quelle che riguardano l’azione. Innanzitutto
l’uomo ha il dovere di esplicitare la conoscenza di sé, poiché in base a tale conoscenza può passare alla
realizzazione della sua natura o costituzione essenziale. Ma come l’uomo può costruire se stesso?
Innanzitutto partendo dalla conoscenza di ciò che egli è. L’uomo conosce la sua essenza propria: e la
conosce come qualcosa che va edificato, come un dover-essere.
Per i Greci, la virtù è condizione di felicità. L’essere in compagnia di un buon demone, vuol dire avere per
demone interiore colui che suggerisce di volta in volta ciò che è conveniente fare. L’”eudaimonia” consiste
nel possedere il principio della coscienza come condizione autonoma di comportamento virtuoso. Non si
tratta di conformità a comandamenti, bensì di conformità a un imperativo interiore. Nel sistema classico
della morale, la virtù fondamentale è la giustizia. Platone pone la giustizia a fondamento di tutte le virtù.
Essa consente di comportarsi nel modo conveniente sia nei confronti degli uomini che degli dèi. Giustizia
vuol dire riconoscere ciò che è proprio di ciascuno; così, in primo luogo, ciò che è proprio degli uomini e
delle società umane e ciò che è proprio degli dèi.
Platone distingue alcune virtù fondamentali: la moderazione, cioè la capacità di seguire il principio del
“giusto mezzo”, specialmente per quanto riguarda i desideri e i beni materiali; il coraggio, in quanto capacità
di valutare i pericoli ai quali si va incontro e le forze necessarie per conseguire uno scopo; il senso della
bellezza, in quanto ciò che facciamo deve rispondere a principi di armonia e di equilibrio; il sentimento
dell’amicizia, in quanto ci consente di riconoscere ciò di cui siamo manchevoli o sovrabbondanti, tanto da
disporne per gli altri; il senso religioso del timore e del rispetto della divinità.
Il riconoscimento delle virtù rappresenta il confine tra valori e disvalori nella tradizione morale
dell’Occidente.
Il sistema simbolico e la rappresentazione artistica
Nella tradizione dell’Occidente è riconosciuto il principio dell’autonomia dell’arte; tuttavia si rivela anche
l’altro motivo per cui ogni manifestazione spirituale è subordinata al fine etico fondamentale, sicché l’arte
rientra nello scopo di rafforzare il sistema delle virtù e combattere il vizio e la passione. In quanto
espressione della bellezza e dell’armonia, l’arte possiede già in sé un principio di valore e s’inquadra nella
stessa costruzione morale dell’umanità. Anche quando il fine morale dell’arte non è esplicito, esso è tuttavia
presente in vario modo e impronta di sé l’opera d’arte, la cui finalità è principalmente espressiva e
rappresentativa.
In primo luogo, l’arte risponde al principio per cui l’essere è rappresentazione. Questa si articola in
diverse forme: o come rappresentazione del reale, dell’esistente; o come espressione di una realtà che è al di
là della visione comune; o come produzione del simbolico. Il realismo intende rispondere a un’esigenza di
possesso di una tecnica rappresentativa: risale alle origini dell’arte e della poesia, ad esempio ai poemi
omerici, dove i particolari sono esattamente descritti e raffigurati. Anche le figure simboliche medievali
rispondono a questo criterio: diavoli e mostri sono raffigurati con precisione di particolari, dunque con un
essenziale realismo. Dunque il simbolismo non esclude il realismo. Le figure esigono di essere tracciate con
ricchezza di particolari, tanto da apparire “vere”, rispondenti alla realtà. La lettura simbolica esige che la
stessa rappresentazione rimandi a ciò che s’intende rappresentare di non visibile e spirituale.
All’arte è assegnato uno scopo educativo. La vita soprannaturale e il destino dell’anima sono le sfere che
gli artisti medievali intendono rappresentare. Nell’età moderna emergono specialmente le scene di vita
cittadina o familiare: la rappresentazione esalta la società del tempo, specialmente la borghesia emergente e i
frutti del lavoro e della molteplice attività umana. L’arte assume una funzione epica. Il cavaliere medievale o
il nuovo modello moderno ispirano specialmente i romanzieri. Il romanzo è l’opera caratteristica della
modernità; poiché risponde all’epica che ha per protagonista la borghesia.
La cultura occidentale ha prodotto una straordinaria fioritura di opere d’arte e oggi si tratta di vedere
come i diversi mezzi di rappresentazione possano avere ruoli propri in rapporto al soddisfacimento delle
esigenze che sempre hanno caratterizzato le opere d’arte. C’è sempre un’istanza epica che va tenuta
presente. L’arte rappresenta l’eroico, ciò che assume un carattere simbolico. L’arte contiene dunque un
elemento epico. Un altro elemento è il romanzesco, che corrisponde all’intreccio, alla trama. L’arte riproduce
i discorsi. Infatti la maggior parte dell’attività sociale e spirituale è espressa per mezzo della parola. La
tradizione della poesia è indubbiamente notevole nella cultura occidentale. La storia della poesia costituisce
un nucleo complesso la cui articolazione appare tuttora in grande sviluppo. La poesia tocca il destino della
parola.
Tutto ciò è indicativo per il rilievo assunto dall’arte nella nostra tradizione culturale.
Idea dell’Occidente
L’idea dell’Occidente come progetto di civiltà ha la sua sede di origine nel cuore del Mediterraneo, nella
civiltà egeo-cretese (minoica) e ha i suoi simboli in Minosse stesso, il leggendario signore dell’isola, suo figlio
Icaro, che tentò per primo di volare attraverso gli spazi solari, e Dedalo, che progettò e costruì il labirinto,
destinato a tenervi chiuso il Minotauro. Minosse è il simbolo del governo cittadino, a suo modo esemplare e
garante di giustizia. Icaro simboleggia l’audacia della scoperta, lo spirito avventuroso, il desiderio di
conoscere sfidando i limiti imposti all’uomo, la sventura alla quale va incontro ogni tentativo umano di
oltrepassare la condizione di finitezza. Dedalo è il simbolo della tecnica e dell’ingegno umano. E’ anche il
simbolo dell’organizzazione dello spazio, della riduzione spaziale e territoriale alle esigenze dell’uomo.
L’Occidente racchiude questo progetto di umanità, basata sulla conoscenza e sulla tecnica.
Occidente è dunque il modello della civiltà apollinea. Questa civiltà implica lo sviluppo delle arti e delle
tecniche.
Il mito di Europa insediata a Creta indica il destino occidentale della stessa civiltà cretese.
Questo modello è trapassato nella sua integrità nella cultura greca.
In Grecia è divenuto il modello perfetto di civiltà umana.
Dalla Grecia, attraverso la cultura ellenistica, tale modello è trapassato nella civiltà romana.
Roma ha impresso il carattere del diritto universale.
Dedalo e il mito della tecnica
Già alle origini della civiltà greca, nel contesto egeo-cretese, preminoico dunque, la figura di Dedalo ha
assunto il significato esemplare di artefice, inventore di opere come risposta a problemi complessi di
organizzazione del sistema ambientale. Il suo nome compare per la prima volta in Omero. Nella celebre
descrizione dello scudo di Achille, fabbricato dallo stesso dio Efesto, in una similitudine si fa riferimento al
“piazzale per le danze” che Dedalo un tempo aveva creato per Arianna, figlia del re Minasse. Non si davano
ulteriori giustificazioni intorno all’arte del celebre architetto, che, pertanto, doveva essere conosciuto da chi
ascoltava il canto epico. Dedalo era famoso come ideatore e costruttore del labirinto, destinato a tenere
prigioniero il Minotauro, e come ideatore di templi e fortezze, dunque come protagonista principale di una
civiltà cittadina, caratterizzata dalla presenza di un’architettura pubblica, simile a quella che avrebbe
caratterizzato le acropoli delle città greche. Dedalo, inoltre, avrebbe costruito statue dotate di una vitalità tale
che si dovettero incatenare, per non farle fuggire. Egli padroneggiava la falegnameria, nel cui ambito aveva
inventato gli strumenti tecnici fondamentali (come il trapano e il filo a piombo) e alcune sostanze come la
colla. Costruì, infine, le ali artificiali, che avrebbero consentito la sua fuga insieme al figlio Icaro, poi vittima
della sua temerarietà.
La citazione omerica è già di per sé prova dello straordinario riconoscimento tributato in età arcaica alla
categoria degli inventori e dei più abili artigiani. La funzione dell’artigiano era allora paragonata a quella del
poeta ed era rivestita di una patina di religiosità. Il riconoscimento tributato all’artista-artigiano era simile a
quello riservato al cantore, al vate, al medico, all’araldo (che era anche abile oratore). “I tratti positivi che
hanno portato nella cultura greca allo sviluppo di un fattore specificamente ‘artistico’ sono presenti e non si
possono negare: i loro presupposti si trovano già nell’età dell’epos, come mostrano le figure mitiche di
Dedalo o Prometeo. Il segreto della produzione artistica di Dedalo era nella sintesi tra le proprie capacità
professionali e l’abilità artistica che aveva ereditato. Le caratteristiche del primo artigiano (e artista) umano
mostrano gli elementi dei quali si componeva la téchne, unico termine posseduto dai Greci per ‘abilità
artigianale’ e ‘opera d’arte’, con cui vengono colte le caratteristiche delle opere che gli antichi intenditori
definivano grandi”.7
Alle origini della civiltà greca troviamo, dunque, l’idea dell’opera artistica come risultato dell’ingegno
umano, di cui sono depositari uomini di straordinarie capacità. Dedalo è il simbolo della “téchne”, della
particolare capacità di creare strutture rispondenti a specifiche esigenze della società. L’invenzione delle ali
artificiali costituisce l’esempio più caratteristico dell’abilità inventiva in virtù della quale gli uomini
soddisfano le loro esigenze e realizzano i loro sogni.
Componenti del mondo occidentale
Le componenti del mondo e del pensiero occidentale sono quelle che stanno alla base della paideia greca.
La visione greca del mondo è quella apollinea, della chiarezza e della distinzione, della ragione del logos.
Dunque la ragione è come un destino per l’Occidente. La visione apollinea si è affermata attraverso una lotta
col principio dionisiaco, della fusione e in distinzione. Euripide nelle “Baccanti” ha rappresentato con grande
efficacia lo sviluppo e l’esito di quella lotta. Nello stesso tempo si è affermato l’uomo faber, costruttore,
inventore e depositario della tecnica. L’universo si è profilato come un orizzonte misurabile, costituito e
ordinato secondo numero, peso e misura. Il reale è intelligibile, tale che di esso si può rendere ragione e in cui
nulla accade senza ragione e necessità. La materia è energia e l’uomo è l’amministratore di tale energia.
Prometeo è il simbolo dell’umanità che si realizza nella tecnica. Ulisse esplora i mari e affronta le tempeste e
l’imprevisto: lo stesso mistero si affaccia e lo travolge. Si perviene alla conoscenza attraverso la sofferenza.
Poesia, musica e danza: lo spazio della bellezza. Esiodo racconta come l’universo sia generato dal Caos e come
sulle forze contrapposte si sia imposta la supremazia dell’ordine di Zeus. Le figure del mito sono i simboli
immutabili che rappresentano la costituzione dell’universo. La filosofia dà la lettura razionale di quelle
figure. La cultura greca ha perseguito la sfida del confronto con le altre culture, con l’obiettivo di dar luogo a una
sintesi cosmopolita. L’ellenismo è questa sintesi. Il mondo greco conteneva nel suo orizzonte le culture orientali e
l’Occidente romano. Il mondo greco-romano costituisce il modello organizzativo di un “impero” universale.
Marco Aurelio è il simbolo di tale governo universale del mondo. Questo modello trovava la sua base
religiosa nel cristianesimo. La teologia universale chiudeva perfettamente il cerchio della perfezione umana,
fondata alle origini sulla virtù, sull’ordine e sulla bellezza e conclusa
con la risoluzione del
problema/mistero dell’essere. La filosofia cristiana comprende lo sviluppo del pensiero occidentale. Questo
pensiero ha come sua peculiarità la sintesi di ragione e fede, come unità della intelligenza e della conoscenza.
L’intero mondo biblico (giudaico-cristiano) confluiva nella cultura occidentale, meglio specificata, in
rapporto alla confluenza delle tante nazionalità, come “europea”. La componente germanica era il simbolo di
ogni nuovo elemento di nazionalità confluito nell’unità europea. Nello stesso tempo il cristianesimo come
esperienza religiosa compiva l’integrazione di un’umanità costituita politicamente come “impero”. La cultura
moderna si profilava come crisi del modello imperiale e affermazione delle nazionalità. L’Europa si profilava
come lo spazio geografico delle nazioni. L’universalità parlava il linguaggio della scienza. La religiosità
7
Dietrich Willers, Dedalo, in I Greci, Einaudi, Torino 1996, II, p. 1201.
tornava a distinguere i popoli e le nazioni. Filosofia, scienza, politica, religione tornavano a distinguersi e
l’Occidente si ricostituiva come luogo di questa distinzione d’impronta laica. Ciò voleva dire che ciascuna
sfera trovava in se stessa i principi della propria fondazione. Così la scienza era la lettura dell’universo da un
punto di vista (dell’esperienza e della ragione), che non era quello della religione. Così la politica riguardava
semplicemente i principi e le regole della pacifica convivenza degli individui e dei popoli. Senza che siano
più possibili interferenze tra l’una e l’altra sfera. La religione riguarda il mistero del sovrannaturale e
dell’infinito: in virtù dell’esperienza religiosa, ciò che è infinitamente lontano e inaccessibile diventa vicino e
familiare; e questa vicinanza rappresenta un fattore di speranza (e anche di conoscenza).
Il “tragico” nella cultura occidentale
La filosofia hegeliana è quella maggiormente pervasa di spirito tragico. Che vuol dire questo? Perché
diciamo così? Perché Hegel più di ogni altro filosofo avverte il bisogno della totalità, di una totalità da
ricomporre nell’ambito di una cultura segnata profondamente dal senso della lacerazione, della opposizione,
dell’assenza e della lontananza. Lontananza e scissione da che? Appunto dalla totalità, dall’unità dell’essere.
I greci nella tragedia hanno avvertito il senso di ciò è l’essere inseriti nella totalità e provare l’esperienza
della totalità. Il senso di colpa originaria, che alimenta la gran parte delle situazioni tragiche ed è fonte di
insanabili conflitti, nasce nell’ambito di una tale esperienza. Altrimenti, colpa di fronte a chi? Invece, colpa
nei confronti del divino, per il tentativo umano di emanciparsi dalla tutela divina. Edipo libera la sua città
dall’incombenza di un male misterioso, ma sconta col suo destino tragico la sua ybris. Questo destino si
proietta ancora sui suoi figli, che lottano tra di loro per il dominio sulla città. Che cos’è, dunque, il tragico? E’
la conseguenza dell’esperienza dell’esistenza nell’unità cosmica, prima della separazione tra il divino e
l’umano. La tragedia allude e descrive una condizione dell’esistenza che si compie prima della vera e
propria entrata nella storia. Hegel considera la filosofia come la possibilità di pensare tale condizione, la
totalità nello svolgimento dello spirito, cioè nella storia. Con Hegel (ma già con l’idealismo in generale) “il
tragico entra di diritto nella filosofia” (Bodei, Conoscenza e dolore. Per una morfologia del tragico, in “Il
Centauro”, n. 7, 1983, p. 9). Il senso del tragico nasce dalla situazione di essenziale e originario conflitto tra
l’umano e il divino. La concezione antica del divino è attraversata da questo senso del conflitto che sta alla
base della stessa esistenza. La stessa condizione umana è vista come condizione che si contrappone alla
divinità, che si pone in concorrenza con essa, che con essa entra in conflitto per il dominio del mondo.
L’uomo poi darà luogo a un ordine proprio, che è quello della storia. Ma originariamente non era avvertita
questa distinzione tra il “tempo che non scorre” e il divenire temporale della storia. La tragedia rappresenta
personaggi ed eventi di quella situazione temporale che si colloca prima dell’avvento della storia e che è
caratterizzata dalla contemporanea presenza degli uomini e degli dèi nell’ambito di una medesima sfera,
quella della natura eterna. Il tragico si sviluppa in un ambito esistenziale che precede l’eventualità storica.
C’è, dunque, un’eventualità del tragico, che è propria di una fase temporale che precede il tempo storico e che
è propriamente il tempo del mito, caratterizzato dalla presenza degli dèi tra gli uomini. Sono i conflitti tra
queste due forme d’esistenza che alimentano gli eventi tragici, di cui sono protagonisti gli uomini (ma gli
uomini nel loro conflitto con gli dèi). Questa è anche la ragione per cui il tragico non può appartenere alla
storia (a meno che non si tratti di eventi che siano attribuiti alla collera delle divinità e, dunque, siano
interpretati come uno strascico lontano di quella condizione originaria, che si colloca prima della storia).
Come ha scritto Salvatore Natoli, “tragico, infatti, non è il soffrire, ma la modalità secondo cui nel soffrire si è
istituiti. In altri termini, non è l’intensità del dolore, e neanche l’esperienza di morte ad essa connessa, che
rende tragico il soffrire, ma è la percezione tragica dell’esistenza che muta il dolore in tragedia, ossia lo fa
vivere ed esistere nella forma del tragico” (L’esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale,
Feltrinelli, Milano 1987, p. 36). Nella tragedia di Eschilo già la consapevolezza umana è una via per
dominare il dolore: lo ha messo bene in rilievo Emanuele Severino nel suo bel libro Il giogo. Alle origini della
ragione. Eschilo (Adelphi, Milano 1989), notando la funzione catartica che il coro dell’Agamennone svolge
esaltando la potenza del pensiero che annulla il dolore (dando ad esso una ragione: e “rendere ragione” vuol
dire riportare alla dimensione del pensiero filosofico, per cui questo sarebbe una condizione per il
superamento dell’esperienza tragica e il dispiegamento dell’esperienza storica, libera da potenze superiori e
divine). A questo proposito Franco Rella ha precisato che in realtà liberatorio è stato non tanto il pensiero
filosofico tout court ma il “logos” dei contrari, antinomico, “che tiene in sé il vero e in non vero, il bene e il
male, perché bene e verità sarebbero nulla senza i loro contrari”. In questo senso appare sempre più stretto il
nesso fra tragedia e filosofia. I poeti tragici hanno posto le condizioni fondamentali per lo sviluppo del
pensiero: le condizioni per pensare le opposizioni, cioè, in sintesi, l’essenziale dialettica che è insita al
pensiero filosofico. Osserva Rella: “Il tragico ci ha così insegnato a pensare insieme ciò che non possiamo
pensare insieme: ciò che il pensiero filosofico da sempre ci ha impedito di pensare insieme” (Amore e contesa,
in F. Holderlin, Edipo il tiranno, intr. di F. Rella, Milano 1991, pp. 11-12). Il pensiero filosofico ha superato il
senso del tragico razionalizzandolo, cioè considerandolo come una condizione dell’esistenza stessa (non solo
dell’esistenza umana ma dello sviluppo dell’intera realtà: si veda, in questo senso, la concezione di Eraclito).
Si considerino queste altre osservazioni di Franco Rella: “La tragedia è il sapere dell’uomo che ha accettato lo
spaesamento, dell’uomo che si espatria dal suo linguaggio e dalle sue pratiche cognitive abituali: che si
sradica da tutto per aprirsi alla dimensione cosmogonia di uno sguardo fisso sul mistero” (Le soglie
dell’ombra. Riflessioni sul mistero, Feltrinelli, Milano 1994, p. 46). La tragedia usa ancora il linguaggio proprio
dell’esperienza tragica. La filosofia ha ricondotto alla razionalità “logica” il pensiero tragico dell’opposizione
e del dolore; e in questo senso ha liberato l’intera cultura occidentale dal peso misterioso del “tragico”. Si
capiscono così meglio le osservazioni che Nietzsche sviluppava nel classico saggio sulla nascita della
tragedia, allorché attribuiva al senso del tragico, alimentato dallo spirito dionisiaco, le più significative
espressioni creative della grecità intera (la poesia tragica, appunto). Come è noto, per questo filosofo, che è il
maggiore critico della razionalità occidentale, “la logica e la logicizzazione del mondo” rappresentano la
maggiore disgrazia per la cultura europea. Così nella prevalente tradizione metafisica del pensiero
occidentale il senso del tragico è stato costantemente emarginato ma non stato cancellato, tanto che esso si è
manifestato drammaticamente coi segni della decadenza, della contraddizione, della sconfitta dello spirito
lungo l’arco della storia dell’Occidente. Come osserva Sergio Givone, Nietzsche da un lato riconosce nel
tragico la dimensione spirituale e l’eventualità che “si sottrae alla storia e si consegna al mito e per l’altro
proprio nel tragico scopre la misura della storia – la storia dell’Occidente – cioè la decadenza come
progressivo allontanamento dal tragico stesso” (Ermeneutica e Romanticismo, Mursia, Milano 1983, p. 66). In
questo senso nel pieno stesso del corso della storia il senso del tragico può riaffiorare, mostrandosi come
“quel luogo in cui ciò che è perfettamente contraddittorio si rende finalmente pensabile o almeno
formulabile” (op. cit., p. 69).
CAPITOLO XIV
Cristianesimo e filosofia
Nell’età in cui la struttura politica dell’Occidente antico (l’Impero romano) ebbe a subire la sua
disgregazione, l’eredità spirituale e culturale che costituiva il suo patrimonio più significativo fu raccolta,
conservata e tramandata alla nuova epoca, dalla religione cristiana. Il cristianesimo svolse la funzione,
diremmo quasi provvidenziale, di salvezza nei riguardi della civiltà antica e di adattamento alle nuove
istanze, presenti specialmente nel sistema politico delle realtà nazionali permeato ancora della visione
imperiale unitaria. La cultura del cristianesimo si plasmò sui modelli della retorica e della filosofia grecoromana, assimilò i motivi e i metodi del pensiero razionale, fece tesoro delle grandi componenti relative alla
concezione della vita spirituale (ad esempio la teoria dell’immortalità dell’anima), sviluppò e approfondì il
discorso sul destino etico dell’umanità. I primi filosofi cristiani furono gli “apologisti”, difensori (sul modello
dell’oratoria giudiziaria) della dottrina cristiana e primi elaboratori delle tesi proprie della “verità” filosofica
che poteva dirsi in accordo col cristianesimo. Poi sono venuti i “Padri della Chiesa”, che si sono assunti il
compito di dare alla stessa dottrina religiosa una veste razionale e sistematica. La “Patristica” seguì una
linea di sviluppo diversa in Oriente e in Occidente. Sant’Agostino è il maggiore rappresentante del pensiero
patristico occidentale; Clemente Alessandrino di quello orientale. La distinzione consiste nel fatto che il
primo è basato sulla separazione tra la fede e la ragione e dunque sulla convinzione che è impossibile
conoscere pienamente il divino, mentre l’altro è animato da una interna tensione che lo spinge a cercare la
comprensione dell’essenza di Dio. Nello sviluppo del pensiero occidentale si è ovviamente inserita la linea
agostiniana.
L’intera sapienza greca tende a rivelare il mistero dell’esistenza umana. La presenza dell’uomo
nell’universo appariva già ai greci come l’evento fondamentale, quasi come il significato stesso della realtà.
Essere e pensiero, diceva Parmenide, sono la stessa cosa, costituiscono un’identità. In questa identità è
incardinato l’uomo. Una certa analogia con la concezione cristiana salta subito davanti agli occhi: anche nel
cristianesimo l’esistenza dell’uomo è incardinata nel mistero della Trinità divina, anzi essa è raffigurata in
una delle tre “Persone”, appunto il “Figlio”. E’ chiaro che in Parmenide il pensiero è il “Logos” e, nel
cristianesimo, il “Figlio” non è altro che il “Verbo” incarnato. Il “Figlio” è la “Verità”, altrettanto di quanto lo
è la “Scrittura”: il “Verbo” (il “Logos”) si è manifestato nella Scrittura e si è incarnato in Cristo. Vi è, dunque,
una profonda identità tra Cristo e la Scrittura: entrambi costituiscono la “Verità”. Ed è chiaro il riferimento
all’uomo: la Scrittura è la rivelazione che Dio ha voluto (e vuole continuamente) dare di sé agli uomini. Dio
ha rivelato (e rivela) la Verità, in modo che gli uomini potessero (possano) conformarsi ad essa. La Verità è
mezzo di salvezza per l’umanità. Anche Parmenide dichiara di essere stato ammesso al cospetto della dea
della Verità, che gli ha rivelato la vera conoscenza intorno all’essere e all’universo degli enti. Anche in questo
caso la conoscenza è considerata come strumento di salvezza per l’uomo. Il filosofo si attribuisce una
funzione di portatore della verità rivelata dalla divinità. Alla radice della cultura greca c’è questa esigenza di
verità: se la realtà è manifestata riguardo al suo senso, l’umanità, conformandosi ad essa, può salvarsi,
altrimenti sarà costretta a vivere nell’errore. Nella concezione cristiana, l’errore è il peccato originale; e Cristo
rappresenta la salvezza da questo peccato. Anche Parmenide muove da un problema di salvezza dell’uomo:
egli si attribuisce una funzione quasi profetica, poiché intende contribuire alla partecipazione della verità
agli uomini, in modo che essi non vivano (più) nell’errore. Per San Paolo, Cristo è la Verità che sopravanza
ogni sapere: egli, infatti, è mezzo di salvezza; al di fuori di lui, non c’è ulteriore bisogno di nulla per la
salvezza, non c’è bisogno, cioè, di altro sapere. Parmenide, invece, ha a che fare con la filosofia, che è un
sapere in svolgimento. Il filosofo attinge continuamente la verità dal pensiero, dal “Logos”.
Su questi presupposti, l’incontro tra cristianesimo e filosofia doveva essere inevitabile. In qualche modo,
avevano ragione quei cristiani che consideravano la filosofia greca e tutta la sapienza antica quasi come
un’anticipazione della verità del cristianesimo.
In questo modo, si giustifica il nesso tra cristianesimo e filosofia. Entrambi riguardano la verità intorno
alla salvezza dell’uomo. La filosofia si avvale del solo mezzo della ragione, per cui la rivelazione è solo una
metafora per indicare la ricerca attraverso il pensiero; il cristianesimo, invece, dispone della Verità incarnata:
si pone, così, sul piano del mistero.
Il cristianesimo ha cercato, quindi, di ricondurre la stessa filosofia nell’ambito della verità rivelata, facendo
in modo che essa non avesse più un ambito proprio di conoscenza, alternativo alla rivelazione. Esso ha
affermato il carattere unitario della verità, e pertanto ha combattuto ogni tendenza verso la costituzione di una
gnosi indipendente dalla rivelazione, che, nel suo insieme, comprende l’Antico e il Nuovo Testamento, cioè il
racconto biblico e, insieme, la testimonianza di Cristo. Cristo, infatti, è il culmine della rivelazione: la
salvezza non solo annunciata, ma compiuta. In virtù della Scrittura (e Cristo fa parte di essa), l’umanità è
salva o, almeno, dispone dello strumento fondamentale in base al quale può salvarsi.
Lo sforzo compiuto dai Padri della Chiesa (tra i quali spicca Sant’Agostino) per ricondurre la riflessione
filosofica nell’ambito della verità rivelata è coerente con la concezione dell’unica verità; esso corrisponde
all’esigenza di instaurare in modo compiuto la stessa verità cristiana come tale da non potere essere insidiata
da forme di conoscenza diverse e autonome. In una condizione di relativismo conoscitivo, appariva difficile
indicare e trovare la via della salvezza. Questa, infatti, è unica: è quella rappresentata da Cristo.
Clemente Alessandrino già metteva in luce con grande chiarezza l’alternativa tra l’antica conoscenza e la
verità cristiana: “Ma a voi – egli scriveva – resta ancora questo ultimo gesto, cioè di scegliere ciò che è utile a
voi, o il giudizio o la grazia. Quanto a me, io credo che neppure sia il caso di dubitare su quale delle due cose
sia migliore: né infatti è lecito confrontare la vita con la perdizione” (Protreptico ai Greci, XII). E Tertulliano,
dall’opposta sponda della patristica occidentale, esprimeva concetti analoghi, quando avvertiva: “Nobis
curiositate opus non est post Christum Jesum nec inquisitione post Evangelium”. E’ vero, tuttavia, che negli
“alessandrini” la “gnosi” continua ad assumere un rilievo essenziale, mentre per gli occidentali (i “latini”) la
fede rende superflua ogni riflessione e ricerca, e ciò che conta principalmente è l’osservanza della “legge”
(come avvertiva ancora lo stesso Tertulliano: “Fides in regula posita est. Habet legem et salutem de
observatione legis”). Perciò è stato osservato che nella corrente orientale prevale l’istanza greca della
conoscenza, mentre nella patristica latina l’accento è posto sul modello etico di vita da seguire, cioè, in fondo,
sull’osservanza della legge mosaica e sul conformarsi agli esempi evangelici.8
8
Cfr. P. Th. Camelot, Foi et gnose. Introduction à l’étude de la connaissance mystique chez Clément d’Alexsandre, Paris 1945,
pp. 139: “più che per l’imitazione del salvatore in croce, più anche che per le preghiere, è per il solo sforzo ascetico e dialettico che il
credente si eleverà fino ai vertici della gnosi; e questo è più greco che cristiano”. Così, più che “Logos” incarnato, Cristo è
considerato come il “Logos” che si rivela nell’interiorità della coscienza, in modo simile a quanto era ritenuto nella tradizione
filosofica. L’accento, in tal modo, è posto ancora sulla verità e sulla conoscenza di essa per mezzo della ragione. “Per Clemente, il
Verbo è soprattutto pedagogo, educatore, e si fa rivelatore molto più – sembra – per mezzo di una illuminazione interiore che con la
presentazione di un oggetto nuovo. Più attento forse alle realtà invisibili che alla realtà dell’Incarnazione, alla voce del Maestro
Questa caratteristica interpretazione del “Logos” come rivelazione della verità all’interno della coscienza,
da una parte, e nell’ordine cosmico, d9all’altra, è ancora più evidente in Origene, dove, come ha notato P.
Lieske, “il significato cosmologico del Logos è la minaccia più grave per il mistero trinitario della filiazione e
il contraccolpo più forte del pensiero neoplatonico sulla sua speculazione”.
La preoccupazione della patristica latina, rispetto a quella greca, è di conservare nella sua integrità il
significato del mistero dell’Incarnazione. In questo ambito s’inquadra, ad esempio, la polemica antipelagiana
di S. Agostino. “Evacuatum est scandalum Crucis”, egli dice a proposito di quell’eresia. Pelagio, in realtà,
interpretava la verità cristiana alla luce del razionalismo greco. La venuta di Cristo, nella sua dottrina, ha
solo una funzione pedagogica, di insegnamento della via da seguire per ottemperare i decreti divini.
S. Agostino accentuò le conseguenze della concezione pessimistica dell’uomo, come essere interamente
dipendente, per la sua salvezza, dalla grazia. Invece nella teologia alessandrina era rivalutato il significato
della dottrina platonica dell’ascesi dell’anima, come processo di progressivo recupero della originaria natura
divina.
Il motivo platonico dell’aspirazione dell’anima a elevarsi a una condizione pressoché divina diventa, in S.
Agostino, ricerca, da parte dell’anima, della Trascendenza. E Dio non è inconoscibile a causa della sua unità
priva di determinazioni, come l’Uno di Plotino, bensì per l’infinita distanza che lo separa dal mondo (5). Né
Dio può essere in qualche modo conosciuto partendo dalla conoscenza del mondo, poiché è escluso ogni
emanatismo. La rivelazione è l’unica via per conoscere Dio e la sua volontà, né è possibile, per l’uomo,
elevarsi a Dio con le sue forze spirituali. Perciò acquista un valore sempre più fondamentale il modo in cui
Dio si rivela ed entra in rapporto con l’uomo e col mondo. E il momento cruciale della rivelazione è
l’Incarnazione. Perciò risulta ingrandita la figura del Figlio e la vita del cristiano consiste essenzialmente in
una “imitatio Christi”. Il cristianesimo sarà sempre più cristocentrico e meno mistico. Perciò acquista sempre
maggiore importanza il culto dell’umanità” del Cristo, come modello di perfetta vita spirituale, improntata
alla nuova legge d’amore stabilita da Dio col suo stesso sacrificio. Nello stesso tempo, è sempre di più
accentuato il motivo della trascendenza, contro ogni tentativo di interpretare, ad esempio, lo Spirito Santo
come l'’Anima del mondo, secondo lo schema platonico e neoplatonico. In tal modo, la natura viene sempre
di più privata di ogni elemento divino e viene avviata quella concezione che culminerà nel meccanicismo
moderno. Ogni intervento soprannaturale è concepito come avvenuto attraverso la mediazione del Cristo; e
così la stessa conoscenza di Dio è mediata dalla conoscenza del Figlio.
Così si spiega il carattere essenzialmente etico del cristianesimo. La perfezione del cristiano si consegue
attraverso l’incontro personale col Cristo. Questo incontro attua la rivelazione stessa della via della salvezza:
Cristo si rivela come il Salvatore e l’incontro con lui ha il significato di una conversione profonda, di una
trasmutazione della nostra natura personale. E’ l’incontro col Cristo che ci fa “cristiani”. Il cristiano sa che
non può anticipare nel mondo la beatitudine della pura vita spirituale e che, d’altra parte, l’incontro col
Cristo è significativo anche per la vita terrena, in quanto essa acquista il carattere e il valore della
testimonianza. La vita terrena è una prova per il cristiano: il suo “essere cristiano” si manifesta nella vita
interiore che alla oggettività di una rivelazione, quando egli fa allusione alla rivelazione del Logos, non sembra che si tratti del Logo
incarnato” (p. 39).
2) Cfr. J. Danielou, Origène, Paris 1948, p. 250. E’ noto che, nell’ambito della corrente gnostica, Cristo è interpretato come un
“eone” di livello e portata fondamentali nel processo di emanazione. In questo modo, come è evidente, Cristo viene a costituire un
elemento della realtà cosmica ed è specialmente connesso con l’ordinamento dell’universo, perdendo gli essenziali caratteri di ente
trascendente, che mantiene in quanto Persona della Trinità divina.
3) Cfr. G. De Plinval, Pélage, Lausanne 1943, pp. 155-56: “Riducendo la gravità della caduta e l’estensione delle sue conseguenze,
Pelagio diminuiva simultaneamente l’importanza e l’universalità della redenzione: secondo l’espressione energica dei suoi avversari,
egli ha “evacuato” il mistero della Croce. Egli riconosce bensì che la venuta di Cristo ci ha valso di più di quanto noi fossimo in
diritto di attenderci per i nostri meriti, la remissione dei peccati e la redenzione. Ma, al di fuori di questi due punti, l’influenza
trascendente di Gesù sparisce, si riduce a un insegnamento, a un esempio, invece di tradursi in una rigenerazione misteriosa, in una
protezione e una infusione di forza e di santità. Non vi è più tra il cristiano e il Cristo che un rapporto di imitazione mediante la
riproduzione docile nel discepolo dell’effige del maestro, la sottomissione al suo modello divino di umiltà, di povertà e di
perfezione”.
4) Cfr. P. Filiasi Carcano, Problematica della filosofia odierna, Milano 1953, pp. 213-14: “Con Agostino (e in genere con la
patristica latina) si tolgono le ambiguità; alla concezione ‘fisica’ della redenzione (prevalente nei greci) si sostituisce la concezione
‘giuridica’, e sulla nozione di grazia elevante prevale la nozione di grazia medicinale […]. Dall’anima viene tolta ogni traccia di
divino; questo si raccoglie invece sempre più nella persona del Cristo, che diventa il vero centro della religiosità e l’unico fattore
della salvezza”. In questo senso, S. Agostino ha operato una profonda trasformazione nell’ambito dell’antropologia cristiana: egli,
infatti, eliminando dall’uomo ogni traccia di divino, ha riaffermato che ogni motivo di elevazione spirituale dipende dalla grazia. La
stessa conoscenza è possiible in virtù dell’illuminazione dell’intelletto umano da parte di Dio. In sostanza, cioè, l’intera vita spirituale
dipende dalla grazia, dall’aiuto divino. La concezione cristiana dell’uomo, secondo cui l’uomo dipende interamente da Dio,
rappresenta, da questo punto di vista, la vera antropologia.
etica, che è fondata sulla virtù dell’amore fraterno. Questo amore fonda quella comunità che è la sola
immagine, nell’esilio terreno, della comunità dei beati.10
Ciò è in aderenza con la concezione cristiana del tempo. Il cristiano vive nella dimensione lineare del
tempo e non può assolutamente bruciare le distanze temporali; per quanto egli può vivere l’esperienza del
rapporto con Dio, la fruizione della visione dell’Eterno è rimandata alla conclusione della sua vicenda
terrena. In tal modo è impossibile realizzare qualcosa come l’antica esperienza della presenza dell’essere
totale. L’apprensione diretta dell’essere, l’istante come “un mezzo di accesso nel presente eterno”, la
possibilità di un’“inserzione dell’essere particolare nel tutto, di cui si riconosce come un elemento” (Lavelle),
sono escluse dalla condizione del cristiano. Si tratta, infatti, di esperienze che implicano una concezione
panteistica e una rappresentazione circolare del tempo.
La concezione creazionistica, la percezione della distanza tra l’uomo e Dio, la centralità del motivo
cristologico, sono tutti elementi che concorrono a formare una mentalità antimetafisica (almeno nel senso
della metafisica come scienza dell’essere totale), empiristica (in quanto il mondo è la sola dimensione nella
quale si esplica pienamente l’attività umana), storicistica (all’uomo è affidato il governo del tempo storico),
per la quale, esclusa la possibilità di una esperienza (e di una scienza) del “fondamento”, all’uomo rimane
solo (almeno per la durata della vita terrena) l’esperienza della successione temporale e la sua attività si
dispiega nel senso dell’esplorazione (e del possesso) del mondo. Poiché tutto il divino si concentra nella
realtà del Dio trascendente, l’uomo può solo vivere nell’attesa (aspettando che in qualche modo Dio si riveli e
gli dispensi i suoi doni gratuiti, oppure che egli stesso raggiunga quella condizione spirituale che gli
consente la beatitudine).11
La concezione antica, invece, afferma una sostanziale parentela dell’anima con la divinità (9). E la
tradizione gnostica riprende proprio questo motivo della costituzione divina dell’anima e di un legame con
tutto ciò che di divino vi è nel cosmo: gli elementi e le condizioni dell’ascesi e della stessa salvezza sono
10
5) Come è stato notato, “il Dio di Dionigi, inconoscibile per natura, Dio dei Salmi ‘che fece delle tenebre il suo ritiro’, non è il
Dio unità primordiale dei neoplatonici. Se egli è inconoscibile, non è in virtù della sua semplicità […]; egli è una inconoscibilità, per
così dire, assoluta. In effetto, se essa avesse per base la semplicità dell’Uno come in Plotino, Dio non sarebbe più inconoscibile per
natura. Ora è precisamente la inconoscibilità che è la sola definizione adeguata di Dio” (V. Lossky, Essai sur la théologie mystique
de l’Eglise d’Orient, Paris 1944, p. 29). Dio, pertanto, può essere conosciuto solo in quanto egli si rivela, in Cristo, in realtà, non solo
egli si manifesta, ma si presenta, in modo che si possa incontrarlo, ascoltarlo e parlare con lui. Questa prerogativa è propria del Diopersona, che si differenzia dal Dio dei filosofi, che è impersonale.
6) “Nel cristianesimo non vi sono più emanazioni, vie all’in su e vie all’in giù, sforzi ascetici, partecipazioni, estasi, ma soltanto (a
prendere la cosa con rigore) il Cristo, i suoi profeti e i suoi martiri che hanno reso testionianza; neppur tanto, a ben considerare, i
miracoli (che anche Apollonio di Tiana era capace di compiere), ma appunto lo scandalo della Croce, la parola fatta carne e fatta
scrittura, ela Chiesa dei martiri divenuta corpo vivente del Cristo” (P. Filiasi Carcano, op. cit., pp. 215-16).
7) “Il rapporto personale dell’uomo col Dio vivente non si rivolgerà più alla Trinità, ma avrà piuttosto per oggetto la persona del
Cristo che ci rivela l’essenza divina. Il pensiero e la vita cristiana diverranno cristocentrici, attaccandosi soprattutto all’umanità del
Verbo incarnato e si può dire che questo sarà la loro ancora di salvezza” (V. Lossky, op. cit., p. 63).
8) “E’ facile ora comprendere meglio le ragioni della profonda diffidenza del cristianesimo verso la mistica; mistica, in fondo, vuol
dire immediatezza, partecipazione, trascendimento dei limiti della nostra esperienza ordinaria. […] Anzitutto, nel cristianesimo è il
mondo stesso che viene redento, e non v’è bisogno di uscire dal ondo per redimersi. Quest’ultima concezione ha radici dualistiche e
gnostiche; nel cristianesimo il mondo diventa il teatro della passione di Cristo, ed è, quindi, da questo punto di vista, intrinsecamente
santificato; al tempo stesso il mondo è l’ambiente in cui ciascuno di noi deve vivere, il più possibile evangelicamente, imitando
Cristo. Nessun bisogno quindi (e soprattutto nessuna fretta di trascendere; questo potrebbe denotare una indifferenza verso il
prossimo, una freddezza nell’imitazione di Cristo, una impazienza nel compiere la volontà di Dio” (P. Filiasi Carcano, op. cit., pp.
196-97).
11
10) Secondo Jung, “forse è un po’ spinto voler parlare di un rapporto di parentela [tra l’anima e Dio], in tutti i modi però l’anima
deve avere in sé una possibilità di rapporto, cioè una corrispondenza con l’essenza divina” (Psicologia e alchimia, tr. it., Roma 1950,
p. 22). A questo proposito, egli rileva la differenza tra il cristiano e l’alchimista (che ricerca in se stesso le energie profonde che gli
consentano di realizzare una vita spirituale come esperienza del divino). “Il cristiano – egli osserva – si merita ex opere operato i
frutti della grazia; l’alchimista invece si crea ex opere operantis (nel senso più letterale della parola) una ‘medicina della vita’, che gli
appare o come un surrogato dei mezzi di grazia della Chiesa, o come un completamento e un parallelismo dell’opera di redenzione
divina continuata nell’uomo” (p. 515). Secondo Jung, la rimozione, operata dal cristianesimo, dei poteri più profondi della psiche è
uno dei fattori causali della nevrosi dell’uomo contemporaneo. Lo gnosticismo, la tradizione alchemica, la ripresa della tradizione
ermetica e magica nel Rinascimento, non sarebbero altro che manifestazioni di quella concezione dell’anima, che il cristianesimo ha
cercato di combattere e di eliminare dalla storia spirituale dell’Occidente. Così, in contrapposizione all’”opus” alchemico, che si
appella alle forze dell’anima, la dottrina cristiana ha sempre più accentuato la funzione centrale del Cristo salvatore. In realtà, in
questo modo, osserva Jung, l’uomo viene esonerato da ogni autentica responsabilità, così rispetto al peccato come rispetto alla
possibilità di conseguire la salvezza: “Se il valore supremo (Cristo) e la suprema mancanza di ogni valore (peccato) si trovano
all’esterno, l’anima è vuota, le manca l’estrema bassezza e l’altezza suprema” (p. 20). “L’esigenza dell’’imitatio’ di Cristo, - osserva
ancora Jung – cioè di seguire il modello e di diventare simili a lui, dovrebbe mirare allo sviluppo e alla elevazione della propria
personalità interiore, ma viene ridotta dal fedele, con la sua superficialità e con la sua tendenza a una schematicità meccanica, a un
oggetto di culto esteriore, il quale, proprio a causa della devozione, si trova nella impossiiblità di intervenire nella profondità
dell’anima, e di ricrearla in quella totalità che corrisponde al modello” (p. 19).
impliciti, secondo questa concezione, nell’uomo e nelle forze cosmiche con le quali è intimamente connesso e
dalle quali è attraversato.
Nella concezione cristiana, data la funzione redentrice di Cristo, all’anima non è riconosciuta più nessuna
iniziativa autonoma di innalzamento al divino. In particolare, l’anima viene identificata con la coscienza, con
la “mens”, che è essenzialmente facoltà rappresentativa; e in tal modo essa perde quella dimensione più
profonda, che già Eraclito aveva rilevato e che costituisce la ragione della sua misteriosa insondabilità. Si
tratta, infatti, di quella dimensione che lega l’anima all’essere totale e al suo “logos”. Perciò Jung ha cercato
di recuperare il concetto di “realtà dell’anima” (secondo il titolo di un suo libro), osservando, peraltro, che lo
stesso cristianesimo può risultare efficace per tale scopo, se esso diventa stimolo al raggiungimento di una
perfezione spirituale (10).
In realtà, ciò che è essenziale per il cristiano non è partecipare all’Essere, ma avere la possibilità di
testimoniare l’amore di Dio mediante la subordinazione di ogni altro interesse all’assoluta osservanza dei
comandamenti divini. Dio esige dall’uomo un impegno per la vita spirituale, la lotta contro gli impulsi che
portano a desiderare le cose limitate e i beni effimeri, la santificazione della natura, la testimonianza del
messaggio evangelico. Il cristiano, in sostanza, non vuole altro che ciò che è voluto da Dio e perciò impronta
il suo comportamento alla “legge”.
La vera metafisica è la teologia, basata sul sapere rivelato. Ogni sapere che prescinda dalla rivelazione è
considerato solo un’approssimazione molto imperfetta alla verità. Perciò la ragione non ha il compito di
costruire un sapere autonomo, bensì quello di collaborare ad approfondire quell’unico sapere di cui
l’elemento fondamentale è la rivelazione. Si hanno così le due formule che esprimono il reciproco
richiamarsi di fede e ragione nella teologia cristiana: crede ut intelligas; intellige ut credas. Il cristiano ha il
compito non solo di credere nelle verità rivelate, ma anche quello di confermarle con la ragione:
“Negligentia mihi videtur, - osserva S. Anselmo – si, postum confirmati sumus in fide, non studemus quod
credimus intelligere”. Tuttavia, l’”intelligenza” non può rendere interamente comprensibili sul piano
razionale e concettuale le verità rivelate; e l’”intelligere”, in realtà, non fa che fare apparire sempre più
ampio il divario tra la ragione e la fede, tra ciò che l’uomo può afferrare e comprendere con la sua mente e
ciò che Dio ha rivelato (e rivela). Si ha il paradosso per cui le verità della fede più sono comprese più
appaiono incommensurabili alla ragione. Perciò, infine, risulta valido il principio affermato da S.Tommaso,
secondo cui “idem non potest esse scitum et creditum”. Così, le verità per cui non si pone nessuna
incommensurabilità, cioè le verità interamente umane appaiono legittimamente fondate. Esse riguardano,
però, aspetti limitati della realtà e del mondo, non possono riguardare, ad esempio, il senso delle cose e il
significato dell’esistenza.
Tuttavia, dai due modi (o “vie”) in cui si configura il rapporto tra la fede e l’intelletto derivano
conseguenze diverse, già nell’ambito dello sviluppo della filosofia scolastica. Da una parte (“crede un
intelligas”) si ha la prospettiva di una continua compenetrazione della sfera filosofica e di quella teologica;
dall’altra parte (“intellige ut credas”) si ha la tendenza a separare sempre di più decisamente entrambe e ad
affermare la loro reciproca autonomia.12 Infatti, l’intelletto che indaga intorno alle verità rivelate instaura una
dialettica ascendente che investe la profondità della coscienza e ne rivela sempre di più la consistenza
ontologica. Questa tensione dialettica caratterizza, come è ovvio, il platonismo cristiano.
Il cristianesimo, però, tende a dissipare ogni equivoco rispetto all’oggetto della fede. Questo non può mai
diventare un “intelligibile” nel senso della sua intera trasposizione sul piano concettuale della razionalità. La
verità non è più tanto il termine di un processo interiore di ricerca, quanto, invece, l’”oggetto” di una
credenza immediata.13 La verità assume la forma dello stesso Cristo, che è il culmine della rivelazione: il
senso di ogni contenuto della Scrittura, infatti, è in funzione del compimento della redenzione. La verità
riguarda, in definitiva, la salvezza; e di questa verità non ci può essere una conoscenza “oggettiva” (nel
senso in cui può darsi di ogni realtà finita).14
12
Come osserva il Filiasi Carcano, si ha che “l’intelletto che precede la fede (e che è l’unico, ovviamente, rivendicato dal tomismo
come organo della filosofia) è diverso dall’intelletto che segue la fede, che deve intelligere il contenuto della fede”, e che il
significato della parola “intelletto” nelle due formule è diverso: “l’intelletto che può condurre alla fede, mostrando la convenienza
della rivelazione, senza però interferire nel contenuto della medesima, è un intelletto limitato, empirico e non ontologico,
organizzativo dell’esperienza e non partecipativo” (pp. 309-10).
13
“Il Cristianesimo ha accentuato la distinzione fra oggettività e verità, ogni autentica verità (anzi “la” verità) concentrando in
Gesù Cristo; ne segue che, la conoscenza o la scienza essendo dell’oggettività, la Verità non può essere che creduta” (P. Filiasi
Carcano, op. cit., p. 313).
14
Come ha notato R. Mehl, bisogna tenere presente che “la nozione di verità non è univoca, e che, per quanto scandalosa possa
apparire questa esigenza per la ragione, vi è una verità cristiana”. E analogamente si deve dire della ragione: “Vi è una ragione creata
da Dio, vi è una ragione intaccata dalla caduta, vi è una ragione che attende il rinnovamento dell’intelligenza, vi è una ragione
gloriosa che vedrà Dio faccia a faccia” (op. cit., p. 48). E a ogni tipo di ragione spetta una funzione specifica; così diversa è la
Alla sapienza antica il cristianesimo ha sostituito la fede in Cristo, sicché la conoscenza razionale perde
ogni significato metafisico (essendo tutto ciò che riguarda il “fondamento”, considerato ora specialmente
come fondamento della salvezza, oggetto della fede nella rivelazione) e assume un carattere esclusivamente
mondano e positivo. La filosofia rientra in questo ambito di conoscenza: e così si spiega la prevalenza
progressiva del problema gnoseologico, inteso, nel senso cartesiano, di ricerca intorno al metodo della
scienza esatta della natura.15 La scienza, in questo senso, si profila, piuttosto, come una tecnica (nel senso
struttura della ragione che fonda il sapere intorno all’universo, così come diversa è quella della ragione che comprende le verità
rivelate. “Questo è il motivo per cui ogni tentativo di sfuggire alla sua condizione attuale di homo viator (con tutte le conseguenze
gnoseologiche che questa condizione comporta) appare al cristiano un atto di infedeltà, un moto d’impazienza, e in definitiva un
tentativo empio: ed egli sarà pertanto avversario irriducibile di ogni gnosticismo, di ogni tentativo di oltrepassare lo stadio della fede,
e di instaurare quindi – sin da questa vita – una theologia gloriae, e per questo stesso motivo egli avrà in sospetto anche la mistica e
quelle speculazioni teologiche che (pur restando indubbiamente ortodosse come nel caso di S. Anselmo) tendono a porsi inter fidem
et speciem” (P. Filiasi Carcano, op. cit., p. 316).
15
“E per questa via la riflessione filosofica, rinunziando a ogni esigenza partecipativa, stornandosi dall’esperienza mistica, finiva
col mettere in luce – anziché la presenza – la mancanza di Dio: il Deus absconditus del Cristianesimo rivelandosi altrimenti ed
altrove che nella coscienza ontologica o nell’ordine della natura” (Ibid., p. 317). Come osserva ancora efficacemente il Filiasi
Carcano: “Il cristianesimo vuol distruggere il vecchio uomo e edificare l’uomo nuovo: la lotta contro la metafisica (vale a dire contro
il complesso della nostra saggezza naturale) non è che un episodio significativo di questa lenta, ma implacabile distruzione del
vecchio uomo; il Cristianesimo distrugge, e anche le virtù pagane diventano splendidi vizi, l’uomo è costretto a vivere innaturalmente
nell’assenza di conoscenza e nell’attesa del futuro, la gioia della vita s’inaridisce nella gola. La vera religione è, in un certo senso,
contro natura; e anzi (come insinua la teologia dialettica) il Cristianesimo non può dirsi neppure religione, forse perché invece di
‘legarci’, esso accresce il senso della nostra solitudine, la spietata e lucida coscienza del nostro abbandono” (Ibid.).
Fede e ragione nella recente enciclica di Giovanni Paolo II
Giovanni Paolo II riconosce nell’uomo una fondamentale ansia di conoscere se stesso: l’uomo è,
essenzialmente, il “conoscitore di se stesso”; egli, cioè, secondo le testimonianze presenti nei più diversi
contesti culturali, tende a interrogarsi sul senso della sua esistenza. La Chiesa, in quanto “nel Mistero
pasquale, ha ricevuto in dono la verità ultima sulla vita dell’uomo” (2), si è assunto il compito di diffondere
questa verità, nella consapevolezza di potere, in questo modo, aiutare l’uomo a vivere secondo il destino che
l’amore di Dio gli ha riservato. La verità ultima riguarda Dio stesso: Dio, cioè, può essere l’oggetto di una
conoscenza assoluta e definitiva; egli stesso è la verità. Tutto ciò che riguarda la vita nel mondo è oggetto di
una conoscenza che si approfondisce via via: e l’uomo ha creato una via per realizzare questa conoscenza, la
filosofia. “La capacità speculativa, che è propria dell’intelletto umano, porta ad elaborare, mediante l’attività
filosofica, una forma di pensiero rigoroso e a costruire così, con la coerenza logica delle affermazioni e
l’rganicità dei contenuti, un sapere sistematico” (4). La filosofia ha contribuito alla scoperta di alcuni princìpi
che sono stati riconosciuti, presso le varie culture, come forniti di validità universale. La Chiesa, perciò,
riconosce nella filosofia “la via per conoscere fondamentali verità concernenti l’esistenza dell’uomo”, e, nello
stesso tempo, vede in essa “un aiuto indispensabile per approfondire l’intelligenza della fede” (5). Nell’età
moderna, è accaduto che la filosofia ha finito, però, per riporre un’eccessiva fiducia nelle sue forze,
considerando se stessa come unico strumento di verità. Ma la verità che può attingere la filosofia, nei suoi
processi autonomi di indagine, non può essere che relativa, commisurata alla vicenda storica e temporale.
Perciò la filosofia non può rispondere al bisogno dell’uomo di trovare verità definitive, certezze intorno al
senso della sua vita. Di fronte all’eccessivo relativismo che domina nella cultura attuale, la Chiesa intende
giovarsi della fede nella rivelazione per “riaffermare la necessità della riflessione sulla verità” (6).
“Riaffermando la verità della fede, possiamo ridare all’uomo del nostro tempo genuina fiducia nelle sue
capacità conoscitive e offrire alla filosofia una provocazione perché possa recuperare e sviluppare la sua
piena dignità”. Oggi, infatti, si avverte uno straordinario bisogno di verità: l’uomo ha bisogno di riferirsi a
un fondamento, che non possa essere messo in discussione. “L’esigenza di un fondamento su cui costruire
l’esistenza personale e sociale si fa sentire in maniera pressante soprattutto quando si è costretti a constatare
la frammentarietà di proposte che elevano l’effimero al rango di valore, illudendo sulla possibilità di
raggiungere il vero senso dell’esistenza”. La filosofia deve contribuire a rafforzare questa fiducia dell’uomo
nelle possibilità di tendere a una verità per il cui conseguimento la fede nella rivelazione è indispensabile.
Fede e ragione, cioè, devono tornare a collaborare strettamente in questa rinnovata tensione verso la verità
intorno al senso dell’esistenza. “La filosofia, che ha la grande responsabilità di formare il pensiero e la
cultura attraverso il richiamo perenne alla ricerca del vero, deve recuperare con forza la sua vocazione
originaria”. Oggi, infatti, sembra che l’umanità abbia particolare bisogno di un’illuminazione, che gli può
venire dalla fede, dato che la via autonoma della conoscenza denuncia sempre nuovi limiti.
aristotelico di conoscenza delle cause per disporre interventi pratici adeguati, come, ad esempio, nella
medicina). La scienza “contemplativa”, in quanto riguarda le essenze immutabili, l’”essere in quanto essere”,
il fondamento, risulta ormai impossibile, essendo l’”essere” oggetto proprio della teologia, per la cui
costruzione la ragione è insufficiente ed è, tuttavia, un presupposto imprescindibile la ratio quaerens fidem.
Dio stesso si fa conoscere e rivela quelle verità che la ragione non può mai raggiungere da sola. Le verità
razionali, infatti, non bastano per la consapevolezza del senso dell’esistenza e della via della salvezza.
Queste verità possono essere comunicate solo da Dio. “Dio, in quanto fonte di amore, desidera farsi
conoscere, e la conoscenza che l’uomo ha di lui porta a compimento ogni altra vera conoscenza che la sua
mente è in grado di raggiungere circa il senso della propria esistenza” (7).
In seguito alla critica razionalista, che intendeva mostrare l’illegittimità di ogni sapere che non fosse
conseguito coi mezzi intellettuali, il Concilio Vaticano I ha ribadito con forza “che, oltre alla conoscenza
propria della ragione umana, capace per sua natura di giungere fino al Creatore, esiste una conoscenza che è
peculiare della fede” (8). “Esistono due ordini di conoscenza, - si afferma – distinti non solo per il loro
principio, ma anche per il loro oggetto: […] nell’uno conosciamo con la ragione naturale, nell’altro con la
fede divina; per l’oggetto, perché oltre le verità che la ragione naturale può capire, ci è proposto di vedere i
misteri nascosti in Dio […]”. “La filosofia e le scienze – ribadisce Giovanni Paolo II – spaziano nell’ordine
della ragione naturale, mentre la fede, illuminata e guidata dallo Spirito, riconosce nel messaggio della
salvezza la ‘pienezza di grazia e di verità’ che Dio ha voluto rivelare nella storia e in maniera definitiva per
mezzo di suo Figlio Gesù Cristo” (9). Il Concilio Vaticano II ha, infatti, ribadito: “La profonda verità su Dio e
sulla salvezza degli uomini, per mezzo di questa Rivelazione, risplende a noi in cristo, il quale è insieme il
mediatore e la pienezza di tutta la rivelazione” (10). Attraverso Cristo, Dio ha voluto anticipare nel tempo la
realtà connessa alla conoscenza che di lui si avrà col “compimento del tempo”. Il Verbo eterno è venuto tra
gli uomini, si è insediato nella storia, rivelando i misteri di Dio. In questo modo Dio stesso accompagna
l’uomo nel suo cammino e fa sì che “la verità rivelata esprima in pienezza i suoi contenuti grazie all’azione
incessante dello Spirito Santo” (11). “L’incarnazione del Figlio di Dio permette di vedere attuata la sintesi
definitiva che la mente umana, partendo da sé, non avrebbe neppure potuto immaginare: l’Eterno entra nel
tempo, il Tutto si nasconde nel frammento, Dio assume il volto dell’uomo” (12). “Con questa Rivelazione
viene offerta all’uomo la verità ultima sulla propria vita e sul destino della storia”. “Al di fuori di questa
prospettiva il mistero dell’esistenza personale rimane un enigma insolubile”.
La fede nella rivelazione implica l’adesione completa ai contenuti di verità rivelata. Ciò vuol dire che vi
aderisce la stessa ragione umana. In questo modo, la ragione si fa complice della fede. “In aiuto alla ragione,
che cerca l’intelligenza del mistero, vengono anche i segni presenti nella Rivelazione. Essi servono a
condurre più a fondo la ricerca della verità e a permettere che la mente possa autonomamente indagare
anche all’interno del mistero. Questi segni, comunque, se da una parte danno maggior forza alla ragione,
perché le consentono di ricercare all’interno del mistero con i suoi propri mezzi di cui è giustamente gelosa,
dall’altra la spingono a trascendere la loro realtà di segni per raccoglierne il significato ulteriore di cui sono
portatori” (13).
CAPITOLO XV
Cultura e filosofia nel medioevo
Il programma di una filosofia cristiana si è venuto attuando nel corso del medioevo. Nell’ambito di un sistema
saldamente ancorato a un’articolazione del sapere sulla base delle “arti” del “trivio” (grammatica, retorica, dialettica o
logica) e del quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia, musica), la filosofia fu chiamata a svolgere la funzione di
“ancella della teologia”, mentre proprio a questa era attribuito il posto di conclusione e sintesi di ogni conoscenza. La
teologia, la scienza razionale di Dio, era, dunque, in stretto rapporto e dialogo con la filosofia. Fede e ragione erano le
grandi fonti della verità: alla filosofia era affidato il compito di giustificare razionalmente le verità rivelate. I due
processi “credi per intendere” e “intendi per credere” costituivano i due momenti di uno stesso itinerario conoscitivo: la
comprensione del mondo e di Dio. Nel medioevo il sapere era pressoché interamente custodito dalla Chiesa con le sue
istituzioni scolastiche. Queste furono dapprima le scuole fiorite presso i monasteri; quindi, a partire dal secolo XI e in
concomitanza con la rinascita delle città, furono le scuole vescovili (cattedrali) e infine furono le sedi universitarie. Le
grandi fonti continuarono ad essere Sant’Agostino e gli altri Padri occidentali. Motivi di conflitto furono forniti
specialmente dalla opposizione dei “dialettici”, sostenitori radicali del ragionamento, e dagli antidialettici, sostenitori di
una via mistica a Dio attraverso l’approfondimento della fede.
Nel medioevo spetta specialmente alla Chiesa conservare, interpretare e trasmettere il patrimonio culturale;
gli intellettuali sono monaci, chierici e frati, che fanno parte di quelle specifiche istituzioni che sono le “scuole”,
annesse ai monasteri (la scuola monastica caratterizza l’alto medioevo e il mondo feudale: è diffusa, dunque, fino
a tutto il secolo XI), alle cattedrali (in relazione alla rinascita delle città, nel XII secolo), ai conventi (a partire dal
secolo XIII, con l’istituzione dei grandi ordini dei francescani e dei domenicani). Anche le “università” (scuole
di corporazioni) sono in massima parte controllate dalle autorità ecclesiastiche e i maestri che vi insegnano
sono quasi sempre chierici. Le istituzioni ecclesiastiche monopolizzano la cultura e l’insegnamento, in quanto si
ritiene che la Chiesa sia l’unica depositaria della “verità”, che, come è noto, è fatta coincidere con la dottrina
rivelata nella Sacra Scrittura.
La cultura medievale è pressoché interamente fondata sull’autorità dei grandi maestri dell’antichità, per
quanto riguarda le arti del “Trivio” (Donato per la grammatica, Quintiliano per la retorica, Aristotele per la
logica/dialettica) e del “Quadrivio” (aritmetica, geometria, astronomia, musica, di cui un autorevole mezzo di
trasmissione è considerato Boezio) e la stessa filosofia (S. Agostino è considerato fino al secolo XII l’autorità
fondamentale, in quanto attraverso la sua opera è conservata la tradizione filosofica antica, specialmente il
platonismo e il neoplatonismo, considerati più vicini allo spirito della concezione cristiana; dalla fine del secolo
XII in Occidente si diffonde, attraverso la mediazione dei filosofi arabi, la filosofia di Aristotele, considerata
come il sistema di sapere che può essere costruito con la sola ragione. La stessa Scrittura e l’interpretazione dei
Padri della Chiesa, nonché l’intera tradizione apostolica e episcopale, costituisce l’autorità per quanto riguarda
la teologia e la dottrina relativa al destino soprannaturale dell’uomo.
S. Agostino costituisce la principale autorità per la filosofia: egli è il maestro indiscusso del sapere cristiano.
Per secoli, egli ha insegnato che il sapere antico deve essere utilizzato in conformità della fede e per scopi che
confluiscono nel fine ultimo della salvezza; che Dio è verità ed è luce che illumina direttamente l’anima e le
consente di conoscere; che il Verbo divino raccoglie in unità il cosmo delle idee (reali universali, modelli e
archetipi dell’universo degli enti); che l’anima è immortale, immateriale e una e che per essa più importante è
“diligere” (volere e amare) che “intelligere” (pensare e sapere); che all’infuori di Dio e dell’anima (e della sua
salvezza) nulla ha veramente importanza; che nel mondo creato la materia è una realtà positiva e che il male in
sé è nulla, puro limite del bene; che il bene è reale e che prima o poi è destinato ad attuarsi, vincendo ogni
resistenza che si oppone ad esso (cioè ogni male).
Un’altra autorevole fonte della filosofia cristiana è uno scrittore dalla personalità non bene definita, Dionigi
l’Areopagita, ritenuto (a torto) discepolo ateniese di S. Paolo. I suoi libri, in greco, giunsero da Bisanzio
all’imperatore Ludovico II il Pio e furono tradotti in latino da Scoto Eriugena. Il motivo fondamentale della
dottrina contenuta in quei testi è che tutto l’universo è ordinato gerarchicamente: così nella Gerarchia celeste e
nella Gerarchia ecclesiastica è delineata la disposizione degli “ordini angelici”, secondo tre gradi (serafini,
cherubini, troni; dominazioni, virtù, podestà; principati, arcangeli, angeli), a cui corrispondono l’ordine dei
“misteri” (battesimo, eucarestia, ordine), quello dei ceti ecclesitici che li amministra (diaconi, preti, vescovi) e
quello vigente nella comunità dei fedeli (penitenti, energumeni, catecumini). Un’unica legge (lo stesso principio
gerarchico) fa sì che tutto, nei vari domini e nelle diverse sfere della realtà, si corrisponda: l’universo non è che
la totalità armonica delle creature e delle continue, infinite corrispondenze reciproche tra i domini in cui tale
legge esercita il suo potere. Nello stesso tempo, Dionigi insegna la via per uscire dal mondo, per oltrepassarlo.
Infatti, Dio è al di là di ogni ordine e di ogni gerarchia, assolutamente irriducibile a qualsiasi aspetto della
realtà. Così vengono posti i concetti fondamentali della teologia negativa, basata sul presupposto che di Dio non
si può assolutamente parlare e che i termini che usiamo per indicare i suoi attributi servono solo a dire ciò che
egli non è (che Dio non è finito, ecc.). E, nello stesso tempo, vengono introdotti nuovi termini, come “mistica”,
“estasi”, “contemplazione”, per indicare le tappe o le modalità di percorso della via che conduce a Dio. Lo
Pseudo-Dionigi è anche il maestro della concezione gerarchica dell’ordine universale, che sarà il cardine della
cultura e della società medievali.
Il sapere medievale è essenzialmente sistematico ed “enciclopedico”: ogni disciplina e ogni nozione
all’interno di essa occupano un posto preciso, che è stabilito dall’ordine armonico e gerarchico dell’insieme:
Perciò tra le “autorità” emergono, dopo i grandi maestri della dottrina cristiana, i primi compilatori di
“enciclopedie” cristiane: Boezio e Isidoro di Siviglia.
Boezio e il celebre autore del De consolatione philosophiae, scritto durante il perido della sua carcerazione per
ordine di Teodorico e rimasto esemplare per l’esaltazione della filosofia come la via che consente il
conseguimento della vera felicità, in quanto insegna che i beni materiali e mondani sono effimeri e che il fine
della nostra esistenza è il sommo bene, Dio, che dobbiamo cercare con l’impegno della volontà rettamente
orientata e sostenuta dalla ragione. Egli svolse una vasta attività enciclopedica e i suoi testi sono rimasti,
almeno fino al XII secolo, strumenti fondamentali per la maggior parte delle arti liberali, cioè per la logica,
l’aritmetica, la geometria e la musica. Egli fu in primo luogo l’autorità esclusiva in materia di logica, avendo
tramandato la traduzione e il commento dei libri Sull’interpretazione e Sulle categorie di Aristotele: Il corpo di tali
opere costituì la cosiddetta “logica antiqua”, alla quale si aggiunse poi la “logica nova”, costituita dalle altre
opere aristoteliche di logica.
A Isidoro di Siviglia si deve la prima vera e propria enciclopedia cristiana medievale. Questa enciclopedia,
rappresentata dalle Origines o Etymologiae, è basata sul principio secondo cui, una volta conosciuta l’”origine” o
etimologia del nome di una cosa, “si coglie direttamente l’essenza stessa della cosa”: ad esempio, se si vuole
ricercare l’essenza dell’uomo, si risale all’etimologia della parola, cioè a “humus”, e così si apprende che tale
essenza è “terra e polvere”; analogamente della pietra: la parola “lapis” risalirebbe a “ledens pedem”, sicché
l’essenza della pietra è che essa fa male al piede. Poiché il compito della filosofia è scoprire le essenze, essa si
configura come scienza etimologica: il grammatico è, così, il vero filosofo. La filosofia non è l’inquieta ricerca
agostiniana all’interno della coscienza, ma è il paziente lavoro dell’analisi etimologica delle parole.
Isidoro ha delineato anche una precisa visione della vicenda temporale: la vera realtà consiste in una
condizione originaria, che si è andata consumando nel tempo; dalla perfezione del paradiso terrestre al
labirinto della natura e della storia, le cose si sono degradate; e le parole consentono in qualche modo di
recuperare quell’essenza che si è andata via via corrompendo: esse sono i segni di una vita e di una realtà
sommerse dal tempo.
La filosofia, nella concezione medievale, comprende l’intero sistema del sapere profano: perciò filosofi sono
considerati anche i poeti, i retori, gli storici e gli scienziati; autorevoli “filosofi” sono, così, Virgilio (che, come è
noto, ancora Dante considera come il maestro di ogni sapere basato sull’uso della ragione), Ovidio, Lucano e
Stazio, così come Aristotele e Porfirio. E per lo studio della natura, che registra un incremento a partire dal XII
secolo, anche dietro l’impulso della scienza araba, gli “auctores” (dunque “auctoritates”) sono Aristotele,
Ippocrate, Galeno e Avicenna (per la biologia e la medicina), Tolomeo (per l’astronomia), Euclide (per la
geometria), gli arabi Geber (per lo studio della composizione chimica dei corpi attraverso la determinazione dei
rapporti numerici tra i vari elementi) e Alhazen (per i fenomeni ottici).
Nel XIII secolo in Occidente vengono acquisiti altri testi, di “autori” greci, alessandrini e musulmani,
relativamente ai diversi ambiti scientifici che via i maestri universitari inglobano nella “filosofia”. In
particolare, è acquisito l’intero sistema aristotelico, che rappresenta una “teoria” completa riguardante
l’universo (fisica), l’uomo (etica e politica), i princìpi della realtà e Dio stesso (metafisica). E tale “filosofia”
appare costruita dalla sola ragione umana, dunque autonoma e sufficiente per quanto riguarda tutto ciò che la
natura razionale dell’uomo può consentire di conoscere.
La filosofia scolastica nei secoli IX-XI (età delle scuole monastiche)
Per tre secoli, dal IX all’XI, la filosofia è affidata ai monaci, che insegnano nelle loro “scuole” incluse nei monasteri. Ai
monasteri, diffusi nell’impero, è affidato il compito dell’insegnamento e della trasmissione dell’intero sapere: in essi
vengono trascritti e conservati i “codici”. Carlo Magno impose a tutti i monasteri la regola benedettina, che prevedeva
circa 1500 ore di lettura all’anno.
Nel IX secolo la filosofia trovò un significativo sviluppo presso la “Scuola palatina” (annessa alla corte), dove
ai tempi di Carlo il Calvo troviamo Giovanni Scoto Eriugena, che tradusse le opere di alcuni rappresentanti
della patristica greca (Gregorio di Nissa e Massimo il Confessore) e le opere dello Pseudo-Dionigi, e scrisse il
De divisione naturae. Compito della filosofia è, per l’Eriugena, di intendere la Scrittura nei suoi significati più
profondi, allegorici e mistici, cioè come l’insieme dei libri che contengono l’intera sapienza e offrono diversi
livelli di verità (verità fisiche sull’ordine dell’universo, verità orali sulla legge che regola la vita degli uomini,
verità teologiche). La logica è la “disciplina” (o “regola”) dell’intelletto, che si accinge a comprendere i diversi
ordini di verità. In effetti, l’ordine dell’intelletto è anche quello della realtà ed è quello della rivelazione:
attraverso la ricerca razionale, cioè per mezzo dell’intelletto che segue l’ordine logico, si scopre nella Scrittura
l’ordine della realtà. L’universo viene compreso, dunque, non attraverso l’osservazione, bensì attraverso la
Parola di Dio, in quanto, cioè, esso è originariamente rivelato. Per Scoto Eriugena, l’ordine della realtà, quale
appare dalla Scrittura, ha una costituzione “trinitaria” e “dialettica”, in quanto si attua attraverso un doppio
processo che gravita intorno a un elemento centrale: il doppio processo è quello della “divisione” e della
“risoluzione” e l’elemento centrale è l’uomo. Infatti: 1) tutto discende da Dio, creatore increato; 2) tutto ritorna a
Dio; 3) al centro si trova l’uomo, sintesi di corpo e anima e compendio dell’universo. La “divisione” riguarda il
processo di derivazione da Dio dei diversi livelli della realtà, cioè delle diverse “nature”, che sono concepite,
neoplatonicamente, come logiche conseguenze dell’attività creante della “natura” originaria. La “risoluzione” è
il processo inverso, attraverso il quale le diverse “nature” si risolvono di nuovo in quella originaria. La
“natura” è qui Dio, inteso come l’Uno dei neoplatonici, superiore all’essere e al bene e principio da cui
derivano a cui ritornano tutte le cose. Si hanno, per l’Eriugena, quattro specie di natura: 1) la natura non creata e
creante, cioè Dio Padre, che è al di là di ogni determinazione e, dunque, di ogni conoscenza (“superessenza” e
“superverità”), per cui di lui si può dire ciò che non è (teologia negativa); 2) la natura creata e creante, cioè il
Figlio o Verbo, che è il luogo delle idee eterne e delle cause primordiali (forme ed essenze); 3) la natura creata e
non creante, cioè il mondo, in cui le essenze si manifestano come enti individuali; 4) la natura non creata e non
creante, cioè di nuovo Dio, in quanto fine di tutte le cose, termine di ritorno e di compimento dell’intero ciclo. Il
processo di ritorno a Dio avviene per opera dell’uomo, che è il microcosmo che in sé compendia (e con sé
trasporta) l’intero universo; ed è articolato in cinque momenti: la morte, la resurrezione del corpo, il suo
tramutamento in spirito, il suo sollevarsi alle essenze intelligibili e, infine, il suo riassorbimento in Dio. In
questa concezione si possono individuare motivi panteistici e mistici insieme: infatti, se da una parte la
derivazione di tutte le cose da Dio e la loro risoluzione in lui medesimo appaiono propri di un panteismo
neoplatonico (per cui i diversi livelli della realtà non sono altro che aspetti dell’unica natura, al cui interno si
svolge il ciclo dialettico), d’altra parte la stessa inconcepibilità di Dio fa supporre che l’intera concezione qui
espressa nei termini della comprensione razionale non sia altro che una trasposizione in termini concettuali
(filosofici) di una “visione” mistica, che è al di là di ogni adeguata espressione nel contesto discorsivo.
In realtà, l’esigenza razionale (logica, dialettica) e quella sovrarazionale (fideistica, mistica) si intrecciano e si
sovrappongono in questa prima fase di sviluppo della filosofia scolastica. I “dialettici” intendono ricondurre la
teologia sul terreno della filosofia, sostenendo la possibilità di una comprensione razionale delle stesse verità
rivelate; gli “antidialettici” sostengono il carattere sovrarazionale di tali verità, la cui discussione con l’uso della
logica appare pericolosa per la stessa integrità della fede nella rivelazione. Poteva accadere, infatti, che su
alcune verità dogmatiche l’esame logico portasse a risultati che compromettevano la compattezza del dogma.
R. Roques (Remarques sur la signification del Jean Scot Eriugène, in “Divinitas”, Roma 1967) mette in rilievo la
fondamentale unità di ragione e fede, di indagine e rivelazione. Scoto Eriugena si sarebbe proposto il compito
di costruire un sistema coerente di metafisica cristiana, un edificio intelligibile e razionalmente rigoroso, basato
sull’assunto fondamentale che sia la natura che la Scrittura sono opere di Dio, nelle quali, in modi diversi, si
esprime lo stesso linguaggio, il medesimo disegno dell’intelletto divino. Così tutta la natura deve costituire un
sistema stabile e perfettamente intelligibile. Dio, infatti, non può avere creato nulla di irrazionale e di
imperfetto. Non si pone, dunque, neppure il problema dell’accordo tra la ratio e la rivelazione. “Noi vorremmo
sapere, per esempio, in quale momento parla l’esegeta, in quale il puro logico o il teorico della conoscenza, in
quale momento il teologo o il mistico. Ma queste distinzioni e questi problemi sono quasi privi di senso per
l’Eriugena. Per lui, la verità è una, venga dall’una o dall’altra fonte; la ‘dimostrazione’ è sempre e egualmente
valida, purché attinga realmente a queste fonti l’insieme dei suoi argomenti” (p. 56 dell’estratto).
Il razionalismo di Scoto Eriugena influenzò, in primo luogo, la scuola benedettina di Auxerre: Remigio di
Auxerre (sec. IX) diede una interpretazione logica della teologia, identificando, ad esempio, Dio col genere
supremo, cioè con l’Essere, che si comunica per partecipazione agli altri generi e specie. Berengario di Tours (sec.
XI), poi, trasse dall’applicazione della logica alcune conseguenze apertamente contrastanti col dogma della
presenza reale del corpo e del sangue di Cristo nell’Eucarestia: infatti, egli sosteneva che, anche dopo la
consacrazione dell’ostia, a causa della permanenza degli accidenti, permane anche la sostanza del pane e del
vino; sicché il corpo e il sangue di Cristo sono solo termini di riferimento simbolici (“Se il pane e il vino
vengono chiamati carne e sangue di Cristo, ciò è dovuto al fatto che, in memoria della crocifissione della sua
carne, si celebra un sacrificio che ricorda la Passione, e che, con tale ricordo, ci invita a crocifiggere la nostra
carne”).
Contro i pericoli derivanti dall’uso della logica reagì gran parte del mondo monastico. Nel secolo XI la
filosofia e lo stesso insegnamento del sapere profano apparivano per lo più incompatibili con la vita del
monaco, interamente dedita alla carità e alla contemplazione. La logica appariva come un semplice complesso
di regole per ordinare le parole e sviluppare un discorso coerente: essa era un’”ars disserendi” e non tanto una
vera e propria “ars investigandi”, non poteva, perciò, riguardare l’ordine della realtà. Le cose sono unicamente
governate dalla volontà di Dio; e alla “meditatio” sulla Parola divina la logica non serve. E’ solo un’illusione
della ragione volere ammettere un ordine logico-necessario dell’universo: infatti, se il mondo coincidesse con
un tale ordine, Dio non sarebbe più onnipotente. Così all’abate Desiderio di Montecassino, che esprimeva la
convinzione che “neanche Dio può far sì che ciò che è accaduto non sia accaduto”, sicché la volontà di Dio
trova un limite nell’ordine dell’universo, Pier Damiani rispondeva con un libro De divina onnipotentia, nel quale
ribatteva che il mondo non è un ordine necessario sottoposto alle leggi della logica, poiché l’ordine del mondo
non è in realtà che il “corso consueto” delle cose, secondo il quale Dio stabilisce che le cose accadano. Dio, in
quanto onnipotente, non è sottomesso a nessuna regola logica, neppure al principio che stabilisce che “è
impossibile far sì che ciò che è avvenuto non sia avvenuto” (“factum infectum fieri nequit”).
L’equilibrio tra la ragione e la fede venne ristabilito, nel secolo XI, da S. Anselmo d’Aosta, il quale si propose
di dimostrare l’esistenza di Dio usando solo il rigore della logica, senza ricorrere all’autorità della Scrittura.16 iI
suoi due famosi opuscoli Monologion e Proslogion sono dedicati a questo argomento. Nel primo, ideale
“soliloquio”, troviamo una concatenazione logica di tre argomenti (“rationes”): 1) il mondo contiene
innumerevoli beni, di grado maggiore o minore; al di sopra di essi occorre, però, ammettere un “Bene sommo”,
cioè Dio; 2) il mondo comprende innumerevoli enti, che esistono l’uno in virtù di qualche altro e nessuno esiste
per sé; perciò occorre supporre un ente o un principio in virtù del quale tutti gli enti sono quel sono, cioè un
“Ente sommo”, che sia “la più alta realtà”; 3) gli enti sono di grado maggiore o minore; bisogna dunque
ammettere che al di sopra della scala degli enti vi è un grado al di sopra di ogni altrio, il “grado più grande e
migliore di tutti”, Dio stesso.
Come si vede, nel Monologion l’esistenza di Dio è dimostrata partendo dalla constatazione dei caratteri e
dell’ordine dell’universo (si tratta, cioè, di argomenti “a posteriori”). Nel Proslogion (cioè “colloquio”), Anselmo
sfida l’incredulo, che ammette solo la validità delle dimostrazioni razionali e che, perciò, non è disposto ad
ammettere l’esistenza di Dio sulla base della fede nella sapienza rivelata, conducendolo su un terreno del tutto
“a priori”, cioè quello della logica e del puro ragionamento. Egli invita il suo interlocutore a considerare cosa
comporti la presenza, sul piano del puro pensiero, dell’idea di Dio. L’incredulo dice “Dio non esiste”; ma
Anselmo subito fa osservare come questa proposizione sia contraddittoria. Egli si sofferma sulla parola “Dio” e
ne chiede una definizione: questa non può essere che “Dio è l’ente di cui nulla si può pensare più perfetto”.
L’incredulo osserva che, in realtà, l’unica esistenza di Dio è quella dell’idea presente sul piano del pensiero. Ma
Anselmo ribatte rilevando la contradizione: se si ammette che Dio è l’ente di cui non se ne può pensare uno più
perfetto, si deve anche ammettere che questo ente comprende l’esistenza, perché, altrimenti, si potrebbe
pensare un altro ente più ancora perfetto in quanto fornito di esistenza. L’incredulo si contraddice nel
momento in cui afferma che Dio è solo nella sua mente, come idea, perché ciò equivale a dire che “ciò di cui
non si può pensare il maggiore è ciò di cui si può pensare il maggiore”. Anselmo può concludere che è
16
Anselmo d’Aosta (1033-1109) si formò nel monastero di Bec, dove ebbe per maestro Lanfranco di Pavia
(che nell’opera De corpore et sanguine Domini aveva reagito contro le argomentazioni di Berengario di Tours)
e poi gli successe nella carica di abate. A quell’epoca risale la composizione dei due opuscoli famosi.
Successivamente successe allo stesso Lanfranco nella carica di arcivescovo di Canterbury e primate d’Inghilterra.
Essendo venuto a conflitto con la monarchia inglese sulla questione dei rapporti tra chiesa e regno, fu costretto
a ritirarsi in Italia, dove scrisse alcune opere teologiche, tra cui: Cur Deus homo?, De processione Spiriti Sancti,
De concordia praescientiae et praedestinationis Dei cum libero arbitrio.
logicamente necessario dire che “esiste senza dubbio un ente di cui non si può pensare il maggiore sia
nell’intelletto che nella realtà”.17
La rinascita del XII secolo
Tra l’XI e il XII secolo, in concomitanza con la rinascita delle città e l’affermarsi di nuovi ceti (liberi artigiani e
mercanti), anche le strutture scolastiche divengono prevalentemente “cittadine”: oltre alle scuole “cattedrali”, dirette
dai vescovi, si affermano scuole gestite da liberi maestri che impartiscono i loro insegnamenti specializzati in qualcuna
delle sette arti liberali facendosi pagare dai loro scolari, e, inoltre, scuole gestite da chierici canonici che seguono la
regola semimonastica di S. Agostino. Nello stesso tempo si diversifica il campo del sapere: presso ogni scuola si
impartisce una qualche particolare disciplina. E intanto cresce il bisogno di sapere e si introduce un nuovo metodo, che
consiste nell’esame e nella discussione delle varie soluzioni delle “questioni disputate”.
In questo contesto troviamo una principale questione che viene discussa nel campo della logica, il problema
degli “universali”. Questo problema muoveva da un passo di Porfirio, che nella sua “Introduzione” al libro sulle
“Categorie” di Aristotele si domandava se le “sostanze seconde” (generi e specie), cioè gli “universali”, “siano
entità esistenti in sé o siano solo semplici concetti posti dalla mente, e, ammesso che siano “reali”, se siano
corporee o incorporee, e se infine siano separate o invece esistano nelle cose sensibili”. I filosofi che nel XII
secolo esaminarono tale questione abbracciarono, di volta in volta, qualcuna delle soluzioni ipotizzate da
Porfirio: alcuni sostennero che gli “universali”, cioè, come già li definiva Aristotele, “quei predicati che sono
costitutivamente atti a essere attribuiti a più di un soggetto”, hanno una funzione semplicemente logica, in
quanto servono a classificare gli individui (che sono le sole entità reali), quindi sono semplici termini mentali,
“nomi”, per i quali non è possibile ammettere corrispondenti realtà (nominalismo);ii altri sostennero, invece, che
gli “universali” indicano le “essenze” immutabili delle cose, che sono realtà separate da queste e ad esse
precedenti (realismo platonico: gli universali sono le “idee” presenti nella mente di Dio e, dunque, hanno una
consistenza indipendente dalle cose, sono, cioè, ante rem),18 oppure che sono tali da assumete consistenza reale
solo nell’atto di formazione degli enti individuali e contestualmente ad essi (realismo moderato: gli “universali”
sono in re); altri, infine, sostennero che gli “universali” sono concetti, connessi all’attività dell’intelletto, che
riferisce sempre a entità reali i termini generali che esso ricava dall’esperienza (concettualismo).19
La più importante scuola cattedrale cittadina del secolo XII, per la nuova visione dell’uomo e della natura
che in essa si sviluppò, è quella di Chartres, illustrata da maestri di alto livello, come Ivo e teodorico di
17
Un monaco, Gaunilone di Mormontier, in un suo Liber pro insipiente (comparso anonimo, intorno al 1070) prende le
difese dell’incredulo, rilevando che l’”intendere” in senso proprio implica la constatazione della realtà di cui si parla e di
cui si ha idea, e che non è di un tale intendere che si può parlare a proposito dell’idea di Dio che è presente nella mente
dell’incredulo. Questa idea, in realtà, è sostenuta solo dalla parola, dal nome “Dio”, che, in tal modo, non sostenuta da altri
apporti conoscitivi, è solo un “flatus vocis”. Solo altri elementi, come l’esperienza e l’osservazione diretta, consentono di
attuare l’intendere come conoscenza di qualcosa di reale. L’incredulo non può avere inteso Dio, per il solo fatto che ne ha
udito pronunciare il nome. La definizione di Dio come “ciò di cui nulla di maggiore si può pensare” ha senso solo se
riferita alla comprensione della realtà di Dio; ma tale comprensione non può essere assicurata dalla semplice presenza
dell’idea e del nome corrispondente. Prima occorre constatare la realtà (l’esistenza) di una cosa, e poi la si può definire e
intendere. Ma nessun uomo sulla terra ha mai visto Dio; solo ai beati è consentita una tale visione. Così, altro è parlare di
un’isola mai veduta da alcuno; altro è dire che necessariamente deve esistere, dato che se ha l’idea come dell’isola più ricca
di tutte. Gaunilone riconosce le sante intenzioni di Anselmo, ma, contro ogni argomentazione, lascia intendere che solo la
fede può condurre ad ammettere l’esistenza di Dio.
18
Realisti furono lo stesso Anselmo e tutti i filosofi di orientamento platonico, tra i quali, più famoso di tutti,
Guglielmo di Champeaux, antidialettico, maestro della scuola cattedrale di Parigi e poi fondatore del monastero di san
Vittore.
19
Il grande rappresentante del “concettualismo” è Pietro Abelardo (1079-1142), allievo prima di Roscellino e poi di
Guglielmo di Campeaux. Con la sua prospettiva, alternativa al nominalismo e al realismo, egli rivendicava la funzione
fondamentale del pensiero e dell’attività mentale nella costruzione del sapere: gli “universali”, infatti, indicano i nostri
modi di comprendere gli individui attraverso i loro caratteri comuni; sono, cioè, i termini stessi della modalità umana della
comprensione della realtà. L’influsso di Abelardo nel campo della logica è stato notevole, specialmente perché egli ha
coniato gran parte della terminologia tecnica che sarà propria di tutta la logica medievale e anche moderna. Le sue
principali opere sono: Introductiones dialecticae, Dialectica, De unitate et trinitate divina, Theologia christiana, Ethica. In
quest’ultima opera Abelardo esalta la responsabilità umana: solo dalla nsotra volontà e dalla nostra iniziativa sorgono il
bene e il male morale; tutto l’essenziale, nella vita pratica così come nella scienza, dipende da noi; né il corpo è di per sé
negativo e fonte di peccato.
Chartres, Gilberto Porretano, Guglielmo di Conches, Bernardo di Tours, Giovanni di Salisbury. In particolare, a
Chartres venne sviluppata una nuova concezione del mondo e dell’uomo. La concezione della natura è basta
su due fonti antiche, oltre che sulla Scrittura, cioè sul “Timeo” platonico e sul “De natura deorum” di Cicerone.
Da quest’opera specialmente è tratta l’idea di una serie di enti “intermediari” tra le idee eterne e gli enti
sensibili, che, come gli scultori delle cattedrali gotiche, adornano l’universo di meravigliosi dettagli. L’universo
è concepito come una costruzione armonica, disposta secondo ordine, proporzione e misura; nulla avviene in
esso a caso, bensì tutto è determinato dal concorso delle “cauese seconde”. Ciò che occorre intendere è, perciò,
l’ordine razionale del mondo, le “ragioni” per cui le cose esistono, cioè qual è il loro posto e a quali fini sono
disposte. 20
L’altra grande scuola del XII secolo è quella di San Vittore. I “ vittorini” (Ugo, Riccardo, Gualtiero, Goffredo)
cercarono di attuare un nuovo equilibrio tra la filosofia come ricerca razionale e la sapienza rivelata. Ugo nel
suo Didascalikon compendia l’orientamento culturale e religioso della sua scuola. Egli parte da una riflessione
sui tre beni perduti da Adamo in seguito al peccato originale: la conoscenza, la virtù, l’immortalità, che lo
costituivano ad immagine della sapienza, della bontà e della eternità di Dio. L’uomo ora deve tendere a
recuperare questi beni perduti. Da questa esigenza nasce ogni “ars”, compresa la filosofia, che è la ricerca, da
parte dell’uomo decaduto, di quella condizione originaria di felicità e di perfezione, e che, in quanto tende a
riconquistare la conoscenza, è “theoria”, mentre, in quanto è ricerca della virtù, è “practica”, e, infine, in quanto
ricerca dei mezzi per la produzione dei beni materiali, è “tecnica”. Ma l’uomo in questo modo può solo, coi
mezzi della “filosofia”, imitare, realizzare parzialmente e imperfettamente i beni che ha perduto. Dio solo può
restituire all’uomo quei beni nella loro pienezza. La sapienza teologica è, dunque, un dono di Dio. Essa
comprende tre gradi: la “cogitatio”, una conoscenza legata alle immagini sensibili; la “meditatio”, che è una
riflessione dell’anima intorno a se stessa; la “contemplatio”, cioè la conoscenza di Dio conseguita attraverso
l’unione mistica. Nell’ambito di questo grado supremo, Riccardo distingue, quindi, ancora tre livelli: la
“dilatatio mentis”, che consiste nel vedere Dio figurativamente; la “sublevatio mentis”, mediante la quale si
vede Dio come in uno specchio; l’”alienatio mentis”, “allorché si contempla Dio nella sua schietta verità”.
La via mistica è ancora più decisamente perseguita da S. Bernardo di Chiaravalle, per il quale Dio non è tanto
un oggetto da conoscere quanto una persona da amare. La salvezza dipende unicamente dalla grazia e la
ragione è assolutamente inadatta a pensare la natura di Dio. Questa può essere solo l’oggetto di una “visione”
che può essere conseguita grazie a un intervento divino ed è un dono che si ottiene mediante la fede. 21
Invece per altri pensatori l’istanza mistica, tendendo a ricercare Dio nella natura stessa, sfociava in forme
ibride di panteismo. Tale è il caso di Almarico di Bène e Davide di Dinant, che affermarono l’univocità dell’essere
e che Dio è la sola sostanza, che, come “nous”, è forma di tutte le anime, e, come “hyle”, è materia
fondamentale di tutti i corpi. I discepoli di Almarico, poi, affermavano (come anche Gioacchino da Fiore) che
l’epoca dello Spirito aveva avuto inizio, che i sacramenti erano quindi inutili e che alla fede doveva ormai
subentrare la scienza, basata sul principio panteistico che “Dio è l’essenza di tutte le creature e l’essere di tutte
le cose”.
Nella seconda metà del secolo XII, per combattere le dottrine eretiche, alcuni maestri procedettero a una
sistemazione organica delle verità cristiane, secondo uno schema che per lo più seguiva l’impianto
neoplatonico. Nell’abito di tale programma, Pietro Lombardo nei suoi famosi quattro Libri sententiarum raccolse
e ordinò le principali dottrine ortodosse su Dio, la creazione, la redenzione e i sacramenti.
Invece Alano di Lilla proseguì nell’indirizzo dei maestri di Chartres e nelle Regulae de sacra theologia tracciò
un metodo rigorosamente razionalistico per lo sviluppo del sistema teologico: le verità teologiche sarebbero
dedotte, procedendo per assiomi e dimostrazioni, in un modo analogo a quello seguito nella geometria. In tal
20
Il più organico tentativo di interpretare il racconto biblico sulla creazione del mondo alla luce del “Timeo” è stato
compiuto da Teodorico di Chartres, il quale, tra l’altro, scrive nel suo De sex dierum operibus: “La somma Tinità opera
nella materia, che è l’insieme dei quattro elementi: in quanto causa efficiente, essa crea tale materia; in quanto causa
formale, la informa e la dispone; in quanto causa finale, la ama e la governa. Il Padre, infatti, è la causa efficiente, il Figlio
la causa formale, lo Spirito Santo la causa finale e la materia la causa materiale”. Qui appare significativa l’interpretazione
della Trinità in senso neoplatonico, per cui lo Spirito viene identificato con l’”anima del mondo”, la struttura razionale
dell’universo. In Guglielmo di Conches (De philosophia mundi), il motivo panteistico appare ancora più accentuato,
poiché la “processione dello Spirito” è fatta consistere “nell’estendere la volontà divina dalla potenza e dalla sapienza fino
alla creazione e al governo del mondo”. Il mondo, cioè, è considerato espressione della sapienza divina, sua diretta
manifestazione. In questo modo, era anche accentuata la visione del cosmo basato su un esatto ordine di rapporti
matematici.
21
S. Bernardo di Chiaravalle (1090-1153) fu fondatore dell’omonima abbazia cistercense e avversario irriducibile dei
“dialettici”; si scontrò specialmente con Abelardo, di cui fece condannare alcune dottrine teologiche.
modo si sarebbe ripercorso logicamente l’ordine reale della derivazione di tutte le cose da Dio. Con un metodo
simile, cioè applicando le regole della dimostrazione matematica, altri studiosi ceracrono di rinnovare il
sistema scientifico della natura; in particolare, Adelardo di Bath nelle sue Quaestiones naturales riprese il motivo
della concatenazione delle cause fisiche, per delineare un sistema rigorosamente concatenato dei fenomeni, in
base a una concezione matematico-meccanica della natura.
La filosofia araba
Già nel secolo IX gli studiosi arabi (riuniti specialmente nella “Casa della Sapienza” a Bagdad) avevano tradotto le opere
dei principali filosofi e scienziati greci. La conoscenza della filosofia greca determinò lo sviluppo di una tendenza
prevalentemente aristotelico-neoplatonizzante, centrata sull’idea di una gerarchia stabile nella processione causale che da
Dio va fino agli enti sublunari, passando per i cieli e le loro intelligenze motrici.
Al-Farabi (prima metà del secolo IX), autore di commenti ad Aristotele e sostenitore in una sua opera della
Concordanza tra Platone e Aristotele, pone una serie di “intelligenze” tra Dio e il mondo: immediatamente dopo
Dio e creata direttamente da lui, la “prima intelligenza”, che, riflettendo su se stessa, emana necessariamente la
seconda; e, così via, la concatenazione procede fino alla “decima intelligenza”, che è quella del cielo della luna
ed è anche da identificare con l’”intelletto agente”, che produce le essenze di tutte le sostanze terrestri (detto,
perciò, dai latini “dator formarum”). L’uomo possiede solo l’”intelletto possibile”, il quale diventa “intelletto in
atto”, allorché astrae le forme intelligibili dagli oggetti dell’esperienza. Questa concezione è, quindi, ripresa e
perfezionata da Avicenna (prima metà dell’XI secolo), autore del primo grande sistema di filosofia araba,
articolato in parti corrispondenti al “corpus” aristotelico (“Logica”, “Fisica”, “Psicologia”, “Metafisica”).
Ma il più famoso dei filosofi arabi è Averroè (1126-1198), nato a Cordova e quasi interamente dedito allo
studio e al commento delle opere di Aristotele. Il primo fondamentale motivo della sua concezione è la
distinzione tra i due livelli della conoscenza e i due corrispondenti modi della realtà. Questa distinzione è il
risultato del trasferimento sul piano della ragione della distinzione coranica tra “le cose soprannaturali,
nascoste, divine” e “le cose sensibili, umane” e, dunque, tra la conoscenza umana e quella divina. Al suo livello
più basso, la conoscenza umana è quella dei sensi e dell’immaginazione, ovviamente relativa; ma neppure al
livello più alto la conoscenza raziocinativa attua le condizioni della conoscenza adeguata e oggettiva, la quale è
definita come unità e identità perfetta fra il soggetto (intelletto) e l’oggetto conosciuto. Sia che riguardi gli
“universali” (intelligibili) che gli individui, la nostra conoscenza riguarda entità che sono fuori della mente; e,
per quanto concerne gli intelligibili, si deve ammettere che essi non sono mai colti nella loro semplicità, in
quanto non sono mai interamente liberati dagli aspetti sensibili delle forme immaginative: questa conoscenza,
perciò, non comprende le essenze delle cose; ciò che essa afferra sono piuttosto gli “accidenti” che si presentano
nell’esperienza, come, per esempio, il caldo, il freddo e le altre qualità; e anche la connessione causale si
riferisce agli accidenti. La conoscenza divina è, invece, intuitiva: essa, anzi, non dipende dalle cose, ma queste
vi dipendono, in quanto essa è la causa e la ragione della loro esistenza. In essa il soggetto e l’oggetto
coincidono e costituiscono una perfetta unità e identità. Dio, conoscendo se stesso, produce le essenze nel loro
ordine coerente; e queste sono la causa dell’esistenza delle cose.
Ai due modi di conoscenza corrispondono, per Averroè, due modi di realtà. La realtà noumenica, essenziale,
è il prodotto dell’attività divina ed è, come Dio stesso, senza inizio e senza fine. Solo quando la realtà è appresa
dalla mente umana attraverso la categoria soggettiva del “tempo” essa è concepita come avente inizio e fine,
“perché l’anima non può concepire l’infinito”. I sostenitori della creazione del mondo applicano la categoria del
tempo alla realtà noumenica, basandosi sulla erronea credenza “che se una cosa nella mente possiede una
determinata proprietà, bisogna immaginare che essa deve possederla anche fuori della mente, e perciò, se gli
avvenimenti passati possono essere concepiti dalla mente soltanto come finiti, tutto ciò che si è svolto nel
passato dev’essere ritenuto ugualmente finito”. Il noumeno è la realtà divina, che si manifesta nel movimento
continuo dei cieli; e solo per l’intelligenza umana quest’unico movimento circolare e infinito appare come
composto di molteplici movimenti circolari.
Conseguenze di questa concezione, incompatibili col cristianesimo, sono: l’eternità del mondo, l’impossibilità
divina di mutare l’ordine necessario dell’universo, la non conoscenza divina degli individui particolari e la
negazione della provvidenza, l’unità dell’intelletto agente e la negazione dell’immortalità dell’anima
individuale. Secondo Averroè, non solo l’intelletto agente è unico e separato, ma tutta l’anima intellettiva (e
dunque anche l’intelletto possibile) è unica per tutta la specie umana: in essa, pertanto, si conservano tutte le
conoscenze via via acquisite dagli uomini nella storia. L’intelletto agente agisce sull’intelletto possibile in
ragione del progressivo approfondimento conoscitivo che questo attua, col concorso dell’immaginazione, nel
campo dell’intelligibile.22
Il Duecento
Il secolo XIII (iniziato col pontificato di Innocenzo III e finito col primo anno di quello di Bonifacio VIII) vede il declino
dell’agostinismo culturale e politico (che tendeva all’assorbimento dello Stato nella Chiesa). Esso è anche il secolo delle
università e della scoperta e diffusione in Occidente delle opere di Aristotele.
Proprio quest’ultimo fenomeno determina il declino dell’agostinismo intellettuale, che estendeva senza limiti
il campo della teologia, fino a comprendervi tutti gli aspetti della vita e della cultura. Ora c’è posto per una
filosofia razionale distinta dalla teologia, come c’è posto per uno Stato indipendnete dalla Chiesa. Il grande
rappresentante della filosofia del secolo XIII è, perciò, l’aristotelismo; e la storia di quel secolo comprende gli
opposti sforzi compiuti per arginarne la diffusione o per farlo rientrare nell’ambito della mentalità cristiana. iii
In diverso modo, la fisionomia culturale del secolo XIII è influenzata dalla conoscenza di Aristotele. A questo
proposito, si distinguono tre correnti: la prima (che fa capo ai teologi francescani e a molti dottori secolari)
accoglie il procedimento scientifico di Aristotele, ma accentua il valore degli elementi agostiniani per quanto
riguarda la sfera teologico-religiosa; una seconda (che fa capo ad Alberto Magno e Tommaso d’Aquino) è
quella che dà luogo alla linea classica e ufficiale dell’aristotelismo cristiano e si pone in antagonismo con la
teologia platonizzante d’orientamento mistico; una terza corrente (che si riallaccia alla filosofia di Averroè) è
quella che intende ripristinare l’Aristotele autentico, senza sfuggire alle eventuali conseguenze contrastanti con
la dottrina cristiana. Teatro del nuovo movimento filosofico sono le facoltà di teologia, tra cui primeggiano
quelle di Parigi e di Oxford, dove prevalgono, rispettivamente, i domenicani e i francescani.
La scuola francescana accetta il procedimento razionalistico degli aristotelici; ma, al di sopra della ragione,
pone una facoltà intuitiva più alta, appropriata alla conoscenza delle cose divine. Dio è l’oggetto di
un’apprensione intellettuale immediata: è il “primo cognito”, nella cui luce tutte le rimanenti cose sono
conosciute. Inoltre i francescani negano il principio aristotelico che ogni conoscenza proceda dai sensi: essi
professano la dottrina platonica delle idee innate. E, mentre gli aristotelici considerano l’anima come forma,
cioè come parte di una sostanza e che ha bisogno del corpo per formare una sostanza completa, essi fanno,
platonicamente, dell’anima una sostanza che sta a sé, indipendente dal corpo e fornita di una materia propria.
Il più grande maestro di teologia dell’ordine francescano è San Bonaventura di Bagnoregio.23 Ciò che ispira
lo sviluppo della sua sintesi dottrinale è l’”auctoritas” di S. Agostino, ritenuta sufficiente per fondare una
“scientia-sapientia” interamente cristiana. In questa prospettiva si recupera pienamente il concetto della
teologia come il sommo sapere, al quale ogni altro sapere è subordinato, per cui le “artes” (o “disciplinae”)
concorrono insieme alla suprema verità che riguarda la salvezza eterna. La teologia proclama la sua signoria su
tutte le discipline e sulle facoltà di diritto e di medicina: la teologia è “domina”, “regina scientiarum”. Questo è
il tema della Reductio artium ad theologiam (circa 1253). E ogni forma di sapere è un gradino e una tappa verso la
conoscenza razionale della Parola divina. Bonaventura esprime, in particolare, l’idea che ogni scienza è cieca se
lasciata alla sua pretesa autonomia: perciò sostiene vigorosamente il principio dell’impossibilità per la ragione
di raggiungere da sola la verità. La filosofia, senza il sostegno della fede, si è smarrita in errori: così, ad
esempio, se Platone nel “Timeo” divide l’anima in varie parti, ponendo ciascuna di esse in una parte del corpo,
è perché questa soluzione s’impone alla ragione lasciata se stessa. Ciosì è vano cercare cause solo fisiche degli
22
I commenti di Averroè ad Aristotele cominciarono ad essere conosciuti nel mondo latino dopo il 1212, attraverso le
traduzioni di Michele Scoto, che svolgeva la sua attività di dotto presso Federico II, sicché esse da Napoli furono diffuse
nelle varie università italiane e, poi, in quella di Parigi.
23
Il primo dei maestri francescani fu, però, Alessandro di Hales 81185-1245), che occupò la cattedra di teologia a Parigi.
L’opera conosciuta con il nome di Summa Alexandri, anche se contiene delle parti dovite a lui, sembra sia stata piuttosto
opera collettiva di discepoli dedicatisi alla continuazione e allo sviluppo delle sue idee: si può dire che racchiude la
“somma” del pensiero francescano dal 1235 al 1260. In particolare, quest’opera ci fa conoscere un momento importante
della lotta contro l’indirizzo avicenniano. Affermando che Dio non può produrre che un effetto unico, un’intelligenza per il
cui tramite si produce la molteplicità delle cose, Avicenna avrebbe attribuito a tale intermediario un potere maggiore di
quello di Dio stesso. Tale critica è analoga a quella rivolta ad Avicebron, che spiega la varietà delle forme con la resistenza
sempre più grande che trova una forma unica nell’imprimersi nella materia, a mano a mano che questa diventa più oscura e
più lontana da Dio: la ragione della olteplicità deriverebbe, quindi, dalla materia. La “Summa” di Alessandro mira ad
affermare che le forme sono in se stesse distinte le une dalle altre e che esse concorrono a dividere la materia (e non
viceversa).
eventi naturali: ciò che è importante è cercare in tutti gli eventi, processi e aspetti della natura, un “vestigium
Dei”. Il compito della scienza non è di raggiungere un “altro” visibile fisico (naturalismo), né di attingere un
“altro” invisibile matematico-geometrico (matematismo), ma di raggiungere misticamente l’unità della natura
attraverso la presenza in essa di Dio stesso. S. Bonaventura propone, pertanto, una fisica mistica, una psicologia
mistica e una metafisica mistica. Si tratta di una “filosofia” che in realtà è una “teologia” mistica, la quale
pervade, raccoglie e unifica teocraticamente in se stessa tutti i diversi e specifici campi e piani del sapere
(Reductio artium ad theologiam, secondo il titolo dell’opera più famosa di S. Bonaventura), che invece
l’aristotelismo rivendica come autonomi, forniti ognuno di un proprio senso e di modi e strumenti specifici
d’intendimento. Così, mentre gli aristotelici pongono la filosofia alla base della teologia, affermando che
l’esistenza di Dio deve venire dimostrata partendo da considerazioni sul mondo, per Bonaventura l’esistenza
di Dio è evidente: infatti, “il nostro intelletto nulla intende se non grazie alla verità prima”. E la natura intera è
ricollegata a Dio, sulla base del riconoscimento che tutte le creature sono “espressioni” di Dio.
Bonaventura identifica il mondo delle idee col Verbo, che è generato da Dio come presupposto della
creazione, la quale deve essere concepita come una conseguenza della stessa natura divina. “Si dice infatti –
egli osserva – che il bene ha la tendenza a diffondersi (“diffusivum sui”) e che tutte le cose esistono in vista di
esso”: solo che qui la diffusione del bene non è, come nel neoplatonismo, una emanazione necessaria. Nel
mondo si disvela, così, la sapienza divina: questa “è diffusa in ogni cosa, poiché ogni cosa, qualunque essa sia,
secondo una proprietà qualunque, contiene la norma della saggezza divina e la disvela, e colui che conoscesse
tutte queste proprietà conoscerebbe chiaramente tale saggezza”. Ma la natura spesso sta davanti anoi come un
libro aperto di cui non comprendiamo il linguaggio: infatti noi non risaliamo dalla constatazione delle cose e
dei fenomeni alle divine intenzioni e a quel disegno originario secondo cui l’intero creato è stato disposto. Alla
filosofia pagana Bonaventura rimprovera di fermarsi alle cose nel loro aspetto esteriore, mentre la filosofia
cristiana considera la natura come un sistema di “segni” di cui occorre ricercare il profondo significato, che è
fondato sulla sapienza divina. E’ questa sapienza che bisogna cercare di interpretare, considerando ogni
aspetto della realtà: Il pensiero di S. Bonaventura è tutto proteso verso lo sviluppo di questo soprannaturalismo
che rifiuta di fare della natura un oggetto di semplice osservazione e di studio autonomo, come se essa avesse
proprie leggi e non fosse, invece, l’espressione della volontà di Dio.
Tutte le realtà create sono composte di materia e forma. Così, per Bonaventura, anche gli angeli hanno la
medesima composizione e non sono forme pure, come per gli aristotelici. Se si considera la materia “in senso
lato come ciò che esiste in potenza”, si deve ammettere che non c’è creatura che non sia esistita, almeno
logicamente, in potenza, prima di esistere in atto. La materia è, dunque, la carattersistica di ogni creatura in
quanto tale. Bonaventura rifiuta anche la tesi classica che attribuisce l’individuazione alla materia: l’individuo
deriva piuttosto dal legame della materia con la forma. L’unione dell’anima e del corpo non è, come in
Aristotele, l’unione di una forma con una materia, perché l’anima è già di per se stessa, come per Platone, una
sostanza completa.
Bonaventura ammette una fondamentale unità nell’attività dell’anima: perciò tutte le facoltà
(l’immaginazione, l’intelletto, la volontà), che sono fonti di operazioni specifiche, sono legate da un vincolo di
collaborazione. Così la conoscenza sensitiva è in rapporto di continuità con quella intellettuale. E le facoltà
dell’intelletto non sono caratterizzate da funzioni di sola attività o passività: “L’intelletto possibile non è
puramente passivo, avendo esso il potere di rivolgersi verso la specie contenuta nella rappresnetazione e, nel
rivolgersi ad essa, di riceverla con l’aiuto dell’intelletto agente e di giudicarla; e l’intelletto agente non è
completamente in atto, perché esso da solo non può comprendere nulla, se non è aiutato da una specie che,
separata dall’immagine, possa unirsi a lui”.
L’Itinerarium mentis in Deum descrive il processo della conoscenza e, quindi, i gradi di un’ascesa che va dalle
cose sensibili fino a Dio. La conoscenza ha inizio dalla sensazione, che consiste nel subire un influsso da parte di
un oggetto esterno, prosegue nell’immaginazione, che riguarda la forma sensibile dell’oggetto, coglie le forme
intelligibili attraverso l’intelletto, ordina e sistema i concetti nei giudizi e nei ragionamenti (individuando, ad
esempio, le cause delle cose e i loro effetti) mediante la ragione. L’anima conosce, poi, se stessa per mezzo
dell’intelligenza, e in sé trova i princìpi di tutte le verità, cioè le stesse ragioni eterne delle cose. L’intelligenza,
infatti, è caratterizzata dalla presenza in essa dell’idea dell’essere, cioè di Dio, che è come la luce che consente la
comprensione di ogni verità.
La volontà, l’altra fondamentale potenza dell’anima, comprende la conoscenza innata di ciò che è bene e, col
concorso dell’intelligenza (“sinderesi”) conosce Dio. E’ da notare che l’anima conosce se stessa come imago Dei,
in quanto le sue tre facoltà (intelletto, memoria, volontà) sono un’immagine della Trinità, e che la conoscenza di
Dio in questa vita avviene attraverso similitudini (il mondo stesso è vestigium Dei), mentre per i beati si attua in
una visione diretta.
Anche nella vita morale, Bonaventura pone una distinzione tra le virtù che possono essere acquisite
dall’”industria” umana (le virtù cardinali o “politiche”) e quelle che esigono l’intervento della grazia. La
natura e l’abitudine sono capaci di dare inizio a ciò che solo la grazia potrà portare a compimento: solo la carità,
virtù soprannaturale, è “la radice, la forma e il fine delle virtù, ricongiungendole tutte al fine ultimo e
collegando tutte le cose insieme con ordine; essa conserva l’ordine nella diversità delle cose da amare e
possiede in se stessa l’unità in quanto tende ad un fine unico e a un primo amato”. 24
L’altra grande facoltà di teologia era presso lo “Studium” di Oxford, fondato alla fine del secolo XII in
seguito all’espulsione di un gruppo di studenti da Parigi e caratterizzato da un prevalente orientamento
naturalistico, di impronta neoplatonizzante.
Il maestro che introdusse a Oxford le opere di Aristotele (che poi poterono essere adottate liberamente),
attuando una interessante sintesi di motivi aristotelici e neoplatonici nell’interpretazione della natura, fu
Roberto Grossatesta (1168-1253), cancelliere di quell’università e poi vescovo di Lincoln. Nel suo commento
agli “Analitici secondi”, egli dice che il tipico procedimento logico di ogni scienza è di tipo deduttivo, che, cioè,
ogni scienza è veramente tale quando è rigorosamente dedotta. Questa idea del sapere come sistema di
deduzioni impronta un caratteristico ideale di scìentificità, che è professato da tutti i maestri di Oxford. Così
Ruggero Bacone riprenderà questa idea, giungendo a una conclusione radicale: se ogni conoscenza è basata
sulla deduzione, la matematica rappresenta il vero modello di ogni conoscenza valida, e la logica si riconduce
alla procedura matematica. Infatti essa è la scienza della deduzione rigorosa, dunque la dottrina del sapere
scientifico. La logica, anzi, coincide col procedimento matematico assunto su un piano universale (tale da
essere valido per ogni scienza): gli “Elementi” di Euclide (di recente tradotti) sono presi a modello di
procedimento deduttivo per ogni forma di sapere. Ora, di fatto, la matematica è “scienza della quantità”; e le
scienze del quadrivio hanno il loro fondamento e trovano la loro unità in essa, poiché, in realtà, ciascuna non
ne è che un capitolo, che riguarda un particolare aspetto dell’universale matematismo. Infatti, come la realtà è
essenzialmente “una”, nonostante le diverse specifiche manifestazioni della quantità, una è la fondamentale
scienza matematica, che coglie la realtà nel suo carattere essenziale e unitario. I maestri di Oxford hanno
imparato dalla Scrittura che Dio ha creato ogni cosa secondo “pondus”, “ratio” (“ordo”) e “mensura”. Il
mondo, nella sua costituzione più profonda ed essenziale, è un intreccio di rapporti quantitativi; la “quantità”
(misurabile) è l’unità essenziale di ogni cosa. Perciò la matematica è la scienza per eccellenza: essa studia e
coglie l’essenza una e generale dell’universo: essa è la “scienza prima”, la scienza metafisica per eccellenza.
Sulla matematica (che è la stessa metafisica) si fondano tutte le scienze, che, così, risultano ordinate in una scala
gerarchica, per cui dopo la matematica vengono le arti del quadrivio e dopo le altre scienze che sono
subordinate a queste o ne sono particolari diramazioni e specificazioni. Per “philosophia” s’intende l’intero
edificio scientifico così ordinato: perciò l’intero sapere, per i maestri di Oxford, è rigorosamente deduttivo
(logica) ed è matematico nel suo contenuto fondamentale (matematismo). Questa scienza unitaria non ha
finalità pratiche (ad esempio, per il calcolo mercantile), ma rappresenta una specie di “teoria generale
dell’universo”, cioè una metafisica sulla quale si fonda ogni scienza relativa ai diversi aspetti della realtà.
L’universo è un sistema di rapporti quantitativi, un ordine matematico e geometrico. Ciò non vuol dire che il
mondo fisico si risolve in una rete di evanescenti forme geometriche o di astratti rapporti matematici, ma che le
leggi quantitaivo-matematiche e geometriche sono l’impalcatura di esso, che è sensibile, visibile, corporeo. Le
leggi matematiche s’incarnano nei fenomeni e costituiscono le loro intrinseche forme regolatrici.
Nel suo trattato De luce, il Gossatesta sviluppa la famosa metafisica della luce, per la quale la luce è l’elemento
fisico fondamentale, che di sé compenetra la materia e la plasma secondo leggi matematiche. Questa visione
della natura sarà adottata anche da Dante nel “Paradiso”. Nell’universo si danno molteplici eventi che
dimostrano che l’”anima del mondo” è matematico-geometrica e che essa è regolatrice di ogni fenomeno.
Perciò la luce procede secondo inflessibili leggi matematiche e queste sono alla base della costituzione di tutti i
corpi e di tutti i processi di aggregazione e disgregazione. In questo quadro, l’ottica è la scienza fisica
fondamentale.
24
Giovanni Fidanza (detto Bonaventura) era nato a Bagnoregio nel 1221; entrato giovanissimo mell’ordine francescano,
studiò a Parigi alla scuola di Alessandro di Hales e poi vi tenne l’insegnamento di teologia dal 1248 al 1257; nominato
generale dell’ordine, lasciò la cattedra, per partecipare, tuttavia, frequentemente alle dispute che in quella stessa università
ebbero luogo tra i francescani e i domenicani. Intervenne per ostacolare la diffusione dell’aristotelismo e del naturalismo
nelle università: così, vedendo crescere, all’università di Parigi, il moviemnto averroista, nel 1270 ottenne la famosa
condanna delle principali tesi di quella filosofia: creazione di un’intelligenza da parte di un’altra, unità di tutti gli intelletti
umani, mortalità dell’anima, negazione della creazione “ex nihilo” e, dunque, eternità del mondo. Morì a Lione nel 1274.
Nel periodo del suo insegnamento compose i Commentari alle Sentenze di Pietro Lombardo, il breviloqium, il De
reductione artium ad theologiam e varie Quaestiones; successivamente scrisse il famoso Itinerarium e altre opere di
argomento mistico.
Questa concezione, secondo i maestri di Oxford, trova conferma nel racconto biblico, secondo il quale Dio
creò per prima la luce. Il “fiat lux” è il momento fondamentale della creazione: con la luce, Dio ha posto, nello
stesso tempo, le regole dell’intero mondo fisico. Così elementi biblici si uniscono a idee euclidee, motivi
neoplatonici a motivi cristiani.25 La metafisica della luce, contro ogni “demonizzazione” del mondo e della
realtà corporea, metteva in rilievo l’essenziale natura luminosa (e dunque positiva) di ogni aspetto
dell’universo.
Perciò Ruggero Bacone, il maestro francescano di Oxford più vicino all’orientamento naturalistico
d’impronta aristotelica, esalta matematica, geometria ed ottica come le “grandi scienze”, su cui si basa ogni
forma di sapere, e dichiara che le matematiche sono “la porta e la chiave di tutte le scienze”. Nello stesso
tempo, però, egli mette in rilievo l’importanza dell’esperienza ed esalta la “scienza sperimentale”. Infatti, se la
legalità di ogni evento fisico è di tipo matematico e se essa opera all’interno della materia, si deve ammettere
che a noi non è dato conoscerla se non attraverso i modi in cui si manifesta fenomenicamente, cioè osservando
la “corporeità” fisica dell’evento, in cui la legge matematico-quantitativa si trova “incarnata”. La legge
matematica che opera con estrema regolarità ed esattezza all’interno dei fenomeni viene riconosciuta
dall’intelletto nei modi in cui l’esperienza riesce a certificarla (ad esempio, si comprendono i rapporti
quantitativi nell’ambito dei fenomeni, come quantità di calore, di umidità, di luminosità; velocità, direzione,
composizione di movimenti; aumento o diminuzione di volume, e così via). In ogni forma di sapere,
l’esperienza ha pari importanza della matematica e non è possibile prescindere da essa nell’indagine intorno ai
fenomeni del mondo reale. L’intelletto non può astrarsi rispetto all’osservazione, così come la legge matematica
che opera all’interno dell’evento fisico fa tutt’uno con esso. Il “matematismo” dei maestri di Oxford converge
con un “empirismo” altrettanto marcato: “sine experientia nihil sciri potest”. Deduzione (matematica e logica) e
intuizione (sensibile e sperimentale) si trovano strettamente congiunte. Ma com’è possibile questa convergenza
di matematica ed esperienza?
Per Ruggero Bacone (come già per il Grossatesta), agostinianamente, la deduzione matematica muove da
“princìpi primi” che sono intuitivamente dati all’intelletto entro un’altra forma d’esperienza, quella “interiore”.
E’ dall’intuizione della “quantità” che si snoda l’intero edificio deduttivo delle scienze matematiche. I maestri
di Oxford fanno propria questa idea agostiniana: è nella invisibile profondità dell’anima che si trovano le
fondamentali “illuminationes”, cioè i princìpi primi del sapere, a partire dai quali è possibile lo sviluppo di
ogni conoscenza, compresa quella che è, insieme deduttiva e sperimentale e che riguarda la costituzione
interna del mondo fisico e, nello stesso tempo, il suo sviluppo fenomenico. In realtà, non vi è, da questo punto
di vista, differenza tra la fisica sperimentale e la filosofia naturale. Nell’anima si trova, infatti, per effetto
dell’illuminazione diretta da parte di Dio, il principio (l’idea di quantità) da cui procede la matematica, con le
quattro scienze del quadrivio, che contengono, in effetti, i princìpi di tutte le scienze. Un altro motivo, presente
nei maestri di Oxford, è dato dall’idea che il sapere che l’uomo si sforza faticosamente di ricostruire è già
interamente contenuto nella Sacra Scrittura. Dio ha rivelato già tutto il sapere, comunicandolo in forme adatte
all’intendimento degli antichi. La filosofia ha il compito non già di elaborare un nuovo sapere, ma quello di riconoscere le verità già comunicate da Dio e di esplicitare l’infinito sapere contenuto nella Bibbia. Bacone
condanna i domenicani aristotelizzanti e gli aristotelici naturalisti che seguono false e indegne “auctoritates:
l’intero sapere si basa sull’autorità della ragione e dell’esperienza.26
Ruggero Bacone interpreta, così, l’esigenza universalistica di una scienza fondata sulle due fonti a
disposizione dell’uomo: quella naturale dell’osservazione e dell’elaborazione concettuale e quella della
rivelazione; e in tal modo propone una nuova sintesi fondata sull’accordo tra ragione e fede, pur accentuando il
motivo della funzione interpretativa che ogni scienza sperimentale è chiamata a svolgere rispetto alla Scrittura.
In realtà, la Parola divina riveste una profondità che gli uomini riescono a intndere sempre più adeguatamente,
a mano a mano che sviluppano il sistema delle scienze positive, razionali e sperimentali. La conquista della
“sapienza” si presenta così come l’obiettivo di un progetto che vede insieme congiunti gli sforzi di tutte le
25
Già S. Agostino aveva teorizzato l’identificazione dell’essere positivo con la luce, contrapposta al non-essere delle
“tenebre”, mentre, nella stessa epoca del Grossatesta, in Linguadoca riviveva quel manicheismo che considerava il mondo
stesso come lo scenario della lotta tra quei due princìpi contrapposti.
26
Ruggero Bacone si fece sostenitore del programma di Clemente IV di realizzare l’unità della fede cristiana e intese
fornire i mezzi intellettuali per quell’impresa: la sua opera principale, l’Opus maius, intendeva dimostrare che le condizioni
di quel grandioso progetto di rinnovamento dell’umanità per mezzo della fede e della scienza stavano in due motivi
essenziali: l’idea dell’unità della sapienza, la cui fonte unica è la Scrittura, e la costruzione di una scienza sperimentale,
destinata ad assicurare il dominio dell’uomo sulla natura.
istituzioni umane, e tale obiettivo non ha un semplice significato teorico, ma costituisce la condizione di
attuazione dell’umanità rigenerata secondo il modello della vita evangelica. 27
La dialettica nella filosofia medievale
E’ dovuta agli stoici la denominazione “dialettica” riferita alla “logica”. Aristotele aveva chiamato “dialettico” il
sillogismo che parte da premesse probabili: dialettica era, pertanto, la logica della conoscenza probabile. Gli stoici hanno
elaborato un sistema di logica delle proposizioni (anziché dei termini): le variabili delle loro formule sono proposizioni e
non termini; perciò abbiamo specialmente il sillogismo ipotetico e disgiuntivo che ha come premesse connessioni di
proposizioni (e non di termini). Es.: Se è inverno, fa freddo; ora fa freddo, dunque è inverno; o è inverno o è estate; o fa
freddo o fa caldo; fa caldo ed è estate.
Le uniche opere logiche note al medioevo latino fino al secolo XII costituiscono la cosiddetta logica vetus e
sono l’Isagoge di Porfirio, coi commenti di Boezio, e le opere dello stesso Boezio Introductio ad categoroas
syllogismos, De sillogismo categorico, De sillogismo hypothetico, De divisione, De differentis tipicis. Le successive
traduzioni latine degli Analitici, dei Topici e degli Elenchi sofistici costituiscono la logica nova,
Nel medioevo la “dialettica” è lo strumento fondamentale per superare (o evitare) il dubbio, lo scetticismo,
e dare alle stesse verità di fede un fondamento razionale (di assoluta indubitabilità e certezza). Il discorso
teologico-metafisico deve essere in accordo con se stesso (deve consistere di sistemi di verità bene
organizzati e coerenti), e poi con la realtà terrestre (con la stessa esperienza) e con la realtà soprannaturale e
la grazia. Anzi compito della dialettica è consentire l’accordo della fede e della ragione e, dunque, il raccordo
tra i diversi piani della realtà (tra la realtà soprannaturale e il mondo) e della verità (tra le verità dogmatiche
e rivelate e quelle razionali). La coerenza del discorso serve a preservare l’uomo dalla contraddizione (e
dunque dal dubbio).
Il ciclo delle arti liberali è un motivo ricorrente nelle raffigurazioni medievali. L’iconografia rappresenta la
dialettica secondo la descrizione che ne danno Marziano Capella nel De nuptiis e Alano di Lilla (XII secolo).
In queste descrizioni troviamo alcune note caratteristiche: la dialettica è rappresentata come una donna dal
volto pallido (come indice degli “insonni moti del suo animo”), che nel dirimere questioni “porta i capelli
verso il basso”, a indicare un esercizio acuto ed estenuante. Ma che lascia intravedere i caratteri di uno
strumento completo, capace di un risultato compiuto (per la “struttura circolare”, cioè perfetta, del capo; cfr.
Capella: “i capelli apparivano sinuosi, arricciati con una piega elegante e intrecciati, ed essi poi disposti con
ondulazioni progressive conferivano una struttura così circolare a tutta la testa tanto da far pensare che non
mancava nulla”). Ha poi gli occhi vibranti e lo sguardo acuto; e le mani rivolte a una funzione duplice, in
quanto “la destra ha il sapore del miele, la sinistra del fiele (Alano); nell’una porta “alcune formelle o
tavolette finemente lavorate, splendenti per la bellezza delle loro variopinte illustrazioni” e nell’altra “un
serpente raggomitolato in enormi spire” (Capella), a indicare la duplice funzione, cioè la buona
argomentazione e quella capziosa, comunque l’esercitazione esposta ai pericoli della sottigliezza e della
doppiezza sillogistica.
Accanto alla grammatica e alla retorica, la dialettica forma il “trivio” delle arti liberali. Una Dialettica di
Eric d’Auxerre (IX secolo) porta anche il titolo di “Tractatus de Trivio” ed è ispirata a una serie di scritti di
Agostino dedicati alle arti liberali (in parte andati perduti), in cui era rilevata l’importanza della dialettica
per l’esposizione, la fondazione e la difesa della dottrina cristiana. Nel De ordine di S, Agostino, la dialettica è
definita “disciplina disciplinarum”.
A partire dall’XI secolo la dialettica rappresenta il motivo centrale del dibattito filosofico: nello stesso
tempo soggetto e oggetto, in quanto tutti si avvalgono di argomentazioni condotte con coerenza logica, ma
alcuni rivalutano i diritti della ragione nei confronti della fede, mentre altri tendono a ridimensionarli o
sminuirli. Il problema centrale è quello del “rinnovamento dell’insegnamento della teologia mediante l’uso
della dialettica” (Bréhier, 125). La dialettica si rafforza anche perché alla logica aristotelica fino allora
27
Il programma di una generale riforma e unificazione del sapere caratterizza anche l’attività del francescano Raimondo
Lullo (1235-1315), che insegnò a Montpellier, a Parigi e a Napoli la sua “Ars generalis”, la disciplina costituita dalla
confluenza di tutte le scienze e fondata attraverso la preliminare risoluzione di tutte le discipline particolari ai loro termini
più semplici e comuni, secondo modalità e regole corrispondenti alle diverse esigenze conoscitive (questioni relative alle
essenze, alle cause, alle qualità, alle relazioni, al tempo, al luogo, e così via). La tecnica lulliana, cioè la famosa “arte
combinatoria”, ebbe molta fortuna e ispirò successivamente tutti i progetti di attuazione di una scienza unificata, costruita
con procedimento logico, mediante la combinazione di concetti e nozioni fondamentali, rappresentati con simboli di tipo
logico-matematico e tali da poter essere oggetto di operazioni simili a quelle del calcolo.
conosciuta (“logica vetus”) si aggiunge la fonte fino allora sconosciuta dell’Organon, in particolare la teoria
degli “Analitici secondi” sulla dimostrazione.
La più importante e la più attiva tra le scuole del secolo XI, la scuola episcopale di Chartres, diretta nel 990
dal vescovo Fulberto (allievo di Gerberto), faceva largo posto allo studio delle opere di Aristotele, di Boezio e
di Cicerone sulla logica. Tuttavia Fulberto poneva Dio al di sopra di tutte le nozioni dialettiche,
evidentemente razionali (“superessentia deitatis”). Già troviamo l’idea che l’essenza di Dio è connessa alla
sua volontà e che, pertanto, è al di là di ogni comprensione razionale (non è basata su nessuna necessità
razionale, né è comprensibile coi mezzi della ragione, dunque con la dialettica, né è esprimibile nei termini
del discorso).28 In particolare, la dialettica non poteva spiegare il mistero della transustanziazione (e in realtà
questo mistero era insidiato dal ragionamento dialettico): “Se si crede – scriveva Fulberto – che Dio può
tutto, bisogna credere che quelle creature che egli ha potuto creare dal nulla, egli può elevarle a maggior
ragione alla dignità di una natura più eccellente e farle passare nella sostanza del suo proprio corpo”.29
“Grazie a una sorta di ambiguità che spiega numerose caratteristiche del pensiero medievale, si potevano
collocare, in tale regione inaccessibile al pensiero umano, sia la realtà ineffabile della mistica neoplatonica sia
i dogmi rivelati. […] Tutto il periodo centrale del secolo XI doveva venir precisamente occupato da
controversie sulla legittimità dell’applicazione della dialettica alle cose divine, mettendo di conseguenza in
dubbio la divisione delle scienze, così nettamente fino allora segnata, in scienze delle cose divine e scienze
delle cose umane” (Bréhier, pp. 128-29).
In realtà, in quel periodo, la dialettica finiva con l’attaccare alcuni dogmi fondamentali, quali la verginità
della madre di Cristo, la resurrezione, l’immortalità dell’anima, la transustanziazione. Quest’ultimo dogma
venne discusso da un discepolo di Fulberto, Berengario di Tours: la consacrazione non avrebbe il potere di
mutare il pane e il vino nel corpo di Cristo; il pane e il vino sarebbero solo un sacramento, nel senso dato alla
parola da S. Agostino, un signum sacrum, un segno visibile, che ci consente di andare al di là dell’apparenza
sensibile, a un’idea.30 La dottrina di Berengario venne condannata nel 1050 da Leone IX nel concilio di
Vercelli. Lanfranco di Bec rimproverava a Berengario di “abbandonare le sacre autorità e di rifugiarsi nella
dialettica.
Nel corso di tali discussioni venne emergendo una distinzione tra la dialettica come pretesa di
determinare i confini del reale e la dialettica come semplice arte formale della discussione. Gli avversari di
Berengario respingono la dialettica intesa nel primo significato, che pretende arrogarsi il diritto di limitare la
potenza divina e d’intervenire nella critica dei dogmi (mettendone in luce le contraddizioni logiche),
pretendendo così, ad esempio, di impedire a Dio di mutare la natura d’una sostanza, col pretesto della
costanza delle essenze. Così la conversione del pane e del vino nel corpo di Cristo è incomprensibile,
ineffabile, miracolosa, ma niente affatto impossibile. Se però la dialettica è respinta come mezzo di
determinazione delle natura delle cose, essa conserva tuttavia la sua funzione di arte della discussione.
San Bonaventura e il sistema medievale del sapere
Bonaventura da Bagnorea visse nel secolo XIII, in un’epoca di grande ripresa culturale e di notevole rifiorimento
filosofico, specialmente intorno all’università di Parigi, dove egli stesso visse per la maggior parte e svolse la sua attività
intellettuale, prima come scolaro, poi come lettore e maestro nella facoltà di Teologia.
Fattore principale della notevole ripresa speculativa del secolo XIII è senz’altro l’introduzione in Occidente
di un gran numero di opere filosofiche, specialmente di Aristotele, fino a quel tempo sconosciute. Le opere
28
“La profondità incomprensibile del divino consiglio è incomprensibile alla pura intuizione conoscitiva della umana
sapienza; la nostra anima, allorché desidera elevarsi al di sopra di sé fino alla regione inaccessibile dei segreti divini, è
respinta dall’ostacolo della propria debolezza, e, rinchiusa nei confini della propria ignoranza, non può né comprendere
ciò che è al di là di se stessa, né valutare ciò che è in sé”; i misteri divini vengono rivelati solo “agli occhi della fede”; lo
spirito umano non può “presumere le cose invisibili in base a quelle visibili, né misurare le cose incorruttibili, se non
vuol cadere, prigioniero delle proprie definizioni e confidando nei ciechi suoi sensi, nel precipizio dell’errore” (Lettera
a Enhard, cit. da Bréhier, pp. 127-28).
29
Ibid.
30
“Se il pane e il vino vengono chiamati carne e sangue di Cristo, ciò è dovuto al fatto che, in memoria della
crocefissione della sua carne, si celebra un sacrificio che ricorda la Passione, e che, con tale ricordo, ci invita a
crocefiggere la nostra carne” (De Sacra Cena adversus Lanfrancum, cfr. Bréhier, p. 129). Berengario ricorda che il
pane e il vino nelle Sacre Scritture sono chiamati “species, similitudo, signum, sacramentum”: termini che sono riferiti
al corpo di Cristo, ma che non si identificano con esso.
aristoteliche di logica, conosciute e tradotte già verso la metà del secolo XII, avevano dato luogo a importanti
controversie filosofiche, come quella sul problema degli universali, ma non avevano toccato i veri problemi
metafisici. Invece le opere di fisica e di metafisica provocarono seri conflitti speculativi e suscitarono sospetti
e perplessità nelle autorità ecclesiastiche che in gran parte ne proibirono l’insegnamento. La diffusione delle
più importanti di tali opere si ebbe verso la fine del secolo XII: dapprima vennero diffuse dalla Spagna nelle
traduzioni e nei commenti, più o meno contaminati da motivi neoplatonici, dei filosofi arabi, come Avicenna
e Averroè; e in seguito tradotte direttamente dal greco specialmente ad opera di Guglielmo di Moerbeke. La
dottrina di Aristotele si trovò subito in antitesi con la dottrina allora dominante nelle facoltà di Teologia.31
Questa, infatti, risaliva ad Agostino, la cui influenza era preponderante nella cultura occidentale fino a quel
tempo.32 Quando perciò apparvero le opere di Aristotele, un grande fermento di idee e di studi sorse,
agitando l’ambiente culturale tradizionalmente dominato dai temi agostiniani.
Il Mandonnet (Sigier de Brabant et l’averoisme latin au XIII siècle, Louvain 1911) distingue tre indirizzi di
pensiero nel secolo XIII. Il primo indirizzo costituisce una corrente non del tutto omogenea, che comprende
pensatori di diverso orientamento, non solo cioè i farncescani in genere come Alessandro di Hales, Giovanni
della Rochelle, Bonaventura medesimo e i suoi discepoli, ma anche Ruggero Bacone e Duns Scoto; e poi
numerosi altri appartenenti al clero secolare, come Guglielmo di Auxerre, Roberto Greathead, Gerardo
d’Abbeville, Enrico di Gand, Egidio di Roma; parecchi domenicani, come Rolando di Cremona, Giacomo di
Metz e altri. Codesto indirizzo si caratterizza da alcuni aspetti dottrinali, come la mancanza di distinzione
formale tra verità razionale e verità rivelata; la preminenza della volontà sull’intelligenza e perciò della
nozione di bene su quella di vero; l’affermazione del primato della fede e dunque dell’azione illuminante di
Dio perché l’intelletto possa conoscere; la concezione della materia prima come certa attualità positiva
benché infima, contenente i princìpi e le ragioni seminali delle cose; la concezione degli esseri spirituali come
anch’essi composti di materia e forma e della pluralità delle forme sostanziali nell’uomo. La seconda
corrente è quella albertino-tomista, che si basa sul tentativo veramente poderoso di introdurre Aristotele non
solo nella filosofia ma anche nella teologia. Una terza corrente di puro aristotelismo filosofico si ebbe nella
seconda metà del secolo, la corrente averroistica, combattuta dai rappresentanti delle altre correnti,
specialmente da Tommaso e da Bonaventura e infine colpita dalla condanna della Chiesa nel suo capo Sigieri
di Brabante. 33
Bonaventura non scrisse libri di carattere filosofico e tanto meno sul problema della conoscenza; tuttavia,
questo problema è trattato nelle sue opere maggiori, nell’Itinerarium mentis in Deum, nel De reductione artium
ad theologiam e nei Commentaria in quatuor libros Sentientiarum. 34
31
Nel 1210 il concilio della provincia della Senna decretava: “Nec libri Aristotelis de naturali philosophia nec
commenta legantur Parisis publice vel secreto”; e nel 1215 il legato pontificio Roberto di Courçon a Parigi ordinava:
“Non legantur libri Aristotelis de metaphisica et de naturali philosophia, nec summae de eisdem”.
32
Agostino era considerato il maestro unico dallo stesso Abelardo, le cui tendenze razionalistiche sono note; a lui si
ricollega Bernardo da Chiaravalle ed egli è l’ispiratore di Ugo di San Vittore e della sua scuola; ed è nota l’influenza
esercitata su Anselmo d’Aosta, così come su Scoto Eriugena, che da lui deriva il concetto dell’identità di filosofia e
religione, e su Pier Lombardo, le cui Sentenze costituiscono il testo base dell’insegnamento teologico nel medioevo. E i
maetsri di Agostino sono i neoplatonici, mentre molto scarsi sono i contatti con Aristotele, del cui pensiero egli ebbe
qualche conoscenza e subì qualche influenza per alcune teorie secondarie (ad esempio la distinzione tra sensi esterni e
senso interno, tra sensibili propri e comuni, la teoria dell’immaginazione e della memoria). Agostino poté conoscere,
invece, perfettamente le Enneadi, tradotte da Vittorino. E dal punto di vista filosofico l’agostinismo non è che un
neoplatonismo rielaborato alla luce della dogmatica cristiana. Insieme allo Pseudo-Dionigi, Agostino è il grande
ispiratore del neoplatonismo medievale.
33
Il De Wulf insiste specialmente sulla frammentarietà e molteplicità di motivi confluenti nella corrente agostiniana e
sulla opposta organicità e unità del tomismo, il quale rappresenta “un’intima fusione dell’aristotelismo con un gruppo
importante di dottrine tolte da Agostino” (Storia della filosofia medievale, vol. II, p. 165). Anche il Lutz, in un’opera
sulla psicologia di Bonaventura (Munster 1909), mette in rilievo la mancanza di un’unità organica nel pensiero di
questo dottore della Chiesa, che avrebbe accolto elementi antichi e nuovi senza un coordinamento logico, ricercando di
conciliare, senza successo, Aristotele e Agostino.
34
La dottrina della conoscenza di Bonaventura è oggetto di interpretazioni contrastanti. Il Borgognoni (Le dottrine
filosofiche di S. Bonaventura, Bologna 1882) sostenne che Bonaventura segue esclusivamente Aristotele; così il Lutz
avvicina molto la teoria bonaventuriana della conoscenza a quella tomistica; allo stesso modo gli editori delle opere di
Bonaventura, i padri francescani di Quaracchi, sostengono che, riguardo al problema della conoscenza, vi è accordo fra
Bonaventura e Tommaso d’Aquino; e già prima lo Zigliara (Della luce intellettuale e dello ontologismo secondo la
dottrina dei santi Agostin, Bonaventura e Tommaso d’Aquino, Roma 1874) aveva ridotto la divergenza tra i due
massimi dottori ad “alcune accidentalissime e forse più apparenti che reali differenze di opinare intorno alla natura
dell’intelletto agente”. Il De Wulf medesimo aderisce a questa interpretazione. Generalmente questa interpretazione
Bonaventura ammette una facoltà conoscitiva che si esercita attraverso i sensi e che è chiamata, nel De
reducione, lumen cognitionis sensitivae; essa è distinta dalla facoltà intellettuale di conoscenza, chiamata lumen
cognitionis philosophicae, e ovviamente è considerata di ordine inferiore rispetto a quest’ultima.
In primo luogo, egli enumera i diversi significati che può assumere la parola “sentire”: nel significato
comune, vuol dire conoscere le cose presenti; in un secondo significato, vuol dire conoscere le cose
particolari, e così lo intende Boezio quando dice che sensus est particularium et intellectus universalium; in un
terzo significato, vuol dire ricevere, mediante un organo corporeo, astratte dalla materia, le specie esistenti
nella materia stessa. Bonaventura dice che nei due primi significati il senso si distingue dall’intelletto solo
mentalmente (ratione), nel terzo anche realmente (re et ratione); in questo senso reale, il senso è, per
Bonaventura, una certa potenza legata al corpo.35 Benché inerisca al corpo, la potenza sensitiva è una facoltà
dello spirito.36 Essa si articola nei cinque sensi esterni che sono – si dice nell’Itinerarium – come cinque porte
attraverso le quali entrano nell’anima le conoscenze che riguardano ciò che appartiene al mondo sensibile. I
cinque sensi corrispondono agli elementi semplici costituenti l’universo sensibile (quattro epr il mondo
sublunare e una quinta essenza o sostanza per i corpi luminosi). Alla quinta essenza corrisponderebbe il
senso della vista; all’aria l’udito; al fuoco e ai suoi vapori l’odorato; all’acqua e agli umori connessivi il gusto;
alla terra il tatto.37
Bonaventura nell’Itinerarium afferma che per mezzo dei cinque sensi noi possiamo conoscere tutto ciò che
esiste nel mondo sensibile; nei Commentaria chiarisce il suo pensiero, rilevando che attraverso i sensi
possiamo conoscere non lre sostanze, le essenze delle cose, ma solo le qualità esteriori, anzi più precisamente
quelle qualità che Aristotele nelle Categorie chiama “passiones” e “possibiles qualitates”, ossia quelle qualità
che causano una passione sensibile o che sono da questa causate. Inoltre, seguendo Aristotele, Bonaventura
distingue, nell’Itinerarium, un oggetto proprio di ciascun senso (la luce e i colori per la vista, il suono per
l’udito, l’odore per l’olfatto, il sapore per il gusto, e le quattro qualità primarie per il tatto, cioè il caldo e il
freddo, l’umido e il secco, in quanto qualità “oggettive” degli elementi) e un oggetto comune (il numero, la
grandezza, la figura, la quiete e il moto).
Riguardo al processo della sensazione, Bonaventura nell’Itinerarium dice che le cose sensibili sono
percepite dai sensi non nella loro sostanza ma nelle loro similitudini o immagini, che provengono dalle cose
stesse e, passando attraverso la sostanza che separa il soggetto e l’oggetto, proseguono fino al senso interno e
alla potenza apprensiva che è in grado di accoglierle. Tali immagini non hanno nulla di materiale e, d’altra
parte, non sono semplici modi dell’anima, oppure sono fornite di una natura sostanziale intermedia tra la
semplice materia e l’intelligibilità pura.Esse sono dei modi di essere: sono appunto i modi di essere percepite
delle cose. Bonaventura concepisce tali modalità oggettivamente, come immagini prodotte dagli oggetti;
invece Tommaso d’Aquino, interpretando rettamente la specie sensibile di Aristotele, la considera come una
modificazione che l’oggetto produce nella coscienza attraverso l’atto della sensazione.38 In questo modo,
sviluppata nel secolo scorso trae origine dalla polemica sull’ontologismo rosminiano ed è alimentata da avversari del
rosminianesimo, il quale comprende motivi bonaventuriani.
35
Primis duabusmodis non differt sensus ab intellectu re sed ratione tantum. Tertio vero modo differt potentia
sensitiva ab intellectiva re et ratione, et illo tertio modo sensu est potentia alligata corpori. (In II Sent., d. 8, p. 1, a. 3,
q. 2, ad 4).
36
Anima habet potentias sensitivas, illa ipsam, quae rationalis est (In IV Sent.).
37
Itaque cum quinque sint corpora simplicia, scilicet quatuor elementa et quinta essentia, ut homo omnes formas
corporeas posset percipere, quinque sensus habet illis corrispondentes; quia multa fit apprehensio nisi per aliquam
similitudinem et convenentiam organi et obiecti, pro eo quod sensus est natura determinata (De red., n. 3). Bonaventura
cita un passo del terzo libro del De Genesi ad Litteram di Agostino, per mostrare che la potenza sensitiva si trova in
tutta la sua purità nel senso della vista, mentre si trova mescolata all’aria nell’udito, ai vapori di fuoco nell’odorato, agli
umori liquidi nel gusto, ai corpi solidi nel tatto. Ma veramente Agostino in quel passo intende spiegare semplicemente
come l’anima, che è di natura spirituale, possa venire a contatto con le cose materiali e così avere le varie sensazioni, e
afferma che l’anima giunge agli elementi materiali attraverso l’elemento meno materiale che è la luce, che dunque
l’anima dapprima si mette in contatto con la luce e attraverso di essa mediante i diversi sensi si unisce agli altri elementi
materiali, producendo così le varie sensazioni. Invece Bonaventura interpreta troppo letteralmente la dottrina per cui il
simile si conosce per mezzo del simile. Aristotele afferma che è l’atto della sensazione che produce la somiglianza, anzi
l’identità, tra senso e sensibile (De anima, B 5, 417 a, 20).
38
Aristotele concepisce l’azione dell’oggetto sul senso e l’attività della potenza sensitiva non come due atti distinti e
perciò separatamente completi, ma come gli elementi di un unico atto, che costituisce la sensazione. Bonaventura,
invece, concepisce l’azione dell’oggetto sensibile come una produzione di immagini, le quali sono accolte dallo spirito,
cui è attribuita la vera attività: egli afferma che non basta la produzione delle immagini perché avvenga la sensazione,
ma che questa si ha quando la potenza sensitiva si rivolge all’immagine giunta ad essa e ne prende possesso,
trasformandola in specie sensibile. In questo senso, la produzione dell’immagine da parte dell’oggetto rientrerebbe
Bonaventura intende salvaguardare l’oggettività dell’apprensione sensibile: questa, infatti, riguarda
l’impossessarsi delle immagini oggettive (che corrispondono alle qualità e alle forme reali) delle cose da
parte della facoltà conoscitiva dell’anima. Questa facoltà non produce da sé le immagini stesse, ma le porta
alla conoscenza, in quanto solo essa produce sapere.39 Le immagini passano dall’oggetto al senso esterno, da
qui al senso interno e quindi alla potenza apprensiva, la quale ha la funzione di fondare le specie sensibili in
quanto oggetto di conoscenza sensibile. Bonaventura, tuttavia, ammette che la potenza apprensiva è già
presente nei sensi: “in sensibus alia est potentia quae videt et alia quae videt se videre, quod similiter debeat
esse in intellectu” (In I Sent.). I sensi riconoscono le sensazioni che attraverso di essi vengono a profilarsi. La
potenza non semplicemente apprensiva, bensì riflessiva e giudicativa appartiene all’anima, la cui prima
facoltà è costituita proprio dal senso interno.40 Basata sul senso comune è l’immaginazione o “phantasia”,
cioè la facoltà di produrre immagini fantastiche, connettendo elementi sensibili. La fantasia si trova connessa
intimamente a un’altra facoltà che assume un ruolo fondamentale nella conoscenza, cioè alla memoria.
Bonaventura, esplicitando nei Commentaria la dottrina agostiniana della memoria, rileva che questa facoltà
non solo conserva le immagini sensibili e le idee dell’intelletto, ma contiene le idee innate. In tal modo, essa
accoglie e conserva tutti gli elementi della conoscenza. Come facoltà delle idee innate, essa antecede l’azione
dell’intelletto stesso e si presenta come facoltà originaria e fondamentale del conoscere, in quanto contiene
gli elementi essenziali della conoscenza, cioè quelle “categorie” mentali che condizionano ogni ulteriore
fondazione conoscitiva, compresa la stessa intuizione sensibile.41
La memoria come facoltà delle idee innate o dei princìpi fondamentali della conoscenza è una facoltà già
libera da ogni legame coi sensi e dunque si caratterizza come facoltà intellettuale. Dunque essa costituisce
una particolare potenza o energia della facoltà intellettiva. Infatti le varie facoltà intellettuali non
rappresentano altro che energie o funzioni della stessa facoltà intellettiva, unica e indivisa. Tra le funzioni o
energie della facoltà intellettiva, Bonaventura enumera: la ragione, che conosce l’anima e le altre sostanze
spirituali; l’intelletto, che conosce i primi princìpi; l’intelligenza, che contempla Dio; infine l’apex mentis o
notitia excessiva, che è la facoltà più eccellente e in sé riunisce le altre funzioni, costituendosi in tal modo come
facoltà che tutto conosce e si identifica con la facoltà intuitiva della conoscenza mistica (excessus mentalis et
misticus).
Bonaventura ammette la distinzione aristotelica di intelletto agente e intelletto possibile. Esaminando la
questione Utrum intellectus agens et possibilis sint una potentia an diversae, egli espone le diverse opinioni in
proposito: alcuni considerano le due facoltà come due sostanze, altri come due potenze, altri come abito e
potenza, altri come potenza assoluta e relativa (comparata).
La prima opinione si richiama al neoplatonismo ed è quella di Avicenna: l’intelletto agente è considerato
come intelligenza separata, che illumina l’intelletto possibile che è l’anima umana. Bonaventura rifiuta tale
opinione, in quanto non può ammettere che una sostanza creata quale sarebbe l’intelletto agente possa
illuminare l’anima umana. Egli confuta l’opinione che identifica l’intelletto agente con Dio e ritiene che
nell’ambito dei processi fisici; e l’azione spirituale si rivolgerebbe all’immagine già di per sé formata (e non, invece,
come già avvertiva Aristotele e come ritiene Tommaso) concorrerebbe a formarla.
39
In ciò Bonaventura segue Plotino e S. Agostino: il primo (Enneadi, IV, 4) avverte che le immagini sensibili sono
colte dall’anima, che, perciò, non è impressionata da esse; l’altro ribadisce che le immagini sono oggettive e
appartengono ai corpi come forme di essi, che l’anima è capace di captare.
40
Bonaventura dà una descrizione di questa facoltà nel I capitolo dell’Itinerarium, dove distingue la “sensualitas”, lo
“spiritum” e la “mens”, e, in un’altra classificazione, il “sensus”, l’“immaginatio”, la “ratio”, l’“intellectus”,
l’“intelligentia” e l’“apex mentis”. Per Bonaventura, ognuna delle prime tre facoltà si gemina dando luogo alle sei
facoltà della seconda classificazione. Tali sono le potenze conoscitive dell’anima, tutte insieme concorrenti a costituire
la facoltà d’apprensione. S. Tommaso distingue le facoltà interiori in senso comune, fantasia, estimativa e memoria.
Egli, seguendo specialmente Avicenna, considera tali potenze sensitive interne come entità essenzialmente distinte tra
loro e dall’essenza dell’anima. Bonaventura, seguendo Agostino e partendo dal principio della semplicità dell’anima,
considera le potenze come semplici funzioni o attività e perciò identiche all’anima nell’essenza.
41
“Memoria […] retinet nihilominus scientiarum principia et dignitates ut sempiternalia et sempiternalitur, quia
nunquam potest sic oblivisci eorum, dum ratione utatur, quin ea audita approbet et eis assentiat, non tamquam de novo
percipiat, sed tanquam sibi innata et familiaria recognoscat” (Itinerarium, cap. 3, n. 2).
anche l’anima umana sia dotata di una potenza attiva e dunque di intelletto agente: infatti ad essa è stata
data la facoltà di compiere atti d’intendere.42
Discutendo l’opinione che considera i due intelletti come due potenze, Bonaventura osserva che non è da
ritenere l’intelletto possibile come facoltà puramente materiale e passiva e che invece, invece che due
modalità intellettive, sono da considerarsi come due energie della medesima potenza. Né l’intelletto
possibile è semplicemente passivo, in quanto esso deve giudicare le specie che sono contenute nelle
immagini sensibili e riconoscerle; così come d’altra parte l’intelletto agente non è da ritenersi puramente in
atto, in quanto esso subisce anche in qualche modo l’azione delle immagini sensibili dalle quali sono astratte
le specie (idee) che esso pure deve accogliere come elementi della propria attività conoscitiva.
Riguardo all’opinione che considera l’intelletto agente come un abito o una condizione e l’intelletto
possibile come una potenza, Bonaventura osserva che l’opinione che considera l’intelletto agente come
quello che possiede tutte le conoscenze in atto (come tale è da ritenersi se si considera come la potenza che è
capace di far passare all’atto l’intelletto possibile) contrasta con la tesi aristotelica dell’anima come “tabula
rasa”, che non contiene in atto nessuna conoscenza che non venga acquisita attraverso l’esperienza e
inizialmente attraverso i sensi. Invece Bonaventura si dichiara disposto ad ammettere l’opinione che
considera l’intelletto agente come una certa energia che ha la potenza non solo di ricevere le idee ma anche
di produrle in se stessa: l’intelletto agente, in tal modo, può essere considerato come quella luce che fa
passare all’atto le idee, come la luce fa passare all’atto la percezione dei colori. Con ciò, Bonaventura non
accoglie semplicemente la tesi aristotelica che ogni idea deriva dall’esperienza, ma solo intende dire che i
contenuti di conoscenza non sono tutti allo stato attuale nell’anima, la quale contiene solo quei princìpi che
abbiamo visto costituire la struttura stessa della memoria come facoltà dei princìpi innati del conoscere;
innate non sono tutte le idee, e dunque anche le idee che costituiscono le specie di cose sensibili, ma solo
alcuni princìpi fondamentali del conoscere, come ad esempio le idee di “maggiore”, “minore” e così via, che
costituiscono non idee determinate ma princìpi generali secondo cui è fondato ogni conoscere intellettuale.
Riguardo all’opinione che considera l’intelletto agente come potenza intellettiva in sé e quello possibile
come potenza intellettiva unita al corpo, Bonaventura osserva che essa appare insotenibile, perché l’intelletto
possibile si trova anche nelle anime separate. Egli insiste nel ritenere le due modalità intellettive come due
diversi aspetti della medesima potenza intellettiva; e considera l’intelletto agente come la facoltà atta ad
astrarre e a giudicare le idee e l’intelletto possibile come la facoltà atta semplicemente a riceverle. Si può dire
solo che l’intelletto possibile compete all’anima in quanto destinata a stare unita al corpo, in quanto esso non
è atto a conoscere per se stesso ma solo mediante l’aiuto dei sensi. Invece l’intelletto agente è già abilitato a
conoscere per se stesso ed è sempre in grado di intendere.
Bonaventura ammette anche la distinzione tra l’intelletto risolvente e l’intelletto componente: l’uno
procedente dall’astratto al concreto, l’altro dal particolare e concreto all’universale e astratto. Egli osserva,
peraltro, che non si tratta di due potenze distinte, poiché è attraverso la medesima potenza che lo spirito
umano accede dal concetto individuale all’idea più universale e discende da questa a quello. Bonaventura
osserva che compito dell’intelletto risolvente è anche quello di mettere in rapporto tra loro le idee e di
pervenire alle cause: pertanto, la conoscenza di una cosa è conseguita quando si conoscono i rapporti di essa
con le altre, in modo da risaltino le idee che indicano le cause dell’oggetto in questione. Così questo intelletto
è definito come comparans ad causas. Invece attraverso l’intelletto apprendente noi possiamo conoscere una
cosa, senza avere per questo la conoscenza della sua causa. L’intelletto risolvente è quello che dà la vera
conoscenza: esso comprende la conoscenza di tutte le cose e Bonaventura dice che esso, perché possa perfecte
resolvere cioè giungere al perfetto concetto di una cosa, deve giungere alla conoscenza dello stesso ente primo
e perfettissimo.
Anche la distinzione tra intelletto speculativo e pratico non è intesa da Bonaventura in senso dualistico: in
realtà si tratta sempre del medesimo intelletto, che è pratico quando non persegue la conoscenza del vero ma
semplicemente dirige l’azione sulla base dell’idea di bene, è speculativo quando persegue finalità di pura
conoscenza. Come pratico, l’intelletto, in quanto influenzato dalla volontà, può cadere in errore.
42
Bonaventura rileva che codesta opinione, d’intendere l’intelletto agente come Dio stesso e l’intelletto possibile
come l’anima umana, si collega a quanto dice Agostino, che Dio è la luce che illumina la nostra anima, il maestro che ci
insegna, la verità che ci dirige. E aggiunge che tale atto di fede in Dio come luce che ci illumina non contrasta però con
l’ammettere una potenza attiva nell’anima umana; infatti, come a tutte le creature è data una potenza a compiere atti
determinati e consoni alla natura di ciascuna di esse, così all’uomo è data la potenza o facoltà attiva d’intendere
(potentia ad intelligendum); sicché è da ritenere che Dio stesso abbia attribuito al’anima umana non solo l’intelletto
possibile ma anche quello agente: Sic credendum est indubitanter quod animae humanae non tantum modo dederit
intellectum possibilem, sed etiam agentem, ita quod uterque est aliquid ipsius animae (In II Sent.).
Una ulteriore distinzione è quella tra ratio superior e ratio inferior.43 La ratio inferior riguarda lo spirito in
quanto si rivolge alle cose sensibili, mentre la ratio superior è rivolta alle leggi eterne e alle immutabili idee
divine. Spetta a questa reggere e governare l’altra. Tuttavia essa non è infallibile; quando giudica secondo le
leggi eterne, rivolgendosi a Dio, non può errare; invece può errare quando giudica secondo i suoi poteri
naturali e secondo le conoscenze che apprende dai sensi.44
Bonaventura afferma che non solo conoscere il bene per farlo ma che è necessario amare la verità per
conoscerla, che cioè la volontà non è solo principio d’azione ma anche principio di conoscenza. Egli ammette
un fondamentale influsso della volontà sulla ragione; sicché la volontà è la facoltà principale e dominatrice
di tutte le altre.
Nella sua concezione della volontà, Bonaventura raggiunge posizioni di notevole originalità. Egli
concepisce la volontà come facoltà autonoma, la cui essenza e qualità distintiva è la libertà. Per libertà,
infatti, egli intende la virtù che la volontà ha di determinare e muovere se stessa, dunque la facoltà d’essere
determinato nell’autonomia. Non si tratta della “libertà d’indifferenza”, cioè della facoltà di poter volere
cose qualsiasi, ma della capacità di autodeterminazione: la libertà, cioè, non indica l’assenza di ogni
determinazione, ma solo di quel tipo di determinazione che proviene dall’esterno da forze e istanze estranee
allo spirito. L’unica determinazione della volontà è quella che proviene da se stessa, in quanto essa è la
facoltà di potersi regolare secondo leggi proprie. iN tal modo la libertà si profila nell’ambito della necessità,
cioè di quel modo di determinazione che è intrinseco ad essa medesima. Bonaventura pone per la prima
volta il tema della complementarità di libertà e necessità: il concetto di libertà contrasta con quello di
costrizione ma non con quello di necessità. Dio ama liberamente e necessariamente se stesso, così come
l’uomo vuole liberamente e necessariamente il proprio bene. La volontà, dice Bonaventura con accenti che
preludono a quelli kantiani, sfugge al principio di causalità, il quale è valido per il mondo fisico. La volontà è
essa medesima principio creativo dei propri atti e in sé contiene la ragione del suo deliberare; mentre nel
mondo fisico la ragione del versificarsi di un fatto o di un fenomeno consiste in una causa che dall’esterno lo
condiziona o lo produce, nella sfera della volontà umana nessuna causa esterna condiziona o determina le
azioni. Il principio di spiegazione delle azioni sta nella volontà stessa. Tuttavia, sebbene interamente
determinata da sé medesima, la volontà umana non è pienamente libera, ma in essa permangono residui
esteriori che giustigficano comre essa possa talvolta volgersi all’errore e scegliere il male.
Il concetto di volontà come autonomia è fondato per la prima volta speculativamente da Bonaventura. E
analogamente egli fornisce la prima fondazione razionale del principio credo ut intelligam. Il raggiungimento
della verità non è opera della pura ragione, ma implica l’impegno totale della volontà, la quale deve
innanzitutto scegliere la verità e determinare l’azione del conoscere; infatti il conoscere è un’attività che
come tale ha la sua radice non in qualche causa estrinseca alla volontà ma nella volontà medesima. In questa
sta la radice di ogni azione e perciò anche del conoscere, che è un particolare tipo di azione, cioè l’azione
dell’intelletto rivolto alla comprensione della verità.45
43
Tale distinzione è ripresa da Agostino, il quale contrappone alla ratio inferior, quae intendit temporalibus alla ratio
superior, quae intendit aeternis conspiciendis et consulendis e alla quale compete iudicare de istis corporalibus
secundum rationes incorporales et sempiternas (De Trinitate, XII, 7 e 2).
44
Quamvis aspiciendo ad leges aeternas non peccat iudicando, tamen secundum ea quae percipit a sensibus, vel
etiam secundum lumen sibi datum et innatum potest dificere et errare, maxime in statu naturae lapsae (In II Sent.). La
ragione, per giudicare in base al lume divino, deve essere evidentemente sorretta dalla fede. Infatti dice ancora
Bonaventura: Ratio in inquirendo dupliciter potest procedere: aut prout est adiuta ratio fidei, et sic procedit aspiciendo
ad causas superiores; aut prout iudicio proprio relicta est, et sic procedit inspiciendo ad naturas et causas inferiores;
aquisit enim scientiam per via sensus et experientiae (In II Sent.).
45
Prima di Bonaventura, Agostino aveva già posto il problema, dando quella definizione della volontà come
autonomia, che doveva essere ripresa e fondata speculativamente da Bonaventura: Voluntas est motus animi cogente
nullo, ad aliquid vel non admittendum vel adipiscendum. La volontà non è determinata da nessuna causa, ma essa
medsima è la causa del suo determinarsi. Agostino, anzi, aveva spinto il suo volontarismo fino ad affermare che son
solo la volontà è la facoltà delle spirito superiore a tutte le altre e dominatrice di tutte le altre, ma che niente possediamo
di veramente nostro all’infuori della volontà, la quale in tal modo è la stessa essenza dell’uomo come essere libero.
Bonaventura si colloca nella linea del volontarismo che da Agostino, passando per molta parte della filosofia medievale,
specialmente per la scuola di S. Vittore, giunge a Duns Scoto e Guglielmo di Occam. Egli, in codesta questione
dell’influenza della volontà sull’intelletto, discorda notevolmente da Tommaso d’Aquino, il quale considera la libertà
come “indifferenza” a scegliere tra opposti o diversi, restringendola agli atti contingenti e ai soli mezzi, come egli dice,
e non la estende anche al fine. Inoltre, Tommaso, seguendo i princìpi intellettualistici della dottrina aristotelica,
considera l’intelletto come la facoltà più nobile dello spirito e ammette che esso determina causalmente anche la
volontà. Egli afferma che la causa della libertà è la ragione, in quanto la libertà è condizionata dalla conoscenza del
bene, cioè dal fatto che la ragione può formarsi diversas conceptiones boni: Radix libertatis est voluntas sicut
La fede, per Bonaventura, non è determinata dalla ragione, ma è una certezza immediata, riconosciuta
dalla volontà come essenziale autonomia e libertà. E nei Commentaria egli distingue una certezza scientifica
fondata sulla speculazione e dunque sull’intelletto e una certezza di adesione fondata sulla libertà ed
essenziale per la fede. La fede, per Bonaventura, non segue la ragione, ma la precede, non è il punto di arrivo
ma il punto di partenza dell’indagine filosofica. L’unico scopo della filosofia è quello di permettere di
intendere ciò che si crede per fede, dunque ha uno scopo complementare rispetto alla forma di conoscenza
fondamentale che è quella determinata dall’assenso. La volontà si profila, così, in tutta la sua portata
gnoseologica: essa condiziona la fede e determina l’assenso a ciò che deve essere creduto. E’ la volontà la
fonte della conoscenza fondamentale, che è quella fondata su una certezza non dimostrata razionalmente ma
“sentita” in virtù di un lume interiore che rivela immediatamente i contenuti di verità.
Per quanto riguarda la conoscenza intellettuale, Bonaventura concepisce l’azione dell4ontelletto agente
come una continuazione di quella compiuta dalla facoltà sensitiva; egli ritiene che l’astrazione dell’idea, per
cui avviene la conoscenza, si compia già in un certo grado attraverso la stessa intuizione sensibile, la quale
capta l’immagine, che poi, per l’azione dell’intelletto, diventa specie intelligibile, cioè idea. Agostino aveva
distinto le specie sensibili e quelle intelligibili, affermando tuttavia che tutte si trovano nell’anima e non
provengono dall’esterno; Bonaventura chiarifica il rapporto che corre tra i due tipi di “idee” o “forme” delle
cose, concependo, sulla traccia di Aristotele, la specie intelligibile come una elaborazione e successiva
depurazione della specie sensibile.46 Per Bonaventura, l’astrazione dell’idea implica un atto di giudicare, in
quanto deve discernere tra i vari elementi dell’immagine sensibile, traendone solo quelli essenziali, che
concorrono alla formazione dell’idea. Egli definisce, pertanto, l’astrazione come una specie di giudizio e
chiama naturale iudicatorium l’intelletto agente, facendo inoltre coincidere l’astrazione con la diiudicatio,
definita nell’Itinerarium come quella operazione quae speciem sensibilem, sensibiliter per sensus acceptam introire
facit depurando et abstrahendo in potentiam intellectivam.47
Nel capo terzo dell’Itinerarium, Bonaventura, dopo avere distinto le tre potenze dell’anima e cioè
memoria, intelletto e volontà, procede alla distinzione delle diverse operazioni dell’intelletto, definendole
come percezione o formazione di concetti, giudizio e raziocinio.
A proposito della percezione come formazione dei concetti, Bonaventura dice che essa ci permette di
definire il quid est delle cose, cioè i concetti specifici delle stesse, e osserva che si possiede il concetto di una
cosa quando se ne conosce la definizione, rilevando inoltre che questa avviene solo sulla base di concetti più
universali di quelli di cui si ricerca la definizione. Perciò egli conclude che la definizione piena e completa di
una sostanza si ha quando si conosce che cosa sia l’ens per se, cioè quando si possiede il concetto
generalissimo e supremo: non è possibile giungere al concetto di alcun ente creato se non attraverso il
concetto dell’ente assoluto, la cui definizione comprende la ragione dell’essenza di tutte le cose. Bonaventura
afferma che l’intelletto non può conoscere che un tale ente è imperfetto se non conosce innanzitutto l’ente
nella sua perfezione assoluta.48 Perciò la conoscenza dell’ente assoluto è la condizione indispensabile per la
subiectum; sed sic causa est ratio; ex hoc enim voluntas libere potest ad diversa ferri, quia ratio potest habere diversas
conceptiones boni (Summa Theol., p. I-II, q. 17, a. 1, ad 2). La libertà, in tal modo, è limitata alla scelta tra diversi
aspetti del bene; essa cioè si esplica quando la ragione presenta oggetti come buoni sotto un aspetto e non buoni sotto un
altro; mentre non ha bisogno di esplicarsi quando l’oggetto è presentato dalla ragione come buono sotto tutti gli aspetti.
In effetti, quello professato da Tommaso è un intellettualismo deterministico: infatti la volontà segue necessariamente
ciò che la ragione le presenta come bene; e la ragione è considerata come l’unica retta guida dello spirito umano.
L’intento di Tommaso, così, è quello di mostrare l’accordo della ragione con la fede, riconoscendo il ruolo preminente
della ragione e ricercando la via secondo la quale la ragione conduce alla fede. Perciò egli cerca di rovesciare la tesi di
Anselmo d’Aosta, mutando il credo un intelligam in intelligo ut credam. Ma, allorché la fede è ricondotta al sapere,
essa cessa di essere sé medeima per identificarsi col sapere: infatti, quando è per me razionalmente necessario credere in
qualcosa, allora io non credo semplicemente ma so, so che quel qualcosa è tale quale la fede lo presenta, che cioè quel
qualcosa è vero nel modo che la fede me lo insegna. In tal modo l’assenso di fede è subordinato alla ragione,
all’evidenza razionale, e non richiede la grazia, sicché è annullato ogni merito del credente, in quanto non è meritoria
l’adesione a una verità la cui evidenza è fornita dalla ragione.
46
Aristotele attribuisce l’attività dell’intendere all’intelletto agente, che è “separato” dal soggetto. Tale intelletto,
benché agisca nell’anima umana, non coincide con una facoltà di essa, e anche se non è trascendente non si identifica
con l’anima, che è, da parte sua, corruttibile e mortale, mentre l’intelletto agente è immutabile nella sua pura forma.
Tommaso, invece, tenterà di interpretare il pensiero di Aristotele, affermando che anche per costui l’intelletto agente è
aliquid animae.
47
Per Tommaso l’astrazione è il primo atto intellettuale del nostro spirito; per Bonaventura essa richiede l’aiuto della
luce o verità eterna e cioè una conoscenza anteriore.
48
Quomodo autem sciret intellectus, hoc esse ens defectivum et incompletum, si nullam haberet cognitionem entis
absque omni defectu? (Itin., c. 3, n. 1).
conoscenza di ogni ente creato e finito: la conoscenza di Dio è fondamentale e da essa occorre partire per la
fondazione di ogni altra conoscenza.
Analogamente, per l’atto del giudicare, per cui noi formuliamo proposizioni, Bonaventura avverte che
possiamo dire di conoscere quando sappiamo con certezza che una proposizione è vera; ma ciò che fa vero il
nostro discorso non può essere un nostro criterio di giudicare, bensì può essere solo il principio della verità,
cioè Dio stesso in quanto “Logos”. La luce della verità proviene dall’essere, così come da questo proviene
ogni realtà.
Riguardo al terzo atto intellettuale che è il raziocinio (il ragionamento), Bonaventura osserva che noi
conosciamo veramente una conclusione quando vediamo che essa segue necessariamente da alcune
premesse. Anche qui si rimanda a Dio, in quanto ogni connessione relativa e contingente ha il suo
fondamento nella connessione delle idee divine, cioè nell’ordine stesso che Dio ha stabilito per tutte le cose.
Dio, infatti, oltre che essere assoluto, è fondamento di verità, l’essere che contiene in sé le ragioni o idee
immutabili di tutte le cose.
Bonaventura concorda interamente con Agostino, quando, nei Commentaria, parlando del modo in cui lo
spirito umano conosce Dio, dice che Dio è sempre presente nell’anima umana come verità e che dunque la
sua conoscenza è diretta e si consegue immediatamente, senza alcuna idea o similitudine intermedia. Egli,
inoltre, afferma che la mente umana raggiunge le idee divine delle cose (aeternas rationes attingit) e che tali
idee sono costitutive anche della nostra anima, nel senso che esse costituiscono l’oggetto immediato della
contemplazione in cui consiste l’atto costitutivo essenziale dell’anima stessa. Infatti Bonaventura ribadisce
ciò che dice Agostino, non solo, cioè, che noi conosciamo Dio perché egli è presente in noi, ma che la verità
divina passa da Dio all’uomo come l’immagine passa dal sigillo alla cera, in modo che l’intelletto umano non
tanto in Dio quanto in se stesso la vede e la contempla. La presenza stessa di Dio nell’anima caratterizza lo
spirito umano nel senso del possesso originario della verità: essa è il modo secondo cui gli uomini nel loro
stato terreno conoscono Dio; infatti gli uomini in tale stato di “via” non vedono l’essenza di Dio, ma
conoscono Dio solo in aliquo effectu interiori o per speculum et in aenigmitate, al’interno della propria anima, la
quale è veramente uno specchio che riflette l’essenza divina.49
Vediamo ora come Bonaventura intende la conoscenza in rationibus aeternis. Egli esamina tre modi di
intendere tale conoscenza. Il primo è quello per cui essa è fatta consistere nella contemplazione delle idee
archetipe. Bonaventura rifiuta questa interpretazione, perché in tal modo la nostra conoscenza non
differirebbe né dalla visione dei beati, né dalla conoscenza delle cose nel Verbo, né dalla conoscenza mistica
o sapientia, né da quella comunicata dalla rivelazione. Il secondo modo è quello di S. Tommaso, per il quale
la conoscenza in rationibus aeternis consiste nella semplice influenza o nel concorso di Dio. Bonaventura
rifiuta anche codesta interpretazione, in quanto ritiene che le idee divine non sono solo causa ma anche
oggetto di conoscenza. Rimane l’interpretazione dello stesso Bonaventura, secondo cui la nostra conoscenza
49
Secondo i critici del razionalismo e del panteismo, queste correnti deriverebbero da una errata interpretazione del
principio agostiniano della presenza di Dio nell’anima, cioè dalla confusione tra la ragione divina e la ragione umana. In
realtà, tale principio rappresenta un motivo di estrema valorizzazione dell’uomo, inteso come l’ente che reca in sé
l’immagine di Dio ed è costitutivamente rivolto a conoscere la verità come svelamento del senso delle cose e
dell’esistenza. Perciò gran parte della speculazione ulteriore è ispirata a questo nucleo di pensiero. Il Cusano, ad
esempio, osserva che l’uomo è un dio umano, cioè un aspetto della stessa essenza divina: Homo enim Deus est, sed non
absolute, quoniam homo. Humanus est igitur Deus. Est igitur homo
H , aut humanus quidam
mundus. Regio igitur ipsa humanitatis, Deum atque universum mundum, humanali sua potentia ambit (De coniecturis,
II, 4). Ficino nella Theologia platonica afferma che Dio non è estraneo all’intelletto umano, ma è intimo ad esso, anzi è
il fondamento di ogni intelligibilità, cioè il principio, il mezzo e il fine di tutta la nostra attività intellettuale. L’intelletto
trae la sua fondamentale grandezza e dignità dal fatto di essere sede dell’illuminazione divina e poiché accoglie in sé la
medesima essenza divina. Bruno, poi, rileva che Dio è più intimo a noi che noi a noi stessi e che dunque in noi
dobbiamo ricercare e possiamo trovare la verità assoluta. Cartesio, da parte sua, afferma che l’idea di Dio è fondamento
di ogni certezza. Analoghi rilievi troviamo nei filosofi di Port-Royal, in Pascal, in Fenelon. Quest’ultimo in modo
particolare riproduce lo stile agostiniano, quando si richiama a “questo maestro interiore, che ci fa agire, ci fa parlare, ci
fa credere, ci fa dubitare, ci fa riconoscere i nostri errori o confermare i nostri giudizi, e la cui voce si fa sentire da una
estremità all’altra dell’universo: questa ragione perfetta, che così vicina a noi e così differente da noi, questa ragione
che è Dio medesimo” (Trattato dell’esistenza di Dio, I, 2). Anche Leibniz afferma che noi conosciamo l’essere perché
l’essere è in noi e che le monadi contengono la rappresentazione di tutto l’universo, in quanto tale rappresentazione è
impressa in esse da Dio fin dalla loro creazione; e che dunque l’intera verità esiste già nell’anima e che a noi non resta
che scoprirla, trarla alla luce e svilupparla. Infine il Labertonnière dice che “la conoscenza dell’essere non ci viene dal
di fuori” e che “per conoscere l’essere fuori di sé bisogna cominciare a conoscerlo in se stessi”. La concezione
agostiniana e bonaventuriana dell’interiorità del vero culmina, infine, nella dottrina di Giovanni Gentile e
nell’affermazione che la verità è lo spirito medesimo.
intellettuale (scientia) richiede l’intuizione delle idee divine, le quali tuttavia non costituiscono l’oggetto
immediato della conoscenza ma solo lo stimolo che muove e guida l’intelletto a trarre dalle immagini
sensibili le idee che permettono la conoscenza delle cose in proprio genere.
Bonaventura mostra qui il suo tentativo di conciliare Agostino con Aristotele: le idee divine non
costituiscono l’oggetto immediato della conoscenza ma la regola secondo cui l’intelletto astrae le idee
proprie delle cose; la conoscenza, in quanto conoscenza umana delle cose, differisce dalla visione divina che
appartiene al Logos; essa non è un fatto immediato ma è il risultato di un processo complesso di astrazione.
Bonaventura ammette come innata non l’idea della cosa già formata, ma solo la norma per formarla; quindi
ogni conoscenza è il risultato di un’attività dello spirito umano, che si esplica come potenza di astrazione.
L’intelletto raggiunge la certezza in virtù di quella norma immutabile che possiede in se stesso e che si
costituisce come intuizione originaria della verità. 50
Occorre ora vedere come Bonaventura concepisce la formazione dei concetti che riguardano gli enti
particolari. Matteo d’Acquasparta, seguace di Bonaventura, nella questione Utrum intellectus humanus
intelligat singularia osserva che la conoscenza dell’ente singolo precede la formazione dei concetti universali,
che cioè l’intelletto, per potere procedere nella formazione di concetti più generali da concetti particolari,
deve conoscere le cose nella loro singolarità. Ma Bonaventura nei Commentaria afferma che l’intelletto umano
non può conoscere il singolare, poiché la conoscenza intellettuale è conoscenza per concetti e i concetti sono
il risultato di un processo di astrazione che conduce sempre al superamento del particolare come tale e alla
formazione di concetti universali. La conoscenza dei particolari avviene attraverso la stessa conoscenza degli
universali; non è possibile una semplice conoscenza empirica che colga il particolare nella sua immediata
costituzione, ma la conoscenza procede sempre in una direzione che comprende correlativamente i princìpi
universali e i termini particolari: così, ad esempio, il tutto e la parte si conoscono sulla base del principio che
il tutto è maggiore della parte, e, correlativamente, non si comprende adeguatamente tale principio se non si
conoscono che cosa siano il tutto e la parte; il tutto e la parte sono conosciuti sulla base di un principio
universale, che esige e comprende la conoscenza dei termini ai quali si riferisce. In tal modo Bonaventura
può dire nei Commentaria chei princìpi sono in certo modo innati e in certo modo acquisiti, innati ratione
luminis, acquisiti ratione speciei. L’esperienza non è necessaria per conoscere i princìpi, che in tal modo sono
innati, ma è necessaria per conoscere i loro termini, e, indirettamente, costituisce un elemento fondamentale
della stessa conoscenza dei princìpi. Vi sono, tuttavia, princìpi i cui stessi termini sono conoscibili senza
bisogno dell’esperienza, come ad esempio il principio morale che si deve amare e temere Dio. Conoscenza
dei princìpi e conoscenza dei termini ai quali si riferiscono sono complementari.
Riguardo alla conoscenza dell’anima, Bonaventura segue Agostino, il quale afferma che l’anima è
presente a se stessa e conosce se stessa senza bisogno di alcuna idea intermedia, sicché si può dire che è nello
stesso tempo il conosciuto e il conoscente; e così afferma che nell’anima razionale è innata la conoscenza di
50
Bonaventura osserva che sia Platone che Aristotele non sono riusciti a integrare adeguatamente la propria dottrina
della conoscenza: il primo per non avere avvertito l’esigenza dell’esperienza sensibile come aspetto fondamentale del
processo conoscitivo, il secondo per avere, al contrario, ritenuto questa esperienza come sufficiente a fornire la
conoscenza certa. Invece il filosofo che ha saputo evitare l’unilateralità dei due massimi filosofi antichi è Agostino, il
quale ha fatto posto sia all’intuizione che all’esperienza sensibile, riuscendo così a fondare una integrale teoria della
conoscenza. E in effetti tutti i pensatori medievali hanno avvertito l’esigenza di una conciliazione di Platone e Aristotele
attraverso la rivalutazione delle istanze gnoseologiche dell’esperienza e dell’intuizione immediata: basti ricordare i
nomi di Anselmo d’Aosta e di Gilberto de la Porrée. Anche per Agostino la sensazione costituisce un fattore
fondamentale della conoscenza: essa non semplice occasione per suscitare il ricordo delle idee, ma è elemento attivo per
la formazione delle idee stesse. La certezza sensibile, in questo senso, è un grado della verità ed è l’ambito proprio della
conoscenza della realtà materiale. Bonaventura approfondisce questa prospettiva, ponendo nell’esperienza sensibile la
fonte del materiale della conoscenza e nell’intuizione delle norme intellettuali la forma che dà a quel materiale la
consistenza della verità, per cui tale conoscenza riguarda non solo aspetti fenomenici delle cose ma la stessa realtà
sostanziale. Per Rosmini l’idea dell’essere è la forma della coscienza, in quanto costituisce la stessa essenza dello spirito
come capacità intelligente; essa è la forma o struttura formale dell’intelletto, per cui questo è in grado di comprendere la
stessa essenza delle cose. A questo proposito, si deve rilevare una differenza rispetto a Bonaventura, per il quale l’idea
di Dio non si identifica con la struttura formale dell’intelletto ma è solo una idea il cui possesso rende possibile la
comprensione di ogni altra verità relativa all’essenza di ogni altro ente. Bonaventura, infatti, oltre quella averroistica,
rifiuta anche la teoria di quegli agostiniani che identificavano l’intelletto agente con Dio, nei Commentaria rileva che
l’idea di Dio rende più perfetta l’anima: questa idea non costituisce la struttura o il principio formale medesimo che dà
la capacità di conoscere, ma essa medesima si costituisce come oggetto di conoscenza e suppone che nell’intelletto che
la intuisce vi sia originariamente una tale capacità o potenza conoscitiva.
se stessa, 51 e aggiunge che l’anima conosce se stessa attraverso un atto solo. Tuttavia, questa conoscenza non
è sempre in atto, ma costituisce una possibilità, che per realizzarsi esige che l’anima si rivolga a se stessa e
pensi a sé, ossia implica un atto di riflessione. Ma si tratta di una conoscenza diretta e non indiretta, come
afferma invece Tommaso, il quale sostiene che l’anima si conosce attraverso i propri atti. Conoscendo se
stessa, l’anima conosce anche le cose che sono in essa, come la fede e tutte le modalità spirituali, tranne
alcune, come la grazia, che trascendono le sue capacità.52
Bonaventura distingue una conoscenza per comprehensionem, che consiste nell’aabbracciare con l’intelletto
tutto l’oggetto che si deve conoscere, e una conoscenza per apprehensionem, che consiste semplicemente nel
raggiungere la verità intorno all’oggetto in questione. E’ chiaro che solo quest’ultimo tipo di conoscenza è
dato all’uomo avere di Dio: l’anima umana, essendo finita, non può conoscere adeguatamente Dio, che è
infinito, ma può conoscerlo solo inadeguatamente, seppure con verità.53 Noi non conosciamo la semplice e
assoluta perfezione di Dio, ma fondiamo la nostra conoscenza, attribuendo a Dio stesso caratteri di
perfezione che desumiamo dalla nostra natura e dal campo delle nostre conoscenze e della nostra esperienza
in generale: ad esempio, attribuiamo a Dio una sapienza infinita e una potenza infinita, ma sappiamo che si
tratta di concetti inadeguati a esprimere l’autentica sostanza della divinità. Così anche Bonaventura, nel
cercare di determinare gli attributi di perfezione secondo cui pensare Dio, non fa che seguire il metodo
generalmente adottato dagli Scolastici e consistente nel rimuovere da Dio tutto ciò che è creato e quindi
imperfetto (per ablationem) e nell’attribuire a lui, in grado infinitamente superiore, tutte le perfezioni delle
creature (per excellentiam). La formazione del concetto di Dio, pertanto, avviene secondo una logica
particolare e un metodo specifico; essa segue il metodo dell’estensione all’infinito delle perfezioni e della
sottrazione delle imperfezioni, cioè dell’estensione all’infinito di alcuni concetti e nell’eliminazione di altri.
Riguardo al modo in cui noi arriviamo a conoscere l’esistenza di Dio, Bonaventura, nella questione Utrum
Deus sit cognoscibilis per creaturas, scrive che, siccome la causa risplende nell’effetto e la sapienza dell’artefice
si manifesta nella sua opera, Dio, che è causa del mondo e delle creature in esso comprese, per mezzo di
queste si conosce. Ciò, tuttavia, non compromette l’essenziale innatezza dell’idea di Dio: riconoscere Dio
attraverso le creature è possibile solo in quanto già si possiede quell’idea. Un secondo argomento
corrisponde essenzialmente alla nota dimostrazione che troviamo nella Summa Theologiae di Tommaso
d’Aquino: la cosa creata, essendo ens posterius, esige e suppone l’ens prius, essendo ens ab alio richiede l’ens
non ab alio, essendo ens possibile rimanda all’ens necessarium, essendo ens respectivum, diminutumpropter alid,
per partecipationem, in potentia, compositum, mutabile, esige l’ens absolutum, simpliciter, propter seipsum, per
essentiam, in actu, simplex, immutabile. E il terzo argomento si presenta come corrispondente alla nota prova a
priori o ontologica di Anselmo d’Aosta. Bonaventura rimane, tuttavia, fermo nella convinzione che la
conoscenza di Dio sia un fatto essenziale e originario e che tutte le prove non sono che una conferma
dell’idea di Dio originariamente presente nello spirito.54 La conoscenza di Dio dipende soprattutto dalla
volontà e dalla fede.55
51
Inserta est animae rationali notitia sui, eo quod anima sibi praesens est et se ipsa cognoscibilis (De Mysterio
Trinitatis, Quaest. I).
52
I problemi riguardanti la conoscenza dell’anima sono stati, poi, affrontati da Matteo d’Acquasparta nella questione
Utrum anima cognoscat semetipsam et habitus qui in esa sun, per essentiam suam an per actus tantum.
53
Si potrebbero riscontrare nella dottrina della conoscenza di Bonaventura alcune manchevolezze e contraddizioni.
Ad esempio, Bonaventura non dimostra l’esistenza nel nostro intelletto dell’idea dell’essere assoluto; e dunque il
presupposto di tale idea appare dogmatico. Egli ammette che ogni conoscenza umana è imperfetta; come può allora
affermare che l’idea di Dio è norma e criterio di una conoscenza immutabile e infallibile? Egli ammette che la nostra
conoscenza delle ragioni eterne è imperfetta e tuttavia afferma che tali ragioni costituiscono i princìpi che presiedono
alla formazione dei concetti e a ogni atto di conoscenza. E se afferma che le ragioni eterne sono oggetto di conoscenza e
di immediata intuizione, come può quindi affermare che la conoscenza di Dio è riservata solo ai beati? E’ da tenere
presente, però, che tali rilievi critici si attenuano in modo rilevante quando si pensa alla distinzione tra conoscenza
chiara e certa e conoscenza piena e perfetta: la certezza in questo mondo e nelle condizioni che sono possibili per
l’uomo nella sua esistenza terrena è una certezza relativa, commisurata a tale condizione umana, ma ha il suo
fondamento in Dio stesso ed è dunque interamente valida, senza tuttavia coincidere con la suprema evidenza che le idee
hanno nella ragione divina, ove sono comprese immediatamente con un identico atto e una visione onnicomprendente.
Lo stesso Bonaventura nella Questione IV De scientia Christi scrive: Ratio aeterna movet ad cognoscendum sed cum
veritate principiorum, non specialiter de se, sed generaliter in statu viae et ideo non sequitur quod ipsa sit nota nobis
secumndum se, sed prout relucet in principio et in generalitate.
54
Per Bonaventura, la prova a posteriori non costituisce una vera dimostrazione, in quanto nessuna cosa può essere
conosciuta semplicemente attraverso i suoi effetti e non si può sapere che una cosa è la causa di un’altra se prima non si
conosce questa cosa. Analogamente nella prova a priori Bonaventura non parte dalla semplice idea ipotetica di un ente
assoluto per concludere che un tale ente deve necessariamente esistere, ma parte dalla conoscenza che già possediamo
Nell’Itinerarium Bonaventura esamina, quindi, i diversi momenti della contemplazione mistica che
riguarda la conoscenza di Dio: la contemplazione delle cose esteriori, dell’anima e delle realtà spirituali che
sono in noi, di Dio stesso. La conoscenza mistica è la forma più alta di conoscere e alla quale tutte le altre
sono subordinate e perciò rimandano. L’Itinerarium è dedicato interamente alle modalità in cui questa
conoscenza si attua e che costituiscono, a loro volta, altrettanti gradini tra loro organicamente connessi in
unità. Poiché ciascuno dei tre gradi che abbiamo sopra richiamato (la contemplazione del mondo,
dell’anima, di Dio) si gemina secondo la visione per speculum (quando dalle creature ci eleviamo a conoscere
il creatore) e quella in speculo (quando intuiamo il creatore presente nelle creature), si hanno in tutto sei gradi
di ascesa che rispondono, come sappiamo, alle sei potenze della facoltà conoscitiva (senso, immaginazione,
ragione, intelletto, intelligenza e apice della mente). Il primo gradino riguarda, dunque, la contemplazione di
Dio in quanto si manifesta per speculum negli enti creati (considerati sotto il settuplice aspetto dell’origine, la
grandezza, la moltitudine, la bellezza, la pienezza di perfezione, l’attività, l’ordine del creato). Il secondo
grado riguarda la visione di Dio in quanto egli è presente nel creato. Il terzo gradino comprende la scoperta
e la contemplazione di Dio all’interno del nostro spirito, che è fatto a immagine di lui e, con le sue potenze
(memoria, intelletto e volontà), riproduce la Trinità stessa. A questo proposito, Bonaventura ricorda che
queste tre potenze sono tra loro coordinate e connesse in modo da concorrere insieme allo stesso atto
conoscitivo: la memoria, infatti, genera l’intelligenza, poiché noi conosciamo allorché i princìpi innati si
applicano alle immagini degli oggetti, e la volontà di verità costituisce il vincolo che unisce tutti i momenti
dell’atto conoscitivo. Anche le varie scienze, nelle loro ramificazioni, riproducono l’immagine della Trinità:
così la filosofia si divide in naturale (a sua volta articolata in fisica, matematica e metafisica), razionale
(divisa in grammatica, logica e retorica) e morale (individuale, familiare e sociale). Nel quarto grado, noi
abbiamo modo di contemplare Dio presente nel nostro spirito, riconoscendo i doni molteplici di cui egli lo
arricchisce, come le virtù teologali. Il quinto grado riguarda la conoscenza di Dio sulla base della nozione
fondamentale che noi abbiamo e che è quella dell’essere, cioè del principio di ogni realtà e di ogni
conoscenza. Il sesto grado riguarda Dio stesso nella sua unità e trinità: Dio è visto come sommamente buono
e come principio di bene diffusivo, che, tuttavia, non compromette la sostanziale unità; la perfetta diffusione
del bene sommo, quindi, non può essere che attuale ed intrinseca, sostanziale e ipostatica, naturale e
volontaria, libera e necessaria. Le perfezioni divine sono viste anche nel rapporto di Dio e dell’uomo
nell’unità della persona di Cristo. L’ultimo capitolo dell’Itinerarium tratta dell’unione mistica, per la quale lo
spirito umano oltrepassa se stesso e celebra la sua unione con Dio.56
di Dio per affermare semplicemente che la sua esistenza è inclusa in quella conoscenza. In effetti, come scrive il
Gentile, “il sillogismo della prova ontoloigca, come ogni sillogismo dell’analitica aristotelica e medievale, non è un
processo di pensiero, ma una delucidazione didascalica, la quale si limita a spiegare la premessa: esse aliquid quoi nihil
maius cogitari potest” (I problemi della Scolastica, p. 125). Partire dall’idea di Dio è già partire dall’idea dell’ente
assoluto cui non può mancare l’esistenza; dunque cercare di dimostrare l’esistenza di Dio è solo una contraddizione,
poiché tale dimostrazione è annullata come esigenza logica dal presupposto medesimo di quell’idea che originariamente
si assume. Possiamo quindi concludere che Bonaventura, in luogo di darci la dimostrazione dell’esistenza di Dio, ci ha
lasciato la chiave per la critica di ogni tentativo di essa. Quando infatti egli dice che queste pretese prove non sono che
esercitazioni intellettuali, quando dice che tanto la prova a posteriori quanto quella a priori presuppongono la
conoscenza almeno implicita di quella stessa verità che dovrebbero dimostrare, egli in realtà mette in rilievo come tutte
queste prove non siano altro che petizioni di principio e che nessuna nozione l’uomo potrebbe avere di Dio, se non
l’avesse già originariamente impressa in sé.
55
Invece per S. Tommaso Dio si conosce solo per rationem naturalem, sicché si arriva al paradosso che un peccatore
di acuto ingegno può conoscerlo meglio di un giusto e di credente di capacità intellettuale limitata (invece per
Bonaventura accade il contrario, infatti i filosofi antichi, nonostante l’acutezza del loro ingegno, non poterono conoscre
Dio perché non erano illuminati dalla fede).
56
“Dopo che la mente nostra ha contemplato Dio fuori di sé per mezzo dei vestigi e nei vestigi, entro di sé per mezzo
della immagine e nella immagine, sopra di sé per mezzo della similitudine della luce divina che risplende sopra di noi e
nella stessa luce, per quanto è possibile nello stato presente di viatori e alla capacità della nostra mente; essendo
pervenuta nel sesto grado a contemplare nel principio primo e sommo e mediatore tra Dio e l’uomo, Gesù Cristo, cose
che non possono ritrovarsi nelle creature, e che superano ogni capacità della mente umana: resta che la mente nostra,
speculando, trascenda queste cose e oltrepassi non solo questo mondo sensibile, ma anche se stessa; in questo passaggio
Cristo è via e porta, Cristo è scala e veicolo, come propiziatorio collocato sopra l’arca di Dio, e sacramento nascosto da
secoli” (Itin., cap. VII, 1).
Bonaventura considera, dunque, l’unione mistica dello spirito con Dio come il massimo dono della grazia all’uomo
nella sua condizione terrena. Si tratta del momento culminante dell’esperienza religiosa del cristiano. Il massimo dono
della grazia è, dunque, la conoscenza che Dio offre di sé all’uomo nella sua condizione di viator. Nel Commentarius in
Evangelium Ioannis, infatti, Bonaventura, dopo avere ricordato che si può conoscere Dio in se e in effectu, precisa che
San Tommaso e l’aristotelismo cristiano
Furono specialmente i maestri domenicani che compirono l’opera di conciliazione e di sintesi tra aristotelismo e
cristianesimo; iv e protagonista principale di tale operazione è stato Tommaso d’Aquino, a cui si deve, peraltro,
l’elaborazione del più compiuto e organico sistema di filosofia cristiana (tomismo), destinato a imporsi come la base
filosofica ufficiale della Chiesa e a costituire fino a oggi il punto di riferimento per la discussione di ogni problema alla luce
della dottrina cristiana.57
San Tommaso sostiene il principio della reciproca autonomia di ragione e fede: la filosofia e le scienze
positive hanno una loro intrinseca validità, in quanto fondate sulla ragione e sull’esperienza; e, per quanto
riguarda le verità teologiche, la filosofia può limitarsi ad un ambito preliminare (preambula fidei), riguardante,
ad esempio, le prove dell’esistenza di Dio e dell’immortalità dell’anima; invece, nulla può dire a proposito dei
misteri rivelati (per esempio, la Trinità e l’Incarnazione), i quali sono al di sopra della ragione e costituiscono
oggetto della teologia soprannaturale, comprendente le verità rivelate e credute per fede. Tuttavia, ragione e
rivelazione hanno la loro unica fonte in Dio e pertanto non possono essere in contrasto tra loro.
San Tommaso elabora una originale concezione della verità, definita adaequatio intellectus et rei, reciproca
conformazione dell’intelletto e della cosa, nel senso che l’intelletto, quando conosce, assume la “forma” della
cosa, e questa, in quanto è conosciuta, è investita di quella forma concettuale (“universale”) che è elaborata
dall’intelletto. L’intelletto, di per sé, non ha nessuna forma, cioè nessuna determinatezza: esso ha una
costituzione meramente intenzionale, cioè una disposizione ad assumere determinate forme nel processo della
sua attività (che è, appunto, l’”intendere”), in rapporto alle cose comprese nelle loro “essenze”. L’intelletto
quest’ultima consiste nella conoscenza intellettuale e in se Dio può essere conosciuto in due modi: in modo chiaro e
aperto (ed è questa la visione dei beati) e in caligine; e, appunto, questo è il modo che corrisponde al grado più elevato
della contemplazione. Ecco il testo di Bonaventura a questo proposito: Alio modo cognoscitur Deus in se: et hoc
dupliciter: aut clare, et hoc modo a solo Filio et a Beatis; alio modo in caligine, sicut dicit beatus Dionysius de Pystica
Theologia; et sicut videt Mpyses et sublimiter contemplantes, in quorum aspectu nulla figitur imago creaturae. Et tunc
revera magis sentiunt quam cognoscant. Unde Bernardus dicit, quod aliquid in se sentiebat aliquando, de quo quando
volebat videre, statim emittebat (Comment. in Ioann., c. 1, n. 43). Una tale conoscenza mistica è una esperienza alla
quale tutti i credenti sono ammessi: Hunc modum cognoscendi arbitror cuilibet viro iusto in via ista esse quarendum (d.
23, a. 2, q. 3, ad 6). In un altro passo, Bonaventura esprime lo stesso concetto: Cognitio viae multos habet gradus.
Cognoscitur enim Deus in vestigio, cognoscitur in imagine, cognoscitur et in effectu gratiae, cognoscitur etiam per
intimam unionem Dei et animae. […] Et haec est cognitio excellentissima, quam docet Dionysius, quaequidem est in
ecstatico amore (In III Sent., d. 25, dub. 4). E’ chiaro che una tale conoscenza supera tutte le altre forme di conoscenza
di Dio. Bonaventura dice ancora che l’oscurità di essa è perfetta luminosità, che investe l’apice della mente (in
Hexaemeron coll., XX, n. 11). E se essa è un dono della grazia divina, implica, d’altra parte, la completa deizione del
credente, che non aspira ad altro e null’altro desidera che Dio stesso: haec autem contemplatio fit per gratiam, et tamen
iuvat industria, scilicet ut separet se ab omni eo, quod Deus non est, et a se ipso, si possibile esset. Et haec est suprema
unitio per amorem (Ib., n. 30). Ovviamente, la natura di questa unione mistica è affettiva e non intellettuale, anche se
coincide con la conoscenza perfetta: Dicitr sapientia magis proprie et sic nominat cognitionem Dei experimentalem, et
hoc modo est unum de septem donis Spiritus Sancti, cuius actus consistit in degustando divinam suavitatem (In II Sent.,
d. 35, q 1). Un tale atto, dice ancora Bonaventura, può essere detto amore conoscitivo di Dio, cioè un tipo di esperienza
in cui l’amore e la conoscenza si identificano: Actus doni sapientiae partim est cognitivus et partim est affectivus: ita
quod in cognitione inchoatur et in affectione consummatur (Ib.). Lo stesso Bonaventura, tuttavia, confessa di non avere
raggiunto una tale unione mistica e aggiunge che quelli stessi che l’hanno raggiunta non ne sono consapevoli, in modo
anche da poterla descrivere. Si tratta di un’esperienza che ha, dunque, un valore paradigmatico: essa rappresenta il fine
e il senso dell’intera vita del cristiano. E si tratta anche di un motivo qualificante dell’intera concezione bonaventuriana,
la quale culmina in questa affermazione dell’estrema possibilità dello spirito umano. Come è stato acutamente
osservato, per questa via “Bonaventura arriva alla deificazione dello spirito individuale, che è la conclusione più
legittima anche di tutta la sua teoria del conoscere” (Francesco Dal-Monte, Filosofia e mistica in Bonaventura da
Bagnorea, Roma 1924, p. 318).
57
Tommaso, della famiglia dei conti d’Aquino, nacque a Roccasecca, presso Cassino, nel 1225; nel 1243 entrò
nell’ordine domenicano e proseguì a Parigi gli studi iniziati a Napoli; dopo aver seguito l’insegnamento di Alberto Magno
a Conia, nel 1252 fu chiamato a insegnare teologia a Parigi e nel 1272 presso lo Studio Generale dei domenicani a Napoli;
nel 1274, ammalatosi durante il viaggio che doveva condurlo a Lione per partecipare a un concilio, morì a soli 49 anni. Il
suo capolavoro è la Summa theologiae.
rimane nella sua indeterminatezza, finché non intende qualcosa, assumendone la forma: perciò esso può
intendere se stesso, cioè avere coscienza di sé, riflettere su se stesso, solo nell’atto in cui intende qualcosa.
La conoscenza ha inizio dalla sensazione, la quale ci fa conoscere la “specie sensibile”, cioè la “figura”, la
forma secondo cui le cose si presentano, l’aspetto sensibile. Da questa figura o “immagine” l’intelletto ricava,
per astrazione, la “specie intelligibile”, cioè l’essenza. Questa è l’”universale” intelligibile, esistente come specie
potenzialmente intelligibile nella cosa e come intelligibile in atto (“concetto”) nell’intelletto. Chi rende
intelligibile in atto la specie è l’“intelletto agente”. Secondo San Tommaso, sia l’“intelletto possibile” che quello
“agente” sono facoltà dell’anima individuale: infatti, il soggetto dell’intellezione è sempre un individuo,
“questo uomo qui”. In tal modo, egli rifiuta sia l’interpretazione di Averroè, per il quale entrambi gli intelletti
sono universali e unici, sia quella di Alessandro d’Afrodisia, per cui universale e unico è l’intelletto agente.
Poiché l’intellezione, pur presupponendo la conoscenza sensibile, è un’attività immateriale, l’anima intellettiva
è una forma pura, di per sé sussistente (senza il sostegno di una materia) e dunque immortale. Questa anima,
nell’uomo, svolge anche le funzioni (inferiori) della sensibilità e dell’immaginazione.
Così sostanze immateriali sono gli angeli, che Dio ha creato per primi. Invece, le cose naturali sono sostanze
materiali, composte di materia e forma, e in virtù della loro forma sono “cause seconde”, cioè danno luogo ai
vari processi naturali. Così l’intero ordine dei processi fisici (tutto ciò che avviene in antura) costituisce un
ambito autonomo, in cui agiscono unicamente cause naturali.
La forma è principio di determinazione: essa, inaftti, determina una certa specie e la distingue da ogni altra;
mentre la materia è principio di individuazione, in quanto determina l’ente individuale e lo distingue da tutti
gli altri. Per San Tommaso, l’unica determinazione che la materia può assumere è quella quantitativa, sicché
l’elemento materiale di ogni ente è dato dalla quantità di materia che esso conserva nelle sue pur varie vicende.
In tal odo è respinta la concezione agostiniana della “incohatio formarum”, per cui esistono forme latenti nella
materia.
La nozione metafisica fondamentale è quella di ente (di qualcosa che esiste), in cui si distinguono l’essenza
(l’essere qualcosa di determinato) e l’esistenza (l’essere attualmente). In Dio essenza ed esistenza coincidono,
poiché è l’Essere stesso sussistente. Tutti gli enti, invece, non sono dotati di essere proprio (non sono, infatti,
l’“essere”, ma “partecipano”, in varia forma, dell’essere.
San Tommaso rileva che dell’Essere di per sé sussistente non si può avere una conoscenza diretta; si può
avere una conoscenza “per via di rimozione”, cioè rimuovendo da Dio tutte le imperfezioni che si riscontrano
negli enti (il che corrisponde alla teologia negativa, di ispirazione neoplatonica). Dio può essere conosciuto
anche “per analogia dell’essere”: l’essere, infatti, non è né univoco, cioè dotato di un unico significato, né
equivoco, cioè dotato di più significati completamente diversi, bensì è analogo, cioè dottao di significati in parte
uguali e in parte diversi. Si può dire che l’essere delle creature, pur essendo diverso (infinitamente
“dissomigliante”) da quello di Dio, è pur sempre una forma d’essere e, pertanto, ha una certa “somiglianza”
con esso (anche perché l’effetto rassomiglia sempre in qualche modo alla causa). Ciò consente di dire che Dio
possiede, in grado massimo e dunque in modo infinitamente diverso, le qualità possedute dalle cerature più
perfette, come l’intelletto e la volontà.
Ma la ragione non può da sé giungere alla prova dell’esistenza dell’Essere sussistente; perciò San Tommaso
rifiuta l’argomento ontologico di S. Anselmo. L’esistenza di Dio può essere dimostrata, invece, muovendo
dall’esperienza e andando verso il principio che è necessario ammettere, per giustificare aspetti e processi che
sono propri del mondo. Le prove “a posteriori” addotte da San Tommaso sono cinque: 1) Ex motu: poiché tutto
ciò che si muove esige un motore, e poiché non si può andare all’infinito, bisogna ammettere un primo motore
non mosso; 2) Ex causa: poiché ogni effetto rinvia a una causa, bisogna ammettere una causa prima non causata da
altro che da se stessa; 3) Ex contingentia: poiché tutte le cose sono contingenti (non necessarie ma possibili), esse
rimandano a un essere necessario, che ha in se stesso la ragione del suo esistere; 4) Ex gradu: poiché le cose
hanno gradi diversi di perfezione, bisogna ammettere un grado massimo di perfezione; 5) Ex fine: poiché tutte le
cose sembrano ordinate a un fine, bisogna ammettere una superiore intelligenza ordinatrice che si pone come
supremo fine dell’universo.58
58
Nel capo della morale e della politica, san Tommaso segue lo stesso principio di autonomia e, insieme, di rapporto
armonico tra ragione e rivelazione. Se il fine ultimo dell’uomo è la contemplazione di Dio, bisogna, d’altra parte,
ammettere che questo ha carattere soprannaturale e riguarda la condizione umana dopo la permanenza nel mondo. Nella
vita terrena, all’uomo sono accessibili solo beni relativi e particolari, che egli deve perseguire e scegliere con l’aiuto della
ragione, seguendo i princìpi universali della legge morale. Questa legge, che l’uomo comprende in quanto essa è
connaturata alla ragione, non è altro che la legge naturale, cioè la legge secondo la quale Dio ha cerato e ordinato il
mondo. La legge positiva, stabilita dagli uomini per il governo delle società, deve essere ispirata ai princìpi della legge
naturale. La legge divina, poi, comunicata agli uomini attraverso la rivelazione, riguarda la vita religiosa e i fini
soprannaturali. La società umana, edificata al fine del comune benessere, ha propri istituti autonomi; e così autonomo è lo
La crisi del Trecento
Nel Trecento assistiamo alla crisi del sistema scolastico: un sistema che si riteneva così solido e saldo, in quanto
fondato, da una parte, sull’autorità dei filosofi antichi, e, dall’altra, sulla verità cristiana. L’aspetto più rilevante di
questa crisi è la dissoluzione della stessa filosofia scolastica, determinata dal riconoscimento dell’impossibilità di un
accordo tra la ragione e la fede. Seguiamo questa crisi, perciò, nello sviluppo del pensiero degli ultimi due grandi
rappresentanti di quella filosofia, entrambi maestri francescani nell’università di Oxford, Duns Scoto e Guglielmo di
Occam.
Di fronte all’orientamento averroistico, per cui la filosofia è sufficiente a risolvere tutti i problemi, in modo
che non si possa richiedere un sapere superiore ad essa, Duns Scoto riafferma i diritti della fede (e della
teologia soprannaturale), in quanto la “ratio” è assolutamente impotente di fronte al problema del fine ultimo
dell’uomo e della salvezza. E non si tratta più, come per San Tommaso, di stabilire punti di accordo,
convergenze, motivi comuni, tra il più alto esito della filosofia e la teologia basata sulla verità rivelata, bensì si
tratta di riconoscere la totale distinzione tra l’una e l’altra. La filosofia riguarda ciò che è comune a tutte le
scienze: essa, in quanto metafisica, è “regina delle scienze”; la teologia è scienza “sapienziale”, sapere rivelato
da Dio. La filosofia, per Duns Scoto, è scienza deduttiva e, perciò, ha il rigore logico della matematica: essa non
può partire da dati empirici (instabili e relativi), bensì muove da un’evidenza razionale che si dà attraverso atti
di intuizione intellettuale.
Il motivo centrale della metafisica di Duns Scoto è il concetto di essere-in-quanto-tale: questo termine è
rigorosamente “univoco”, cioè ha il medesimo significato in riferimento ai diversi enti reali. Non si può, ad
esempio, parlare di “essere” per “analogia”: non si può parlare dell’essere della sostanza, partendo dall’essere
degli accidenti e supponendo che quello debba essere analogo a questo; la conoscenza degli accidenti non può
costituire una via per la conoscenza della sostanza, e pertanto quest’ultima conoscenza deve procedere per una
via propria. La conoscenza della sostanza attraverso gli attributi sarebbe possibile solo nel caso che essa
s’intendesse coincidere esattamente con tali attributi; ma è evidente che essa li oltrepassa, almeno nel senso che
costituisce il loro fondamento. E, per quanto riguarda Dio, noi non abbiamo nessuna conoscenza dei suoi
attributi, se prima non ne definiamo la natura, in modo da poter distinguere tra ciò che di lui può essere
affermato e ciò che deve essere negato. L’unica affermazione che possiamo fare è che “è necessario porre una
entità reale, unica, prima, che non ne esige alcun’altra prima di sé”, cioè un ente che possiede l’essere “per sé e
da sé”. Oltre a ciò, non possiamo dire nulla di Dio, in base al concetto di “essere”, cioè in senso metafisico; a
Dio non possiamo attribuire nessuna determinazione, dato che a noi è dato accedere con la nostra intelligenza
ad attributi propri degli enti finiti. Per quanto riguarda questi enti, non possiamo porre nessun legame
necessario tra i diversi attributi che cogliamo partendo dalla nostra esperienza: possiamo semplicemente dire
che un dato ente (o sostanza) possiede determinati attributi, ma non possiamo stabilire nessuna relazione
intelligibile tra di essi. Per Duns Scoto, non vi è nulla di intelligibile nelle relazioni tra gli attributi di una data
sostanza, né in quelle tra diverse sostanze, né in quelle degli enti finiti con Dio. Possiamo concludere, con un
atto di fede, che tali legami e rapporti dipendono dalla volontà di Dio. In questo senso, la ragione e la fede
divergono radicalmente.
Duns Scoto non ammette la presenza nell’intelletto di nozioni impresse direttamente da Dio, ma ammette
una inclinazione naturale della mente umana a conoscere e, dunque, la presenza in questa di un’attitudine che
le consente di intervenire attivamente nel processo conoscitivo e di costruire, col concorso delle sue categorie,
gli oggetti in quanto termini del sapere. Egli, così, avverte che “Né l’anima né l’oggetto da soli sono causa totale
dell’atto intellettivo” e che “tutti e due insieme costituiscono la causa integrale della cognizione” (Op. Oxon., I,
3, 7, 20). Infatti, “è proprio della potenza intellettiva non solo il ricevere la specie intenzionale dell’oggetto, ma
anche il tendere col suo atto verso l’oggetto” (Quaest. In Metaph., VII, 18, 11). In definitiva, questa attitudine
della potenza intellettiva ha il suo fondamento nel fatto che l’oggetto al quale in primis esso tende è l’”ens in
quantum ens”, nel fatto cioè che l’intelletto è per sua costituzione intenzionalmente disposto alla comprensione
dell’essere nella sua totalità, indipendentemente da ogni esperienza.
stato nella sua specifica sfera d’azione (la cura del benessere e della felicità degli uomini sulla terra), ma è subordinato alla
Chiesa per quanto riguarda il rispetto dei valori stabiliti da Dio e i fini ultraterreni.
Accanto al vero e al bene, San Tommaso pone il bello, che corrisponde all’essere in quanto suscita piacere nel venire
contemplato. Esso consiste, in particolare, in quei caratteri di perfezione, proporzione e luminosità, per cui le cose
piacciono e destano meraviglia e rimandano allasapienza del loro creatore.
Questa disposizione dell’anima si ripercuote sulla volontà, che, così, costituisce un’inclinazione razionale che
agisce in base a orientamenti comunicati dall’intelletto. L’attitudine a conoscere l’essere si configura, così, come
attitudine a volere il bene, e questa inclinazione della volontà rappresenta il vero fondamento dell’esistenza
umana. Intelletto e volontà operano concordemente, l’uno con un’intenzione conoscitiva, l’altra con
un’intenzione morale.
Analogamente, il “volontarismo” (ma si tratta di una concezione basata sull’equilibrio tra intelletto e volontà)
“non introduce nessun elemento di irrazionalità nell’azione divina” (Bréhier, La filosofia del Medioevo, tr. it.,
Torino 1952, p. 415). Dio, secondo Duns Scoto, crea le infinite possibilità d’essere della realtà finita e, tra di esse,
ne sceglie una; tali possibilità sono, dunque, come le diverse immagini o imitazioni della infinita essenza divina
e l’universo esistente riflette l’intelligenza del suo creatore. Dio è determinato unicamente dalla sua natura e
anche la sua creazione risulta coerente con essa. Tutto dipende dalle scelte di Dio. Così, ogni bontà delle
creature non appartiene ad esse per una qualche natura propria ma per scelta divina; e la stessa bontà delle
azioni umane non è intrinseca ad esse ma è tale in rapporto all’ordine stabilito da Dio: le opere umane non
sono, cioè, di per sé meritevoli, ma assumono tale carattere da quell’ordine soprannaturale che Dio ha disposto
per la salvezza.
Duns Scoto salva la razionalità dell’ordine dell’universo, ammettendo che esso è costituito da una serie di
“universali” (generi e specie), intelligibili, che rappresentano la “natura communis” a cui individui di una
stessa specie appartengono. Questa “natura comune” ha la capacità di individuarsi, cioè di dotarsi di un modo
d’essere “sui generis”, che riporta nella costituzione dell’ente individuale, il quale, perciò, non risulta
individuato dalla sola materia (come secondo la concezione aristotelica), ma da una entità specifica che si
aggiunge alla natura comune della specie e alla materia, individuando entrambe. Questa entità è stata chiamata
dagli scotisti “haecceitas” (“questità”). Così ogni indivciduo è costituito da una “natura comune” (la specie), da
una materia e da una “entità della singolarità”, che dispone le prime due all’individualità: sicché esso comporta
una forma e una materia parimente individuate. Le “ecceità” non sono intelligibili allo stesso modo in cui lo
sono gli “universali”; e pertanto Duns Scoto concorda con Aristotele che non vi è scienza del singolare, ma
aggiunge che ciò dipende dalla limitatezza della nostra intelligenza e non dalla natura delle cose. In questo
senso, egli accentuava i limiti della ragione nell’ambito conoscitivo e, come osserva il Bréhier, “tutti i suoi
princìpi miravano, ch’egli lo volesse o no, a dissolvere quel sistema che univa la fede e la ragione, il dogma e la
filosofia” (Op. cit., p. 419).
Guglielmo di Occam, negando che i concetti corrispondano a sostanze, porta a compimento la crisi del
razionalismo medievale. 59 Egli libera la conoscenza umana non solo da qualsiasi relazione con la fede ma
anche da qualsiasi sovrastruttura metafisica, delimitandola al solo campo dell’intuizione sensibile e della
organizzazione razionale dei dati empirici.
Occam considera specialmente le regole dell’organizzazione del discorso e considera la logica la base della
costruzione di ogni scienza, in quanto è scienza ogni insieme di nozioni ordinato in un discorso razionalmente
coerente. Anche la teologia, se vuole configurarsi come scienza, deve seguire le regole della logica, che è
“scientia scientiarum” (o “ars artium”), universale fonte di norme per la costruzione di discorsi
scientificamente rigorosi. Il discorso, del resto, è l’unico ambito in cui l’uomo può disporre di regole e norme
coerenti con le sue facoltà razionali: il linguaggio, in realtà, è fondato sulla logica e segue interamente le regole
della ragione. Al di là di questo dominio della ragione umana, c’è il mondo reale, del quale solo Dio è
assolutamente “signore” e legislatore. Occam rifiuta, così, l’identificazione di logica e metafisica, cioè tra
l’universo del linguaggio e del discorso umano e l’universo reale: la logica non è “scienza del reale” (“scientia
de rebus”), ma è “scienza del discorso” (”scientia de vocibus”) e riguarda l’ordine dei termini nel discorso. Il
mondo non corrisponde necessariamente all’ordine logico del discorso. Che ai fatti logici e linguistici, alle
relazioni discorsive, alle deduzioni razionali corrispondano fatti, eventi e cose reali, è una nostra errata
convinzione. Occam intende sradicare completamente il pregiudizio di una perfetta corrispondenza tra i
concetti e le cose, tra l’ordine della ragione e l’ordine della realtà.
59
Guglielmo di Occam, entrato nell’odine francescano, studiò a Oxford, dove fu allievo di Duns Scoto e
successivamente insegnò; nel 1324 fu citato davanti a Giovanni XXII per avere aderito al movimento dei francescani
“spirituali”; nel 1328 fuggì da Avignone e si unì al seguito di Ludovico il Bavaro nella sua spedizione in Italia, trovandosi
insieme al generale dell’ordine Michele da Cesena e ad altri intellettuali come Marsilio da Padova e Giovanni di Jandun,
sostenitori dell’autonomia dell’imperatore dall’autorità papale; fu scomunicato come eretico e dopo la morte di Michele da
Cesena divenne il capo spirituale dei “fraticelli”; morì nel 1349, dopo essersi riconciliato con la Chiesa. Nel periodo
oxoniense scrisse la Summa totius logicae e due commenti alla “Fisica” di Aristotele; nel periodo avignonese alcuni
opuscoli di polemica antipapale; e quindi opere di carattere teologico-politico sui poteri dell’imperatore e del papa.
Occam considera il “realismo” l’esempio più evidente di questa identificazione dell’ordine logico-discorsivo
e dell’ordine reale, della logica e della metafisica. Infatti, il realismo, come è noto, attribuisce una realtà effettiva
all’”universale”, che, invece, è un termine che noi usiamo per indicare più enti. Gli “universali” sono termini
linguistici e logici; il loro “aver valore per più d’uno”, come diceva Aristotele, significa solo che essi stanno per
altri termini parimenti linguistici che indicano enti particolari: essi, cioè, sono “segni di altri segni”. Gli
“universali” considerati come realtà essenziali non sono altro che una inutile (e fallace) creazione di una realtà
illusoria, che starebbe oltre quella fisica ed empirica. Ora, Occam avverte che “la realtà non deve essere
incrementata da reificazioni del tutto superflue” (“entia non sunt moltiplicanda praeter necessitatem”). . Solo le
individualità determinate sono reali, e in ogni ente complesso sono reali solo le singole parti; la totalità è solo
un segno linguistico (ad esempio, sono reali i singoli frati, non è una realtà l’”ordine dei francescani”, che è,
invece, un segno per indicare la totalità dei singoli frati). Occam, così, intacca uno dei princìpi su cui si regge
l’intero mondo medievale. Per la concezione medievale, infatti, “la Chiesa”, “l’Impero”, “la Città”, “l’Ordine”, e
così via, rappresentano entità reali basate su essenze indistruttibili e tali da oltrepassare l’esistenza dei singoli
componenti (i cristiani, gli imperatori, i cittadini, i frati). Occam, col suo “nominalismo”, riconduce la realtà ai
soli individui; e, così, dissolve la compattezza di quelle presunte realtà universali. Così le relazioni tra gli
individui sono meramente accidentali e provvisorie e non danno luogo a nessuna realtà che si aggiunga a
quella che essi possiedono. Anche la relazione di “causa” è un modo di considerare insieme più enti o fatti
nell’ambito della nostra esperienza. I concetti universali servono, pertanto, a conoscere gli enti individuali
rispetto a particolari modalità della loro esistenza e della loro condizione storica e temporale, e non vi è
conoscenza che non riguardi gli individui. Perciò la sola conoscenza valida è quella fornita dall’evidenza,
dall’intuizione diretta di esistenze, stati, eventi, che l’esperienza ci consente di constatare. Tutto ciò che non ha
riscontro nell’esperienza diretta non ha una realtà autonoma e non può essere oggetto di conoscenza: così,
quando si parla di “città”, “stato”, “ordine religioso”, e così via, in realtà si parla di individui che, in una data
situazione storica, sono inquadrati in un sistema di relazioni che essi concorrono esclusivamente a fondare.
Nello stesso tempo, si dissolve l’idea di una unità del sapere. Non vi è, infatti, una realtà superindividuale, la
cui scienza sia preminente e comprensiva rispetto ad altre scienze. Così cade l’idea della metafisica come
“scientia scientiarum”: il concetto di “essere-in-quanto-tale”, infatti, è solo un termine astratto, che serve a
indicare l’esistenza dei singoli enti, ma che di per sé non possiede nessuna realtà. Non è possibile, pertanto,
dedurre da una nozione più universale conoscenze particolari, senza che prima la stessa nozione sia stata
costruita per via induttiva: e in tal caso la deduzione non fa che ripresentare ciò che è già noto.
Allo stesso modo, ogni singola scienza non costituisce un sistema organico, tale da superare la portata delle
singole nozioni: ad esempio, l’astronomia risulta dalla riunione e sistemazione di tutte le nozioni relative ai
singoli astri ed eventi astronomici e non tratta di “entità” come il “sistema planetario” o l’”universo”, che
risultano esclusivamente dai corpi celesti nei modi in cui sono conosciuti. Ciò che chiamiamo “fisica”,
“astronomia”, “medicina”, ecc., non è una “scienza” nel senso di un sistema ordinato che unifichi in una sintesi
superiore tutti i singoli atti di conoscenza che in essa confluiscono, ma è solo un “nome” che noi usiamo per
caratterizzare un determinato atto di conoscenza e per indicare aggregati di conoscenze messe insieme con un
criterio puramente empirico. Non vi è una necessità logica che obblighi a costituire tali aggregati di nozioni, ma
solo un criterio pratico, di comodità e convenienza.
L’empirismo di Occam implica la dissoluzione di tutte le nozioni che formavano l’impalcatura dell’universo
aristotelico e medievale: all’universo, infatti, noi non possiamo attribuire nessun
a unità metafisica; non possiamo, cioè, farlo dipendere dall’intelligenza ordinatrice di Dio né da un sistema di
“cause seconde” disposte gerarchicamente. Noi possiamo considerare l’universo solo come il sistema delle
relazioni che riusciamo a stabilire tra le nozioni intorno ai corpi fisici.
Risultano scosse anche le basi della teologia razionale. Occam ritiene che non si possa giungere a dimostrare
l’esistenza di Dio e che nessuna delle verità teologiche può essere compresa dalla ragione. Al cristiano non
resta che affidarsi alla fede nella rivelazione; né vi è la possibilità di stabilire un legame razionale e sistematico
tra le verità della fede. Non vi è alcun termine che possa rendere intelligibile l’opera della volontà divina e della
grazia (perciò non ha senso un “quaerere intellectum” da parte della fede).60
60
Notevoli sono anche le conseguenze dell’occamismo sul piano politico e sociale. In primo luogo, la distinzione tra il
piano soprannaturale della grazia e quello naturale dell’operare umano conduce a una netta separazione della politica da
ogni ingerenza religiosa; in secondo luogo, il potere politico è considerato come consistente unicamente nel consneso del
popolo, cioè nell’insieme delle relazioni di fatto esistenti in una comunità di individui; infine, è considerata illegittima la
proprietà privata dei beni, i quali non sono valori in sé ma semplici mezzi, messi a disposizione degli uomini in via del
tutto provvisoria e accidentale.
Guglielmo di Occam ebbe, nel secolo XIV, numerosi seguaci, che svilupparono specialmente questioni di fisica. I più
notevoli rappresentanti di questo movimento, il cui motivo centrale è la radicale separazione tra ragione e fede, sono:
Nicola d’Autrecourt, Giovanni Buridano, Nicola di Oresme, tutti maestri a Parigi. Il primo critica specialmente le idee di
“sostanza” e di “causa”, anticipando alcune osservazioni moderne. In base a tale critica, non rimane nella della tradizionale
concezione di una natura costituita da essenze fisse e la conoscenza dell’universo riguarda soltanto una serie di successioni
uniformi constatate empiricamente. Il secondo è famoso per la sua teoria dell’”impetus”, per cui, dovendosi rinunciare a
dedurre il movimento dalla natura o essenza dei “mobili”, si deve ammettere che i corpi in movimento siano mossi da una
forza impressa inizialmente da un motore e che risulta proporzionale alla velocità e alla che essi assumono e alla quantità
di materia che contengono. E’ abbandonata l’idea di una natura dalle molteplici potenze, dalle quali derivano determinati
effetti, e s’impone l’idea di una natura nel cui ambito si hanno fenomeni che sono variamente posti in relazione gli uni con
gli altri: così a una scienza che intende “spiegare” i fenomeni si sostituisce una scienza che più empiricamente intende
“salvare” i fenomeni attraverso ipotesi verosimili. Così Nicola di Oresme nel suo Libro del cielo e del mondo avanzò
l’ipotesi del moto diurno (di rotazione) della terra, per spiegare i fenomeni connessi all’avvicendarsi del dì e della notte,
pur rimanendo fermo all’astronomia geocentrica.
Nel secolo XIII, inoltre, con la dissoluzione della stessa unità del sapere e l’abbandono del progetto di una scienza
“superiore”, identificata con la metafisica o con la teologia, il campo del sapere si diversifica in una pluralità di scienze
autonome, indifferenti al problema di una comprensione totale della realtà. In questa prospettiva s’inquadra il particolare
sviluppo di quelle scienze che appaiono rivolte ad assicurare la salute fisica e la convivenza pacifica, cioè la medicina e il
diritto. La più importante facoltà di medicina era quella di Padova, mentre per il diritto si era affermata specialmente
l’università di Bologna; e i più notevoli rappresentanti di queste discipline sono Pietro d’Abano e Marsilio da Padova, i
quali hanno discusso le basi metodologiche delle due scienze. In primo luogo, troviamo le linee di un metodo scientifico,
che non intende essere interamente deduttivo, nel senso della derivazione dell’intero sapere da un’unica idea fondamentale,
e, d’altra parte, neppure esclusivamente empirico. Pietro d’Abano, autore del Conciliator differentiarum, costruisce la
scienza medica col concorso dell’esperienza e della ragione e con l’intento di scoprire le leggi costanti degli accadimenti
fisici, individuate attraverso le “cause prossime”, accertate mediante l’esperienza. Così la natura è concepita secondo il
modello di un immenso organismo vivente, in cui tutti i vari elementi stanno in interconnessione reciproca e producono
una serie di condizionamenti e influssi, che occorre studiare, al fine di stabilire, in particolare, quali influenze agiscono
sugli organismi e quali ne promanano, e con quali interventi si può modificare il quadro delle forze interagenti, allo scopo
di ristabilire equilibri naturali in diversi modi alterati. Nel sistema della natura Pietro d’Abano inserisce anche gli influssi
astrali. La natura, infatti, è un complesso intreccio di azioni e reazioni, che muovono da ogni punto e si dirigono verso ogni
altro punto dell’universo; e anche gli astri sono, in modo più o meno diretto, concause degli eventi fisici, fattori che
influiscono, attraverso la mediazione di altri elementi, sulla salute degli organismi, in quanto fanno parte della totalità
organica dell’universo. La “filosofia”, come scienza generale della natura e come specifica scienza medica, considera
questo sistema, in cui ogni elemento interagisce con ogni altro. Il medico, in quanto scienziato di tale sistema, può
intervenire in modo che il sistema delle forze naturali (compresi gli influssi astrali) concorra al mantenimento degli
equilibri organici e, dunque, alla salute degli individui; egli ha il compito di indagare sui nessi che si stabiliscono tra i vari
fattori della vita e di sfruttare, operativamente, ogni elemento che può essere di aiuto agli uomini per il loro benessere e la
loro felicità.
Analogo al sistema della natura è quello politico-sociale e, pertanto, la scienza del diritto seguirà le stesse linee
metodiche della filosofia naturale e della medicina. In un organismo politico, diversi elementi – individui, condizioni
sociali, attività e professioni, inclinazioni e temperamenti – stanno insieme uniti da rapporti solidali, in modo che ogni
azione e ogni fatto hanno significato in rapporto all’insieme, ordinato da leggi precisamente definite. Come in un
organismo vivente la salute è assicurata dal giusto rapporto tra i vari “stati” individuali e sociali, cioè dal fatto che interessi
individuali, libere volontà, occupazioni e attività, funzioni e istituzioni, insieme concorono al benessere individuale e
collettivo. Così l’organismo politico è visto, in analogia con l’organismo naturale, come un insieme ordinato di elementi,
ognuno dei quali ricerca e trova, nell’ordine dell’insieme, la sua condizione propria. Perciò è necessario che ogni elemento
sia posto in equilibrato rapporto con gli altri; infatti, ogni alterazione o insufficienza nello “stato” di un individuo o di una
parte organizzata dell’insieme provoca un disagio nell’intera comunità. Ciò che mantiene saldo uno stato è l’equilibrio che
s’instaura nella trama dei rapporti tra tutti i suoi membri; e tale equilibrio è basato sul soddisfacimento delle esigenze
fondamentali di ogni individuo e sulla eliminazione di tutti i fattori che recano danno. Ogni funzione ha, così, significato in
quanto fa parte dell’organismo politico; e anche la religione e il sacerdozio s’inquadrano nel complessivo equilibrio
politico-sociale. Marsilio da Padova trae la conseguenza che il sacerdozio è interamente soggetto all’autorità statale. In
quanto inserita in un organismo storico e mondano, la Chiesa è soggetta allo stato; in quanto attinge la sua dottrina dalla
Scrittura, è autonoma riguardo agli articoli di fede.
Marsilio da Padova, il cui Defensor pacis è rimasto il punto di riferimento per ogni concezione giurisdizionalistica,
opera una trasformazione nel modo di concepire la legge umana e politica. Secondo la concezione medievale, dalla “legge
eterna” deriva la “legge naturale” e da questa è dedotta la “legge umana”. Marsilio distingue “legge divina” e “legge
umana”: la prima esprime un comando diretto di Dio ed è connessa a premi e castighi eterni, dunque si esplica fuori del
tempo e del mondo; la seconda è sanzionata in questo mondo da una pena imposta al trasgressore. La violazione della
legge divina non comporta penalità in terra; e così ogni legge umana comporta solo sanzioni nel mondo. La legge è tale per
La separazione tra ragione e fede determina anche un orientamento di pensiero religioso e teologico in senso
mistico. Poiché le stesse istituzioni ecclesiastiche sono messe in discussione e la religione diventa sempre di più
un fatto di coscienza individuale, il cristiano cerca una via di rapporto diretto con Dio. Mentre nella tradizione
medievale la salvezza è assicurata dalla Chiesa atraverso il complesso dei suoi riti e degli obblighi imposti ai
fedeli, la nuova “devotio” si appella all’interiorità, all’intensità del sentimento religioso.
Il grande “padre” e “maestro” della mistica trecentesca è il domenicano Giovanni Eckhart, il cui pensiero si è
formato attraverso lo studio dei testi neoplatonici, specialmente della “Elementatio theologica” di Proclo,
tradotta in latino da Guglielmo di Moerbeke e diffusa dal 1268. Eckhart riprende il motivo neoplatonico dello
slancio mistico dell’anima che tende a una unificazione completa con l’Assoluto. Questo è assolutamente
trascendente, al di là di ogni determinazione finita, dunque è il totalmente “Altro” dal mondo. Nessuna
teologia può configurarsi come scienza, in quanto l’Assoluto è al di là di ogni intelligenza, comprensione e
discorso. La conoscenza riguarda sempre qualcosa di determinato: è essa stessa determinazione e definizione; e
pertanto può riguardare l’ambito del finito. Eckhart sostiene il principio della “teologia negativa”: Dio è al di là
di ogni definizione e anche al di là di ogni rivelazione. Solo chi riesce a unirsi misticamente a Dio, riesce a
conoscerlo. La “visione” di Dio implica l’annullamento dell’individualità definita, la negazione di tutto ciò che
costituisce distinzione e separazione e che rende gli enti dottati di una loro realtà indipendente; essa implica il
farsi identici con Dio. Questo stato di estatica unione con l’Assoluto si conquista attraverso la negazione
completa del mondo: l’”essere-del-mondo” diventa, nell’esperienza mistica, un “purum nihil”; e così solo
l’oblìo totale della stessa intelligenza delle cose, l’annullamento di ogni conoscenza mondana, l’immersione in
una realtà in cui non è possibile più compiere nessuna distinzione, poiché non vi è più nessuna cosa distinta e
separata, la negazione di ogni residuo legame con l’esperienza del finito: solo queste condizioni consentono la
via mistica dell’unione con Dio.
La filosofia di Dante
Dante ha elaborato una filosofia originale? Indubbiamente egli ha assimilato il complesso panorama della filosofia
medievale e scolastica e lo ha aggiornato in rapporto al compito che egli si è assunto e al carattere generale della sua
opera. In questo senso, egli è autore di una originale operazione culturale, che avrebbe dovuto insieme concorrere
notevolmente a risolvere il duplice problema dell’umanità, quello di un’ordinata convivenza nel sistema dei governi
cittadini e quello della salute eterna.
L’attenzione del poeta è rivolta costantemente a questi due problemi, visti in un’unità contestuale
dominata dall’idea del rinnovamento spirituale. Il centro della visione è, dunque, l’uomo, protagonista
insieme della storia del mondo e della vicenda soprannaturale della salvezza. L’uomo è richiamato al senso
di responsabilità, alla consapevolezza della sua natura e della sua funzione nell’ordine dell’intero creato. Il
motivo fondamentale è il cambiamento da attuare nell’uomo per il rinnovamento civile e la salvezza cristiana.
La selva oscura indica lo stato di vizio in cui si trova l’umanità intera, la situazione di smarrimento che non
riguarda solo il poeta ma rappresenta un carattere generale della storia del tempo. La condizione esistenziale
rappresentativa dell’umanità del tempo è quella dell’errore. Le fonti che illuminano lo spirito umano e lo
guidano nella scelta del bene sono piuttosto oscurate per il venire meno della disposizione positiva a seguire
la verità. La stessa ragione è indebolita. L’uomo è, pertanto, lasciato in balia degli istinti, che sono facile
dominio del male: egli vive nel vizio e nell’errore.
La selva oscura indica la condizione esistenziale dominante del tempo. Le tre fiere indicano
evidentemente le forme principali in cui si presentano le forze del male. Sono potenze attive che si insinuano
nelle sedi del governo spirituale e storico dell’umanità, presso la medesima corte pontificia, presso la sede
imperiale e nei governi dei popoli e delle città.
Dunque le forze del male si sono impossessate dell’umanità e fanno scempio del mondo. Dante
rappresenta, in primo luogo, questa situazione e le molteplici forme in cui si viene dispiegando il dominio
del Maligno nel mondo.
il fatto che una “volontà” la emana e commina una pena a chi la viola. E, per quanto riguarda la legge umana, vediamo che
la volontà che la emana è quella del popolo (nel senso che il popolo è la “prima ed effettiva causa efficiente della legge”).
E’ la volontà del popolo, oppure della parte eminente di esso, che decide, per sua scelta, in un’assemblea, in termini
precisi, “che certi atti umani devono compiersi e altri no, sotto pena di punizioni temporali”.
L’umanità è straziata, condannata a subire le pene più atroci, umiliata e schernita. La rappresentazione
delle pene infernali è proprio la denuncia degli orrori verso i quali le forze del male sospingono l’umanità. Il
Maligno, infatti, è il nemico dell’uomo.
La natura propria dell’uomo è di carattere ascetico. L’uomo è creato per tornare a Dio e la sua esperienza
più propria comprende i gradi di questa ascesa. La via dell’elevazione è quella della virtù, al cui esercizio
Dante richiama innanzitutto i governanti.
L’umanità ha bisogno di una efficace paideia che la riporti sul retto cammino. Dante indica, infatti, col
simbolo della mano sinistra la condizione dell’errore. E’, ad esempio, la via che segue Ulisse nel suo “folle
volo” verso il tragico naufragio, cioè verso la perdizione. L’umanità, in questo senso, è in gran parte vittima di
una paideia perversa, che, con l’illusione della sfida dell’infinito, in realtà la rigetta nell’oscurità.
Ulisse rappresenta, in qualche modo, l’errore del mondo pagano: egli è simbolo di un’umanità accecata
dall’illusione del potere infinito, dunque caratterizzata specialmente dalla mancanza della coscienza della
divinità. Per la cultura antica, infatti, l’uomo sfida l’impossibile e non trova limiti alla sua volontà. Questa
eredità della paideia umanistica e non ancora cristiana pesa sull’umanità (e il suo influsso sarà ancora più
fortemente visibile nell’età moderna, segnata in gran parte dalla ripresa dello spirito dell’antichità).
Dante intende interpretare la possibilità di un nuovo aiuto provvidenziale, che, nelle condizioni storiche
segnate da una estrema decadenza, costituisca l’occasione della salvezza. La Divina Commedia è la
testimonianza di questa possibilità dell’intervento divino per la salvezza dell’umanità.
Da Dio stesso, infatti, è venuto l’ordine per il compimento del viaggio di Dante attraverso i regni
dell’oltretomba.
Il primo strumento restituito all’uomo è il pieno possesso della ragione. Virgilio guiderà Dante nelle
prime tappe del suo cammino verso la liberazione dall’errore. La ragione indica all’uomo anche i limiti del
suo potere e delle sue facoltà; nello stesso tempo è fondamento delle virtù civili ed sufficiente per
l’orientamento nel mondo. Il governo secondo giustizia si esplica attraverso la ragione.
Virgilio rappresenta la ragione liberata dall’ybris antica della tracotanza costituita dalla convinzione
dell’onnipotenza. Si tratta della ragione cristiana, che si pone in stretta collaborazione con la fede ed è, in
primo luogo, riconoscimento dei limiti propri.
La ragione, così configurata, è il primo strumento della rigenerazione dell’umanità.
Uno dei compiti che Dante si propone è, dunque, la restaurazione della ragione come principale strumento
della realizzazione dei fini storici e mondani dell’uomo. Questi fini sono razionali e si configurano come la
progressiva attuazione della razionalità nel mondo. La ragione, dunque, è non solo strumento della
conoscenza, che, collaborando con la fede nella verità rivelata, elabora il sistema del sapere scientifico,
filosofico e teologico, ma è anche lo strumento dell’attuazione delle istituzioni storiche e dell’ordine morale
che impronta ogni manifestazione e ogni attività nel mondo.
In questa prospettiva si configura il rapporto tra la ragione e la fede. Dante non solo attribuisce alla
ragione la funzione di intervenire per rafforzare la fede, ma le conferisce una funzione autonoma per quanto
riguarda la fondazione della morale, della politica, della scienza mondana. E’ vero, tuttavia, che si tratta
della ragione illuminata dalla fede. La razionalità antica, infatti, è deviata verso l’esaltazione smisurata di sé
ed è diventata essa medesima fonte di errore.
La razionalità cristiana non può cadere nella hybris antica e pagana: essa è costituita in modo da
collaborare con la fede; dunque contiene in sé la consapevolezza dei suoi limiti e dell’ambito entro il quale
esercita la sua funzione.
Dante si riferisce alle fonti della scienza razionale e, per quanto riguarda le verità sovrarazionali, attinge a
tutte le fonti della rivelazione, in primo luogo ai libri sacri e quindi ai testi dei Padri della Chiesa,
direttamente ispirati da Dio. La conoscenza approfondita di questi testi gli dà la possibilità di affrontare tutti
i problemi di carattere teologico.
Dante è convinto perciò della “verità” delle dottrine che professa. Egli, del resto, non fa che attingere
direttamente da quelle fonti e, sulla base di quelle conoscenze, si ritiene autorizzato a scegliere, tra fonti
diverse e contrastanti, quelle più autorevoli.
In questo senso, Dante si propone il compito di una ricostruzione organica della sapienza cristiana, con
riguardo alle esigenze attuali dell’umanità. Lo stesso sapere simbolico, ad esempio, degli antichi profeti
trapassa nelle immagini della Commedia. Le nuove immagini poetiche non sono altro, in gran parte, che una
trascrizione di quei simboli. E indubbiamente una delle principali caratteristiche della poesia dantesca
consiste nella straordinaria ricchezza delle immagini simboliche, allusive a verità rivelate che riguardano la
storia dell’umanità e le stesse vicende della Chiesa.
Dante è il grande sistematore del sapere medievale incentrato sull’idea del rinnovamento cristiano
dell’umanità. E la filosofia occupa un posto centrale in questa sistemazione. Essa comprende tutte le
questioni che sono dominate dalla ragione e dall’intelletto.
Perciò il poeta dichiara: Io veggio ben che già mai non si sazia/ nostro intelletto, se il ver non lo illustra/ di fuor del
qual nessun vero si spazia./ Posasi in esso come fiera in lustra/ tosto che giunto l’ha, e giugner puollo,/ se non ciascun
disio sarebbe frustra./ Nasce per quello, a guisa di rampollo,/ a piè del vero il dubbio; ed è natura/ che al sommo pinge
noi di collo in collo (Paradiso, IV, 124-132). Il “vero” fuori del quale non può esservi altra verità è
indubbiamente il vero supremo: e in questo senso indica la verità rivelata; ma potrebbe indicare anche il
vero filosofico. Infatti qui si parla di quella verità che può essere compresa dall’intelletto e della conoscenza
che ha la sua base nella ragione. Dunque non può essere considerato vero ciò che non si accorda con la verità
rivelata, ma anche ciò che non si accorda con la ragione. Del resto ragione e fede non costituiscono un
dualismo antinomico, ma formano insieme un plesso unitario. La verità rivelata (o il vero filosofico, dato che
tra i due non vi è antinomia) è come la tana (la dimora propria) per la fiera, il luogo dove l’umano intelletto
si sente sicuro e si acquieta. Dante fa riferimento a quel vero che l’intelletto può raggiungere con l’aiuto della
fede. Dio, infatti, ha posto nell’uomo il desiderio di questo sapere e nello stesso tempo lo ha dotato della
facoltà di conseguirlo, fornendogli lo strumento della ragione e insieme comunicandogli le verità
soprannaturali. Certo, l’umano desiderio di verità non può essere soddisfatto dalla sola ragione, senza
l’aiuto della rivelazione. Ma, d’altra parte, l’intelletto ha la facoltà di comprendere le verità rivelate. Perciò in
questa dinamica di raggiungimento della verità si pone il dubbio. Il conseguimento di alcune verità fa
sorgere il dubbio intorno ad altre questioni. In tal modo si sviluppa la vita intellettuale, che rappresenta,
comunque, il terreno proprio dell’acquisizione di ogni conoscenza. Anche quelle verità che si acquistano con
l’aiuto della fede sono stimolate dalla dinamica intellettuale, che, così, si presenta come il fattore di ogni
conoscenza. E’ il naturale desiderio di verità e di sapere che consente all’intelletto di salire di vetta in vetta.
La Divina Commedia è la più grandiosa sintesi filosofica e teologica che sia stata elaborata nel medioevo.
Essa si pone nella tradizione biblica e patristica e intende rappresentare la condizione dell’umanità e della
Chiesa in un momento decisivo per l’attuazione del piano divino nel mondo. L’umanità è identificata con la
cristianità, per la quale si invoca una guida che sia all’altezza del disegno divino.
L’intera economia della salvezza è dispiegata in rapporto alla situazione dei tempi.
I tempi sono quelli dello smarrimento. Indebolitasi la Chiesa per la mancanza di papi consapevoli del
proprio ruolo, l’umanità vaga senza una vera e propria guida spirituale. Dante insiste su questa mancanza.
Dio ha disposto l’Impero e il Papato come le grandi guide dell’umanità, l’una per la vita nel mondo, l’altra
per la salute eterna. La crisi nelle grandi istituzioni universali è giunta al suo punto estremo. A questo punto
è necessario l’intervento divino. Il poeta si candida a portavoce di Dio per la ripresa della vita cristiana. Il
disegno della redenzione si ripropone come attuale. Tutti i tralignamenti saranno puniti: perciò la Commedia
si apre con la visione dell’inferno, perché lo spettacolo dei dannati costituisca l’occasione della purificazione
dell’umanità. L’umanità rinnovata è, appunto, quella purificata, che ha operato su di sé la grande catarsi ed è
pronta ad affrontare i compiti della nuova epoca storica. La Commedia, secondo i fini assegnati da Aristotele
alla tragedia, dovrà favorire questa catarsi universale e preparare la nuova umanità. Il poema si presenta
come la grande paideia, lo strumento deciso da Dio stesso per rivelare all’umanità la verità sulla condizione
attuale e sulla via da seguire per la ripresa nel segno della corretta azione nel mondo e della fede salutare. E’,
infatti, il poema al quale hanno posto mano il cielo e la terra.
Tutti i simboli medievali confluiscono nel poema dantesco e compongono la grandiosa scenografia dei
regni ultraterreni. Così l’intera storia dell’umanità è vista nella sua proiezione nella dimensione dell’eternità.
Infatti ogni vicenda temporale è destinata ad avere il suo corrispondente stato sul piano soprannaturale. I
protagonisti della storia umana si presentano alla visione dantesca nel loro destino ultimo e definitivo. La
visione dell’eternità è la nuova rivelazione che Dio ha riservato all’umanità per la sua salvezza.
Dunque, in primo luogo si tratta di considerare questo aspetto fondamentale della Divina Commedia, cioè il
carattere vero e proprio di poema sacro. Il poema è reso possibile dalla decisione divina di ammettere l’autore
alla visione dei regni eterni e di concedergli quindi la straordinaria vis poetica, adatta allo straordinario
compito. In questo senso il poema è strumento della rivelazione. Dio, infatti, ha voluto svelare all’umanità il
destino eterno dell’umanità storica fin da Adamo. L’umanità conosce così tutto ciò che riguarda il suo
destino soprannaturale. La conoscenza che è naturalmente limitata a questo mondo si estende al mondo eterno della
salute e della dannazione.
Così si dispiega la singolare condizione umana. Questa condizione è tale per cui si trova sempre di fronte al
compito di dover decidere intorno al proprio destino. L’uomo, come è stato osservato da un filosofo del
Novecento, è l’ente per cui ne va del suo essere. E qui l’essere è il destino ultimo, nel quale si proietta
l’esistenza storica. L’uomo decide col suo libero arbitrio intorno al suo destino soprannaturale, sceglie tra la salute e la
dannazione. Col messaggio affidato al poema dantesco, Dio ha voluto manifestare all’umanità tutta la verità
intorno alla dimensione soprannaturale così come essa si è venuta configurando in rapporto allo sviluppo
del libero arbitrio. Ora l’umanità conosce ciò che ne è della sua condizione in rapporto alle sue decisioni. In
questo modo si ripropone nella sua totale drammaticità il problema della libertà.
Dante richiama l’attenzione sul problema che riguarda l’uso del libero arbitrio. L’uomo generalmente non è
abbastanza educato in merito a questo problema. Egli fa un uso della libertà in gran parte sollecitato dagli
impulsi sensibili e non dalle virtù.
S’impone, pertanto, un’opera di educazione, che riguardi, appunto, quest’uso. La Commedia intende essere
lo strumento di questa paideia. Si tratta di una “paideia” che si avvale principalmente della rivelazione divina
e alla quale, dunque, si affida un compito universale.
In questo modo si profila l’immagine dell’umanità rigenerata. L’epoca storica che si viene profilando è
quella della vera attuazione del cristianesimo. Dante intende l’umanità cristiana rispetto alle due dimensioni
dell’esistenza, quella terrena e quella soprannaturale. La piena attuazione di questa umanità nel mondo è
quella che segue i princìpi della morale e attua la virtù. Lo strumento di questa attuazione è l’impero
universale, sotto la cui giurisdizione si pongono i popoli e le città.
In tale prospettiva si configurano le comunità cristiane cittadine. Queste comunità sono le cellule
dell’ordinamento umano secondo i princìpi della giustizia. Dante sviluppa una forte dialettica della vita
cittadina, assumendo a emblema la Firenze del suo tempo.
Firenze appare, ovviamente, come una città divisa, come una comunità disgregata. Il problema è quello che
contempla la ricomposizione dell’unità cittadina, la fine delle discordie, la possibile riconciliazione sulla base
di una condizione di giustizia. Dante, nel famoso VI canto dell’Inferno, conduce una analisi disincantata
(perciò messa in bocca a Ciacco) della disgregazione alla quale è giunto il tessuto della vita cittadina. Nello
stesso tempo sono tracciate le linee essenziali della ricomposizione pacifica. Dante ha un’idea precisa della
comunità pacificata, anche se la visione di questa si allontana drammaticamente, in coincidenza con
situazioni così laceranti come, ad esempio, l’esilio dello stesso poeta.
Dante pensa alla comunità cittadina come a un ordine basato sul riconoscimento dei rispettivi ruoli e a un
armonico contemperamento delle funzioni di ciascuno in vista del bene pubblico. Egli condanna il prevalere
degli interessi privati. La città, infatti, è diventata lo scenario nel quale si dispiega disordinatamente
l’individualismo. Ognuno approfitta del bene comune per arricchirsi e conseguire potere.
Dante, perciò, pone il problema del governo delle città come problema che tocca la responsabilità
dell’Imperatore. Questi ha il compito di riportare la concordia e la pace nell’ambito delle città dilaniate da
interne discordie.
Una analoga situazione di discordia si pone per l’Italia. Le città e gli stati sono lacerati da guerre continue.
E veramente impressionante è la visione che dell’Italia è presentata nell’altrettanto famoso VI canto del
Purgatorio (“non signora di province ma bordello”).
Dante si pone come assertore dell’unità d’Italia, configurata non certo ancora come uno stato unico, bensì
come una comunità di stati dotata di organismi di governo comune (“signora di province”). Si ha, cioè,
un’organizzazione che somiglia a un assetto federativo, in cui l’autonomia dei singoli stati è sostenuta, a sua
volta, da organismi unitari. In questo modo si profila l’Italia “signora di province”. E anche in questo caso la
salvezza potrà venire dall’Imperatore.
Il quadro politico universale è chiaramente delineato. L’Impero è il vero organo del governo mondiale.
Perciò in primo luogo si profilano gli organismi di questo governo. In primo luogo si pone il problema della
pace universale. L’Impero è garante di questa condizione di pace che è essenziale per l’intera umanità. La
nuova epoca, perciò, è quella della pace per tutti i popoli. Con questa condizione, non si avranno più guerre:
non vi saranno, infatti, più nemici, né popoli che cercheranno di sottomettere altri popoli. La Comunità
internazionale avrà le caratteristiche della monarchia universale. Monarchico, infatti, sarà il governo mondiale.
Ogni dispersione di potere non può che nuocere al retto governo dei popoli. L’unità del potere è richiesta
dall’uniformità del governo e dalla tempestività di applicazione ed esecuzione delle leggi.
Con questi organismi di governo si presenta la nuova umanità che la civiltà medievale concorre a creare,
come sbocco della sua universale tensione. L’intera civiltà medievale è vista sotto l’aspetto di questa tensione
indirizzata verso l’attuazione del governo universale dell’umanità cristiana. Il sogno dell’umanità unificata
rappresenta la grande utopia dantesca. La Commedia è il poema di questa utopia.
Gli esempi del disordine, della vita condotta secondo gli istinti, della discordia e della guerra, delle
molteplici forme in cui si esprime la bestialità umana, questi esempi dispiegati attraverso l’Inferno sono un
ammonimento affinché non si ripetano i comportamenti meritevoli della punizione eterna. Dante riporta nel
suo poema gli scenari che erano rappresentati generalmente nelle chiese e nelle sedi pubbliche, affinché fosse
visibile il modo in cui nel mondo si prepara la condanna (o la beatitudine). Il richiamo ai modi della vita
terrena è sempre il tema dominante. Vediamo, ad esempio, il Conte Ugolino. La scena del dannato che
affonda i denti sul cranio dell’altro dannato è solo l’introduzione al racconto della lunga storia sulla
prigionia del protagonista. L’episodio storico campeggia con evidenza, intrecciato strettamente con la
rappresentazione della punizione eterna. Tutto rimanda al tempo storico, nel senso che si richiama
l’attenzione sulla necessità di rimuovere ormai dal mondo la possibilità della ripetizione di simili episodi e
delle diverse manifestazioni del vizio.
La storia dovrà essere liberata da tali esempi di bestialità umana. Dante riporta nel suo poema tutti gli
esempi che l’iconografia medievale aveva acquisito. Per ogni rappresentazione ricorre a precise scene che
colpivano l’immaginazione popolare. E’ possibile che molte scene egli le abbia inventate ex novo; ma la
maggior parte erano presenti davanti agli occhi di tutti e mostravano le loro figure ammonitrici dalle pareti
delle chiese e dai pavimenti e dai muri delle cattedrali.
Dante raccoglie tutta questa materia e la fonde organicamente nella forma del poema unitario.
Dante filosofo, dunque. Noi condividiamo in pieno la convinzione espressa recentemente da Massimo
Donà, in occasione dell’inserimento del Convivio in una collana di testi filosofici per le scuole, che la stessa
opera poetica di Dante sia costituita come opera filosofica originale.61
Generalmente, infatti, la filosofia di Dante è stata intesa solo come un complesso di rimandi e citazioni alle dottrine
filosofiche antiche e medievali, specialmente ad Aristotele e a S. Tommaso, oltre che ai Padri della Chiesa, considerati
come i grandi e fondamentali interpreti della Sacra Scrittura.
Bruno Nardi, che pure ha scritto saggi penetranti e di eccezionale valore critico sul pensiero di Dante,
rimane sulla linea secondo la quale “lo schema generale della sua metafisica è quello della scolastica
cristiana”.62
Il Gilson, invece, ha sottolineato l’originalità del pensiero di Dante, in primo luogo mostrando come il
poeta spesso si discosti dall’autorità di S. Tommaso e si riporti direttamente alle fonti aristoteliche, e quindi
mettendo in rilievo come “Dante persegua evidentemente su questo terreno un progetto del tutto
personale”.63
L’originalità dantesca è stata sottolineata, per altro verso, da Giovanni Gentile, il quale si è soffermato
specialmente sulla concezione dell’autonoma opera spirituale dell’uomo, il quale “non ha fuori di sé, già
attuato il suo mondo, ma deve produrlo egli stesso”.64
Per Massimo Donà, che approfondisce questi spunti interpretativi, Dante ha elaborato già una concezione
rinascimentale dello spirito umano.65
61
M. Donà, Introduzione, in Dante Alighieri, Convivio, “Philosophia”, Pagus Edizioni, Padova 1992. Si tratta della
“convinzione che siano proprio la poesia e la prosa dantesche a costituirsi, in quanto tali, ossia indipendentemente dagli
espliciti rimandi alle dottrine dei ‘maestri’, a costituirsi innanzitutto come una delle più radicali e complesse, nonché
originali, esperienze filosofiche della nostra storia. Come dire che Dante non si limita ad ‘usare’ i filosofi per
giustificare questa o quella sua affermazione, il cui interesse rimarrebbe comunque eminentemente ‘poetico’, ma è in
primis ‘grande filosofo’ egli stesso, capace, attraverso un’originalissima interpretazione delle più interessanti questioni
teoriche sviluppatesi nel medioevo e nell’antichità, di dare inizio ad una ‘nuova’ direzione di pensiero, che, venuta a
maturazione ed affermatasi con l’incipiente esplosione della rinascenza, verrà bruscamente interrotta (e non più ripresa)
nell’evo moderno, da quella che di quest’ultimo è stata senza dubbio la grande e vera origine: la filosofia di Kant” (Op.
cit., p. 4).
62
B. Nardi, Dante e la cultura medievale, Bari 1983, p. 4.
63
E. Gilson, Dante e la filosofia, tr. it., Milano 1987, p. 148.
64
G. Gentile, Studi su Dante, Firenze 1990.
65
Il curatore della citata edizione scolastica del Convivio dichiara che il suo intento è quello di proporre “un
disincantato confronto con alcuni passi centrali del Convivio, grazie al quale possa emergere quanto basta a fare di
Dante non solo un vero filosofo e, più specificamente, il precursore di una nuova apertura concettuale quale quella che
verrà a determinarsi nel corso del quattrocento, nella forma di una radicale renovatio cultural-filosofica, bensì, in modo
assai più radicale, il luogo di formazione di una ratio, e dunque di una corrispondente idea mundi, rispetto alle quali il
cosiddetto rinascimento non si muoverà sostanzialmente neppure di un passo” (M. Donà, l. cit., p. 5). In conclusione, si
deve ammettere che “un serio confronto con il pensiero di Dante finisca per equivalere, sic et simpliciter, alla perfetta
comprensione della forma mentis auattro-cinquecentesca” (ib.). Sarà nostro intento, invece, quello di mettere in risalto
la differenza del pensiero di Dante rispetto a quello che sarà elaborato di lì a poco nel nuovo clima umanisticorinascimentale. In particolare, anticipiamo che la nota dominante di tale differenza è costituita dalla consapevolezza del
limite dell’uomo e del necessario intervento della Provvidenza divina, mentre l’umanesimo rinascimentale sarà fondato
sull’eliminazione di tale limite e sul riconoscimento della stessa natura divina dell’uomo. Il senso della lontananza tra
Dio e l’uomo, ancora presente in Dante, nonostante la fiducia in un’ascesi mistica che conduca fino alla contemplazione
dell’essenza divina, a poco a poco svanisce nella coscienza rinascimentale, troppo dominata dal “ritorno” alla temperie
spirituale classica (caratterizzata, come è noto, dal sentimento della presenza del divino nel mondo). Il tormento
A questo proposito, bisogna avvertire che l’originale sintesi dantesca si pone, tuttavia, in riferimento alle
fonti della filosofia antica e medievale e specialmente a quelle della teologia cristiana. Ad esempio, Dante, al
termine del suo viaggio, potrà contemplare direttamente Dio, sarà, cioè, ammesso a compiere
quell’esperienza mistica che rappresenta l’obiettivo di San Bernardo e dello stesso San Bonaventura; e ciò in
quanto a lui è concesso ciò che è riservato alle anime beate. Si può dire quanto si vuole che in questo modo si
esalta l’autonomo potere dello spirito umano; ma l’iniziativa è riservata ancora a Dio. E Dante pone come
punto centrale della sua concezione la distinzione tra ciò che rientra nel pieno potere dell’uomo e ciò che,
invece, è riservato alla grazia divina. Tale distinzione verrà in gran parte meno nella cultura rinascimentale.
La creazione del mondo
Dante affronta il problema della creazione del mondo nel canto XXIX del Paradiso. Siamo nel Primo Mobile e
il poeta contempla già Dio come un punto luminosissimo che lo abbaglia e i nove cerchi dei motori angelici
giranti intorno. Beatrice, dopo averlo ragguagliato intorno ai movimenti di quei cerchi, spontaneamente gli
fornisce spiegazioni sulla creazione nel suo insieme. Dio, dice, si è mosso all’opera della creazione
dell’universo non perché in tal modo la sua natura conseguisse la perfezione ma solo perché il suo splendore
potesse rifulgere dapprima in una dimensione reale eterna, fuori di ogni tempo e di ogni spazio. Perciò in
primo luogo Dio ha creato gli angeli, facendoli sbocciare dalla sua sostanza, come da una pianta sbocciano i
fiori. Né si pone la questione intorno a ciò che Dio facesse prima della creazione, poiché la creazione è opera
che avviene nell’eternità, in una dimensione che non ammette né un prima né un dopo. E la creazione
avviene, secondo, Dante in virtù di un atto unico e contemporaneo per tutti gli aspetti dell’universo. Questo,
cioè, è creato nel suo insieme in virtù di un atto solo. Perciò Dante dice che insieme Dio ha creato le realtà
puramente spirituali, costituite di essenza pura e pura forma, quelle costituite da forma e materia e quelle,
infine, di sola materia. Sono stati, perciò, creati insieme gli angeli, i cieli e la terra. La creazione ha
riguardato, pertanto, le tre nature sostanziali: le pure forme spirituali e immutabili, eterne, cioè le nature
angeliche; la materia come potenzialità di dar luogo a enti reali per influsso di princìpi formali attivi;66 i cieli,
costituiti già di forma e materia e anch’essi immutabili nella loro costituzione. La sfera terrena, come è
evidente, è quella della continua formazione e trasformazione degli enti (in rapporto ai processi di unione di
forma e materia e, dunque, di passaggio all’atto di realtà potenziali). Dio, dunque, ha creato le essenze
angeliche, che sono un riflesso diretto della sua natura, in quanto riproducono l’essere eterno, fuori del
tempo e dello spazio; quindi ha creato i cieli, in quanto anch’essi eterni e immutabili, poiché in essi l’unione
di materia e forma è stabilita una volta per sempre; e infine ha disposto i princìpi della formazione degli enti
terreni. Le tre nature o essenze sono state create in modo da avere, ciascuna, una forma di esistenza e di
realtà propria, perfetta rispetto al suo ordine. E come in vetro, in ambra od in cristallo/ raggio risplende sì, che dal
venire/ a l’esser fratto non è intervallo,/ così ‘l triforme effetto del suo sire/ ne l’esser suo raggiò insieme tutto,/ senza
distinzione in esordire (vv. 25-30). La creazione è avvenuta in modo istantaneo, così come istantaneamente un
raggio luminoso si riflette attraverso un corpo trasparente. Così immediata è stata anche la disposizione
dell’ordine dell’universo. Più in alto sono state collocate le sostanze puramente spirituali, consistenti di
“puro atto” o di pura forma; più in basso sono state poste le realtà materiali, costituite da “pura potenza”,
cioè gli enti che si formano in seguito all’unione di forma e materia, esistono nello spazio e nel tempo e sono
soggetti a trasformazione; e nella zona intermedia gli enti costituiti definitivamente dall’unione di materia e
forma, in modo da avere esistenza eterna e immutabile.
Dante riporta quindi la tesi di San Girolamo, secondo la quale gli angeli sono stati creati in un tempo
lungamente precedente a quello in cui è stato creato l’universo. Egli dimostra l’inverosimiglianza di questa
tesi, osservando, in primo luogo, che in tal modo gli angeli se ne sarebbero stati per lungo tempo inoperosi,
dell’errore e del peccato è ben vivo in Dante, così come è forte l’ansia di una liberazione. L’opera dantesca è basata su
questa potente sete di liberazione, che è anche sete di grazia e di nuova religiosità.
66
Dio ha creato, pertanto, quella che si può dire la prima materia e che può definirsi come pura potenza. Il problema
relativo all’azione diretta di Dio nella creazione del mondo materiale era motivo di ampio dibattito nella filosofia
medievale. Avicenna aveva spiegato che la derivazione degli enti da Dio avviene per emanazione, attraverso la
mediazione gerarchica, per cui gli enti superiori sono causa di quelli inferiori. Così dall’azione dei cieli deriverebbero le
cose terrene. San Tommaso rifiutava ogni traccia di emanatismo e, considerando la materia come pura potenzialità,
ammetteva un intervento di Dio nella creazione degli enti composti di materia e forma. I filosofi che, come Enrico di
Gand e Duns Scoto attribuivano alla materia una certa forma, ritenevano la sola materia opera diretta di Dio. Dante
accoglie il concetto platonico (cfr. Timeo, 41 a-c) di una materia informe, ricettacolo di tutte le forme. Così egli pensa
alla sostanza puramente materiale (precisamente l’opposto della sostanza spirituale, che è pura forma o puro atto).
mentre essi sono stati creati con la funzione di presiedere al movimento delle sfere celesti. E ricorda che la
“verità” da lui condivisa è quella riportata in molti passi della Bibbia e che è suffragata dalla ragione.67
Nel Convivio Dante sembra accogliere la dottrina della creazione mediata, secondo la quale il mondo
corporeo è stato creato da Dio non direttamente ma attraverso la mediazione degli angeli.68 In questo senso,
egli afferma che gli angeli conoscono Dio come la propria causa e il mondo come il proprio effetto.69 Così le
intelligenze celesti finiscono per costituire le “specialissime cagioni” della forma umana e “d’ogni forma
generata”.70 I cieli, per l’azione delle potenze angeliche che presiedono al loro movimento, appena creati,
hanno incominciato a esercitare la loro influenza sulla materia, concorrendo, con la loro “virtù informante”,
ad attuare le forme dei quattro elementi e, quindi, quelle delle “cose che di lor si fanno”. I cieli, così, per
mezzo della luce e del moto, sono la causa di tutte le forme che si presentano nel mondo.
Un posto a parte è occupato dall’uomo, la cui creazione è considerata come un evento successivo,
giustificato dalla volontà divina di ricostituire l’ordine angelico venuto meno in seguito alla ribellione di
Lucifero e degli angeli ribelli suoi seguaci.71 E’ questa la tesi per la prima volta sostenuta da Origene,
secondo il quale, appunto, Dio ha creato dapprima gli enti spirituali e, quindi, ha creato la terra come luogo
di punizione del peccato. S. Agostino a sua volta era convinto che l’uomo fosse stato creato da Dio con lo
scopo di ripristinare l’ordinario ordine degli angeli.72 E S. Girolamo precisava che doveva trattarsi della
costituzione di un ordine angelico nuovo, quello decimo.73 Si riteneva che quando fosse stato ricostituito il
numero degli spiriti e riparati gli effetti dell’”angelica ruina” avrebbe avuto fine il movimento dei cieli e
sarebbe finito anche il corso del tempo.74
L’uomo è stato posto dapprima nel paradiso terrestre, fuori del “turbar che sotto da sé fanno l’esalazion
de l’acqua e della terra”, 75 ma per sua colpa perse il dono dell’immortalità ed ebbe come sua dimora la terra.
Origine e costituzione dell’anima
67
San Tommaso sembra a questo proposito la principale fonte dantesca. Egli, infatti, aveva difeso la tesi della
contemporanea creazione degli angeli e dell’universo. Per l’Aquinate, gli angeli fanno parte dell’universo, hanno una
precisa funzione nell’ordine cosmico e non costituiscono una sfera separata del creato. L’ordine dell’universo è
garantito dalla presenza delle potenze angeliche e non sarebbe possibile senza la funzione e l’attività di esse. E
quest’ordine rappresenta un tutto unitario, in cui non possono sussistere entità separate: Nulla autem pars perfecta est a
suo toto separata (Summa theologiae, I, q. 61, a. 3). L’osservazione relativa all’improbabilità che sostanze create per
svolgere la funzione di motori dei cieli rimanessero per lungo tempo senza esercitare la loro specifica attività è presente
nel commento di Averroè alla Metafisica di Aristotele.
68
Questa tesi era stata fortemente avversata da San Tommaso, il quale la faceva risalire a Simon Mago (che dagli
antichi Padri era ritenuto il fondatore della setta degli Gnostici) e osservava come essa fosse stata professata da
Avicenna e si trovasse esposta anche nel Liber de causis.
69
Convivio, III, VI, 4-5.
70
Invece per San Tommaso le intelligenze celesti hanno la funzione di “movere ad formam” e non di “inducere
formam”, sicché alla prima produzione delle forme destinate a modellare la materia non bastano i moti celesti, ma
occorre la preesistenza delle forme stesse poste da Dio.
71
Cfr. Convivio, II, V, 12: “Dico che di tutti questi ordini si perderono alquanti tosto che furono creati, forse in
numero de la decima parte; a la quale restaurare fu l’umana natura poi creata”.
72
De Civitate Dai, XXII, 1.
73
Homil., XXXIV, 6: “Novem sunt ordines angelorum. Sed ut compleretur electorum numerus, homo decimus
creatus est”. Questa tesi era ampiamente diffusa e condivisa negli ambienti teologici. Pietro Lombardo così
efficacemente la sintetizza: De homine quoque in Scriptura reperitur, quod factus sit propter restaurationem angelicae
ruinae (Sent., II).
74
Sul modo in cui, nell’ambito della teologia medievale, si riteneva che i beati ristabilissero l’ordine degli spiriti,
riportiamo questa sintesi del Nardi: “Si discuteva tra i teologi medievali, se tutti gli uomini degni della beatitudine
eterna, o almeno una parte di essi, vengano assunti ai nove ordini angelici, oppure se formino un decimus ordo.
Tommaso, In Sent., dist. 9, q. 1, a. 8, riferisce tre opinioni. La prima, seguita dal vescovo Eustrazio, negava che gli
uomini potessero essere assunti agli ordini degli angeli, e riteneva che tutti gli uomini salvi costituissero un decimo
ordine. La seconda opinione era di coloro secondo i quali ‘solum virgines ad ordines assumentur’, mentre tutti gli altri
eletti formano il decimo ordine. La terza opinione poneva ‘quod perfecti assumentur ad ordines angelorum, sed illi qui
sunt imperfectorum meritorum decimus ordinem consummabunt’. Per conto suo l’Aquinate dichiara: ‘Tertia positio
mihi placet, quae etiam dictis sanctorum magis consonat, scilicet, quod omnes electi assumantur ad ordines angelorum,
quidam ad superiores, quidam ad inferiores, quidam ad medios, pro diversitate suarum meritorum; sed beata Virgo
maria super omnes’. Dante invece riunisce tutti gli uomini beati nella candida rosa, facendo di tutti un decimus ordo”
(Bruno Nardi, Dante e la cultura medievale, Bari 1949, p. 334, nota 83).
75
Purgatorio, XXVIII, 97.
Sul problema dell’origine dell’anima umana, Dante si attiene specialmente alla teoria di Aristotele, esposta,
in particolare, nei primi capitoli del II libro del De generatione animalium e poi divenuta oggetto di
interpretazione d di dibattito tra i commentatori greci, arabi e latini.
Aristotele, per spiegare la capacità formativa del seme, ammette che “nel seme di tutti gli animali è
presente ciò che rende fecondi i semi: ciò che è chiamato caldo” e che questo “non è fuoco, né una facoltà
simile al fuoco, ma il pneuma”, la cui natura “è analoga all’elemento di cui sono costituiti gli astri”.76 Gli
scolastici chiamarono “virtù formativa” o “informativa” quella posseduta dal seme maschile, attribuendo ad
essa la facoltà di dare impulso e presiedere alla formazione e allo sviluppo del nuovo organismo vivente.
Essi, poi, identificarono ciò che rende fecondi i semi con la virtù degli astri, una specie di calore proveniente dai
cieli e recante le “ragioni seminali”, dunque tale da essere la causa di tutto ciò che si genera sulla terra. Inoltre, i
filosofi medievali distinguevano una terza virtù, risultante dalla mescolanza dei quattro elementi terrestri e
che costituisce la particolare complessione del seme.
Questa distinzione viene accolta da Dante nel Convivio. La “vertù formativa”, aiutata dalla “vertù del
cielo”, unendosi alla materia, costituita dal “sanguis menstruus”, organizza l’embrione e dà luogo alla vera e
propria anima vegetativa e sensitiva. “La vertù formativa prepara gli organi a la vertù celestiale”, dice
Dante. Dunque, questa è la causa che rende possibile il passaggio dalla potenza all’atto. Nel seme, infatti,
l’anima è solo in potenza. “La vertù celestiale […] produce da la potenza del seme l’anima in vita”. L’anima
vegetativa e sensitiva è tratta “dalla potenza del seme”. Quest’anima, infine, “riceve da la virtù del motore
del cielo lo intelletto possibile”. Così nel XXV canto del Purgatorio (vv. 38 sgg.) Dante dice che la virtù attiva
del seme, cioè la virtù informativa, dapprima dà luogo all’anima vegetativa, quindi concorre a creare gli
organi preposti alla sua facoltà d’anima sensitiva. Così la virtù ch’è del cuore del generante, cioè la virtù
informativa, si dispiega in tutto l’organismo, per attuarvi “le posse ond’è semente”.
Fin qui la generazione umana non si differenzia dalla generazione degli altri animali. Ciò che fa sì che
l’anima dell’uomo si completi con l’acquisizione della capacità intellettiva è la “vertù del motore del cielo”,
cioè di Dio. Il principio vegetativo e sensitivo è ciò che lo “spirito novo”, spirato nell’uomo dal primo
motore, trova attivo nel feto, e che esso “trae in sua sustanza”, in modo che il tutto costituisca un’anima
caratterizzata dalla capacità intellettiva: e questa è da considerarsi una sola sostanza. Dante ricorre all’analogia
del cibo che è tratto nella sostanza dell’organismo mediante il processo dell’assimilazione, per dare un’idea
del modo in cui l’anima vegetativa e sensitiva è tratta dallo “spirito novo”, proveniente da Dio, e così
assimilata alla sostanza intellettiva. Egli, d’altra parte, si rende conto della difficoltà d’intendere questo
processo, sicché dice che “pare maraviglia, come cotale produzione si può pur conchiudere e con lo intelletto
vedere”.77 Questa difficoltà aveva indotto molti filosofi, come lo stesso Averroè, a mantenere distinto
l’intelletto dall’anima sensitiva.
Sembra che Dante, nell’impostazione dell’intero problema, segua una via di mezzo tra le dottrine che
ammettevano la pluralità dei princìpi animati e la dottrina di S. Tommaso, rigorosamente monistica. Dante
ammette che i princìpi animati sono distinti e che essi si “accendono” l’uno sull’altro. Così l’anima
vegetativa e sensitiva è nel seme in potenza e la virtù del cielo concorre a trarla dalla potenza all’atto.
Dunque la formazione dell’organismo appartiene all’opera della natura, che dispone nel seme le potenzialità
della vita e del senstire e fa, quindi, passare all’atto tali potenzialità mediante l’intervento della “vertù
celestiale”, cioè dell’azione dei cieli (alla quale risale ogni processo di formazione, sulla terra, di nuovi
organismi). Ma, per Dante, l’anima razionale, infusa direttamente da Dio, è tale che assimila a sé i princìpi
inferiori, sicché, infine, si deve parlare di un’“alma sola”.78 Così l’anima razionale, infine, diventa il principio
attivo di tutte le funzioni psichiche, di quelle intellettive non meno che di quelle vegetative e sensitive. San
Tommaso, più coerentemente, afferma l’unità della forma sostanziale, eliminando la pluralità dei princìpi.
L’immortalità dell’anima
Le ragioni riconosciute da Dante come fondamentali per dimostrare l’immortalità dell’anima sono esposte
sinteticamente nel Convivio (II, VII, 8-13). Esse sono tre: 1) il “consensus philosophorum”; 2) il desiderio e la
speranza di una sopravvivenza, che sono insiti alla stessa natura umana; 3) “le divinazioni de’ nostri sogni”.
76
Aristotele, De gen. an., II, 3.
Convivio, IV, XXI, 6.
78
[…] sì tosto come al feto/ l’articular del cerebro è perfetto/ lo motor primo a lui si volge lieto/ sovra tant’arte di
natura, e spira/spirito novo di virtù repleto,/ che ciò che trova attivo quivi, tira/ in sua sustanzia, e fassi un’alma sola,/
che vive, e sente, e sé in sé rigira. (Purgatorio, XXV, vv. 68-75).
77
I primi due argomenti si riconducono, in effetto, a uno solo, in quanto il “consensus omnium gentium”
deriva dal fatto che in tutti gli uomini vi è un desiderio naturale d’immortalità. Ora, se questo desiderio fosse
vano, ne deriverebbe che l’uomo, anziché il più perfetto degli animali, sarebbe il più imperfetto: infatti la
stessa ragione della sua perfezione sarebbe illusoria. Dante riprende l’argomento del desiderio naturale
dell’immortalità da Cicerone e lo espone con linguaggio aristotelico.
L’argomento delle visioni profetiche che si hanno nei sogni ha origini stoiche e neoplatoniche e su di esso
si ha un’abbondante letteratura medievale. Il fenomeno delle “divinationes” e delle “divinae revelationes” si
avrebbe allorché l’anima rallenta i suoi legami col corpo: in quei momenti l’anima è “velut a corpore soluta
et expedita”; e questa condizione è provata dal fatto che “nobilissima operatio fortissima virtutis
intellectivae, quae prophetia vel revelatio est, tunc maxime viget, cum corpus infirmissimum est” (Domenico
Gundisalvi). Dante preferisce insistere sulla “proporzione” che deve esservi tra il rivelante e l’anima, ossia
sulla “conformitas animae humanae ad intellectus supernos celestes”.79 Infatti, come scrive Avicenna,
“animae humanae maiorem habent comparationem cum substantiis angelicis quam cum corporibus
sensibilibus”. La visione degli avvenimenti futuri non può essere comunicata che da Dio e dalle menti
angeliche, e specialmente dalle potestà angeliche che sono preposte ai moti celesti. In Purgatorio, XVII, 15-18,
Dante dice che talvolta l’immaginazione ci rapisce tanto fuori di noi stessi, che non sentiamo anche se
intorno a noi suonino mille tube, e in ciò riscontra la prova che quelle immagini sono prodotte in noi per
influsso dei cieli o per volontà di Dio. Il rivelante, perciò, può essere incorporeo (Dio e gli angeli) o corporeo
(i cieli): comunque esso, essendo immortale, informa ciò che è immortale, poiché “quello ch’è mosso o vero
informato da informatore immediato debba proporzione avere a lo informatore”.
Nel VII canto del Paradiso, poi, Dante apporta un nuovo argomento. Secondo questa più matura
concezione dantesca, l’anima umana è immortale perché creata direttamente da Dio. In quanto creata
immediatamente da Dio, l’anima umana non è soggetta all’influsso delle cause secondarie. Infatti, ciò che
deriva direttamente da Dio non perisce, perché quando Dio dà forma a qualche cosa, questa non è soggetta
ad alterazione: ciò che da essa sanza mezzo piove/ libero è tutto, perché non soggiace/ a la virtute de le cose nove (vv.
70-72). E’ chiaro, d’altra parte, che l’anima umana non sarebbe immortale se Dio stesso non le assicurasse
tale condizione. Così, in ultima analisi, è per un atto della volontà divina che l’anima partecipa della vita
eterna. E ciò si spiega con la bontà di Dio. Tale bontà diffonde nell’universo qualcosa della luce divina e il
punto più alto di questa diffusione si ha proprio là dove sono create altre entità immortali. L’anima umana,
in virtù della libertà e della immortalità, è ciò che più somiglia alla natura divina: più l’è conforme, e però più le
piace/ ché l’ardor santo ch’ogni cosa raggia,/ ne la più somigliante è più vivace (vv. 73-75).
Il processo della conoscenza
Dante muove dalla constatazione che nell’uomo è innato il desiderio di sapere: infatti ogni ente è inclinato a
raggiungere la propria perfezione e così l’uomo tende alla scienza, che è “ultima perfezione de la nostra
anima, ne la quale sta la nostra ultima felicitade”.80
Il processo della conoscenza si basa, conformemente alle dottrine dominanti nell’antichità e nel medioevo,
sull’intelletto, che ha la capacità di concepire le forme proprie (o essenze) di tutte le cose (e, dunque, i
princìpi di costituzione delle cose stesse).
Dante accetta la convinzione aristotelica che la conoscenza muove dalla sensazione. Le forme sensibili, del
resto, riflettono, nella loro esteriorità, la stessa interna costituzione delle cose. Le qualità sensibili che sono
colte con un senso specifico sono dette “sensibili propri” e intorno a questi non si danno possibilità di errori
(se le sensazioni avvengono in condizioni perfette); invece le qualità che “con più sensi comprendiamo” sono
dette “sensibili comuni” e la loro percezione può dar luogo ad errori.
A correggere tali errori interviene la capacità “cogitativa” o “estimativa”, che corrisponde a una forma di
sensibilità interiore (la cui funzione, però, è limitata al mondo delle impressioni sensibili e non riguarda i
concetti, che appartengono, invece, all’intelletto). Oggetto di questo senso interno è l’“intentio individualis”,
la forma corrispondente a un oggetto singolo: perciò l’attività dell’estimativa corrisponde a quella che nella
psicologia moderna è detta percezione (per cui, nell’ambito dell’esperienza, è riconosciuto un determinato
oggetto: ad esempio, io dico “questa è una casa”, “questo è un albero”, e così via). Lo stesso Avicenna già
distingueva questo “iudicium imaginabile coniunctum cum singularitate” (che riguarda un oggetto
determinato e colto mediante la percezione) rispetto al “iudicium intellectuale” (che riguarda un concetto
universale).
79
80
Tale espressione è di Alberto Magno.
Convivio, I, I, 1.
Un’altra funzione della sensibilità interna è quella immaginativa, per cui essa si qualifica come “fantasia”.
L’immaginazione (o immaginativa) agisce non in presenza di impressioni fornite dai sensi esterni, ma per
influsso di “lume che nel ciel s’informa”, cioè per l’influenza delle sfere celesti. A questa attività è connessa
la formazione delle immagini nei sogni, che hanno anche un carattere divinatore e premonitore (finanche
profetico).81
Vediamo ora come Dante interpreta il pensiero medievale sulla funzione dell’intelletto.
L’intelletto possibile, come abbiamo visto, costituisce la stessa anima razionale, infusa direttamente da Dio e
tale da assorbire nella sua sostanza l’anima vegetativa e sensibile. Esso “potenzialmente in sé adduce tutte le
forme universali, secondo che sono nel suo produttore, e tanto meno quanto più dilungato da la prima
Intelligenza è”.82 Questo intelletto possibile non può essere identificato con l’aristotelico “intelletto passivo”,
capace di diventare, su un piano di comprensione ideale, tutte le cose. Infatti Dante dice che l’intelletto
possibile adduce in sé, potenzialmente, le forme universali che, in modo archetipo, sono in Dio. Dunque in
ciò egli segue la dottrina platonico-agostiniana. Le forme universali sono, dunque, irraggiate nell’intelletto
possibile dalla luce della prima intelligenza. Così si spiega perché Dante non faccia menzione dell’intelletto
agente.83
La sensazione, mettendo l’intelletto a contatto delle forme esterne delle cose, promuove la sua attività, in
modo che esso da sé trae le forme universali (i concetti) che potenzialmente già possiede.
Dalla stessa originaria impressione delle forme universali nell’intelletto si alimenta la naturale inclinazione
dell’anima verso la conoscenza. La mente umana, così, aspira a tornare a quell’origine da cui provengono le
forme impresse in essa, cioè allo stesso Logos, che si identifica con la sapienza divina. L’illuminazione
divina, peraltro, non si limita a suscitare nell’anima il desiderio di sapere, imprimendo nell’intelletto le
forme universali e le prime notizie, ma sostiene l’intero svolgimento del processo conoscitivo, alla stessa
maniera in cui la virtù dei corpi celesti non solo imprime nella materia i germi attivi di tutte le cose che
nascono, ma aiuta tali germi a esplicarsi, passando dalla potenza all’atto. L’anima, sostenuta dal desiderio di
raggiungere la verità, ricerca di attivare i processi che conducono ad essa. Le impressioni sensibili esercitano
una prima fondamentale azione di stimolo; i sensi forniscono il primo materiale, che costituisce l’occasione
per lo sviluppo dell’attività intellettiva. E Dante insiste sullo spirito della ricerca, che sostiene l’attività della
ragione: attraverso il dubbio e la ricerca, si procede nel cammino della conoscenza.
Nel Convivio Dante considera la sapienza come una forma unica di conoscenza, che comprende l’intera
verità e, quindi, la totalità stessa dei modi e delle vie attraverso cui l’uomo realizza il suo desiderio di sapere.
Infatti è da tenere presente che l’uomo è sostenuto da Dio nel processo della conoscenza, sicché la
rivelazione fa parte del complesso della conoscenza umana, in quanto questa è fondata sulla Sapienza
divina. Così la Sapienza non è solo la filosofia ma è lo stesso Logo giovanneo, la Sapienza per mezzo della
quale Dio ha ordinato l’universo. In tal modo si stabilisce il nesso inscindibile di ragione e fede.84
Un altro punto è da tenere presente: esso riguarda il modo particolare in cui si sviluppa il processo
conoscitivo in ciascun individuo. Benché, infatti, la luce divina, che irraggia nell’anima razionale le forme
universali e le prime notizie, sia unica, tuttavia si diversifica in ciascun individuo il modo in cui esse via via
vengono richiamate nel sapere in atto. Ogni individuo, così, seguendo una via del tutto particolare, muove
dalla materia fornita dai sensi e poi, via via, esplica il sapere, riuscendo a riconquistare, attraverso il
superamento progressivo delle forme particolari, nozioni universali e comuni.
Nello sviluppo di questo processo una funzione importante è svolta dal linguaggio. Dante afferma che solo
tra gli uomini si giustifica l’esistenza del linguaggio; contrariamente all’opinione di San Tommaso, egli nega che
gli angeli abbiano la facoltà di parlare: infatti le nature angeliche, essendo sostanze puramente intellettuali,
sono del tutto trasparenti le une alle altre e non hanno bisogno di ricorrere ad alcun mezzo per rivelarsi il
pensiero da cui pure sono pervase. Invece gli uomini hanno bisogno di comunicarsi reciprocamente il loro
pensiero: ogni soggetto ha qualcosa da dire al suo simile, qualcosa che appartiene alla sua individuale
esperienza, impressioni e concetti che egli solo possiede e che gli altri ignorano. L’identica natura razionale
81
L’azione delle stesse intelligenze motrici dei corpi celesti si comunica alla mente umana allorché questa è più
libera dalle immagini fornite dalla percezione diretta: […] la mente nostra, peregrina/ più da carne e men de’ pensier
presa,/ a le sue vision quasi è divina (Purgatorio, IX, 16-18). Questa dottrina risale piuttosto alla tradizione platonica e
si riscontra, oltre che in Avicenna, nei libri ermetici.
82
Convivio, IV, XXI, 5.
83
Come osserva B. Nardi: “la funzione essenziale dell’intelletto agente è già attribuita da lui, in conformità della
metafisica neoplatonica, alla virtù divina che raggia nella mente dell’uomo” (Dante e la cultura medievale, cit., p. 191).
84
“Anzi che distinte, la ragione e la fede, la filosofia e la teologia, sono, nel Convivio, costantemente confuse tra loro
e formano in fondo una cosa sola” (B. Nardi, Dante e la cultura medievale, cit., p. 204).
(e il fatto che le forme universali provengono dalla medesima fonte) fa sì che gli uomini si intendano fra loro.
E per la comunicazione una funzione essenziale è svolta dai segni, cioè dalle parole.
L’estetica dantesca
Anche nell’estetica Dante si rifà a concetti della filosofia medievale e specialmente a San Tommaso.
Ricordiamo alcune tesi fondamentali della tradizione estetica medievale: 1) la bellezza sensibile rimanda
alla bellezza spirituale, intelligibile; 2) ogni bellezza imperfetta rimanda alla bellezza perfetta, divina: essa è
un riflesso di questa e tende alla medesima; 3) il bello differisce concettualmente, ma non “in re”, dal bene; 4)
la bellezza consiste nella congruenza e proporzione (“consonantia”) e nella chiarezza (“claritas”).
San Tommaso nella Summa theologiae definisce “belle” quelle cose che “viste piacciono” (quae visa placent) e
dice che “bello” è “ciò la cui stessa percezione procura piacere” (cuius ipsa apprehensio placet). E’ da notare che
nella concezione medievale “vista” (visio) e “percezione” (appregensio) non erano limitate alla sensazione: si
parlava di visio intellectiva, e così anche di visio supernaturalis; analogamente si parlava di apprehensio non solo
per sensum ma anche per intellectum.
Nelle definizioni di San Tommaso sono inclusi due modi di intendere il piacere estetico: uno oggettivo,
prodotto dalle cose viste e caratterizzato dall’attribuzione a queste della qualità fondamentale della bellezza;
l’altro soggettivo, prodotto dall’atto del vedere.85
San Tommaso distingueva il bello dal bene: il bello è ciò che è oggetto di contemplazione e non di
desiderio; il bene, invece, è ciò che è oggetto di desiderio e che costituisce il fine al quale aspiriamo. Il bello,
dunque, si definisce non solo rispetto a una qualità oggettiva, ma anche rispetto a un sentimento soggettivo;
esso è strettamente legato al piacere provocato dall’atto della visione e della contemplazione.
La bellezza, in senso oggettivo, deriva dalla “commensuratio” (cioè dalla proporzione) e dalla
“convenientia” (cioè dalla corrispondenza). Tommaso intende la “proporzione” in senso molto ampio: non
solo, cioè, in senso quantitativo, ma anche come relazione della forma e della materia, della copia e del
modello, della cosa con l’idea, della cosa con se stessa (cioè nel senso dell’armonia intrinseca). La
proporzione produce la bellezza allorché essa è rispondente al fine o all’essenza di una cosa: così la
proporzione conveniente al corpo umano è quella appropriata all’anima umana e alla sua attività.
Ma la teoria del bello in San Tommaso non riguarda l’arte: la bellezza, per San Tommaso, come per la
maggior parte degli Scolastici, riguarda l’armonia della natura. Ma, poiché “l’arte imita la natura”, il bello
riguarda anche le opere d’arte. Tutte le arti, perciò, producono oggetti belli. “Nessuno rappresenta e dipinge
se non qualcosa di bello” dichiara l’Aquinate; e le opere d’arte “sono nient’altro che disposizione, ordine e
forma”. Ma la bellezza delle opere d’arte non è rivolta solo a procurare piacere, in quanto le arti producono
oggetti che hanno una utilità e uno scopo.
Dante accoglie il concetto tomistico della bellezza: scrive, ad esempio: “E quando egli [un corpo] è bene
ordinato e disposto, allora è bello per tutto e per le parti, ché l’ordine debito delle nostre membra rende un
piacere non so di che armonia mirabile”.86 Ma egli si riferisce in modo particolare alla bellezza dell’arte. E
specialmente si riferisce alla poesia, la quale, in primo luogo, raggiunge la bellezza su un piano puramente
formale. Infatti la poesia, dice Dante, è in grado di commuovere anche coloro che non riescono a penetrare il
suo significato più profondo. Indipendentemente dal contenuto, dunque, la poesia si caratterizza per la
bellezza della forma. D’altra parte, la poesia è in grado di esprimere i significati più profondi e le verità più
ardue. I quattro possibili “sensi” che gli esegeti riscontravano nella Bibbia sono estesi da Dante all’opera
poetica. Questa raggiunge e realizza la compiuta compenetrazione e sintesi di contenuto e forma, mediante
figure e simboli che vanno oltre il senso letterale, che è pure il primo, e assumono un senso allegorico (cioè
“quello che si nasconde sotto il manto di queste favole, ed è una verità ascosa sotto bella menzogna”), quindi
un senso morale e, infine, quello anagogico (“quando spiritualmente si spone una scrittura, la quale eziandio
nel senso litterale, per le cose significate significa delle superne cose dell’eterna gloria”87).
85
“Nonostante la sua semplicità, la definizione di Tommaso è di grande importanza storica. Essa contiene due idee
fondamentali: in primo luogo le cose belle procurano piacere e ciò costituisce il criterio per cui le riconosciamo come
tali. In secondo luogo, non tutto ciò che procura piacere è bello, ma solo ciò che piace immediatamente nel momento in
cui è visto; infatti non chiamiamo bella una cosa che piace per altre ragioni, per esempio perché è utile. La prima di
queste idee si poteva trovare già nella prima Scolastica, per esempio in Guglielmo d’Alvernia; la seconda, invece, era
contributo originale di Tommaso. La cosa più importante tuttavia era il fatto che le due idee venissero unificate” (W.
Tatarkiewicz, Storia dell’estetica, tr. it., vol. II, Torino !979, p. 280).
86
Convivio, IV, 25.
87
Convivio, II, 1.
Nella poesia, inoltre, Dante vedeva la sintesi tra esperienza e visione personale e verità (filosofica e
teologica). Perciò la sua poetica oltrepassa la prospettiva medievale, secondo la quale la poesia doveva
attenersi a regole e adempiere a funzioni strettamente didascaliche.88
La concezione politica e la missione di Dante
La riforma vagheggiata da Dante è rivolta al fine di instaurare un ordine universale basato sui due scopi
che sono propri dell’uomo: la felicità terrena e la beatitudine eterna. Il mondo storico e il regno celeste
costituiscono due sfere che implicano il conseguimento di una duplice perfezione: la giustizia e la pace sulla
terra e la beatitudine ultraterrena appartengono alla natura umana e implicano due ordinamenti distinti. Dio
stesso ha disposto i due “regimina” come “remedia contra infirmitatem peccati”: una Monarchia universale e
una Chiesa che sia libera da ogni preoccupazione terrena. “Una monarchia universale fondata sulla ragione,
e ordinata a moderare colla giustizia i rapporti tra le comunità ad essa inferiori e ad assicurare una perpetua
pace feconda di opere; città e regni soggetti all’impero e intenti a organizzare la vita civile “per diversi
offici”, secondo le diverse capacità e attitudini dei cittadini; classi sociali distinte sul ‘fondamento che natura
pone’, e premurose di assicurare nella giusta misura il fabbisogno a un tranquillo e riposato viver di
cittadini; una nobiltà costituita sulla virtù anzi che sulla nascita e sul censo, e tale da insegnare col suo
esempio il valore e la cortesia del popolo; famiglie patriarcali come quelle fiorentine del tempo di
Cacciaguida, quando la cupidigia di guadagni e il lusso eccessivo non le aveva ancora guastate; e per tutti
una vita che non si esaurisca nella ricerca dei beni materiali, ma permetta, a chi n’è capace, d’attendere
altresì al perfezionamento dello spirito per mezzo dell’arte e della scienza, sì da realizzare quell’ideale di vita
felice assegnato all’uomo sulla terra dall’Etica di Aristotele; infine, accanto a questi istituti soggetti
all’impero, la chiesa di Cristo, libera da ogni cupidigia terrena e rivolta solo alla sua missione evangelica, di
additare agli uomini la via del cielo, insegnando con la dottrina e coll’esempio il distacco dai beni della terra;
e ordini monastici al suo servizio, come strumenti per combattere l’eresia”.89
Si tratta di un’utopia profetica, il cui valore certo non dipende dal fatto che essa sia attuata o no, bensì
dalla grande tensione spirituale e poetica di cui essa è espressione. In questo senso, la concezione politica di
Dante si pone come un grande mito capace di rappresentare la condizione costante dell’umanità, come una
soluzione che vale per ogni tempo e non solo per una determinata epoca. Quindi per noi l’utopia dantesca si
colora delle tensioni e dei problemi dell’umanità odierna, protesa principalmente a trovare definitivamente
la via della pace e dell’universale concordia. L’esigenza di un governo universale rappresenta oggi una
necessità, al cui soddisfacimento occorre por mano con il contributo di tutti gli stati e di tutti i popoli.
Dante: la poesia, la scienza razionale e la scienza teologica cristiana
Partendo dal presupposto che Dante è stato vero filosofo, si tratta di vedere di che tipo di filosofia si
tratta. Sarebbe mio intento di dimostrare che Dante ha elaborato un concetto originale di filosofia: una
filosofia per la quale si uniscono i ruoli del poeta e del teologo e si attua una sintesi originale di fede e
ragione. Virgilio e Beatrice rappresentano le componenti e le fonti di questo sapere filosofico: da una parte la
poesia e la ragione, dall’altra la fede e la teologia. “Scienza e Sapienza”: si può dire che intorno a questo
binomio ruoti l’intera produzione poetica dantesca.
Vediamo, dunque, di precisare in primo luogo il concetto dantesco di filosofia. Tutta la produzione dantesca è
di carattere filosofico. Anche la Vita Nuova, come è dimostrato dal fatto che in essa compare una parte in
prosa, in cui la narrazione della vicenda “amorosa” non è altro che una allegoria della vicenda sapienziale.
Beatrice è la teologia, il sapere in cui fede e ragione si uniscono e si fondono. E ciò a partire dalla Vita Nuova.
Si dà tutto uno sviluppo coerente dell’itinerario sapienziale di Dante. Il poeta attraversa il mito, il mistero,
l’enigma, il logos, la fede, e approda infine alla sapienza. La teologia, il sapere sapienziale cioè, è sempre
88
“Anche se per molti aspetti non ci fu un poeta e un pensatore più medievale di Dante, individuando una
connessione tra arte e bellezza, egli muove verso la poetica rinascimentale. Infatti, nonostante desiderasse attenersi alla
tradizione, egli impresse all’estetica un nuovo orientamento; la sua poesia, che si basava su presupposti scolastici, minò
la teoria scolastica della poesia: l’ascesa alla vetta soprannaturale del Parnaso non gli fece perdere di vista l’altra vetta.
L’antichità, al suo declino, aveva cominciato a collegare arte e bellezza; ora, alla fine del medioevo, avveniva la stessa
cosa. Così, anche se Dante assumeva questo nuovo atteggiamento soltanto nei confronti della poesia, il passo era ormai
fatto e non era difficile adottare lo stesso atteggiamento nei confronti delle altre arti” (W. Tatarkiewicz, op. cit., p. 316).
89
B. Nardi, Dante e la cultura medievale, cit., p. 413.
presente in una forma più o meno velata. L’apparizione di Beatrice è la prima rivelazione della sapienza. Si
tratta, all’inizio, ovviamente solo di una promessa. E lungo il cammino si danno difficoltà, sbandamenti,
errori. E’ possibile scambiare per scienza l’opinione ed è possibile allontanarsi dalla via della filosofia. Dante
anticipa il giudizio sugli errori moderni di una scienza della natura separata dalla sapienza teologica. La
“selva oscura” è sì la rappresentazione del peccato, ma è anche la rappresentazione dell’errore e della
scienza unilaterale.
La scienza moderna, a partire da Galileo, che ha inteso separare nettamente fede e scienza sperimentale, si
presenta come un sapere definitivo; essa intende essere il vero sapere che considera le leggi dei fenomeni.
Questa linea scientifica sarebbe il peccato della cultura occidentale. La scienza fondata esclusivamente sulla
ragione, come la filosofia hegeliana, sarebbe la vera illusione, che falsifica ogni approccio alla realtà e
impronta di sé tutti i nostri atteggiamenti e la nostra mentalità. A questo proposito un ritorno a Dante
potrebbe essere salutare. Noi abbiamo bisogno di “sapienza” e non solo di “scienza”. Abbiamo bisogno di
“sapere” verso quali territori culturali e spirituali andiamo, quali sono i nostri compiti, quali le condizioni
della nostra “salvezza”. Oggi ci troviamo veramente nella “selva oscura”: siamo disorientati, abbiamo
perduto tutte le certezze, si sono dissolte le speranze e la fiducia in un mondo migliore.
I recenti avvenimenti attestano, piuttosto, che oggi crescono le paure, si radicalizza l’incertezza,
aumentano le stesse possibilità del pericolo incombente sulla nostra vita e sulla nostra civiltà. Da ogni parte
avanzano i famosi “mostri”, prodotti dalla nostra incuria, dal fatto che non siamo riusciti ad essere custodi
attenti e premurosi della nostra dimora terrestre. Abbiamo, infatti, seminato veleni nell’atmosfera, nelle
acque, nel suolo; abbiamo sfruttato il pianeta con tutti i mezzi e in ogni modo; ogni giorno produciamo
milioni di tonnellate di rifiuti che non sappiamo ormai dove collocare; stiamo per sovvertire aspetti notevoli
dell’ordine naturale. E poi abbiamo creato fonti di conflitto e di odio, accresciuto le disuguaglianze sociali,
determinato sacche di povertà e di miseria, alimentato fanatismi, illusioni, intolleranze. Di ciò tutti siamo
responsabili. E’ questa, ora, la “selva oscura” di cui parla Dante: è ormai il mondo intero, questo pianeta che
non “sappiamo” abitare. E’ questa la situazione in cui si trova l’umanità: una condizione di errore e di
“peccato”. Siamo privi di “sapienza”, nonostante disponiamo di un immenso “sapere” scientifico.
Dante intende indicare all’umanità la via della sapienza: egli stesso si accinge alla realizzazione del grande
edificio della sapienza salvifica: Tutte le sue opere non sono altro che tappe di questo cammino. La Divina
Commedia è la grande sintesi del sapere sapienziale cristiano. Le altre opere sono tutte preparatorie e
convergono verso la sintesi conclusiva. In qualche modo potrebbero essere considerate come parti del
commento al maggiore poema. In esse troviamo esplicazioni, chiarimenti, annotazioni alle rappresentazioni
allegoriche della Commedia.
Dante, in questo modo, rivela tutta la sua attualità. Questa attualità si esprime in primo luogo sul motivo
del modo di intendere la filosofia. Questa si delinea come sapere totale e comprensivo, un sapere che deve dirci
qualcosa sul nostro destino; non deve configurarsi come un sapere puramente teorico, in grado di sviluppare
le più ardite argomentazioni sull’essere o sul nulla; deve, invece, costituirsi come consapevolezza e
illuminazione sul nostro modo di essere nel mondo.
Il motivo della sapienza appare costantemente nella storia della cultura. Prendiamo, ad esempio, Spinoza.
Il supremo grado della conoscenza, che consiste in una specie di amor Dei intellectualis, si configura come un
sapere intuitivo, che supera d’un colpo le argomentazioni e i ragionamenti. Evidentemente questa forma di
sapere si richiama alla fonte della fede: a una specie di rivelazione interiore. Nell’uomo è presente un
frammento dell’intelligenza divina. Ed è questa capacità superiore che si esprime al vertice dell’attività
intellettuale. Essa è alimentata dalla forte volontà di sapere. Per Spinoza è questa facoltà interiore che ha
ispirato e prodotto il contenuto stesso della verità rivelata. A un livello inferiore sta la conoscenza scientifica,
basata specialmente sul metodo della geometria. Il sapere scientifico ha la forma del sistema coerente di
argomentazioni e dimostrazioni. Il sapere empirico, a un livello inferiore, ha una finalità essenzialmente
pratica: serve per dominare i fenomeni ed eseguire i calcoli pratici. Al primo livello c’è il sapere dell’uomo
della strada, costituito da contenuti d’esperienza acquisiti senza senso critico e consapevolezza causale.
Anche per Spinoza, infatti, il principio causale è il principale elemento e fattore della scienza. E’ questo
principio che dà alle affermazioni e alle esposizioni nell’ambito delle scienze fisiche una vera e propria
concatenazione geometrica e dimostrativa.
Per Dante la filosofia rappresenta il tipo di sapere comprensivo che è basato unicamente sulla ragione.
Questo sapere può essere anche la rielaborazione di antichi miti per opera di poeti. In questo senso Dante
attribuisce un importante ruolo a Ovidio. Lo stesso Virgilio è poeta che dà una veste nuova ai miti antichi.
Omero, Virgilio, Ovidio sono i rappresentanti della sapienza poetica antica, che deriva dalla elaborazione di
miti antichi attraverso la ragione. Abbiamo anche qui una forma di sapere che va al d là della semplice
razionalità e tende verso la comprensione della sapienza. Si tratta di una poesia sapienziale fondata sulla
mitologia antica. Mentre la filosofia intende avvalersi della sola ragione, la poesia recupera ed eredita la
tradizione sapienziale più antica, quella consegnata alla mitologia. La poesia di Omero, Virgilio e Ovidio
rappresenta, quindi, il tipo di sapienza realizzato fuori della rivelazione biblica e cristiana. Essa è propria del
mondo pagano. Tuttavia, si tratta di sapere sapienziale, cioè di un sapere che intende andare oltre la stretta
sfera razionale ed empirica.
La sapienza pagana, in questo modo, appare realizzata in questa forma di sapienza. La poesia esprime,
pertanto, il sistema della sapienza antica precristiana. In questa sapienza un posto fondamentale è occupato
dalla filosofia. Ma la filosofia, in quanto sapere razionale, si configura con caratteri identici nel corso del suo
sviluppo storico. Virgilio non simboleggia la filosofia, dunque la sola ragione, considerata nella sua
autonomia, bensì simboleggia la sapienza poetica degli antichi, che è un sapere che va oltre la sfera della
ragione, cioè della filosofia, e attinge il suo contenuto principalmente dalla tradizione mitologica. La
“sapienza”, che è realizzata dai poeti, risponde ai grandi interrogativi sul senso della vita e sull’ordine eterno
del mondo.
Una questione di notevole rilievo, per la concezione dantesca, è costituita dal rapporto tra la poesia e la
filosofia. Dante rimprovera, a un certo punto, a se stesso di essere “poeta” e di coltivare esclusivamente la
poesia; e nello stesso tempo si riconosce “filosofo”. Che vuol dire tutto ciò? L’elemento che gli sembra che sia
escluso dai suoi stesi interessi è la “teologia”, il sapere basato sulla rivelazione biblica ed evangelica. Il
problema gli si presenta, dunque, nella costruzione di un sapere cristiano. Alla costruzione di un tale sapere
concorrono ora tre elementi: la filosofia, la poesia e la teologia. Beatrice, come è noto, simboleggia la teologia.
La “donna gentile” simboleggia, più che la filosofia, la poesia in sé. Dante ritiene che la poesia stilnovistica
sia in massima parte poesia realizzata secondo i canoni dell’antichità, che, dunque, essa si muova nell’ambito
della concezione pagana del mondo. Beatrice, espressione e simbolo della teologia cristiana, è il fattore
principale della costruzione della nuova poesia, che è espressione della sapienza cristiana. Dante stesso si
ritiene il poeta che nella sua opera realizza questa forma di poesia cristiana, che è nuova per i suoi tempi.
Vediamo dunque di cercare di tracciare l’itinerario poetico-sapienziale di Dante. Quando Dante scrive La
Vita Nuova, egli è consapevole di muoversi ancora sul piano della poesia tradizionale. Però la tensione di
andare oltre quella sfera poetica e realizzare un tipo di poesia teologica è già presente. Dante rimanda ad
altro tempo la realizzazione di un’opera in cui possa esprimere il contenuto della nuova sapienza poeticoteologica. La figura di Beatrice appare come quella di una donna il cui vero e completo influsso e significato
sarà attuato con la morte di lei. Intanto il poeta si muove nell’ambito della concezione stilnovistica e avverte
di non avere gli strumenti necessari per superarla. Dante è ancora un poeta dello Stilnovo: il motivo
dominante della sua ispirazione è l’amore per la donna-angelo, cioè una forma di amore trasfigurato dalla
spiritualità. Dante compie il suo apprendistato poetico: infatti il poetare secondo i canoni dello “Stil novo”
gli appare come una specie di appartenenza a una scuola; e ciò nel senso proprio dell’apprendistato. Il poeta
segue interamente la poetica stilnovistica; solo che accentua già il motivo teologico, l’allusione alla superiore
sapienza intorno alla salvezza. In particolare viene enfatizzato il motivo della corrispondenza fra mondo
terreno e mondo celeste: Beatrice è creatura venuta dal cielo nel mondo “a miracol mostrare”. La varietà dei
temi affrontati da Dante è già in qualche modo un preludio alla materia della Commedia. Si tratta di una
poesia considerata ancora come propedeutica, preliminare alla poesia compiuta, realizzata nella forma della
poesia teologica. La varietà dei temi intanto allude agli aspetti della vita del cristiano, compresi,
specialmente, i doveri politici e morali. La filosofia è principalmente guida morale dell’uomo. Si tratta,
perciò, di una poesia intesa come guida etica, riflessione sul significato della vita dell’uomo in questo
mondo.
Nella Commedia, poi, la poesia ingloberà l’intera sapienza: essa riguarderà nello stesso tempo l’etica e la
teologia, la vita nel mondo e il destino soprannaturale. Si può dire, in questo senso, che Dante ripercorra il
complesso iter della formazione poetica: egli vuole essere poeta “in toto”. La stessa materia della Commedia
implica un approfondimento progressivo della formazione poetica. Nel Paradiso Dante invoca l’aiuto dello
stesso Apollo, poiché non gli è più sufficiente quello delle Muse. E Apollo è qui allegoria di Cristo o di Dio
stesso come fonte della parola e della rivelazione. Per mezzo del poeta, cioè, si compie un’altra rivelazione,
supplementare a quella contenuta nei sacri testi. Dante, cioè, ha bisogno della fonte viva della rivelazione;
non gli bastano i testi sacri e i commenti dei Padri della Chiesa. In questo modo la poesia del Paradiso sta a
indicare il culmine della realizzazione poetica come sapienza cristiana. Si deve leggere il Paradiso come testo
teologico: in esso è esposta la sapienza cristiana in una forma aggiornata ai tempi. Le prime due cantiche
rappresentano un preludio e un’introduzione alla terza; esse contengono, sì, la sapienza teologica, ma non
parlano ancora di Dio stesso. Come è noto, il poema si chiude con la visione di Dio. Questa visione
rappresenta il culmine della sapienza teologica realizzata nella poesia. Si tratta, infatti, di una visione che si
attua nello spazio poetico del racconto dantesco. Ciò che conta è l’espressione e la comunicazione di
un’esperienza che non sarebbe stata possibile fuori della poesia. E’ nell’ambito della sapienza poetica che si
compie la visione di Dio: cioè nel campo della parola e al limite estreme del dicibile. La poesia, infatti, copre
lo spazio del dicibile e tocca il confine dell’ineffabile. Nel punto simbolico dell’incontro tra il dicibile e
l’ineffabile si compie l’esperienza della visione estrema, che è riservata i beati e si attua solo per via
soprannaturale. La poesia in qualche modo oltrepassa la sfera naturale e congiunge l’uomo a Dio, in qualche
modo lo riporta e lo conduce nello spazio del mistero. Tale è la sapienza per Dante, è l’esperienza poetica
estrema, la poesia come sistema teologico, che, infine, conduce l’uomo al limite della parola e lo pone di
faccia al mistero.
Dobbiamo imparare a considerare Dante come il nostro vero maestro: maestro di vita e d’esperienza.
Perciò dobbiamo abituarci a introdurre il poeta nella nostra vita quotidiana. Il poeta ci parla della complessa
vicenda umana e ci indica il cammino della salvezza. Noi auspichiamo che le lecturae Dantis si moltiplichino,
che ogni città istituisca la sua lettura pubblica del poema, secondo la consuetudine introdotta dagli stessi
Fiorentini dopo la morte del poeta. Ogni città si costruisce anche sulle fondamenta del pensiero morale, sulla
consapevolezza del compito etico e del limite umano che solo la sovrabbondanza della grazia divina può
colmare. Bisogna accostarsi al “divino poema” con lo spirito dell’apprendimento, con la sete del sapere
sapienziale.
La conoscenza attinta dalla lettura di Dante è una conoscenza completa, perché riguarda anche il nostro
destino storico. In particolare Dante ci insegna come possiamo superare le difficoltà del nostro tempo e
uscire dall’errore nel quale ci siamo imprigionati. L’umanità ha bisogno di sapienza ed è ancora il poeta il
liberatore: egli parla con lo spirito stesso della rivelazione divina. Nel Paradiso Dante parla dell’impero
universale, del governo unico dell’umanità. Si tratta di un’utopia, ma bisogna incominciare a lavorare perché
questa utopia diventi una realtà. L’umanità ha bisogno già di un governo mondiale.
Una nuova edizione del “Convivio” di Dante ripropone il problema dei tempi della poesia dantesca
Una nuova edizione del "Convivio" di Dante, con il commento di Cesare Vasoli e Domenico De Robertis
(“Opere minori”, Tomo I, Parte II, Ricciardi, pagg. 1107, L. 100.000), propone il problema dell’influsso della
corrente aristotelica, rappresentata specialmente da Alberto Magno e da S. Tommaso, sul pensiero dantesco.
Nella sua brillante e documentatissima “Introduzione” (che è un vero e proprio saggio, con le sue novanta
pagine) e nell’approfondito commento al testo, con note che sono, a loro volta, trattazioni organiche di
tematiche per lo più filosofiche, Vasoli esplicita tutte le questioni sollevate dal problema delle conoscenze
filosofiche di Dante e delle loro ascendenze antiche e medievali.
E’ indubbio che Dante fu attratto dal disegno di una piccola enciclopedia filosofica ad uso del pubblico più
vasto. Egli perciò tenne presenti le opere che si rendevano disponibili al suo tempo e gran parte delle quali
sono ignote a noi. La conquista dell’intelligenza di Dante è subordinata, pertanto, alla nostra possibilità di
accedere alla “biblioteca” che il poeta poté consultare.
Tra le opere conosciute da Dante e ignorate dai moderni, Vasoli segnala la “Super Ethica” di Alberto
Magno, cioè di un commento all’”Etica Nicomachea” compilato dal secondo grande rappresentante
dell’aristotelismo medievale. Lo studioso è convinto della maggiore influenza esercitata da questo
commentatore di Aristotele rispetto a quella dello stesso Tommaso. Alberto Magno appare come il maestro
medievale che ha di più influito sulla concezione filosofica e scientifica di Dante.
Lo stesso Gilson, che rappresenta, si può dire, la massima autorità in questo campo, ci presenta un Dante
poeta-filosofo che segue i testi di S. Tommaso per lo più alla lettera. In questo senso il pensiero e la visione di
Dante sono apparsi piuttosto compatti e rigorosamente improntati a un modello teologico preciso, appunto
quello tomista. Vasoli ci avverte, invece, degli esiti più apertamente problematici di Alberto Magno, il quale
non a caso fu maestro di Tommaso ma anche di Sigieri di Brabante, il pensatore che rappresenta l’ala
“eretica” dell’aristotelismo, con la sua adesione all’averroismo. D’altra parte, conosciamo l’orientamento
naturalistico di Alberto, dunque il suo interesse prevalente per la costituzione di una scienza autonoma delle
cose naturali.
In questo stesso senso si configura la concezione dantesca della “filosofia” come conoscenza autonoma
delle leggi dell’universo. L’interruzione del “Convivio” ebbe probabilmente come sua causa principale la
crisi maturata nella coscienza di Dante intorno al valore autonomo da attribuire alla filosofia. Il poeta
manifestò una vera e propria esclusiva “passione” per la filosofia, raffigurata nelle vesti della “donna
gentile”. Egli professò l’identità dello “studio” filosofico con l’amore essenzialmente mondano. Perciò nello
stesso “Convivio” a un certo punto (III, XII, 2) scriveva: “Per Amore intendo lo studio lo quale io mettea per
acquistare l'amore di questa donna”. E la donna di cui trattasi è la filosofia aristotelica. A ragione, perciò,
Vasoli osserva: “Perché a fondamento del discorso del Convivio sta la profonda persuasione che l'’auctoritas’
della Filosofia (e del filosofo per eccellenza, Aristotele, ‘il maestro di color che sanno’) deve essere sovrana e
libera nel suo dominio, e che il suo fine è indicare la sola felicità a noi possibile in questa vita”. In questa
stessa direzione sembra che vada interpretata la condizione di felicità mentale che tale studio/amore
procura. La canzone “Amor che ne la mente mi ragiona” rappresenta, a questo proposito, uno dei documenti
più eloquenti della concezione dantesca del sapere filosofico (nella fondamentale direzione aristotelica, pur
non senza una interna tensione teologica di ascendenza neoplatonica e agostiniana),
Dante ci presenta quindi la filosofia in figura o allegoria d'amore. Ma questa passione esclusiva per la
scienza razionale entra in crisi già alla fine del terzo Trattato. Vasoli mette bene in evidenza la frattura fra
questo e il successivo: nel Trattato IV, il poeta malinconicamente abbandona il tema dell’identità
studio/amore e rinuncia alle figurazioni allegoriche dell’amore come simbologia del sapere filosofico. Ciò
vuol dire che già Dante pensa al ristabilimento del rapporto tra la filosofia e la teologia e al significato che
ogni sapere deve assumente in rapporto al problema della salvezza, che ora emerge come l’unico e assoluto
problema dell’uomo.
Data per esaurita la trattazione delle virtù “etiche”, Dante affronta subito, nel Trattato IV, il problema
della trattazione teologica intorno alle quattro virtù cardinali. Polemicamente, si dichiara che le virtù etiche
non consentono il raggiungimento di nessuna felicità. La stessa scienza contemplativa, la filosofia, che
riguarda l’ordine dell’universo, in quanto riguarda le creature e non Dio stesso, risulta di ordine inferiore.
Soltanto lo sforzo inteso a raggiungere la beatitudine risulta pienamente giustificato in base alla stessa
natura umana. “L’uomo desidera per sua natura filosofare” aveva affermato Aristotele e aveva ripetuto
Dante all’inizio del “Convivio”; ora questa affermazione viene trasmutata nella seguente: “L’uomo desidera
per sua natura conoscere Dio”. E questa conoscenza non può conseguirsi che nella condizione di beatitudine,
per via del tutto soprannaturale.
La stessa canzone in apertura del Trattato IV, “Le dolci rime d'amor ch'i' solìa” si riferisce a un’esperienza
considerata conclusa e prelude a un discorso nuovo, cioè al discorso che attuerà la sintesi poesia/teologia.
In questo modo siamo all’ultimo e conclusivo livello dell’esperienza poetica di Dante. Allo studio/amore
subentra l’amore/verità, di cui simbolo è Beatrice trasfigurata, non più figura umana ma creatura celeste e
tramite di ogni rapporto tra l’uomo e Dio.
ii...
Tra i nominalisti, il più famoso è Roscellino di Compiègne (1050-1120), il quale, secondo la testimonianza di S. Anselmo, sarebbe
stato costretto dalla sua prospettiva a non poter comprendere nessuna realtà non sensibile e a intendere la stessa Trinità come costituita da
tre entità individuali diverse (“triteismo”), incorrendo nell’accusa di eresia.
iii...
In Spagna, sotto gli auspici dell’arcivescovo Raimondo di Toledo, si era formato un vero e proprio collegio di traduttori di opere
aristoteliche dall’arabo: Gerardo da Cremona, Domenico Gundisalvi, Giovanni Ispano tradussero, oltre ad opere di Aristotele, anche
scritti di Avicenna e di altri filosofi arabi.