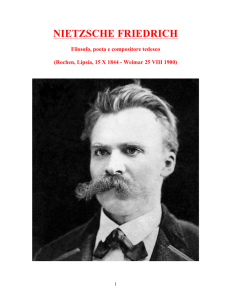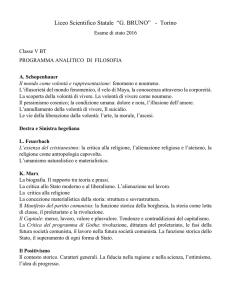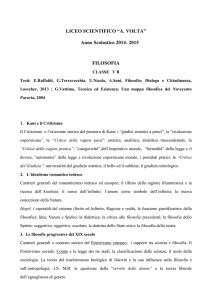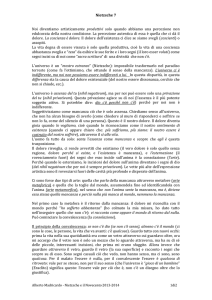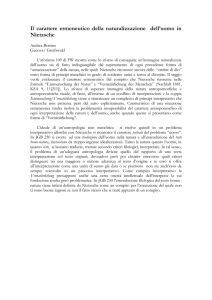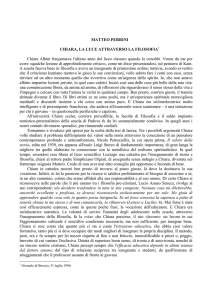International
RIVISTA QUADRIMESTRALE - ANNO XXVI
NUOVA SERIE - N. 83 –MAGGIO-AGOSTO 2014
1
This Review is submitted to international peer review
ISSN:1121-6530
Segni e comprensione International
Pubblicazione promossa nel 1987 dal Dipartimento di
Filosofia e Scienze sociali dell’Università degli Studi di Lecce,
oggi Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del
Salento, con la collaborazione del “Centro Italiano di Ricerche
fenomenologiche” con sede in Roma, diretto da Angela Ales
Bello.
General Editor/Direttore responsabile
Giovanni Invitto ([email protected])
Steering Comittee/Comitato direttivo
Giovanni Invitto, Università del Salento (Editor/Direttore
responsabile), Angela Ales Bello, Università Lateranense;
Angelo Bruno, Università del Salento; Daniela De Leo,
Università del Salento; Antonio Delogu, Università di Sassari;
Aniello Montano, Università di Salerno; Paola Ricci Sindoni,
Università di Messina.
Editorial board/Comitato editoriale
Jean-Robert Armogathe, École Normale Supérieure de
Paris (F); Renaud Barbaras, Paris I – Sorbonne (F); Francesca
Brezzi, Università di Roma 3 (I); ϯBruno Callieri, Università di
Roma 1 (I); Mauro Carbone, Université Jean Moulin Lyon 3 (F);
Giovanni Cera, Università di Bari (I); Claudio Ciancio,
Università del Piemonte Orientale (I);ϯFrançoise Collin,
fondatrice di «Les Cahiers du Grif» (F); Umberto Curi,
Università di Padova (I); Roger Dadoun, Université de Paris
VII-Jussieu (F); Franco Ferrarotti, Università di Roma 1 (I);
Renate Holub, University of California – Berkeley (Usa);
Roberto Maragliano, Università Roma Tre (I); William McBride,
Purdue University, West Lafayette, Indiana (Usa); Augusto
Ponzio, Università di Bari (I); Pierre Taminiaux, Georgetown
2
University (Usa); Christiane Veauvy, Cnrs (F); Sergio Vuskovic
Royo, Universidad de Valparaiso (RCH); Chiara Zamboni,
Università di Verona (I)
Team/staff di redazione
Siegrid Agostini; Daniela De Leo (responsabile); Lucia
De Pascalis; Maria Teresa Giampaolo; Alessandra Peluso;
Rosetta Spedicato.
Sede
Comitato Scientifico e Segreteria hanno sede presso il
Dipartimento
di Studi Umanistici, Università del Salento – Via M.
Stampacchia – 73100 Lecce – tel.0832.294627; fax
0832.294626. E-mail: [email protected].
Periodico iscritto al n. 389/1986 del Registro della
Stampa, Tribunale di Lecce.
3
Questa
rivista
è
sui
siti:
http:
//www.segniecomprensione.it; ha dei rimandi al Dipartimento di
Studi Umanistici e al Siba con i link: dipfil.unile.it
e siba-ese.unisalento.it
I numeri fino al 68 sono consultabili anche al seguente
sito http://www.mannieditori.it/rivista/segni-e-comprensione.
NOTE PER GLI AUTORI
I contributi scientifici devono riportare, prima del testo, il
titolo, Autore e il relativo istituto di appartenenza, indirizzo per
la corrispondenza e un abstract (di max 900 battute, scritto in
italiano/inglese/francese) con parole-chiave (fino a 5) ed
essere redatto secondo le norme redazionali riportate sul sito.
Per la sezione “Saggi” i testi non dovranno superare le
venti cartelle di 30.000 battute, spazi inclusi e comprese le note
bibliografiche. Per le “Note” non si dovranno superare le
10.000 battute, spazi e note inclusi, con le medesime
caratteristiche dei Saggi.
I testi vanno inviati alla Direzione, indirizzati alla
seguente e-mail: segniecomprensione@ libero.it.
I testi, in forma anonima, verranno esaminati da due
referees, esterni al Comitato Direttivo, e competenti nelle
diverse tematiche trattate dai contributi. Questi forniranno al
Comitato Direttivo gli elementi necessari per valutare la
correttezza e l’utilità, segnalando la necessità di modifiche o
integrazioni per migliorarne le caratteristiche o evidenziando gli
aspetti che, se non correttamente modificati, ne potrebbero
impedire la pubblicazione.
4
INDICE
Saggi
6
Moira De Iaco
IL COLORE COME NARRAZIONE
ESISTENZE IN COLORI
21
Cristina Manzo
LA RICERCA DELLA FELICITA/VIRTU DEGLI ANTICHI E
LA PRATICA FILOSOFICA NEGLI EPISTOLARI DI
EPICURO, SENECA E DESCARTES
Note
58
Elsa Martinelli
ILLUSORIETÀ DELL’IDEALE WAGNERIANO IN
NIETZSCHE
81
Andrea Mincigrucci
LE PAROLE SONO RIVOLTELLE CARICHE
PRATICA LETTERARIA, SITUAZIONE ED ENGAGEMENT
IN JEAN-PAUL SARTRE
Recensione
101
Antonio Stanca
L’ALTRO DELLA VITA
5
ESISTENZE IN COLORI
di Moira De Iaco
Se ciascuno di noi chiudesse gli occhi o improvvisamente diventasse
cieco il mondo continuerebbe a serbare i propri colori, proprietà insite
negli oggetti che lo costituiscono. Per quanto tuttavia siano proprietà
oggettive ed è perciò possibile accordarsi su di essi nella forma,
potremmo dire, universale del linguaggio, nonostante le diversità
linguistiche, mentre non è affatto possibile rivendicare una proprietà
privata che sia legata alla natura di rappresentazione mentale,
1
interna, privata del colore , i colori sono comunque legati in quanto
fenomeni, per giunta esemplari per la nostra riflessione e vedremo
perché, alla singolarità dei vissuti di ciascuno. E ciò li rende
particolari, molteplici, indefiniti, irriducibili. I colori sono molto più che
proprietà fisiche del mondo. Mostrano la capacità di svelare i
contenuti di una cultura, di un tempo, di un modo di vivere e di
pensare, nonché quella di narrare frammenti della nostra esistenza.
If we closed our eyes or suddenly became blind, the world would
continue to preserve his own colours, properties in the objects that
constitute it. The colours are objective properties and therefore it is
possible to agree on them in the form of language, in a certain sense
universal in despite of the different languages, but it is not possible to
consider them private properties connected with a supposed mental,
private, internal nature of the colour, however they are, as
phenomena moreover exemplars for our reflection, related to the
singularity of the experience of each. And this makes them particular,
multiple, undefined, irreducible. The colours are much more than
physical properties of the world. They are able to reveal the contents
of a culture, a time, a way of living and thinking and to narrate
fragments of our existence.
SAGGI
Abstract
6
Wenn jeder von uns die Augen schließen würde oder er plötzlich
blind wäre, würde die Welt ihre Farben, Eigenschaften in den
Objekte, bewahren. Die Farben sind objektive Eigenschaften und es
ist daher möglich in der Form der Sprache, der trotz der sprachlichen
Vielfalt in einem bestimmten Sinn universell ist, einverstanden und ist
es stattdessen nicht möglich die Farbe als a Privateigentum für ihre
vermutliche geistige und interne Natur betrachten, jedoch sind sie als
Phänomene mit der Singularität unseres Erlebnis verbunden.
Deshalb sind sie besonders, undefiniert und irreduzibel. Die Farben
sind viel mehr als physikalische Eigenschaften der Welt. Sie können
den Inhalt einer Kultur, einer Zeit, einer Art zu leben und zu denken,
zeigen, und die Fragmente unserer Existenz erzählen.
Si chacun d’entre nous fermait les yeux on tout d’un coup
devanait aveugle, le monde continuerait à garder ses couleurs,
propriétés entrinsèques des objects qui le constituent. Pur
autant qu’elles soient des propriétés objectives et c’est donc
possible de s’accorder autour d’elles pour ce qui concerne la
forme, on peut dire, universelle du langage, nonobstant les
différences langagières (alors que ce n’est pas du tout possible
de revendiquer une propriété privée qui soit liée à la nature de
représentation mentale, intérieure, privée de la couleur), les
couleurs restant quand même liées en tant que phénomènes,
en plus de phénomènes exemplaires pour notre réflexion et on
verra dans quel sens, à la singularité des vécus de chacun.
C’est ça qui les rende particulières, multiples, indéfinies,
irréductibles. Les couleurs sont bien plus que propriétés
physiques du monde. Elles montrent la capacité de dévoiler les
contenus d’une culture, d’un temps, d’une façon de vivre et
penser, ainsi que la capacité de narration de fragments de
notre existence.
1. Empirico e grammaticale
7
Si rende necessario ai fini di questa ricerca distinguere diversi
piani di riflessione. Un’importante distinzione in tal senso, per
la quale seguiamo Wittgenstein, è quella tra un piano empirico,
quello dell’esperienza che ci fornisce le singole percezioni
vissute dei colori e sul quale si giocano importanti irriducibili
differenze tra le diverse culture, legate a particolari immagini
del mondo, e tra le singolarità di ciascuno di noi; e un piano
grammaticale, quello dell’espressione linguistica dei colori,
della loro grammatica, sul quale si gioca la comunanza che ci
permette la comprensione reciproca e la condivisione anche di
ciò che resta refrattario alla sintesi, per esempio, le singole
percezioni dei vissuti dei colori che sono per ciascuno uniche e
irripetibili. Il piano delle regole grammaticali, come dice
Gargani, è quello in cui si costituisce e si disciplina, secondo
dei paradigmi ideali e aprioristici, non nel senso di
trascendentali, ma nel senso di già dati per l’animale sociale
umano che si trova sin dal grembo materno immerso nel
linguaggio, il linguaggio dei colori2, che ci accomuna, ci pone in
relazione l’uno con l’altro senza tuttavia poterci ridurre l’uno
all’altro. Il piano delle regole grammaticali costituisce il nostro a
priori sociale: quello nel quale prende forma tanto il colore in sé
quanto il colore per ciascuno, tanto l’universale quanto il
particolare. Quest’ultimo però non sarà mai del tutto sussunto
sotto la logica dell’universale: resterà sempre estraneo
all’ordinario. Rientra infatti nella possibilità che ciascun parlante
ha di decidere l’applicazione delle regole: non credere sempre,
scrive a tal proposito Wittgenstein, «di ricavare le tue parole
dalla lettura dei fatti; di raffigurare i fatti in parole, secondo
certe regole! Perché l’applicazione della regola al caso
particolare dovrai farla tu, senza alcuna guida»3. Infatti, ciò che
distingue la proposizione empirica da quella grammaticale,
ovvero l’esperienza dalla norma, è l’impiego4. E c’è anche il
caso di proposizioni che oscillano tra logica ed empiria
esprimendo ora una norma ora un’esperienza. Dobbiamo
8
perciò, ed è questo l’invito di Wittgenstein, guardare l’uso del
linguaggio dei colori evitando di costruire teorie5, come ha fatto
per esempio Goethe, in maniera del tutto insoddisfacente a
giudizio di Wittgenstein. Il massimo che si può fare quando si
parla di un colore è pensare, «sempre e soltanto, a un
determinato modo del suo impiego»6.
Sulla scia della distinzione tra empirico e grammaticale,
Wittgenstein può dire che non importa «la quantità dei colori
visti, ma la sintassi»7 e ciò vuol dire che se anche un uomo
avesse visto per tutta la vita un unico colore, per mezzo di una
lingua potrebbe comunque avere conoscenza anche di tutte le
differenze cromatiche di cui la sintassi della lingua a lui nota gli
permetterebbe di parlare. L’esempio che Wittgenstein adduce
è quello dello spazio:
Se qualcuno non esce mai dalla sua camera, sa tuttavia che lo
spazio continua, che esiste cioè la possibilità di uscire dalla
camera (avesse pure le pareti di diamante). Non è quindi
un’esperienza; è insito alla sintassi dello spazio, a priori. Ora,
ha senso domandare quanti colori occorra aver incontrato nella
propria vita per conoscere il sistema dei colori? No! [...] Non
importa la quantità dei colori visti, ma la sintassi (Così come
non importa la “quantità di spazio”)8.
Pensiamo a questo proposito alla possibilità che un cieco
scriva o parli dei colori di contro a quanto sosteneva Goethe, il
quale scrisse che «con il cieco non vi è modo di parlare di
colore»9. Può capitare di leggere addirittura delle poesie scritte
da una persona cieca dalla nascita attraversate costantemente
da riferimenti ai colori e il primo inevitabile pensiero è quello di
chiedersi come possa quel poeta parlare così tanto dei colori
pur non avendoli mai visti. La memoria ci riporta qui a Diderot e
agli esempi che egli descrive a tal proposito nella sua Lettera
sui ciechi per quelli che ci vedono: è come se la persona cieca
9
avesse formalmente introiettato il mondo per mezzo del
linguaggio senza passare per l’assimilazione e astrazione di
esso per mezzo della vista. Il tatto è il senso che il cieco
sostituisce alla vista: ma il tatto, per quanto quello del cieco sia
finemente perfezionato al punto che Diderot giunge a dire che
«Saunderson vedeva con la pelle»10, non gli permette di
vedere ciò che è distante, che sta dentro oppure oltre la forma.
Se il vedente combina punti visibili e colorati, il non vedente
combina punti palpabili: la vista per lui è una specie di tatto. Il
sapere linguistico del cieco non trova scambio diretto con il
sapere del mondo e questo lo vediamo dal fatto che «la vita del
cieco è diversa dalla vita di chi vede»11.
La sintassi del linguaggio dei colori permette alla persona cieca
di conoscere i colori: è questo il motivo per cui, come racconta
Diderot, Saunderson in qualità di professore di matematica a
Cambridge riuscì «a dare lezioni di ottica, pronunciò discorsi
sulla natura della luce e dei colori, spiegò la teoria della
visione»12. Gli mancava l’esperienza diretta, ma poteva, grazie
al linguaggio, prenderla in prestito dall’altro: il cieco, scrive
Diderot, «prende le supposizioni come gli vengono offerte»13 e
quando «dice “questo è bello”, non formula un giudizio, riporta
semplicemente il giudizio di quelli che ci vedono»14. Diderot
dice: «la bellezza per un cieco non è che una parola»15. E ciò,
aggiungiamo noi, non vuol certo dire che il cieco non possa
trarne dei significati: infatti, nella misura in cui è in grado di
usare la parola bellezza ne conosce anche quello che
chiamiamo significato. Vuol dire piuttosto che non è in grado di
scambiarla con il mondo, di nutrirla del sapere del mondo
attraverso uno scambio diretto con esso.
Una persona cieca può parlare o scrivere dei colori perché
conosce un sistema linguistico entro il quale questi sono
disciplinati. Chiede Wittgenstein: «Sarebbe corretto il dire, che
nei nostri concetti si rispecchia la nostra vita?». E risponde:
«Stanno nel bel mezzo»16. È vero dunque che «la regolarità del
10
nostro linguaggio pervade tutta la nostra vita»17. I sistemi
linguistici sono connessi con forme di vita e dunque con
tradizioni, culture, giudizi, modi di vivere. Tant’è che i colori
anche nelle poesie di una persona cieca possono trovare
empatie figlie della cultura di un tempo e di un luogo, di una
data pratica interpretativa. Possiamo sostenere che un non
vedente, per quanto sembra che abbia il mondo tutto dentro di
sé, meno ancora di un vedente può vivere il mondo
solipsisticamente: egli mostra la necessità dell’altro, della
parola che viene dall’altro. La persona cieca può interiorizzare
il mondo solo in quanto qualcun altro gliene parla.
La sintassi del linguaggio dei colori ci permette di verificare
l’esistenza reale o immaginaria di un dato colore, di verificare
la nostra esperienza: essa prevale, commenta Gargani,
per una sorta di diritto di priorità logica, sulle stesse percezioni
dei colori. In questo senso, una superficie bianca può apparire
grigia in certi tratti per effetto della diversa distribuzione
dell’intensità luminosa; ma noi non diciamo che è grigia,
troveremmo addirittura assurdo dire ciò, anche se l’evidenza
sensoriale potrebbe indurci a dirlo18.
Dice Wittgenstein: «qui decidono i giochi linguistici»19. Se il
significato dei colori è fissato nella grammatica dei colori,
ovvero nel linguaggio, allora perde senso qualsiasi riferimento
a esperienze private di essi. Senza che venga tuttavia mai
annullata l’irriducibile singolarità del vissuto dei colori. I colori
non sono coleotteri custoditi nelle nostre scatole craniche, ma
trovano tuttavia importanti connessioni con i nostri particolari
vissuti o con quelli di un particolare vivere comune. Connotano
il vivere di ciascuno. Le nostre esistenze possono esprimersi in
colori.
11
2. Comunicazione ed espressione
In che senso si può dire che «l’azzurro è il colore della
lontananza»20? Il cielo e il mare sono azzurri ed entrambi sono
spazi infiniti. Kandinsky dice che «più il blu è profondo e più
richiama l’idea di infinito, suscitando la nostalgia della purezza
e del soprannaturale. È il colore del cielo»21. In che senso il
colore può narrare un vissuto? Può addirittura narrare la
morale: il giallo, per esempio, colore dal lato del Più insieme al
giallo-rosso e al rosso-giallo, come indicato da Goethe, «si
mostra estremamente sensibile, producendo un’impressione
sgradevole, quando è sporco o quando è in qualche misura
condotto verso il lato del Meno»22, quello dei colori azzurro,
azzurro-rosso e rosso-azzurro. È sufficiente, scrive Goethe,
«un leggero e impercettibile movimento per tramutare la bella
impressione del fuoco e dell’oro nella sensazione del
sudiciume, invertendo il colore della dignità e del diletto nel
colore dell’infamia, della ripulsa e del disagio»23. I colori caldi,
quelli dal lato del Più, avvicinano l’osservatore, mentre quelli
freddi, quelli dal lato del Meno, lo allontanano. Come dice
Kandinsky, i colori rispondono al principio di necessità
interiore24. Toccano l’interiorità, laddove per interiorità,
distaccandoci da Kandinsky, non intendiamo qui uno spazio
metafisico, quanto piuttosto ciò che caratterizza l’essere
singolare di ciascuno, ciò che non appartiene allo spazio di
mondo oggettivo né trova immediato riconoscimento nello
spazio linguistico condiviso. Anima e interiorità sono per noi
metafore della singolarità: modi di esprimere l’esistenza unica
e singolare di ciascuno.
La seconda distinzione che si pone come necessaria,
all’interno della quale lavoreremo per sviluppare il tema del
vissuto del colore, è quella tra piano comunicativo e piano
espressivo. Questa distinzione nasce in continuità con quella
precedente. Sul piano comunicativo il colore può essere
conosciuto, il che vuol dire parlato e capito anche da chi non
12
l’abbia mai visto e singolarmente vissuto in uno scambio diretto
con il mondo. Su quello espressivo il colore può solo essere
mostrato e può mostrare (intendiamo dire che mostra anche
attraverso le parole) senza tuttavia poter mai essere
compiutamente detto. Dice in tal senso Kandinsky che le
tonalità cromatiche, come quelle musicali, danno emozioni più
sottili di quelle dei sentimenti fisici, emozioni inesprimibili a
parole. Forse, egli scrive, «ogni tono troverà col tempo
un’espressione materiale, verbale. Eppure ci sarà sempre
qualcosa che la parola non potrà rendere compiutamente, e
che non è il superfluo, ma l’essenziale. Per questo le parole
sono e restano accenni, segni abbastanza esteriori dei
colori»25. Ciò ha a che fare con l’inesprimibile, che fa da sfondo
al linguaggio segnandone i limiti, e con il fatto che il colore può
essere considerato, come lo stesso Wittgenstein ci ha lasciato
chiaramente intendere, un paradigma dell’indeterminatezza
concettuale. In tal senso ha infatti scritto che «non esiste il
concetto puro di colore»26: «i differenti concetti di colore sono
certo strettamente affini l’uno all’altro, le differenti “parole di
colore” hanno un uso affine; ma c’è ogni sorta di differenze»27.
E ha aggiunto: «l’indeterminatezza del concetto del colore
risiede, prima di tutto, nell’indeterminatezza del concetto di
eguaglianza tra colori, e dunque nell’indeterminatezza del
metodo del confronto tra colori»28.
Se si possiede una lingua, si possiedono anche i colori
disciplinati entro quel sistema. Tuttavia i colori non sono mai
del tutto disciplinabili, sfuggono a qualsiasi determinazione
ultima, e per questo esprimono anche al di là del detto:
esprimono, e il che vuol dire che oltrepassano il detto, il piano
comunicativo, quello con uno scopo. Esprimono emozioni, stati
d’animo: li producono senza limitarsi ad adattarsi a essi29. I
colori che indossiamo possono narrare il nostro carattere o
l’umore odierno di qualcuno. Per fare un esempio tra i più
immediati: se siamo tristi difficilmente riusciamo a indossare
13
colori vivaci. Goethe arriva addirittura a ipotizzare che i colori
scelti per vestirsi possano narrare il grado culturale della
persona che li indossa: «le persone colte mostrano una certa
avversione al colore. Ciò può risultare in parte da un’incertezza
del gusto che tende a mettersi al riparo del nulla. Le donne
vestono quindi quasi sempre di bianco, gli uomini quasi sempre
di nero»30. Vera o no questa ipotesi, resta il fatto che i colori
stimolano la riflessione e ci inducono a interpretare, a narrare,
a scrivere storie che possono essere reali o immaginarie.
Indossare un colore può in tal senso significare, a volte in
accordo con una sorta di schema concettuale, mostrare parte
della propria anima, ovvero parte di sé.
3. Il colore come trama dell’esistenza
I colori parlano con l’interiorità e dell’interiorità, con l’esistente e
dell’esistente. Kandinsky scrive che «in generale il colore è un
mezzo per influenzare direttamente l’anima. Il colore è il tasto.
L’occhio è il martelletto. L’anima è un pianoforte con molte
corde. L’artista è la mano che, toccando questo o quel tasto, fa
vibrare l’anima»31.
L’esperienza, seppur spesso pregiudicata dalle immagini
culturali, ci insegna, dice Goethe, che «ogni singolo colore
dona un particolare stato d’animo»32. E ciò vuol dire anche che
nessuna teoria concettuale potrà mai chiudere, definire, questi
insegnamenti, nella misura in cui non potremo mai prevedere
una volta per tutte quali saranno le possibilità narrative di un
colore, ovvero come questo potrà connettersi con le nostre
esistenze arrivando a coltivare e custodire l’anima dei vissuti.
Una teoria come quella esposta da Goethe, come dice
Wittgenstein, non può far altro che fornirci dei vaghi schemi
concettuali33, ma non può dire a un’artista come ricercare
quella spiritualità di cui parla Kandinsky. Nell’espressione
«l’albero rosso», presa come esempio proprio da Kandinsky, il
14
colore rosso ci narra una temporalità, quella dell’autunno34. Ma
in questa veste potrebbe anche risvegliare un ricordo della
nostra infanzia legato al periodo dell’anno che sta esprimendo
o una nostra particolare esperienza con le foglie rosse tipiche
del periodo autunnale. Suonerebbe così le corde della nostra
interiorità e narrerebbe qualcosa di unico, frutto di una
particolare esperienza, non teorizzabile né prevedibile o
ripetibile. Una stessa parola, in tal caso la parola rosso,
attingendo alla tavolozza dell’immaginario comune, quella che
ci viene donata da una lingua, può esprimere tanto ciò che è
per sé quanto ciò che è per il sé di ciascuno.
I colori esprimono una necessità interiore nella misura in cui
nella loro infinita capacità espressiva sono forme che ben si
adattano per accogliere la singolarità dei vissuti: forme elusive
e allusive. S’imprimono nell’anima connettendosi alle nostre
vite per poi risvegliare i vissuti che colorano nel momento in cui
quei dati colori si rifanno incontro alla vista. Ciò che acquisiamo
a livello comunicativo ci permette di esprimere. Ciò che
esprimiamo, a sua volta, ci permette di incrementare tanto la
comunicazione quanto l’essere del colore nel quale si iscrivono
sempre nuove narrazioni e l’essere di ciascuno che a quello di
un colore associa un proprio particolare vissuto. Per mezzo del
comune si crea il particolare, che a sua volta, con la sua
particolarità, accresce, ricrea e rinnova il comune senza
esaurirsi mai in esso: serba sempre una sua irriducibilità. Il
sapere linguistico del colore ci permette di acquisire il sapere
dei colori del mondo, il quale a sua volta ci permette di
arricchire quello linguistico attraverso le nostre particolari
esperienze.
I colori di un paesaggio della nostra infanzia narrano sì le
proprietà di quel dato paesaggio, proprietà visibili a chiunque lo
veda, ma narrano anche un vissuto singolare in quel
paesaggio. Quei colori qualificano un dato vissuto, ne sono la
trama. Possono per esempio narrare un ritorno impossibile,
15
una nostalgia incurabile. Un’infanzia rubata. O un’infanzia
immensamente gioiosa. I colori attribuiscono spesso nuovi
sensi: creano sensi. Avvicinano una lontananza. Rispondono a
differenze di pathos. Ogni narrazione è, come scrive Invitto,
«espressione di vissuti, quindi di esistenza»35 e il colore, con la
sua spiccata capacità di suonare i tasti dell’interiorità, è da
questo punto di vista un narratore esemplare.
Dove non c’è differenziazione cromatica, dove c’è monocromia,
omologazione cromatica, spesso inter-posta, imposta, non vi è
qualità, vi è de-qualificazione. Il nero indiscriminato, il nero che
è assenza, che segna la mancanza. Il fumo nero del camino di
una fonderia. Quel fumo che copre una città più che mai
moderna, che ne copre i colori, le qualità. Narra di un’aria
insalubre, di un territorio inquinato, di uno stato di malattia
umana, ambientale, animale. Narra la morte. La si chiama area
da ri-qualificare, affinché tornino a splendere il verde dei prati e
delle folte chiome degli alberi, l’azzurro del cielo infinito, il
colore dei mille petali profumati, il calore della pietra dei
palazzi. Affinché venga restituito l’anelito di vita: l’anima.
Riqualificare può quindi significare restituire colore. Permettere
ai colori della natura di ricominciare a narrare. A dimostrazione
di quanto la narrazione di un’industria possa inscriversi in
questo schema che vede i suoi grigi colori come espressione di
inquinamento, vi è il caso di un’industria, visibile percorrendo
l’autostrada che collega Roma con Napoli, che ha scelto di
colorare i propri camini e le pareti dell’intera struttura con colori
come fucsia, rosa, verde: le tonalità di colore scelte sono poco
assimilabili a quelle visibili nella natura circostante, ma tuttavia
avvicinabili a quelle dei giochi in un parco o delle pareti di un
asilo, assimilabili insomma a quelle di uno spazio innocuo nel
quale faresti giocare tuo figlio, uno spazio ludico, divertente. I
colori di quest’industria ci dovrebbero perciò allontanare
dall’idea che essa possa seminare morte. Per provare a
significare diversamente, al di là del giudizio imperante e della
16
narrazione quotidiana che concerne tal sorta di spazi,
un’industria non a caso sceglie di colorarsi e non a caso
sceglie quei dati colori piuttosto che altri, i quali non richiamano
tonalità naturali, bensì artificiali.
In un’immagine in bianco e nero è difficile cogliere stati d’animo
che non siano legati a un senso di privazione, di mancanza, di
nostalgia. Un’immagine in bianco e nero può raccontare vissuti
di cui si è persa l’anima per troppa lontananza o esistenze a
cui è stata sottratta l’anima. Il bianco, il nero e il grigio, punto di
equilibrio tra il bianco e il nero, sono colori del silenzio.
Kandinsky scrive che «il bianco ci colpisce come un grande
silenzio che ci sembra assoluto» facendosi «quasi simbolo di
un mondo in cui tutti i colori, come principi e sostanze fisiche,
sono scomparsi»36. Non è però un silenzio morto, bensì un
silenzio iniziante dal grande potenziale espressivo: «un nulla
prima dell’origine, prima della nascita». Il nero, invece,
continua Kandinsky, è «un nulla senza possibilità»: risuona
dentro di noi come un eterno silenzio senza futuro e senza
speranza. «Dal punto di vista musicale si può paragonare a
una pausa finale». Il nero è infatti come «il silenzio del corpo
dopo la morte, dopo il congedo dalla vita»37. Il grigio non può
che essere silenzioso e immobile: «è l’immobilità senza
speranza. Più diventa scuro, più si accentua la sua
desolazione e cresce il suo senso di soffocamento»38.
Poniamoci ad esempio la domanda: quali colori avrebbe mai
potuto scegliere un pittore dopo Auschwitz? L’olocausto ha,
nell’immaginario comune, i grigi colori di una foto in bianco e
nero. I colori del silenzio dei vinti. L’unico colore vitale che si
potrebbe forse immaginare è quello del cappotto rosso della
bambina del film Schindler’s List. Una macchia rossa da
sottrarre al dolore di mille macchie grigie. Un rosso forte e
deciso: trae la sua forza dal grigio sfondo di morte entro il
quale prende posto. Diviene così, con tutto il suo vigore,
simbolo di una grave sottrazione d’amore. Questo contrasto tra
17
il rosso e il grigio simboleggia la più atroce sottrazione delle
qualità umane: una disumanizzazione. È simbolo di tante
narrazioni private dei loro colori. Esistenze rese incolori.
Narrazioni a cui è stato negato narrarsi.
Gli orrori di una guerra, di un genocidio, di eventi così indicibili
nella loro brutalità, possono forse narrarsi solo in un’irrazionale
scomposta composizione in scala di grigi come in Guernica di
Picasso: una sorta d’istantanea che seppur nata da un preciso
evento storico, data la mancanza di riferimenti diretti a luoghi e
date, è diventata manifesto universale contro la guerra e la
violenza in generale.
Bibliografia
AA. VV., Figure e forme del narrare, a cura di A. Ponzio,
Milella, Lecce 2013.
DENIS DIDEROT, Lettre sur les aveugles, à l’usage de ceux qui
voient, 1749 (Lettera sui ciechi per quelli che ci vedono, trad. di
M. B. Savorelli, La Nuova Italia, Firenze 1999).
ALDO GARGANI, Introduzione in LUDWIG WITTGENSTEIN,
Osservazioni sui colori, Einaudi, Torino 2000.
JOHANN W OLFGANG VON GOETHE, Zur Farbenlehre, 1810 (La
teoria dei colori, trad. di G. C. Argan, Il Saggiatore, Milano
2008)
GIOVANNI INVITTO, Il diario e l’amica. L’esistenza come
autonarrazione, Mimesis, Milano 2012.
WASILIJ KANDINSKY, Über das Geistige in der Kunst.
Insbesondere in der Malerei, 1912 (Lo spirituale nell’arte, trad.
di E. Pontiggia, SE, Milano 2005)
ANTONIO PRETE, Trattato della lontananza, Bollati Boringheri,
Torino 2009.
FRIEDRICH W AISMANN, Wittgenstein und der Wiener Kreis, aus
dem Nachlass, herausgegeben von B. F. McGuinness, Basil
Blackwell, Oxford 1967 (Ludwig Wittgenstein e il Circolo di
18
Vienna, trad. di di Sabina de Waal, La Nuova Italia, Firenze
1975.
LUDWIG W ITTGENSTEIN, Bemerkungen über die Farben,
Blackwell, Oxford 1977 (Osservazioni sui colori trad. di M.
Trinchero, Einaudi, Torino 2000).
LUDWIG W ITTGENSTEIN, Philosophische Untersuchungen, Basil
Blackwell, Oxford 1953 (Ricerche filosofiche trad. di M.
Trinchero, Einaudi, Torino 1999).
1
Con questo non si vuole negare la legittimità e scientificità degli
studi fisiologici sulla percezione del colore, quanto limitare piuttosto
l’esclusiva concentrazione su questi, che darebbe una visione di
certo parziale del fenomeno del colore trascuradone la dimensione
esistenziale.
2
ALDO GARGANI, “Introduzione” in LUDWIG WITTGENSTEIN, Osservazioni
sui colori, Einaudi, Torino 2000, p. XI.
3
LUDWIG W ITTGENSTEIN, Philosophische Untersuchungen, Basil
Blackwell, Oxford 1953 (Ricerche filosofiche trad. di Mario Trinchero,
Einaudi, Torino 1999), § 292, p. 132.
4
LUDWIG W ITTGENSTEIN, Bemerkungen über die Farben, Blackwell,
Oxford 1977 (Osservazioni sui colori, trad. di Mario Trinchero,
Einaudi, Torino 2000), pp. 11, 33.
5
LUDWIG W ITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, op. cit., § 340, p. 145.
6
LUDWIG W ITTGENSTEIN, Osservazioni sui colori, op. cit., § 73, p. 20.
7
ALDO GARGANI, Introduzione in op. cit, p. XIII.
8
FRIEDRICH W AISMANN, Wittgenstein und der Wiener Kreis, aus dem
Nachlass, herausgegeben von B. F. McGuinness, Basil Blackwell,
Oxford 1967 (Ludwig Wittgenstein e il Circolo di Vienna trad. di a
cura di Sabina de Waal, La Nuova Italia, Firenze 1975).
9
JOHANN W OLFGANG VON GOETHE, Zur Farbenlehre, 1810 (La teoria
dei colori trad. di G. C. Argan, Il Saggiatore, Milano 2008), p. 15.
10
DENIS DIDEROT, Lettre sur les aveugles, à l’usage de ceux qui
voient, 1749 (Lettera sui ciechi per quelli che ci vedono trad. di M. B.
Savorelli, La Nuova Italia, Firenze 1999), p. 49.
19
11
LUDWIG W ITTGENSTEIN, Osservazioni sui colori, op. cit., p. 104.
DENIS DIDEROT, Lettera sui ciechi per quelli che ci vedono, op. cit.,
p. 41.
13
Ivi, p. 43.
14
Ivi, p. 7.
15
Ibidem.
16
LUDWIG W ITTGENSTEIN, Osservazioni sui colori, op. cit., p. 100.
17
Ibidem.
18
ALDO GARGANI, Introduzione a op. cit., p. XVI.
19
LUDWIG W ITTGENSTEIN, Osservazioni sui colori, op. cit., p. 4.
20
ANTONIO PRETE, Trattato della lontananza, Bollati Boringheri, Torino
2009, p. 91.
21
W ASILIJ KANDISKY , Über das Geistige in der Kunst. Insbesondere in
der Malerei, 1912 (Lo spirituale nell’arte trad. di E. Pontiggia, SE,
Milano 2005), p. 63.
22
JOHANN W OLFGANG VON GOETHE, La teoria dei colori, op. cit., p.
191.
23
Ibidem.
24
W ASILIJ KANDISKY, Lo spirituale nell’arte, op. cit., p. 46.
25
Ivi, p. 72.
26
LUDWIG W ITTGENSTEIN, Osservazioni sui colori, op. cit., § 73, p. 46.
27
Ivi, § 75, p. 47.
28
Ivi, § 78, p. 47.
29
Cfr. JOHANN W OLFGANG VON GOETHE, La teoria dei colori, op. cit., p.
202.
30
Ivi, p. 203.
31
W ASILIJ KANDISKY, Lo spirituale nell’arte, op. cit., p. 46.
32
JOHANN W OLFGANG VON GOETHE, La teoria dei colori, op. cit., p. 190.
33
LUDWIG W ITTGENSTEIN, Osservazioni sui colori, op. cit., § 70, p. 19.
34
JOHANN W OLFGANG VON GOETHE, La teoria dei colori, op. cit., p. 80.
35
GIOVANNI INVITTO,
Il diario e l’amica. L’esistenza come
autonarrazione, Mimesis, Milano 2012, p. 66.
36
W ASILIJ KANDISKY, Lo spirituale nell’arte, op. cit., p. 66.
37
Ivi, p. 67.
38
Ibidem.
12
20
LA RICERCA DELLA FELICITA/VIRTU DEGLI ANTICHI E
LA PRATICA FILOSOFICA
NEGLI EPISTOLARI DI EPICURO, SENECA E
DESCARTES
di Cristina Manzo
Non si dà vita felice senza che sia intelligente, bella e giusta, né
vita intelligente, bella e giusta priva di felicità, perché le virtù sono
connaturate alla felicità e da questa inseparabili.
Epicuro
Ricordati di spogliare gli avvenimenti dal tumulto che li
accompagna e di considerarli nella loro essenza: capirai che in
essi non c'è niente di terribile se non la nostra paura.
Se la felicità consistesse nella sensualità, le bestie sarebbero più
felici dell'uomo; l'umana felicità invece ha sede nell'anima, non nel
corpo.
Lucio Anneo Seneca
La filosofia non è un tempio, ma un cantiere.
René Descartes
Abstract
Con la pratica filosofica, oggi, la figura del counselor cerca,
mediante il dialogo, di dare sollievo all’uomo che vive una crisi
esistenziale, di risolvere l’enigma della vita, di arrivare a soluzioni
sul perché delle cose, di riassegnare senso e significato a tutto
quello che apparentemente sembra esserne privo. Esattamente
come nella maieutica socratica, l’arte della retorica è utile per
tirare fuori, tutto quello che grava sulla nostra anima e
appesantisce il nostro essere con un macigno angosciante di
21
paure e destabilizzazioni, che offuscano la via della verità
intrapresa, in questo viaggio che è la vita, e ci fanno credere di
esserci smarriti in una “selva oscura.” Parlare o scrivere del senso
della vita, dell’essere, dell’esistenza tangibile e intangibile di
ostacoli e problemi, aiuta a individuare insieme una soluzione, che
dispone di più punti di vista, e dà chiarezza. Ma, quello che oggi si
opera con la pratica filosofica, veniva già realizzato dai filosofi
antichi o moderni in vari modi, uno di questi era proprio il carteggio.
Lunghe lettere scritte con l’intento di curare le ferite dell’anima, e
apportare sollievo e conforto a dilemmi esistenziali, lettere sulla
felicità, la virtù, la malattia, la metafisica.
With the philosophical practice, today, the figure of the counselor
tries, through dialogue, to give relief to the man who lives a life
crisis, to solve the riddle of life, reaching solutions on the why of
things, to reassign meaning and meaning to everything what
appears to be without one. Exactly as in the Socratic midwifery, the
art of rhetoric is useful to pull out, all that weighs on our souls, and
makes our being with a ton of distressing fears and destabilization,
which obscure the path of truth undertaken in this trip that is life,
and make us believe I lost in a "dark forest." Talk or write about the
meaning of life, being, existence of tangible and intangible
obstacles and problems, it helps to find a solution together, that
has multiple points of view, and it gives clarity. But what is now
working with the practice of philosophy, was already built by the
ancient philosophers and modern in many ways, one of those ways
was just the chart. Long letters written with the intent to heal the
wounds of the soul, and bring relief and comfort to the existential
dilemmas, letters on happiness, virtue, disease, metaphysics.
Avec la pratique philosophique, aujourd'hui, la figure du conseiller
tente, par le dialogue, pour donner du relief à l'homme qui vit une
crise de la vie, de résoudre l'énigme de la vie, de trouver des
solutions sur le pourquoi des choses, de réaffecter des sens et
sens à tout ce qui semble être sans. Exactement comme dans la
pratique sage-femme socratique, l'art de la rhétorique est utile de
se retirer, tout ce qui pèse sur nos âmes, et fait de notre être avec
une tonne de craintes angoissantes et la déstabilisation, qui
obscurcissent le chemin de la vérité entrepris dans ce voyage qui
22
c'est la vie, et nous faire croire que j'ai perdu dans une «forêt
noire». Parler ou d'écrire sur le sens de la vie, l'être, l'existence
d'obstacles et de problèmes matériels et immatériels, il est utile de
trouver une solution ensemble, qui dispose de plusieurs points de
vue, et il donne la clarté . Mais ce qui est maintenant de travailler
avec la pratique de la philosophie, a déjà été construit par les
philosophes antiques et modernes, à bien des égards, l'un d'entre
eux vient de la carte. Longues lettres écrites avec l'intention de
guérir les blessures de l'âme, et apporter un soulagement et
réconfort aux dilemmes existentiels, des lettres sur le bonheur, la
vertu, la maladie, la métaphysique.
Premessa
Il linguaggio filosofico ha portato una ventata di aria nuova
nel campo della ricerca e della cura della sofferenza
esistenziale, educando il soggetto a una differente modalità
di ascolto e di interpretazione dei disagi psiche-anima, e la
figura del counselor filosofico, riacquista così, quelle
competenze che già erano proprie sin dall’antichità, dai
tempi della maieutica socratica, quando, proprio alla parola,
era affidato il compito di dare sollievo e di guarire dai
continui patimenti, ragionando e meditando sul senso
dell’esistenza, ovvero filosofando su qualsiasi aspetto della
vita.
Originariamente la filosofia pratica si configura come un
dialogo filosofico che viene avviato dalla narrazione del
soggetto sulle sue difficoltà e,
non certo, come una
professione di aiuto; essa non ha la capacità di proporre
soluzioni, tuttavia si propone come modo alternativo di
pensare il mondo, secondo una linea che ricorda la funzione
dell'antico dialogo socratico. Si è discusso a lungo, negli
anni, sul fatto che
la consulenza filosofica possa
considerarsi o meno una forma di quella filosofia pratica che
pretendeva di soddisfare il bisogno e che il pensiero
23
potesse rendere l'agire umano razionale, sia nel campo
della morale che in quello della politica. Ci sono autori che
ritengono, che la consulenza filosofica come pratica
filosofica, in una accezione dilatata rispetto alle sue origini,
sia l'erede della filosofia pratica1. La terapia noetica, porta a
chiedersi se le emozioni non possano essere influenzate
dalle cosiddette cure dialogiche (talking cures), che sono il
cuore della psicoterapia, ed, oggi, anche della consulenza
filosofica. È luogo comune pensare che le emozioni, che
ognuno di noi prova, sono basate sulle nostre credenze,
sulla gente o sulle cose, e quindi che esse siano sotto il
nostro controllo conscio. Questo pensiero non è affatto
nuovo. Nella Repubblica, Platone suggeriva che, per avere
emozioni come la paura o il lutto, si devono prima avere
credenze di un certo tipo, credere che possa avvenire
qualcosa di terribile e inevitabile2. Nel suo manuale, Epitteto
dice di credere che “gli uomini sono agitati e turbati, non
dalle cose, ma dalle opinioni ch’essi hanno delle cose”3. Sia
nell’Etica Nicomachea che nella Retorica, Aristotele afferma
che le emozioni non sono sempre corrette, non più di quanto
lo siano sempre le credenze e le azioni.
Egli sostiene che se devono essere in armonia con una
visione della vita buona, esse possono e devono essere
educate4. Anche Epicuro propone l’idea che solo con l’arte
dell’argomentazione e del ragionamento le false credenze,
causa di preoccupanti passioni e “malattie dell’anima,”
possano essere scacciate5. Tommaso D’Aquino6 e Thomas
Hobbes7 concordano con Aristotele sul fatto che la ragione
umana possa controllare le emozioni. Questi antichi filosofi
posseggono una concezione delle emozioni simile a quella
di molti praticanti filosofici moderni, e in forte contrasto con le
influenti teorie della psicanalisi classica, che bandisce le
emozioni nel selvaggio “id” dell’ inconscio. Idealmente, il
dialogo in consulenza filosofica vuol essere “autentico,
aperto e non conflittuale”7. Nella consulenza filosofica, è il
24
tentativo empatico di interpretare e comprendere il “testo” del
cliente come questi l’ha vissuto e lo vive.
L’uso della parola “testo,” per denotare quello che il cliente
può rivelare al consulente della sua vita, nel corso di un
dialogo, segue l’allargamento della concezione di questo
termine (opera di Ricoeur) a includere ogni azione o
situazione umana8.
Aristotele fu il primo filosofo a definire la filosofia pratica:
È giusto anche chiamare la filosofia (philosophian) scienza
della verità, poiché di quella teoretica è fine la verità, mentre
di quella pratica è fine l'opera (ergon); se anche infatti i
(filosofi) pratici indagano come stanno le cose, essi non
considerano la causa per sé, ma in relazione a qualcosa ed
ora.9
Di sicuro il tema della cura di sé appare con chiarezza fin
dal V secolo a.C. Nel periodo ellenistico e in quello
imperiale, divenne tema filosofico comune o universale, il
concetto socratico del «prendersi cura di sé». Sulla «cura di
sé» fu d’accordo Epicuro e furono d’accordo i cinici, gli stoici
come Seneca, e anche Galeno. La tradizione filosofica, a
partire da Platone, ha associato il principio dell'esortazione
«conosci te stesso» (Γνῶθι σεαυτόν, gnôthi seautón), scritta
sul tempio di Delfi, a Socrate, ma, ad essa, sarebbe giusto
accompagnare anche il principio “curati di te stesso”
(epimelei heautou). In alcuni testi, addirittura, gnōti seauton
appare subordinato a epimelei heautou, concetto che,
secondo il punto di vista di Fuocault, tornerà ad essere
modificato nel periodo cartesiano. Nella stessa Apologia di
Socrate compaiono tre brani in cui Socrate sollecita gli altri a
occuparsi di se stessi. La cura di sé non costituiva una
raccomandazione astratta, ma una attività ampiamente
diffusa, una rete di obblighi e servigi resi alla propria anima10.
25
Ma la cosiddetta anima ha ancora la capacità di conoscere
se stessa e il proprio soggetto?11 Il conoscere se stessi può
sembrare in opposizione al conoscere il mondo, ma le due
conoscenze possono considerarsi due facce di una sola
medaglia: la filosofia è slancio dell'uomo verso il conoscere e
una conoscenza viva e attuale non può prescindere dalla
mente che conosce e dai suoi condizionamenti12.
L'anima, che conosce le relazioni logico-matematiche, non è
uno strumento privato (òrganon ìdion)13, ma qualcosa che è,
in quanto ente conoscente, intrinsecamente pubblico e
interpersonale, perfino quando ha a che fare col pensiero di
un pensatore solitario: «come un ignorante io cerco di
spiegarti la cosa; ma insomma l'anima, quando pensa, io
non la vedo sotto altro aspetto che di persona la quale
conversi (dialégesthai) con se medesima, interrogando e
rispondendo, affermando e negando»14. Quindi, ai suoi inizi,
la filosofia aveva assunto i caratteri della conduzione del
"modo di vita", per esempio applicando i principi dedotti
attraverso la riflessione, o la meditazione, secondo la
concezione cartesiana che, in età contemporanea, verrà
definita, dal pensiero di Pierre Hadot, “esercizio spirituale”.
«Io penso, in effetti, che quando Cartesio sceglie di intitolare
una delle sue opere Meditazioni, sa molto bene che quella
parola nella tradizione della spiritualità antica e cristiana sta
ad indicare un esercizio dell’anima. Ogni “meditazione” è
effettivamente un esercizio spirituale, vale a dire
precisamente un lavoro di se stessi su se stessi, che
bisogna avere portato a termine per passare alla tappa
successiva».15 In effetti Hadot è convinto che «Agostino,
nella misura in cui nei suoi dialoghi di gioventù scritti a
Cassiciacum si trovano reminescenze degli esercizi spirituali
della filosofia antica, ha probabilmente influenzato Cartesio,
che, soprattutto nelle Meditazioni […] pratica e fa praticare al
suo lettore la meditazione filosofica»16.
26
Tornando alla filosofia come modus vivendi, tale esigenza di
concretezza era poi andata dileguandosi, sino a quando, con
l'avvento dei sofisti, la filosofia pretese di divenire
l'insegnamento di un sapere tecnico indirizzato alla pratica.
Se Socrate con il suo dialogare tendeva a dimostrava
come fosse impossibile per la filosofia arrivare a risposte
definitive che servissero a risolvere questioni pratiche e che
essa si risolveva nel praticare quel confronto dialogico,
quella "scienza del bene e del male", il dialeghestai, definito
come to meghiston agathòn, il sommo bene,17 più avanti
l'epicureismo presentava il filosofo come "medico
dell'anima", con il compito di curarla dalle paure degli dei,
della morte, del dolore, restituendo così all'uomo la pace
interiore.18
Perché il filosofo possa diventare il “medico dell’anima” però,
è necessario che egli stesso faccia della sua vita una
continua ricerca volta alla conoscenza del bene, affinché
possa servire a individuare qual è la giusta via da seguire,
prima per se stesso e poi per gli altri. Solo dalla conoscenza
perfetta può scaturire, infatti, la giusta scelta dell’uomo,
nell’atto pratico della vita. Quindi, la filosofia è «l'uso del
sapere a vantaggio dell'uomo»19. Pierre Hadot con i suoi
studi, ha dimostrato che “il modo migliore di intendere la
filosofia antica, in generale, è quello di considerarla come un
esercizio spirituale e come una medicina dell'anima”20.
Possiamo parlare di Hadot come dello studioso che più di
tutti si è battuto per restituire un’immagine adeguata dello
spirito della filosofia antica. Ricercatore e, poi direttore, dell’
École pratique des hautes études, fu amico di Michel
Foucault. Confrontando il pensiero filosofico dei due, però,
emergono alcune divergenze sull’interpretazione della
filosofia antica. Secondo Hadot, il fine dei filosofi antichi era
quello della felicità, e non della conoscenza fine a se stessa
come stratificazione del sapere. A questo scopo essi si
preoccupavano di ripensare la loro vita secondo lo stile e la
27
pratica della via filosofica scelta, affinché il loro percorso
potesse risultasse coerente. Gli scritti dei filosofi antichi, non
erano destinati a diventare dei monumenti architettonici del
sapere, ma si identificavano piuttosto con componimenti
musicali che procedono liberamente con frequenti mutamenti
di tema. Lo scritto era, infatti, pensato al modo di una lezione
orale, destinato alla trasmissione ai discepoli, e alla loro
formazione, poiché avevano il compito di portare
all’acquisizione dell’arte del ben vivere.
Secondo il filosofo, ci sono due importanti dimensioni che
fanno parte dell’esistenza di un saggio, che sono invece
assenti nella vita di un uomo comune e sono la coscienza
cosmica, che è la coscienza dell’universo e della natura in
cui viviamo, e la libertà interiore, a cui appartiene la capacità
di giudicare senza pregiudizi, liberi dall’influenza esteriore,
rispettando la propria interiorità che ancora una vota deriva
da quel socratico “prenditi cura di te stesso”. Nei modelli di
felicità proposti dai filosofi antichi, sono sostanzialmente
proposte due tendenze e sono la tradizione socratica e
l’atteggiamento epicureo. Nel primo caso l’uomo può trovare
la felicità attraverso la via dello spirito, la più alta che si
conviene. Nel secondo, per raggiungerla è opportuno
liberarsi dalle false paure, quindi bisogna conoscere bene
ciò che deve essere temuto e ciò che può essere desiderato.
La conoscenza, quindi, resta sempre il soggetto centrale,
ma si tratta di una conoscenza che non è fine a se stessa in
quanto deve risultare vissuta e praticata, in modo che possa
trasformare l’anima e indicare un percorso di vita felice:
L’esercizio della filosofia non era dunque unicamente
intellettuale, ma poteva essere “anche” spirituale. Il filosofo
non insegna soltanto a saper parlare, a saper discutere, ma
anche a saper vivere nel senso più nobile e più forte del
termine. É a un’arte di vivere, a tutto un modo di vivere, che
egli incita i propri discepoli. Ne consegue che il discorso del
28
filosofo può assumere la forma di un esercizio destinato non
soltanto a sviluppare l’intelligenza del discepolo, ma anche a
trasformare la sua vita.[…] Talvolta come nei discorsi di
Platone, l’esercizio intellettuale è al tempo stesso spirituale.21
Michel Foucault esplicita un particolare che sembra essere
sfuggito
all’amico
Hadot,
relativamnewte
a
quest’interpretazione e cioè che, se nelle pratiche cristiane
che ruotano attorno all’ermeneutica del soggetto, l’uomo è
tenuto a confessare la verità sulla propria identità, nell’antica
Grecia, l’esame di coscienza in atto, invece, non induce il
soggetto a confessare una verità su se stesso, ma piuttosto
a verificare le proprie capacità di adattarsi e adeguarsi
conformemente alla vita che egli stesso ha scelto per sé.
Non si tratta, quindi, di un esporsi in prima linea, come se si
trattasse di un atto giuridico, ma di un atto privato nel quale
l’uomo da solo sceglie di verificare le sue possibilità, in
itinere con le direttive che si è dato:
da quando l’essere del soggetto non è più rimesso in
questione dalla necessità di avere accesso alla verità, siamo
entrati in un’altra età della storia dei rapporti tra la
soggettività e la verità. La conseguenza di tutto ciò, o se
volete l’altra faccia, è rappresentata dal fatto che l’accesso
alla verità, che ormai non comporta come condizione
nient’altro che la conoscenza, a titolo di ricompensa e di
compimento finale, non troverà in questa nient’altro che il
processo indefinito della conoscenza stessa. […] Per come
essa appare, la verità non è più capace di salvare il
soggetto.22
Quando nel 1981-82 Foucault tenne il corso al Collège de
France, nella prima lezione dedicata a L’ermeneutica del
soggetto, sostenne che il tema centrale nel pensiero antico,
dell’epimeleia heautou, si era eclissato a favore del principio
29
dello gnothi seauton, attribuendone la causa principale alla
trasformazione impressa da Descartes al discorso filosofico
della modernità. La vera rottura, per lui, si sarebbe introdotta
con il “momento cartesiano”: “dal momento in cui il filosofo (o
lo scienziato, o anche solo chi cerca la verità) è diventato
capace di riconoscere la verità, e ha potuto avere accesso
ad essa, in se stesso, e in virtù dei suoi soli atti di
conoscenza, senza che da lui si esiga più nient’altro, ovvero
senza che il suo essere di soggetto debba essere modificato
o alterato in alcun modo”23. Il filosofo aggiunge, in
un’intervista rilasciata nell’ultimo anno della sua vita, che, se
pur si volesse riconoscere la stessa preoccupazione
spirituale della filosofia antica nelle Meditazioni di Descartes,
di poter accedere a un modo d’essere in cui il dubbio non
trova più posto e si può conoscere, ci si dovrebbe accorgere
necessariamente del fatto che è
la conoscenza che
definisce interamente il modo di essere a cui si accede con
la filosofia.
La soggettività, per Foucault, si costituisce storicamente in
relazione ai processi di soggettivazione. I processi di auto
soggettivazione: le “tecnologie del sé” comprendono pratiche
che gli individui compiono su di sé al fine di trasformare sé
stessi e la propria esperienza del mondo, assumendo se
stessi come campo d’azione al fine di autoformarsi.
Esaminandone i tratti fondamentali, Foucault ne descrive il
cambiamento di accento e sottolinea il “disancoraggio” che
l’epimeleia heautou mostra sia rispetto alla pedagogia sia
rispetto alla politica, assumendo il carattere di un’arte di
vivere che si esercita durante tutto il corso della vita, che è
finalizzata a se stessa ed oltrepassa il campo conoscitivo:
diventa dunque una pratica autonoma, autofinalizzata e
generale, raccomandata a tutti39. Accanto al compito
educativo, viene ad assumere una funzione correttiva e
critica, aiutando gli uomini a liberarsi dalle cattive abitudini.
Per questo il suo campo semantico si intreccia con quello
30
dell’arte medica, dove il therapeuein indica la stessa finalità
curativa, mia chora40 sia verso i mali del corpo sia verso
quelli dell’anima.
È questo il quadro teorico entro cui Foucault conduce la sua
indagine sulla nozione di cura di sé nell’età tardo antica.
L’aiuto e la mediazione dell’altro sono importanti, come
nell’età classica, ma con accenti diversi: al maestro che
secondo il modello socratico pungola l’ignoranza dei discenti
(e dei concittadini) in funzione politica e in direzione eidetica,
si sostituisce la pratica della direzione di coscienza e
dell’aiuto spirituale per conseguire il buon governo di se
stessi. Diventa così centrale l’esercizio della parresia, che
assume un accento personale, e non più politico, dal
momento che l’altro aiuta ad acquisire consapevolezza dei
propri difetti per poter progredire sulla via di una vita
buona(41)25. L’orizzonte è quindi quello della cura di sé, dove
il sé funge da centro di risignificazione di valori tradizionali
del mondo classico e si presenta come un valore universale,
sostenuto da riflessioni teoriche, ma soprattutto centro verso
cui converge tutta una serie di comportamenti, di esperienze
e di pratiche destinate a trasformare il modo d’essere e di
agire degli individui. Al campo teorico della cura di sé è
correlata la nozione di “salvezza”, che viene impiegata con
un’accezione diversa e in riferimento a un ambito di
applicazione enormemente più vasto rispetto all’età classica.
La nozione di salvezza nei testi dell’età tardo-antica non
rinvia a qualcosa d’altro rispetto alla vita stessa, dal
momento che il suo fine è immanente all’esistenza terrena: è
la ricompensa per l’esercizio della cura di sé, e permette
all’individuo di trovare protezione dai turbamenti e dalle
sventure della vita. Il suo campo semantico è dunque
prossimo ai precetti dell’atarassia e dell’autarchia, in quanto
riguarda quelle attività che il soggetto è tenuto a esercitare in
modo permanente su se stesso, se intende conseguire come
ricompensa un certo rapporto con sé. Foucault osserva che
31
in questa prospettiva non è prevista alcuna rinuncia a sé
(come avviene invece per la nozione religiosa di salvezza),
ma al contrario il suo significato è interamente immanente,
dal momento che il sé è l’agente, lo strumento, ma anche
l’oggetto e il fine ultimo delle pratiche di salvezza. In
accezione analoga viene impiegato il termine di
‘conversione’ (epistrophè) che si trova declinato in
riferimento al sé: epistrophè eis heautòn. Vero e proprio
obiettivo di tutte le tecniche del sé, la conversione viene
intesa capacità di fare ritorno a se stessi, trovando in sé
rifugio dagli affanni e dalle incertezze della realtà esterna.
Offre il privilegio di riuscire a sottrarsi all’asservimento del
mondo per poter fare ritorno al proprio animo, come oasi e
riparo dalle vicissitudini quotidiane. Il modello giuridico del
possesso (potestas sui, suis juris) evidenzia il significato di
un’etica della padronanza intesa come modalità che
permette di godere stabilmente di sé, imparando a
conseguire quel piacere che si trae da sé quando si può
stare serenamente con se stessi. «Disce gaudére» («Impara
a gioire»), secondo il noto passo della XXIII Lettera di
Seneca a Lucilio, in cui alla voluptas che dipende da un
oggetto esterno vengono contrapposti il gaudium e la laetitia,
che nascono in noi e grazie a noi(42). La conversione a sé
non si consegue con un sapere di conoscenza, che non
implica alcuna trasformazione del soggetto, ma richiede una
serie di atti che comportano un vero e proprio lavoro su se
stessi in tempi della giornata espressamente dedicati a
questo.
La ricerca di Foucault individua nell’àskesis la forma degli
esercizi spirituali che nell’epoca tardo-antica garantivano al
soggetto la costituzione di sé e il conseguimento di un
rapporto pieno e autosufficiente con se stessi. Le pratiche di
discorso fanno dunque parte di un sapere spirituale che mira
a costituire il soggetto di veridizione, ossia capace di dire il
vero in funzione di tradurre il logos in ethos, in
32
comportamenti di vita. La soggettivazione del discorso vero
comporta tecniche di incorporazione del discorso vero
finalizzate a saperlo mettere in atto nell’agire quotidiano. La
questione della verità, dunque, non è solo teoretica, dal
momento che coinvolge in primis il modo in cui si vive. La
pietra di paragone del ‘dir vero’ è la corrispondenza tra il
soggetto dell’enunciazione e il soggetto del comportamento:
l’adaequatio da conseguire non è quella tra il pensiero e
l’oggetto, in vista del dominio di un reale reso altro dal
soggetto; è invece quella tra un soggetto che dice il vero e lo
stesso soggetto che lo mostra nel suo modo d’essere, nel
suo agire quotidiano: «Quella verità che ti dico, tu puoi
vederla in me»26.
Comunque, nella cura, il discorso filosofico non risulterà
mai un semplice “parler pour parler”, poiché, come sostiene
Epicuro, “Vana è la parola di quel filosofo da cui non è
guarita nessuna passione dell’anima.”27. Nel dizionario
filosofico Centro Studi di Gallarate28, che pur come tutti i
dizionari non può essere assunto come testo
scientificamente critico, ma solo come sintesi credibile di
teorie e pensieri, alla voce Philosophie de l’esprit, troviamo
proposto un interessante significato, che intende ricondurre
la filosofia a quello che è il suo compito di sempre, cioè
restituire all’uomo il senso della sua esistenza, nonché la
facoltà di poter autonomamente elevare anima e pensiero
verso l’assoluto43.
Pertanto, il discorso filosofico, procede dall’interiorità
all’esteriorità, all’inizio puramente teorico, si fa più vicino
all’anima nel momento in cui il maestro lo adatta ai discepoli,
esercitando la sua direzione spirituale, e infine si interiorizza
attraverso il dialogo con se stessi o con gli altri, o anche
attraverso la scrittura.[…] Tutto questo, che è vero in sommo
grado per la filosofia stoica, può valere come abbiamo
accennato, per la filosofia epicurea, che definiva se stessa
33
come un’attività che realizza la vita felice con l’aiuto del
discorso e delle discussioni.29
Tuttavia “Per conseguire la guarigione dell’anima e una vita
conforme alla scelta fondamentale, non è sufficiente avere
preso conoscenza con il discorso filosofico epicureo.
Occorre continuamente esercitarsi. Innanzitutto bisogna
meditare, vale a dire raccogliersi intimamente, prendere
intensamente coscienza dei dogmi fondamentali”30.
Sappiamo che, già dall’antichità, il dialogo veniva usato
come terapia filosofica. Socrate, per come ci è noto
attraverso Senofonte e Platone, assisteva i giovani e gli
anziani nella riflessione sul loro modo di vivere. L’esame del
passato, del presente e del futuro creava nell’interlocutore di
Socrate una consapevolezza di sé. Invece di lasciarsi
trascinare da un sé sconosciuto, le persone diventavano
individui autoconsapevoli e autodeterminati. Il tentativo di
capire se stessi rendeva sopportabile una vita difficile,
Socrate come levatrice filosofica e come consulente
filosofico è uno dei temi che ricorrono costantemente nella
letteratura della pratica filosofica31. La dialettica, e quindi la
possibilità stessa della filosofia, per Socrate, ha allora come
propria condizione la vita nella comunità degli uomini. E
d'ora in poi, e per secoli, sarà la comunità il luogo della
filosofia, non il tavolo da studio dell'intellettuale che legge e
scrive.
Certo, tanti intellettuali per secoli leggeranno e scriveranno,
ma sempre in rapporto ad una comunità.
La tesi non è che la dialettica sia l'unico metodo di ricerca
possibile. È soltanto che nella versione socratica essa è
coerente con la sua filosofia. Permette, allo stesso tempo, la
ricerca filosofica e la vita filosofica. Sia che si parli di ricerca
o di vita filosofica, il metodo in filosofia, non è infatti
indipendente dalla risposta al problema della sua identità e
della identità del filosofo: è il correlato di questa risposta. Il
34
discorso filosofico è una delle forme stesse di esercizio del
modo di vita filosofico, sotto forma di dialogo con un altro o
con se stessi32. I filosofi possono per varie ragioni, e lo
hanno fatto, costruire mondi di sogni o universi paralleli o
possibili. Ma vivono in un mondo reale e di questo ricercano
la verità. Ora, che fare se la ricerca della verità entra in
contraddizione con il mondo? Il filosofo non può dire: io sono
nella verità, il mondo è malvagio; non può limitarsi a dire così
perché questa malvagità e la sua ansia di ricerca della verità
appartengono alla stessa realtà, ed è questa, non un'altra, la
realtà di cui cercare la verità. Dunque, qual è la natura del
mondo, se in esso convivono malvagità e ansia della verità?
E come si iscrive l'identità del filosofo in questa ricerca: egli è
uomo del mondo o uomo della verità? Perché le due figure in
una sola persona possono non riuscire a convivere. Socrate
quindi, imprendibile nella sua piena libertà di ricerca, incarna
un preciso e, per conseguenza, ben prendibile modello: la
figura del filosofo è in lui chiara: filosofo è colui che, senza
rinunciare al mondo, ai suoi doveri e ai suoi piaceri, sa bere
senza ubriacarsi, il filosofo, sa amare senza divenire
schiavo, ha imparato l'arte di vivere in piena libertà di spirito,
fedele alla ricerca della verità, seguendo uno stile di vita che
non gli viene imposto dall'esterno, ma che egli liberamente
sceglie coniugando la fedeltà alla ricerca e la fedeltà al
mondo.33 In un certo senso, egli ci appare persino doppio, al
contempo strano ed estraneo al mondo umano. Nelle varie
scuole che rappresenteranno la scelta fondamentale della
vita interiore, sia che essa sia legata alla conoscenza o alla
saggezza,
varie
saranno
le
tecniche
prescelte,
dialettica/retorica, tensione/distensione, e soprattutto esercizi
che giovano allo spirito, esercizi della ragione che hanno per
l’anima la stessa valenza della cura medica, esercizi della
ragione che sono “meditazione”.
La ricerca della felicità
35
A partire dall’antichità, si è sempre cercato di definire il
concetto di felicità e si è sempre pensato ad essa come a
un elemento essenziale, e per alcuni, addirittura,
rappresenta il fine ultimo della vita umana, quello per cui
bisogna vivere, desiderare, lottare, e a volte anche morire:
“È allora che ci si può avvedere che l’uomo desidera tutto ciò
che vuole, per l’influsso del Bene ultimo”34. La soluzione
attraverso cui giungervi l’uomo deve cercarla non all’esterno,
ma dentro se stesso, ovvero conoscendosi. Gli stoici
dividevano la filosofia in tre discipline: la logica, che si
occupa del procedimento del conoscere; la fisica, che si
occupa dell'oggetto del conoscere; l'etica, che si occupa
della condotta conforme alla natura razionale dell'oggetto.
Essi portavano un esempio: la logica è il recinto che delimita
il terreno, la fisica l'albero e l'etica è il frutto35. L'anima del
saggio nella sua ricerca è ispirata da un messaggio divino
che è il logos. La verità che il logos annuncia è che il conflitto
fra gli opposti è solo apparente, in quanto gli opposti sono
una sola e medesima cosa, in quanto al di là di essi vi è una
legge immutabile che li sovrasta: gli opposti sono frammenti
di un'unica realtà che permane immutabile e racchiude
dentro di sé il cambiamento. Ovvero, se non ci fosse il bene
non esisterebbe il male, così come non esisterebbe la bugia
se non ci fosse la verità, due metà che formano l’intero, il
buio e la luce, il freddo e il caldo, il giorno e la notte, la
cattiveria e la bontà, il vizio e la virtù. Tutto si gioca sulla
capacità di discernimento dell’uomo, sulla sua ragione e sul
libero arbitrio. Parrebbe quasi, perciò, che l’essere distratti
nello spirito, rappresenti l’unico ostacolo al raggiungimento
della vera sapienza, che a sua volta può permettere il
raggiungimento della beatitudine e della felicità. Ma essendo
lo spirito e la materia uniti indissolubilmente, la saggezza
dagli stoici non è concepita come un'attività puramente
intellettuale, essa diventa propedeutica all'agire. Fra i doveri
degli uomini che sono esseri razionali, quindi vi è
36
innanzitutto la politica, per dedicarsi all’esercizio del bene
pubblico. L’uomo che fa parte della natura, è coinvolto a tutto
tondo con i vari aspetti della vita, nell’universo. Nel definire il
concetto di felicità, Platone introduce per la prima volta il
concetto di giustizia, che si riferisce, come tutti i valori
morali, alla più intima natura dell’uomo, quindi alla sua
anima (psyche): “l’uomo giusto è più felice dell’ingiusto?”36
A questo punto diviene necessario per il filosofo porsi una
domanda: quali condizioni si rendono necessarie affinché
l'uomo possa trovarsi in pace con se stesso, visto che
proprio nell'anima si svolge una continua lotta di elementi in
contrasto fra di loro? Secondo il suo pensiero, non vi sono
grandi alternative, infatti può ritenersi uomo giusto e sano,
solo colui che non si lascia sopraffare dalle passioni, un
uomo nel quale a governare sarà la parte razionale
dell'anima, che avrà il compito di guidare le altre due
componenti, quella concupiscibile e quella irascibile, in modo
che l’anima tenda verso i valori spirituali più puri, unico
mezzo per raggiungere la felicità. Secondo Seneca, quando
un uomo è schiavo del piacere, egli lo diventa
inevitabilmente anche del dolore. Se si vive ancorati alle
bellezze terrene e materiali, e ci si affida alla fortuna, allora
si perde il controllo di se stessi, e si diventa estremamente
vulnerabili, tanto da essere perennemente infelici, quando il
fato avverso non esaudisce le nostre richieste. Il piacere in
genere, e poi anche il piacere delle cose, dovrebbe essere
solo un compagno di viaggio della vita, e non colui che ne
detta le leggi, l’uomo dovrebbe entrare più in sintonia con la
natura, perché è solo lì che può risiedere la beatitudine.
Perciò vivere secondo natura equivale a vivere felici. Per
vivere felici bisogna conoscere e saper ben giudicare. In
questo di grande aiuto può essere la filosofia e la
meditazione, intesa come raccoglimento nei propri pensieri.
L'intento di Seneca è morale, egli ha come obiettivo il
progresso morale degli uomini: prendere coscienza di se
37
stessi. Un importante aiuto nel prendere coscienza di sé
viene proprio dall’ozio filosofico, dalla meditazione, da quella
vita ritirata che permette di staccarsi dai falsi beni e dalle
vanità della vita terrena e porta a guardarsi dentro. Egli è
un vero maestro dell’introspezione della coscienza. Poiché la
nobiltà di un uomo è data solo dalla virtù, bisogna imparare
il più presto possibile a far buon uso del tempo, e ciò è
determinato innanzitutto dalle nostre scelte di vita buone o
cattive. Come dice ancora una volta Pierre Hadot:
“Apprendre à vivre" était le premier but des exercices
spirituels. Pour toutes les écoles philosophiques de
l’antiquité la principale cause de souffrance et
d’inconscience de l’homme ce sont les passions: désirs
desordennés, craintes exagérées. […] La philosophie va
donc éduquer l’homme pour qu’il ne cherche à atteindre que
le bien qu’il peut obtenir et qu’il ne cherche à eviter que le
ne mal qu’il peut éviter.37
Le lettere dell’anima
Arriverà un momento nella storia della filosofia e della
scienza, in cui la lettera assumerà un ruolo importante di
divulgazione del sapere. Essa prenderà il posto che prima
apparteneva al dialogo. Gli epistolari diventeranno preziosi
documenti di vita, di arte e di indottrinamento. Attraverso
questi scritti dall’aria solo apparentemente informale, grandi
filosofi e scienziati divulgheranno il loro pensiero, la loro arte,
le loro scoperte, e tutto il loro ingegno, indirizzandole a
parenti, amici o colleghi lontani. Nasceranno miliardi di reti di
corrispondenza, attraverso corrieri, accademie e salotti
culturali, grazie alle quali col tempo sarà possibile ricostruire
secoli di storia, di vite, di pensieri e di menti geniali. I
carteggi, che a volte sembrano veri e propri trattati,
riguardano la metafisica, l’arte, la scienza, l’etica, la politica,
l’amore, la felicità, la morte, la medicina, l’astrologia e altro
38
ancora. Ogni filosofo durante la sua vita abbraccia con il suo
pensiero molti aspetti correlati tra loro, ma l’aspetto che a noi
interessa, in questa sede, continua ad essere quello del ben
vivere, per il raggiungimento della felicità. Dall’antichità
greca alla modernità del seicento, molti filosofi hanno scritto
lettere sulla felicità, sulla virtù e il saper ben vivere, offrendo
vari spunti per meditare.
La scuola aristotelica dei peripatetici segnò in maniera
evidente la via della nascita degli epistolarî. Ai peripatetici si
affianca Epicuro, che visse tra il 341 a.C. e il 270 a.C.,
dunque in età ellenistica, il quale, decisamente, spicca tra i
filosofi greci nell'uso dell'epistola dedicata ai suoi seguaci ed
amici. La lettera è espressione caratteristica della scuola
epicurea, una scuola che visse a lungo, fino al IV sec. d. C. e
che teneva immensamente agli stretti legami spirituali tra gli
affiliati dispersi su un gran territorio, come la Grecia, l'Asia
o l'Egitto, e sente il bisogno importante di convincere e
persuadere. Unito a loro quasi da fede religiosa, egli spiega
il suo credo filosofico in molte e varie trattazioni, che
possono avere a volte solo l’apparenza esteriore
dell'epistola, e trattano di fisica, meteorologia, etica, ecc.
fino a diventare dei veri trattati. L'attività epistolare epicurea
ha fatto pensare in certo senso all' attività apostolica, di
persuasione e diffusione di quello che in principio era il
verbo, divenuto poi parola scritta nelle lettere e nei vangeli.
Epicuro ritiene che negli uomini coesistano due stati d'animo
innegabili e originariamente irriducibili: il piacere e il dolore.
Tuttavia l'uomo è destinato a provare dolore solo se non
conosce la verità, e la verità, è assolutamente dipendente
dal saper distinguere il vero piacere dal piacere dei dissoluti.
Scopo dell’epicureismo è avviare l’uomo alla serenità felice,
ma proprio per questo è necessario che egli conosca la
realtà, dissolvendo con la ragione le illusorie paure. Dunque
la filosofia epicurea assume le sembianze di un vero
"farmaco" per l'anima, anzi un tetrafarmaco a largo spettro,
39
che copre tutti i mali e li guarisce secondo la visione del
filosofo fornendo la conoscenza indispensabile che convinca
l’uomo che: 1) la divinità non deve fare paura, 2) la morte
non è paurosa, 3) è facile procurarsi il bene, 4) è facile
sopportare il dolore. Ma come facciamo noi ad apprendere la
vera realtà? Secondo Epicuro unica fonte della conoscenza
è la sensazione, che rispecchia sempre una realtà. Dal
ripetersi delle sensazioni nasce in noi l’anticipazione (o
prolessi) che è vera in quanto confermata dall’esperienza. La
morale di Epicuro tende così a guidare il saggio al
raggiungimento di una serenità pari, appunto a quella degli
dei (atarassia). Serenità basata sulla liberazione dalle false
paure e sul giusto godimento dei piaceri, compresi i
godimenti del corpo, che corrispondono agli stimoli del
processo vitale. Connessa a questo scopo, però, è la virtù
della prudenza che, intesa come fondata sull’esperienza, ci
insegna l’incompatibilità di taluni piaceri e la necessità di
rinunciare serenamente agli uni se vogliamo godere gli altri.
Essa ci insegna principalmente ad anteporre a tutti gli altri il
piacere dell’amicizia. Quindi ingredienti e rimedi
indispensabili per la felicità sono: l'amicizia, la libertà ed il
pensiero, la parola e la scrittura consolatoria. "Ciò che al
presente non ci turba, stoltamente ci addolora quanto è
atteso". Questa frase riassume bene l'atteggiamento
filosofico di Epicuro: la vita è pratica di felicità, non conviene
pensare a ciò che potrà accadere in futuro se questo implica
la rovina della propria serenità presente. La Lettera a
Meneceo di Epicuro, vuole essere una sorta di formula per
liberare l'uomo dalle paure più comuni: la paura degli dei, la
paura della morte, la paura del futuro. Secondo il filosofo,
una volta liberato da queste paure, l'uomo raggiunge la
tranquillità dell'animo e la felicità, e la lettera si apre quindi,
con un'esortazione rivolta sia al giovane che al vecchio a
filosofare, in quanto la filosofia è riconosciuta come lo
strumento che conduce verso questi nobili obiettivi. Anche
40
se la vita del vecchio si volge più al passato e quella del
giovane più al futuro, è la filosofia a far sì che il primo non si
perda nel rimpianto, suggerendogli di godere dei beni
trascorsi, e i piaceri e i beni trascorsi, sono una certezza
della quale bisogna essere grati alla vita. Allo stesso modo è
la filosofia a placare l'ansia del giovane, liberandolo dalle
paure e da quei turbamenti e desideri che possono renderlo
infelice, consentendogli così di non temere l'avvenire.
Epicuro nella Lettera sulla felicità scrive a Meneceo:
(122) Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων
ὑπάρχων κοπιάτω φιλοσοφῶν· οὔτε γὰρ ἄωρος οὐδείς ἐστιν
οὔτε πάρωρος πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον. ὁ δὲ λέγων ἢ
μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν ὑπάρχειν ᾥραν ἤ παρεληλυθέναι τὴν
ᾥραν ὅμοιός ἐστι τῷ λέγοντι πρὸς εὐδαιμονίαν ἤ μὴ παρεῖναι
τὴν ᾥραν ἤ μηκέτι εἶναι. ὥστε φιλοσοφητέον καὶ νέῳ καὶ
γέροντι, τῷ μὲν ὅπως γηράσκων νεάζῃ τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν
χάριν τῶν γεγονότων, τῷ δὲ ὅπως νέος ἅμα καὶ παλαιός ᾖ
διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν μελλόντων· μελετᾶν οὖν χρὴ τὰ
ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν, εἴπερ παρούσης μὲν αὐτῆς πάντα
ἔχομεν, ἀπούσης δέ, πάντα πράττομεν εἰς τὸ ταύτην ἔχειν.
(123) Ἃ δέ σοι συνεχῶς παρήγγελλον, ταῦτα καὶ πρᾶττε καὶ
μελέτα, στοιχεῖα τοῦ καλῶς ζῆν ταῦτ’ εἶναι διαλαμβάνων.(44)
38
Egli parla così, all’amico, della filosofia come quadrifarmaco,
efficace contro la paura degli dei e della morte, del dolore e
del piacere, che risulta essere il solo fine della ricerca
filosofica in grado di assicurare benessere all’uomo.
Vivere secondo natura, vivere secondo ragione, vivere
secondo virtù. I massimi filosofi stoici concordano sulla
coincidenza della natura con il logòs che governa l’universo.
Vivere secondo natura equivale a vivere secondo ragione.
Adeguarsi a questa armonia universale è il compito
dell’uomo virtuoso, e il premio che a lui è destinato è la
41
felicità. La felicità per Seneca è vivere nella dimensione del
proprio essere razionale, vivere secondo verità perché
nessuno lontano dalla verità può dirsi felice. La perfetta
attuazione della ragione è la virtù morale ed essa può
avvenire solo tramite la conoscenza. La felicità non
consegue dalla virtù ma è la virtù stessa. L’uomo felice è
artefice della propria vita in quanto non si lascia sopraffare o
condizionare dall’esterno, la vera libertà del saggio infatti
consiste nell’uniformare i propri desideri con ciò che vuole il
destino stesso. A chi si trova fuori da ogni desiderio non può
venirgli nulla dall’esterno, perché ha già tutto dentro di sé.
Una delle ultime opere che Seneca scrisse, dopo il suo ritiro
dalla vita politica attiva, vivendo in una villa privata fuori città,
furono Le lettere a Lucilio, scritte tra il 62 e il 65 d. c., opera
che però è giunta incompleta. Abbiamo: 124 Epistulae
morales ad Lucilium, venti libri, composti negli ultimi anni di
vita. Seneca trasmette in questa raccolta epistolare il suo
pensiero e la sua esperienza, secondo i principi della
filosofia stoica. Tacito ci racconta che ebbero molti lettori e
anche molte critiche. Secondo questo nuovo mezzo, quindi,
l'oggetto della cura dell’anima è anche l'autore, che medita
scrivendo. La forma epistolare diventa un colloquio familiare,
che concede libertà nell'affrontare vari argomenti che si
intrecciano. Nelle lettere coesistono la dimensione teoretica
e quella pratica. Ci sono lettere scritte in tono familiare ed
altre che nel loro componimento diventano simili a veri e
propri trattati, si scrive per dare chiarezza a se stessi, ai
propri dubbi che hanno bisogno di essere elaborati, ma si
scrive anche per dare appoggio a coloro che cercano i lumi
nella filosofia. Si medita sui temi della vita, si mettono per
iscritto le proprie riflessioni, e si inviano a coloro che soffrono
con la speranza di recare conforto e alleviare le pene del
cuore e dell’anima. L’inchiostro diventa medicina. L'epistola
assume, così, un'importanza ancora sconosciuta; occupa, il
posto che precedentemente apparteneva al dialogo
42
socratico. Il modello cui egli intende uniformarsi è Epicuro,
colui che nelle lettere agli amici ha saputo arrivare ad un alto
grado di formazione e di educazione spirituale. Seneca
utilizza la lettera come strumento ideale soprattutto per la
prima fase della direzione spirituale. Propone l'ideale di una
vita indirizzata al raccoglimento e alla meditazione, ad un
perfezionamento interiore mediante un'attenta riflessione
sulle debolezze e i vizi propri e altrui.
Ita fac, mi Lucili:
vindica te tibi, et tempus quod adhuc aut auferebatur aut
subripiebatur aut excidebat collige et serva. Persuade tibi
hoc sic esse ut scribo: quaedam tempora eripiuntur nobis,
quaedam subducuntur, quaedam effluunt. Turpissima tamen
est iactura quae per neglegentiam fit. Et si volueris
attendere, magna pars vitae elabitur male agentibus,
maxima nihil agentibus, tota vita aliud agentibus. [2] Quem
mihi dabis qui aliquod pretium tempori ponat, qui diem
aestimet, qui intellegat se cotidie mori? In hoc enim fallimur,
quod mortem prospicimus: magna pars eius iam praeterit;
quidquid aetatis retro est mors tenet. Fac ergo, mi Lucili,
quod facere te scribis, omnes horas complectere; sic fiet ut
minus ex crastino pendeas, si hodierno manum inieceris. [3]
Dum differtur vita transcurrit. Omnia, Lucili, aliena sunt,
tempus tantum nostrum est; in huius rei unius fugacis ac
lubricae possessionem natura nos misit, ex qua expellit
quicumque vult. Et tanta stultitia mortalium est ut quae
minima et vilissima sunt, certe reparabilia, imputari sibi cum
impetravere patiantur, nemo se iudicet quicquam debere qui
tempus accepit, cum interim hoc unum est quod ne gratus
quidem potest reddere.(45) 39
Il distacco dal mondo e dalle passioni che lo agitano si
accentua, nelle Epistole, di pari passo al fascino della vita
appartata e dell'erigersi dell'ozio a valore supremo: un ozio
43
che non è inerzia, ma instancabile ricerca del bene. Le
Epistole torneranno alla luce nei monasteri carolingi Francesi
e in Germania. In Italia nel 13° sec. ottengono grandi
successi, suscitando interesse nel periodo che va
dall’umanesimo al rinascimento. In seguito saranno una vera
e propria ispirazione per tutti quei letterati, scienziati,
pensatori e filosofi che le useranno mettendo per iscritto le
proprie meditazioni, divulgandole ad amici e membri delle
varie accademie, come i moralisti francesi.
Cartesio ritenne di aver trovato un metodo – guida, per
l’orientamento dell’uomo nel mondo, che avrebbe condotto
ad una filosofia non meramente speculativa, ma anche
pratica, permettendo cioè, all’uomo, di utilizzare le forze
della natura per rendersene padrone e possessore, e
magari in questo modo si sarebbe potuti riuscire anche a
schivare l’indebolimento della vecchiaia. Quindi la saggezza
di chi studia la filosofia non è altro che la conoscenza
perfetta di tutte le cose che l’uomo può sapere in virtù
dell’indirizzo che ha saputo dare alla sua vita, grazie alla
buona salute e alle buone arti che ha saputo sfruttare nella
vita pratica del mondo. Tutta la filosofia è come un albero, le
cui radici sono la metafisica, il tronco è la fisica, ed i rami
principali sono la medicina, la meccanica e la morale.
Secondo il filosofo, il buon senso è la cosa del mondo meglio
distribuita, e la verità si raggiunge con il buon senso o la
ragione, che distingue l’uomo dall’animale, cioè la facoltà di
ben giudicare e di distinguere il vero dal falso. Effettivamente
però, egli distingue due domini diversi: l’uso della vita e la
contemplazione della verità.
Nel primo caso la volontà ha l’obbligo di decidersi senza
attendere l’evidenza; nel secondo ha l’obbligo di non
decidere finché l’evidenza non sia stata raggiunta. Nel
dominio della contemplazione l’uomo non può contentarsi
della verità evidente, nel dominio dell’azione l’uomo può
44
contentarsi della probabilità. Mentre viene impegnato dalla
rifondazione della struttura conoscitiva ed operativa umana,
Cartesio, elabora una morale provvisoria, in attesa di poter
poi approfondire le massime di comportamento. La prima
regola, di questa morale, era di obbedire alle leggi e ai
costumi del proprio paese, restando fedeli alla religione
tradizionale, del suo re e dei suoi tutori, e regolandosi, per
ogni questione, secondo opinioni moderate evitando sempre
di eccedere. In effetti, questa regola, ha per Cartesio un
valore permanente e definitivo. La seconda regola era di
essere il più fermo e risoluto possibile nell’azione e di
seguire con costanza anche l’opinione più dubbiosa una
volta che fosse stata accettata. Anche questa regola è
suggerita dalle necessità della vita che obbligano, molte
volte, ad agire in mancanza di elementi sicuri e definitivi. La
terza regola era di cercare di vincere se stessi piuttosto che
di cercare di vincere la fortuna, quindi più facile sarebbe
risultato cambiare e adattare i propri pensieri piuttosto che
l’ordine del mondo. Questa regola rimane il caposaldo
fondamentale della sua morale, essa esprime nella formula
tradizionale del precetto stoico lo spirito del cartesianesimo,
il quale esige che l’uomo si lasci condurre unicamente dalla
propria ragione. L'attenzione alle massime è manifesta
anche nell'epistolario di Cartesio, in particolare nelle lettere
che il pensatore scambia con la principessa Elisabetta, nelle
quali egli si presenta in qualità di direttore spirituale.
Quello della direzione spirituale, era proprio un metodo atto
a consentire al discente di prendere coscienza dei propri
difetti, aiutandolo a compiere scelte individuali e ragionevoli
nella vita quotidiana, che ha origine nella scuola stoica. Ma
soprattutto è evidente nel pensiero filosofico di Seneca, il
quale dedica l'intero dialogo De tranquillitate animi a
condurre il malato, in maniera serena, sulla via di una
saggezza, che si identifica
anche con la guarigione,
mettendo a nudo la natura dei mali da cui è afflitto. Verso la
45
fine del 1642, un amico di famiglia, Pollot, parlò della
principessa del Palatinato a Cartesio che in quel periodo
risiedeva in Olanda. Egli aveva già sentito parlare del suo
acuto intelletto, e desiderava incontrarla. L’anno successivo
iniziò una fitta corrispondenza, nella quale la principessa
chiedeva a Cartesio di essere istruita. I due si scrissero dal
1643 al 1649. Il carteggio a noi pervenuto comprende 26
lettere di Elisabetta a Descartes e 33 lettere di Descartes a
Elisabetta. In genere il contenuto delle lettere di Elisabetta
viene a torto sottostimato a vantaggio delle idee del filosofo,
mentre in realtà ella pone delle questioni che mettono in
difficoltà il celebre pensatore. Queste lettere partendo dalla
trattazione di scienze come la fisica, diventano lezioni di
approfondimento, addirittura un vero corso di filosofia
morale, che avrà l’intento di curare l’anima afflitta della
principessa, che, dopo la morte di Cartesio, si ritirerà nel
convento luterano di Herdford in Westfalia, diventandone
badessa.
Nel corposo carteggio di Descartes, prezioso per i suoi
contenuti che affrontano un’infinità di argomenti, uno dei
quali è proprio quello della virtù e della scelta del bene che
derivano dalla conoscenza, per poter ben vivere senza
assoggettarsi alla fortuna, e condurre una vita senza molte e
inutili sofferenze, una delle sue più importanti
corrispondenze è proprio quella che riguarda tale aspetto,
che terrà per molti anni, con la giovane reale, alla quale
consiglierà in un primo tempo proprio la lettura del De Vita
Beata di Seneca, pensando di renderle un utile servigio
fornendole materiale per una interessante e piacevole
meditazione. Tuttavia si accorgerà presto di aver commesso
un errore, in quanto lo stoico in questo libro non riesce
pienamente a chiarire e a definire quale sia il concetto del
bene e della virtù, né quale via bisogna seguire per poterle
conseguire, così sarà egli stesso, nelle lettere successive a
illuminare la principessa, contrapponendosi alla tesi di
46
Seneca. Particolarmente in alcuni passi della loro
corrispondenza, si evince in modo chiaro, la pratica volta a
illuminare questo cammino a due, sulla ricerca della
beatitudine e della virtù, come in questa lettera del 4 agosto
1645, che Descartes scrive alla principessa, partendo
proprio dalla lettura di Seneca consigliata:
Descartes a Elisabetta
En suite de quoi, il me semble que Sènèque eût dû nous
enseigner toutes les principales vèritès, dont la
connaissance est requise pour faciliter l’usage de la vertu, et
règler nos dèsirs et nos passions, et ainsi jouir de la
bèatitude naturelle; ce qui aurait rendu son livre le milleur et
le plus utile qu’un Philosophe païen eût su Votre Altesse.(46)
40
Lettera alla quale Elisabetta risponderà di non essere ancora
riuscita a dissipare i suoi dubbi, sul come si possa
raggiungere la beatitudine senza far ricorso anche a ciò che
non dipende dalla volontà, in taluni casi in cui una malattia,
per esempio della ragione, ci pone:
Elisabetta a Descarets
Et c’est ainsi que ne saurais encore me dèsembarrasser du
doute, si on peut arriver a la bèatitude dont vous parlez,
sans l’assistance de ce qui ne dèpend pas absolumentde la
volontè, puisqu’il y a des maladies qui ȏtent tout à fait le
pouvoir de raisonner, et par consequèntcelui de jouir d’une
satisfaction raisonnable, d’autres qui diminuent la force, et
empȇchentde suivre les maximes que le bon sens aura
forgèes, et qui rendent l’homme le plus modéré, sujet à se
laisser emporrequierent une résolution prompte.(47) 41
47
Nel carteggio, il filosofo, verrà definito dalla stessa
principessa “il medico della sua anima”, poiché ella gli si
rivolgerà proprio con l’intento e con il bisogno di trovare cura
per i mali dello spirito, ma non solo, che l’affliggono,
causando angosciosi dubbi e perplessità.
Aggiunge: “Non sempre si misura a sufficienza fino a che
punto la visione antica della filosofia sia costantemente
presente in Cartesio, come ad esempio nelle Lettere alla
principessa Elisabetta, che sono d’altronde, fino ad un certo
punto, lettere di direzione spirituale”42. Ma è soprattutto nella
lettera del diciotto agosto 1645 che si può cogliere la filosofia
come terapia dell'anima e moderna "meditatio.” Con la scelta
del termine “meditatio” Cartesio intende favorire
l’assimilazione del suo pensiero attraverso un percorso di
immedesimazione con il suo fruitore. Il termine indica un
processo di autoriflessione, un esercizio spirituale ripetuto e
sistematico. Il lettore, in questo modo, viene reso partecipe
in maniera attiva dell’itinerarium mentis di conquista della
certezza, ed è spinto a lottare contro l’assuefazione dalle
abitudini, contratte attraverso le illusioni. Questo processo
porta a un rovesciamento dal senso comune.
Descartes a Elisabetta
Je remarque, premièrement, qu’il y a de la différence entre la
béatitude, le souverain bien et la dèrniere fin ou le but
auquel doivent tendre nos actions: car la béatitude n’est
pas le souverain bien; mais elle le présuppose, et elle est le
contentement ou la satisfaction d’esprit qui vient de ce qu’on
le possède. Mais, par la fin de nos actions, on peut entendre
l’un et l’autre; car le souverain bien est sans doute la chose
que nous devons proposer pour but en toutes nos actions, et
le contentement d’esprit qui en revient, étant l’attrait qui fait
que nous le recherchons, est aussi bon droit nommè notre
fin.(48) 43
48
Continuando in questa discussione su che cosa consista il
sommo bene e la beatitudine da raggiungere, il filosofo
aggiunge:
Enfine Epicure n’a pase eu tort , considérant en quoi
consiste la béatitude, et quel est le motif, ou la fin à laquelle
tendent nos actions, de dire que c’est la volupté en général,
c’est-à-dire le contentement de l’esprit; car, encore que la
seule conaissance de notre devoir nous pourrait obbliger à
faire de bonnes actions, cela ne nous ferait toutefois jouir
d’aucune béatitude, s’il ne nousen revenait aucun plaisir.[…]
Je crois pouvoir ici conclure que la beatitude ne consiste
qu’au contentement de l’esprit, c’est a dire le contentement
en général; car bien qu’il y ais des contentements qui
dépendent d corps, et des autres, qui n’en dépendent point,
il n’y en a toutefois aucun que dans l’esprit: mais que, pour
avoir un contentement qui soit solide, il est besoin de suivre
la vertu, c’est-a-dire d’avoir une volonté ferme et costante
d’exécuter tout ce que nous jugerons ȇtre le meilleur et
d’employer toute la force de notre entendement à en bien
juger.(49) 44
Nella loro corrispondenza inoltre, grazie agli interrogativi
posti da Elisabetta, Descartes cominciò a interessarsi al
tema delle passioni, la principessa, quindi, è da considerarsi
certamente all’origine di questo trattato che non può
prescindere dall’essere letto in relazione alla loro vasta
corrispondenza epistolare, dove Cartesio, ascoltando le sue
difficoltà esistenziali, si adopera negli anni a confortarla
attraverso la conversazione filosofica, che oggi potremmo
definire quasi un counseling filosofico ante litteram.
Elisabetta a Descartes
Je vous voudrais encore voir définir les passions, pour les
bien connaȋtre; car ceux qui les nomment perturbations de
49
l’ȃme, me persuaderaient que leur force ne consiste qu’ȃ
éblouir et soumettre la raison, si l’experience ne me |
montrait qu’il y en a qui nous portent aux actions
raisonnables. Mais je m’assure que vous m’y donnerez plus
de lumiére, quand vous expliquerez commente la force des
passions les rend d’autant plus utiles, lorsqu’elles sont
suijettes à la raison.(50) 45
E Descartes, effettivamente, si dedicherà da questo
momento, come se fosse una solenne promessa, a
riprendere la stesura del Trattato delle passioni dell’anima,
per poter arrivare a dare ad Elisabetta le risposte che
attende, compito facile in un certo senso, dovendo
interloquire con lei che più di chiunque altro conosce ormai
così bene, gli altri suoi scritti e il suo pensiero. I due
corrisposero costantemente (1643-1649) su temi di varia
natura (medicina, matematica, filosofia, politica). Descartes
le dedicò i Principi della filosofia (1644). Durante una
malattia della principessa (estate-autunno 1645) le inviò una
serie di lettere in cui le espose i principi della morale, cosa
che lo indusse poi a scrivere nell’inverno del 1645-1646 un
primo abbozzo delle Passioni, che già nell’aprile del 1646
darà da leggere alla principessa.
Descartes a Elisabetta
Mais il faut que j’examine plus particuliȇrement ces |
passions, afin de les pouvoir dȇfinir; ce qui me sera ici plus
aisé, que si j’écrivais à quelque autre.(51) 46
Così nella lettera del maggio 1646, il filosofo scriverà:
Pour les remédes cointre les excés des passions, j’avue bien
qu’ils sont difficiles pratiquer, et mȇme qu’ils ne peuvent
suffire pour empȇcher les désordres qui arrivent dans le
corps, mais seulement pour faire que l’ȃme ne soit point
50
troublée, et qu’elle puisse retenir son jugement libre.A quoi
je ne Juge pas qu’il soit besoin d’avoir une connaissance
exacte de la vérité de chaque chose, ni mȇme d’avoir prévu
en particulier tous les accidents qui peuvent survenir, ce qui
serait sans doute impossible; mais ḉ’est assez d’en avoir
imaginé en général de plus fȃcheux que ne sont ceux qui
arrivent, et de s’ȇtre préparé à les souffrir. Je ne crois pas
aussi qu’on péche guére par excés en désirant les choses
nécessaires à la vie: ce n’est que des mauvaises ou
superflues quel es désirs ont besoin d’ȇtre réglés. Car ceux
qui ne tendent qu’au bien sont, ce me semble, d’autant
meilleurs qu’il sont plus grads”(52) 47
Quando Cartesio capì che i bisogni della principessa non
erano solo di tipo teorico, iniziarono insieme un cammino
finalizzato a dare sollievo, nella vita della giovane, e a farle
considerare che le disgrazie non sono così devastanti,
purché si riesca a trovare equilibrio e felicità dentro se stessi.
La rivisitazione della morale provvisoria, il commento al De
Vita Beata di Seneca, l’analisi delle passioni, sono alcune
tappe del percorso. Cartesio diventerà, è vero, il medico
della sua anima, ma si può senz’altro dire che Elisabetta fu
la sua musa ispiratrice.
L’unica cosa che appare certa è che, da quando esiste,
l’uomo è sempre stato afflitto tanto dai mali fisici quanto dai
mali dell’anima, quelli che noi oggi tendiamo a chiamare
problemi esistenziali, ed è solo parlandone, che essi
possono guarire. Gorgia, grande sofista siceliota, sosteneva
che: “La potenza della parola nei riguardi delle cose
dell'anima sta nello stesso rapporto della potenza dei farmaci
nei riguardi delle cose del corpo.” Antichissimo quindi è il
bisogno della “cura” che è passato attraverso i secoli dal
dialogo come mezzo della trasformazione del singolo,
attraverso cui si imparava a vivere in maniera filosofica, alla
51
scrittura, che permetteva di rielaborare il proprio esercizio e
la propria meditazione, per arrivare sino ad oggi alla figura
del counselor filosofico. Oggi più che mai l’uomo ha bisogno
di essere affiancato e aiutato a superare i disagi della vita,
tirando fuori tutto il negativo che ha dentro, e ancora una
volta il miglior modo per avere successo sembra proprio
essere il metodo della maieutica socratica. Certamente
esistono i medici della psiche, ma che cos’è la psiche se non
una piccola parte dell’anima? La psicologia non è forse nata
proprio sulla scia del tramonto dell’anima voluto dalla cultura
occidentale moderna? Viviamo in un’epoca in cui per ogni
problema sembra esserci una soluzione, e c’è uno
specialista per ogni malattia, eppure non c’è più nessuno
che sia in grado di curare la nostra anima. Qual è la nostra
dimensione di realtà oltre la superficie dello spazio
impersonale degli scambi sociali? Quali sono le passioni
della nostra epoca? E ancora come si costruisce
l’esperienza soggettiva, il sapere dell’anima, in un vivere
dove si è smarrito il senso dell’agorà, il tempo dell’incontro e
del confronto, il tempo dell’ascolto dell’altro e del sentire di
sé in ognuno di noi? Viviamo in un’epoca dominata da quelle
che Spinoza chiamava le “passioni tristi.” Con questa
espressione il filosofo si riferiva all’impotenza e alla
disgregazione. La speranza era quella di un sapere globale,
capace di spiegare le leggi del reale e della natura per poterli
dominare. L’incertezza della nostra epoca ci viene
continuamente rimandata da eventi che evocano paesaggi
apocalittici: quasi a ribadire l’inconsistenza del dogma
positivista, “libero è colui che domina,”48 il succedersi
continuo di catastrofi naturali e le innumerevoli sequenze di
guerre e di lutti, hanno dissolto l’idea che l’universo globale
delle conoscenze, garantisca un qualsiasi dominio del reale
e che l’uomo possa essere padrone del suo tempo.
Ma le passioni tristi, ovvero il senso di disgregazione e di
impotenza, secondo Spinoza, non derivano solo da una crisi
52
di un’epoca che minaccia il futuro, bensì dalla diminuzione
della percezione di realtà, che viene dall’incapacità di
sentire, di avvertire il valore delle cose, e i vissuti del cuore
all’interno del mondo che scorre, del tempo che passa. La
parte IV dell’Etica49 è dedicata alla possibilità di trasformare
le passioni da stati di passività della mente in affetti
consapevoli, capaci di conservare le spinte emozionali più
costruttive contenendo le componenti depressive e
distruttive. Ciò che è venuto meno nel presente è la ricerca
di un diverso modo di accogliere il limite e la precarietà, che
invece proprio perché così palesemente pressanti, ci
dovrebbero spingere a godere di più del nostro tempo e ad
essere più felici. Viviamo in una società dove ormai si amano
più le cose delle persone, e questo non è più definibile
“amore per la vita.” Il tempo della modernità, lacera i
messaggi concettuali d’amore e misticismo che l’uomo
dovrebbe recepire nel suo animo, dall’ascolto della natura e
dall’infinto incomprensibile dell’universo. L’angoscia del
senso di vuoto, della perenne mancanza, della precarietà, si
consuma proprio in quel sapere dell’anima, che diventa
sempre più profondità di conoscenza e la conoscenza stessa
è un archetipo che si proietta in un tempo ancestrale. Alla
sua origine c’è una lotta con se stessi e la coscienza di
dover dare massima libertà alla parola, per concedere
respiro alla realtà che rischia di soffocare.
Di fronte alle incongruenze della vita, alla sua fragilità, alle
sue disattenzioni e contraddizioni, l’uomo deve trovare un
punto saldo a cui appoggiarsi, qualcosa in cui credere, e
credere che quel qualcosa darà pace al suo tormento.
L’uomo avverte il bisogno di fuggire da se stesso e il
bisogno, ancora più forte, di recuperare se stesso, sperando
che possa essere un passaggio di eternità dove si compia la
vera rivelazione del sé. Un tempo quando non si era ancora
smarrito il concetto di anima, le persone sofferenti trovavano
proprio nel dialogo, magari con un monaco, con un saggio,
53
con un anziano, quelle risposte e quel sollievo di cui
avevano bisogno, per placare il tumulto dell’anima, che non
può certo essere messo a tacere da un tubetto di ansiolitici.
Saper ascoltare un’anima in difficoltà, è una cosa
delicatissima, nobile ed estremamente faticosa, esattamente
come avveniva un tempo attraverso la confessione
liberatoria. Nel tempo abbiamo deliberatamente eliminato la
nozione di anima; abbiamo distrutto, idealmente, l’odioso
armadio del confessionale; ma che cosa ci è rimasto? Il
lettino dello psicanalista? Esso non può bastare a risanare il
baratro che oggi si è aperto nell’esistenza del singolo e della
comunità. Per curare il male di viverre, il male dell’anima,
dobbiamo ritornare alla filosofia che è, come sosteneva
Platone, la capacità di vedere l’intero e non le singole parti.
Siamo diventati dei professionisti delle mezze verità, degli
esperti del mezzo vedere, del mezzo sentire, del mezzo
comprendere: e questo sapere dimezzato, questa
conoscenza mutilata, li abbiamo chiamati verità,
accontentandoci di vedere solo quelle singole parti, ma
impossibilitati a vedere l’insieme. Tutto dipende da noi.
L’infelicità nasce dal desiderio di cose che non possiamo
avere la sicurezza di ottenere. Se le otteniamo siamo
persone felici e se non le otteniamo diventiamo persone
frustrate. Allora, un ottimo esercizio di filosofia pratica è
proprio quello di esercitarsi a rinunciare, ai piaceri volubili,
saper trasferire i nostri desideri, su cose realizzabili solo
grazie alla nostra volontà e non essere schiavi
dell’esteriorità. Sarà proprio esercitando il libero arbitrio sulla
nostra volontà che potremo diventare liberi e padroni della
nostra vita, e prenderci cura della nostra anima. Occorre
innanzitutto riabituarsi al raccoglimento interiore, alla
“meditatio,” alla riflessione, sui valori che rappresentano i
principi cardine della nostra esistenza, così da non avvertire
più alcun senso di vuoto e di smarrimento, nessuna
angoscia lacerante che ci consuma. Come dice Simon Weil:
54
“Quaggiù ci sentiamo stranieri, sradicati, in esilio; come
Ulisse che si destava in un paese sconosciuto, dove i
marinai l’avevano trasportato durante il sonno, e sentiva il
desiderio d’Itaca straziargli l’anima”.50
1 Aa. Vv., La svolta pratica in filosofia. Vol. 2. Dalla filosofia pratica
alla pratica filosofica, Discipline Filosofiche, XV, I, 2005
2 Platone, La Repubblica, X, 606.
3 Epitteto, Manuale, Mursia, Milano, 1971, trad. it. di Giacomo
Leopardi
4 Aristotele, Etica Nicomachea, III, 1 e II, 6 e Retorica, II, 1 -11.
5 Epicuro, Lettera a Meneceo (lettere sulla felicità.)
6 T. D’Aquino, Summa Theologiae, II, 2, 22-48.
7 T. Hobbes, Leviathan, 1, 6.
8 P. Ricoeur “ What is a text? Explanation and interpretation”, in
Hermeneutics and Human sciences , a cura di Jhon B. Thompson,
Cambridge UP, Cambridge 1981, pp.145-164
9 Aristotele, Metafisica, II, 1, 993 b 19-23
10 M. Foucault, Tecnologie del sé. in Un seminario con Michel
Foucault - Tecnologie del sè. Torino, Boringhieri, 1992. pag. 23
11 G. Invitto, La misura di sé tra virtù e malafede, Mimesis, MilanoUdine 2012, p.22
12 C. Manzo, titolo del saggio Segni e comprensione, n. 79, 2013,
p.3
13 Platone, op. cit., 85d.
14 Ivi, 189e-190d
15 P. Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique?, Gallimard,
Paris 1995; trad. it. Che cos’è la filosofia antica?, Einaudi, Torino
1998, p. 252
16 P. Hadot, La filosofia come modo di vivere. Conversazioni con
Jeannie Carlier e Arnold I. Davidson, Einaudi, Torino, 2008, cit., p.
170.
17 Cfr. Rivista di storia della filosofia, Volume 63, FAE Riviste,
2008; Guido Calogero, Scritti minori di filosofia antica, Bibliopolis,
1984; Patricia Fagan, John Edward Russon, Reexamining
Socrates in the Apology, Northwestern University Press, 2009 e
55
Gabriele Giannantoni, Dialogo socratico e nascita della dialettica
nella filosofia di Platone, Edizione postuma a cura di Bruno
Centrone, Edizioni Bibliopolis.
18 Walter Bernardi e Domenico Massaro, La cura degli altri. La
filosofia come terapia dell’anima, Università degli studi di Siena,
2005
19 Nicola Abbagnano, Dizionario di filosofia, ed. UTET, Torino,
1992, pag. 391
20 Cfr. P. Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica, (1987), tr. it.,
Torino, Einaudi 1988, pp. 29-68.
21 P. Hadot, La felicità degli antichi, Raffaello Cortina Editore,
Milano, 2011, p.63
22 M. Foucault
L’herméneutique du sujet, 2001, trad. it.
L’ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France (19811982), Feltrinelli, Milano 2003, cit., pp. 20-21, 71.107, 88-91, 180200, 330-367.
23 Ivi, p. 19
24 M.Foucault Histoire de la sexualité 3. Le souci de soi, 1984, tr.
it. Storia della sessualità 3. La cura di sé, Feltrinelli, Milano 2001,
pp. 48-53, 57-61, 67-70.
25 M. Foucault Discorse and Thruth, 1985, tr. it. Discorso e verità
nella Grecia antica, Donzelli, Roma 1997.
26 Maria Luisa Martini L’autocostituzione del soggetto in Michel
Foucault. www.pratichefilosofiche.it
27 Porfirio, Lettera a Marcella, 31, trad. it. Porfirio. Vangelo di un
pagano ( a. c. di A. R. Sodano), Rusconi, Milano, 1993, p.83.
28 Centro studi di Gallarate, Dizionario filosofico, Sansoni Editore,
Firenze, 1976, p. 914
29 P. Hadot, (2011) op. cit. p.73
30 P. Hadot,(1998) op. cit, p.119
31 S. C. Schuster, La pratica filosofica Apogeo editore, 2006,
pp.45,46.
32 P. Hadot, ivi, p.170
33 Mario Trombino, www.ilgiardinodeipensieri.eu/storiafil
34Tommaso d’Aquino, Summa Teologica, I-II q. 1, a. 6.
35 Hans Von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, II, fr. 38, Lipsia
1903
36 Platone, Repubblica, 352 d.
56
37 Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique,
Etudes Augustiniennes, Paris, 1981, pp. 16,17., 169-176.
38 Epicuro, Lettera sulla felicità. Massime capitali. Testo greco a
fronte, trad it di M. Lazzati, Brossura, Milano, 2010.
39 L. Annaei Senecae, Epistularum Moralium ad Lucilium Liber
Primus. Seneca, Lettere a Lucilio, libro I, Paideia Editrice, Brescia,
2001
40 Renè Descartes, Tutte le lettere 1619-1650, Giulia Belgioioso
(a. c. di), Descartes a Elisabetta, 4 agosto 1645, 267, 514,
pp.2060,2061, Bompiani, Milano, 2005.
41 Ivi, Elisabetta a Descartes, 16 agosto 1645, 269, 516, pp.
2064,2065.
42 P. Hadot, 1998 [2007], op. cit. p. 254.
43 René Descartes, (2005), op.cit., Descartes a Elisabetta, 18
agosto 1645, 275, 517, pp.2068,2069
44 Ivi, Descartes a Elisabetta, 18 agosto 1645, 276-277, 517,
pp.2070,2071
45 Ivi, Elisabetta a Descartes, 13 settembre 1645, 289-290, 520,
pp.2080,2083
46 Ivi, Descartes a Elisabetta, 6 ottobre 1645, 310, 526,
pp.2102,2103
47 Ivi, Descartes a Elisabetta, Maggio 1646, 411, 556, pp.
2200,2201
48 M. Benosayag, G. Smith , L’epoca delle passioni tristi,
Feltrinelli, Milano 2004, pp. 20,21
49 B. Spinoza,
Etica, Borirgheri, Torino 1973 parte IV,
proposizione 18
50 S. Weil Attente de Dieu, Arthème Fayard, Paris, 1966, tr. It.
Attesa di Dio, Rusconi, Milano, 1972, p.144.
57
La musica non è solo un’arte,
ma una categoria dello spirito umano
F. NIETZSCHE
1. Pro et contra Wagner
Il primo approccio di Nietzsche con il mondo musicale
wagneriano risale agli anni giovanili, quando costituì con altri
due sedicenni una sorta di sodalizio di estetica, dal nome
“Germania”. I conti di cassa della società registrarono, a un
dato momento del suo corso, l’acquisto dello spartito del
Tristano e Isotta53 (nella versione pianistica a cura di Hans
von Bülow), opera wagneriana che nel cuore del giovane
Friedrich restò a lungo simbolo di somma perfezione. Solo
nell’ottobre 1868 poté finalmente godere dal vivo il sensuale
effetto del Preludio, in occasione del concerto tenuto da
Wagner all’Euterpe Gesellshaft di Lipsia54. L’incontro diretto
di Nietzsche con il musicista seguì a breve, quando Wagner
si recò nella città natale, ospite della sorella Ottilie e del
cognato Hermann Brockhaus, per una alquanto misteriosa
visita in incognito. A seguito delle entusiasmanti discussioni
filosofiche e musicali tenute in casa dei Brockhaus, i due si
ripromisero di continuare altrove gli interessanti colloqui nei
quali s’erano ritrovati sorprendentemente vicini55.
Chiamato alla cattedra di filologia classica presso
l’Università di Basilea, per segnalazione del maestro
NOTE
ILLUSORIETÀ DELL’IDEALE WAGNERIANO
IN NIETZSCHE
di Elsa Martinelli
58
Ritschl56, Nietzsche giunse in città il 19 aprile 1869. Dopo
alcune settimane si recò a far visita a Wagner nel soggiorno
di Tribschen, presso Lucerna. Approssimandosi alla villa,
ascoltò il maestro al pianoforte intento a comporre le
armonie del lamento di Brünnhilde in Sigfrido, “Verwundet
hat mich, der mich erwekt!” (ferita m’ha colui che m’ha
svegliata!)57. Come ridestato da un lungo sonno e illuminato
da luce nuova, a seguito di quell’incontro iniziò a guardare al
musicista come a una figura centrale della propria esistenza,
dando inizio a un rapporto alla lunga tormentato e segnato
da ferite insanabili, sebbene fondamentale alla formazione
del filosofo.
Sentimenti di venerazione e gratitudine per Wagner
animarono il giovane in quella fase iniziale dell’amicizia 58.
Sebbene impegnato da orari gravosi in università e da una
quantità di impegni ai quali attendere in privato, trascorse
ore stupende a Tribschen, attratto oltre che dal musicista,
dalla di lui consorte, Cosima Liszt59, i quali sembrarono
piuttosto ritenere che il dottor Nietzsche non dovesse avere
altro compito che tornar utile alle proprie necessità – Cosima
rivolgendo all’amico richieste di personali commissioni a
Basilea, Wagner affidando alle sue cure la supervisione della
stampa dei primi capitoli del proprio Mein Leben60.
Pur provando grandissima simpatia riguardo a
Nietzsche, l’amicizia del tutto disinteressata fu un lusso che
Wagner si permise di rado: riconoscendo al giovane fini doti
di scrittore, si adoperò per asservirle alla propria causa. Il
titolo di professore onorario di filologia classica conferito a
Nietzsche aveva fortemente impressionato il musicista, il
quale per parte sua non aveva ricevuto troppi appoggi dai
dotti. Per l’ambizioso musicista la compagnia del giovane
filologo e del suo brillante collega di studi Erwin Rohde fu
motivo di grande orgoglio.
In quest’ottica utilitaristica, Wagner si aspettava,
evidentemente, che gli scritti di Nietzsche avrebbero
59
concorso a diffondere il wagnerismo nei circoli accademici
presso i quali l’entusiasmo era stato, fino a quel momento,
pressoché limitato. Benché consapevole di tali manovre
propagandistiche61, il giovane filologo restò profondamente
legato a Wagner, al quale riconobbe una genialità filosofica
oltre che musicale62.
Divenuto il rapporto tra i due sempre più stretto,
durante il periodo funestato dalla guerra franco-tedesca
(1870/71), che segnò il culmine della loro intimità, entrambi
attesero a scritti che riflettono questo felicissimo momento
della loro amicizia: il Beethoven, redatto da Wagner in
occasione del centenario della nascita del musicista (1870),
e Die Geburt del Tragödie aus dem Geiste der Musik (La
nascita della tragedia dallo spirito della musica), che
Nietzsche pubblicò nel gennaio del 187263.
L’opera di Nietzsche trae spunto da una serie di
problemi estetici, condivisi da Wagner, la cui soluzione fu
elaborata per anni nel suo pensiero. Teso allo sviluppo di tali
problematiche, aveva tenuto agli inizi del 1870 due
conferenze pubbliche a Basilea, rispettivamente dal titolo Il
dramma musicale greco (18 gennaio) e Socrate e la tragedia
(1 febbraio). I testi di queste due relazioni menzionano già i
cortei dionisiaci dell’antica Grecia, ma le categorie
“apollineo” e “dionisiaco” vi sono presentate secondo un uso
non estetico. Saranno tali poco più oltre nel saggio dal titolo
Visione dionisiaca del mondo, redatto nell’estate del 1870.
Nel Dramma musicale greco la troppo forte
preoccupazione per le tesi wagneriane ostacolò
un’esposizione originale: sulla scia di Wagner, Nietzsche
insisteva nella critica dell’opera moderna e della tragedia
classica francese, contrapponendo ad esse il dramma antico
visto come pluralità unificata di parallele prestazioni
artistiche. In Socrate e la tragedia le critiche furono
indirizzate contro Socrate ed Euripide ritenuti principali
corruttori della tragedia. Ricevuto a Tribschen il testo
60
manoscritto delle due conferenze, Wagner restò
particolarmente impressionato dalle tesi esposte nelle due
relazioni:
Ieri sera ho letto il Suo lavoro all’Amica [Cosima]. Dopo di
che ho dovuto darmi da fare un bel po’ per calmarla [...].
Quanto a me, ho provato per lo più un certo spavento per
l’ardire con cui Ella, così concisamente e categoricamente,
comunica una idea talmente nuova ad un pubblico
presumibilmente non troppo suscettibile di essere educato,
sicché Ella potrà ricevere l’assoluzione soltanto se da quella
parte nessuno capirà nulla. Persino coloro che sono iniziati
alle mie idee potrebbero, a loro volta, spaventarsi, se a
causa di queste idee si trovassero in conflitto con la loro fede
in Sofocle e, persino, in Eschilo. Io – per quanto riguarda la
mia persona – Le grido: così è! Ella ha colpito giusto, e ha
indicato esattamente e con la massima acutezza l’aspetto
decisivo, sicché attendo, pieno di meraviglia, il Suo ulteriore
sviluppo, per convincermi del comune pregiudizio dogmatico.
Ma mi preoccupo per Lei, e mi auguro con tutto il cuore che
Ella non debba rompersi il collo. Perciò vorrei consigliarLa di
non palesare più idee così sensazionali in lavori che mirano,
per fastidiose considerazioni, a un effetto superficiale; bensì
se Ella – come riconosco – ne è così profondamente
convinto, raccolga le Sue forze per un lavoro più ampio e di
più vasta portata su questo argomento. Allora, certamente,
troverà anche le parole giuste per gli errori divini di Socrate e
di Platone, i quali erano nature così possentemente creative,
che, sebbene ci allontaniamo da loro, dobbiamo tuttavia
venerarli.64
I presupposti alle teorie contenute nella Nascita della
tragedia si riscontrano nel saggio Visione dionisiaca del
mondo, inviato da Nietzsche a Cosima Wagner in occasione
del Natale 1870, col titolo mutato in La nascita del pensiero
61
tragico. In questo scritto, accanto alle categorie di “apollineo”
e “dionisiaco” nella accezione di istinti artistici primordiali
furono abbozzati vari temi estetici (il sentimento, il linguaggio
gestuale, il simbolismo del linguaggio musicale, il grido), in
vista di un approfondimento teoretico dell’intero problema
dell’arte.
Tali lavori costituirono la trama di riferimento sulla
quale impiantare le teorie che informano La nascita della
tragedia, primo saggio di grandi proporzioni del giovane
filologo sul quale continuarono a incombere le tesi
wagneriane al punto che, per le argomentazioni in esso
esposte, l’autore dichiarò apertamente di provare nei
confronti dell’amico musicista un certo imbarazzo. Quel che
aveva pensato e scritto apparve ai suoi occhi la parafrasi
imperfetta di intuizioni già da tempo elaborate da Wagner65.
Di ciò sembra voler fare ammenda nella minuta di una lettera
inviata a Wagner, in data 2 gennaio 1872:
Tutto quello che qui ho da dire sulla nascita della tragedia
greca, sarebbe stato detto da Lei meglio, più chiaramente e
in modo più convincente [...]. Infatti debbo scusare
l’esistenza di questo scritto, giacché che cosa potrei
raccontarLe, che Ella, proprio in questo campo dell’indagine
estetica non abbia già indovinato da lungo tempo? Mentre
d’altro canto temo che Ella, in molti punti, troverà che vado a
tentoni e sono fuori strada, mentre Ella con una parola ha
pronta l’illuminazione decisiva.66
Nel testo definitivo della missiva Nietzsche ribadì tali
convincimenti, dando peraltro l’impressione di provare un
qualche timore a non poter corrispondere, con la propria
opera, a quelle che credeva fossero le aspettative dell’amico
musicista:
62
Possa la mia opera, almeno in certo grado, corrispondere
alla simpatia che Ella, certo con mia confusione, ha rivolto
alla sua nascita. E se io, a mia volta, ritengo di avere ragione
nella questione principale, ciò vuol dire soltanto che Ella con
la Sua Arte deve avere ragione per l’eternità. In ogni pagina
troverà che cerco soltanto di ringraziarLa per tutto ciò che mi
ha dato: e in me si insinua soltanto il dubbio, se veramente
ho sentito in modo giusto che cosa Ella mi ha dato. [...]
Frattanto sento con orgoglio di essere segnato, e che d’ora
in poi mi si nominerà in rapporto con Lei.67
Per parte sua, Wagner dimostrò sincero entusiasmo
per La nascita della tragedia, e persino Cosima ebbe per
Nietzsche parole di elogio per aver concepito e realizzato
quel saggio68.
Assai diversa fu la posizione assunta riguardo
all’opera negli ambienti accademici. Il libro provocò accese
polemiche, soprattutto per l’improvvisa direzione intrapresa
dall’autore con quella pubblicazione che sembrò costituire
una minaccia per la scienza. Fino a quel momento Nietzsche
aveva interpretato il ruolo del classico studioso che «accetta
la tradizione della filologia, ammonisce i suoi amici a
reprimere la fantasia, a rispettare il metodo, a controllare le
ipotesi. Poi viene questo libro, dove tutto è contraddetto,
dove nessuno allora riconobbe l’autore. Dall’università
tedesca esce la rottura della sua stessa visione del mondo,
d’improvviso, senza che nessuno potesse aspettarselo, da
uno che aveva studiato a Pforta, a Bonn, a Lipsia. [...] Tutti
capirono che la scienza ufficiale era in pericolo, che quelli
erano modi illeciti, contro il galateo, di trattare l’antichità.
L’antichità doveva restare appunto qualcosa di antiquato, di
inoffensivo, eventualmente edificante o illustrativo o retorico.
Come si poteva permettere che diventasse qualcosa di
ingombrante, di vivente, che non si può “storicizzare”, cioè
sterilizzare?».69
63
La diffusione dell’opera segnò l’avvio di una furiosa
querelle che annoverò nelle file dell’opposizione persino il
princeps philologorum, l’erudito Wilamowitz70, il quale replicò
pubblicamente alla Nascita della tragedia con il pamphlet
Zukunftsphilologie! (1872). In risposta al tentativo di
salvataggio del lavoro di Nietzsche ad opera di Wagner e del
fidato amico e collega Erwin Rohde71, Wilamowitz ribadì le
proprie posizioni pubblicando nel 1873 la seconda parte di
Filologia dell’avvenire! La diffusa ostilità e i numerosi giudizi
negativi sulla Nascita della tragedia amareggiarono
profondamente Nietzsche:
Tra i miei colleghi sono diventato improvvisamente così
screditato. [...] Tutti mi condannano e perfino quelli “che mi
conoscono” non arrivano più in là che a compiangermi per
quella “assurdità”. Un professore di filologia [Hermann
Usener, filologo e storico delle religioni], che stimo molto, ha
detto semplicemente ai suoi studenti a Bonn che il mio libro
è “follia pura” e assolutamente inservibile; e che uno che
scrive roba del genere è “morto per la scienza”.72
Che un giovane filologo dal così promettente
avvenire avesse elaborato la sua prima opera rigettando i
mezzi tradizionali della scienza, per di più in favore di una
causa (il wagnerismo) guardata con tanto sospetto, apparve
come un tradimento che ne decretò la morte accademica.
È innegabile che nel saggio vi sia un’impronta
wagneriana. La musica della Nascita della tragedia è musica
wagneriana e in qualche luogo anche lo stile e il clima
espressivo del libro riecheggiano la prosa di Wagner. Se il
punto di partenza della meditazione di Nietzsche sulle origini
fu l’amore (intensissimo sempre) per il Tristano e Isotta,
proprio tale amore estremo celava in sé il presentimento di
un conflitto che non tardò ad emergere.
64
È difficile indicare con precisione il momento di
frattura, il momento in cui Nietzsche iniziò a dubitare di
Wagner e delle sue opere. Con ogni probabilità i dubbi
andarono sviluppandosi al tempo del trasferimento a
Bayreuth, come annotato in appunti risalenti all’estate del
1876:
Il mio errore è stato di andare a Bayreuth con un ideale,
perciò dovetti subire la delusione più amara. L’eccesso di
volgarità, di sapidità, mi respinse violentemente. Allora non
soltanto toccai con mano la completa vanità e illusorietà
dell’ideale wagneriano; ma vidi soprattutto che, perfino per
coloro che vi erano più impegnati, l’“ideale” non era la cosa
più importante, e che le cose del tutto estranee venivano
ritenute più importanti, più appassionanti.73
A riconferma di tale sentimento di delusione, ne
precisò le motivazioni nel pamphlet dal titolo Nietzsche
contra Wagner, scritto nel suo ultimo anno di lucidità mentale
(1888-1889):
Già nell’estate del 1876, nel bel mezzo del primo festival [al
Festspielhaus di Bayreuth], presi dentro di me congedo da
Wagner. Non sopporto nessuna ambiguità; da quando
Wagner venne in Germania, accondiscese poco per volta a
tutto ciò che io disprezzo – persino all’antisemitismo... Era
proprio quello, in realtà, il momento giusto per congedarsi:
ben presto ne ebbi la prova.74
Nietzsche iniziò a individuare nel wagnerismo, più
che una forza artistica rigenerante, una moda, una snervante
menzogna, un discorso artificioso da demagogo adatto per
ogni folla. L’antico sospetto sulla fondamentale identità tra
dramma wagneriano e grand-opéra si fece maggiore
certezza. Più nulla poté distogliere Nietzsche dalla
65
convinzione che l’opera di Wagner costituisse un tentativo di
imporre e dominare mettendo insieme qualunque cosa:
l’elemento nevrotico, quello estatico, sontuoso, fragoroso,
tutti scaraventati alla rinfusa entro la cornice grandiosa del
grand-opéra. Il teatro totale di Wagner, con la retorica del
senso tragico e l’importanza conferita all’elemento
drammaturgico-spettacolare, gli apparve ben lontano
dall’ebrezza dionisiaca e piuttosto affine al dramma
decadente di Euripide.
La delusione per tante promesse disattese si fece col
tempo più cogente e il distacco dal genio, così devotamente
ammirato, doloroso ma necessario: «Niente può
compensare per me il fatto di aver perduto negli ultimi anni la
simpatia di Wagner [...]. Ma ormai è finita: e a che serve
avere ragione in parecchi punti contro di lui».75
Tra il 1876 e il 1888, nel decennio che corse tra la
pubblicazione di Richard Wagner a Bayreuth (esaltazione
incondizionata del genio wagneriano) e Il caso Wagner
(accusa insolente e spietata mossa al musicista), Nietzsche
nutrì il proprio risentimento per avere subito e patito il fascino
del grande maestro ed elaborò la propria rivolta contro la
modernità, che Wagner compendiava, nel timore, tuttavia, di
ricadere nella sua rete. Visse il rapporto di amore-odio con
Wagner in termini esasperati, persino allucinati, quando non
solo dichiarò il suo entusiasmo per il Bizet della Carmen76,
ma gli capitò addirittura di affermare la sua preferenza per
l’opera di Peter Gast, musicista destinato nel tempo al più
completo e meritato oblio77.
La prospettiva era inevitabilmente mutata, definitivo e
ineluttabile il congedo dal musicista:
Eravamo amici, e siamo diventati estranei. Ma è giusto che
sia così, e non vogliamo nascondercelo né stendervi un velo,
quasi che dovessimo vergognarcene. Siamo due navi,
ognuna delle quali ha il suo fine e la sua rotta; possiamo
66
benissimo incrociarci e far festa insieme, come abbiamo
fatto, [...] forse ci rivedremo ma non ci riconosceremo: i mari
e i soli diversi ci hanno cambiato! Che dovessimo diventare
estranei l’uno all’altro è la legge che sta sopra di noi: ma
proprio così dobbiamo diventare più degni di noi! Proprio
così il pensiero della nostra amicizia di un tempo deve
diventare più sacro!78
La grande illusione wagneriana era finita, i problemi
posti nei libri erano diventati vita, iniziavano gli anni del
tormento fisico. L’ultimo Nietzsche rimase solo, con i suoi
interrogativi inquietanti e le sue convinzioni (il tentativo
sovrumano di una affermazione e giustificazione della vita, il
valore della scienza e dell’arte e la loro giustificazione
dinanzi alla vita). Perduto ogni contatto con quelli che pure lo
avevano seguito nella sua avventura, volse l’esistenza verso
un tragico epilogo. Il velo protettivo della pazzia gli evitò
ulteriori tradimenti ed equivoci.
2. Sogno ed ebrezza
Die Geburt del Tragödie aus dem Geiste der Musik
(La nascita della tragedia dallo spirito della musica) è il primo
importante saggio del 1872 con il quale Nietzsche si
allontanò dagli studi rigorosamente filologici che avevano
caratterizzato gli anni della formazione, per rivolgere i suoi
interessi alla filosofia. Gli studi scientifici, che pure gli
avevano
procurato
numerosi
successi
(appena
venticinquenne fu nominato professore straordinario di
filologia classica presso l’Università di Basilea, incarico che
tenne dal 1869 al 1879), non poterono più soddisfare gli
impulsi che lo spinsero a indagare nel passato per ritrovare
le verità originarie della vita, quel desiderio di vivere l’arte e
non farne solo oggetto di metodica ricerca. Questi stimoli e
alcuni felici incontri della sua esistenza (la scoperta della
67
filosofia di Schopenhauer e l’amicizia con Wagner) fecero di
un così promettente filologo un eccellente pensatore. In
questa metamorfosi vanno collocate le sue meditazioni
sull’arte tragica e musicale che trovarono sfogo sistematico
nel saggio filosofico dal titolo La nascita della tragedia.
Per Nietzsche il mondo può essere spiegato solo in
termini estetici (obiettivo principale è trovare nella propria
speculazione un posto per la tragedia dell’esistenza,
dimostrare che essa appartiene a quell’affresco totale della
vita vista come processo creativo). Per fondare la propria
teoria prende spunto dal mondo greco: il popolo ellenico è il
solo che, nella storia dell’umanità, abbia sentito
profondamente la tragicità dell’esistenza, riuscendo a
trasfigurare la consapevolezza del dolore nell’arte.
Il pensiero nietzscheano muove dalla medesima
diagnosi della vita fornita da Schopenhauer: l’esistenza è
dolore, caos, lotta insensata e crudele. A fronte della cieca
animalità del vivere, Schopenhauer aveva indicato la via
della rinuncia e dell’ascesi contemplativa, ora Nietzsche
respinge questa morale schiva, tipica dell’umiltà cristiana,
per affermare la necessità di accettare e celebrare
entusiasticamente la vita, così com’è.
Indica il popolo ellenico quale luminoso esempio,
nella storia della civiltà, della possibilità di dominare le
oscure forze della natura, dominazione che i Greci
conseguirono facendo ricorso al “mondo intermedio” degli
dei olimpici.
Il Greco conobbe e sentì i terrori e le atrocità dell’esistenza:
per poter comunque vivere, egli dové porre davanti a tutto
ciò la splendida nascita sognata degli dei olimpici. L’enorme
diffidenza verso le forze titaniche della natura [...] fu dai
Greci ogni volta superata o comunque nascosta e sottratta
alla vista, mediante quel mondo artistico intermedio degli dei
68
olimpici. Fu per poter vivere che i Greci dovettero, per
profondissima necessità, creare questi dei.79
Deriva da tali premesse il celebre assunto della
Nascita della tragedia, vale a dire il conflitto tra “apollineo”
(capacità di contemplare, sognare, creare nel sogno e
nell’illusione) e “dionisiaco” (forza dell’ebrezza, del delirio,
impulso che bandisce limite e rassegnazione).
Alle loro [dei Greci] due divinità artistiche, Apollo e Dioniso si
riallaccia la nostra conoscenza del fatto che nel mondo
greco sussiste un enorme contrasto, per origine e per fini, fra
l’arte dello scultore, l’apollinea, e l’arte non figurativa della
musica, quella di Dioniso: i due impulsi così diversi
procedono l’uno accanto all’altro, per lo più in aperto dissidio
fra loro e con un’eccitazione reciproca a frutti sempre nuovi e
più robusti, per perpetuare in essi la lotta di quell’antitesi,
che il comune termine “arte” solo apparentemente supera;
finché da ultimo, per un miracoloso atto metafisico della
“volontà” ellenica, appaiono accoppiati l’uno all’altro e in
questo accoppiamento producono finalmente l’opera d’arte
altrettanto dionisiaca che apollinea della tragedia attica.80
La spiegazione delle varie fasi della civiltà e cultura
greche va ricercata nel conflitto tra Apollo e Dioniso, tra
impulso apollineo e impulso dionisiaco (sogno ed ebrezza), i
quali di volta in volta avrebbero prodotto opere d’arte
secondo che l’uno o l’altro, vicendevolmente, abbia prevalso.
La conciliazione delle due forze in contrasto trova attuazione
nella tragedia attica del V secolo a.C.
Da buon esegeta dell’antichità, Nietzsche pone la
questione delle origini della tragedia e del ditirambo
drammatico. Teoria di partenza è ancora la teoria della
musica di Schopenhauer, che vuole la musica radicalmente
separata da ogni altra forma artistica: la musica rappresenta
69
la realtà metafisica, mentre le altre arti sono solo prototipi
della realtà. Anche in Nietzsche la musica rappresenta la
“volontà”, ma il problema consiste nel superare la distinzione
tra le varie arti e realizzare un’organica unione tra musica e
poesia, essendo la tragedia scaturita dallo spirito della
musica.
Il punto sul quale Nietzsche si allontana da
Schopenhauer sta nella poesia lirica, originariamente unione
di parole e musica. In questo legame trova germe la
coordinazione tra musica e dramma. Il poeta lirico (artista
dionisiaco) si identifica nel suo delirio con l’uno originario, col
reale metafisico, producendo un’immagine riflessa di tale
reale come musica finché, sotto l’influsso del “sogno
apollineo”, tale musica gli ridiventa visibile in una visione che
gli permette di interpretare la propria esperienza metafisica.
La poesia è effolgorazione imitativa della musica in
immagini e concetti balenanti, immagini che, in forma più
estesa, divengono ditirambi drammatici e tragedia. Una
melodia può produrre un numero indefinito di effolgorazioni
imitative, di visioni illusorie. Tali effolgorazioni non sono altro
che un tentativo del poeta di interpretare la propria
esperienza musicale a se stesso in forma visionaria. Non
sempre tali tentativi hanno completo successo, essendo
impossibile esprimere adeguatamente in parole il significato
metafisico della musica. Il linguaggio compie ogni sforzo per
imitare o esprimere la musica, ma non c’è sentiero che
conduca dal reale metafisico (la musica) alla comprensione
(le parole della poesia). Solo la musica, grazie all’intimo
rapporto che ha con la vera essenza delle cose, ci dà di
esse il senso più chiaro, arricchendo di significato, con la
propria potenza espressiva, le immagini e i concetti, i quali,
per parte loro, sono in grado solo di imitare l’apparenza. La
musica rappresenta l’origine, l’identificazione con le forze
primordiali e istintive, costituisce il nucleo, l’essenza intima
70
delle cose, con la conseguente indipendenza da immagine e
concetto, capaci solo di restituirne l’involucro.
Dalla teoria della poesia lirica Nietzsche pone in
evidenza la proposizione più importante sull’origine della
tragedia greca. Accogliendo i dati della tradizione indica
come prima forma di poesia tragica il coro ditirambico dei
satiri adoratori di Dioniso. Nel satiro riconosce un simbolo
dionisiaco attraverso il quale il coro trascende ogni
convenzione sociale e ricerca la conciliazione di uomo e
natura, per un processo in difesa dal nichilismo. Nella loro
profonda conoscenza del dolore, i Greci superarono il
rinnegamento della vita trasformandola in arte tragica. Il
germe della tragedia va individuato in un gruppo di adoratori
di Dioniso che, incantanti nella propria estasi e convertiti
nella propria immaginazione in satiri, trovano unione con le
forze della natura. Nasce, così, il coro tragico che nell’estasi
dionisiaca (come il poeta lirico) ha una visione
(originariamente le sofferenze di Dioniso).
Questo coro contempla nella sua visione il suo signore e
maestro Dioniso ed è perciò in eterno il coro servente: esso
vede come questi, il dio, soffra e si glorifichi, e perciò non
agisce esso stesso. Nonostante questa posizione,
assolutamente servile di fronte al dio, esso è tuttavia
l’espressione suprema, cioè dionisiaca della natura, e perciò
nell’entusiasmo pronuncia, come questa, sentenze oracolari
e di saggezza; come partecipe della sofferenza esso è
insieme il saggio, che annuncia la verità del cuore del
mondo.81
Se il coro è la rievocazione dei πάθη, delle sofferenze
di Dioniso, occorre spiegare l’evidenza delle fonti, vale a dire
giustificare il contenuto dei drammi pervenuti che solo
occasionalmente fanno riferimento a Dioniso e ai suoi riti,
mentre in sostanza il soggetto delle tragedie è tratto dai miti
71
sugli eroi. Nietzsche risolve la questione sostenendo che, nel
momento in cui la vicenda teatrale si trasforma in
rappresentazione di eventi mitici, l’eroe tragico rappresenta
in realtà il nume celato.
È tradizione incontestabile che la tragedia greca, nella sua
forma più antica, aveva per oggetto solo i dolori di Dioniso, e
che per molto tempo l’unico eroe presente in scena fu
appunto Dioniso. Con la stessa sicurezza peraltro si può
affermare che fino a Euripide Dioniso non cessò mai di
essere l’eroe tragico, e che tutte le figure famose della scena
greca, Prometeo, Edipo, eccetera, sono soltanto maschere
di quell’eroe originario. Che dietro a tutte queste maschere si
nasconda una divinità, è l’unica ragione essenziale della
tipica “idealità”, così spesso ammirata, di quelle celebri
figure.82
La morte dell’eroe tragico è simbolo della morte del
dio e della sua rinascita garantita dall’illusione apollinea che,
collocandosi come un mondo interposto tra l’individuo (i satiri
del coro ditirambico, l’eroe-dio) e la frantumazione del suo
essere individuale, gli rende salva la vita. Come il poeta lirico
nella funzione inebriante con il reale metafisico produce dalla
sua musica molte imitazioni o effolgorazioni in parole, il coro
dionisiaco “si alleggerisce” ripetutamente nelle visioni
apollinee.
Scena drammatica e azione sono una serie di visioni
originariamente presenti nella mente del coro, di seguito
proiettate nel teatro reale. Il dramma, nel senso più stretto
del termine, inizia quando la massa (originariamente solo ed
esclusivamente tutto il coro) si divide in attori e pubblico.
Intento originariamente ad auto-estasiarsi, il coro assume in
questa separazione il compito di diffondere la propria estasi
tra gli spettatori, mentre il pubblico, identificatosi con esso,
può godere della sua medesima visione. Il pubblico delle
72
origini non ha richieste razionalistiche tipiche di quello
euripideo o dell’opera: completamente ipnotizzato ed
estasiato mediante i canti del coro realizza la sua stessa
visione. Tutta la rappresentazione poggia sull’unione
ritualistica e religiosa del pubblico con gli attori. Fino a
quando tale rapporto ideale è in grado di esistere, lo spirito
della tragedia corrisponde strettamente allo spirito degli
spettatori. Lo stile primigenio sta proprio nell’unione di
musica e visione, nella combinazione impenetrabile di
sfondo e primo piano, di profondità e semplicità. Il mondo
visionario, col dialogo degli attori, si rivela chiaro e
trasparente, ma di una superficialità ingannevole che
maschera, in realtà, le più grandi profondità dionisiache e
tragiche.
Il declino della tragedia greca è prodotto di un nuovo
stile e, conseguentemente, di un diverso atteggiamento del
pubblico. È quel che avviene con i drammi di Euripide,
laddove il poeta non riconosce la funzione dell’elemento
dionisiaco della tragedia, anzi lo rimpiazza col razionalismo e
la passione, mettendo in scena l’uomo quotidiano, la
maschera fedele della realtà nella quale lo spettatore non
riconosce altri che se stesso: «Per opera sua l’uomo della
vita quotidiana si spinse, dalla parte riservata agli spettatori,
sulla scena; lo specchio, in cui prima venivano riflessi solo i
tratti grandi e arditi, mostrò ora quella meticolosa fedeltà che
riproduce coscienziosamente anche le linee non riuscite
della natura».83
Più che il cittadino medio, Euripide intende soddisfare
con la propria arte due figure taciturne e assorte individuate
nella cavea rumorosa. In ordine, lo stesso Euripide, visto non
come poeta, ma come pensatore che assiste perplesso ai
drammi di Eschilo e di Sofocle: «Così egli sedette in teatro,
stillandosi inquietamente il cervello da spettatore confessò a
se stesso di non capire i suoi grandi predecessori».84 Al
fianco di Euripide, come secondo spettatore, è Socrate, quel
73
demone che oppone all’entusiasmo dionisiaco il genio
razionalizzante.
Benché per solito si attribuisca a Euripide l’uccisione
materiale della tragedia, Nietzsche individua in Socrate il
vero antagonista dello spirito tragico dato che in virtù del
principio socratico secondo il quale “tutto deve essere
razionale per essere bello” il poeta osò spingere la propria
arte nella sfera limitante della dialettica, causandone
l’inevitabile declino. Il nuovo stile accorda così la vittoria allo
spirito scientifico, a tutto svantaggio dello spirito istintivo, e
tale vittoria sarà simbolo di tutte le epoche di decadenza.
Alla luce di tale lotta storica ideale, tra spirito critico e
spirito dionisiaco, Nietzsche interpreta le grandi tappe della
civiltà musicale, dalla tragedia attica fino al melodramma dei
suoi tempi. La logica socratica ha plasmato anche il mondo
dei suoni realizzando un prodotto, il melodramma, che priva
la musica della sua missione universale dionisiaca, per
conferirle carattere di puro diletto.
Se il programma degli umanisti fiorentini della
Camerata de’ Bardi intende far rivivere in questa nuova
forma d’arte lo spirito della tragedia greca, con Nietzsche il
melodramma non rappresenta la rinascita di tale spirito, ma
ancora una volta decreta la vittoria della cultura anti
dionisiaca. Con la sua innaturalità ed esteriorità il recitativo
può essere giustificato esclusivamente da una “tendenza
extra-artistica”.85
Questo alternarsi di discorso appassionatamente insistente,
ma cantato solo a metà, e di interiezioni tutte cantate, che è
nella natura dello stilo rappresentativo, questo sforzo
rapidamente mutevole di agire ora sul concetto e la
rappresentazione, ora sul fondo musicale dell’ascoltatore, è
qualcosa di così totalmente innaturale e di così intimamente
contraddittorio – in pari misura – con gli impulsi artistici del
74
dionisiaco e dell’apollineo, che bisogna dedurre un’origine
del recitativo che si trovi al di fuori di tutti gli istinti artistici.86
Anche la cultura socratica ha conosciuto il momento
del declino. Nietzsche colse i sintomi del risveglio dello
spirito dionisiaco nella propria epoca e, in particolare, in
Wagner, ultimo grande rappresentante della musica tedesca,
dopo Bach e Beethoven. Quanto non era riuscito agli eroici
restauratori dell’ideale greco nella poesia e nel pensiero (non
a Goethe, né a Schiller o a Winckelmann) si andò
realizzando, nel suo presente, grazie alla irresistibile forza
del dramma wagneriano.
Nel dramma musicale di Wagner l’individuo attinge le
più alte verità metafisiche, ode il grido di esultanza e
angoscia che si leva dalle profondità del mondo senza
esserne annientato. Come un tempo fece la tragedia greca,
il dramma wagneriano frappone tra rivelazione dionisiaca e
ascoltatore il mito, quale mezzo di salvazione dalla rinuncia
ascetica. Sulla sua persona, l’eroe del mito accetta il peso
della suprema idea del mondo. Solo commiserando lui con
pietà profondissima ci si può salvare dal dolore primordiale.
Nell’illusione apollinea le immagini allegoriche del mito
(Wotan, Brünnhilde, Tristano), soffrendo, additano la verità e
difendono dalla spaventosa esperienza del dolore. La luce di
una nuova cultura del mondo è nel mito germanico spinto ai
più alti significati dalla musica di Wagner.
Pur nell’entusiastica considerazione del dramma
musicale wagneriano, Nietzsche vi riconobbe solo l’esempio
più vicino al proprio ideale tragico, e già all’epoca della
Nascita della tragedia i dubbi sui drammi di Wagner poi
divenuti certezze si fecero in qualche modo sentire.
Nietzsche si trovò imbrigliato in pochi problemi nella
stesura del saggio, per non venir meno alla fedeltà verso
l’amico musicista e più ancora per non dover rinunciare alle
proprie convinzioni. Proprio il tentativo di conciliare
75
l’inconciliabile spiega alcune affermazioni provvisorie
contenute nella Nascita della tragedia o le vaghe allusioni
che lasciano spazio, com’è loro prerogativa, a differenti
interpretazioni. A ben vedere, gran parte dei riferimenti a
Wagner appare velata da una certa ambiguità. Servendosi di
tale escamotage Nietzsche riuscì a salvare la propria lealtà
verso l’amico e mascherare la contraddizione tra Wagner e
se stesso, in specie riguardo al fondamentale problema della
relazione tra musica e dramma.
Se in Wagner tutte le arti concorrono alla
realizzazione dell’unico fine che è il dramma (nella sua
concezione la musica è solo un mezzo), Nietzsche guardò
alla musica come arte autosufficiente, capace di annullare in
sé ogni contenuto poetico e drammatico. Appare evidente
quanto l’affermazione di Wagner, della derivazione della
musica dal dramma, potesse essere fonte di grande
imbarazzo per Nietzsche, il quale peraltro nella prima
stesura della Nascita della tragedia definì questa tesi una
“mostruosa superstizione artistica”, omettendo ovviamente
una così negativa e radicale considerazione nelle versioni
successive.
Nietzsche fu combattuto tra opposti sentimenti
riguardo a Wagner, le cui opere gli si offrirono
esclusivamente come primo progredire nella giusta
direzione, più che come esemplificazione perfetta del proprio
ideale di tragedia. Scorrendo con cura il saggio e leggendo
attentamente tra le righe della Nascita della tragedia diventa
palese come Nietzsche si premunì dal proclamare
nettamente Wagner novello Eschilo, lasciando invece
intendere che se uno ce ne sarebbe stato, sarebbe stato
prodotto del futuro. Le speranze poggiavano ancora sul
potere dionisiaco della musica tedesca, ma lo sguardo di
Nietzsche era rivolto alle generazioni a venire, nella scia di
Wagner, oltre Wagner.
76
1
La prima del Tristano e Isotta di Wagner si era tenuta
all’Hoftheater di Monaco in data 10 giugno 1865.
2
Nietzsche confidò all’amico Erwin Rohde (Amburgo 1845Heidelberg, 1898) le impressioni e sensazioni di rapimento
suscitate in lui da quel concerto in una lettera, in data 27 ottobre
1868, per la quale cfr. F. NIETZSCHE, Epistolario 1850-1869 (a
cura di G. Colli e M. Montinari), Milano, Adelphi 1976, pp. 637-640.
3
Nietzsche riferì a Rohde con entusiasmo di questo primo incontro
con Wagner in una lettera da Lipsia, in data 9 novembre 1868,
ibid., pp. 642-650.
4
Il filologo Friedrich Wilhelm Ritschl (Großvargula, 1806-Leipzig,
1876) fu un fervido studioso dei testi di Plauto e professore in varie
università, quali Halle, Breslavia, Lipsia e Bonn.
5
Atto III, scena III.
6
In proposito, cfr. le testimonianze dello stesso Nietzsche, che si
possono leggere passim in Carteggio Nietzsche Wagner (a cura di
M. Montinari), Torino, Boringhieri, 1959, Epistolario1850-1869, cit.,
e F. NIETZSCHE, Lettres choisies (20 novembre-21 dicembre
1888), Paris, Stock 1931.
7
Sposata da Wagner in seconde nozze dopo il divorzio dal
musicista Hans von Bülow.
8
La mia vita (1865-1880).
9
Perfino Nietzsche fu cosciente del desiderio dei wagneriani di
mettere a frutto le sue capacità letterarie. Al riguardo, cfr. la lettera
a Rohde, in data 28 febbraio 1869, in Epistolario 1850-1869, cit.,
pp. 684-687: «Recentemente ho espresso alcuni miei punti di vista
sulla musica del futuro, e ora i seguaci di questa cercano
insistentemente di cavarmi fuori qualcosa: io, per quanto mi
riguarda, non ho la minima voglia di mettermi subito a
schiamazzare in pubblico come una gallina. Senza considerare poi
che i miei signori fratelli in Wagnero [sic] sono per la maggior parte
terribilmente stupidi e scrivono in modo disgustoso».
77
10
Per gli esaltanti giudizi su Wagner confidati da Nietzsche
all’amico Rohde, cfr. la lettera da Lipsia, in data 9 dicembre 1868,
ibid., pp. 656-661.
11
Per le diverse stesure e rielaborazioni di quest’opera, cfr. le note
di G. Colli e M. Montinari in appendice a F. NIETZSCHE, La
nascita della tragedia, Milano, Adelphi 1972, vol. III, t. I, pp. 499503.
12
Lettera da Tribschen, in data 4 febbraio 1870, in Carteggio
Nietzsche Wagner, cit., pp. 33-35.
13
Spunti e analogie con le teorie esposte nella Nascita della
tragedia si riscontrano, in particolare, negli scritti zurighesi di
Wagner: L’arte e la rivoluzione (1849), L’opera d’arte dell’avvenire
(1849), Opera e dramma (1851).
14
Carteggio Nietzsche Wagner, cit., pp. 54-55.
15
Ibid., pp. 55-56.
16
Cfr. lettere di Wagner, in data 4 e 10 gennaio 1872, ibid.,
rispettivamente p. 57 e pp. 57-60: «Caro amico! Non avevo ancora
letto niente di più bello del Suo libro! Tutto è magnifico!»; «E ora
Ella pubblica un lavoro che non ha eguali. Ogni influenza che
potrebbe essere stata esercitata su di Lei è ridotta quasi a nulla
dall’intero carattere di questo Lavoro: ciò che contraddistingue il
Suo libro rispetto a tutti gli altri, è la compiuta sicurezza con cui vi
si manifesta un carattere estremamente profondo»; e ancora, v.
lettera di Cosima Wagner a Nietzsche, in data 10 gennaio 1872,
ibid., pp. 134-135: «In questo libro, Ella ha evocato degli spiriti che
credevo ubbidissero soltanto al nostro Maestro [Wagner]; Ella ha
gettato la luce più intensa su due mondi, dei quali l’uno non lo
vediamo perché è troppo lontano, l’altro non lo conosciamo perché
ci è troppo vicino: sicché afferriamo la bellezza che ci ha esaltato e
riempito di presentimenti, e comprendiamo la volgarità che per
poco non ci soffocava. [...] Non posso dirLe quanto mi commuova il
Suo libro, nel quale Ella constata con estrema semplicità la
tragicità della nostra esistenza; e come Le è riuscito di ottenere la
massima chiarezza nelle questioni più difficili!».
17
Dalla nota introduttiva di G. Colli a F. NIETZSCHE, La nascita
della tragedia, Milano, Adelphi 1986, pp. XI-XII.
18
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (Markowitz, 1848-Berlino,
1931).
78
19
Wagner intervenne in difesa del saggio incriminato con una
lettera aperta a Nietzsche, pubblicata in “Norddeutsche Allgemeine
Zeitung” il 23 giugno 1872; Rohde contribuì con due recensioni
all’opera, entrambe del ’72 (la prima presentata come
comunicazione al “Litterarisches Centralblatt”, ma respinta dal
direttore della rivista, la seconda per la “Norddeutsche Allgemeine
Zeitung”) e con una lettera a Wagner, dal titolo Afterphilologie,
sempre del ’72.
20
Lettera a Wagner, da Basilea, in data metà novembre del 1872,
in Carteggio Nietzsche Wagner, cit., pp. 81-84.
21
Ibid., pp. 153-154.
22
F. NIETZSCHE, Nietzsche contra Wagner (a cura di G. Colli e
M. Montinari), Milano, Adelphi 1970, vol. VI, t. III, p. 406.
23
Lettera a Peter Gast, in data 20 agosto 1880, in Carteggio
Nietzsche Wagner, cit., pp. 164-165.
24
Nietzsche ebbe modo di assistere alla prima italiana della
Carmen di Bizet il 27 novembre 1881 al Teatro Paganini di
Genova, restando particolarmente entusiasta del carattere di
quest’opera istintiva, solare e mediterranea, ricca di accenti
estremamente tragici, ma anche chiara e intellettuale. Nel saggio
Der Fall Wagner (Il caso Wagner) del 1888, originariamente
pubblicato con il sottotitolo Il problema di un musicista, esaltò gli
elementi esotici di quest’opera e la chiarezza strutturale della sua
partitura, definendola un simbolo della vera nuova musica. Al
riguardo, cfr. L. ABBATINO, Nietzsche tra Wagner e Bizet. La
Carmen di Bizet vista da Nietzsche, Lecce, Pensa multimedia
2007.
25
Peter Gast, pseudonimo di Heinrich Köselitz (Annaberg, 1854-ivi,
1918), studiò filologia e filosofia presso l’università di Basilea sotto
la guida di Burckardt, Overbeck e dello stesso Nietzsche, alla
morte del quale si dedicò alla sistemazione dell’archivio in Weimar.
Tra le composizioni di Gast (dalle opere teatrali alla musica da
camera e per coro) si ricorda l’elaborazione per orchestra della
Manfred-Meditation e dell’Hymnus an das Leben di Friedrich
Nietzsche; in merito ai giudizi in favore di Peter Gast, cfr. la lettera
di Nietzsche alla madre, in data 30 ottobre 1887, in Lettres
choisies, cit., p. 255: «Cette amélioration de situation lui a permis
de recommencer à composer des choses admirables bien
éloignées, fort heureusement, du coup de poing et de la crispation
79
de Wagner», e ancora la lettera di Nietzsche allo stesso Peter
Gast del 31 maggio 1888, ibid., p. 282: «Toutes les fois qu’une de
vos mélodies me vien à l’esprit je m’attarde à ces souvenirs avec
une longe rèconnaissance: rien ne m’ha jamais mieux renouvelé,
et élevé, et allégé que votre musique. C’est ma bonne musique par
excellence, et je me revêts toujours l’âme pour elle d’une vêtement
plus net que pour toute autre». Per la musica di Nietzsche (73
composizioni musicali), v. S. ZACCHINI, Al di là della musica.
Friederich Nietzsche nelle sue composizioni musicali, pref. di
Giorgio Penzo, Milano, Franco Angeli 2000.
26
Aforisma sull’amicizia “astrale”, in Carteggio Nietzsche Wagner,
cit., p. 165.
27
F. NIETZSCHE, La nascita della tragedia (ed. critica a cura di G.
Colli e M. Montinari), Milano, Adelphi 1972, vol. III, t. I, p. 32.
28
Ibid., p. 21.
29
Ibid., p. 62.
30
Ibid., p. 71.
31
Ibid., p. 76.
32
Ibid., p. 81.
33
Ibid., p. 124.
34
Ibid., p. 125.
80
LE PAROLE SONO RIVOLTELLE CARICHE
PRATICA LETTERARIA, SITUAZIONE ED ENGAGEMENT IN
JEAN-PAUL SARTRE
di Andrea Mincigrucci
La drammatica contingenza storica della guerra e
dell’occupazione, l’esperienza della resistenza e dell’azione
clandestina: tutto ciò non poteva passare senza conseguenze,
filosofiche e letterarie, nell’esistenza di Jean-Paul Sartre.
Quando viene dato alle stampe il saggio Que est-ce que la
littérature? è il 1947. Fino ad allora, il pensiero del filosofo
francese, declinatosi da subito sia nella sfera prettamente
filosofica che in quella letteraria, si aggirava tra le maglie
riflessive di un solipsismo esistenziale, dando forma
all’atteggiamento dell’uomo solo, che rappresenta la struttura
portante del suo primo romanzo, La Nausée. L’intellettuale
borghese che cerca di smascherare la malafede della sua
classe di provenienza che rifiuta e odia, non è solo un
personaggio letterario ma una figura filosofica forte; egli
subisce un’evoluzione che è la stessa che supporta l’intera
esistenza del suo autore. Già ne L’Être et le Néant, Sartre si
era reso conto in corso d’opera della necessità del
superamento dell’impasse teoretica del solipsismo, così come
lo aveva posto. Nella sua visione della “condizione umana
secondo l’esistenzialismo”, sottotitolo del suo trattato di
ontologia, egli aveva introdotto, dopo l’analisi del rapporto
individuale che intercorre tra l’essere umano come coscienza e
il mondo come in-sé – che d’altronde mantiene - quelle
81
categorie di ipseità, situazione e essere-per-altri, che denotano
i prodromi della sua svolta, teoretica ed esistenziale. Per un
intellettuale a tutto tondo come egli era, il solo ambito teoretico
era eccessivamente ristretto, il limitarsi all’indagine astratta del
pensiero e delle sue modalità di conoscenza rappresentava un
tradimento del concreto. Rimasto sempre fedele al suo
l’esistenza precede l’essenza, sentiva la necessità di un
ripensamento della letteratura, vista come apertura della
riflessione filosofica al mondo concreto della Storia, come
messa-in-situazione del pensiero stesso. Il saggio che qui si
cerca di analizzare, si mette subito in luce per la sua
impostazione rivoluzionaria e “scomoda” sul che cosa è quella
produzione umana intellettuale, la letteratura, e su che cosa
siano, o debbano impegnarsi a diventare, lo scrittore e – per la
prima volta nella storia culturale europea – il lettore. La ricerca
solipsistica della coscienza autodichiaratasi autonoma de La
Nausée e, in parte, dei personaggi che compongono il mosaico
di racconti della raccolta Le Mur, viene soppiantata da Sartre
da una serie di domande all’apparenza banali ma di un portata
storica e culturale fondamentale per l’evoluzione del romanzo
nel Novecento, che vengono poste direttamente in seno
all’agone della produzione letteraria. Senza dimenticare che
tale agone si svolge nel teatro situazionato della Storia. Perché
si scrive? Per chi si scrive? Che cos’è scrivere? Possiamo
affermare che il porre queste tre domande, che rappresentano
il fulcro, l’ossatura di Que est-ce que la littérature? abbia creato
un sommovimento di grande portata all’interno del panorama
letterario non solo francese ma europeo e mondiale. L’incedere
del saggio, che non a caso porta una domanda come titolo, è
una riflessione di ampio respiro sul fenomeno letterario, sui
rapporti tra letteratura e società, sui compiti e il ruolo
dell’intellettuale moderno, lo scrittore-in-situazione. Possiamo
affermare che questo saggio, centrale nello sviluppo del
pensiero sartriano, abbia rappresentato anche uno degli snodi
82
fondamentali per comprendere l’evoluzione della Teoria del
Romanzo e i suoi fondamentali legami con la Storia e con
l’esistenza umana.
L’unicità della letteratura e il problema del significato. Secondo
Sartre, ciò che è alla base di tutte le arti è una stessa scelta
indifferenziata, che in un secondo momento verrà determinata
dalle contingenze del mondo. In una medesima epoca storica,
tutte le arti sono influenzate dai fattori sociali, politici e culturali
nei quali sono immerse, e sono vicendevolmente condizionate
da loro stesse. Ma esse non sono fra loro parallele; non solo la
forma ma anche la sostanza diversifica fra loro le arti. È quindi
un problema di significato, in quanto non è possibile dipingere
o mettere in musica i significati, ma è possibile scrivere dei
significati. A differenza del poeta, lo scrittore di prosa ha a che
fare con i significati. Secondo Sartre, infatti, la poesia fa coppia
con la scultura e la pittura, il poeta non si serve delle parole
come il romanziere, e anzi le serve, «si ritirato di colpo dal
linguaggio-strumento; ha scelto una volta per sempre
l’atteggiamento poetico che considera le parole come cose e
non come segni»1. Le parole non perdono completamente il
loro significato, ma vengono rovesciate, esso diviene naturale,
e il linguaggio diviene lo specchio del mondo, per cui una
parola diviene un’immagine verbale scelta per somiglianza ad
un oggetto del mondo, ma che può tranquillamente non essere
la parola con la quale il linguaggio designa e significa un
determinato oggetto. La parola poetica è una sintesi di
reciproche implicazioni tra corpo sonoro ed anima verbale.
Viene così a instaurarsi tra la parola e la cosa, un duplice
rapporto di significato e rassomiglianza magica, e ciò compone
quell’unità poetica della frase-oggetto. Diversamente la prosa è
utilitaria, e lo scrittore si serve delle parole, le quali diventano
un particolare momento dell’azione. La prosa, quindi, assume
essa stessa i caratteri di una certa azione, mentre la poesia è
83
contemplazione disinteressata delle parole. Lo scopo del
linguaggio è comunicare, parlare è agire. «Così nel parlare,
svelo la situazione mentre progetto di cambiarla; la svelo a me
stesso e agli altri prima di cambiarla.»2
Il concetto di situazione: perché non si può essere imparziali.
Quindi, se da un lato la scrittura di prosa si struttura a partire
da un impegno concreto nel mondo presente, dall’altro essa
mette in atto una certa trascendenza, che lo supera in
direzione dell’avvenire; lo scrittore – di prosa – è colui che,
quindi, ha scelto di agire in un modo ben determinato, che
Sartre chiama di azione per rivelazione. Se la parola è azione e
lo svelare attraverso le parole è già un cambiamento, lo
svelamento è possibile solo all’interno di un progetto di
cambiamento. Non è possibile quindi un’imparzialità e,
paradossalmente e ironicamente, Sartre ci dice che qualora dio
esistesse non potrebbe essere imparziale di fronte all’uomo e
si troverebbe in-situazione. Evidentemente, assume centralità il
concetto di situazione, esplicitato già ne L’Être et le Néant e
che nel discorso letterario fonda l’urgenza della scrittura, la sua
traiettoria e la sua produzione di significati. La situazione è
l’intersezione tra l’inseità del mondo, che limita la mia libertà
sottoforma di dati e strutture situazionanti (il luogo di azione, il
passato storico-esisitenziale del singolo, le cose che mi
circondano e il loro coefficiente di utilizzabilità, la presenza
dell’Altro, l’alienazione che, superata e superabile attraverso
l’azione non può mai essere del tutto eliminata, e che invece
rappresenta il carattere essenziale di ogni situazione, la molla
della nostra presa di coscienza, e la morte come caduta
irresolubile e assurda nella datità definitiva) e la libertà
dell’individuo, che si esplicita nel progetto, come superamento,
attraverso l’azione, della situazione attuale verso l’avvenire. Il
linguaggio si situa come modalità primaria e fondamentale
attraverso la quale declinare tale impegno: tutt’altro che
84
innocenti, disinteressate o imparziali, le parole sono rivoltelle
cariche. «Lo scrittore ha scelto di svelare il mondo e, in
particolare, l’uomo agli altri uomini, perché questi assumano di
fronte all’oggetto così messo a nudo tutta la loro
responsabilità»3. Attraverso lo scrittore e la sua produzione,
nessuno ha più il diritto di ignorare il mondo e di proclamare la
propria innocenza nei suoi confronti. Nei rapporti dell’uomo col
mondo e con gli altri uomini, una volta che si compie il passo
verso il linguaggio, questi diventa ineludibile, non è più
possibile uscirne e anche il tacere, lungi dall’essere un
indifferente mutismo, assume i caratteri del rifiuto di parlare, e
quindi, attraverso questo suo stesso rifiuto, è già un parlare. La
centralità della situazione con cui lo scrivere necessariamente
si trova in rapporto, per Sartre non solo pone in secondo piano
lo stile – in quanto prima del come bisogna sapere su che cosa
scrivere – ma spiega anche i cambiamenti e le evoluzioni
linguistiche come il rinnovamento di una lingua che si trova
sprovvista di mezzi adatti per affrontare nuove situazioni a lei
successive. Viene rimproverato a Sartre che lo scrittore,
anziché trattare argomenti temporali, dovrebbe lanciare al
lettore dei messaggi, ma questi messaggi sbandierati dai
“critici”, sarebbero solo messaggi vuoti, in quanto svuotati dei
contenuti reali che lo scrittore voleva comunicare ai propri
lettori. Ciò che vorrebbero è che, distaccandosi nettamente
dalla realtà, lo scrittore parli di argomenti superati e di idee
talmente vuote e generiche che convincano in partenza il
lettore. Ma secondo Sartre, «il pensiero nasconde l’uomo, ed è
proprio l’uomo che ci interessa»4. La vera e pura letteratura,
allora, altro non sarebbe che una soggettività che si offre sotto
le mentite spoglie dell’oggettività, un discorso disposto
abilmente in modo tale da essere silenzio, un pensiero che
nega se stesso, una Ragione come maschera della follia. «Il
messaggio, in fin dei conti, è un’anima fatta oggetto. Un’anima;
e che cosa si fa d’un’anima? La si contempla a rispettosa
85
distanza»5. La letteratura dunque si esaurirebbe nell’arte
letteraria, cioè in una serie di trattamenti che la renderebbero
inoffensiva. Secondo Sartre, al contrario, ogni scritto è
un’impresa e lo scrittore, prima di essere morto, è vivo nel suo
tempo, e anche qualora l’avvenire dia torto alle sue opere, non
è comunque un buon motivo per darselo da soli in partenza. Lo
scrittore deve impegnarsi nelle proprie opere come volontà
risoluta, come scelta, come impresa totale di vivere.
Soggettivismo della creazione ed esigenza dialettica della
lettura: il ruolo del lettore. Uno dei motivi primari della
creazione artistica è quello per l’uomo di sentirsi essenziale al
mondo, nonostante egli sia completa gratuità, sia di troppo per
l’eternità. Attraverso il linguaggio viene rivelata una parte
dell’essere, e l’uomo è il mezzo attraverso il quale le cose si
manifestano. Egli fa sì che si manifestino, ma non le produce, e
ciò crea quel sentimento di inessenzialità che lo spinge verso
la creazione artistica. Ma ci troviamo comunque divisi tra due
fuochi; certamente sono essenziale all’oggetto che creo, ma
esso mi sfugge in quanto ne sono io il creatore, poiché non si
può svelare e produrre contemporaneamente; la creazione
diventa inessenziale all’attività creatrice. La mia creazione mi
appare comunque incompiuta, in quanto se fosse il contrario, è
come se io la guardassi con gli occhi di un altro, ma, essendo
noi i produttori della nostra opera, non vi ritroviamo che noi
stessi, i risultati raggiunti non ci appaiono oggettivi. «Nella
percezione l’oggetto si dà come essenziale e il soggetto come
inessenziale; quest’ultimo cerca l’essenzialità nella creazione e
la ottiene, ma allora diventa inessenziale l’oggetto»6. L’oggetto
letterario porta in sé un’esigenza dialettica concreta che è la
lettura; l’autore non può leggere ciò che scrive, sapendo già
quello che verrà dopo. La lettura è un’operazione per cui il
lettore trascende sempre ciò che legge in direzione di ipotesi
probabili da lui stesso formulate, e questi probabili crollano o si
86
consolidano man mano che prosegue la lettura, facendo
apparire l’oggetto letterario nelle vesti di un orizzonte mobile.
Lo scrittore contrariamente, non può fare previsioni sulla
propria opera leggendola, ma sa già ciò che incontrerà, cioè la
sua volontà, i suoi progetti, le sue conoscenze, cioè se stesso.
Non si scrive mai per se stessi, in quanto l’opera letteraria ha
bisogno della lettura per venire alla luce come opera, e quindi
scrivere è uno dei due poli dialettici che implica
necessariamente quello della lettura come suo correlativo, e il
risultato di questa operazione dialettica è l’opera letteraria.
«L’arte esiste per gli altri e per mezzo di altri» 7. La lettura pone
l’essenzialità del soggetto e dell’oggetto, il lettore svela
l’oggetto, fa sì che vi sia un oggetto, ma ha coscienza di creare
e svelare a un tempo, in quanto proietta sulle parole una forma
sintetica e dunque il senso non sarà la somma delle parole ma
la loro totalità organica, e l’oggetto letterario, realizzato
mediante il linguaggio, non ha il suo senso nel linguaggio. I
silenzi della lettura conferiscono all’oggetto letterario il suo
senso più proprio, il suo volto particolare, dacché sono il suo
inesprimibile, e lo scrittore guida il lettore attraverso la selva di
questi silenzi. E quindi l’azione della lettura, lungi dall’essere
una pura passività ricettiva, assume la una forma di creazione
vera e propria, in quanto, se da un lato l’oggetto letterario trova
la sua sostanza nella soggettività del lettore, dall’altro ogni
singola parola è una trappola regolata ad arte per suscitare
determinati sentimenti che, a sua volta, il lettore colloca in
un’operazione di trascendenza su di un personaggio
immaginario che vive solo per lui e per mezzo di lui. Poiché la
creazione si completa nella lettura, ogni opera letteraria viene
ad assumere il senso di un appello al lettore, il quale conferisca
un’esistenza obiettiva a quella rivelazione che lo scrittore ha
abbozzato per mezzo del linguaggio, e il termine ultimo di
questo appello è la libertà del lettore, che il libro esige come
suo fine. Dunque, l’immaginazione del lettore non ha solo
87
funzione regolatrice ma anche costitutiva, sempre impegnata in
un’impresa. A differenza di Kant, secondo Sartre la bellezza
della natura non può essere paragonata a quella dell’arte;
secondo il filosofo tedesco l’opera d’arte non ha fini, ma,
Sartre aggiunge, è un fine; infatti Kant sostiene che l’opera
d’arte esisterebbe in un primo tempo di per se stessa e che,
solo in un secondo momento, sarebbe vista. Ma sappiamo
come, sartrianamente, l’opera d’arte diviene tale solo dopo che
l’operazione del fruitore, lettura o visione che sia, sia stata
compiuta, in quanto necessaria affinché l’opera d’arte si
costituisca come tale, essa «non esiste se non la si guarda ed
è, inizialmente, puro appello, pura esigenza di esistere»8, si
presenta, sotto forma di imperativo categorico, come compito
da assolvere per una libertà; l’opera d’arte è un valore in
quanto appello alla libertà. Dialetticamente, da un lato lo
scrittore scrive rivolgendosi alla libertà dei lettori, libertà non
astratta ma che impegni tutto il loro essere, chiedendogli di
conferire esistenza alla sua opera, e dall’altro esige da loro la
stessa fiducia che lui gli ha accordato riconoscendo la sua
libertà creatrice. Incontriamo qui il primo paradosso della
lettura: tanto più avvertiamo la nostra libertà, tanto più
riconosciamo la libertà altrui. Nella lettura non vi è l’insicurezza
della casualità, in quanto il lettore si trova sempre a percorrere
strade che lo scrittore ha già tracciato, la causalità nell’opera
letteraria è pura apparenza, in quanto nella lettura incontriamo
una causalità senza causa, mentre la sua realtà profonda è la
finalità. Nella letteratura, l’oggetto ha le sue radici profonde
nella libertà umana, ed ogni atto di creazione si dirige in
direzione di una riconquista totale del mondo, un recupero
della totalità dell’essere, che poi viene presentata alla libertà
del lettore. È però necessario un atteggiamento di generosità
nel rapporto reciproco tra scrittore e lettore; ciascuno conta
sull’altro, si affida all’altro e dall’altro esige né più né meno di
quanto esige da se stesso.
88
Responsabilità, libertà e engagement tra estetica e morale.
L’oggetto dell’opera letteraria è il mondo focalizzato attraverso
immagini; e questo mondo assume il ruolo di valore, di compito
proposto alla libertà umana. Avviene qui una modificazione
estetica del progetto umano; il mondo appare sempre come
l’orizzonte della nostra situazione, una totalità sintetica del
dato, allo stesso tempo indifferenziata e piena di ostacoli da
superare e strumenti utilizzabili, ma mai come un’esigenza che
si propone alla nostra libertà; qui il mondo è un compito. Nella
letteratura, nella gioia estetica, la coscienza posizionale
immagina il mondo nella sua totalità, allo stesso tempo come
essere e dover essere, interamente nostro e interamente
estraneo simultaneamente, «poiché lo scopo finale dell’arte è
per l’appunto questo: ricuperare questo mondo presentandolo
alla vista così com’è, ma come se la sua fonte fosse la libertà
umana. Ma, poiché ciò che l’autore crea assume la sua realtà
obiettiva solo agli occhi dello spettatore, è la cerimonia dello
spettacolo – e in particolare della lettura – che consacra tale
ricupero»9. Nello svelare il mondo scrivendo, si ricorre alla
generosità del lettore per farsi riconoscere come essenziale al
mondo. Cominciamo a intravedere quel concetto di engagmént
se ora ci poniamo la seguente domanda; se lo scrittore vuole,
creando un’opera letteraria, farsi riconoscere come essenziale
al mondo, egli può volere questa essenzialità anche in
relazione alle ingiustizie che l’universo racchiude? Secondo
Sartre la risposta non può che essere affermativa: lo scrittore si
accetta come creatore di ingiustizie al fine di superarle verso la
loro abolizione, il lettore crea e mantiene il mondo ingiusto
propostogli dallo scrittore per rendersene responsabile, per
compromettersi. Entrambi si assumono la responsabilità
dell’universo che si svela nelle sue ingiustizie che io non devo
affatto contemplare freddamente dall’esterno, ma invece
assumere come ingiustizie-che-vanno-superate. Nel fondo
stesso dell’imperativo estetico si coglie appieno l’imperativo
89
morale, il mondo è presentato sotto una forma immaginaria
quale esigenza della libertà umana, e proprio la libertà è il tema
centrale dello scrittore che, da uomo libero si rivolge ad altri
uomini liberi per impegnarsi insieme a loro con le proprie
libertà. «Scrivere è un certo modo di volere la libertà; una volta
che si è cominciato, per amore o per forza ci si trova
impegnati.»10 Secondo Sartre, non esiste una libertà data, ma
essa trae il suo aspetto dall’ostacolo che ha di fronte e che
deve di volta in volta superare. Lo scrittore è storico, vive ed
incarna la sua epoca, al pari di tutti gli altri uomini, ed egli si
rivolge agli uomini della sua epoca, ed un libro è pienamente
comprensibile solamente dai suoi contemporanei in quanti,
nello scrivere, utilizza il linguaggio come un’ellissi, nel senso
che, condividendo coi suoi lettori le medesime problematiche,
non ha bisogno di una spiegazione analitica, ma si serve di
parole chiave condivise, e svela determinati aspetti
dell’universo. «Scrivere e leggere sono due aspetti di uno
stesso fatto di storia, e la libertà alla quale lo scrittore ci invita
non è solo una coscienza astratta d’essere liberi (...) non è mai
ma si conquista invece in una situazione storica. «Ogni libro
propone una liberazione concreta partendo da una particolare
alienazione»11. E il lettore compie la sua la propria liberazione,
partendo dal fatto che il mondo è alienazione, situazione e
storia; ognuno deve assumere il mondo, mutarlo o conservarlo
per se stesso e per gli altri, in un atto di libertà che, negazione
concreta, conserva ciò che nega e ne è pervasa. Per quanto
riguarda lo scrittore, il mondo è una forza propulsiva che agisce
da dietro, mentre il pubblico incarna un’attesa, un vuoto da
colmare; è l’Altro; lo scrivere assume il carattere specifico di un
libero superamento di una situazione umana determinata e
totale, e lo scrittore è impegnato, quando assume una
coscienza chiara del fatto di essere concerné, e trasferisce per
sé e per gli altri l’impegno dalla spontaneità immediata sul
90
piano della riflessività, lo scrittore è «mediatore per eccellenza,
e questa mediazione costituisce il suo impegno»12.
Lo svelamento della letteratura e il problema del pubblico.
All’origine della scelta di essere scrittore c’è un atto di libertà,
ma una volta intrapreso questo progetto libero, esso comporta
un determinato ruolo sociale. Ma chi è il suo destinatario? A chi
egli si rivolge? Il colui a cui lo scrittore si rivolge non è affatto
l’uomo universale. Come difatti egli non parla, ad esempio, di
una libertà eterna, ma di quella libertà situazionata, storica, allo
stesso modo egli si rivolge all’uomo come gruppo storico dei
suoi lettori, dislocati in contesti sociali e culturali particolari.
Analizziamo ora il concetto di gratuità della letteratura; le opere
sono gratuite, non vi è, economicamente, un rapporto stabilito,
tra l’opera frutto della mente e il compenso pagato. L’attività
dello scrittore non è utile alla società, ma spesso invece le può
crear danno, stimolando una presa di coscienza e quindi una
mobilitazione, dato che i concetti di danno e utilità sono
determinati all’interno dei quadri della stessa società.
Dicevamo che scrivere è svelare; attraverso la letteratura la
società diventa visibile a se stessa e cosciente di essere-vista,
e quindi determina una contestazione di quei valori costituiti e
del regime politico vigente. «Lo scrittore impone alla società
una coscienza inquieta, perché è in eterno antagonismo con le
forze conservatrici, che mantengono l’equilibrio che lui vuole
rompere. Il passaggio al mediato, infatti, che si può compiere
solo negando l’immediato, è una rivoluzione perpetua»13. La
situazione della scrittore, secondo Sartre, è un conflitto
originario fra il suo essere parassita della classe dominante da
un lato, e il suo operare contro i valori di quella stessa classe;
dare un nome significa rivelare, e rivelare è il primo passo
verso il cambiamento. L’aspetto oggettivo e reale del conflitto
può essere espresso dalle due categorie, nel caso di Sartre, di
forze conservatrici, il pubblico reale, borghese, e forze
91
progressiste, il pubblico potenziale, il proletariato, i cui valori lo
scrittore porta avanti senza che questi, ancora, lo riconoscano
come tale. Nella società senza classi lo scrittore sarebbe
mediatore per tutti, e quindi la letteratura sarebbe
completamente liberata dalle opposte tendenze, e
rappresenterebbe la negazione come momento necessario
della costruzione. Inoltre lo scrittore deve operare su di sé un
distacco dalla classe dei suoi lettori reali, per poter farne un
ritratto confutazione, e quindi deve avere coscienza della
contraddizione che intercorre fra sé e il suo pubblico, ed
avvicinarsi ad esso dall’esterno.
Lo scrittore nell’epoca dell’ascesa della borghesia. Nel XVII
secolo non vi era il lettore potenziale, dacché vi è da parte
dello scrittore l’accettazione senza critiche dell’ideologia del
potere, ed esso scrive ciò che il potere vuole leggere, in una
prospettiva in cui senso e valore della letteratura vengono
fissati dalla tradizione. Sartre chiama questi scrittori i classici, e
il classicismo viene ad essere quella forma d’arte fondata sul
mito della sua continuità. Il carattere della letteratura è quello
del riconoscimento, il lettore vuole leggere nei romanzi i suoi
stessi pensieri. Ma che cosa accade quando lo scrittore rifiuta
l’ideologia delle classi dirigenti. Nel XVIII secolo la borghesia
ha iniziato a leggere, proprio nel momento in cui la classe
dirigente tradizionale ha perso fiducia nella propria ideologia, e
rimanendo in un atteggiamento difensivo tenta di impedire il
dilagare delle nuove idee che comunque iniziano già a
permearla, ed una verità pragmatica viene a prendere il posto
della verità rivelata. In questo contesto, qualora lo scrittore
attraverso le sue opere voglia ancora schierarsi dalla parte del
vecchio regime politico, quanto meno compie una scelta
volontaria. La borghesia è qui una classe che se da un lato
subisce un’oppressione politica, dall’altro possiede mezzi
economici, denaro, cultura; essa viene ad essere il primo
92
abbozzo di un pubblico di massa, e lo scrittore gioca il ruolo di
arbitro tra le due fazioni, in quanto egli non è più il parassita
della sola classe dirigente ma viene sovvenzionato da
entrambe. Una classe non può avere coscienza di sé fin
quando non si possa vedere sia dal di dentro che dal di fuori, e
questo ruolo è affidato allo scrittore, l’eterno declassato, che
trae orgoglio dal pensare se stesso come sciolto dalle classi e
che al contempo però, mantiene con esse un certo rapporto,
per poterle guardare anche dall’interno. La letteratura prende
coscienza della propria autonomia e libera lo scrittore e se
stessa, identificandosi con lo spirito, cioè potere permanente di
formulare idee e critiche, e a sua volta lo scrittore, «prendendo
la penna in mano, si scopre come coscienza senza luogo e
senza data, come uomo universale (...) la letteratura che lo
libera, è una funzione astratta e un potere a priori della natura
umana: è il movimento che permette all’uomo, minuto per
minuto, di liberarsi della storia: è cioè, l’esercizio della
libertà»14. Lo scrittore del XVIII secolo esercita contro la storia
una ragione antistorica ponendo in luce le esigenze di una
letteratura astratto, ed in quanto diventato universale si rivolge
ad un pubblico universale, reclama che i suoi contemporanei
spezzino i loro legami storici per seguirlo nell’universalità. La
libertà d’opinione è la prima tappa che la classe della
borghesia si propone per raggiungere quel potere politico che
ancora non detiene, e per farlo ha bisogno di essere illuminata;
reclamando la libertà d’opinione per sé e per gli altri, lo scrittore
necessariamente serve gli interessi della borghesia. L’appello
che lo scrittore rivolge attraverso le sue opere è duplice: da un
lato chiama la borghesia alla rivolta, dall’altro intima alla nobiltà
l’abbandono dei suoi privilegi, e allo stesso tempo prende
coscienza della gratuità e della libertà assoluta che
caratterizzano lo creazione letteraria. La sua posizione è quella
per eccellenza della critica, la quale viene rivolta contro le
istituzioni, le tradizioni e le suopersitizioni. Lo scrittore scopre la
93
dimensione temporale del Presente al quale conferisce un
senso appassionato che lo distacca nettamente da posizioni
idealistiche che concepiscono Libertà ed Eguaglianza come
concetti astratti, come idee eterne, e le cala invece nella
quotidianità della vita pubblica prendendone parte. Ma
inversamente, perseguendo, anche indirettamente gli interessi
della borghesia, sotto forma di libertà d’opinione ed
uguaglianza di diritti, la difesa della letteratura diventa
puramente formale, poiché, nel momento in cui la borghesia
prenderà il potere, essa diverrà la prigione della letteratura, in
quanto non vi sarà più una distinzione tra lettore potenziale e
reale, dacché proprio il lettore potenziale reintegra in sé quello
reale, e in secondo luogo perché, classe produttrice per
eccellenza, non considererà la letteratura come gratuità ma
come servizio da retribuire, ovvero perseguendo un utilitarismo
dell’opera d’arte, che porterà la letteratura ad abbandonare la
sua posizione di critica e svelamento per rendersi utile a sua
volta. «L’arte borghese sarà mezzo o non sarà; si vieterà di
toccare i princîpi per timore che crollino e di sondare troppo a
fondo il cuore umano per paura di trovarvi disordine»15.
Temendo la genialità come rivelatrici di zone d’ombra, oscure,
da tenere nascoste per non minare l’ordine costituito, la
borghesia preferirà la facilità, ovvero il genio incatenato e
ammansito all’interno del recinto della tranquillità. L’ottimismo,
tipico della borghesia, è agli antipodi della concezione dell’arte
secondo lo scrittore; egli vuole svelare l’essere in quanto tale,
con le sue luci e le sue ombre, nell’indefinita spontaneità
dell’esistenza. L’opera d’arte sarà dunque irriducibile all’idea, e
il concetto del Male verrà ad assumere le forme
dell’irriducibilità del mondo e dell’uomo al pensiero. Il principio
utilitaristico della borghesia ridurrà tutto a parte del
meccanismo sociale, permeato di quell’utilità, e quindi non
potrà riconoscere le istanze del proletariato, in quanto non solo
non riconosce ma fugge la libertà dell’uomo. Utilitaristica ed
94
antilibertaria, l’ideologia borghese è antitetica ai principi che
fondano la letteratura, ma questa ancora non trova legami con
il proletariato, che come classe oppressa potrebbe accogliere
gli scrittori, mantenendo allo stesso tempo le loro istanze. Ma
la letteratura era rivoluzionaria solo aglio occhi della borghesia,
in quanto le libertà formali che essa propugna non hanno nulla
a che vedere con le esigenze rivendicate dal proletariato.
L’intellettuale e il potere nel XIX secolo. Nel XIX secolo la
letteratura, appena svincolatasi dall’ideologia religiosa, non
vuole affatto asservirsi a quella borghese; ma essa stessa è
ideologia, e si affanna continuamente ad affermare quella tanto
agognata quanto sterile autonomia che nessuno le contesta. I
soli che sembrano avere intuito l’esistenza di un rapporto
intimo tra le rivendicazioni della letteratura e quelle delle classi
oppresse sembrano essere Marx e Prodhon, ma essi non sono
affatto dei letterati. In nome di una forzata liberazione la
letteratura diviene oggetto di se stessa, riflette e mette alla
prova i suoi metodi; non volendo piegarsi ad un pubblico
determinato, e alle sue esigenza, non prende in considerazione
il fatto di avere dei contenuti, altrimenti dovrebbe alienarsi da
se stessa per stabilire canoni e parametri in base a quei
contenuti. Ma, vediamo anche come, nella sua pretesa e
presuntuosa autonomia, la letteratura prende tacitamente una
scelta fondamentale; in quanto le classi oppresse, che vogliono
prendere il potere, non hanno né cultura né tempo per
formarsela, essa opera in favore del conservatorismo sociale, e
quindi effettua un ritorno in seno a quel pubblico borghese che
essa sbandierava di aver abbandonato. Questo abbandono è
meramente simbolico e lo scrittore si trova in malafede, sa e
insieme non vuol sapere per chi scrive, la sua solitudine è una
pura finzione in quanto lo scrittore borghese e lo scrittore
maledetto si muovono sullo stesso campo. Viene così a
ricrearsi una conventicola di artisti e più lo scrittore si allontana,
95
nello scrivere, dalla vita e più l’arte si riveste delle vestigia delle
sacralità. Lo scrittore che in malafede prova a distaccarsi dalla
sua classe reintegra il modello di una società simbolica di
stampo aristocratico e passatista, in cui lo scrittore è parassita
dei potenti e martire del consumo puro, e nella quale vige il
canone dell’arte per l’arte, nel sogno di raggiungere, nello
scrivere o nel leggere, lo status di soggetto assoluto e
trasformarsi in puro sguardo; l’immaginazione viene ad
assumere i caratteri di una illimitata negazione del reale e il
suo oggetto viene edificato solo sulle macerie che seguono il
crollo dell’universo. «Il limite estremo di questa letteratura
brillante e nefasta è il nulla, limite estremo ed essenza
profonda, perché il nuovo spirituale non ha nulla di positivo: è
negazione pura e semplice del temporale»16. Così facendo lo
scrittore vuole stabilire la propria irresponsabilità, in quanto se
egli mirasse ad edificare qualcosa sarebbe suscettibile di una
resa dei conti, ma in quanto egli afferma se stesso e la sua
opera come distruzione pura sfugge a qualsiasi giudizio. Sul
finire dell’800 tutto ciò è ancora confuso, ma quando col
surrealismo la letteratura istigherà all’assassinio, il circolo si
chiude e lo scrittore pone esplicitamente il principio della sua
assoluta irresponsabilità, si adopererà per provocare lo
scandalo e per sfuggirne le conseguenze. Quest’opera così
concepita, necessita della borghesia come implicito
committente ed unico lettore, in quanto le tematiche che tratta
sono troppo distanti da quel proletariato che rappresenta la
reale minaccia all’ordine costituito; dunque la figura dello
scrittore, lungi dall’essere rivoluzionaria, incarna invece la
figura del ribelle, in quanto agli occhi della classe dominante la
sua opera è innocua, un semplice gioco, un divertimento. La
letteratura è quindi diventata una negazione astratta, che si
nutre solo di se stessa e, da parte della borghesia, il capriccio
ribelle dello scrittore che si cerca come soggetto assoluto,
viene disinnescato della sua pericolosità sotto l’etichetta n’est
96
pas qui littérature. Il romanziere del XIX secolo riduce il diverso
all’identico, poiché la borghesia teme più di qualsiasi altra cosa
il cambiamento e propugna invece una difesa spasmodica
dell’ordine e dell’abitudine; il cambiamento altro non è che un
non-essere, e qualora esistesse, sarebbe tradotto come il
turbamento individuale di un’anima disadattata; «non si tratta di
studiare in un sistema in movimento – la società, l’universo – i
movimenti relativi di sistemi parziali, ma di considerare dal
punto di vista della quiete assoluta il movimento assoluto di un
sistema parziale relativamente isolato»17. Se in una società
ordinata che si crede e si vuole eterna, nella quale questa
eternità si celebra attraverso dei riti collettivi, si evoca un
fantasma di un disordine, nel momento in cui esso si fa
inquietante, lo si fa sparire magicamente, reintegrandolo nella
malformazione del singolo individuo, e lo si sostituisce con la
gerarchia eterna delle cause e delle leggi. In questo periodo,
nella letteratura vi è sempre il narratore interno, ma la storia è
proposta non dalla soggettività storica individuale di uno
scrittore, ma attraverso la figura dell’uomo di esperienza che è
ideale ed universale, un po’ come il vecchio capofamiglia che
davanti al focolare domestico racconta a generazioni di figli e di
nipoti, innocui e momentanei peccati di gioventù, conditi dal
sorriso affabile dell’ipocrisia. Non a caso, infatti, il tempo del
racconto è il passato, che è necessario proprio a creare quel
distacco tra il pubblico e gli avvenimenti, e l’aneddoto è narrato
dal punto di vista dell’assoluto, cioè dell’ordine, come
mutamento locale di un sistema in riposo. Non v’è spazio per la
sorpresa e l’imprevisto, il fatto è avvenuto nel lontano passato
e ormai catalogato. In una società borghese che crede di
trovarsi al di là della storicità e secondo la quale non vi saranno
più avvenimenti rilevanti, non è concepibile altra forma di
romanzo; e l’altra letteratura, quella cosiddetta maledetta,
nonostante la sua posizione di rivolta, rispecchia nelle sue
strutture profonde e nello stile le classi dirigenti. Se lo scrittore
97
avesse dato il suo appoggio al proletariato avrebbe affermato
quella che è l’essenza dello scrivere, la coincidenza tra la
libertà formale del pensiero e libertà politica concreta; e anche
lo stile avrebbe trovato una sua propria tensione interiore in
quanto sarebbe stato rivolto ad un pubblico diviso: da un lato
avrebbe cercato di risvegliare le classi oppresse e dall’altro
avrebbe posto le classi dominanti davanti alle ingiustizie ai
privilegi che quotidianamente perpetrano e difendono. Avrebbe
parlato al mondo intero, ed avrebbe contribuito a fare del
marxismo un pensiero ed un movimento rivoluzionario molto
più sfaccettato ed aperto. Calando però nello specifico un
discorso che appare astratto, notiamo come non sia possibile
scrivere senza un pubblico, formato dalle circostanze storiche,
e senza un mito della letteratura, che dipende dalle richieste e
dalle esigenze del pubblico. L’autore, lo scrittore, è un uomo in
situazione, al pari di tutti gli altri uomini, e i suoi scritti, come
qualsiasi atto umano, racchiudono, precisano e superano la
situazione presente. La libertà è per natura situata, e
descrivere la situazione, operando su di essa, non è affatto un
attentato alla libertà.
Conclusioni. Situando in diverse epoche la libertà dello
scrittore, Sartre ne ha descritto i rapporti con la società nella
quale, in un modo o nell’altro, veniva a trovarsi ed agire
attraverso lo scrivere; «se è vero che l’essenza dell’opera
letteraria è la libertà che si scopre e vuole essere un appello
alla libertà degli altri uomini, è anche vero che le diverse forme
dell’oppressione, impedendo agli uomini di accorgersi che
erano liberi, hanno dissimulato questa essenza, tutta o in parte,
agli autori»18. La letteratura di una certa epoca è alienata
quando non ha ancora raggiunto la coscienza della propria
autonomia, e dunque si sottomette al potere temporale o a una
ideologia. La letteratura è astratta quando non vede in modo
completo la sua essenza, quando si limita a porre la sua
98
propria autonomia solo sul piano formale, ma rimane
indifferente alla scelta dell’argomento. Tra la fine del XIX
secolo e l’inizio del XX, la letteratura si fa negazione assoluta,
rompe i legami con la società e si ritrova senza un pubblico,
preferendo il disordine della poesia alle composizioni in prosa,
realizzando ciò che Sartre chiama terrorismo o autodistruzione
della letteratura. Superato il terrorismo, Sartre vuole fissare i
caratteri di una letteratura concreta e libera. Lo scopo e l’idea
regolatrice dello scrittore non sono più assumibili nella gloria,
ma al contrario nella totalità degli uomini viventi in una
determinata società; in una società senza classi non c’è
differenza tra i temi e il pubblico, che diverrebbero, insieme,
l’uomo-nel-mondo. E se il pubblico si identificasse con
l’universale concreto, lo scrittore potrebbe davvero scrivere per
la totalità degli uomini. Non andrebbe adorato lo Spirito, ma
invece bisognerebbe recuperare il mondo nella sua opacità e
varietà, e il Male invincibile che da sempre lo corrode senza
mai riuscire a distruggerlo. Il tratteggio di una simile
concezione di letteratura è già un invito al cambiamento,
all’interno di un universo non più considerato nelle sue
possibilità di consumo, ma come le speranze di coloro che lo
abitano. La letteratura concreta sarà dunque una sintesi tra
Negazione, come sottrarsi al potere del dato, e Progetto, come
intenzione di abbozzare un ordine futuro. Ma perché tali aspetti
possano essere tra loro complementari, non solo lo scrittore
ma anche il lettore devono avere la completa libertà di dire
tutto, e ciò non si traduce solo con un progetto di abolizione
delle classi, ma anche e soprattutto nell’abolizione di qualsiasi
dittatura, del rinnovamento continuo delle strutture e del
rovesciamento senza sosta dell’ordine al fine di evitare una sua
fissazione. «la letteratura è, per essenza, la soggettività di una
società in rivoluzione permanente.»19
99
1
J.P. Sartre, Que est-ce que la littérature, Librarie Gallimard, Paris,
1947, tr. It. Luisa Arano-Cogliati...[et al], Milano, Il Saggiatore, 1995,
p. 16
2
Op. cit. p. 23
3
Op. cit. p. 23
4
Op. cit. p. 29
5
Op. cit. p. 30
6
Op. cit. p. 33
7
Op. cit. p. 35
8
Op. cit. p. 38
9
Op. cit. p. 45
10
Op.cit. p. 50
11
Op.cit. p. 53
12
Op. cit. p. 57
13
Op. cit. p. 61
14
Op. cit. p. 77
15
Op. cit. p. 83
16
Op. cit. p. 95
17
Op. cit. p. 102
18
Op. cit. p. 109
19
Op. cit. p. 114
100
La scrittrice francese Fred Vargas pubblicò il romanzo Parti in
fretta e non tornare1 nel 2001, quando aveva quarantaquattro
anni ed aveva prodotto altre opere di narrativa. E’ un romanzo
giallo, del gruppo che ha come protagonista il commissario
Adamsberg e che ha contribuito più delle altre narrazioni a far
conoscere la scrittrice, a renderla nota anche all’estero.
Fred Vargas ha cinquantasette anni, vive a Parigi dove è nata
nel 1957, è ricercatrice di archeozoologia presso il Centro
nazionale francese per le ricerche scientifiche (CNRS), è
studiosa del Medioevo, per molto tempo ha indagato sui modi
con i quali la peste si trasmette dagli animali all’uomo, ha
scritto opere scientifiche, saggi, romanzi, racconti e da alcune
sue narrazioni sono stati tratti film per la televisione.
Soprattutto i romanzi gialli l’hanno resa nota perché diversi
sono rispetto alla maniera tradizionale. In essi la scrittrice
tende a far rientrare nella quotidianità della vita , nello scorrere
dei giorni anche i misfatti, i crimini sui quali indaga la sua
polizia. Di tali misfatti cerca la spiegazione nelle zone più
remote dell’anima, dello spirito di chi li commette ed una volta
trovata la loro gravità si riduce perché risulta motivata. I “casi”
da lei presentati diventano misteri inestricabili, molto tempo,
molte operazioni richiedono per essere risolti e quando lo sono
non stupiscono più perché quel tempo, quelle operazioni hanno
procurato loro una ragione, sono serviti a farli rientrare tra le
altre manifestazioni, gli altri elementi, aspetti dell’esistere.
Dentro i crimini entra la Vargas col suo commissario e tanto
chiare sono le rivelazioni finali alle quali questi giunge, tanto è
Recensioni
L’ALTRO DELLA VITA
di Antonio Stanca
101
servito per ottenerle che essi finiscono col poter stare accanto
ad ogni altra cosa.
Così avviene pure in Parti in fretta e non tornare dove il
commissario Adamsberg, come altre volte, si trova in una
situazione intricata, confusa, si dibatte tra molte supposizioni
prima di giungere a quell’intuizione finale che ha in ogni
romanzo, che avviene sempre durante una delle sue
passeggiate solitarie e che gli serve per risolvere il caso. Come
altre volte egli si è mostrato in modi diversi da quelli richiesti
dalla forma, dall’ufficio perché semplici, naturali, spontanei.
L’indagine che conduce in questo romanzo è tesa a capire la
morte che sta avvenendo, a Parigi e dintorni, di alcune persone
perché strangolate. Esse muoiono uccise e intanto il misterioso
colpevole vuol far credere che muoiano a causa della peste,
del contagio trasmesso loro dalle pulci di topo che si trovano
sempre sul luogo del delitto e che sono portatrici d’infezione. Di
tale contagio, di tale infezione ci sono continui annunci da parte
di un banditore che li trova sistematicamente nella cassetta
postale insieme ad altri che tante persone vi mettono perché li
legga pubblicamente. Così avviene in una determinata zona di
Parigi e la maggior parte degli annunci letti dice della rovina,
della morte che stanno per verificarsi e che riguarderanno
l’intera umanità. Essi si richiamano alle più antiche epidemie di
peste, con queste collegano le morti recenti e la distruzione
che verrà. «Il signor Le Guern fa il banditore, professione
tramandatagli dal suo trisavolo. Declama le notizie del
quartiere all’incrocio Edgar Quinet-Delambre. […] Ogni giorno,
e al momento due o tre volte al giorno, il signor Le Guern trova
questi brevi scritti che annunciano la peste. E ogni nuovo
annuncio ci avvicina al momento in cui scoppierà».2 Intanto la
polizia continua a scoprire persone che muoiono per
strangolamento. Un vero e proprio mistero per Adamsberg che
indaga aiutato da tanti collaboratoti e che non crede di
potercela fare. Un lunga, lunghissima azione diventa la sua
102
durante la quale è visto pure nella vita privata, nei rapporti con
la sua donna, nei luoghi frequentati, nelle abitudini, nei modi di
vestire, mangiare, camminare, guardare, in tutto quanto è suo.
Un uomo completo ha voluto creare con lui la Vargas, un uomo
vero che si muove in ambienti veri, tra strade, piazze, case,
persone, volti,discorsi, momenti della vita di ogni giorno, e lo ha
messo alla ricerca di altre verità, di altre vicende che
avvengono all’insaputa di tutti e che, pur se malvagie, hanno
una loro spiegazione.
Così si propone di fare la scrittrice, vuole mostrare per mezzo
del suo Adamsberg, delle sue indagini, quanta vita avviene
lontano da quella conosciuta, come essa meriti di essere
compresa, accettata.
Anche in questo romanzo sarà l’improvvisa illuminazione
finale ad orientare definitivamente il commissario, a fargli
scoprire come dietro una situazione così complicata, dietro un
mistero divenuto sempre più fitto si celi la triste storia di una
famiglia, di un padre crudele, di una madre isolata, di un figlio
diverso dagli altri due, di amori, odi, rancori che si sono formati,
di violenza subita, di vendetta cercata.
Giungerà Adamsberg a sapere che qualcuno crede di
uccidere diffondendo una peste che non esiste e che un altro
uccide veramente strangolando, che due sono i responsabili
della confusione che si è creata, giungerà a conoscere quanto
di complicato, di tortuoso può verificarsi nell’animo dell’uomo,
come in esso ci sia la spiegazione di ogni azione compresa
quella criminale. Nessuno dei due responsabili aveva mai
pensato di poter giungere a tanto e, tuttavia, niente aveva
potuto evitarlo giacché la loro vita, le loro esperienze avevano
fatto rientrare tra le loro cose anche il male. Questa era la
tragica verità che andava riconosciuta. Sempre così sarà con
l’Adamsberg della Vargas, sempre altro gli farà scoprire la
scrittrice, sempre disposta sarà a capire, comprendere, far
rientrare quell’altro nella vita, sempre chiara la sua intenzione
103
di trarne un messaggio, di scrivere per ottenerlo e diffonderlo.
E sempre riuscirà, sempre questo sarà lo scopo delle situazioni
complicate, delle ampie costruzioni che ogni romanzo contiene.
Non solo la scrittrice ma anche la studiosa, l’erudita emergono
dalle narrazioni dal momento che a distinguerle concorrono
l’ampiezza dei contenuti, la sicurezza nell’espressione e la
ricerca di una finalità diversa dalla realtà rappresentata.
1
In Italia il romanzo è stato pubblicato nel 2004 e più volte ristampato
dalla casa editrice Einaudi di Torino. La più recente ristampa risale al
2012 ed è comparsa nella serie Super ET con traduzione dal
francese di Maurizia Balmelli e Margherita Botto (pp. 359).
2
Ivi, p. 104.
104
Pubblicazioni ricevute
AA. VV., Frammenti di cultura del Novecento, a c. di I. Pozzoni,
Gilgamesh, Asola 2013, pp. 374
AA. VV., L’esistenza come viaggio. Il cinema come viaggio, a c.
di G. Invitto, Amaltea, Melpignano 2013, pp. 152
F. BIRULES Y ROSA RIUS GATELL, eds., Lectoras de Simone
Weil, Icaria, Barcelona 2013, pp. 222
M. R. BOZZETTI, Tu, l’altra carne, poesie, Milella, Lecce 2012,
pp. 120
H. CAVALLERA, Max Horkheimer e Theodor W. Adorno.
Tenebre e dialettica, Pensa, Lecce 2013, pp. 246
G. COGLITORE, Sulle emozioni. Filosofia e Neuroscienze,
Pellegrini, Cosenza 2012, p. 270
L. DE BERNART, Antico Manoscritto, Fondazione “MarioLuzi”,
Roma 2012, pp. 218
F. DE NATALE, La presenza del passato. Un dibattito tra filosofi
italiani dal 1946 al 1985, Guida, Napoli 2012, pp. 164
P. DI NUNNO, Riflettere Bergson. La filosofia come
rovesciamento, Trauben, Torino 2012, pp. 338
A. INVITTO, Roccia, Libro aperto ed., Marino 2013, pp. 54
G. INVITTO, Lanx satura. Asterischi filosofici su soggetti temi ed
eventi dell’esistenza, Mimesis, Milano-Udine 2013, pp. 316
S. LO GIUDICE, Breve documento sulla “Nuova Filosofia”, n. e.,
Pellegrini, Cosenza 2012, pp. 118
MAINE DE BIRAN, Difesa della Filosofia, a c. di S. Cavaciuti, Il
Ramo, Rapallo 2013, pp. 172
F. PASCA, L’a-Thea (Uomo) di Nazareth, Il raggio verde, Lecce
20121, pp. 126
P. RICCI SINDONI, Viaggi intorno al Nome. Percorsi e figure
dell’ebraismo contemporaneo, Le Lettere, Firenze 2012, pp.
254
L. ROMANO, Diario Elementare, Fernandel, Ravenna 2012, pp.
105
182
I. TAVILLA, Senso tipico e profezia in Sǿren Kierkegaard. Verso
una definizione del fondamento biblico della categoria di
gjentagelse, Mimesis, Milano-Udine 2012, pp. 160
A. ZORETTI, Carmelo Bene il fenomeno e la voce, Lupo,
Copertino 2012, pp. 224
Periodici
Annuario Filosofico, n. 27, 2011; Mursia, Milano
Chiasmi International, n. s., n. 14, Vrin, Mimesis, Penn State
University;
Foedus, n. 33 e n. 34, 2012; Associazione Artigiani e Piccole
Imprese, Mestre
Idee, n. s., a. II, n. 4, 2012; Milella, Lecce;
L’immaginazione, n. 273, 2013; Manni, San Cesario di Lecce;
Itinerari. Quaderni di studi di etica e di politica, n. 3, 2012, a. LI;
Ed. Itinerari, Lanciano;
Plat. Quaderni di Pratiche linguistiche e analisi dei testi, n.
1/2012, Tempo, corpo, scrittura, Pensa multimedia, Lecce
Ricercazione, v. 4, n. 2, 2012¸ Erickson, Trento
106