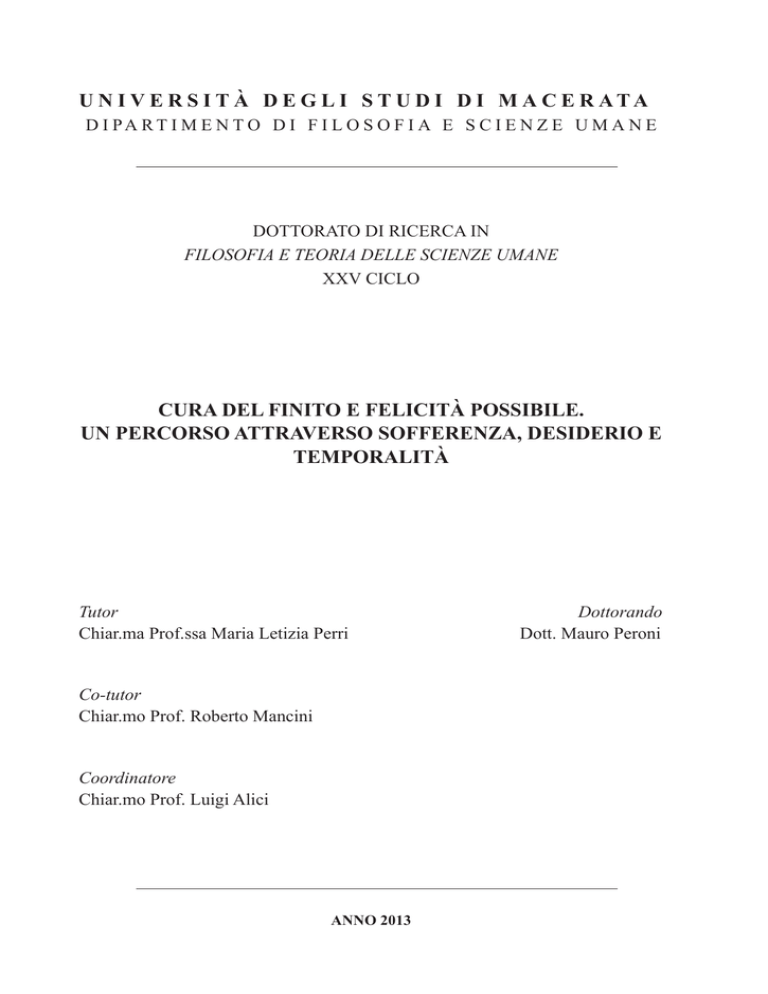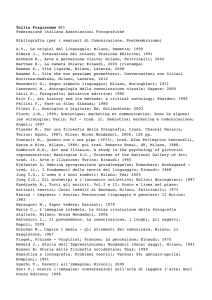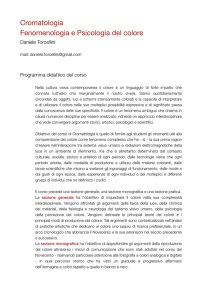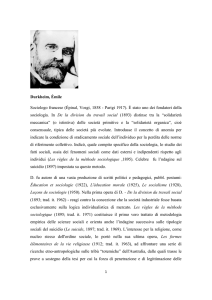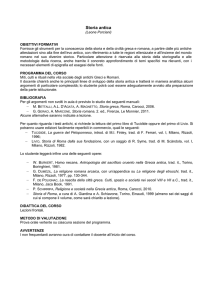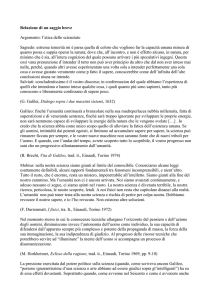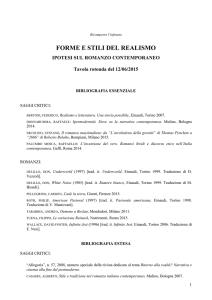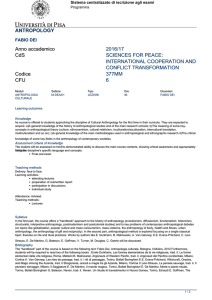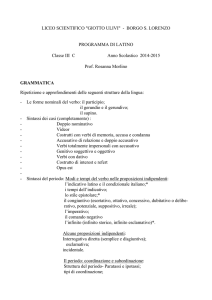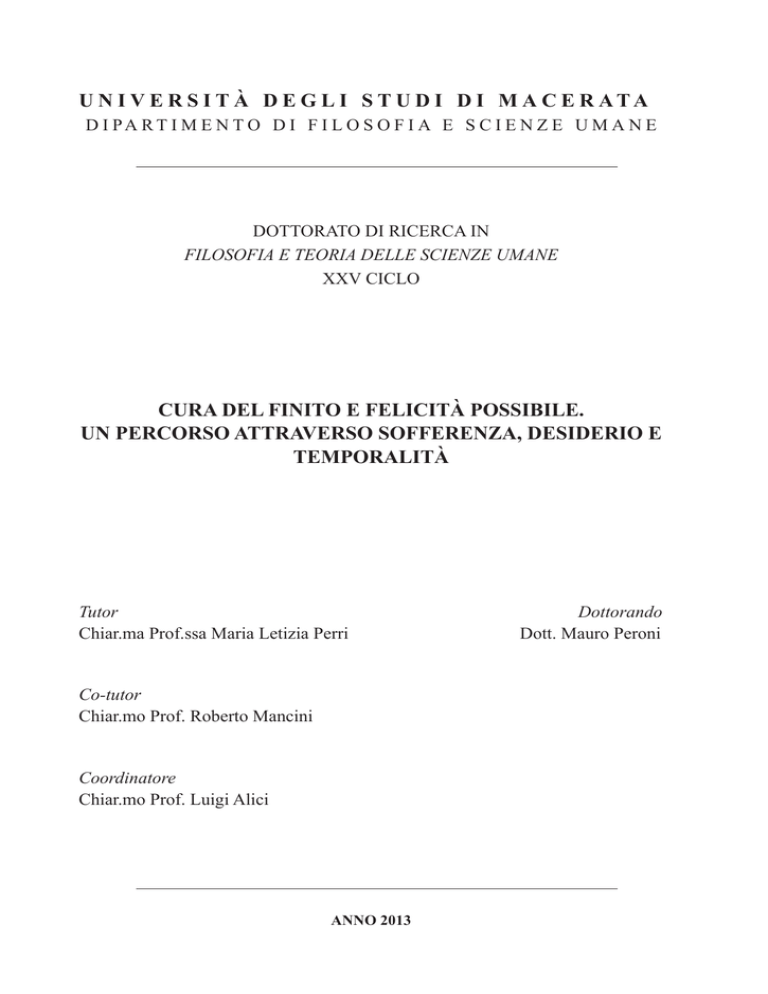
U N I V E R S I T À D E G L I S T U D I D I M A C E R ATA
D I PA RT I M E N T O D I F I L O S O F I A E S C I E N Z E U M A N E
_______________________
__________________________
DOTTORATO DI RICERCA IN
FILOSOFIA E TEORIA DELLE SCIENZE UMANE
XXV CICLO
CURA DEL FINITO E FELICITÀ POSSIBILE.
UN PERCORSO ATTRAVERSO SOFFERENZA, DESIDERIO E
TEMPORALITÀ
Tutor
Chiar.ma Prof.ssa Maria Letizia Perri
Dottorando
Dott. Mauro Peroni
Co-tutor
Chiar.mo Prof. Roberto Mancini
Coordinatore
Chiar.mo Prof. Luigi Alici
__________________________________________________
ANNO 2013
Indice
Premessa ......................................................................................................... 3
I. Depressione e ricominciamento ........................................................................... 7
1. La grande stanchezza ................................................................................ 7
2. Una felicità disabitata .............................................................................. 12
3. La forza del soffrire .................................................................................. 17
4. Corpi impazienti ....................................................................................... 22
5. Continuare a nascere ................................................................................ 26
6. Cenni conclusivi ....................................................................................... 32
II. Misure del desiderio ............................................................................................. 36
1. Motivi per essere ...................................................................................... 36
43
3. Desiderio senza mondo ........................................................................... 50
4. Attenzione e pudore: passioni della prossimità ....................................... 55
III. Ritmi della felicità ................................................................................. 64
1. Le rovine e le tracce ................................................................................. 64
2. Euritmia .................................................................................................... 72
3. Stagioni dell’identità ................................................................................ 75
4. Le opere dei giorni .................................................................................... 81
Congedo ........................................................................................................ 88
91
91
102
2
Premessa
Di tutto ciò che si osserva,
che cosa può far coraggio se non l'osservazione stessa?
Elias Canetti, La provincia dell'uomo
Il presente percorso di indagine mira a collocarsi sulla lunghezza d'onda di quelle che vengono
chiamate “pratiche filosofiche”. Rinviando altrove per un approfondimento sull'argomento1, qui è
sufficiente dire che esse consistono in modalità di declinazione del filosofare che si prefiggono di
integrare, senza volerle sostituire, le tradizionali forme accademiche dell'insegnamento e della
produzione scientifica indirizzata ad un circuito di fruizione prettamente specialistico. A segnare la
distanza fra i due orizzonti è soprattutto il fatto che le pratiche filosofiche intendono farsi carico
delle richieste di senso che circolano diffusamente nell'attuale orizzonte sociale; più esattamente,
esse provano a fornire possibili risposte a tali richieste: risposte che non esauriscano le domande di
senso ma che le rendano sostenibili. Ciò significa che, mentre la filosofia nella sua configurazione
tradizionale tende a limitarsi a studiare il fenomeno contemporaneo della dolorosa mancanza di
senso del vivere che molte esistenze sperimentano, le pratiche filosofiche tentano di fornire, ad
un'utenza la più vasta possibile, strumenti per ridurre questo spaesamento o almeno limitarne gli
effetti più nocivi. Va evidenziato che esse non costituiscono esercizi di “applicazione” della
disciplina filosofica (così come, ad esempio, si danno forme di etica applicata all'economia e alla
scienza), ma muovono in direzione della promozione di un modo di essere filosofico: laddove con
questa espressione si intende – con chiaro riferimento al tema della “saggezza” tipico del filosofare
greco-ellenistico – anche un modo di vivere caratterizzato dalla capacità di mettere in discussione se
stessi (le proprie idee, i proprio criteri di giudizio, la propria maniera di compiere scelte e di
1
Cfr. R. Màdera, L. V. Tarca, La filosofia come stile di vita. Introduzione alle pratiche filosofiche, Bruno Mondadori,
Milano, 2003; N. Pollastri, Il pensiero e la vita. Guida alla consulenza e alle pratiche filosofiche, Apogeo, Milano,
2004; C. Brentari, R. Màdera, S. Natoli, L. V. Tarca, Pratiche filosofiche e cura di sé, Bruno Mondadori, Milano,
2006.
1
3
relazionarsi agli altri, ecc.), al fine di conseguire un'esistenza ricca di significato e valore e
realmente appagante.
Tali pratiche assumono configurazioni differenti, tra le quali vanno senz'altro segnalate le
modalità della consulenza rivolta a singoli o a gruppi e la promozione della metodologia dialogicorelazionale all'interno di contesti organizzativi ad alto tasso di complessità gestionale (ad esempio
aziende ed ospedali)2. In tempi recenti esse hanno iniziato a “retroagire” nella realtà accademica,
per cui in alcuni dipartimenti universitari sono stati attivati corsi specifici di pratiche filosofiche. È
quindi in forza di questo feedback, a mio avviso prezioso, che si origina la ricerca che qui presento.
Una ricerca in cui l'approccio filosofico essenziale viene affidato non solo ma anche al gesto del
curare.
Senza dubbio il tema della cura conosce da tempo una vasta diffusione nell'ambito degli studi
filosofici, dove viene svolto in una molteplicità di direzioni di indagine che, a seconda dei casi, si
rifanno in maniera più o meno esplicita ai due luoghi teorico-concettuali da cui esso proviene:
l'epimeleia del pensiero socratico e l'heideggeriana Sorge. Ma si tratta, appunto, del tema della cura:
nel senso che in queste numerose trattazioni la cura rappresenta l'oggetto dei discorsi filosofici, i
quali di volta in volta domandano, per esempio, quale sia il significato da attribuire a tale concetto,
quali siano le pratiche soggettive e collettive che possono essere legittimamente sussunte sotto di
esso, quale sia il suo possibile impiego in sede epistemologica, e così via. Il mio studio si
caratterizza, invece , per un taglio differente, poiché prova a fare della cura lo stile del suo discorso;
esso, cioè, presenta un filosofare che non si occupa di discutere delle pratiche di cura, ma ha
l'ambizione di costituire esso stesso una pratica di cura: nello specifico, una pratica volta a favorire
il dispiegamento delle condizioni di possibilità di una vita felice.
Questa intenzione si concretizza anzitutto nella scelta preliminare di distanziarsi dall'approccio
diffuso che tratta la questione della felicità come se fosse una domanda specifica della filosofia,
mentre invece essa è una domanda dell'umano – domanda che può essere avvicinata in modo
filosofico ma anche a partire da altre prospettive di ricerca, ad esempio quella psicologica. Facendo
della questione della felicità una faccenda di “proprietà” della filosofia non di rado si finisce con
2
Sarebbe incongruo tacere il fatto che in taluni casi queste modalità rischiano di ridursi ad un innocuo discorso di buon
senso, per così dire, adatto a tutti i palati. A mio parere si tratta però di eccezioni all'interno di un fenomeno che nella
sua interezza costituisce una valida alternativa alle sedicenti forme di sostegno e sviluppo personale che popolano il
“mercato dell'equilibrio interiore”. Per uno sguardo meno bendisposto del mio rimando comunque al pamphlet di
Alessandro Dal Lago Il business del pensiero. La consulenza filosofica tra cura di sé e terapia degli altri,
Manifestolibri, Roma, 2007.
2
4
l'indagarla limitandosi a discutere, commentare e confrontare le teorie sulla felicità che la storia del
pensiero filosofico ha ampiamente prodotto, smarrendo così il contatto con i mondi di vita
storicamente determinati da cui essa continua a scaturire sotto forma, appunto, di domanda di
felicità3. Pertanto, lo stile curante del lavoro si esprime in primo luogo nel prendersi cura della
domanda di felicità che proviene dal nostro presente e, quindi, nel non impiegare il concetto di
felicità come fosse un universale di senso impermeabile al divenire storico.
In secondo luogo, l'assunzione di questo stile ha condotto a non limitarsi a stilare il resoconto
delle sciagure del nostro tempo (che pure sono numerose), ma a coniugare la lettura critica dell'oggi
con uno sforzo teoretico mirante ad indicare buone pratiche di vita nel presente, ovvero modi di
essere che possano rivelarsi capaci di far fiorire l'esistenza anche in un frangente storico che, sotto
diversi profili, risulta disumano.
In tal senso, il discorso che segue procede lungo una traiettoria che si distanzia da quelle che mi
paiono essere le due prospettive prevalentemente percorse dall'attuale riflessione filosofica intorno
alla felicità: da un lato, le indagini che si interrogano sulla plausibilità di un'articolazione interna tra
vita felice e vita giusta, distinguendo più o meno nettamente l'aspirazione alla felicità dall'esercizio
del dovere; dall'altro, gli studi che si propongono di individuare quali siano le istituzioni e le
procedure politico-giuridiche capaci di garantire le condizioni sociali dell'esercizio del “diritto alla
felicitàˮ. Discostandomi da tali linee di sviluppo – senza tuttavia voler indicare una “terza viaˮ che
le escluda pregiudizialmente – in questo lavoro indago le condizioni esistenziali, oggi, di una
felicità possibile. Come si vedrà, questa indagine ha la natura di un'analisi di carattere eticoantropologico rivolta a tre nuclei fondamentali dell'esperienza umana: la sofferenza, il desiderio e la
temporalità.
Inoltre, il proposito di formulare un discorso che potesse risultare curante mi ha indotto a
scegliere di lavorare in sinergia con i saperi psicologici, ai quali mi sono rivolto con la cautela
indispensabile quando si maneggiano strumenti che non sono i propri. Così facendo non sono
andato alla ricerca di una sorta di attestazione di oggettività per le mie speculazioni; al contrario,
spesso mi sono trovato a pensare a partire da contenuti di natura psicologica, ossia grazie ad essi.
Ciò è significato procedere in controtendenza rispetto a quell'atteggiamento di orgogliosa
autoreferenzialità che talvolta connota le ricerche che si muovono in ambito etico;
un'autoreferenzialità che, va detto, è anche un'autolimitazione del filosofare, che in questo modo
3
In questa scelta è da vedersi la ragione del fatto che nelle pagine che seguono si troveranno rari riferimenti a testi
filosofici sulla felicità.
3
5
rischia di smarrire la capacità di mantenersi in comunicazione diretta con il vissuto dei soggetti:
cioè di non comprendere adeguatamente quel che gli abitanti del presente sperimentano e di non
farsi comprendere da loro.
Vale la pena inoltre precisare, allo scopo di evitare possibili fraintendimenti, che l'intenzione che
anima la ricerca – farsi carico dell'attuale domanda di felicità – non simpatizza né tantomeno
coincide con la volontà di realizzare un testo che presenti i tratti tipici di quella produzione pseudofilosofica che sta conoscendo un'ampia diffusione; in altre parole, non si nutre qui alcun proposito
di imbastire un discorso di natura precettistica ed edificatoria, una sorta di filosofia prêt-à-porter.
Al contrario, la sfida consiste nel far convivere il rispetto dei criteri, dei canoni e degli standards di
qualità propri del lavoro scientifico con l'esigenza di articolare un pensiero in grado di dar voce e
insieme rispondere (almeno un poco) alle istanze che provengono da uno scenario collettivo dove
circola, ormai stabilmente, un multiforme disagio esistenziale.
Si sarà già intuito che la felicità di cui qui si tratta non coincide con quelle che Otto Bollnow
chiama «tonalità emotive allegre»4 e che comprendono gli stati d'animo della gaiezza, dell'allegria,
della serenità; essa non coincide nemmeno con la gioia che, per quanto costituisca una potente
elevazione dello stato interiore, possiede comunque un carattere di subitaneità. Si tratta invece del
senso di pienezza prolungato, anche se ad intensità variabile, che scaturisce dall'avvertire che la
propria esistenza sta riuscendo, ossia sta divenendo ciò che può essere, poiché i semi di vita in cui è
racchiusa la propria unicità hanno iniziato a germogliare. Dunque, non la felicità di momenti di vita,
ma la vita felice.
Per quanto riguarda la distribuzione interna del lavoro, la tesi è stata concepita in maniera da
presentare tre capitoli che risultassero sia disposti lungo una linea di sviluppo chiaramente
percepibile, sia dotati di una propria autonomia argomentativa, così da poterli anche leggere
separatamente o, addirittura, in un ordine diverso da quello in cui li ho collocati.
Nell'apparato delle note, oltre agli indispensabili rimandi testuali, sono presenti alcune riflessioni
che non andrebbero considerate come meramente marginali poiché sono invece parte integrante del
percorso generale: sono state poste “fuori” dal testo soltanto per evitare di compromettere la fluidità
del discorso e quindi la scorrevolezza della lettura.
4
Cfr. O. F. Bollnow, Das Wesen Stimmungen, Klostermann, Frankfurt am Main, 1956, trad. it. di D. Bruzzone, Le
tonalità emotive, Vita e Pensiero, Milano, 2009, pp. 37-39.
4
6
I. Depressione e ricominciamento
1. La grande stanchezza
In questo primo capitolo l'attenzione è rivolta al modello teorico e pratico sul quale nel presente
vengono calibrate le domande di felicità, sia nella dimensione individuale che in quella collettiva. Il
funzionamento di tale modello sembra offrirsi pienamente all'osservazione laddove esso fallisce in
maniera eclatante; precisamente, se ne possono delineare i tratti salienti a partire da come essi si
evidenziano in controluce nelle dinamiche di un preoccupante fenomeno in espansione. Si tratta della
depressione, nelle configurazioni inedite che ha assunto nel corso degli ultimi anni. A questo
proposito mi rivolgo anzitutto agli sviluppi più recenti del lavoro del sociologo francese Alain
Ehrenberg1, che da tempo conduce una serrata ed estesa indagine sui caratteri che connotano l'uomo
contemporaneo.
Nel contesto sociale attuale le depressioni si profilano tendenzialmente con i tratti di una «patologia
dell'insufficienza»2, uno scacco doloroso che prosciuga le risorse affettive e volitive dell'agire e fa sì
che la persona non si senta all'altezza delle proprie aspirazioni di vita. Ehrenberg pone in evidenza
una declinazione del vissuto depressivo alquanto differente rispetto a quella che la psicopatologia
aveva conosciuto e studiato fino a poco tempo fa e che si organizzava attorno all'esperienza della
colpa; ora essa assume in prevalenza il volto dell'incapacità e dell'inibizione. Questa mutazione
rappresenta un'imprevista conseguenza della «nuova normatività»3 che si è imposta sulla scena
sociale a partire dalla metà del secolo scorso, modificando in profondità i processi di strutturazione
1
Per quanto riguarda l'opera di Ehrenberg il riferimento specifico è al testo La fatigue d'être soi. Depression et société,
Editions Odile Jacob, Paris, 1998, trad. it. di S. Arecco, La fatica di essere se stessi. Depressione e società, Einaudi,
Torino, 2010. Tessendo insieme le vicende della storia della farmacologia e gli sviluppi teorici della psicoanalisi e della
psichiatria nel corso della seconda metà del Novecento, l'autore indaga il senso che la depressione assume nella società
contemporanea. Nel suo contributo più recente (La societé du malaise. Le mental et le social, Éditions Odile Jacob, Paris,
2010, trad. it. di V. Zini, La società del disagio. Il mentale e il sociale, Einaudi, Torino, 2010) lo studioso focalizza
l'attenzione sulla comparazione dei modelli interpretativi della sofferenza mentale vigenti nel contesto americano e in
quello francese. Per uno sguardo completo sul percorso di ricerca di Ehrenberg si vedano anche Le Culte de la
performance (1991) e L'Individu incertain (1995), entrambi editi da Calmann-Lévy, Paris.
2
A. Ehrenberg, La fatica di essere se stessi, cit., p. 10. È bene precisare che tale patologia costituisce una delle
componenti della fenomenologia depressiva attuale: per quanto sia in rapida espansione, non va in alcun modo
considerata come “laˮ depressione. Ho scelto di utilizzare la formula plurale (“le depressioniˮ) per dar meglio conto di
ciò che si presenta come una tendenza generale ma, appunto, non esclusiva.
3
Ivi, p. 4.
1
7
delle identità personali. In quel frangente è giunta a piena maturazione la crisi dell'impianto
tradizionale di regole che amministravano i comportamenti dei singoli plasmandoli secondo codici
rigidi e spesso opprimenti; si è così definitivamente dischiuso il margine di legittimazione culturale
necessario a favorire una crescente enfasi sul valore dell'unicità individuale e sulla dignità dei vissuti
emotivi che contraddistinguono le singole esistenze. In questo modo è venuto consolidandosi il
diritto per ciascuno ad esprimere se stesso, senza dover essere obbligato ad aderire a stereotipi di
condotta anonimi. L'intrecciarsi di sviluppo economico e vocazione alla “liberazioneˮ dei costumi e
la loro diffusione trasversale rispetto ai differenti ceti sociali hanno sostenuto la democratizzazione
del principio secondo cui tutti possono disincagliarsi da un destino deciso da altri, per tentare di
condurre in proprio la vita, sia sul versante pubblico che su quello privato4.
È nel cuore di questo processo di generale affrancamento psicologico e morale che si è verificato il
passaggio normativo. In virtù di una «nuova grammatica della vita interiore»5, promossa con forza
anche dai mezzi di comunicazione, gli individui si sono progressivamente orientati verso il traguardo
dell'autostima, ormai comunemente riconosciuto come l'obiettivo primario da raggiungere. Ha
attecchito in modo capillare le precisa indicazione etica secondo cui «la felicità consiste nel sapersi
uniformare ai propri desideri»6, ed essa sarebbe alla portata di chiunque, al punto che il suo
perseguimento sembra essere giunto a coincidere con un dovere più che con un diritto.
L'autorizzazione ad aspirare ad una vita “autenticaˮ si è infatti mutata in imperativo: non solo si può,
ma si deve essere felici. È ciò che Philip Rieff ha definito «il vangelo dell'autosoddisfacimento»7.
Anche Gehlen, nella sua analisi psico-sociale della contemporaneità, ha posto l'accento sul «bisogno
di far valere la propria personalità» che impegna le coscienze in ogni frangente di vita, sottolineando
come questa irrinunciabile impellenza risulti «onnipresente con un'intensità e in pari tempo con un
senso di insicurezza che non hanno precedenti nella storia»8.
Intorno al tipo di soggettività che in questa maniera è venuta costituendosi si è addensato un
universo di saperi esperti che accolgono, riproducono e orientano la domanda di autenticità.
Componendo un tessuto di discorsi di verità attorno all'individuo, essi si offrono di rispondere alla
sua esigenza di felicità e, al fine di soddisfarla, mettono in campo «un linguaggio proprio (l'aiuto a
4
Circa il “ritornoˮ dell'individualismo dopo decenni di ideologia collettivista si veda A. Laurent, Histoire de
l'individualisme, PUF, Paris, 1993, trad. it. di M. C. Marinelli, Storia dell'individualismo, il Mulino, Bologna, 1994, pp.
111-121.
5
A. Ehrenberg, La fatica di essere se stessi, cit., p. 159
6
Ivi, p. 159.
7
P. Rieff, The Triumph of Therapeutic. Uses of Faith after Freud, Harper & Row, New York, 1966, trad. it. di S.
Sabbadini, Gli usi della fede dopo Freud. Il trionfo della terapeutica in Freud, Jung, Reich e Lawrence, ILI, Milano,
1972, p. 298; si veda l'intero capitolo ottavo, pp. 275-308.
8
A. Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter, Rowohlt, Hamburg, 1957, trad. it. di A. Cori, L'uomo nell'era della
tecnica. Problemi socio-psicologici della civiltà industriale, Sugar, Milano, 1967, p. 197.
2
8
vivere), una letteratura propria, tecnologie proprie (farmacologiche, psicologiche), professioni
proprie (sessuologia, psicoterapia di gruppo ecc.)»9. La cultura terapeutica che si è istituzionalizzata,
mentre promuove il compimento di sé a tutti i costi, postula la figura di un soggetto bisognoso di
supporto costante, emotivamente inerme e minacciato dalla possibilità che dietro ogni difficoltà del
vivere si celi un potenziale trauma10.
Se si riconoscono pieni diritti alla «volontà di essere felici»11, se sembra concesso ad ognuno di
provare ad essere se stesso, come mai allora un simile proposito naufraga oggi con tanta frequenza?
Ciò che accade è che lì dove ci si attendeva che l'esistenza di ognuno avesse finalmente
l'opportunità di fiorire, le forze vitali invece tendono ad appassire. L'individuo a cui si presenta –
almeno in apparenza – la chance di farsi sovrano di sé e del proprio destino si ritrova spaesato e
incerto sul da fare; sottratto all'obbligo di obbedienza ai vecchi sistemi di divieti, rinunce e
imposizioni, egli vacilla al cospetto del vuoto angosciante che si apre tra possibile e impossibile. Il
terreno di inedita libertà su cui è stato collocato si rivela un pantano che lo immobilizza. Il rischio
della depressione, cioè, si affaccia nel momento in cui la persona non può evitare di sentirsi stanca di
dover essere se stessa, spossata dal compito incessante di farsi carico di sé; quando ella cede sotto il
peso delle pressioni sociali che la spingono ad attivarsi, intraprendere iniziative, inventare e sostenere
progettualità in cui esprimere appieno le proprie qualità e capacità. Difatti l'ampia offerta di vita da
cui ciascuno è investito agisce come richiesta incalzante di continue performances (cognitive,
lavorative, relazionali) da cui ci si attende che producano il massimo del “profitto esistenzialeˮ. E
affinché le proprie attitudini e competenze affiorino per essere impiegate in maniera proficua, si è
costantemente chiamati a decifrarsi e lasciarsi decifrare, all'interno di una rete di colloqui, interviste,
test attitudinali, incontri di orientamento a cui sono sottoposti lavoratori e studenti di ogni grado e
posizione12.
9
A. Ehrenberg, La fatica di essere se stessi, cit., p. 160.
Cfr. F. Furedi, Therapeutic Culture. Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age, Frank Furedi, 2004, trad. it. di L.
Cornalba, Il nuovo conformismo. Troppa psicologia nella vita quotidiana, Feltrinelli, Milano, 2005, capitoli 5-6-7, pp.
132-195; per una ricostruzione dell'ascesa dell'homo sentimentalis cfr. Eva Illouz, Cold Intimacies: The Making of
Emotional Capitalism, Polity Press, London, 2007, trad. it. di E. Dornetti, Intimità fredde. Le emozioni nella società dei
consumi, Feltrinelli, Milano, 2007.
11
Cfr. O. Rank, Wahrheit und Wirklichkeit (1929), trad. it. di F. Marchioro, La volontà di essere felici. Progetto di una
filosofia della vita psichica, SugarCo, Carnago, 1992. Rank appartiene alla cerchia dei primi seguaci di Freud, dalla
quale si allontana progressivamente sviluppando una direzione teorica e terapeutica che insiste sulla centralità della
volontà umana e dell'agire creativo. Uno degli elementi di maggior distanza dal maestro è costituito dal riferimento
esplicito e costante ad autori filosofici, tra i quali spiccano Schopenhauer e Nietzsche: riferimenti che Freud tendenza
invece a sottacere.
12
La promozione di una costante (auto)formazione dell'individuo in ogni campo del vivere si inserisce nel nuovo
orizzonte del capitalismo cognitivo, a carattere sempre più “personalizzatoˮ: cfr. A. Gorz, L'Immtatériel. Connaisance,
valeur et capital, Galilée, Paris, 2003, trad. it. L'immateriale. Conoscenza, valore e capitale, Bollati Boringhieri,
Torino, 2003; A. Bonomi-E. Rullani, Il capitalismo personale. Vite al lavoro, Einaudi, Torino, 2005.
10
3
9
Dunque, sarebbe qui da ricercare la radice di quell'insufficienza che «è per l'individuo di oggi
quello che il conflitto era per l'individuo del XX secolo»13. Alle prese con un codice morale che
valuta i singoli in base non più alla loro docilità – come fino a pochi decenni fa – ma al tasso della
loro entusiastica intraprendenza, un numero crescente di persone si trova ad avvertire un penoso
senso di inadeguatezza, a cui si mescolano avvilimento e complesso di inferiorità. Si tratta di una
generalizzata estenuazione psicologica ed emotiva che tra i suoi effetti più devastanti comprende
l’assottigliarsi progressivo della distinzione tra curarsi e drogarsi; l'utilizzo sfrenato di dopanti ed
energizzanti si mischia pericolosamente al consumo di sostanze psicoattive che modificano l'umore.
È così che «alla felicità a comando fa da contraltare la chimica della disperazione; alla
medicalizzazione del malessere, la depressione come malattia vera e propria; alla pubblicità che tesse
l’elogio di una nuova medicina miracolosa, la contro-pubblicità di una droga che garantisce assenza
di tossicità e dipendenza»14.
Senza dubbio l'io contemporaneo sperimenta un variegato spettro patologico che comprende, fra
l'altro, problemi d'ansia, attacchi di panico, episodi di burnout. Qui mi concentro sul fenomeno
depressivo ritenendo che esso, più di altre forme di sofferenza psicologica, investa radicalmente la
questione della felicità così come si configura nell'orizzonte dell'«individualismo illimitato», per
usare un'espressione di Elena Pulcini, ovvero in un paesaggio di vita in cui coabitano prometeismo e
narcisismo15. Tale convivenza si caratterizza per una duplice privazione: da un lato, la «perdita dei
confini» (territoriali, identitari) che genera costante insicurezza in ambiti come quelli delle relazioni
comunitarie, del lavoro e dell'amministrazione politica; dall'altro, la «perdita dei limiti» rintracciabile
nella dismisura autoreferenziale, nella voracità consumistica, nel delirio di potenza tecnologica16. I
drammatici effetti di destabilizzazione psichica che si producono sono al centro delle considerazioni
raccolte in L'epoca delle passioni tristi, dove Benasayag e Schmit (psicoanalista il primo, psichiatra
13
A. Ehrenberg, La fatica di essere se stessi, cit., p. 300.
Ivi, p. 6. Si tratta di un processo socio-economico rispetto al quale giocano un ruolo decisivo anche gli interessi delle
case farmaceutiche, in grado di influenzare i protocolli e le decisioni di organi come l'Organizzazione mondiale della
sanità: cfr. P. Pignarre, Comment la dépression est devenue une épidémie, Éditions La Découverte & Syros, Paris, 2001,
trad. it. di M. Pezzella, L'industria della depressione, Bollati Boringhieri, Torino, 2010.
15
A partire dall'originaria distinzione freudiana tra narcisismo primario e secondario, le teorie psicoanalitiche
contemporanee convergono tendenzialmente nell'individuare una dimensione narcisistica necessaria nelle prime fasi di
sviluppo del bambino e una a carattere più o meno patologico che può riguardare la persona in età adulta (cfr. M.
Mancia, Narcisismo. Il presente deformato dallo specchio, Bollati Boringhieri, Torino, 2010). Per approfondire questa
tematica sono imprescindibili gli studi di Heinz Kohut, che ha inaugurato la cosiddetta psicologia del Sé. È da tener
presente anche l'oramai classico lavoro sociologico di Christopher Lasch Culture of Narcissism. American Life in the
Age of Diminishing Expectations, Norton, New York, 1979, trad. it. di M. Bocconcelli, La cultura del narcisismo,
Bompiani, Milano, 1981.
16
Cfr. E. Pulcini, La cura del mondo. Paura e responsabilità nell'età globale, Bollati Boringhieri, Torino, 2009, in
particolare il cap. I, pp. 31-59. In questo testo la studiosa italiana svolge un accurato lavoro di analisi socio-politica
della contemporaneità, mobilitando un rilevante numero di autori e utilizzandone i contributi in maniera da argomentare
un sua autonoma posizione teorica, sia in funzione critica che propositiva.
14
4
10
infantile il secondo) constatano il fatto che nel loro lavoro le crisi individuali e familiari su cui sono
chiamati ad intervenire non nascono in ragione di «una rottura, un incidente che costituisce una
parentesi in un continuum stabile»17, ma rappresentano la regola di un organismo sociale esso stesso
in crisi permanente. Chi come loro svolge un'opera di aiuto e sostegno si trova così a dover far fronte
ad «un nuovo tipo di richiesta», del tutto differente rispetto a quella «classica, di tipo
psicopatologico»18.
Questa situazione si fa poi ulteriormente allarmante in concomitanza con una fase economica in cui
sempre più persone faticano ad approntare le condizioni materiali che pure sono importanti ai fini di
una vita appagante. Cresce il malcontento per il mancato adempimento delle promesse che hanno
accompagnato la nascita e il primo sviluppo dei regimi democratici: dopo pochi decenni essi
manifestano sintomi da invecchiamento precoce che si rivelano soprattutto nell'incapacità ad
assicurare un'equa distribuzione delle ricchezze e una solida rete di assistenza sociale.
Si vanno così estendendo depressioni che si confondono con la “normalitàˮ e che hanno i connotati
sfuggenti di malattie-non-malattie le quali, pur mettendo alla prova la salute19 di molti, resistono ai
tentativi di rubricarle in rigide classificazioni; è comunque lecito distribuirle nella vasta area delle
depressioni di natura psicogena. Queste «trovano la loro spiegazione in motivi psicologici
riconoscibili e dimostrabili. Il caso più evidente è la depressione reattiva a un'esperienza vissuta
come perdita. Tale è il lutto, la delusione amorosa, l'insuccesso nell'affermazione sociale, la
frustrazione delle proprie aspettative»20. Le depressioni reattive o motivate si collocano tra due
17
M. Benasayag-G. Schmit, Les passions tristes. Souffrance psychique et crise sociale, La Découverte, Paris, 2003, trad.
it. di E. Missana, L'epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano, 2004, p. 13.
18
Ivi, p. 10.
19
Trovo opportuno puntualizzare che con “saluteˮ intendo qui – secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale
della sanità – «uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o
infermità»; dunque una sorta di ideale regolativo che ciascun individuo “soddisfaˮ a suo modo e comunque mai del
tutto.
20
U. Galimberti, Dizionario di psicologia, Utet, Torino, 1994, edizione speciale realizzata per Gruppo Editoriale
L'Espresso, 2006, p. 565. «La relazione tra la reazione della personalità e i meccanismi psicodinamici che la
determinano consente di distinguere tra la reazione depressiva semplice [...] e la reazione depressiva nevrotica dove la
motivazione non è chiaramente presente alla coscienza e si confonde con la biografia del paziente e il suo sviluppo
affettivo» (ivi, pp. 565-566). «L'umore varia dall'indifferenza all'apatia a un profondo abbattimento, scoraggiamento e
disperazione. L'anedonia, la totale incapacità di provare piacere, è una caratteristica costante; viene esperita come
mancanza di gioia e rivelata nell'espressione facciale, nel discorso, nel comportamento, nello stile di vita (...). Un
rallentamento della capacità di iniziare il pensiero o l'azione viene notato da parte dell'osservatore in forma di ritardo
(...). L'agitazione e l'attivazione afinalistica peggiorano il senso di disagio e l'incapacità di realizzare alcunché. Tale
ansia e concentrazione su pensieri malinconici peggiorano la capacità di concentrazione. (...) Vi è solitamente una
sensazione di perdita di capacità, inutilità e incapacità a fare fronte alle necessità. (...) Al pari dei deliri di colpa e di
indegnità, il deliri ipocondriaci e nichilistici sono relativamente comuni nella depressione» (A. Sims, F. Oyebode, Sim's
Symptoms in the Mind. An Introduction to Descriptive Psycopathology, Elsevier, Amsterdam, 2008, trad. it. di L.
Bellodi, M. Battaglia e A. Ranieri, Introduzione alla psicopatologia descrittiva. Quarta edizione, Raffaello Cortina,
Milano, 2009, pp. 416-418).
5
11
dimensioni di sofferenza. Da una parte, le depressioni “esistenzialiˮ, i disturbi distimici che
«attraversano la vita di tutti gli uomini come episodi legittimi e comprensibili, dove il soggetto è di
solito consapevole di poterle superare da sé»21. In quanto caratteristica di stagioni in cui «ci sentiamo
svuotati di interesse e di iniziativa, e soprattutto non riusciamo più a ritrovare un senso nella vita»,
questa tipologia di sofferenza «non è una tristezza patologica» ma «una esperienza di vita che non è
estranea a ciascuno di noi»22. Dall'altra parte ci sono le depressioni psicotiche o endogene, la vera e
propria «depressione-malattia che non ha motivazioni riconoscibili nella sua insorgenza e che
corrisponde alla diagnosi di “Episodio Depressivo Maggioreˮ»23.
2. Una felicità disabitata
Da questa ricognizione sul presente viene in evidenza il funzionamento di potenti automatismi
autorealizzativi; le depressioni tenderebbero infatti ad innescarsi poiché le configurazioni sociali in
cui la persona è coinvolta, e dalle quali è spronata senza tregua a plasmare la sua soggettività,
agiscono di fatto come ostacoli che impediscono di coltivare adeguatamente la propria esistenza,
quando invece esse parrebbero costituire un campo di opportunità favorevoli. L'origine di queste
sofferenze andrebbe cioè ravvisata nei modi di essere in cui viene declinato il paradigma culturale
che individua nella felicità l'ideale di una piena e libera espressione delle possibilità di vita. Si è detto
sopra che fino a tempi recenti le depressioni conseguivano principalmente dai conflitti tra i desideri
individuali e le istanze normative interiorizzate. Il depresso era colui che soffriva del non sentirsi
autorizzato ad essere se stesso, appunto perché censurato nei bisogni e nelle ambizioni da autorità
come la famiglia, la scuola, ecc. Oggi le istituzioni sociali non sembrano più intenzionate a frenare i
tentativi singolari di mettere in opera progetti di vita congruenti con gli ideali che ciascuno serba in
sé; si ha anzi l'impressione che lavorino in direzione contraria. Basti pensare all'enfasi con cui nei
campi dello studio, del lavoro e dei consumi i soggetti sono invitati ad agire “creativamenteˮ,
mettendo in gioco la propria personalità intellettuale e la propria emotività24.
21
U. Galimberti, Dizionario di psicologia, cit., p. 564.
E. Borgna, Elogio della depressione, in A. Bonomi-E. Borgna, Elogio della depressione, Einaudi, Torino, 2011, pp. 6061.
23
Ivi, p. 64.
24
Si consideri che ciò che il capitalismo emotivo pone in vendita non sono più “pacchettiˮ di identità, fruibili mediante il
consumo di prodotti di marca (brand), ma campi di esperienze sensoriali, affettive, ludiche, intellettuali, ecc. Le aziende
– da intendersi come tutte le realtà sociali organizzate in modo aziendale, dalle imprese commerciali agli atenei
universitari – operano cioè come experience providers.
22
6
12
Per meglio focalizzare la relazione tra coazione alla felicità e insorgenza della depressione mi pare
proficuo ricorrere ad alcuni contributi di Michel Foucault, tratteggiandone possibili linee di sviluppo.
Dopo aver ricostruito l'origine e la meccanica del sistema disciplinare con cui a partire dal XVII
secolo il potere statale ha gestito l'esistenza dei cittadini25, il pensatore francese percepisce l'inizio di
una pronunciata destabilizzazione di questo apparato. In più occasioni ha modo di sostenere la
convinzione che il «governo» – da intendersi come «l'insieme di istituzioni e pratiche tramite le quali
si guidano gli uomini: dall'amministrazione, all'educazione ecc.» – conosce una fase di profonda
«rivalutazione complessiva»26. Certamente sono intervenute numerose e significative spinte sociali
che hanno promosso mutamenti, riforme e innovazioni in tale direzione. Ad ogni modo, quello che
Foucault intravede è il delinearsi di una tipologia inedita di pericoli legati all'esercizio dei poteri nello
spazio della collettività. Innanzitutto, perché viene meno la centralità del ruolo dello Stato a
vantaggio di altri attori sulla scena pubblica, fra cui spiccano le imprese multinazionali e i vari
potentati economico-finanziari. Ma specialmente perché il governo della società comincia ad essere
organizzato in forme tanto leggere da divenire quasi impercettibili, capaci di intervenire nelle pieghe
più intime della vita. In un'intervista del 1975 lo studioso dichiara: «a partire dagli anni '60, ci si è
resi conto che questo potere tanto gravoso non era più indispensabile come si credeva, che le società
industriali potevano accontentarsi di un potere sul corpo molto meno serrato. [...] Rimane da studiare
di quale corpo ha bisogno la società oggi»27. Tale processo appare evidente, ad esempio, nella
dimensione della sessualità, che rappresenta uno dei versanti di interrogazione prediletti da Foucault.
Piuttosto che essere frenati nel loro manifestarsi, gli impulsi sessuali sono ricompresi in dinamiche
che li stimolano in maniera da renderli scrutabili, tracciabili e possibilmente remunerativi. Si pensi
soltanto alla pornografia che, una volta abbandonata la sua natura “notturnaˮ, dilaga nella
quotidianità della vita mediatica e arricchisce una vasta trama affaristica.
Riprendendo le sollecitazioni foucaultiane, sul finire degli anni '80 Gilles Deleuze osserva che i
sistemi disciplinari «sono precisamente ciò da cui ci stiamo allontanando, ciò che noi ormai non
siamo più». Le società che si stanno realizzando «non funzionano più sul principio dell’internamento,
25
Questi interessi di ricerca costituiscono il principale campo di studio di Foucault durante la gran parte degli anni
Settanta; tra i vari lavori vanno tenuti in considerazione almeno Surveiller et punir: naissance de la prison, Gallimard,
Paris, 1975, trad. it. di A. Tarchetti, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino, 1976; Naissance de
la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-1979, Seuil-Gallimard, Paris, 2004, trad. it. di M. Bertani e V. Zini,
Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Feltrinelli, Milano, 2005.
26
D. Trombadori, Colloqui con Foucault. Pensieri, opere, omissioni dell'ultimo maître-à-penser, Castelvecchi, Roma,
1999, pp. 114-115.
27
M. Foucault, Pouvoir et corps (1975), trad. it. di A. Fontana, P. Pasquino e G. Procacci, Potere e corpo, in M. Foucault,
Il discorso, la storia, la verità. Interventi 1969-1984, a cura di M. Bertani, Einaudi, Torino, 2001, p. 151.
7
13
bensì su quello del controllo continuo e della comunicazione istantanea»28. In un orizzonte come
questo i tentativi di normalizzazione minacciano di passare lì dove ognuno confida di esercitare
forme di condotta squisitamente personali; per esempio nell'agire comunicativo con cui si radunano,
compongono e forniscono informazioni che dettagliano le identità individuali al fine di renderle
uniche e allo stesso tempo immettibili e fruibili in circuiti infiniti di scambio29.
In un'altra intervista Foucault suggerisce uno spunto critico che trovo decisamente rilevante ai fini
dell'argomentazione che sto svolgendo. Discutendo delle difficoltà che le persone omosessuali
incontrano nel praticare pubblicamente il loro stile di vita, egli sostiene che «i piaceri si tollerano»,
visto che nella società si è verificato un «allargamento dell'economia del piacere»30. Questa ipotesi di
interpretazione del presente socio-politico è riproposta da letture critiche più attuali come quella di
Slavoj Žižek, il quale ha ben mostrato che perfino la trasgressività – come prorompente brama di
godimento che travalica censure e regolamentazioni – è prevista e favorita nel regime giornaliero dei
poteri31. Del resto, in Italia recenti vicende hanno fornito un'ulteriore indicazione in tal senso,
chiarendo che la trasgressione incarnata da influenti personaggi pubblici può addirittura incontrare il
favore ammiccante di una considerevole porzione di cittadini. Tutto questo, comunque, non
impedisce che per i soggetti che padroneggiano i rapporti di forza del tessuto sociale un certo campo
dell'esperienza umana riesca inammissibile, disturbante: «Ma la felicità invece? Ecco cosa fa saltare
il principio di questa economia compensata dei piaceri, e cosa risulta intollerabile. [...] Il piacere è
ammesso, basta sapere che dietro c'è un po' di angoscia. [...] Ma cosa c'è dietro la felicità? Le nostre
capacità esplicative non hanno nulla da dire, ed è questo che non si tollera»32.
Da tali cenni si può raccogliere un'indicazione preziosa. Gli apparati di potere che controllano
l'attuale campo sociale hanno messo a loro sevizio l'ideale di felicità che ha accompagnato il lungo
28
G. Deleuze, Pouparlers, Les Éditions de Minuit, Paris, 1990, trad. it. di S. Verdicchio, Pourparler, Quodlibet,
Macerata, 2000, p. 230.
29
L'attenzione va ovviamente ai networks di socializzazione: per sviluppare un adeguato quadro di riflessione in merito si
veda il fascicolo n. 347 (2010) di “aut autˮ intitolato Web 2.0. Un nuovo racconto e i suoi dispositivi, dove tra l'altro è
possibile reperire numerose indicazioni bibliografiche. In un passaggio significativo di uno degli articoli si legge: «Non
ci sono prove che il mondo stia diventando più virtuale. I cyberprofeti si erano sbagliati su questo. [...] Il virtuale sta
diventando sempre più reale. Tutti gli investimenti si concentrano lì, mentre abbandonano Second Life, la
virtualizzazione e le mascherate. Non siamo più incoraggiati a fingere di essere un altro, bensì a essere noi stessi. Ci
registriamo continuamente, creiamo profili allo scopo di presentarci sul mercato globale del lavoro, dell'amicizia,
dell'amore. [...] L'idea originaria, in base alla quale il virtuale doveva aiutare a liberarci del nostro vecchio io, è andata
in pezzi. Adesso tutto gira intorno al management di sé e al techno-sculpturing: che forma diamo al nostro io nel flusso
di tempo reale?» (G. Lovinik, Tre tendenze del Web 2.0, pp. 29-30).
30
M. Foucault, Le Gai savoir (1978), trad. it. di D. Borca, Il gay sapere, in "aut aut", n. 331 (2006), p. 41.
31
Si veda la raccolta di scritti del filosofo e psicoanalista sloveno Il grande Altro. Nazionalismo, godimento, cultura di
massa, a cura di M. Senaldi, Feltrinelli, Milano, 1999. Riguardo alla dialettica trasgressione-limite nella sessualità cfr.
M Foucault, Préface à la transgression (1963), trad. it. Prefazione alla trasgressione, in M. Foucault, Scritti letterari, a
cura di C. Milanese, Feltrinelli, Milano, 2004, pp. 55-86.
32
M. Foucault, Il gay sapere, cit., p. 42. Corsivo mio.
8
14
processo di emancipazione culturale: ne hanno avvelenato il senso, lo hanno ritorto contro se stesso,
conservandolo esteriormente intatto ma disabitato. L'aspirazione singolare e plurale alla felicità si è
così progressivamente stravolta in felicismo, che oggigiorno si presenta come l’ideologia della fine
delle ideologie. Si tratta dell'ennesimo incubo in cui si tramuta il sogno di un «assoluto
immanente»33, di un altro momento “dialetticoˮ che perpetua l'incompiutezza della modernità. Il
risultato è che l'ideale di felicità conserva tutto il suo potenziale sovversivo nei confronti delle istanze
di dominio sociale; quando si incarna in pratiche di vita rappresenta ancora uno “scandaloˮ e fa
paura, perché anima un tipo di esperienza che trascende la funzione dei piaceri34.
I contributi dello psicoanalista Massimo Recalcati consentono una migliore messa a fuoco di questa
prospettiva. Le sue esperienze cliniche lo inducono a rilevare una situazione particolarmente
preoccupante: all'edonismo frivolo e disimpegnato, che ha conosciuto il suo massimo fulgore nel
periodo degli anni '80, si va sostituendo la condizione «di annullamento, di nirvanizzazione, di
ibernazione, di pietrificazione, di cancellazione del desiderio»35. Dissociato da quest'ultimo, il
godimento tenderebbe a farsi «acefalo» e a vagare nel vuoto di una prestazione di piacere
compulsiva. Ciò accade ad esempio nelle frequenti dipendenze patologiche, «dove il corpo diventa
luogo di puro consumo del godimento pulsionale (obesità, bulimia, tossicomania ecc.), o in un certo
modo perverso di agire la sessualità sganciandola dalla dimensione dell'incontro con l'Altro, dove il
33
H. Blumenberg, Die Legitimitat der Neuzeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1974, trad. it. di C. Marelli, La legittimità
dell'età moderna, Marietti, Genova, 1992, p. 188.
34
Nell'orizzonte del presente vacilla la tenuta dello schema socio-antropologico elaborato da Freud, visto che è la società
stessa a non consentire all'individuo di relegare sullo sfondo il compito di procurarsi piacere, per accontentarsi di una
tollerabile infelicità. Com'è noto, il punto di vista di Freud è il seguente: dato che l'aspirazione alla felicità che tutti
nutrono mira «da un lato all'assenza del dolore e del dispiacere, dall'altro all'accoglimento di sentimenti intensi di
piacere», e visto che tale programma confligge irrimediabilmente con la realtà del mondo – addirittura con la
«Creazione» –, non resta per l'uomo che una felicità “al ribassoˮ; non c'è da meravigliarsi cioè se «il compito di evitare
il dolore relega nello sfondo quello di procurarsi il piacere»: S. Freud, Das Unbehagen in der Kultur (1929), trad. it. di
E. Sagittario, Il disagio della civiltà e altri scritti, Bollati Boringhieri, Torino, 1971, pp. 211-212.
35
M. Recalcati, L'uomo senza inconscio. Figure della nuova clinica psicoanalitica, Raffaello Cortina, Milano, 2010, p.
12. Stupisce constatare che Recalcati non faccia alcun riferimento al lavoro di Žižek (anch'egli noto psicoanalista
lacaniano) il quale da tempo si occupa di queste tematiche. Ad ogni modo, l'apparato teorico che lo psicoanalista
italiano utilizza è articolato sul «discorso del capitalista» delineato da Lacan, secondo cui il capitalismo comporta
inesorabilmente la distruzione di ogni legame: «Il fondamento ideologico-culturale dell'affermazione del capitalismo si
troverebbe, secondo la tesi classica di Weber, nella cultura dell'ascetismo protestante. [...] Il discorso del capitalista
lacaniano è [...] radicalmente antiweberiano. Esso non esalta affatto il legame come effetto della rinuncia pulsionale,
come prodotto del sacrificio o come manifestazione della virtù delle opere, ma è un discorso che esalta a senso unico la
spinta del godimento contro ogni forma di legame. Si tratta pertanto di un discorso al limite di ogni possibile discorso,
perché se il discorso è un modo per definire il legame sociale, in quanto ogni discorso si organizza per introdurre un
certo freno significante al godimento e per rendere possibile in questo modo una civilizzazione dei legami tra gli esseri
umani, quello del capitalismo tende a distruggere ogni forma discorsiva affermando il soggetto come pura spinta al
godimento solitario, dunque dissolvendo ogni freno al godimento, anzi, incoraggiando il godimento come nuova forma
di comando sociale. Il sacrifico di sé risulta così totalmente contraddittorio in un regime che pone il proprio fondamento
sull'imperativo sregolato del “consumo di consumoˮ» (ivi, p. 28).
9
15
corpo viene frammentato in oggetti multipli di godimento senza alcun rapporto col desiderio»36.
Dunque, se nel pieno delle contestazioni a cavallo degli anni '60 e '70 era ancora sensato, almeno in
certi limiti, invocare la dirompente immediatezza del desiderio, oggi questa opzione sarebbe del tutto
incapace di intaccare un'organizzazione sociale che – come avvisa Umberto Galimberti – «finisce col
mobilitare, e non per liberare, le potenzialità espressive del corpo». Di esso infatti viene ora messa a
profitto non tanto la forza-lavoro ma la forza del desiderio, «allucinandolo con quegli ideali di
bellezza, giovinezza, salute, sessualità che sono poi i nuovi valori da vendere»37.
Abbozzando una risposta all'interrogativo di Foucault, direi che oggi la società ha bisogno di un
corpo costantemente coinvolto in in-trattenimenti materiali e immateriali; un corpo impegnato a
scolpirsi nelle sue forme, a svagarsi spostandosi da un punto all'altro del pianeta, a comunicare
parlando e facendo parlare di sé. L'unica cosa che sembra non gli si debba proprio lasciar fare è di
trattenersi presso di sé. C'è infatti il rischio che la persona non si trovi nel modo di essere che le
viene docilmente imposto e che possa quindi iniziare ad interrogare e interrogarsi – ad interrompere
cioè l'esecuzione degli automatismi autorealizzativi. Il problema, allora, non è tanto di esser presi in
«circuiti bassi del principio di piacere»38 ma piuttosto che, per quanto si assaggino brani di vita e si
accumulino godimenti, in questa “felicitàˮ noi non ci siamo. Come un sacco bucato, la si scopre
vuota non appena si provi a stringerne il contenuto. È di certo una felicità illusoria, eppure di
un'illusorietà concreta e capace di potenti effetti di realtà. Mentre se ne denuncia la falsità si deve
allora prestare attenzione a non indulgere ad una «repulsione antropologica»39 che impedirebbe di
vedere come anche ciò che è falso può dotare di senso l'esistenza – un senso disponibile, spendibile e
acquistabile.
Conviene compiere un passo indietro. In apertura ho affermato che i fenomeni di sofferenza
depressiva costituiscono esempi eclatanti del fallimento del modello attuale di felicità: questa prima
indicazione va precisata. Cos'è esattamente che fallisce con le depressioni? Non fallisce il proposito
dei poteri che fanno funzionare questo modello, ovvero disperdere le forze umane dirottandole su una
miriade di sentieri; svilire le energie individuali e collettive, non spegnendole bensì dissipandole,
sprecandole. Falliscono invece le domande di felicità che prorompono dal cuore stesso delle singole
vite – quasi contenessero una promessa che si eredita nascendo –, perché in tale modello non trovano
ospitalità. Laddove la persona è dis-tratta, strappata a se stessa, il suo tentativo di conoscere la
felicità non può che essere vacuo affannarsi, improduttività, deperimento: esattamente la stanchezza a
cui corrispondono le comuni depressioni odierne.
36
M. Recalcati, L'uomo senza inconscio, cit., p. 25.
U. Galimberti, Il corpo, Feltrinelli, Milano, 2002, p. 13.
38
F. de Luise-G. Farinetti, Storia della felicità. Gli antichi e i moderni, Einaudi, Torino, 2001, p. 530.
39
F. Cassano, L'umiltà del male, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 18.
37
10
16
3. La forza del soffrire
Un elemento indispensabile al consolidamento del fenomeno depressivo è l'incapacità ad
ammettere il fatto del soffrire. A questo misconoscimento generalizzato contribuisce il processo di
“anestetizzazioneˮ delle coscienze tipico delle società contemporanee, dove sono attivi meccanismi
di diniego che consentono di minimizzare la dimensione della sofferenza, vicina e lontana, o
addirittura di ripudiarne la realtà stessa40. In virtù di questo sortilegio, il corpo che soffre – in primis
il corpo invecchiato o malato che sta per morire41 – viene spesso relegato dietro le quinte e in scena
resta il suo fantasma, il simulacro mediatico svuotato di carne e caricato di tratti sensazionalistici su
cui l'attenzione si posa svogliatamente. Rimane insomma lo “spettacoloˮ della sofferenza42. Ma essa
ovviamente non scompare e quando emerge nel vivo dell'esistenza – come in occasione della
depressione – viene investita con parole e azioni che la riducono a stato da “superareˮ quanto prima,
a fastidioso incidente di percorso da lasciarsi alle spalle come se non fosse mai accaduto. Laddove la
sua manifestazione è ineludibile essa è accompagnata da un pregiudizio che la interpreta come
esperienza di segno puramente negativo; la sofferenza trova infatti la sua intelligibilità in una
precomprensione antropologica, più o meno consapevole, secondo cui il soffrire in quanto tale
contraddirebbe il valore implicito del vivere umano, e di conseguenza ogni forma dello star-male
possiederebbe lo statuto di “maleˮ. La persuasione che vivere un malessere psicologico significa
essere “malatiˮ, ad esempio, rappresenta una delle varianti di questa fissazione pregiudiziale.
Si è visto che oggi il ferimento e il fallimento delle speranze e delle ambizioni di vita spesso si
originano dalle stesse dinamiche sociali che le inducono pungolando i soggetti a prodursi in un
40
Cfr. S. Cohen, States of Denial. Knowing about Atrocities and Suffering, Polity Press, Cambridge, 2001, trad. it. di D.
Damiani, Stati di negazione. La rimozione del dolore nella società contemporanea, Carocci, Roma, 2002.
41
Cfr. N. Elias, Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1982, trad. it. di
M. Keller, La solitudine del morente, il Mulino, Bologna, 1985; M. Marzano, Scene finali. Morire di cancro in Italia, il
Mulino, Bologna, 2004. Una volta giunta la fine, anche il defunto subisce una vera e propria «estradizione», come
scrive Jean Baudrillard: «a poco a poco i morti cessano di esistere [...] nulla è più previsto per i morti, né nello spazio
fisico, né nello spazio mentale. Perfino i pazzi, i delinquenti, gli anormali possono trovare una struttura di assistenza
nelle nuove città, cioè nella razionalità di una società moderna – solo la funzione-morte non può esservi programmata
né localizzata. Perché al giorno d'oggi non è normale essere morti [...] Essere morto è un'anomalia impensabile, rispetto
alla quale tutte le altre sono inoffensive. La morte è una delinquenza, una devianza incurabile» (J. Baudrillard,
L'échange symbolique et la mort, Gallimard, Paris, 1976, trad. it. di G. Mancuso, Lo scambio simbolico e la morte,
Feltrinelli, Milano, 2002, p. 139).
42
Cfr. L. Boltanski, La souffrance à distance. Morale humanitaire, médias et politique, Métailié, Paris, 1993, trad. it. di
B. Bianconi, Lo spettacolo del dolore. Morale umanitaria, media e politica, Raffaelo Cortina, Milano, 2000; rilevante
anche il recente testo di Alessandro Dal Lago, Carnefici e spettatori. La nostra indifferenza verso la crudeltà, Raffaello
Cortina Editore, Milano, 2012.
11
17
vitalismo drogato; in questa insostenibile esaltazione, «ogni condizione di sofferenza [...] non può se
non essere immediatamente cancellata e rimossa». A legittimare tale esercizio di sparizione concorre
in modo decisivo l'entusiasmo dovuto alla constatazione che «gli psicofarmaci delle “ultime
generazioniˮ [...] agirebbero [...] non solo nelle depressioni psicotiche ma anche nelle depressioni
delle persone “normaliˮ»43. Il messaggio che circola è insomma il seguente: se attraverso la chimica è
possibile aggirare gli stati di abbattimento e amarezza che sono parte integrante della comune
condizione dell'umano, perché non approfittarne assumendo regolarmente sostanze psicoattive? In
parole più povere, la sofferenza, particolarmente quella depressiva, è dichiarata del tutto inutile.
Il misconoscimento della realtà e del valore delle forme del soffrire costituisce l'humus culturale
che alimenta la materia ideologica del felicismo e lo rende capace di oscurare il volto doloroso
dell'esistenza quotidiana. È una delle fondamenta di senso su cui il regime felicista edifica le sue
condizioni di possibilità, riproducibilità ed efficacia. Se così è, esso rappresenta uno snodo
problematico decisivo su cui bisogna concentrarsi e intervenire efficacemente. Benché il quadro che
si ha davanti agli occhi sia senza dubbio fosco e inquietante, è pur vero che la partita della felicità,
per così dire, non è perduta già dall'inizio e sembra poter continuare anche con la sofferenza diffusa
che oggi si avverte: ovvero a partire da essa, nella relazione con il sé che soffre – proprio e altrui.
Per procedere in tale direzione è necessario innanzitutto sottrarre la questione della felicità ai
discorsi di potere che, tenendola in certo senso in ostaggio, impediscono di scorgere la complessità
che la abita. A questo scopo è opportuno svolgere una ricognizione semantica, non certo per
rifugiarsi in sterili esercizi linguistici, ma con l'obiettivo di recuperare l'originaria pregnanza di
significato delle categorie in gioco ed attingere alla sapienza antropologica che in esse sopravvive.
Il primo elemento da porre in evidenza con forza è che “sofferenzaˮ è concetto che «dice l'evento,
non l'essenza o la cosa»44; esso riferisce di un duplice movimento del corpo. Il patire che, come
indica il greco pathos, è l'incontrare qualcosa che viene e, nel suo avvenire, fa male; il ricevere il
colpo del dolore che si abbatte e al quale si è totalmente esposti. È l'essere invasi da quello che Nancy
chiama «l'intruso», che «si introduce di forza, con la sorpresa o l’astuzia, in ogni caso senza
permesso e senza essere stato invitato»45. A questo “attaccoˮ corrisponde immediatamente il
sopportare (sub-ferre) la pressione del colpo che minaccia di schiacciare. Il corpo cioè non si limita a
patire il dolore ma agisce attivamente: resiste trattenendo e spingendo.
43
E. Borgna, Prefazione a A. Ehrenberg, La fatica di essere se stessi, cit., p. XV.
G. Deleuze-F. Guattari, Qu'est-ce que la philosophie?, Les Éditions de Minuit, Paris, 1991, trad. it. di C. Arcuri, Che
cos'è la filosofia?, Einaudi, Torino, 2002, p. 11.
45
J. L. Nancy, L'Intrus, Galilée, Paris, 2000, trad. it. di V. Piazza, L'intruso, Cronopio, Napoli, 2000, p. 11.
44
12
18
La sofferenza dunque non sarebbe riducibile – almeno non integralmente – ad una sottrazione46 o
confutazione del vivere, poiché questo sembra potersi cogliere in tutta la sua positività su tale fronte.
Soffrire è infatti una delle declinazioni del «linguaggio originario che si esprime per segni somatici»,
rientra fra gli «“eventi che parlano da soliˮ»47. E dato che «il modo di interrogare prescrive un certo
tipo di risposta», che il volto della sofferenza resti muto o invece comunichi un suo possibile senso
dipende da come lo si guarda e da cosa gli si chiede. Questa opportunità di comprensione è legata alla
«fede percettiva» che Merleau-Ponty raccomanda di praticare verso «tutto ciò che si offre
genuinamente» come «una esperienza-fonte»48, allo scopo di evitare il rischio di ritrovarsi tra le mani
solo delle «invarianti ideali» che non esprimerebbero null'altro se non le stesse parole con cui già in
partenza si è deciso di nominare ciò che si ha davanti. Di fronte al soffrire non si tratta allora di
scegliere tra un atteggiamento “impressionistaˮ e uno essenzialista; la vera sfida è rendersi capaci di
porsi al modo di «una specie di chiasma»49, collocandosi all'incrocio relazionale, là dove la
sofferenza fa sì che transiti una verità vivente per il soggetto.
La segnalazione o l'in-segnamento che in maniera immediata proviene dall'evento del soffrire è che
esso costituisce uno dei modi di espressione della potenza del corpo umano, partecipa cioè delle
modalità in cui l'«esuberante pienezza e possanza» del corpo si svolge «ingenuamente»50. Anche
nella sofferenza si esplica quel «quantum di energia»51 che compete ad ogni corpo vivente ed è
direzionato alla propria conservazione e affermazione: il conatus in cui Spinoza ha individuato
l'essenza attualizzante di ogni cosa, lo sforzo indefinito di cui essa vive. In altri termini, il soffrire è
un'affermazione di quell'«io posso» in cui Ricoeur colloca l'origine di ciò che rende «meraviglioso»52
il corpo dell'uomo: il fatto che la sua potenza è potenza di agire. Nucleo di libera iniziativa, l'«io
posso» indica il processo «del corpo proprio, cioè di un corpo che è anche il mio corpo», il quale ha
modo di esistere «sul punto di articolazione di un potere d'agire, che è il nostro, e di un corso di cose
46
Appunto di sottrazione di vita parla Salvatore Natoli nel suo L'esperienza del dolore. Forme del patire nella cultura
occidentale, Feltrinelli, Milano, 2002, cap. 1 Grammatica del patire. I contrassegni, pp. 7-47.
47
U. Galimberti, Il corpo, cit., pp. 353-354.
48
M. Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, Gallimard, Paris, 1964, trad. it. di A. Bonomi, Il visibile e l'invisibile,
Bompiani, Milano, 1969, pp. 189-190. Un'interessante analisi dell'inter-grammatica comunicativa del corpo umano è
presentata da Isabella Poggi in Le parole del corpo. Introduzione alla comunicazione multimodale, Carocci, Roma,
2006.
49
Ivi, p. 191.
50
F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft (1882), trad. it. La gaia scienza, in Opere, vol V, tomo II Adelphi, Milano,
1965, p. 263.
51
Ivi, p. 236.
52
Cfr. F. Nietzsche, Nachlassene Fragmente 1984-1985, trad. it. Frammenti postumi 1884-1885 , in Opere, Adelphi,
Milano, 1986, vol. VII, tomo III, p. 243: «Il corpo umano [...] ecco un pensiero più meraviglioso della vecchia
“animaˮ».
13
19
che dipende dall'ordine del mondo»53. La vita activa dell'uomo ha così la sua condizione ontologica
nella «meta-categoria dell'essere come atto e come potenza», che rende possibile l'«unità analogica
dell'agire» e la «polisemia dell'azione»54. In particolare, Ricoeur sottolinea come sia l'aristotelica
energeia-dynamis, sia la potentia di Spinoza – che «non vuol dire potenzialità, ma produttività»55 –
costituiscano il «fondo di essere, ad un tempo potente ed effettivo, sul quale si staglia l'agire umano»,
ovvero la vita di quel corpo che è «luogo di leggibilità per eccellenza di questa accezione
dell'essere»56.
Da questa angolazione prospettica sulla condizione umana emerge l'indicazione secondo cui le
odierne patologie dell'insufficienza sono percorse da una sofferenza che può anche essere oltremodo
struggente, ma che pure non di-strugge e non disfa le condizioni di possibilità dell'esistenza: essa è
ancora ricompresa nel processo della naturale felicità del corpo. Di nuovo l'approfondimento
semantico aiuta a porre in maniera adeguata la questione.
Il latino felix appartiene all'area di significato che comprende termini quali femina e fecundus; essi,
come indica Émile Benveniste, «hanno in comune questo radicale fē- che corrisponde al greco thē-, il
cui senso proprio è 'fecondità, prosperità'»57. Felicitas è cioè in relazione costitutiva con i significati
del verbo phyo (“produco, genero, nasco, germoglioˮ) e designa il dispiegarsi della physis (“essere
che cresceˮ) e della natura (participio di nascor). Riguarda tutto ciò che è fertile e può fruttificare
(felix ager, felix arbor); e se dice anche dell'esperienza antropologica è nella misura in cui vi si
riferisce come ad una «provincia»58 che ha luogo entro un'entità più vasta, in un orizzonte di vita che
la abbraccia e di cui essa non è in alcun modo il centro. L'idea originaria di felicità, sgombrata da
fuorvianti ipoteche semantiche, nomina quindi l'umano in quanto corpo che partecipa della vita della
natura, integralmente compreso nella sua incessante attività generativa; natura che non è “contestoˮ
dell'attività umana quanto sostanza stessa dell'uomo
Se il senso originario di felicità è la produttività del corpo, la sua estroversione generativa,
l'infelicitas corrisponde invece all'irrigidimento del processo del vivere in una stasi, al rapprendersi
della tensione espansiva. Essere infelici equivale ad una sorta di cattività dell'esistenza che rischia di
53
P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Seuil, Paris, 1990, trad. it. di D. Iannotta, Sé come un altro, Jaca Book, Milano,
1993, p. 198.
54
Ivi, p. 415.
55
Ivi, p. 429.
56
Ivi, p. 421.
57
É. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes. I. Économie, parenté, societé, Les Éditions de Minuit,
Paris, 1969, trad. it. di M. Liborio, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. I. Economia, parentela, società,
Einaudi, Torino, 1976, p. 143.
58
Mi riferisco alla potente suggestione che proviene dal titolo del testo di Elias Canetti Die Provinz des Menschen.
Aufzeichnungen 1942-1972, Hanser, München, 1973, trad. it. di F. Jesi, La provincia dell’uomo. Quaderni di appunti
1942-1972, Adelphi, Milano, 2006.
14
20
intrappolarsi in una tonalità emotiva, un rapporto interpersonale, un luogo, un evento, ecc. Anche il
linguaggio popolare offre un'utile indicazione in questa direzione, quando definisce infelice la
persona gravemente menomata nelle capacità di deambulare, di parlare o di ragionare: in breve, il
soggetto costretto entro margini molto limitati di esperienza e comunicazione. Ciò non significa
affatto che colui che è disabile non possa conoscere la felicità ma che, per farlo, ha bisogno di
ricevere un surplus di gesti di amore: che lo si aiuti ad esprimere le possibilità di essere che pure
porta con sé, mettendolo al riparo dal pericolo di finire «perduto in se stesso come una pietra in un
oceano»59.
Con infelicità si dovrebbe intendere il vivere che fatica a trovare spazio per prosperare e tende a
rattrappirsi e sclerotizzarsi. Questo restringimento è propriamente l'angustia che produce angoscia ed
ansia (angere), la sensazione di soffocamento che la persona infelice prova. Come prigioniera della
sua stessa passività, ella si ripiega su di sé e allenta progressivamente il suo aggancio con il mondo
delle cose e delle altre vite; mentre questo cambia il proprio assetto, la persona infelice ne viene
coinvolta in misura sempre meno rilevante e a sua volta non lo modifica in modo significativo.
L'infelicità, allora, non sarebbe riducibile banalmente ad una cupezza continua; infatti si può essere
infelici e allo stesso tempo allegri, di un'allegria che è increspatura momentanea di un mare che sotto
la sua superficie resta immobile. Seguendo un monito di Cesare Pavese, direi che l'infelice è piuttosto
una specie di «tomba»60, e che quando questa non risulta più abbastanza capiente e comincia a
chiudersi definitivamente, l'infelicità assume la gravità dell'alienazione e il soggetto inizia a “sparireˮ
dal mondo.
A questo punto sembra lecito ritenere che le depressioni diffuse nel presente non equivalgano di per
sé alla paralisi propria dell'infelicità. La loro sofferenza può essere concepita come una “lotta per la
vitaˮ che il corpo conduce con tutte le sue forze, mentre l'infelicità è l'inizio della sconfitta, il
profilarsi della disfatta esistenziale. Ci sono ovviamente forme di sofferenza depressiva che
conducono pericolosamente all'infelicità più radicale e che possono portare alla morte – la morte che
il depresso cerca e a volte trova. Tuttavia la preoccupante normalità depressiva di oggi può
ragionevolmente essere osservata con uno sguardo accogliente che vi scorga il perseverare doloroso
e, per l'appunto, faticoso delle singole vite nel tentativo di organizzare il loro essere-nel-mondo e al
mondo.
Di tale sforzo è simbolo universale la figura di Giobbe, che prova su di sé il rischio concreto di non
riuscire più a soffrire, a tollerare il peso del dolore fisico e morale – a tenerlo su e portarlo con sé.
59
60
G. Ceronetti, Sensibilità e dolore, in Id., La carta è stanca, Adelphi, Milano, 2000, p. 56.
«C'è mai stato un santo che ha salvato una sola persona? Tutti ne hanno salvate molte, hanno svolto una missione,
hanno cercato gli infelici, ma qualcuno si è mai fermato a un infelice, chiudendosi in questa tomba?»: C. Pavese, Il
mestiere di vivere. Diario 1935-1950, Einaudi, Torino, 1982, p. 76 (appunto del 15 gennaio 1938).
15
21
Egli, come suggerisce Massimo Cacciari, ardisce non tanto a misurarsi con Dio e chiedere conto dei
suoi dolori, quanto a voler conoscere se stesso: «Ciò che gli è capitato è certamente segno della sua
natura, appartiene al suo essere – e questo essere gli rimane indecifrabile»61. La “lezioneˮ che riceve
non va quindi confusa con un'ultima bastonatura che lo induce a piegare il capo ad una autorità che lo
sovrasta; consiste piuttosto nell'invito a praticare «l'umiltà nella libertà della ricerca umana»62. Dio fa
soffrire Giobbe non per sottometterlo e per godere dello spettacolo del suo sub-ire, ma perché sa che
egli – «uomo di perfetta purità»63 – saprà sostenere la vera parte che compete all'umano: il coraggio
di stare nella propria misura finita, colmandola. Coraggio che non corrisponde ad uno slancio eroico
della volontà, che Dio potrebbe placare in qualsiasi istante senza alcuna spesa; coraggio che invece è
“grazia sotto pressioneˮ64, la forza fragile che l'uomo esprime quando soffre.
4. Corpi impazienti
Grazie alla ritessitura concettuale dell'originaria costellazione semantica a cui appartiene il concetto
di felicità, si possono considerare le attuali forme depressive come vissuti di sofferenza che chiedono
e meritano non consolazioni, bensì sollievi: nell'accezione precipua del termine (sub-levare), gesti
che provvedano ad alleggerirli aiutandoli a divenire ciò che possono essere. Laddove infatti si
sapesse cogliere l'intenzionalità dei corpi che si deprimono e darle luogo, in essi si potrebbero
riconoscere i segnali non solo di un fallimento vitale ma anche di una preziosa occasione di
ricominciamento.
Si muovono in questo quadro interpretativo le argomentazioni dello psichiatra Eugenio Borgna,
secondo il quale le emozioni che compongono l'arcipelago depressivo costituiscono un «baluardo»65
nei confronti dell'asservimento al paradigma di autocomprensione esistenziale che domina le
coscienze contemporanee. Ovviamente non si tratta di celebrare presunte «meraviglie esistenziali
insite nella sofferenza psichica»66, che è e resta un frangente drammatico che chiunque vorrebbe
61
M. Cacciari, Toccare Dio, in M. Ciampa (a cura di), Domande a Giobbe. Modernità e dolore, Bruno Mondadori,
Milano, 2005, p. 106. Corsivo mio.
62
K. Jaspers, Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, Piper, München, 1962, trad. it. di F. Costa, La fede
filosofica di fronte alla rivelazione, Longanaesi, Milano, 1970, p. 468. Per un ulteriore sguardo da questa prospettiva
sulla figura di Giobbe si veda A. Poma, Parole vane. Pazienza, giustizia, saggezza: una lettura del libro di Giobbe,
Apogeo, Milano, 2005.
63
Cfr. Il Libro di Giobbe, a cura di Guido Ceronetti, Adelphi, Milano, 1972.
64
È la definizione di coraggio che circola nel libro di Ernest Hemingway Death in the Afternoon, Scribner's, New York,
1932, trad. it. di F. Pivano, Morte nel pomeriggio, Einaudi, Torino, 1967.
65
E. Borgna, Elogio della depressione, cit., p. 71.
66
È la critica che Gilberto Corbellini nel suo articolo Morire di depressione (“Il Sole 24 Oreˮ, 4 dicembre 2011) indirizza
a Borgna. Dato che quest'ultimo ribadisce in più di un passaggio di non voler affatto tributare elogi al disagio
16
22
comprensibilmente non attraversare. Non ci si può però sottrarre all'interrogativo che chiede quale
senso attribuirle nel momento in cui essa si fa esperienza comune e quotidiana. Con ragioni vivificate
da decenni di incontro col malessere anche più abissale, Borgna intravede nelle depressioni di oggi
tracce che testimoniano la praticabilità di una esistenza altra; ovverosia che «un'altra forma di vita
non solo è possibile ma è realizzabile, e si realizza, quando in noi scendano, volontariamente o
involontariamente, consciamente o inconsciamente, le ombre del dolore»67.
Si può dare corso alla suggestione di Borgna argomentando che curare questa fatica di vivere che si
colloca ai limiti esterni della dimensione patologica dovrebbe significare innanzitutto approcciarla
come una soglia di ricominciamento o risveglio attraverso cui la persona entra in contatto, doloroso
ma potenzialmente rigenerante, con le possibilità di divenire se stessa. Assumendo le precauzioni
dovute quando si tocca la sofferenza umana, si tratterebbe di far affiorare il fondo spirituale della
depressione – nell'accezione di spiritualità che Foucault ha delineato studiando le pratiche del
filosofare dell'età greca e romana. In rapporto all'indagine presente va evidenziato soprattutto uno dei
caratteri che la qualificano e che il filosofo francese articola così: «La verità è concessa al soggetto
solo a condizione che venga messo in gioco l’essere stesso del soggetto, poiché, così come egli è, non
è capace di verità»68. Oggi l'opportunità di un simile azzardo mi pare che filtri soprattutto attraverso
le ferite della depressione, quelle soglie dolorose che si aprono ovunque nella società e che si tenta
smaniosamente di tamponare. La sofferenza, insomma, può introdurre a quel tanto di verità di sé e
del mondo che serve a realizzare l'essere del soggetto, poiché con il soffrire questa verità comincia
letteralmente a prendere corpo. Affinché la pena che si prova non rimanga una tribolazione vana, una
misera «fame di vento»69, bisognerebbe quindi leggervi l'inizio di una conversione.
Il termine greco metanoia indica il mutamento del pensare e del fare che accade “dopoˮ che si è
“vedutoˮ uno scorcio di realtà precedentemente celato. L'avvicinamento alla verità di cui esso
riferisce non è praticabile senza un certo travaglio che gli è consustanziale, ma non in quanto prezzo
da pagare per il commercio con la verità o come prova da superare per mostrarsene degni agli occhi
depressivo, e visto che lo svolgimento delle sue argomentazioni conferma questa intenzione, la critica risulta legittima
solo nella misura in cui bersaglia un titolo frutto di una scelta obiettivamente infelice e fuori luogo: con tutta probabilità
motivata dalla volontà dell'Editore di utilizzare una formula capace di catturare l'attenzione del pubblico. Per
completezza si legga anche l'intervento di Pietro Barcellona in difesa del testo di Borgna: Cosa c'entra il dolore con la
democrazia?, pubblicato il 9 dicembre 2011 su www.ilsussidiario.net
67
Ivi, p. 79.
68
M. Foucault, L'herméneutique du sujet. Cours au Collège de France 1981-1982, Seuil/Gallimard, Paris, 2001, trad. it.
di M. Bertani, L'ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France (1981-1982), Feltrinelli, Milano, 2003, p. 17.
Corsivo mio. Attraverso il punto di svolta epocale che egli individua nel «momento cartesiano», Foucault vede
irrompere un nuovo paradigma filosofico che muta in profondità le condizioni della relazione tra verità e soggetto di
conoscenza: a quest'ultimo infatti non è più richiesta alcuna modificazione del proprio modo di essere, ma piuttosto la
corretta adeguazione a “protocolliˮ epistemologici; cfr. ivi, pp. 3-36 (lezione del 6 gennaio).
69
Qohélet, 4, 16: nella traduzione di Guido Ceronetti, Adelphi, Milano, 2001, p. 162.
17
23
di un'autorità che avrebbe il potere di elargirla. Il “pentimentoˮ – la paenitentia con cui nella Vulgata
è stato tradotto il biblico metanoia – dice del penare che è luogo propriamente umano di incontro con
la verità, senza gravarlo di alcun tono tragico o di autocommiserazione. Il “ravvedersiˮ è infatti il
vedere e vedersi con occhi nuovi, nuovamente capaci di verità, che inaugura la costruzione della
felicità70.
A questo punto della riflessione credo che si disponga di elementi teorici significativi ed efficaci
onde avanzare la seguente ipotesi: la sofferenza che invade gran parte delle esistenze contemporanee
non è necessariamente antitetica alla felicità e anzi la stringe ad essa un intimo legame, una
comunicazione sotterranea che va decifrata. Proprio la depressione custodirebbe infatti il segno della
felicità possibile; essa indicherebbe che la felicità non si dà dove si è stati indotti a cercarla ma
altrove, e se pure non si conoscono le coordinate di questo luogo poiché fino adesso ci si è rivolti in
altra direzione, tuttavia i propri percorsi che là conducono possono essere scorti a partire da qui, dal
soffrire che si va sperimentando.
Più precisamente, l'esperienza della depressione, se opportunamente ospitata dal soggetto,
opererebbe in lui una decisiva ricentratura di quell'ideale di autenticità che rappresenta il principale
asse categoriale e valoriale che sostiene i discorsi ideologici sulla felicità. Anche a questo proposito
si può impiegare con profitto il lavoro di Foucault.
È nota la diffidenza dello studioso verso le teorie che proclamano la necessità di “liberareˮ o
“disalienareˮ i soggetti da sovrastrutture che ingabbierebbero la loro natura autentica. Piuttosto, egli
invita a considerare fino a che punto i poteri socialmente determinanti intervengano sul nucleo
identitario a cui si vorrebbe attingere come ad una sorgente incorrotta. Di conseguenza, se con l'idea
di autenticità si intende l'accesso diretto del soggetto alla profondità di sé, l'autoevidenza e
autotrasparenza che consentono un definitivo autopossesso – la “proprietà di séˮ che il tedesco
Eigentlich suggerisce –, essa andrebbe senza meno respinta: tale esperienza “puraˮ infatti non si dà.
Tuttavia Foucault non organizza un'analisi votata a dissolvere qualsiasi forma di consistenza della
soggettività, né si limita a svolgere un'operazione esclusivamente critica71. Negli interventi dei suoi
ultimi anni di lavoro emergono sollecitazioni che rinviano ad un ambito di riflessione costruttiva e
che possono aiutare ad allentare il nodo problematico che ho messo a fuoco, per quanto questo si
collochi in una direzione di indagine che egli non ha percorso.
70
In Storia di Chiara e Francesco (Einaudi, Torino, 2011) Chiara Frugoni insiste a più riprese sul fatto che con
“penitenzaˮ si tende a significare un'opera di automortificazione, mentre il “facere paenitentiamˮ che Francesco
d'Assisi predicava, recuperando il significato originario presente nella Bibbia, consisteva nell'esortazione a modificare
con atteggiamento lieto il proprio modo di vita, avviandosi a divenire davvero felici.
71
Vincenzo Sorrentino – nel suo Il pensiero politico di Foucault, Meltemi, Roma, 2008 – ricostruisce in maniera accurata
il tragitto teorico del pensatore, soffermandosi attentamente anche sulle oscillazioni e le incongruenze che lo costellano;
si vedano in particolare i capitoli 7 e 8, pp. 215-277.
18
24
In un testo del 1982 che può essere considerato un manifesto della sua rinnovata impostazione
teorica, Foucault scrive: «Forse oggi l'obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma
piuttosto di rifiutare quello che siamo»72. Cioè a dire che il passaggio preliminare che avvia
all'esercizio delle «pratiche di libertà»73 consiste nell'abbandonare i modi di costituzione della propria
soggettività che la società favorisce con interventi che si collocano a metà strada tra concessione e
imposizione. Ma – lo si è detto – a tal fine non è possibile far affidamento su un'autocoscienza che
funzioni da principio regolatore: c'è infatti il pericolo concreto di rispecchiarsi in un'immagine di sé
già da sempre deformata. Tuttavia nella depressione – ecco la tesi che intendo sostenere – si può
riconoscere il “detonatore eticoˮ che fa saltare l'evidenza di senso degli ideali e dei modelli di vita
eterodiretti. In quanto forma di autosovversione spontanea con cui il corpo fa resistenza alle
ingiunzioni che lo bersagliano, vi si può ravvisare l'esperienza che fornisce criteri non “astrattiˮ di
autenticità, non assistiti cioè da una razionalità disincarnata e, almeno in parte, colonizzata da verità
di potere. In altre parole, nella sofferenza attuale – nel suo “prender su e portareˮ – sembra
riscontrarsi l'intersezione tra la pressione delle stratificazioni archeologiche con cui i poteri
“produconoˮ intimamente la soggettività e la proiezione teleologica che caratterizza l'umano.
Attraversata dalla «santa impazienza» che si sprigiona quando si è giunti al limite estremo di una
«lunga coabitazione con l'inabitabile»74, la vita depressa testimonia inequivocabilmente
l'impossibilità di eseguire appieno un modello di felicità insostenibile. Con il suo linguaggio doloroso
afferma che tale modello fa star male proprio perché non riesce ad ingannare del tutto la vitale
operosità del corpo e la sua “grande ragione”, pur offendendole.
Se tale congettura è valida, si riesce a guadagnare il necessario distanziamento dalle formule
critiche tipiche del libertarismo che non riescono ad intaccare il funzionamento del regime felicista,
il quale anzi le fagocita e assimila. Si può effettuare un decisivo passaggio teorico perché il problema
non sarebbe (più) di chiedersi cosa è che impedisce di essere se stessi; si affaccia invece un
interrogativo differente: in che modo posso sperimentare ciò che potrei essere? Ovvero, come devo
modificarmi per pormi nelle condizioni di far fluire il processo del mio divenire-felice? La domanda
72
M. Foucault, The Subject and the Power, Afterword, in H.L. Dreyfus-P. Rabinow, Michel Foucault: Beyond
Structuralism and Hermeneutics, The University of Chicago Press, Chicago, 1982, trad. it. di D. Benati, M. Bertani e I.
Levrini, La ricerca di Michel Foucault. Analitica della verità e storia del presente, GEF, Firenze, 1989, p. 244. Corsivo
mio.
73
Cfr. M. Foucault, L'étique du souci comme pratique de la liberté (1984), trad. it. L'etica della cura di sé come pratica
della libertà, in Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste 3. 1978-1985. Estetica dell'esistenza, etica, politica, a
cura di A. Pandolfi, Feltrinelli, Milano, 1998, pp. 273-294.
74
J.-P. Peter-J. Favret, L'animale, il pazzo, il morto, in M. Foucault (a cura di), Moi Pierre Rivière, ayant égorgé ma
mère, ma sœur et mon frère..., Gallimard, Paris, 1973, trad. it. di A. Fontana e P. Pasquino, Io, Pierre Rivière, avendo
sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello... Un caso di parricidio nel XIX secolo, Einaudi, Torino, 2000, pp. 199200.
19
25
si riconfigurerebbe attorno alla questione relativa alle modalità con cui il soggetto deve aver cura
della verità che la sofferenza gli annuncia e che lo esorta ad assumere una differente postura verso se
stesso, a stare diversamente presso di sé.
5. Continuare a nascere
Non ci si può nascondere che la fatica “ontologicaˮ propria della depressione fa presagire alla
persona che soffre una verità che potrebbe anche distillare «terrore e annientamento»75. Ciò per dire
che la linea di riflessione che ho intrapreso si muove lungo un crinale piuttosto stretto dal quale è
facile scivolare in una direzione pericolosa: sottostimare il problema della depressione, diluirlo in una
sorta di ottimismo o inutile irenismo. A ben vedere, dietro tale rischio se ne cela un altro forse ancor
più grave. Malgrado le intenzioni, si potrebbe presentare la depressione come occasione di
“indebolimentoˮ dell'io, replicando in certo modo la postura culturale che esalta una forma di
soggettività light e raccomanda una disgregazione identitaria da cui dovrebbe scaturire un soggetto
più mobile, agile e maggiormente compatibile con una realtà socio-culturale sempre più sfuggente
nei suoi riferimenti simbolici e valoriali. “Debolismoˮ che, per inciso, nell'ideologia felicista trova un
successo insperato e solo in apparenza contraddittorio.
A fronte di tali insidie è doveroso chiarire che qui intendo procedere in tutt'altra direzione e cioè
ricercare le possibilità di rendere agibile la (ri)conquista dell'integrità delle forze interiori che, come
si è visto, vengono invece abitualmente disperse. Inoltre, ho la consapevolezza di maneggiare una
questione che nella sua bruciante immediatezza non è in alcun modo padroneggiabile dalle sole
competenze filosofiche; volendo avvicinarla con la massima cautela, è opportuno pertanto ricorrere
ad alcune analisi di natura psicologica, così da precisare e consolidare l'ipotesi facendo leva anche sui
contenuti che esse mettono a disposizione.
Ma con quali dimensioni della psicologia e della psichiatria la filosofia può proficuamente
dialogare quando si interroga sulla sofferenza attuale? C'è da tener presente che la tendenza oggi
prevalente in tali settori è quella di interpretare e curare le sofferenze psicologiche soltanto in termini
di disfunzioni chimiche e neurologiche, e in nome della legittima lotta contro un ingenuo
spiritualismo spesso si giunge a lambire gli eccessi del biologismo antiumanistico. In uno scenario
che conosce la vertiginosa accelerazione delle scoperte neuroscientifiche e una complessa
divaricazione di posizioni teoriche e terapeutiche, il versante della “medicina dell'animaˮ ad indirizzo
75
«Non serve a niente dirsi la verità, sempre e soltanto la verità. La verità che non si trasforma in qualcos'altro è terrore e
annientamento»: E. Canetti, Die Fliegenpein. Aufzeichnungen, Hanser, München, 1992, trad. it. di R. Colorni, La
tortura delle mosche, Adelphi, Milano, 1993, p. 142.
20
26
fenomenologico sembra invece assicurare, in virtù della ricchezza di risorse culturali che mobilita, la
possibilità di collocare le conoscenze biologiche nell'interalità dell'orizzonte di esperienza
dell'umano. Senza tralasciare l'importanza né della componente neurobiologica che può attenere ai
disagi mentali, né del conseguente ricorso, dove necessario, a terapie farmacologiche (oltretutto
oramai sempre più raffinate), esso pare in grado di ricucire questi elementi nella trama della
questione eminentemente filosofico-esistenziale del senso: di sé, degli altri, del mondo76.
Oltretutto, l'opzione di assecondare tale orientamento consentirebbe di mettere in debito conto i
notevoli risultati conseguiti dalle ricerche scientifiche77 e, allo stesso tempo, di registrare l'eventualità
che essi alimentino un bacino di nuove ideologie. Si riesce infatti a distinguere con maggiore
chiarezza il pericolo di un rovesciamento che all'egemonia dell'anima sostituisca la dittatura di un
soma schiacciato sulla presunta neutralità di “fattiˮ comprovati. Per dirla altrimenti, ci si pone nelle
condizioni di non cedere alla falsa alternativa fra due tipi opposti di riduzionismo, dal momento che
si può fare affidamento su un'idea di corpo – quella veicolata dall'approccio fenomenologico – che
pare dischiudere la giusta «capienza antropologica»78.
76
Inaugurata da Karl Jaspers, Ludwig Binswanger ed Eugène Minkowski, la psichiatria fenomenologica non è
ufficialmente inserita nei curricula di specializzazione medica italiani. Tra i pochi medici ad averla costantemente
praticata e promossa figurano Eugenio Borgna, Danilo Cargnello, Bruno Callieri, Arnaldo Ballerini, ai quali si affianca
Umberto Galimberti in qualità di psicoanalista: per una esaustiva introduzione si veda il suo testo Psichiatria e
fenomenologia, cit. È importante tenere in considerazione che quando questo orientamento ha iniziato a svilupparsi il
suo carattere fenomenologico non implicava necessariamente «una diretta filiazione dalla filosofia fenomenologica, ma
indicava piuttosto l'appartenenza a quella corrente eterogenea della psichiatria che volle definirsi fenomenologica anche
in contrapposizione all'indirizzo clinico-descrittivo dominante dall'epoca del positivismo» (V. P. Babini, La vita come
invenzione. Motivi bergsoniani in psichiatria, il Mulino, Bologna, 1990, pp. 137-138).
77
Ad esempio, Marco Iacoboni sottolinea come il lavoro di Merleau-Ponty abbia anticipato il nuovo paradigma
neuroscientifico inaugurato dalla scoperta (a partire dagli anni Ottanta) di gruppi di neuroni, compresi quelli specchio,
la cui prerogativa è di ricreare costantemente «una mappa dello spazio che circonda il corpo» e tracciare la rete delle
sue «azioni possibili» (M. Iacoboni, Mirroring People. The New Science of How We Connect with Others, Farrar,
Straus and Giraux, New York, 2009, trad. it. di G. Olivero, I neuroni specchio. Come capiamo ciò che fanno gli altri,
Bollati Boringhieri, Torino, 2011, p. 21.)
78
È questa una suggestiva espressione che Luigi Alici utilizza nell'introdurre il volume da lui curato La felicità e il
dolore. Verso un'etica della cura, Aracne, Roma, 2010, p. 11. Aprendo una parentesi di riflessione più generale, direi
che le problematiche qui affrontate indicano, una volta di più, la necessità che la filosofia operi in sinergia con i saperi
biologici e medici, scrollandosi definitivamente di dosso il timore di vedersi sottratte le proprie prerogative culturali
dalle conoscenze empiriche. Al cospetto di traguardi scientifici fino a poco tempo fa inimmaginabili, la mole di lavoro
richiesto alla filosofia piuttosto che diminuire aumenta considerevolmente, poiché essa è ora chiamata a misurarsi con
una rinnovata comprensione delle condizioni di possibilità dell'agire; l'indagine trascendentale che le compete ha
davanti a sé un terreno di scoperta sul quale avventurarsi aggiornando creativamente il proprio bagaglio concettuale. Se
dunque, da una parte, la filosofia ha tutte le ragioni di mettere in guardia dalle sirene del nuovo riduzionismo, dall'altra
il suo allarme risulta legittimo solo se non è motivato dall'angoscia di dover abbandonare una strumentazione teorica
che – piaccia o meno – è in parte ormai inutilizzabile, perché sovente calibrata su controversie e problemi che le scienze
hanno reso obsoleti. Non c'è insomma alcuna sostituzione fatale del filosofare, ma nuove sfide che gli impongono un
mutamento epocale.
21
27
Proprio il contributo di un autorevole psichiatra che ha lungamente operato in un contesto a forte
impronta fenomenologica – Giovanni Jervis79 – può essere di aiuto allo scopo di fugare il pericolo di
un'indesiderata deriva debolista dell'argomentazione che sto svolgendo. Armato del suo consueto stile
sferzante, lo studioso smentisce la retorica che alimenta «il mito dell'io debole» e inquina una parte
della riformata cultura psichiatrica, nata da esperienze rivoluzionarie come quella di Franco Basaglia
a Gorizia, alla quale lo stesso Jervis ha fornito un apporto significativo. Vale la pena riferire una
porzione estesa del suo intervento sia perché costituisce un avvertimento rilevante nell'economia del
mio discorso, sia perché presenta un esempio di come, osservato “dal di fuori”, il filosofare offra
talvolta lo spettacolo poco edificante di un pensare che si crogiola in futili circonvoluzioni
concettuali.
«Tuttora [...] persiste in molti l'idea che sia preferibile indebolire l'io che rafforzarlo, [...] che la
normalità psichica corrente di tutti noi sia una costruzione convenzionale o addirittura un artefatto e
possa essere con vantaggio decostruita o destrutturata. [...] Alcuni considerano questi sforzi [...]
psicologicamente utili al fine di diventare meno dogmatici nella propria soggettività, più aperti a ogni
sorta di “attraversamentiˮ, molteplici, fluidi, e dunque più disponibili verso gli handicappati, gli
immigrati, e così via. Rimane però il sospetto di qualcosa di inguaribilmente velleitario ed estetizzante
in queste vecchie (e solo in parte nuove) ipotesi: [...] il loro rapporto con la realtà appare un po'
nebuloso. [...] Che aspetto hanno le persone che sono riuscite a indebolire il proprio io e a destrutturare
la propria interiore unità identitaria? [...] La sofferenza mentale, quella più comune, più triste e meno
suggestiva, consiste proprio, perlopiù, in un indebolimento dell'io, il quale indebolimento al di là di un
certo limite conduce a una vera destrutturazione della mente»80.
Jervis fa riferimento anzitutto a figure intellettuali che hanno ottenuto il loro maggior successo a
ridosso della stagione del Sessantotto: fra loro pensatori come Deleuze e Foucault, che qui sono stati
coinvolti e lo saranno anche in seguito. Pur avvallando le ragioni e le intenzioni della sua critica, mi
pare però sia necessaria una precisazione, e cioè che essa in verità andrebbe rivolta a molti interpreti
79
La ricerca dello psichiatra italiano, che nei suoi primi anni di attività ha collaborato con Ernesto de Martino, si è
organizzata attorno al fulcro del primato del corpo rispetto all'autoinganno di una coscienza che si proclama autonoma.
«L'esperienza (psicologica e razionalizzata) del nostro corpo è qualcosa di largamente culturale: il vissuto del corpo nel
mondo “civilizzato”, per esempio, non è lo stesso del vissuto del corpo in una cultura preletterata. Ma il corpo, in se
stesso, non è un vissuto: è una realtà oggettiva, ed è sostanzialmente uguale da millenni per tutti gli esseri umani. Il
corpo determina il nostro esserci, domina la nostra vita, precede la nostra coscienza di esistere, influenza le nostre
esperienze mentali, si impone con le sue esigenze e i suoi limiti, resiste a tutti i tentativi di sublimarlo: in sintesi,
mantiene il suo carattere primario» (G. Jervis, La conquista dell'identità. Essere se stessi, essere diversi, Feltrinelli,
Milano, 1997, p. 129).
80
G. Jervis, Il mito dell'io debole (1998), in Id., Il mito dell'interiorità. Tra psicologia e filosofia, a cura di G. Corbellini e
M. Marraffa, Bollati Boringhieri, Torino, 2011, pp. 176-177.
22
28
(specie italiani) che si considerano prosecutori dell'impresa filosofica dei due autori, dei quali lo
stesso psichiatra – che li ha personalmente frequentati – riconosce la serietà speculativa.
Volendo accordarsi al saggio avvertimento di Jervis, cosa si può quindi intendere appropriatamente
con l'ipotesi che la depressione rappresenti una chance di ricominciamento? Conviene continuare a
procedere sul sentiero che costeggia il limite tra il sapere filosofico e quello psicologico.
Nel testo che si colloca a metà strada del tragitto che lo ha condotto dalla psichiatria alla filosofia,
Karl Jaspers argomenta che il soggetto umano riesce a vivere solo nella misura in cui la sua esistenza
è strutturata all'interno di una personale visione del mondo capace di fornire di senso l'esperienza.
Finché il vivere scorre quietamente o almeno senza grandi perturbamenti, ciò che accade – «ed è una
cosa quanto mai immediata e naturale» – è che si riproduce «una concordanza fra l'individuo e gli
involucri dell'oggettività», tale che egli non ha ragione né occasione di porre in questione «le
istituzioni sociali, gli imperativi etici quali vigono in forza dei costumi»81. Questo scollamento ha
luogo, invece, quando la persona incontra quelle che Jaspers chiama «situazioni limite» o antinomie
dell'esistenza, che sono tutte accomunate dall'evento del soffrire82. In esse inizia a sperimentare la
dissoluzione dell'involucro che prima era avvertito come naturale ed ovvio; questo risulta ora una
specie di impedimento poiché sembra privo della «forza necessaria per offrire un punto di
appoggio»83. Si tratta di un'esperienza drammatica per il soggetto, un terremoto psicologico che può
rendere difficilissima la sua sopravvivenza o addirittura condurre al suo annientamento. La cosa
stupefacente, però, è che «durando ancora il processo di dissoluzione del vecchio involucro, l'uomo
edifica contemporaneamente involucri nuovi o abbozzi di essi»84.
Mettendo a frutto le osservazioni jaspersiane, si può affermare che la potenza di agire del corpo
umano, su cui sopra ci si è soffermati, si esprima apertamente nel processo di tale «estrinsecazione»,
al punto che esso coincide con il vivere stesso. Gli involucri e i costrutti di senso vengono così
decomposti da un processo che non è pura dissoluzione ma, esattamente, una «metamorfosi»85. È un
mutamento di questo tipo che qui ipotizzo, e insieme auspico, possa accompagnare le vicende
depressive, sollecitando uno sviluppo costruttivo della loro essenza reattiva.
81
K. Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen, Springer, Berlin, 1925, trad. it. di V. Loriga, Psicologia delle visioni
del mondo, Astrolabio, Roma, 1950, p. 326.
82
Cfr. ivi, pp. 266-326; si veda anche K. Jaspers, Philosophie. II - Existenzerhellung, Springer, Berlin, 1956, trad. it. di U.
Galimberti, Filosofia 2. Chiarificazione dell'esistenza, Mursia, Milano, 1978, cap. VII Situazioni-limite, pp. 184-227.
83
K. Jaspers, Psicologia delle visioni del mondo, cit., p. 327.
84
Ibidem.
85
Ivi, p. 328. «Senza la dissoluzione avrebbe luogo un congelamento, senza l'involucro avrebbe luogo un annientamento»
(ivi, p. 329). Da questo passaggio, come da altri, si evince quanto l'impostazione psicologica e psicopatologica di
Jaspers sia debitrice non solo nei confronti della fenomenologia husserliana ma anche verso le analisi di Kant, in
particolare quelle relative a forma e contenuto. Si veda in proposito l'interessante articolo di Chris Walker, Karl Jaspers
and Edmond Husserl. III: Jaspers as a Kantian Phenomenologist, in "Philosophy, Psychiatry and Psychology", vol. 2,
n. 1 (1995), disponibile sul portale di ricerca scientifica muse.jhu.edu.
23
29
Ad intendere il “cambiamentoˮ come immissione dell'esistenza nel corso della sua realizzazione
autentica sono anche altri modelli psicologici di interpretazione dell'umano. Per concretizzare alcuni
esempi, si può citare la «tendenza attualizzante» di cui parla lo psicologo umanista Carl Rogers, il
quale concepisce l'individuo come processo «organismico» dotato di innate capacità di
autoregolazione e integrazione che, se lasciate intimamente libere di svolgersi, muovono «nella
direzione della realizzazione e del perfezionamento dell'organismo»86. Poiché l'autocostituzione
personale non è assicurata una volta per tutte, il cambiamento o, secondo la semantica che qui
propongo, il ricominciamento avviene quando si pratica una centratura su si sé, cioè ci si produce in
una costante messa a punto dei modi di essere e del sistema di valori al fine di favorire la possibilità
di “ritrovarsiˮ in essi. La posizione di Rogers si colloca sulla stessa lunghezza d'onda del pensiero di
Jung, pur con significative differenze che qui possono essere tralasciate. Lo psicoanalista svizzero
impiega il concetto di «trasformazione» per riferirsi al mutamento che «tende all'individuazione,
ossia alla realizzazione di tutte le potenzialità dell'individuo custodite nel suo inconscio che non è,
come per Freud, solo il luogo del rimosso, ma anche il serbatoio di possibilità a venire»87. Il fattore
teorico fondamentale in entrambe le prospettive è la concezione del Sé non come struttura identitaria
rigida ma, con una formula di Gilbert Simondon, come «permanente nascita relativa»88. Nonostante
questo nascere si dia spontaneamente, esso deve essere sostenuto e favorito: è necessario che il
soggetto si ponga nelle condizioni di divenire se stesso. L'individuazione è un movimento che si offre
da se stesso e contemporaneamente rappresenta un compito arduo e dai risultati non scontati poiché,
scrive Jung, «implica un patire, una passione dell'Io [il centro del ristretto perimetro della coscienza],
cioè dell'uomo empirico [...] a cui accade di essere accolto in una più vasta sfera e di spogliarsi di
quell'ostinata autonomia che si crede libera. Egli patisce, per così dire, la violenza del Sé [la totalità
psichica dell'uomo]»89. Tale lavoro di sé su di sé si dispiega nel margine che abita la distanza mai del
tutto colmabile tra il Sé come momento principiale della vita e il Sé come meta (secondo
l'impostazione junghiana); oppure (secondo Rogers) tra gli estremi dell'unità tensionale in cui si
86
C. R. Rogers, Client Centered Therapy, Houghton Mifflin Company, Boston, 1951, trad. it. di G. C. Pessani, Terapia
centrata sul cliente, edizioni la meridiana, Molfetta, 2007, p. 375.
87
U. Galimberti, Dizionario di psicologia, cit., p. 309. Per una presentazione riassuntiva del tema si vedano le voci del
glossario che chiude Psychologische Typen (1921), trad. it. Tipi psicologici, in Opere, vol. 6, Bollati Boringhieri,
Torino, 1996.
88
G. Simondon, L'Individuation psychique et collective à la lumière des notions de Forme, Information, Potentiel et
Métastabilité, Editions Aubier, Paris, 1989, trad. it. di P. Virno, L'individuazione psichica e collettiva, DeriveApprodi,
Roma, 2001, p. 166.
89
C. G. Jung, Zur Psychologie der Trinitätsidee (1942), trad. it. Saggio d'interpretazione psicologica del dogma della
Trinità, in Opere, vol. 11, Bollati Boringhieri, Torino, 1992, pp. 155-156.
24
30
distende l'identità e da cui dovrebbe poter sorgere – «con un processo di destrutturazione e
ristrutturazione che può essere decisamente doloroso»90 – un Sé rinnovato.
Il ricominciare andrebbe insomma concepito come un passaggio duplicemente connotato: da un
lato, la persona è presa in un cambiamento generico – le “succedeˮ di cambiare –, dall'altro il
cambiamento si fa vero e proprio ricominciamento solo grazie all'agire che consapevolmente
asseconda il movimento per condurlo verso un esito “feliceˮ, cioè là dove esso procede di per se
stesso. Non c'è quindi un destino preordinato che opera alle spalle del Sé, ma piuttosto una sua
propria destinazione che va perseguita e rispetto alla quale l'esperienza depressiva fornisce
segnalazioni preziose. Il ricominciamento è allora una riconversione che possiede il senso della
restituzione – il dono di sé a sé – così come lo si trova ben espresso nel verbo spagnolo volver.
È degno di nota il fatto che uno sguardo di questo tipo, in cui si incrociano traiettorie filosofiche e
psicologiche, sia in profonda sintonia con la concezione etico-antropologica tramandata dall'antica
saggezza europea. Nel pensiero greco ed ellenistico, infatti, l'idea di physis umana comprende due
dimensioni di significato. In prima istanza, la «mera natura», come la definisce Julia Annas: l'insieme
di doti naturali e tendenze ereditarie modellato dall'intervento dell'educazione sociale, «gli aspetti che
inevitabilmente ci condizionano» poiché corrispondono ai «caratteri vitali in rapporto ai quali
dobbiamo progettare»91. Essi non andrebbero intesi come restrizioni di una vagheggiata libertà
incondizionata, quanto come le condizioni che danno luogo al nostro poter essere: come «le nostre
potenzialità di svilupparci in determinate maniere»92. In seconda istanza, la physis è concepita come
fine dello sviluppo umano, fioritura delle possibilità di vita di ognuno. Scrive Arianna Fermani, con
riferimento specifico ad Aristotele ma illuminando un elemento comune a tutto il pensare
dell'antichità: «La natura è ciò che ciascuno riceve in dotazione, ma anche ciò che viene costruito, in
quel lungo e faticoso processo di costituzione del sé che scandisce l'esistenza di ogni individuo»93.
Un processo che si snoda attraverso le scelte di vita che vanno ad edificare la hexis o l'habitus, che a
sua volta influisce sullo stile di scelta con cui si decide l'esistenza.
Dunque, per mezzo di alcuni passaggi emblematici della modernità culturale94 e riaffiorando in
settori significativi del campo psicologico, dall'antichità proviene una concezione della natura umana
90
C. R. Rogers, Terapia centrata sul cliente, cit., p. 207.
J. Annas, The Morality of Happiness, Oxford University Press, 1993, trad. it. di M. Andolfo, La morale della felicità in
Aristotele e nei filosofi dell'età ellenistica, Vita e Pensiero, Milano, 1997, p. 193
92
Ibidem.
93
A. Fermani, Vita felice umana: in dialogo con Platone e Aristotele, EUM, Macerata, 2006, p. 270.
94
Sulla storia “alternativaˮ della relazione tra natura umana, verità e trasformazione cfr. M. Foucault, L'ermeneutica del
soggetto, cit., pp. 24-27; su trasformazione e autoaffermazione in Kierkegaard, Dostoevskij e Nietzsche, si veda C.
Taylor, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Harvard University Press, Cambridge MA, 1989, trad.
it. di R. Rini, Radici dell'io. La costruzione dell'identità moderna, Feltrinelli, Milano, 1993, cap. Visioni dell'età
postromantica, pp. 515-556.
91
25
31
non scissa nei due piani comunicanti ma pur sempre separati del biologico e dello storico-culturale,
come invece si è indotti a considerare dall'idea di “natura secondaˮ che nella sensibilità
contemporanea sembra aver acquisito un'evidenza di senso difficilmente scalfibile. Il pensare antico
si riferisce ad un movimento di autocostituzione dell'umano che è allo stesso tempo circolare ed
espansivo: una linea dinamica di umanizzazione che avanza nella propria direzione solo nella misura
in cui sa tornare costantemente su di sé. È una nozione dall'immediata rilevanza normativa, tutt'altro
che neutralmente connotata, dal momento che rimanda alla capacità di formulare distinzioni
valutative. Ci si deve infatti chiedere: «che cosa nel nostro comportamento e nelle nostre disposizioni
è, insieme, naturale, dovuto a noi e corrispondente al nostro modo di svilupparci senza impedimenti?
Che cosa invece è, insieme, innaturale e dovuto a fattori esterni a noi stessi?»95; e per fattori esterni
vanno appunto intese non le determinazioni socio-culturali tout court bensì, fra loro, quelle che
risultano incongruenti con le effettive energie individuali. A ben vedere, è esattamente questa la
domanda di verità che l'esperienza della depressione oggi avanza e su cui dovrebbe sostare
l'attenzione della persona e della comunità cui appartiene.
6. Cenni conclusivi
In un intervento libero dai toni futilmente provocatori che talvolta ha assunto la sua opera, Gilles
Deleuze delinea lo schema di quella che si potrebbe denominare una “fenomenologia del divenire
umanoˮ, dove il concetto di ricominciamento che si è tentato di tracciare trova le sue giuste
coordinate di senso; è bene allora presentare un cospicuo estratto di questo brano.
«Individui o gruppi, in ogni caso siamo fatti di linee, e queste linee sono di natura molto diversa. La
prima specie di linea è di natura segmentaria, di una segmentarietà rigida; la famiglia-la professione; il
lavoro-le vacanze; la famiglia-e poi la scuola-e poi l’esercito-e poi la fabbrica-e poi la pensione. [...] Al
tempo stesso, però, abbiamo delle linee di segmentarietà molto più flessibili [...] Esse tracciano delle
piccole modificazioni, percorrono delle svolte, delineano delle cadute o degli slanci: non per questo
sono meno precise, e sono in grado di dirigere anche dei processi irreversibili [...] Sono molte le cose
che succedono su quest’ultima specie di linee, sono pluralità di divenire, di micro-divenire, pluralità che
hanno un ritmo diverso dalla nostra “storia”. Ecco perché risultano così faticose le storie familiari, i
riscontri, il ricordare, mentre tutti i nostri veri mutamenti accadono altrove, sotto un’altra politica, un
altro tempo, un’altra forma di individuazione. Certo, un mestiere è sempre un segmento rigido, e però
cos’è che accade al di sotto, quali connessioni si trovano, quali richiami o repulsioni [...], quali follie,
95
J. Annas, La morale della felicità..., cit., p. 194.
26
32
segrete e tuttavia in rapporto con incarichi pubblici, per esempio il mestiere di professore o giudice,
avvocato, ragioniere, casalinga? [...] Contemporaneamente poi esiste come un terzo tipo di linea, ancora
più strana: quasi che ci fosse qualcosa che attraverso i nostri segmenti, ma anche attraverso le nostre
soglie, ci portasse verso una destinazione sconosciuta, non prevedibile e non preesistente [...] è la linea
di fuga [...] C’è forse della gente che una simile linea non la possiede mica, disponendo soltanto delle
altre due, e c’è altra gente ancora che ha una linea soltanto e vive soltanto su quella unica linea.»96
A rendere ancora meritevole di attenzione questa riflessione è il fatto che oggi si assiste alla
complicazione di tali linee, al loro disporsi in tipologie inedite di ordito. La segmentarietà rigida
viene sistematicamente ibridata da forme di flessibilità e – per usare una categoria prettamente
deleuziana – conosce rapidi movimenti di ri-territorializzazione. Mai come ora viene in luce l'intrico
tra la dimensione strutturale e quella processuale del vivere umano, l'evidenza che l'uomo «è un
essere che diviene nel tempo in funzione della sua struttura, e che è strutturato in funzione del suo
divenire»97.
Disposte sullo sfondo interpretativo disegnato da Deleuze, le depressioni che sempre più persone
incontrano possono essere considerate le piccole e segrete “follieˮ, le incrinature che si producono
nella precedente solidità del vivere e che indicano «una soglia di diminuzione di resistenza o la salita
di una soglia di esigenza: uno non riesce più a sopportare quello che prima, ancora fino a ieri, poteva
sopportare; la suddivisione dei desideri si è modificata in noi, i nostri rapporti di velocità e lentezza
sono cambiati, un nuovo tipo di angoscia sopraggiunge»98.
Che la possibilità della felicità si dia (anche) quando il soggetto sperimenta una specie di “infrazioneˮ interna alla sua vita e venga da essa obbligato a restaurare il proprio complesso abituale di
significati e valori, la propria “dimoraˮ – secondo la consonanza semantica di ἔϑος ed ἦϑος – è del
resto un'ipotesi comune ad un gruppo di pensatori i quali, per altri versi, si muovono ciascuno lungo
direttrici di problematizzazione alquanto differenti tra loro. Jaspers, il quale nomina l'esistenza
autentica dell'uomo come essere che fa ingresso nel mondo attraverso la rottura (bruch) dell'ecsistere; questa «va dall'esistenza possibile alla sua realizzazione» e ha luogo sui margini estremi del
vivere che sono le situazioni-limite, prima fra tutte la sofferenza99. Adorno, che nella celebre chiusa
di Minima moralia afferma che il tentativo di passare dalla constatazione della disperazione della
condizione umana al «punto di vista della redenzione» sarebbe agibile qualora si riuscisse a «stabilire
96
G. Deleuze-C. Parnet, Dialogues, Flammarion, Paris, 1977, trad. it. di G. Comolli, Conversazioni, ombre corte, Verona,
1998, pp. 137-138.
97
G. Simondon, L'individuazione psichica e collettiva, cit., p. 126.
98
G. Deleuze-C. Parnet, Conversazioni, cit., pp. 139-140. Si tenga presente anche G. Deleuze, Logique du sens, Les
Éditions de Minuit, Paris, 1969, trad. it. di M. de Stefanis, Logica del senso, Feltrinelli, Milano, 2005, pp. 138-144.
99
K. Jaspers, Filosofia 2, cit., pp. 25-31.
27
33
prospettive in cui il mondo si dissesti, si estranei, riveli le sue fratture e le sue crepe»100. Canetti,
quando scrive: «Solo una cosa può salvare dalla disperazione l'uomo che ha finito per abituarsi a un
proprio modo di pensare [...] Infatti tutto ciò che egli consapevolmente elabora, tutto ciò che
quotidianamente e regolarmente porta avanti col pensiero, accresce il suo irretimento nel mondo, che
lo opprime. [...] Le sue contraddizioni devono salvarlo: la loro molteplicità, la loro imperscrutabile
insensatezza. [...] Si dovrebbe trovare il sistema delle proprie contraddizioni, raggiungendo la pace.
Se l'uomo vedesse le sbarre dell'inferriata, avrebbe conquistato il cielo che vi si apre in mezzo»101.
Inoltre Derrida, che dipinge la suggestiva immagine di un padrone di casa persuaso che la sua felicità
provenga dal fatto di essersi rinchiuso tra solide mura; quando incontra lo straniero che gli chiede
ospitalità, tutto invece cambia, e gli grida: «Presto, entra, perché ho paura della mia felicità»102.
Questo primo percorso d'indagine, in conclusione, lascia inesplorata la questione di quale sia il tipo
di terapia capace di far accadere quel ricominciamento esistenziale che la depressione odierna
inaugura; più esattamente, il carattere patologico ancora sfuggente della “fatica di essere se stessiˮ
induce a domandarsi se attualmente sia disponibile un approccio terapeutico adeguato ad essa. Senza
dubbio il disagio che oggi dilaga richiede una forma di sostegno e accompagnamento che faccia
ripartire la persona depressa e che sappia «contare su quello che c'è per ridare vita»103; con
l'avvertenza però di non utilizzare questo disagio per continuare ad alimentare il processo di
medicalizzazione dell'esistenza.
Ad ogni modo, ciò che qui ho voluto tentare è una presa in carico filosofica del fenomeno
depressivo che, data la vastità della portata e la profondità del radicamento, non può che eccedere le
frontiere delle ricerche psicologiche ed investire altri campi del sapere umanistico. Mi è parso quindi
importante provare ad enucleare la sostanza etica che attiene ad esso – intendendo con etica i modi di
100
T. W. Adorno, Minima moralia. Reflexionem aus dem beschadigtem Leben, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main,
1951, trad. it. di R. Solmi, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, Einaudi, Torino, 1994, p. 304.
101
E. Canetti, La provincia dell'uomo, cit., p. 122, 138.
102
J. Derrida-A. Dufourmantelle, De l'hospitalité, Calmann-Lévy, Paris, 1997, trad. it. di I. Landolfi, Sull'ospitalità,
Baldini & Castoldi, Milano, 2000, p. 112. Sono autori che condividono il “carattereˮ ebraico: anche il cattolico Jaspers
che, sposato a una donna ebrea, ha pagato questa prossimità culturale con l'impossibilità di continuare a lavorare nella
Germania nazista. Oltre al nomadismo del pensare e sovente anche del vivere, tali pensatori sono uniti dalla concezione
del soffrire come evento paradossale che produce l'atteggiamento di lotta e resistenza tipico dell'ebraismo, mentre la
tradizione cristiana propende invece per un'etica dell'abbandono e della pazienza. Cfr S. Natoli, L'esperienza del dolore,
cit., pp. 358-372; si veda anche l'importante saggio di Sergio Quinzio Radici ebraiche del moderno, Adelphi, Milano,
1990.
103
Julia Kristeva fornisce questa definizione di “perdonoˮ laddove vi scorge l'elemento decisivo per la buona riuscita
dell'intervento analitico rivolto alla persona depressa: «Che cos'è il tatto? Intendere bene, insieme con il perdono.
Perdono: dare di più, contare su quello che c'è per ridare vita, per concedere un nuovo inizio al paziente depresso
(questo straniero ritiratosi nella sua ferita) e offrirgli la possibilità di un nuovo incontro» (J. Kristeva, Soleil Noir:
dépression et mélancolie, Gallimard, Paris, 1987, trad. ingl. di L. S. Roudiez, Black Sun: depression and melancholia,
Columbia University Press, New York, 1989, p. 189).
28
34
essere tramite i quali i soggetti si rendono gradualmente, ma mai definitivamente, capaci di divenire
felici.
29
35
II. Misure del desiderio
1. Motivi per essere
La analisi svolte nel primo capitolo hanno mostrato che l'idea di felicità, così come sembra essersi
stabilizzata nell'attuale panorama socio-culturale, è presa nel funzionamento di quelli che ho
chiamato automatismi autorealizzativi. Ciò fa sì che l'ideale di vita felice contribuisca a replicare
pratiche di normalizzazione le quali, come una sorta di «sole nero» (per usare una bella immagine
Julia Kristeva), gettano sulle esistenze del presente l'ombra tragica della depressione.
Si tratta a questo punto di imbastire una speculazione che sappia corrispondere a tale scenario, che
da esso si lasci indicare qual è la direzione di indagine da seguire al fine di formulare un discorso
filosofico in grado di argomentare circa i modi in cui oggi l'umano può far esperienza della felicità.
Alcuni passaggi del precedente percorso hanno già segnalato questa direzione di sviluppo, laddove
è affiorata la connessione tra la questione del vivere felice e quella del desiderio, e dunque è
opportuno esplicitarla, con la consapevolezza che mettere a tema tale questione equivale ad
intraprendere una riflessione di carattere eminentemente antropologico, la quale richiede di
assumere almeno due posizioni preliminari: da un lato, la persuasione che si dia qualcosa di
definibile in termini di natura umana e che sia lecito confidare nella possibilità di comprenderne il
possibile sviluppo; dall'altro, la consapevolezza che tale natura si esprime pur sempre in modi
differenti nelle singole esistenze, le quali sono ogni volta storicamente situate. Questa seconda
avvertenza a mio parere non induce a votarsi fanaticamente al relativismo o al prospettivismo eticoculturale; piuttosto invita a non rendere categorie come quelle di felicità e desiderio costrutti di un
senso universale a partire dai quali sia possibile osservare la totalità dell'orizzonte antropologico,
dispiegato nel (e come) presente. Beninteso, ritengo che inerisca all'indagine filosofica formulare
degli universali: si tratta però di impiegarli per così dire sperimentalmente, come ipotesi di lavoro o
strumenti diagnostici che, per svolgere adeguatamente la propria funzione, devono adattarsi a ciò a
cui si applicano, e non viceversa. In proposito, Deleuze sostiene che «gli Universali non spiegano
1
36
niente, ma devono invece essere spiegati»1; più cautamente, direi che è bene calibrare tra loro – ed è
un'operazione che può rivelarsi piuttosto faticosa – due sguardi differenti sulle cose umane: l'uno
che ne segue i movimenti più ampi, le trasformazioni più clamorose, l'altro che vi cerca quelle
tendenze costanti che sarebbe assurdo negare.
Per iniziare ad investigare il desiderio umano è necessario innanzitutto ricondurlo a quella
fondamentale dimensione dell'agire rappresentata dalle motivazioni: a queste il desiderio è
intimamente correlato, senza tuttavia confondersi con esse. Mi pare si possa guadagnare una prima
comprensione di tale relazione ricorrendo a ciò che Galimberti scrive nel suo Dizionario di
psicologia, dove ordina nel modo seguente i principali modelli interpretativi delle motivazioni:
«a) l'interpretazione intellettualistica per la quale la motivazione è la tendenza determinante della
personalità cosciente che si può intendere come libera volontà (...); b) l'interpretazione biologica che
identifica senza residui la motivazione con il bisogno fisiologico (...); c) l'interpretazione istintiva,
dove, a livello umano, per istinto si intende qualcosa di più plastico e meno coercitivo di quello
animale, perché la componente innata è modificata dall'abitudine appresa; d) l'interpretazione
pulsionale nell'accezione psicoanalitica di pulsione, dove la motivazione del comportamento è da
cercare nell'ambito dell'inconscio; e) l'interpretazione antropologica che considera la motivazione il
risultato della matrice culturale in cui il soggetto nasce e cresce; f) l'interpretazione sociologica che
pone l'accento sul bisogno dell'individuo di sentirsi in sintonia con il gruppo e di valorizzare al suo
interno se stesso; g) l'interpretazione umanistico-esistenziale che fa una netta distinzione tra bisogni e
motivazioni attribuendo queste ultime all'ordine dei valori e degli ideali.»2
Tale sintesi evidenza due elementi: primo, che i termini “motivazione” e “bisogno” a ben
vedere ineriscono al medesimo campo di fenomeni e che l'utilizzo dell'uno o dell'altro dipende
sostanzialmente dal punto di vista da cui lo si osserva; secondo, che le motivazioni sono
1
G. Deleuze-F. Guattari, Qu'est-ce que la philosophie?, Les Éditions de Minuit, Paris, 1991, trad. it. di A. De Lorenzis,
Che cos'è la filosofia?, Einaudi, Torino, 2002, p. XIII.
2
U. Galimberti, Dizionario di psicologia, Utet, Torino, 1994, edizione speciale realizzata per Gruppo Editoriale
L'Espresso, 2006, p. 563. Vanno tenute presenti le riflessioni di Ricoeur in La sémantique de l'action, Éditions du
Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1977, trad. it. di A. Pieretti, La semantica dell'azione, Jaca Book,
Milano, 1986, pp. 74-83, 123-134. Un'interessante ricostruzione delle indagini sulla motivazione svolte dalla prima
“scuola” fenomenologica si trova in P. A. Masullo, Saggio sulla motivazione, Luciano Editore, Napoli, 2005. Per
un'introduzione al significato psicoanalitico e cognitivo-comportamentale della motivazione si vedano rispettivamente
W. Mertens, Psychoanalyse. Geschichte und Methoden, Oscar Beck, München, 1997, trad. it. di G. Cestone, La
psicoanalisi. Storia e metodi, Einaudi, Torino, 2000, pp. 74-89 e F. Rheinberg, Motivation, Kohlhammer, Stuttgart,
2002, trad. it. di C. Conz, Psicologia della motivazione, il Mulino, Bologna, 2003.
2
37
propriamente dei processi motivazionali che attraversano l'intero spettro delle attività
antropologiche. Lungi quindi dal doverle costringere all'interno di un unico recinto disciplinare,
ci si può tuttavia rivolgere, in prima battuta, ad un importante risultato degli studi della
psicologia a carattere umanistico.
Mi riferisco al noto schema piramidale elaborato negli anni cinquanta del Novecento da Abraham
Maslow, in cui lo studioso organizza le motivazioni umane secondo una scansione verticale3: alla
base si trovano le motivazioni fisiologiche (respiro, alimentazione, sonno, ecc.) e salendo si
presentano gradualmente le motivazioni psicologiche e sociali – dalla sicurezza (fisica,
occupazionale, familiare, ecc.) all'affetto, l'amicizia, l'intimità sessuale, sino all'autostima e, oltre, la
moralità e la creatività. Le motivazioni collocate alla base e al vertice della figura sono chiamate
rispettivamente «motivi di carenza» e «motivi dell'essere». Va rilevato che questo schema è stato
sottoposto a critiche anche aspre, inerenti soprattutto all'ordine di successione che esso presenta – la
creatività, ad esempio, è una motivazione che agisce non solo nei “piani alti” dello sviluppo. Senza
entrare nello specifico di un dibattitto che riguarda strettamente il sapere psicologico, qui è
sufficiente impiegare la figura di Maslow per visualizzare in maniera immediata come nell'umano
siano presenti tipologie differenti di agenti motivazionali e che, soprattutto, taluni bisognimotivazioni (i motivi d'essere) si attivano quando altri (i motivi di carenza) sono soddisfatti.
Quest'ultima mi sembra infatti un'evidenza difficilmente contestabile. Nessuno avverte la
motivazione a disquisire sul bello, ad allacciare relazioni sentimentali e sessuali o a formulare
progetti di affermazione personale nel caso sia denutrito o gli venga negata da giorni la possibilità
di dormire. Lo spiega bene Primo Levi descrivendo la nudità biologica a cui erano ridotti i
prigionieri dei lager nazisti, i quali non pensavano ad altro se non a procurarsi un po' di cibo e di
riparo, azzerando ogni altra specie di attività (anche nei sogni i temi ricorrenti erano quelli della
fame, del freddo, delle percosse). L'importante è non pretendere di stabilire aprioristicamente e in
modo universalmente valido “quanta” soddisfazione delle motivazioni basilari sia necessaria
affinché entrino in gioco quelle psico-sociali: si tratta di una dinamica che differisce da persona a
persona. Sempre Levi racconta che a non ridursi alla condizione di semi-animali erano quasi
esclusivamente i soggetti dotati di una coscienza temprata dall'attività politico-ideologica o dalla
fede più robusta; costoro riuscivano a preservare la capacità di avvertire la gravità giuridica e
3
Cfr. A. Maslow, Motivation and Personality, Harper, New York, 1954, trad. it. di E. Riverso, Motivazione e
personalità, Armando Editore, Roma, 1973; S. Nolen-Hoeksema, B. L. Fredrickson, G. Loftus, W. A. Wagenaar,
Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology, Cengage Learning EMEA, Andover, 2009, trad. it. a cura di C.
Mirandola, Atkinson & Hilgard's Introduzione alla psicologia (15ª edizione), Piccin, Padova, 2011, pp. 358-393.
3
38
morale di ciò che gli veniva inflitto, mentre gli altri quasi non ne soffrivano più e semplicemente
sprofondavano in quella che Elie Wiesel ha definito «la notte»4. Ciò per dire che nelle condizioni
della nostra normale quotidianità sperimentiamo la compresenza dei diversi tipi di motivazioni, ma
dal punto di vista filogenetico essi si distribuiscono secondo una progressione, che può essere
percorsa anche all'inverso, come appunto indicano le esperienze di coloro che subiscono una
prigionia prolungata e disumanizzante.
Ritengo, quindi, sia lecito sostenere che quando la persona sperimenta condizioni stabili di
sussistenza (si nutre, si ripara, riposa, ecc.) il suo vivere si apre da sé in una molteplicità di
diramazioni lungo le quali germogliano le motivazioni affettivo-relazionali e morali, ed ella inizia a
corrispondere a queste motivazioni così come corrisponde alla fame, alla spossatezza e così via.
Cioè a dire che la persona, a partire da tale germogliare, si sente appagata e “piena” non soltanto
quando spegne la tensione provocata dagli stimoli fisiologici, ma anche e soprattutto quando
allaccia relazioni affettive, svolge compiti che rivelano le sue abilità, contempla un paesaggio, ecc.
Questo significa che le motivazioni basilari e quelle psico-sociali si distinguono non perché
scaturiscono da sorgenti diverse ma perché producono conseguenze radicalmente differenti. Le
prime tendono a far chiudere l'individuo su se stesso, a stabilizzarlo in una reattività semi-animale;
le seconde invece lo aprono alla relazione attiva e costruttiva col mondo e con gli altri.
Così come ha bisogno di mangiare, un essere umano ha bisogno di amicizia, di sperimentare una
rete pur ridotta di rapporti in cui dare e ricevere rispetto, ecc.: si tratta di motivazioni che insorgono
da sole. Se poi sia possibile indicare un preciso ordine gerarchico di manifestazione dei bisogni
psico-sociali (come fanno Maslow ed altri) è questione che qui non interessa: come ho detto, è
sufficiente riconoscere che ci sono due gradazioni fondamentali dei bisogni umani, quelli fisiologici
e quelli affettivo-relazionali e morali. Invece, l'aspetto che mi sembra opportuno rilevare è che
l'insorgere delle motivazioni psico-sociali coincide con l'organizzarsi dell'agire propriamente
umano, il quale non si riduce al funzionamento di schemi comportamentali finalizzati alla
sopravvivenza. Difatti le motivazioni dell'amicizia, dell'affetto, dell'amore, del dispiegamento dei
talenti e tutte le altre si presentano nella persona come valori-scopi che, per così dire, stanno lì,
sussistono di per se stessi e le danno da fare, poiché attivano in lei «un aver da compiere o, meglio,
un aver da operare»5. Essi si manifestano attraverso un'immediata cogenza: come scrive Alessandro
4
Cfr., P. Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino, 1986; E. Wiesel, La Nuit, Les Éditions de Minuit, Paris, 1958,
trad. it. di D. Vogelmann, La notte, Giuntina, Firenze, 1995.
5
M. L. Perri, L'uomo per l'umano. Ripensare il soggetto oltre la modernità, Il lavoro editoriale, Ancona, 2002, p. 221.
4
39
Ferrara, quando li scorgiamo «ci sentiamo pressati a fare questa attribuzione, cioè ci sembra di stare
riconoscendo una qualche necessità e di “non potere fare altrimenti”»6.
Eppure, i bisogni “superiori” non sono sufficienti a dare pienamente conto della condizione
umana. L'animale non-umano deve mangiare, riprodursi, ecc. poiché i suoi atteggiamenti
scaturiscono da una matrice istintuale: una volta nato, se è fisiologicamente sano esso si comporterà
in una maniera rigidamente codificata. Invece, dire che la persona ha bisogno di mangiare, di amare
ecc. è dire che ella vuole mangiare e amare perché desidera vivere. L'animale non-umano non
desidera, semplicemente fa7; ma se la persona non desidera la vita, non fa nulla. L'umano infatti,
come ha evidenziato Gehlen, è ampiamente carente dal punto di vista della dotazione istintuale8 e
ciò comporta che esso non risulta immediatamente orientato a forme di comportamento
specializzate nel preservare le condizioni della sua sopravvivenza. Lo dimostrano ad esempio i
bambini: il loro desiderio di vivere è talmente vigoroso ed immediato che essi talvolta si
dimenticano di mangiare e quasi vivrebbero solo di esso; gli si insegna allora a mangiare, cioè si
media il loro desiderare educandoli ad un bisogno che possiede sin da subito una veste
istituzionalizzata, poiché le istituzioni socio-culturali ricoprono negli uomini la funzione che gli
istinti hanno nella vita degli altri animali9. Si può portare un altro esempio: la persona
profondamente depressa è quella in cui il desiderio di vita si affievolisce lentamente fino al punto
che ella non vuole più nutrirsi, chiacchierare, dare e ricevere affetto e così via; le manca la spinta
per compiere questi gesti.
Oltretutto, il ruolo antropologicamente fondativo del desiderare viene in luce anche grazie ad
alcune recenti scoperte in campo neurologico. Lavori come quelli di Antonio Damasio illustrano
come nel cervello umano sia presente «una collezione di sistemi coerentemente deputati a quel
processo di pensiero orientato verso un fine che chiamiamo ragionamento, e a quella selezione delle
6
A. Ferrara, L'eudaimonia postmoderna. Mutamento culturale e modelli di razionalità, Liguori, Napoli, 1992, p. 47.
«Se può essere costruito un ponte fra il concetto di valore e quello di bisogno allora potremo anche rendere conto
della validità di giudizi transchematici, transparadigmatici e transculturali, senza però dovere postulare degli assunti
metafisici» (ivi, p. 45).
7
Va detto che taluni animali, come per esempio i gorilla, sembrano avere un'esperienza di sé molto vicina a quella degli
umani.
8
Il riferimento è ovviamente a A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Junker und
Dünnhaupt, Berlin, 1940, trad. it. di C. Mainoldi, L'uomo. La natura e il suo posto nel mondo, Feltrinelli, Milano,
1983.
9
«Integrare le circostanze in un sistema di anticipazione, e i fattori interni in un sistema che regola il loro apparire,
sostituendo la specie. [...] È notte perché si dorme; si mangia perché è mezzogiorno. [...] L'uomo è un animale che si
sta spogliando della specie» (G. Deleuze, Istinti e istituzioni (1955), in L'isola deserta e altri scritti. Testi e interviste
1953-1974, Einaudi, Torino, 2007, p. 18).
5
40
risposte che chiamiamo decisione. [...] La medesima collezione di sistemi è implicata anche
nell'emozione e nel sentimento»10, che costituiscono le particolari forme espressive che il desiderio
di vivere assume. Se queste strutture cerebrali subiscono un danno grave, la persona non è più in
grado di compiere alcuna azione etica; riesce ancora a parlare, a muoversi, a contare, ad essere
presente con la coscienza, ecc., ma non si interessa più di nulla perché nulla sembra più riguardala.
Distaccata e “fredda” di fronte alla realtà, ella non ha più ragioni di scegliere di fare qualcosa
piuttosto che un'altra11.
In altri termini, il desiderio non dice alla persona che cosa deve fare, bensì la pone nelle
condizioni di decidere cosa fare. È forse questo il significato dell'affermazione aristotelica secondo
la quale la scelta – il cuore dell'azione etica – è «intelletto che desidera e desiderio che ragiona, e
tale principio è l'uomo»12. Se le cose stanno così, sarebbe opportuno parlare di desiderio o di
desiderare, ma non di desideri; si rischia altrimenti di confondere questa essenziale componente
antropologica con altri elementi quali preferenze, aspirazioni, speranze e simili, che sono tutti
contenuti cognitivi, mentre il desiderio è piuttosto un movimento corporeo – del corpo in quanto
unità somato-psichica.
La psicoanalisi insegna che il desiderio può ammalarsi, e anche gravemente; in tali casi esso si fa
distruttivo: innanzitutto per la vita del soggetto e finanche per le cose e le persone che gli sono
attorno. Ad esempio, la malattia può insorgere alle origini della storia del desiderio, poiché il
desiderio ha sempre una propria storia, che non si cambia. Esso infatti aderisce al corso di una
personale vicenda biologica e psichica e possiede ogni volta un nome e un nomos, ovvero “del suo”,
una “consuetudine”, una “melodia” interna sulla quale si accordano il pensare, il sentire e il fare che
normalmente la persona pone in essere. Sappiamo che subito dopo la sua nascita il bambino
comincia a desiderare, e il suo desiderio corrisponde sia alla Begierde di cui dice Hegel, alla brama
10
A. Damasio, Decarter's Error. Emotion, Reason, and the Human Brain, Putnam, New York, 1994, trad. it. di F.
Macaluso, L'errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Adelphi, Milano, 2005, pp. 118-119. Sul ruolo
decisivo che la dimensione emozionale ricopre nel ragionamento etico è senz'altro importante il lavoro di M.
Nussbaum, Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions, Cambridge University Press, 2001, trad. it. di R.
Scognamiglio, L'intelligenza delle emozioni, il Mulino, Bologna, 2004. Si veda anche E. Soresi, Il cervello anarchico,
Utet, Torino, 2005.
11
Con ciò non intendo sostenere che il desiderio sia da ridursi a talune funzioni neurobiologiche; esse rappresentano
condizioni che gli sono necessarie ma non sufficienti: possono cioè spiegare il desiderio, senza però esaurire la
comprensione del suo senso. A tale proposito va tenuta presente la distinzione concettuale fra erklären e verstehen
operata da Jaspers nel suo testo Allgemeine Psychopatologie, Springer, Berlin, 1913, trad. it. di R. Priori,
Psicopatologia generale, Il Pensiero Scientifico, Roma, 2000, p. 30.
12
Etica Nicomachea, VI, 2, 1139 b 3-5, a cura di C. Mazzarelli, Rusconi, Milano, 1996, p. 231.
6
41
di ciò che spegne una tensione dolorosa (la fame, il freddo)13, sia al desiderio del desiderio
dell'altro, cioè all'amore; il bambino chiedendo cibo chiede amore: gli si dà quindi amore attraverso
il nutrimento e attraverso le carezze, lo sguardo e la voce. Sappiamo anche che le risposte d'amore
che il bambino riceve in questa fase e nel corso di tutta l'infanzia influenzano in misura decisiva i
suoi modi futuri di vivere il desiderio; purtroppo talvolta accade che non si riesca a rispondere nella
“giusta” maniera, visto anche che non c'è nessuno ad insegnarla14. Nei casi delle anoressie spesso si
scopre che la madre ha sommerso la bambina con un'iper-offerta di cibo, scambiando ciò con
l'offerta di amore che intendeva farle: la bambina desiderava amore, la madre le dava solo cibo.
L'anoressia può così rappresentare una strategia patologica che una ragazza adotta per tentare di
interrompere questa relazione che non funziona e fare spazio ad un'autentica relazione di amore: “se
non mangio più, forse mia madre smetterà di considerarmi solo una bocca da riempire”15.
Dunque, è il desiderio a fare l'umano. È esso a tenerlo in vita e ad attivare e nutrire il processo di
umanizzazione-identificazione della persona, per mezzo della radicale «intenzionalità ontologica»
che lo abita, come scrive Roberto Mancini16. Ciò conduce ad una considerazione ancor più
essenziale, e cioè che è solo in virtù del suo desiderare che la persona può avvertire l'esistenza come
luogo di una felicità possibile, poiché il desiderio non è mero stimolo a conservare la vita biologica,
ma spinta a farla crescere, fiorire e maturare; è desiderare di essere-bene. In altre parole, è grazie al
nostro desiderio di vivere che iniziamo a concepire (più o meno consapevolmente) l'idea di “vita
13
«Il desiderio è la forma nella quale appare l’autocoscienza, al primo grado del proprio sviluppo. Qui [...] il desiderio
non ha ancora alcun’altra determinazione che quella dell’impulso [Trieb], nella misura in cui esso, senza essere
determinato dal pensiero, è rivolto ad un oggetto esterno, nel quale cerca soddisfazione» (G. W. F. Hegel,
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), trad. it. A. Bosi Enciclopedia delle Scienze
Filosofiche in compendio, Utet, Torino, 2005, vol. III, 268-269); cfr. Id, Phänomenologie des Geistes (1807), a cura di
V. Cicero, Rusconi, Milano, 1999, pp. 261-273.
14
Su queste tematiche un testo di riferimento classico è R. A. Spitz, The First Year of Life. A Psychoanalytic Study of
Normal and Deviant Development of Object Relations, International Universities Press, New York, 1965, trad. it. di
G. Galli e A. Galli Arfelli, Il primo anno di vita del bambino, Giunti, Milano, 2008.
15
Cfr. M. Recalcati, L'uomo senza inconscio. Figure della nuova clinica psicoanalitica, Raffaello Cortina Editore,
Milano, 2010, pp. 73-138. In frangenti come questi la persona si trova ad essere intrappolata nelle conseguenze del
vuoto di attenzioni e affetto; pertanto è solo il percorso psicoanalitico che può trarla fuori, mettendo in campo
un'opera di ristrutturazione della personalità, del suo essere-al-mondo. Il terapeuta innanzitutto offre al paziente la
possibilità di sperimentare quel che gli è sempre mancato, ovvero la preoccupazione di qualcuno che si interessa
davvero di lui, di ciò che pensa, sente e vuole; il terapeuta dà valore a tutto questo, anzi fa vedere al paziente che tutto
questo ha valore. Le teorie psicoanalitiche da tempo oramai individuano nella relazione con l'analista il primo fattore
terapeutico, mettendo così in secondo piano l'emersione di contenuti di verità inconsci: cfr. M. N. Eagle, From
Classical to Contemporary Psychoanalysis, Taylor & Francis, London, 2011, trad. it. di D. Moro, Da Freud alla
psicoanalisi contemporanea. Critica e integrazione, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2012, pp. 215-374.
16
Cfr. R. Mancini, Godimento e verità. La vocazione metafisica del desiderio, in C. Ciancio (a cura di), Metafisica del
desiderio, Vita e Pensiero, Milano, 2003, pp. 3-21.
7
42
ben vissuta” e quindi a pensare il vivere nostro e altrui secondo un modello non riparativo bensì
progettuale.
2. Una corda tesa all'infinito
Per cogliere adeguatamente la connessione interna che unisce il desiderare alla possibilità della
felicità è necessario discostarsi, almeno in parte, da quelle che sono le tre traiettorie principali di
riflessione lungo le quali la filosofia moderna e contemporanea ha pensato il rapporto tra desiderio e
vita felice. Trattandosi di contenuti noti, li si può sintetizzare nella maniera seguente.
La prima traiettoria parte da Spinoza, passa per Nietzsche e giunge fino a Deleuze. Qui il
desiderio è il conatus «col quale ciascuna cosa si sforza di perseverare nel suo essere»; tale sforzo
indefinito è l'essenza attuale della cosa stessa e, «quando è riferito insieme alla Mente e al Corpo, si
chiama Appetito»17. Il soggetto umano, al pari di ogni altro vivente, è potenza d'agire che si
intensifica se il suo conatus è determinato da un'affezione utile o buona18; il vivente accede così ad
una condizione di positività nominata come gioia19. In tale prospettiva la felicità coincide
propriamente con il campo d'esperienza a cui si riferisce il termine felicitas di cui si è trattato. A
mio giudizio questa impostazione è insufficiente perché illumina solo una metà della relazione
desiderio-felicità, ovvero si limita a considerare la felicità come aumento della vis existendi senza
dar conto della tensione teleologica che inerisce all'agire dell'uomo. Come affermato poco sopra,
ritengo infatti che la felicità corrisponda alla vita che cresce e fiorisce, le cui energie aumentano
fino a maturare.
La seconda traiettoria è quella del pensiero kantiano, notoriamente anti-eudaimonistico, dove il
desiderio è sdoppiato in una facoltà inferiore e una superiore del desiderare. La felicità si connette
17
Ethica ordine geometrico demonstrata (1677), parte terza, prop. VII e prop. IX, scolio, trad. it. di G. Durante, Etica,
Bompiani, Milano, 2007, pp. 255, 257-258.
18
Cfr. G. Deleuze, Spinoza et le problème de l'expression, Les Éditions de Minuit, Paris, 1968, trad. it. di S. Ansaldi,
Spinoza e il problema dell'espressione, Quodlibet, Macerata, 1999, pp. 169-251.
19
È bene precisare che la Wille zur Macht di Nietzsche non corrisponde esattamente alla potentia spinoziana.
Oltretutto, la concezione nitzscheana del desiderio è altalenante, oscillando fra due poli difficilmente conciliabili: da
una parte, il desiderio come espressione del bisogno di senso, certezza e conformismo che è figlio dell'istinto di
debolezza e della stanchezza vitale, e dall'altra il desiderio in quanto antidoto alla felicità intesa come sazietà. Gilles
Deleuze nella sua teorizzazione del desiderio articola il pensiero dei due filosofi facendo leva su una lettura non
convenzionale dell'opera di Nietzsche: si veda il suo Nietzsche et la philosophie, PUF, Paris, 1962, trad. it. di F.
Polidori, Nietzsche e la filosofia, Einaudi, Torino, 2002.
8
43
alla facoltà inferiore – «patologicamente determinabile» –, ovvero al desiderio sensibile (Appetitio,
Begierde), poiché essa si compone di motivi puramente empirici, incapaci di fungere da principi per
un agire che si voglia universalmente e necessariamente valido. Alla facoltà superiore inerisce
l'essere degni della felicità, cioè quello status morale che una giustizia sovraumana dovrà di
necessità premiare con la felicità vera e propria20.
La terza unisce autori come Hegel21, Heidegger, Sartre e molti altri, ed è quella predominante
nella sensibilità filosofica contemporanea. In questo caso le differenti prospettive di pensiero
tendono a convergere su un punto: l'umano desidera perché in esso c'è un vuoto ontologico che
chiede incessantemente di essere colmato e che tuttavia non è possibile riempire. Così desideriamo
ciò che non abbiamo, ma “ci manca sempre qualcosa”; anche quando il nostro desiderio raggiunge
il suo oggetto esso si placa momentaneamente per poi precipitarsi subito oltre, verso altro, in un
flusso ininterrotto. Per quanto si riconosca al desiderio una funzione antropogenica, allo stesso
tempo si ritiene che esso impedisca all'umano di fare esperienza di una qualche compiutezza; difatti,
come afferma Heidegger, il desiderio è «vagheggiamento deiettivo», cosicché «ciò che è
disponibile, di fronte al desiderato, non basta mai»22.
Si potrebbero portare numerosi esempi testuali per esemplificare questa traiettoria, ma basti
richiamare quello che scrive un autorevole pensatore contemporaneo: «Il desiderio rinvia a una
mancanza originaria che eccede tutto ciò che lo può soddisfare, che si rinnova nell'esatta misura in
cui il desiderio si colma e che senza dubbio è alla radice del bisogno [...] il desiderio non sarebbe
un'aspirazione capricciosa e facoltativa che si aggiungerebbe alle necessità del bisogno ma piuttosto
quella eccedenza (débordement) originaria, più profonda di ogni mancanza, di cui il bisogno è
soltanto la forma degradata e finita»23. In queste parole risuonano distintamente echi sartriani24, e
20
Cfr. I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft (1788), trad. it. di F. Capra, Critica della ragion pratica, Laterza,
Roma-Bari, 2001, pp. 15, 43-49; Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798), trad. it. di G. Garelli, Antropologia
dal punto di vista pragmatico, Einaudi, Torino, 2010, Libro terzo, Della facoltà di desiderare, pp. 257-292.
21
Per un approfondimento della tematica del desiderio in Hegel è prezioso lo studio di Judith Butler Subjects of Desire.
Hegelian Reflections in Twentieth-Century France, Columbia University Press, New York, 1999, trad. it. di G.
Giuliani, Soggetti di desiderio, Laterza, Roma-Bari, 2009, pp. 20-66.
22
M. Heidegger, Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1927, a cura di F. Volpi, Essere e tempo, Longanesi,
Milano, 2005, p. 238. Si veda anche F. Ciaramelli, Heidegger e il diniego del desiderio, in G. Cantillo-F. C. Papparo
(a cura di), Genealogia dell'umano. Saggi in onore di Aldo Masullo, Guida, Napoli, 2000, pp. 311-329.
23
R. Barbaras, Le désir et la distance. Introduction à une phénoménologie de la perception, Vrin, Paris, 1999, pp. 136137. In questa prospettiva sono senz'altro da tenere in considerazione le speculazioni di Emmanuel Levinas circa il
rapporto fra bisogno e desiderio: cfr. Id., De l'existence à l'existant, Vrin, Paris, 1947, trad. it. di F. Sossi,
Dall'esistenza all'esistente, Marietti, Casale Monferrato, 1986, pp. 31-44; Totalité et Infini. Essai sur l'exteriorité,
Nijhoff, La Haye, 1961, trad. it. di A. Dall'Asta, Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità, Jaca Book, Milano, 1990,
9
44
perfino la ben più lontana voce di Hobbes: «Il sommo bene [...] non si può trovare in questa vita.
Infatti, se si tratta del fine ultimo, non si desidera più nulla [...] Il massimo dei beni, pertanto,
consiste in una progressione senza impedimenti verso fini sempre più lontani. [...] La vita infatti è
un perpetuo movimento che, se non può progredire in linea retta, si svolge circolarmente»25.
Tale prospettiva coglie senza dubbio un criticità che abita l'intimo dell'esistenza; gli uomini sono
effettivamente esposti al costante rischio di non riuscire ad esperire la felicità o comunque di restare
prigionieri del «paradosso di una felicità infelice»26: e ciò non tanto a causa dell'esposizione a
contingenze sfavorevoli, della dipendenza dalla determinatezza storico-biologica, ma soprattutto in
ragione di qualcosa che afferisce originariamente al modo stesso con cui tendiamo a fare esperienza
di noi e del mondo. Tuttavia, come ora tenterò di argomentare, il pericolo di questa impasse non
deriva da una presunta mancanza originaria.
Si è detto che il desiderio nasce insieme alla nostra vita e non smette di rigenerarsi. Ricondurre
questa riproduzione incessante ad un'insufficienza d'essere equivale a voler spiegare il positivo con
il negativo: un'opzione evidentemente impraticabile. Come può il desiderio di essere generarsi dalla
mancanza di essere? A ben vedere, la direzione in cui si inoltra il discorso sul desiderio dipende
dalla prospettiva in cui si guarda alla finitezza umana. Se la si osserva dal punto di vista del suo
contrario – l'infinito – essa non può che apparire come quantitativamente e qualitativamente
imperfetta e appunto sempre mancante; con una sorta di rovesciamento logico, si pensa cioè il finito
come la negazione dell'infinito, e il suo desiderio come desiderio di essere infinito (Sartre, ad
esempio, parla di desiderio di essere Dio): è in tal modo inevitabile avvertire un tragico
struggimento pascaliano o leopardiano. Ma perché mai si dovrebbe pensare la vita umana a partire
da ciò che essa non è e non può essere? L'unica risposta plausibile è che si cerchi così di
giustificarla, guardando “dietro” di essa; ma la vita umana non ha bisogno di essere giustificata. La
finitezza va infatti pensata a partire da se stessa. Qui viene in aiuto Heidegger, che in Che cos'è
metafisica? scrive: «l'essere stesso è finito»27, e altrove aggiunge:
pp. 31-50, 58-62. Di particolare rilevanza filosofica è anche la teoria del desiderio come «mancanza ad essere»
elaborata da Lacan, seppure il suo pensiero risulti talvolta inutilmente astruso: cfr. B. Moroncini-R. Petrillo, L'etica
del desiderio. Un commentario del seminario sull'etica di Jacques Lacan, Cronopio, Napoli, 2007.
24
Cfr. J. P. Sartre, L'être et le néant, Gallimard, Paris, 1943, trad. it. di G. Del Bo, L'essere e il nulla, Bompiani,
Milano, 2002, pp. 633-680.
25
T. Hobbes, De Homine (1658), XI, 15, a cura di A. Pacchi, Laterza, Roma-Bari, 1984, p. 126.
26
L. Alici (a cura di), La felicità e il dolore. Verso un'etica della cura, Aracne, Roma, 2010, p. 9.
27
Was ist Metaphysik? (1929), trad. it. di F. Volpi, Che cos'è la metafisica?, in Id., Segnavia, Adelphi, Milano, 1987, p.
75.
10
45
«L'uomo è finito [endlich], in quanto egli ha il rapporto con l'essere e, quindi, in quanto non è egli
stesso l'essere [...]. Questa non è una carenza, bensì propriamente la determinazione della sua essenza.
Finito deve venire qui inteso nel senso greco di πέρας = limite, in quanto ciò che rende-finito-perfetta
[vollendet] una cosa in ciò che essa è, la delimita nella sua essenza e in tal modo la fa venire avanti
distinta [hervortreten].»28
Ma se anche volessimo pensare il nostro vivere a partire da una sua origine infinita (teologica,
cosmologica), non ci sarebbe alcuna buona ragione di fare di questa origine qualcosa in confronto
alla quale ciò che è finito debba considerarsi mancante. L'umiltà che il finito deve riconoscersi non
corrisponde al suo essere “degradato” in confronto ad un Altro che lo sovrasta, ma è appunto il suo
essere humilis, abitante della Terra, che è dove noi abbiamo il nostro luogo; seppure ci pensassimo
come creature di un Padre, ebbene Egli è così che ci ha voluti: così come noi siamo, allora, siamobene.
Nel desiderio, dunque, è da leggersi l'immediata espressione della nostra pienezza ontologica e
nell'eccedenza originaria di cui parla Barbaras va scorta una «grazia» che, invece di mancare,
«dona»29. Anche i diseredati, i derubati della vita non desiderano a causa di tutte le cose che
mancano loro; al contrario, soffrono questa mancanza perché li abita ancora il desiderio di vivere – i
prigionieri di cui racconta Primo Levi non venivano “sommersi” finché una piccola scintilla di
desiderio restava accesa in loro. Là dove la precarietà e la fragilità umane si fanno più atrocemente
manifeste si può comprendere al meglio che la finitezza non è un fatto, bensì una forza, e il
desiderio incarna esattamente questa forza. Poiché il limite che disegna il luogo del finito è una
«barriera benevola» che ci fa essere – giungendo ad essa, giungiamo a costituirci pienamente per
ciò che siamo30.
Pertanto, il pericolo che la felicità ci si riveli impossibile non dipenderebbe dal fatto che ci sia
negli uomini un buco ontologico nel quale il desiderio è destinato a precipitare: questa idea è una
28
Zollikoner Seminare. Protokolle-Gespräche-Briefe, Klostermann, Frankfurt am Main, 1987, trad. it. di A. Giugliano,
Seminari di Zollikon. Protocolli seminariali, colloqui, lettere, Guida, Napoli, 1991, p. 263. Sono giunto a questo
brano grazie alla lettura del bel lavoro di Carmelo Colangelo Limite e melanconia. Kant, Heidegger, Blanchot,
Loffredo Editore, Napoli, 1998.
29
Cfr. G. Deleuze-C. Parnet, Dialogues, Flammarion, Paris, 1977, trad. it. di G. Comolli, Conversazioni, ombre corte,
Verona, 1998, p. 99.
30
Si vedano le intense riflessioni che Ugo Perone svolge nei seguenti interventi: Per un'ontologia del finito, “Filosofia e
Teologia”, n. 1, 1993, pp. 49-54; Al limite del finito, in G. Ferretti (a cura di), Ermeneutiche della finitezza. Atti del
settimo colloquio su filosofia e religione. Macerata, 16 – 18 maggio 1996, Istituti Editoriali e Poligrafici
Internazionali, Pisa, 1998, pp. 207-216.
11
46
difficoltà puramente speculativa che il pensiero filosofico si è creato da sé e che discende da un
preciso paradigma antropo-teologico. Mi pare, invece, che il pericolo che la felicità rimanga
inaccessibile sia connesso ad un'inclinazione spontanea del pensare e del sentire che è necessario
imparare a governare, poiché si rischia di fare della questione del vivere felici quello che Bergson
definisce un «problema mal posto», ossia un problema che confonde cose che differiscono per
natura31. Mi riferisco alla tendenza a reputare che la felicità consista nel terminus ad quem verso cui
si dirige la proiezione del desiderio che attraversa la persona. Questa tendenza è del resto
comprensibile e, per così dire, fisiologica: desiderando avvertiamo di essere sospinti sempre più
oltre, ed è perciò quasi inevitabile ritenere che tale spinta dovrà pur farci approdare ad una meta e
che questa sarà il luogo della nostra felicità. Tuttavia, così facendo ci inganniamo; per usare
un'immagine nietzscheana, confondiamo «la forza propulsiva» del nostro vivere con i suoi obiettivi:
scambiamo cioè «il pilota della nave col vapore»32, sovrapponendo cose che andrebbero mantenute
ben distinte. Il desiderio è infatti trascendimento continuo, il dileguarsi indefinitamente in avanti in
cui è preso l'impulso vitale; è desiderare all'infinito, mentre la felicità riguarda altro, attiene
piuttosto al pieno compiersi della nostra finitezza negli scopi-valori ai quali noi dobbiamo saperla
mantenere orientata. È allora necessario scindere dall'immagine che tendiamo a farci del nostro
desiderio il concetto di fine, sia nell'accezione di compimento che di scopo, poiché questo concetto
è da riferirsi all'esperienza della felicità. È cioè un'operazione teorica indebita ed eticamente
fallimentare quella di sussumere all'idea di desiderio il concetto di un movimento attualizzante che,
appunto, non pertiene al desiderare. L'intenzionalità ontologica che è propria del desiderio possiede
un carattere utopico, è un'intenzionalità che, «nell'insolenza verso ogni pretesa definitività», va
verso «un buon luogo»33 che resta di là da venire; ma se noi sperimentano la felicità – e in effetti la
sperimentiamo – lo facciamo invece qui-e-ora. Non propongo, quindi, di misconoscere la potenza
del desiderio, che ho per l'appunto messo in risalto, ma di collocarla nella dimensione antropologica
che le è propria e che non corrisponde a quella della felicità.
31
«Si tratta, in filosofia e anche altrove, più di trovare il problema e di conseguenza di porlo, che di risolverlo»: H.
Bergson, La Pensée et le Mouvant (1934), trad. it. di G. Perrotti, Il pensiero e il movente. Saggi e conferenze, Olschki,
Firenze, 2001, p. 42.
32
F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft (1882), trad. it. in Id., Opere, vol. V, tomo II, La gaia scienza, Adelphi,
Milano, 1965, p. 236.
33
C. Danani, Idoli e ideali. Considerazioni intorno a utopia, in “Annali del Dipartimento di Filosofia e Scienze
Umane”, Università di Macerata, XXXIII, 2000, pp. 120-121.
12
47
In altri termini, la condizione felice a cui possiamo realmente accedere non equivarrebbe ad uno
status del desiderio, bensì all'esperienza della nostra vita che tramite il nostro desiderare sviluppa
una coerenza e un'unità interne rispetto ai bisogni-scopi che le riconosciamo fondamentali.
Credo che tale relazione sinergica fra desiderio di vita e telos eudaimonistico venga ben
illuminata dal confronto con un orizzonte etico-culturale dove si registra invece l'assenza
dell'anelito alla felicità: mi riferisco al pensiero tradizionale cinese, così come è presentato dal noto
sinologo Francois Jullien. Qui, la prescrizione normativa in vista del vivere bene è di imparare a
fluttuare: «Eliminando il pensiero della destinazione e quindi lasciando riassorbire l'idea della
finalità, “fluttuare” è il verbo che contraddice nel modo migliore l'aspirazione e tensione alla
felicità». La condizione ideale è quella di «non darsi alcuno scopo, e nello stesso tempo restare
sempre attivi», e cioè acquisire la capacità di «mantenersi in movimento continuo», consentendo
all'effetto dell'agire di conseguire da sé, senza averlo di mira34. Il termine che Jullien utilizza
rimanda precisamente all'area semantica in cui ho già collocato il desiderio, parlando di flusso,
dileguamento (de-liquare), navigazione: fluttuare è infatti muoversi assecondando i flutti dell'acqua,
andare avanti nella direzione in cui essi portano, senza intenzioni né obiettivi specifici.
Tuttavia, quando noi, eredi della storia del pensiero europeo, pensiamo alla felicità non ci
riferiamo alla semplice e quieta conservazione delle energie interiori, ma piuttosto
all'individuazione di un'opera rispetto alla quale impiegarle e porle in atto. È in tal senso, dunque,
che ipotizzo che realizzare la felicità equivalga a piegare, senza spezzarla, la corda tesa all'infinito
del desiderio e a legarla agli scopi-valori in cui la nostra umanità diviene matura. A fare qualcosa
del desiderio, senza lasciarlo solamente essere. Renderlo oggetto di dedizione, essergli fedeli,
divenire ansiosi al pensiero che possa consumarsi inutilmente: in una parola, averne cura35.
La felicità implica allora un lavoro, che presuppone il voler divenire felici: poiché non lo si
diventa accidentalmente, per caso o per fortuna36. Questo volere consegue alla scelta di sé, la scelta
che Jaspers chiama esistenziale:
34
F. Jullien, Nourrir sa vie à l'ècart du bonheur, Editions du Seuil, Paris, 2005, trad. it. di M. Porro, Nutrire la vita.
Senza aspirare alla felicità, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006, pp. 128-129.
35
Cfr. L. Mortari, La pratica dell'aver cura, Bruno Mondadori, Milano, 2006, cap. 5, L'essenza dell'aver cura, pp. 111152.
36
Questo è un punto essenziale della differenza che intercorre tra l'ideale eudaimonistico moderno e quello antico; oggi
infatti l'idea di felicità rimanda solitamente «non tanto a un certo periodo della vita o alla vita intera di una persona,
quanto a singoli istanti caratterizzati da forti emozioni, che spiccano emergendo dal resto» (C. Horn, Antike
Lebenskunst: Glück und Moral von Sokrates bis zu den Neuplatonikern, Beck, München, 1998, trad. it. di E. Spinelli,
L'arte della vita nell'antichità. Felicità e morale da Socrate ai neoplatonici, Carocci, Roma, 2004, p. 67).
13
48
«La decisione è qualcosa che alla volontà si offre ancora come dono; qualcosa che io, volendo, posso
realizzare, non nel senso che la posso volere, ma nel senso che da essa prende le mosse ogni mio
volere. Nella decisione, nel fatto cioè che io posso volere, colgo la libertà [...] Nella decisione
sperimento quella libertà in cui non decido solamente su qualcosa, ma anche su me stesso, e in cui non
è più possibile una separazione tra la scelta e l'io, perché io stesso sono la libertà di questa scelta.»37
Scegliendo me stesso, trasformo l'indeterminato slancio vitale in impegno stabile verso l'opera
della mia felicità – opera che consiste nel ricercare le misure del mio desiderio, ossia modi di
desiderare che si rivelino condizioni di possibilità della mia felicità.
Ciò significa che il desiderio non dovrebbe né essere abbandonato al suo spontaneismo, né fatto
oggetto di leggi e regolamentazioni estrinseche che lo frustrerebbero, producendo così rancore,
risentimento, senso di colpa e vergogna. Le sue misure sono criteri che vanno ricavati dall'interno
stesso del desiderio, dalla sua storia, mediante quell'aver cura con cui lo si impara a conoscere, da
soli e anche attraverso gli altri; nell'amicizia e nell'amore, infatti, ri-conosciamo il nostro desiderio
perché gli altri ce lo rimandano: passando per il loro stesso desiderare, esso ci diviene più
comprensibile. Nella ricerca di tali misure si esprime perciò un'istanza di valutazione del desiderio,
la necessità di saper decidere di e con esso; e dall'esito di questo decidere dipende la possibilità di
conoscere la felicità. Francesco Totaro coglie opportunamente che tale esigenza è presente, seppur
sottotraccia, anche nell'interpretazione etico-antropologica di Nietzsche; la capacità di misura funge
infatti da discrimine «tra l'autentico “sentimento di potenza” (Machtgefühl) e la smodata “libidine di
potenza” (Machtgelüst)»38.
Mi permetto di trarre dalla mia storia familiare una vicenda che a mio avviso esibisce proprio
questo esercizio di misura in vista della felicità possibile.
Una delle mie bisnonne era solita raccontare a mia nonna e a mia madre un episodio che le era
capitato diversi anni prima. Come quasi tutte le famiglie dell'epoca (il periodo sono gli anni fra le
due guerre mondiali), la sua viveva del lavoro dei campi svolto in un regime di mezzadria assai
poco equo: i proprietari terrieri, che possedevano anche le case in cui i contadini abitavano, avevano
l'abitudine di pretendere per sé più di quanto il contratto prevedesse, cioè la metà dei prodotti e
degli utili ottenuti con la coltivazione e con l'allevamento e la vendita degli animali; i contadini,
37
K. Jaspers, Philosophie. II - Existenzerhellung, Springer, Berlin, 1956, trad. it. di U. Galimberti, Filosofia 2.
Chiarificazione dell'esistenza, Mursia, Milano, 1978, pp. 167-168.
38
F. Totaro, Misura, potenza, vita in Nietzsche, in Id. (a cura di), Nietzsche tra eccesso e misura. La volontà di potenza
a confronto, Carocci, Roma, 2002, p. 61.
14
49
oltre a sfibrarsi per le immani fatiche, dovevano quindi anche difendersi da simili soprusi. La mia
bisnonna decise un giorno di cucire ed appendere delle tendine ricamate per rendere più gradevole e
decoroso l'interno della casa. La moglie del padrone, non appena vide dalla sua villa queste tendine
appese alle finestre, le mandò a dire di toglierle immediatamente, poiché esse non si “addicevano”
alla loro condizione di famiglia senza conto.
La mia bisnonna aveva senz'altro da pensare a problemi ben più urgenti delle tendine (come
mettere insieme il pranzo con la cena? Come riuscire a vestire l'intera famiglia quando non si hanno
soldi da spendere per l'abbigliamento?); eppure era percorsa da un desiderio di vivere che non le
faceva rinunciare a quei bisogni-valori di autostima e di sano orgoglio che invece tanti nella sua
stessa condizione mettevano a tacere. Per il suo desiderio trovò, almeno in questo caso, una misura:
appunto ricamare e appendere delle graziose tendine, che non davano una “parvenza” di felicità ma
erano felicità, per lei e per i suoi familiari. Non tollerando le tendine, la padrona ostacolò la loro
possibilità di essere felici, poiché in essa si esprimeva il desiderio di essere “di più” di quel che
dovevano essere: soggetti che hanno valore solo fintantoché sono in grado di lavorare e apportare
profitti.
3. Desiderio senza mondo
Edgar Morin afferma che ogni unità di cui si compone il comportamento dell'umano «è a un
tempo genetica/cerebrale/sociale/culturale/ecosistemica»39. Si tratta di un principio che Kant aveva
già individuato ben prima degli autori contemporanei. L'uomo non è mai il semplice homo natura,
perché impara ad essere uomo alla «scuola» del mondo, dove si esercita continuamente nell'utilizzo
(Gebrauch) combinato di naturalità e libertà40. Preso nell'inestricabile «connessione tra il Können
(potere) e il Sollen (dovere)», egli gioca il gioco della natura; un gioco del tutto particolare ed unico
nel regno animale, poiché consiste nel künstlicher Spiel: un giocare che va «dall'ambiguità dello
Spiel (gioco = giocattolo) all'indecisione della Kunst (arte = artificio)»41.
39
E. Morin, Le paradigme perdu: la nature humaine, Seuil, Paris, 1973, trad. it. di E. Bongioanni, Il paradigma
perduto. Che cos'è la natura umana?, Feltrinelli, Milano, 2001, p. 194.
40
Cfr. I. Kant, Antropologia dal punto di vista pragmatico, cit., Prefazione, pp. 99-102.
41
M. Foucault, Introduction à l'Antropologie, trad. it. di M. Bertani, Introduzione all'«Antropologia» di Kant, in ivi, pp.
36-37.
15
50
Collocando il discorso del desiderio sullo sfondo di questa antropologia “complessa”, si deve
rilevare che ognuno traccia i percorsi del proprio desiderare in base alla sua physis (i caratteri e le
tendenze innate) e alle determinazioni “esterne”, che concernono sia la dimensione delle cure
familiari sia il più ampio orizzonte socio-culturale a cui il soggetto deve sapersi adattare al fine di
strutturarsi in maniera adeguata. È questo orizzonte che adesso si tratta di osservare, per provare a
cogliere come oggi si desidera; per farlo è necessario soffermarsi a considerare gli inquietanti esiti
attuali della svolta epocale che si è prodotta nella “storia dei bisogni” con il maturare dell'età
moderna
Ágnes Heller sottolinea con forza che l'interpretazione dei bisogni tipici dell'umanità moderna non
può essere banalmente ridotta al progressivo insorgere dell'uomo consumatore. Richiamandosi a
Marx, afferma che «nelle epoche precapitalistiche lo sviluppo dei bisogni era limitato da una serie
di norme di condotta. Il sistema dei bisogni individuali poteva svilupparsi solo all'interno di questi
limiti prefissati»42, i quali non solo contenevano la soddisfazione dei bisogni basilari, ma più
significativamente trattenevano la fioritura umana dei soggetti, la crescita delle loro possibilità di
vita. Lo smantellamento di questi argini ha generato quella che lei definisce «la società
insoddisfatta», un'organizzazione sociale in cui gli individui non possono ritenersi mai del tutto
paghi delle loro condizioni di esistenza: ma, appunto, non soltanto sul piano dei semplici beni
materiali che si posseggono, bensì anche su quello delle aspirazioni familiari, professionali, civili,
educative e così via. La profonda mutazione che è intervenuta riguarda l'inedito carattere di
illimitatezza delle richieste umane che si produce come effetto della sinergia dei processi di
capitalizzazione, industrializzazione e democratizzazione.
«La fame di possibilità di soddisfazione sempre nuove per i nostri bisogni trascina le persone non solo
in quanto consumatori. Neanche la creazione e la rapida diffusione di nuovi bisogni sono limitate al
consumo: alcuni possibili esempi sono il bisogno d'indipendenza, d'istruzione, di un lavoro
soddisfacente. Ogni cosa pensata, fatta, ricercata nella società moderna è ugualmente in relazione con
la stessa struttura simbolica dei bisogni. L'operaio che sciopera per un maggior salario, la donna che
lotta per il riconoscimento all'interno della famiglia o per la liberazione sessuale, il radicale che mira a
trasformare il mondo intero per mezzo della rivoluzione, lo scienziato che vuole esplorare l'universo o
42
Á. Heller, The Power of Shame. Essays on Rationality, Routledge & Kegan, London, 1985, trad. it. di M. Rocci, Il
potere della vergogna, Editori Riuniti, Roma, 1985, p. 328.
16
51
eliminare tutte le malattie; sono figli della società insoddisfatta alla stessa stregua dell'uomo
consumatore che è insoddisfatto dei beni materiali a sua disposizione.»43
Questa riflessione aiuta a comprendere che ogni organizzazione sociale in qualsiasi epoca ha
sempre plasmato i bisogni degli uomini, suscitandoli o censurandoli e modificando i modi della loro
soddisfazione; ossia, i bisogni sono sempre stati in certa misura socialmente “indotti”. Il problema è
che la società capitalista e liberale – nella quale, come scrive Marx, «la produzione fornisce non
solo un materiale al bisogno, ma anche un bisogno al materiale»44 – non offre ai soggetti criteri in
base ai quali giudicare se il livello di soddisfazione dei propri bisogni sia o meno sufficiente: e
questo vale sia per quelli più futili (il bisogno di «coltelli elettrici» di cui parla Heller) sia per quelli
di segno indubbiamente positivo, che potremmo chiamare bisogni avanzati. Lo si evince
chiaramente oggi, quando pur in un frangente economico drammaticamente incerto molti sembrano
non riuscire a selezionare adeguatamente quali bisogni soddisfare e in quale grado. Fino a pochi
decenni fa ancora funzionava un criterio perlomeno minimo di gestione dei bisogni, in base a cui se
ne giudicava la soddisfazione per via negativa, mediante il paragone con le condizioni di vita della
propria infanzia e di quella dei propri genitori; la vertiginosa crescita economico-sociale, cioè,
consentiva di affidarsi alla narrazione del progresso, a quella «immagine vertebrata» della storia45
che forniva solide ragioni per ritenere che il proprio presente fosse migliore del proprio passato e
che il futuro sarebbe stato ancor più soddisfacente. Vediamo bene che ora questo tipo di fiducia non
ha più modo di prodursi nelle coscienze, giacché il futuro, sia immediato che remoto, è fonte
soprattutto di angoscia e di preoccupanti minacce su scala personale, locale e planetaria.
Oggi dunque il desiderio appare spaesato: non solo perché ha perso l'orientamento che veniva
assicurato dalle “grandi narrazioni” progressistiche della storia, ma anche a causa di un altro fattore
che solo ora emerge in tutta la sua decisività. Finché il desiderio ha potuto investire stabilmente
oggetti concreti, spazi tangibili, progetti di vita ben individuabili, persone in carne ed ossa, esso
riusciva ancora a svolgere la propria azione strutturante nel processo di soggettivazione e a
preservare una rete minima di rapporti interpersonali e comunitari. Per esemplificare, si pensi alla
situazione sociale italiana fra gli anni '50 e '70 del secolo scorso. Gli stessi soggetti fiduciosi che la
43
Ivi, p. 331.
K. Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie (1859), trad. it. di E. Cantimori Mezzomonti, Per la critica
dell'economia politica, Editori Riuniti, Roma, 1979, p. 180; Cfr. P. Prini, Il paradosso di Icaro. La dialettica del
bisogno e del desiderio, Armando, Roma, 1976, pp. 77-91.
45
R. Bodei, Cifre significanti del pensiero filosofico, in AA.VV., Exodus. Congedi dal II Millennio, Edizioni
Augustinus, Palermo, 1993, p. 17.
44
17
52
storia individuale e collettiva fosse «in costante progressione verso il meglio» (per dire con Kant)
erano attraversati da un desiderare che era in presa diretta con la realtà: lavoravano per comprare
una casa ai propri figli, per farli studiare, per far crescere la propria attività professionale, per
acquistare un'automobile con cui andare in vacanza, per dotarsi di oggetti che risultassero belli per
sé e apprezzabili agli occhi di colleghi, vicini e amici, per “far vedere” che si avevano soldi da
spendere e così via. Oggi invece il desiderio dei soggetti si muove tendenzialmente in uno scenario
irreale, perché scorre in circuiti di bisogni che non hanno più alcuna relazione con il mondo ma
soltanto con le sue immagini. Qui si deve intendere tale concetto alla maniera di Sartre: come il
prodotto dell'«atto magico» dell'immaginazione, dell'incantesimo che «fa apparire l'oggetto pensato,
la cosa desiderata, in modo che se ne possa prendere possesso»46; dunque un'immagine che è il
risultato di un'operazione di de-realizzazione. E la realtà che si riduce ad immagini è l'iper-realtà di
cui parla Baudrillard, il risultato del «delitto perfetto»47 che ha soppresso la realtà così come si era
soliti esperirla fino a non molto tempo fa.
Tale fenomeno, per quanto coinvolga tutti gli abitanti dello nostro presente, è particolarmente
evidente nelle generazioni più giovani. Restando all'esempio del lavoro, quando oggi gli studenti
devono scegliere quale corso di laurea frequentare e indirizzarsi così ad un determinato versante
professionale, fanno una gran fatica a decidersi, a prefigurarsi una tragitto esistenziale che
comprenda diversi anni e influenzi in maniera determinante il loro futuro. Ciò non accade, come
pure spesso si afferma, perché hanno “troppa scelta”, ma al contrario perché hanno troppo poco con
cui scegliere: possiedono il loro potente desiderio di vita a cui però manca il mondo. Nativi di un
orizzonte storico immobile e privo di un “fuori” a cui comparare la loro condizione, sono cresciuti
desiderando i simulacri della realtà, i suoi segni, con lo sguardo rivolto a quella metafisica degli
oggetti che oscura le cose mondane, le quali possiedono una loro vita a cui la nostra si deve
intrecciare per solidificarsi; le immagini, invece, sono inconsistenti e quando le si raduna per
riconoscersi e farsi riconoscere in esse, non offrono alcuna “quantità” ma solo un vuoto sinistro.
Soprattutto, sono stati abituati a desiderare contenuti deprivati di qualsiasi ambivalenza, poiché le
immagini che sostituiscono le effettive esperienze del mondo sono, a differenza di queste, o
totalmente “buone” o totalmente “cattive”, e ciò vale tanto per le immagini delle merci quanto per
quelle dei luoghi e delle persone. A mio parere è questo che spiega la facilità con cui i più giovani si
46
J. P. Sartre, L'imaginaire: psychologie phénomenologique de l'imagination, Gallimard, Paris, 1940, trad. it. di R.
Kirchmayr, L'immaginario. Psicologia fenomenologica dell'immaginazione, Einaudi, Torino, 2007, p. 185.
47
Cfr. J. Baudrillard, Le Crime parfait, Galilee, Paris, 1995, trad. it. di G. Piana, Il delitto perfetto. La televisione ha
ucciso la realtà?, Raffaello Cortina Editore, 1996.
18
53
ritrovano ad essere annoiati, delusi o angosciati: quando giungono a toccare effettivamente il
mondo (i suoi oggetti, i suoi luoghi, i suoi abitanti), esso per loro o non è abbastanza – è
insufficiente rispetto alle sue immagini, che sono sempre più ampie e interessanti – o è troppo
“vero”, e quindi ferisce, fa male e addirittura traumatizza.
Affinché il loro desiderare non giri perennemente a vuoto e non rimanga sempre una «orribile
intensificazione»48, è fatale che il mancato incontro con il mondo venga sovente compensato da uno
scontro con esso, da un'aggressione compulsiva nei suoi confronti dalla quale si tenta di trarre
quelle emozioni intense che altrimenti non si riesce mai ad avvertire: emozioni che in qualche modo
facciano sentire vivi. Ecco così il diffuso abuso di alcol, droghe e farmaci dopanti, e la sessualità
che diviene luogo di estorsione del corpo altrui. Questi sono per molti gli unici mezzi di
socializzazione disponibili, e tuttavia costituiscono esperienze (auto)distruttive attraverso le quali la
persona riesce a conferirsi una forma positiva soltanto in quanto «agente del nulla»49. Al di là dei
vissuti più estremi, i ragazzi tendono comunque ad essere preda di una degenerazione narcisistica
che gli impedisce di annodare il loro desiderio a qualsiasi tipo di esperienza autentica di interazione
e di comunità.
Quindi è con lo sguardo rivolto alle esistenze più giovani che si deve indagare criticamente la
situazione sociale. A tale proposito mi pare opportuno fare una precisazione. In questo capitolo e
nel precedente sono ricorso a contributi dello psicoanalista lacaniano Massimo Recalcati, il quale
denuncia la scomparsa nei soggetti contemporanei del desiderio, connessa all'esaurirsi della
dimensione inconscia. Evidentemente non mi è lecito entrare a fondo nel merito di una simile
lettura in quanto coinvolge competenze specialistiche che non possiedo; tuttavia ritengo che dal
punto di vista filosofico sia necessario avvertire che le analisi a carattere “tanatologico” risultano
sempre un po' sospette; ovvero che le “sentenze di morte” (della storia, del lavoro, del prossimo,
dell'inconscio, ecc.) rischiano di esporsi ad un eccesso di semplificazione. Suggerirei quindi di
complicare l'approccio di Recalcati con ciò che sostiene il filosofo e psichiatra Paulo Barone,
laddove scrive che la soggettività attuale, efficacemente rappresentata dalle giovani generazioni,
«pur rimanendo stretta [...] alle sole dimensioni del punto, non equivarrebbe affatto al semplice
individuo atomizzato, denudato e senza prerogative, al consumatore ottuso e saturo di godimento [...]
48
G. Deleuze-F. Guattari, L'Anti-Œdipe, Les Éditions de Minuit, Paris, 1972, trad. it. di A. Fontana, L'anti-Edipo.
Capitalismo e schizofrenia, Einaudi, Torino, 2002, p. 7: si tratta di una citazione che gli autori ricavano dal romanzo
di Lawrence La verga d'Aronne.
49
J. Butler, Soggetti di desiderio, cit., p. 42.
19
54
Nel punto in cui sparisce dovremmo scorgere concentrato anche l'acme (necessariamente immobile)
del desiderio, il vertice (inevitabilmente insignificante) dell'inconscio e del linguaggio, il colmo (per
forza di cose disorientato) della storia. In tal senso, una soggettività certamente residuale (al limite
50
della de-soggettivazione) ma per eccesso» .
Insomma, si dovrebbe evitare una lettura per così dire “post-umana” del presente. Come ho
sostenuto in apertura del capitolo, l'uomo conosce indubbiamente trasformazioni anche radicali – è
nota ad esempio la mutazione antropologica che Pasolini denunciava –, eppure la sua sostanza
naturale permane, e l'attività del desiderio appartiene in maniera costitutiva a questa sostanza. Esso
può depotenziarsi, svilirsi o, come dice Recalcati, farsi acefalo; ma non vedo come possa spegnersi
del tutto. C'è allora da prodursi in un'analisi che non rinunci alla propria lucidità e allo stesso tempo
non si abbandoni alla tentazione di decretare la totale débâcle etica, ricercando piuttosto spazi di
intervento da offrire a coloro che sono nel pieno delle forze biologiche ed ideative e che soli
possono imprimere un cambiamento sostanziale allo stato attuale delle cose.
4. Attenzione e pudore: passioni della prossimità
Quello che oggi si osserva è uno scenario dove le istituzioni sociali (famiglia, scuola, università,
organizzazioni economiche) non educano più i soggetti a gestire il loro desiderio; le necessarie
misure del desiderare, infatti, si imparano grazie ad un processo che consente alla persona di
integrare fra loro misure socialmente codificate e anonime e misure aderenti alle specifiche
esigenze della sua esistenza. Ma se la “scuola del mondo” non svolge più la propria funzione, la
persona si ritrova ad essere abbandonata a se stessa nell'assunzione di un compito che può
dimostrarsi impraticabile, col risultato che il suo desiderio rischia di dirigersi impulsivamente e
caoticamente in ogni direzione, e così smarrirsi. Tuttavia, nell'evaporare di affidabili coordinate di
senso resta pur sempre attivo il nucleo essenziale dell'esperienza umana, ovvero l'essere in relazione
con altri.
Tutto ciò che siamo e facciamo non accade mai al di fuori della nostra essenza relazionale,
rispetto alla quale non si dà alcuna esternalità possibile; a tal proposito Nancy scrive: «ciò che non è
50
P. Barone, Sparizioni. I due punti della soggettività, in “aut autˮ, n. 347 (2010), p. 143.
20
55
insieme è nel nessun-luogo-nessun-tempo del non-essere»51. Si è ricordato sopra quanto incida in
profondità la relazione originaria, quella delle cure dell'infanzia, e come essa non smetta di agire
nell'intero corso di vita della persona, qualsiasi siano le vicende che la contraddistinguono.
Nasciamo da una relazione e in relazione continuiamo a formarci, in termini somatici, psicoemotivi e morali.
Dal momento che la relazionalità è la struttura antropologica basilare, essa permane anche quando
crollano le sovrastrutture di significati e valori. Dopo questo crollo ciò che sopravvive è il «nudo
nome del nostro essere-gli-uni-con-gli-altri»52; nella desertificazione del senso, è il noi a poter
ancora fare senso. Nel tempo che stiamo vivendo, quindi, la dimensione del con-essere deve
rappresentare l'oggetto primario della cura del finito, poiché proteggere e promuovere la
relazionalità significa preservare le condizioni minime della nostra salute esistenziale; perciò oggi
l'impegno etico e politico non può che riguardare innanzitutto la cura della relazionalità.
Non si tratta però di intervenire sulla relazione, di organizzarla per mezzo di costrutti normativi.
La soggettività contemporanea (in particolare quella degli individui più giovani) sfugge infatti al
modello di soggetto con cui tuttora tendono a lavorare la filosofia, le teorie giuridico-politiche e,
almeno in parte, le scienze umane; essa cioè si sottrae alla presa di discipline che maneggiano un
paradigma umanistico le cui categorie (coscienza, responsabilità, libertà e simili) così come sono
declinate faticano a dar conto in maniera soddisfacente di esperienze di sé e del mondo ampiamente
inedite. È per tale ragione, mi pare, che porre agli uomini del presente questioni morali,
nell'accezione tradizionale del termine, equivale spesso ad in-porre esigenze che non possono che
risultare estrinseche alle loro condizioni effettive di esistenza e che di conseguenza scivolano
facilmente nel moralismo.
La cura della relazionalità, pertanto, costituisce la riparazione-preparazione della moralità;
riguarda le condizioni di possibilità del pensiero e dell'azione morali, le cui sorgenti oggi sono
prosciugate. Tale cura si deve nutrire delle energie che la relazione stessa, nella sua immediatezza,
mette a disposizione, ovvero le energie affettive, le quali custodiscono sempre una potenzialità
benefica e risanatrice.
Ovviamente l'essere-in-relazione include diversi tipi di legami. Il rapporto con i morti: sia coloro
che abbiamo conosciuto, sia coloro che non abbiamo mai incontrato (ho parlato della mia bisnonna
51
J.-L. Nancy, Être singulier pluriel, Galilée, Paris, 1996, trad. it. di D. Tarizzo, Essere singolare plurale, Einaudi,
Torino, 2001, p. 85.
52
Ivi, pp. 5. Per un commento ai tentativi di Husserl e Heidegger di delineare una “ontologia del con”, cfr. ivi, pp. 62,
85, 104.
21
56
seppure non l'abbia conosciuta e alla quale mi sento legato attraverso ciò che di lei mi viene
raccontato); il rapporto con il resto dell'umanità, che specialmente ora ci sembra di poter percepire
in un sentimento “planetario”; il rapporto con le generazioni future, anche quelle che non vedremo,
ma verso le quali ci possiamo, e dobbiamo, sentire responsabili; il rapporto con Dio che
accompagna ogni momento dell'esistenza di coloro che hanno fede; inoltre il rapporto con la natura
e in particolare con quegli esseri (animali e vegetali) che non solo ci vivono accanto ma vivono con
noi. Qui mi limiterò a riflettere sulla relazione che ci lega alle persone che possiamo toccare con
mano, ai nostri prossimi.
Laura Boella segnala che l'esperienza della prossimità poggia innanzitutto sul «sentire l'altro»,
sull'evento empatico il cui senso è di renderci capaci di riconoscere che altri sono soggetti di
esperienza come noi; empatizzare, cioè, è «il fondamento di tutti gli atti (emotivi, cognitivi, volitivi,
valutativi, narrativi) con cui entriamo in rapporto con un'altra persona»53. Piuttosto che confondersi
con essi, l'empatia è ciò che rende possibile il sorgere di sentimenti quali la simpatia, la
compassione, l'amore, la pietà54. In quanto duplice movimento dell'“entrare” nel prossimo e
lasciarsi abitare dalla sua esperienza, in quanto risonanza in noi dell'altro, nell'empatia si incarna e
si manifesta il vincolo intersoggettivo che ci costituisce ontologicamente: il quale non può
semplicemente essere compreso e professato per via astratta ma deve potersi fare esperienza viva,
grazie alla quale l'esistenza nostra e altrui conosce una nuova nascita. In altri termini, non è
sufficiente sapere che noi siamo relazione, ma bisogna soprattutto saper vivere la relazione che
siamo, farla accadere e alimentarla: insomma, entrare in prossimità con l'altro. Gli interrogativi
fondamentali che concernono l'incontro con il prossimo sono allora questi: «Come so che l’altro,
l’altra, [...] mi costituiscono e costituiscono una dimensione essenziale del mondo che mi circonda?
Una volta ammessa la realtà di altro, che tipo di relazione mi permette di viverla, di farne
esperienza? Che cosa accade a me, che cosa accade all’altro, che cosa facciamo accadere entrambi
quando ci incontriamo?»55.
53
L. Boella, Sentire l'altro. Conoscere e praticare l'empatia, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006, p. 21. A mio
giudizio, il principale merito dell'autrice è di aggiornare la linea di riflessione fenomenologica sull'empatia, cogliendo
la centralità universale di questo fenomeno e soprattutto sottraendolo agli approcci strumentali con cui spesso lo si
studia e concepisce, ad esempio nell'ambito delle tecniche terapeutiche.
54
Boella sottolinea come gli studi di Edith Stein colgano questo aspetto specifico dell'empatia, a differenza delle analisi
di Max Scheler che, incentrate sulle forme del sentire-insieme (Mitgefühl), rubricano l'atto empatico come proiezione
dell'io sull'altro.
55
Ivi, p. XXVIII. Corsivi miei. Particolarmente interessante la seguente riflessione preliminare che Boella svolge:
«nella filosofia contemporanea si è imposta la forza etica dell'altro – l'altro uomo, l'altra donna, il tu, l'ospite,
l'estraneo, il diverso, il nemico, l'amico. Portando all'estremo i limiti, gli eccessi, i punti ciechi dell'avvicinarci e
22
57
Dunque, l'empatia consiste nell'evento generatore del vissuto di prossimità, che è essenzialmente
un vissuto affettivo; quando essa accade, fa sì che il soggetto umano si configuri come «essere
socchiuso»56: il suo desiderio, passando per l'empatizzazione, diviene desiderio-per-altri, il conatus
altrimenti solipsisticamente autoconservativo investe l'esperienza altrui. A tale proposito mi sembra
si possa seguire l'indicazione di Kant, il quale scorge due modalità di espressione affettiva del
desiderare; da una parte le emozioni, da suddividersi in base al fatto che consistano in un sentimento
istantaneo di piacere o di dispiacere (il timore, la collera, la contentezza, la serenità, l'entusiasmo,
l'abbattimento, ecc.); dall'altra le passioni, che «non sono altro che desideri indirizzati da un essere
umano verso un suo simile, non verso cose»57 (odio, rancore, antipatia, ira, fiducia, amore, pietà,
ecc.). Una persona che vivesse nel totale isolamento e non avesse alcun ricordo di altri individui
avvertirebbe comunque emozioni: si arrabbierebbe perché non riesce a procurarsi cibo, sarebbe
serena dopo aver portato a termine una fatica appagante e via di seguito. Senza poter passare
attraverso l'atto empatico, il suo desiderare si esprimerebbe soltanto in emozioni, che – come scrive
Kant – sono inondazioni che ci invadono subitaneamente quando la realtà corrisponde o meno alle
nostre inclinazioni e intenzioni. Mentre la passione, che come una corrente «scava sempre più in
profondità nel suo letto»58, è una composizione affettiva, ovvero elaborazione affettiva
dell'affettività dell'altro.
In tal senso si può rilevare, ad esempio, che non possiamo nutrire passioni per personaggi
televisivi; essi magari ci avvincono emotivamente ma non possono essere oggetto della nostra pietà
o del nostro amore. La comunicazione mass-mediatica, difatti, funziona innescando forme di
affettività elementari e di breve durata: risposte affettive che si può definire empatiche solo se si
allontanarci l'un l'altro, Levinas ha fatto diventare l'altro, o meglio “altri”, la figura di un linguaggio filosofico
repentinamente cambiato. [...] La relazione con altri è stata il formidabile detonatore che ha fatto esplodere
l'ossessione del pensiero occidentale per il medesimo, la totalità, e di tutte le forme di ripiegamento del soggetto su di
sé. [...] Tuttavia, nel momento in cui l'altro ha assunto un significato metafisico e teologico, per diventare simbolo
dell'infinito, l'esperienza reale vissuta con l'altro, per l'altro, ha perso qualsiasi tratto di riconoscimento e di scambio.
[...] Può sembrare paradossale, ma in questo modo si è saturato lo spazio in cui prendono forma le relazioni
concretamente vissute. Se l'esperienza dell'altro è già da sempre avvenuta, e se è l'esperienza in generale ad essere
costituita da e in una relazione, qual è la consistenza reale dell'incontro sempre diverso e sempre avventuroso con
l'altro?» (ivi, pp. XXIII-XXV). In tale processo di disincarnazione dell'evento relazionale rientra la tradizionale
insistenza sul carattere unicamente visivo dell'incontro, a discapito delle altre dimensioni sensoriali: in proposito è di
notevole importanza l'indagine sulla «ontologia vocale» che Adriana Cavarero svolge nel suo A più voci. Filosofia
dell'espressione vocale, Feltrinelli, Milano, 2005.
56
G. Bachelard, La poétique de l'espace, PUF, Paris, 1957, trad. it. di E. Catalano, La poetica dello spazio, Dedalo,
Bari, 2006, p. 257.
57
I. Kant, Antropologia, cit., p. 276.
58
Ivi, p. 258.
23
58
considera l'empatia come la mera attivazione di sistemi neuronali, e non come l'incontro fra soggetti
umani. Invece ci appassioniamo ai protagonisti di storie letterarie poiché la lettura è un'attività
mentale che funziona mediante immedesimazione e proiezione: siamo noi stessi a definire la
fisionomia dei personaggi e dei luoghi, componendola con elementi che traiamo dal vivo della
nostra esperienza del mondo e degli altri.
L'empatia, quindi, accende la prima scintilla dell'incontro, che bisogna poi proteggere e mantenere
viva. Ci sono due passioni fondamentali capaci di far questo: l'attenzione e il pudore.
Prima di costituire uno skill cognitivo (che, com'è noto, può anche “disturbarsi”), l'attenzione è
innanzitutto passione, «desiderio che non si lascia distrarre», come afferma Ugo Perone59; desiderio
che sa concentrarsi, facendo in sé il posto per altro da sé. Desiderio pensante o pensiero desiderante,
che smette di cercare e inizia a trovare, a lasciarsi penetrare e permeare dalla «nuda verità»60
dell'altro desiderio che si fa avanti. Nell'attenzione si dà allora una duplice disposizione affettiva:
l'attendere-che, ovvero l'aspettare che l'altro accada, ci accada, e l'attendere-a, il favorire tale
accadere, il metterci del proprio affinché l'altro possa accaderci. Così l'attenzione ci mantiene pronti
all'incontro col prossimo, disposti in una postura di accoglienza; con una bella immagine di
Nietzsche, si può dire che l'attenzione ci conserva gravidi dell'altro61.
È essa a permetterci di co-rispondere alla domanda dell'altro di essere contattato da noi, e in tale
suo domandare l'altro è sempre l'estraneo. Il fare-attenzione rinvia pertanto ad una responsività nella
quale, come suggerisce Waldenfels, «è superata la sfera di un senso costituito in modo intenzionale
o comunque regolamentato», poiché ciò a cui si risponde è «una richiesta estranea, che non ha
alcun senso, né segue una regola»62; l'attenzione infatti abita un punto dell'esperienza che si trova
«al di qua del bene e del male, al di qua del diritto e del torto»63. Per poter dare una «risposta
(answer)» all'altro, quindi, devo prima sapergli offrire il mio «rispondere (response)», e cioè saper
prestare «attenzione alle offerte e alle richieste dell'altro»64.
59
U. Perone, Le passioni del finito, EDB, Bologna, 1994, p. 41.
Cfr. S. Weil, Attente de Dieu, La Colombe, Paris, 1950, trad. it. di M. C. Sala, Attesa di Dio, Adelphi, Milano, 2008,
p. 201.
61
« [...] non abbiamo nessun altro rapporto con tutto quanto è essenziale realizzazione, se non quello della gravidanza»
(F. Nietzsche, Morgenröthe. Gedanken über die moralischen Vorurteite (1881), trad. it. Aurora. Pensieri sui
pregiudizi morali, in Opere, cit., vol. V, tomo I, p. 262).
62
B. Waldenfels, Fenomenologia dell'estraneità, a cura di G. Baptist, traduzioni di R. Cristin, F. Longato, M. Failla, G.
Baptist, Vivarium, Napoli, 2002, p. 77.
63
Ivi, p. 79.
64
Ivi, p. 80.
60
24
59
Al pari dell'attenzione, il pudore rappresenta una passione virtuosa, ossia un vissuto in cui sono
fuse tra loro la dimensione del pathos e quella dell'ethos. Già Aristotele ci avverte di questo, con
quell'ambiguità che contraddistingue la sua riflessione etica e che non è altro se non espressione del
tentativo di cogliere la complessità antropologica. Arianna Fermani evidenzia che, se da un lato
Aristotele colloca il pudore nella sfera delle passioni, dall'altro lascia intendere che esso ha
comunque «una qualche tangenza con la sfera dell'hexis»65. Egli «non dice che “il pudore è un
pathos e non una hexis”, ma che esso è “più pathos che hexis”»; in tal modo il filosofo invita ad
accettare l'evidenza che questo vissuto «non è uno stato abituale, eppure che esso, per certi versi, lo
è»66. La natura ibrida del pudore consente così di tracciare dei confini piuttosto netti rispetto alla
vergogna, che è solo passione; una differenziazione che necessita di essere rimarcata poiché spesso
i due concetti vengono impiegati con eccessiva disinvoltura come fossero sinonimi, e ciò è favorito
anche dal fatto che in alcune lingue è disponibile un unico termine per nominare entrambi: per
esempio il tedesco ha solo Scham, mentre l'inglese, oltre a shame, offre anche modesty e decency,
che indicano il riserbo, un'attitudine molto vicina la pudore.67
Il concetto di vergogna si riferisce ad un'umiliazione del senso del proprio valore, ad una
mortificazione della stima di sé. Si tratta di un vissuto che presuppone un preciso contenuto di
autoriflessione, una viva coscienza di se stessi; lo psicologo Michel Lewis suggerisce di utilizzare
questi elementi di autoriflessività come criteri per discernere il vissuto affettivo in base al ruolo che
vi svolge il concetto di sé: «Per suscitare paura, gioia, disgusto, sorpresa, rabbia, tristezza e
interesse non c'è bisogno di introspezione o autoreferenzialità», mentre la gelosia, l'invidia,
l'orgoglio, l'imbarazzo, la vergogna «per attivarsi richiedono un riferimento a se stessi, cioè
65
A. Fermani, Aristotele e i profili del pudore, in “Rivista di Filosofia Neo-Scolastica”, n. 2-3 (2008), p. 188. I passi
presi in esame sono Etica Nicomachea II, 7, 1108 a 31-32 e IV, 9, 1128 b 10-11. Per un'analisi del significato di aidos
si consideri anche E. Irrera, Immagini della vergogna tra Antico e Moderno, in “Intersezioni. Rivista di storia delle
ideeˮ, n. 1 (2007), pp. 5-22.
66
Ivi, p. 189.
67
Le analisi che ricostruiscono la genealogia del nesso pudore-vergogna si sviluppano in due direttrici principali: quella
sociologica di Norbert Elias, il quale fa riferimento al processo di civilizzazione (Über den Prozess der Zivilisation. I.
Wandlungen des Verhaltens in den Weltlichen Oberschichten des Abendlansen, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1969,
trad. it. di G. Panzieri, La civilità delle buone maniere, il Mulino, Bologna, 1982) e quella antropologico-culturale di
Hans Peter Duerr (Der Mythos der Zivilisationproceß. I. Nackheit und Scham, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1988,
trad. it. di G. Benedetti, Nudità e vergogna. Il mito del processo di civilizzazione, Marsilio, Venezia, 1991). Per
un''interessante gamma di riflessioni sul pudore si veda M. L. Perri (a cura di), Il pudore tra verità e pratica, Carocci,
Roma, 2005.
25
60
l'introspezione»68. Vergognandoci di un gesto, di una frase o di un atteggiamento ci vergogniamo di
noi stessi, di essere ciò che siamo; la vergogna, infatti, scatta a partire da un pretesto specifico per
poi investire l'interezza della persona: ci si sente perciò inadeguati, buoni a nulla, indegni, a causa di
un generale pronunciamento negativo su di sé. Da qui l'impulso a fuggire, nascondersi (tipico il
gesto di portarsi le mani al volto), a volersi “scavare una fossa”.
Perché ci sia vergogna è necessaria la presenza di un altro soggetto la cui opinione su di noi
riteniamo particolarmente importante: soggetto che può essere presente sia in carne ed ossa sia in
abstracto, nella proiezione immaginativa o nel ricordo (“cosa penserebbe di me se mi vedesse
ora?”). È questo un elemento comune anche al senso di colpa, il quale però si riferisce
specificamente alle conseguenze negative (reali o supposte) sugli altri del nostro comportamento; il
ruolo che l'altro gioca nella vergogna e nella colpa è quindi differente, poiché nella prima «l'altro ha
il ruolo attivo (l'umiliatore) e chi si vergogna è posto nel ruolo passivo di umiliato», mentre nella
seconda «l'altro occupa il ruolo passivo di vittima e chi si sente in colpa il ruolo attivo o comunque
causale»69. Se nel nostro orizzonte socio-culturale è sempre più raro avvertire il senso di colpa – in
conseguenza del venir meno della fonti e figure di autorità –, è invece molto diffusa la vergogna,
dal momento che essa è una passione tipica del narcisismo: un registro psichico, quest'ultimo, dagli
spiccati tratti conformistici nel quale la stima di sé è affannosamente, e spesso disperatamente,
ricercata nelle conferme da parte degli altri di ciò che si è e si fa. Da qui la facilità con cui il
soggetto narcisista diventa depresso, poiché «nella sua fondamentale megalomania, non può
ammettere le proprie insufficienze, non può ammettere di sentirsi limitato dalla realtà»70.
Anche l'inedita tipologia contemporanea di vergogna – che la sociologa Turnaturi definisce
efficacemente «vergogna fai-da-te»71 – è una configurazione affettiva che tende a precludere la
relazione di prossimità, a renderla affannosa o addirittura impraticabile72. Il pudore, all'opposto,
68
M. Lewis, Shame. The Exposed Self, Free Press, New York, 1992, trad. it. di G. Noferi, Il sé a nudo. Alle origini della
vergogna, Giunti, Firenze, 1995, p. 27.
69
M. W. Battacchi, Vergogna e senso di colpa. In psicologia e nella letteratura, Raffaello Cortina Editore, Milano,
2002, pp. 84-85. Un'utile introduzione al tema della colpa è offerta da Pier Paolo Portinaro nel volume da lui curato I
concetti del male, Einaudi, Torino, 2002, pp. 53-67.
70
Si tratta di una considerazione dello psicoanalista Louis Dujarier citata da Ehrenberg nel suo La fatigue d'être soi.
Depression et société, Éditions Odile Jacob, Paris, 1998, trad. it. di S. Arecco, La fatica di essere se stessi.
Depressione e società, Einaudi, Torino, 2010, pp. 177-178.
71
Cfr. G. Turnaturi, Vergogna. Metamorfosi di un'emozione, Feltrinelli, Milano, 2012.
72
È necessario precisare che da alcuni interpreti la vergogna è considerata come un'esperienza dotata anche di
potenzialità positive; ad esempio, Axel Honneth ritiene che la vergogna che scaturisce in conseguenza della
mortificazione del valore di un singolo o di un gruppo possa fungere da base pulsionale e motivazionale per un agire
che ristabilisca le condizioni minime di riconoscimento reciproco (cfr. A. Honneth, Kampf um Anerkennung.
26
61
agisce in favore della relazionalità, in una duplice modalità. La prima è ampiamente argomentata
dall'interpretazione più diffusa in campo filosofico, che intende il pudore come quel sentire reattivoprotettivo che si accende quando la persona si trova ad essere oggetto dello sguardo reificante
dell'altro. Qui il pudore equivale all'«inizio dell’ira contro qualcosa che non deve essere», come
sostiene Hegel73, e cioè all'opporsi ad una modalità di incontro in cui l'intero del nostro essere
rischia di venire ridotto ad un suo unico aspetto; per cui si è pudici quando si coprono le parti più
intime del proprio corpo, poiché su di esse si fissa immediatamente lo sguardo altrui, e anche
quando si sceglie di non svelare tutto di se stessi nelle parole o nei gesti che rivolgiamo agli altri. In
entrambi i casi, l'atteggiamento del pudore preserva la ricchezza e la complessità della nostra
natura, la sua sacralità74. L'altra modalità con cui il pudore favorisce la prossimità – e che mi pare
resti solitamente un po' in ombra nelle riflessioni – è la sua azione propositiva rispetto alla relazione
interpersonale; esso non si limita a far sì che l'incontro non degeneri in una violazione dell'intimità
ontologica, ma, se assunto come «stile dell'azione»75, predispone all'incontro, agendo come cura
preventiva della prossimità. Difatti non riusciamo ad incontrare davvero gli altri se non siamo
capaci di trovare la giusta distanza fra noi e loro, se non approntiamo lo spazio ed il tempo adeguati
affinché noi possiamo incontrare gli altri e loro noi. Questa buona distanza, poi, non è identica per
tutti, così che ognuno deve individuare la propria mediante una pratica costante. Lo afferma con
chiarezza la psicoanalista Monique Selz:
«Attraverso la sua fondamentale azione nel processo di separazione-individuazione [...] [il pudore]
consente il fondarsi della differenza fra gli individui, riservando in tal modo, o cercando di riservare,
uno spazio di discontinuità fra gli esseri, sempre precario, ma indispensabile [...] La precarietà di tale
spazio fa sì che possa essere mantenuto solo se ognuno si occupa costantemente di sé e dell'altro. Di
conseguenza, prima di essere un dovere morale, il pudore è una necessità vitale.» 76
Grammatik sozialer Konflikte, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1992, trad. it. di C. Sandrelli, Lotta per il
riconoscimento. Proposte per un'etica del conflitto, il Saggiatore, Milano, 2002, pp. 158-166).
73
G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Aesthetik (1836), trad. it. di N. Merker e N. Vaccaro, Estetica, Feltrinelli,
Milano, 1963, p. 978. Nel suo Corpo e persona (Marietti, Genova, 1987, p. 49) Virgilio Melchiorre scrive che il
pudore corrisponde alla «difesa di quella duplicità intenzionale che vive il corpo come unità di oggetto e di soggetto»
74
Guido Ceronetti giustamente osserva che «il senso vero di τά αἰδοία è le cose che ispirano reverenza [...] La parola
greca esprime rispetto che non osa avvicinarsi, non bruttura da nascondere» (G. Ceronetti, Il silenzio del corpo,
Adelphi, Milano, 1994, 130).
75
A. Tagliapietra, La forza del pudore. Per un filosofia dell'inconfessabile, Rizzoli, Milano, 2006, p. 43.
76
M. Selz, La Pudeur, un lieu de la liberté, Buchet/Chastel, Paris, 2003, trad. it. di S. Pico, Il pudore. Un luogo di
libertà, Einaudi, Torino, 2005, p. 128. Direi che questa capacità generativa, e non solo riparativa, del pudore rispetto
alla relazionalità consente la preservazione di quel “tra” in cui Luce Irigaray vede il nucleo energetico che alimenta
27
62
Ecco allora che il pudore è pathos che nasce nell'incontro ed hexis che permette di continuare ad
incontrare le altre persone in maniera sempre più virtuosa, e cioè benefica per noi e per loro. Come
l'attenzione, il pudore rappresenta quindi un irrinunciabile esercizio di misura del proprio
desiderare. Entrambi lavorano incessantemente alla tessitura di una rete di desiderio che sostiene e
protegge la relazionalità e costituisce la matrice da cui sola può scaturire (nuovamente) l'agire
morale, ovvero l'agire che ha in sé le forze necessarie per fare-bene, per realizzare quel bene che è
tale solo se è di e per tutti.
l'autentica relazione d'amore: «La parola tra sostituisce l'attrazione dell'istinto o della somiglianza. [...] “Ti riconosco”
suppone che io non possa vederti totalmente. Tu non mi sarai mai completamente visibile [...]. Quello che non vedo di
te mi spinge verso di te se tu ti preservi, e se la tua energia mi permette di preservare e di elevare la mia energia
insieme a te. Vado verso di te come ciò che non vedrò ma che mi attira [...]. Vado verso ciò che mi permette di
divenire pur restando me stessa(o). La trascendenza, quindi, non è più estasi, uscire fuori da sé verso un
completamente-altro inaccessibile, oltre-sensibile, oltre-terra. È rispetto dell'altro che io non sarò mai, che mi è
trascendente e al quale io sono trascendente» (J'aime à toi. Esquisse d'une félicité dans l'Histoire, Grasset &
Fasquelle, Paris, 1992, trad. it. di P. Calizzano, Amo a te. Verso una felicità nella Storia, Bollati Boringhieri, Torino,
1993, p. 108).
28
63
III. Ritmi della felicità
1. Le macerie e le tracce
Nei capitoli precedenti ho tentato di fornire una lettura originale (almeno in parte) della relazione
che connette la domanda di felicità alle dimensioni antropologiche del soffrire e del desiderare, e
nel far questo ho potuto attingere ad un vasto repertorio di teorie, analisi ed intuizioni, appartenenti
sia all'ambito filosofico sia, più in generale, all'orizzonte delle scienze umane. Qui, invece, mi
inoltro in un territorio di indagine assai meno battuto e di conseguenza maggiormente insidioso
sotto il profilo speculativo. Si tratta di un tragitto che, malgrado tale “pericolosità”, ritengo sia
necessario affrontare, giacché ne va della possibilità di condurre ancor più in profondità la
riflessione sulle condizioni esistenziali, oggi, di una felicità possibile.
Si sarà forse notato che nelle argomentazioni finora svolte ho evitato di impiegare quei termini
che spesso predominano nei discorsi sulla felicità, ossia espressioni quali: “ricercare”,
“raggiungere”, “conquistare”, “ottenere” e simili. Questa scelta è dovuta al fatto che tale
concettualità mi pare rischi di oscurare o addirittura negare implicitamente quella che fin qui si è
mostrato essere la natura diveniente della condizione felice.
In tal senso, nel primo capitolo si è osservato come nel luogo del soffrire – specificamente in
quello della sofferenza depressiva che oggi si conosce – si diano condizioni della felicità possibile,
ovvero l'iniziale dischiudersi di una felicità che può crescere se la persona sa coglierne i segni. C'è
un'immagine suggestiva di Nietzsche che esprime appieno questo “annunciarsi” della felicità,
quando gli scuotimenti e i tremori dell'esistenza che soffre iniziano a trasfigurarsi in una “danza”1.
Se essere felici fosse una condizione sostanziale, uno “stato in luogo” – essere nella felicità – e non
un consapevole divenire felici2, la felicità starebbe in un rapporto puramente oppositivo con la
1
Cfr. F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen (1883-1885), trad. it. Così parlò
Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, in Opere, vol. VI, tomo I, Adelphi, Milano, 1973, pp. 356-357.
2
Qui mi discosto, ad esempio, dalla posizione di Adorno: «È per la felicità come per la verità: non la si ha, ma ci si è.
Felicità non è che l'essere circondati, l'“esser dentro” [...]. Ecco perché nessuno che sia felice può sapere di esserlo.
Per vedere la felicità dovrebbe uscirne [...]. Chi dice di essere felice mente, in quanto evoca la felicità, e pecca contro
di essa. Fedele alla felicità è solo chi dice di essere stato felice. Il solo rapporto della coscienza alla felicità è la
1
64
sofferenza, nel senso che laddove si soffrisse non si potrebbe scorgere alcuna possibilità per il
sorgere della felicità.
Nel secondo capitolo si è visto che la condizione felice a cui possiamo realmente accedere, in
quanto esseri finiti, non equivale ad uno status di definitivo appagamento del desiderio, in cui esso
si estinguerebbe, bensì al prolungato sentimento di pienezza e positività che proviene dall'avvertire
che si sta facendo qualcosa del proprio desiderare, curvandolo e mantenendolo in una unitaria e
salda progettualità di vita. Questo misurare il desiderio fa dell'esistenza della persona un mondo
ricco «di piccole cose perfette, di cose riuscite bene», che le segnalano che sta procedendo lungo «la
sua strada»3.
Intendo qui insistere più esplicitamente su tale aspetto della questione, poiché reputo che accedere
alla consapevolezza del carattere diveniente della felicità costituisca una delle precondizioni
necessarie per disporsi a realizzare una vita buona. In particolar modo, questa acquisizione
consentirebbe di evitare il rischio che nella domanda di felicità si manifestino gli effetti di ciò che,
con una metafora ottica, definirei un accomodamento disfunzionale della “visione etica”. Effetti che
si presentano in una duplice modalità: da un lato la presbiopia, l'incapacità di scorgere la possibilità
della felicità se non da lontano, quando questa è collocata in un punto che resta a fuoco fintantoché
non ci si avvicina ad esso; dall'altro la miopia, che consente una visione nitida solo se la possibilità
della felicità viene colta nelle immediate vicinanze. Il primo “difetto” è tipico del modello
antropologico che colloca la condizione degli uomini in una prospettiva escatologica, secondo la
quale l'autentica felicità umana abiterebbe in un futuro (mondano o intramondano) tanto distante
quanto luminoso; alla persona spetterebbe perciò il compito “eroico” di differire la propria
aspirazione a vivere un'esistenza davvero soddisfacente “sacrificandola” in direzione di questo
domani remoto4. Tale modello – che nella storia occidentale ha assunto una configurazione sia
religiosa sia “secolarizzata”5 – nel corso degli ultimi decenni ha conosciuto un notevole
gratitudine» (Minima moralia. Reflexionem aus dem beschädigten Leben, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1951, trad.
it. di R. Solmi, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, Einaudi, Torino, 1994, p. 127). Dello stesso avviso è
Salvatore Natoli: si veda il suo La felicità. Saggio di teoria degli affetti, Feltrinelli, Milano, 2009, pp. 14-15.
3
F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, cit., p. 357.
4
Va detto che ci sono paradigmi escatologici in cui tale finalismo non necessariamente presenta un carattere
“sacrificale”. Ad esempio, la civitas Dei peregrinans di cui parla Agostino fa esperienza della felicità anche in itinere:
una felicità incompleta eppure reale; su questo si veda il dialogo De beata vita, trad. it. di M. Barracano, La vita felice,
Leone Verde, Torino, 2009.
5
Cfr. K. Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Zur Kritik del Geschichtphilosophie, Kohlhammer, Stuttgart,
1953, trad. it. di F. T. Negri, Significato e fine della storia, Net, Milano, 2004; G. Marramao, Cielo e terra.
Genealogia della secolarizzazione, Laterza, Roma-Bari, 1994.
2
65
depotenziamento, fino al punto che oggi nella coscienza di molti è radicata la persuasione che
l'unica felicità possibile sarebbe quella che si trova a portata di mano; ciò costituisce uno dei
principali fattori che hanno indotto a restringere la prospettiva esistenziale nell'angusto perimetro
della mera attualità e a misurarsi esclusivamente con impegni che non impegnano6.
Quello che mi sembra accomunare queste due visoni etiche, pur nella loro eterogeneità, è il fatto
che in entrambe viene a mancare un'effettiva esperienza del presente; più esattamente, non si dà, o
rischia di non darsi, ciò che Ugo Perone chiama il «passare che trattiene, la mano che si chiude per
reggere e reggersi»7. In altri termini, il presente con cui la persona entra in relazione non è tale da
contenere e rimandare il senso e il valore del trattenersi, ossia del soggiornare e dell'abitare; il
presente, puro spazio di transito, diviene un specie di non-luogo, nell'accezione di Marc Augé8.
Nel primo caso (quello della presbiopia escatologica) l'esperienza del presente assume un
carattere “anfibio”: al tempo stesso si è e non si è nel presente. Questo può avvenire o perché ci si
slancia totalmente in avanti, facendo del presente uno strumento al servizio dell'unico senso/fine
posto nel futuro, oppure perché si sta nel presente assumendo la modalità dell'aspettativa, che a
differenza dell'attesa costituisce un atteggiamento prevalentemente passivo. L'attendere consiste
infatti nella coloritura affettiva di un pensare e un fare impegnati a promuovere qui-e-ora l'oggetto
dell'attesa; in tal senso, esso è il potenziamento della passione dell'attenzione nell'accezione che ne
ho dato nel capitolo precedente: la sinergia dell'attendere-che e dell'attendere-a.
Nel secondo caso, che ci riguarda più da vicino, il presente diviene un puro trascorrere nella
misura in cui si tende a fare esperienza del tempo come di un continuum scandito da momenti
acquisitivi, cioè da quegli atomi temporali durante i quali vengono “consumati” gli oggetti, i luoghi,
i legami interpersonali, ecc. Ciò può verificarsi giacché, come afferma Merleau-Ponty, il presente
nasce dal rapporto che il soggetto intrattiene con le cose del mondo, dalla modalità di inerire ad
esse9. Se tale rapporto ha la natura dell'impossessarsi e fagocitare, del fugace gesto di rapina che
non sa sostare presso le cose facendo maturare l'incontro con esse, il presente in quanto luogo
temporale dotato di senso permane fintantoché le cose non si nientificano per effetto del loro
6
Mi riferisco alla formula coniata da Robert Nozick, «non-binding commitments»: si veda il suo Philosophical
Explanations, Oxford University Press, Cambridge (Mass.), 1981, trad. it. di G. Rigamonti, Spiegazioni filosofiche, Il
Saggiatore, Milano, 1987, pp. 354 e sgg. 7
U. Perone, Il presente possibile, Guida, Napoli, 2005, p. 33.
8
Cfr. M. Augé, Non-Lieux. Indtroduction à une anthropologie de la surmodernité, Seuil, Paris, 1992, trad. it. di G.
Lagomarsino, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, elèuthera, Milano, 2009.
9
Cfr. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris, 1945, trad. it. di A. Bonomi,
Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano, 2003, pp. 526-554.
3
66
consumo. Per fare un esempio, non di rado si concepiscono i rapporti d'amicizia e d'amore come
qualcosa di selezionabile, come fossero voci di un menu: si scelgono amici e partners, li si “prova”
e se non risultano subito soddisfacenti li si abbandona, passando ad un altro “piatto”. In
conseguenza di una simile sfilacciatura della trama di significato e valore che connette il soggetto al
mondo, il tempo degli intervalli fra un gesto acquisitivo e l'altro è vissuto come “vuoto”; in altre
parole, si sperimenta una sorta di successione seriale di presenti, vacui e fugaci, fra loro
giustapposti.
È da ritenere che in questo stato di cose si possa scorgere uno dei segnali più eloquenti della
perdurante funzionalità del paradigma del progresso. Beninteso, l'ideale del progresso in quanto
chiave di lettura della vicenda umana, ossia come trionfale autonarrazione collettiva, è
sostanzialmente venuto a mancare; sono infatti ben pochi coloro che ritengono di poter affermare
che stiamo vivendo “magnifiche sorti e progressive”, che la storia stia volgendo per il meglio.
Eppure l'estinguersi di tale ideale non è coinciso, a mio avviso, con l'esaurirsi dello stile proprio del
progresso. Intendo dire che il paradigma del progresso, ufficialmente sconfessato, circola tuttora
“sotto mentite spoglie”, precisamente come un genere di concezione etico-antropologica secondo
cui lo sviluppo umano (singolare e plurale) non può che coincidere con un avanzare che produce
“residui” privi di qualsiasi valore.
La relazione che stringe intimamente il movimento di sviluppo proprio del progresso e la
produzione di “residui” è colta anzitutto da Walter Benjamin, il quale descrive l'avanzamento
progressivo della storia come un'inarrestabile tempesta che tutto demolisce.
«C'è un quadro di Klee che si intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di
allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese.
L'angelo della storia deve avere questo aspetto. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola
catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben
trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è
impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge
irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al
cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta»10.
10
W. Benjamin, Schriften, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1955, trad. it. di R. Solmi, Einaudi, Torino, 1995, p. 80.
4
67
Questa potente immagine non va affatto considerata come una semplice allegoria, bensì come la
nitida fotografia di una realtà tangibile: le rovine sono le macerie delle città e le cataste di cadaveri
causate dalle guerre, i ruderi della natura devastata da uno sfruttamento smisurato, i detriti della
memoria collettiva che, caduta in disuso, si sbriciola11.
Per provare a condurre la visione benjaminiana, che abbraccia l'orizzonte dell'intera vicenda
storica, sul campo relativo all'esperienza dei soggetti, ovvero sul terreno su cui si muove questa
ricerca, credo si possa utilmente impiegare un brano di Italo Calvino estratto dal suo celebre testo
Le città invisibili.
«La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni: ogni mattina la popolazione si risveglia tra lenzuola
fresche, si lava con saponette appena sgusciate dall'involucro, indossa vestaglie nuove fiammanti,
estrae dal più perfezionato frigorifero barattoli di latta ancora intonsi, ascoltando le ultime filastrocche
dall'ultimo modello d'apparecchio.
Sui marciapiedi, avviluppati in tersi sacchi di plastica, i resti della Leonia d'ieri aspettano il carro dello
spazzaturaio. [...] più che dalle cose che ogni giorno vengono fabbricate vendute comprate, l'opulenza
di Leonia si misura dalle cose che ogni giorno vengono buttate via per far posto alle nuove. Tanto che
ci si chiede se la vera passione di Leonia sia davvero, come dicono, il godere delle cose nuove e
diverse, o non piuttosto l'espellere, l'allontanare da sé, il mondarsi d'una ricorrente impurità. Certo è
che gli spazzaturai sono accolti come angeli, e il loro compito di rimuovere i resti dell'esistenza di ieri
è circondato d'un rispetto silenzioso, come un rito che ispira devozione, o forse perché una volta
buttata via la roba nessuno vuole più averci da pensare»12.
Oltre alla mirabile predizione di un problema sociale che oggi ben si conosce, è possibile
ravvisare nello scenario rappresentato in questo brano il verificarsi nel soggetto di un processo di
disaggregazione dell'esperienza di sé, provocato appunto dal fenomeno dell'intermittenza del
presente. Qui, “esperienza” è da intendersi secondo la semantica del vocabolo tedesco Erfahrung: il
sedimentarsi del senso di sé lungo il viaggio (Fahrt) del vivere. Se la vita della persona re-inizia
ogni giorno – la Leonia di oggi, infatti, non è la Leonia di ieri – o addirittura ad intervalli ancor più
brevi, tale sedimentazione non può prodursi e l'esperienza di sé diviene una semplice somma di
esperienze-eventi (Erlebnisse), di microcosmi di significato e valore che implodono subito dopo
11
Si veda l'interessante riflessione di Marc Augé Le temps en ruines, Galilée, Paris, 2003, trad. it. di A. Serafini, Rovine
e macerie. Il senso del tempo, Bollati Boringhieri, Torino, 2004.
12
I. Calvino, Le citta invisibili, Mondadori, Milano, 2011, p. 111.
5
68
essersi formati13. Disaggregandosi l'esperienza di sé, inevitabilmente si disaggrega anche il senso di
responsabilità verso ciò che si è e si fa: per cui quel che è accaduto in precedenza, anche nel passato
più prossimo, non ha alcuna rilevanza morale e quel che potrebbe accadere nel futuro prossimo
pertiene ad una specie di “al di là” che non interessa la coscienza.
Direi allora che il soggetto vive un'“esistenza-progresso” quando avverte di poter “esserci” solo
nella misura in cui oltrepassa incessantemente se stesso e lascia dietro di sé gli scarti delle
Erlebnisse consumate; fra questi scarti ci sono senz'altro i resti delle merci, come osserva Calvino,
ma anche, e più significativamente, le relazioni personali, i gesti lavorativi, gli scambi
comunicativi14 e tutto ciò che rende l'esistenza una vicenda autenticamente umana.
Si manifesta così una delle mutazioni fondamentali nella relazione Io-mondo che, dal punto di
vista fenomenologico, connotano la condizione di maniacalità: destrutturandosi la sua
temporalizzazione, per il soggetto il tempo si fa talmente breve che gli oggetti, le persone e i luoghi
gli appaiono immediatamente raggiungibili e disponibili. E poiché tutto è vicino, la sua attenzione e
il suo interesse vagano senza requie; egli tocca e assaggia tutto senza soffermarsi davvero su niente
e nessuno. La maniacalità si configura, in tal modo, come il dominio dell'effimero, di una
mondanità colta nella fuggevolezza di una presenza momentanea, che «determina l'appresentazione
dell'altro come presenza di un estraneo, se non addirittura di una cosa»15. È così che il soggetto
maniacale appare animato da costante euforia, da una sinistra allegria che lo fa sembrare tanto
indaffarato quanto inconcludente.
Se è plausibile affermare che la temporalità maniacale connota il vivere di molti abitanti dell'oggi,
è possibile rintracciare in tale dimensione l'origine di quella forma disagio che, affianco alla fatica
di essere se stessi, costituisce l'altra “zona d'ombra” delle esistenze contemporanee, ossia il panico?
Forse sì, soprattutto se si osserva che tale malessere si presenta sotto forma di improvviso “attacco”,
il quale determina una situazione emotiva talmente drammatica che porta la persona a sentire la fine
di tutte le cose, la morte totale, percependo nel mentre il proprio essere come “sospeso”, privo di un
13
Cfr. R. Bodei, Erfahrung/Erlebnis. Esperienza come viaggio, esperienza come vita, in V. E. Russo (a cura di), La
questione dell'esperienza, Ponte alle Grazie, Firenze, 1991, pp. 115-118. Per una riflessione di carattere più generale
su tale questione rimando a G. Agamben, Infanzia e storia. Distruzione dell'esperienza e origine della storia, Einaudi,
Torino, 2001.
14
Si noti come nei networks di socializzazione – che oramai costituiscono il format di quasi tutti i siti della Rete – il
proprio profilo deve essere aggiornato di continuo e quello che ci si è detti comunicando con gli altri utenti viene di
fatto dimenticato in brevissimo tempo.
15
U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 268.
6
69
fondo e di una base sicuri; l'ansia culmina nell'angoscia più opprimente16. Quando il soggetto è in
panico l'ambiente viene percepito come un cerchio che si chiude verso il centro che egli occupa,
senza più offrigli alcun punto di riferimento e negandogli, al contempo, ogni appiglio e via d'uscita.
È così che il soggetto si sente «costretto a subire passivamente un'azione esterna che lo chiude su se
stesso, strozzandolo»17. Di qui le reazioni di fuga improvvisa o paralisi che si accompagnano agli
attacchi18.
Ansia, comportamento maniacale, panico costituiscono casi estremi, vissuti nell'esistenza concreta
e personale, che sembrano rimandare ad un'esperienza del tempo la quale – come si è colto con
l'aiuto di Benjamin e di Calvino – resta imbrigliata nelle maglie del “cattivo progressismo”, non
consente il potersi chiudere della “mano” del presente e pertanto impedisce, oscurandole, le
condizioni della felicità possibile, nell'accezione che qui se ne è data. Il divenire felici ha infatti
bisogno di “aver luogo” in uno “spazio di tempo” accogliente, in cui l'adesso si riveli quale spaziotempo dove l'umano abbia respiro sufficiente per approssimare – vedere, toccare, riconoscere,
cogliere – le possibilità del suo divenire felice .
È evidente che il percorso qui abbozzato discorsivamente ha bisogno di ricevere in sede filosofica
un insieme di strumenti concettuali adeguati, grazie ai quali pensare e interpretare il vivere secondo
un modello di senso che non sia ancora apparentato, più o meno visibilmente, con il paradigma del
progresso, il quale, assai più radicato di quanto vorremmo credere, rema contro ogni autentica e
onesta intenzione di mutare realmente ed efficacemente i modi dell'umano abitare19.
16
A seconda dei diversi contesti disciplinari in cui sono utilizzati (filosofia esistenziale, psichiatria, psicologia,
psicoanalisi), i termini “ansia” e “angoscia” vengono distinti o invece intesi come sinonimi. Ad esempio, in ambito
psichiatrico l'ansia è riferita ad aspetti psichici, mentre l'angoscia è riferita a manifestazioni somatiche. Si consideri
poi che la lingua inglese e quella tedesca offrono un unico vocabolo per entrambi i concetti (Anxiety, Angst); la radice
è comunque la medesima, il latino angere (“stringere”).
17
F. Barale, M. Bertani, V. Gallese, S. Mistura, A. Zamperini (a cura di), Psiche. Dizionario storico di psicologia,
psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze, Einaudi, Torino, 2009, vol. I, p. 86.
18
Per una comprensione fenomenologica della sintomatologia del panico cfr. A. Sims, F. Oyebode, Sim's Symptoms in
the Mind. An Introduction to Descriptive Psycopathology, Elsevier, Amsterdam, 2008, trad. it. di L. Bellodi, M.
Battaglia e A. Ranieri, Introduzione alla psicopatologia descrittiva. Quarta edizione, Raffaello Cortina, Milano, 2009,
pp. 429-437.
19
Trovo che praticare questo ripensamento radicale del modello antropologico del progresso coinciderebbe con
un'opera di autoimmunizzazione da parte della cultura occidentale, e quindi con un'impresa aderente all'autentico
spirito moderno, se con “modernità” si intende – come invita a fare Foucault sulla scorta di Kant – non tanto un
periodo della storia con dei “pre-” e dei “post-”, quanto un modo di pensarsi e agire che «sottolinea un'appartenenza e,
al tempo stesso, si presenta come un compito» (M. Foucault, What is Enlightenment? (1984), trad. it. Che cos'è
l'Illuminismo?, in Archivio Foucault 3. Interventi, colloqui, interviste. 1978-1985. Estetica dell'esistenza, etica,
politica, a cura di A. Pandolfi, Feltrinelli, Milano, 1998, p. 223).
7
70
È con tale spirito che intendo accogliere ed elaborare concettualmente, nel senso che si è appena
indicato, una suggestione proveniente dall'autorevole psichiatra fenomenologo Eugène Minkowski,
tra i cui “appunti filosofici” si trova una descrizione dell'esistenza umana particolarmente
interessante: esistere è come percorrere una strada lungo la quale si lasciano tracce20.
«[A partire dal momento in cui prendiamo coscienza di avere una vita da vivere] noi ci troviamo posti
a confronto con la possibilità di forgiare la nostra vita. [...] La vita non consiste forse in una
ricreazione continua e inevitabile di una prospettiva di vita? [...] [Per noi] la vita è una strada da
percorrere, una strada che non ha nulla di metaforico in sé. Si tratta al contrario dell'unica strada che
noi dobbiamo percorrere necessariamente, tracciandola e costruendola con le nostre mani. Non ce ne
sono altre. [...] Per questo parliamo abitualmente delle svolte che incontriamo sulla nostra strada,
benché questa strada si prolunghi dritta davanti a noi, o usiamo talvolta l'espressione “prendere una
buona o una cattiva strada”, benché la strada, una volta imboccata, possa essere soltanto quella buona.
Allo stesso modo, “allontanarsi dalla retta via”, significa discostarsi, più o meno a lungo, dalla nostra
strada, per farvi ritorno in seguito [...]. Che cosa incontriamo nel cammino della nostra vita? [...]
[Incontriamo gli] ostacoli. [...] Ma l'ostacolo non è tutto. Oltre ad esso, e sullo stesso piano, troviamo
anche un altro fenomeno[: le tracce]. [...] Un'opera personale matura lentamente, si fa strada in me,
come se risalisse in superficie, assume progressivamente una forma concreta, ed infine si stacca da me,
diventando di dominio pubblico. [...] Lo sguardo rivolto all'avvenire, mi metto già a pensare all'opera
seguente. E sono consapevole di lasciarmi così alle spalle, continuando sempre ad avanzare, alcune
tracce del mio passaggio quaggiù. [...] L'opera, tuttavia, non la cogliamo in tutta la sua pienezza
quando, compiuta, la esaminiamo semplicemente dal di fuori, ma quando riusciamo invece a penetrare
nella durata vissuta, seguendone la lenta maturazione, fino al momento in cui essa si distacca da
noi.»21
Minkowski fa combinare l'idea che l'umano sia l'essere che costantemente si avverte impegnato
a proseguire sul cammino che gli si apre innanzi – in virtù dello slancio vitale che gli mantiene
schiuso l'orizzonte dell'avvenire22 – con l'idea che le tracce, da cui è possibile riconoscere il suo
20
Trattandosi di un pensiero che Minkowski elabora in modo non sistematico ma più vicino alla forma letteraria, lo
ricostruisco inserendo alcuni brevi passaggi che non sono presenti nel testo originale, al quale rimando per una
comprensione più esaustiva.
21
E. Minkowski, Vers une cosmologie. Fragments philosophiques, Aubier-Montaigne, Paris, 1936, trad. it. di D.
Tarizzo, Verso una cosmologia. Frammenti filosofici, Einaudi, Torino, 2005, pp. 194-203.
22
Sullo slancio vitale si veda E. Minkowski, Le temps vécu. Études phénoménologiques et psycopathologiques,
Delachaux, Paris, 1933, trad. it. di G. Terzian, Il tempo vissuto. Fenomenologia e psicopatologia, Einaudi, Torino,
2004, pp. 42-60.
8
71
cammino, siano le opere che si lascia dietro: tali opere, come si può intuire, sono il risultato di un
costruire e non di un progredire, che consuma e distrugge. L'importanza di questa riflessione sta
nel fatto che in essa coabitano sia il riconoscimento del necessario avanzare della vita sia anche,
e più essenzialmente, l'individuazione del come questa debba avanzare, al fine di essere buona.
L'idea che dà conto di questo procedere è suggerita da Minkowski laddove parla di maturazione.
2. Euritmia
Passare dall'idea che lo sviluppo della persona sia un movimento progressivo per pensarlo invece
come processo di maturazione conduce a considerare come tale sviluppo presenti un andamento
poliritmico, nel senso che esso è capace di distribuirsi e distendersi in una temporalità esistenziale
variamente accentata. Più esattamente, si può dire che la persona si sviluppi potendo riconoscere
una simultaneità di modulazioni temporali della sua esperienza, ognuna delle quali è connotata da
una specifica combinazione ritmica. In questa prospettiva, trovo proficuo connettere l'idea di felicità
non solo a quella di maturazione ma anche a quella di ritmo.
Per poter procedere in tale direzione di indagine è opportuno, in primo luogo, formulare una
definizione adeguata di ritmo, un concetto non molto familiare nell'ambito della filosofia – sono
infatti pochi i pensatori che ne hanno trattato23 –, essendo evidente l'operatività filosofica che è
necessario fornire al concetto medesimo.
Dal punto di vista dell'etimologia, il termine greco ῥυθµός presenta un evidente legame
morfologico con il verbo ῥέω, il quale designa lo scorrere dell'acqua; tuttavia, se una prima
tradizione di studi individuava l'origine dell'idea di “ritmo” (così come noi lo intendiamo) nel
movimento delle onde del mare, Émile Benveniste pone giustamente in evidenza che le onde
marine non scorrono, tanto che ῥέω è utilizzato per indicare movimenti come quello dell'acqua del
fiume. Egli suggerisce, pertanto, di ricercare lo specifico significato di ῥυθµός nel vocabolario della
filosofia ionica, particolarmente presso i creatori dell'atomismo. In tale contesto, «ῥυθµός è
equivalente a σχῆµα», che significa “forma”, “configurazione”, ovverosia «l'assetto caratteristico
delle parti di un tutto». Va però segnalata un differenza rilevante fra i due termini: σχῆµα è da
23
Oltre che nell'ambito della teoria musicale, il concetto di ritmo è stabilmente impiegato nella psicologia della
percezione temporale: rimando all'importante ricerca di Paul Fraisse Psychologie du rythme, PUF, Paris, 1974, trad. it.
di L. Calabrese, Psicologia del ritmo, Armando, Roma, 1979.
9
72
leggersi in rapporto ad ἔχω, “sto” (come il latino habitus rinvia ad habeō) e definisce perciò «una
forma fissa, realizzata, posta in certo qual modo come un oggetto». Diversamente, ῥυθµός dice
della forma «nell'attimo in cui è assunta da ciò che si muove, è mobile, fluido»; si addice cioè ad
una «forma improvvisa, momentanea, modificabile».
Ma è a partire dai testi di Platone che ῥυθµός inizia ad essere impiegato nell'accezione di ritmo
che ci è più familiare; il filosofo introduce un'importante innovazione concettuale applicando questa
parola alla «forma del movimento che il corpo umano compie nella danza, e alla disposizione delle
figure nelle quali si risolve questo movimento». L'aspetto più rilevante dell'operazione platonica è
l'aver definito la «nozione di un ῥυθµός corporeo associato al µέτρον e sottomesso alla legge dei
numeri»; questa forma, determinata da una misura e soggetta ad un ordine, può quindi essere
impiegata per parlare «del “ritmo” di una danza, di un'andatura, di un canto, di una dizione, di un
lavoro, di tutto quanto suppone un'attività continua scomposta dal metro in tempi alternati»24.
C'è da compiere un balzo fino alla contemporaneità per trovare una teorizzazione filosofica del
ritmo altrettanto decisiva di quella platonica: mi riferisco alla «ritmoanalisi» di cui tratta Gaston
Bachelard, il quale si richiama esplicitamente alle riflessioni del filosofo brasiliano Pinheiro dos
Santos presenti in un'opera del 1931 (opera ormai irreperibile). Il tema del ritmo è affrontato da
Bachelard all'interno dei suoi studi sulla temporalità, dove sviluppa una critica serrata e, almeno a
mio avviso, convincente alla concezione bergsoniana della durata25. Contestando la legittimità del
24
É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Gallimard, Paris, 1966, trad. it. di M. V. Giuliani, Problemi di
linguistica generale, il Saggiatore, Milano, pp. 391-398. La celebre definizione di Platone è in Leggi, II, 665 a:
«L'ordine del movimento si chiama ritmo».
25
«La filosofia di Bergson è una filosofia del pieno e la sua psicologia e una psicologia della pienezza. Questa
psicologia [...] dà attività al riposo, permanenza alla funzione [...]. In queste condizioni [...] la nostra vita è tanto piena
che agisce quando noi non facciamo niente. In certo qual modo, c'è sempre qualcosa dietro di noi [...]. L'intero nostro
passato veglia quindi dietro il nostro presente, ed è proprio perché l'io è antico e profondo e ricco e pieno, che esso
possiede un'azione veramente reale. La sua originalità viene dalla sua origine. Essa è ricordo, non è affatto una
trovata. [...] Sotto questo riguardo, il bergsonismo ha la facilità di ogni sostanzialismo, la disinvoltura e il fascino di
ogni dottrina dell'interiorità. [...] Esso ha conservato una solidarietà tra il passato e il futuro, una viscosità della durata,
la quale fa sì che il passato resti la sostanza del presente, o, detto altrimenti, che l'istante presente non sia mai altro che
il fenomeno del passato. Ed è così che, nella psicologia bergsoniana, la durata piena profonda, continua, ricca, funge
da sostanza spirituale. [...] Il panpsichismo non è se non un pancronismo. La continuità della sostanza pensante non è
se non la continuità della sostanza temporale [...]. Poiché il presente risolve il passato così come l'allievo risolve un
problema assegnato da un maestro, il presente non può creare niente» (G. Bachelard, La dialectique de la durée,
Bovin, Paris, 1936, trad. it. di D. Mollica, La dialettica della durata, Bompiani, Milano, 2010, pp. 59-63). Si evince
chiaramente che ciò a cui mira Bachelard non è «mostrare dove il nuovo nasce dal vecchio, bensì dove il vecchio
muore nel nuovo» (affermazione di Giovanni Sertoli citata in L. Alici (a cura di), Tempo e storia. Il «divenire» nella
filosofia del '900, Città Nuova, Roma, 1978, p. 35). Per una ricognizione delle analisi bachelardiane dedicate al tempo
si vedano: V. Cicero, Istante durata ritmo. Il tempo nell'epistemologia surrazionalista di Gaston Bachelard, Vita e
Pensiero, Milano, 2007; G. Polizzi, Una filosofia del tempo. Tempo spazializzato e tempo complesso in Gaston
10
73
continuismo con il quale Bergson ritiene di dar conto della temporalità umana, il pensatore francese
si propone di dimostrare «che c'è fondamentale eterogeneità nel seno stesso della durata vissuta,
attiva, creatrice, e che per conoscere o utilizzare bene il tempo, bisogna attivare il ritmo della
creazione e della distruzione, dell'opera e del riposo. Solo la pigrizia è omogenea; non si può
conservare che riconquistando; non si può mantenere che riprendendo»26. Così concepita, la durata
non equivale perciò ad un dato di fatto originario ma consiste in un'opera la cui costituzione
conosce accelerazioni e soste: un ritmo, appunto. Sono le nostre azioni a sorreggere il tempo,
cosicché la tenuta della continuità temporale dipende dalla compattezza interna del nostro agire. Ne
risulta che il tempo che sperimentiamo – perché siamo noi a “fabbricarlo” – è «un tempo fatto di
accidenti, molto più vicino alle incongruenze quantiche che alle coerenze razionali o alle
consistenze reali»27.
In accordo con tali presupposti, Bachelard individua nel ritmo il basilare modello di sviluppo
della vita: «Ripristinando una forma, il ritmo ripristina spesso una materia, una energia. [...] Il ritmo
è veramente la sola maniera di disciplinare e di preservare le energie più diverse. È la base della
dinamica vitale e della dinamica psichica»28.
Sulla scorta delle riflessioni di Bachelard, è possibile avanzare la seguente ipotesi: se si
concepisce l'esistenza del soggetto come un intero, se cioè vi si legge il costituirsi di una forma
complessiva di esistenza, è plausibile sostenere che tale forma possa giungere ad essere buona
anzitutto nella misura in cui si sviluppa in modo euritmico: ovvero se il processo che la attua
possiede una modulazione temporale tale da consentire la maturazione delle energie che la
definiscono. Tale euritmia consisterebbe nel bilanciamento fra le varie durate che la persona
sperimenta e che sono tutte caratterizzate da una cadenza specifica. In altre parole, l'euritmia
sarebbe il meta-ritmo in cui si compongono “felicemente” i singoli ritmi che la vita umana conosce.
Come sottolinea Henri Lefebvre, proseguendo lungo la strada delle intuizioni di Bachelard, il
corpo umano è «composto di differenti ritmi – avendo ogni organo e ogni funzione il suo proprio –
che esso mantiene in equilibrio metastabile, [...] con l'eccezione di quelle perturbazioni (aritmia)
Bachelard, in F. Bonicalzi, C. Vinti (a cura di), Ri-cominciare. Percorsi e attualità dell'opera di Gaston Bachelard,
Jaca Book, Milano, 2004, pp. 59-80.
26
G. Bachelard, La dialettica della durata, cit., p. 75.
27
Ivi, p. 241. «Bachelard ebbe l'acutezza di evitare un “mistica del ritmo”, costruendo piuttosto un realismo ritmico [...]
cercò di fondare la ritmoanalisi sulle innovazioni dell'inizio del ventesimo secolo interne alla fisica dei quanti e
riguardanti la composizione a particelle/onde della materia/energia» (S. Goodman, Sound Warfare. Sound, Affect, and
the Ecology of Fear, MIT, Cambridge, 2010, formato Kindle, posizione 1037).
28
G. Bachelard, La dialettica della durata, cit., p. 317. Corsivo mio.
11
74
che presto o tardi divengono malattia (lo stato patologico)». Inoltre, il corpo è sempre circondato,
sia nell'ambiente naturale sia in quello sociale, da «fasci, bouquets, ghirlande di ritmi, ai quali è
necessario prestare ascolto al fine di cogliere gli insiemi naturali e quelli costruiti»29.
Tali ghirlande di ritmi possono essere pensate come disposte concentricamente. La più piccola è
quella dei ritmi “microcosmici”, ossia i bioritmi, gli andamenti periodici riscontrabili nel nostro
corpo dei quali si occupa la cronobiologia. La ghirlanda più ampia concerne i ritmi propri della vita
nella sua portata periecontologica, per dire con Jaspers, cioè della natura “abbracciante” che si
manifesta con evidenza nel susseguirsi delle stagioni climatiche, nel movimento delle maree, nelle
fasi lunari e in numerosi fenomeni in cui possiamo immediatamente cogliere l'appartenenza della
Terra ad un sistema vivente più vasto. Per la maggior parte della sua storia l'umanità ha mantenuto
la consapevolezza di essere inserita in una temporalità cosmica e ha inventato riti, usi e simbologie
che le consentissero di sapersi in sincronia con essa. A partire dall'instaurarsi nel Medioevo del
tempo lineare che scandisce la vita cittadina rispetto alla vita della campagna, e successivamente
con il radicarsi della percezione scientifica dell'universo, questa relazione è progressivamente
venuta meno, col risultato che oggi, malgrado il perfezionamento delle conoscenze fisicoastronomiche, tendiamo a condurre un'esistenza del tutto “a-cosmica”.
Fra il cerchio ritmico più ristretto e quello più ampio ve ne sono altri generantesi all'interno della
naturale artificialità, come direbbe Gehlen, della dimensione di vita specificamente umana. Mi
riferisco, ad esempio, alle durate determinate dall'organizzazione sociale della tempo, come i cicli
lavorativi e quelli scolastici o gli appuntamenti e le ricorrenze della vita religiosa.
Rispetto alla maturazione, intesa come il processo del dischiudersi della felicità, credo sia
opportuno rivolgere l'attenzione in particolare su due dei ritmi che compongo la trama temporale
dell'umano: l'avvicendamento delle stagioni dell'esistenza e il corso dei giorni.
3. Stagioni dell'identità
La stagione dell'esistenza è un periodo della vicenda personale che conosce specifici principi di
regolazione interna, che cioè è dotato di una configurazione normativa incommensurabile a quella
degli altri periodi. In tal senso, la maturazione attraversa le stagioni distribuendosi su due livelli di
sviluppo: l'uno riguardante l'esplicazione, la chiarificazione e il rafforzamento dei principi propri
29
H. Lefebvre, Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life, Continuum, London, 2004, p. 20.
12
75
della singola stagione, l'altro concernente il passaggio da una stagione all'altra. Definirei il primo
sviluppo “evolutivo” e il secondo sviluppo “critico”. Quest'ultimo è accompagnato da una forte
perturbazione del pensiero e dell'affettività, e dunque del comportamento, che va riconosciuta e
accettata, cercando di opporre la minor resistenza possibile al cambiamento che si sta
sperimentando. La difficoltà che caratterizza i passaggi da una stagione all'altra è dovuta anche alla
circostanza che l'ambiente relazionale nel quale la persona è inserita può persistere nel rivolgersi a
lei come se tale mutamento non fosse in atto, agendo così in favore di una continuità che in verità le
risulta insostenibile30.
Lungo tale sviluppo a doppio livello – intra-stagionale e trans-stagionale – maturano sia la
personalità sia gli atteggiamenti e i giudizi; si tratta però di due tipologie di maturazione assai
diverse. Come scrive Giovanni Jervis, la personalità di un soggetto consiste in «tutto ciò che lo
differenzia sul piano psicologico da qualsiasi altro [...] ed è dunque costituita dalle sue attitudini e
dai talenti, così come si sono sviluppati nel corso dell'infanzia, dalle forme della sua intelligenza, e
in un parola dallo stile personale che lo caratterizza in tutti gli atti della vita quotidiana»31. Nella
personalità non rientrano né gli atteggiamenti sociali (i “ruoli” che si assumono) né i giudizi sulla
realtà: questi, pur influenzati dalla personalità, dipendono soprattutto dalle credenze e dai valori di
riferimento, che sono fattori che si acquisiscono. In tal modo, «mentre la personalità di un individuo
cambia piuttosto poco nel corso della vita, atteggiamenti e giudizi [...] possono subire mutamenti
profondi e anche rapidi»32. La maturazione della personalità è dunque del tipo dell'attualizzazione,
mentre quella delle credenze e degli atteggiamenti è del tipo della sostituzione e
dell'aggiornamento. Ciò che vorrei porre in evidenza è che, mentre le componenti cognitivocomportamentali le si assume e le si può dismettere o modificare, la personalità invece la si scopre
gradualmente. Può essere opportuno, a tal riguardo, svolgere una stilizzazione etica delle stagioni
durante le quali si compie tale scoperta, indicando i principali fattori normativi che attengono ad
ognuna e dai quali dipende la possibilità che esse conoscano le forme e i gradi di felicità che gli
sono proprie33.
30
Questi passaggi critici possono rivelarsi assai dolorosi e vedere l'insorgenza di disturbi psico-emotivi e
comportamentali che impediscono od ostacolano la maturazione; tuttavia non metto a tema tale aspetto perché ciò
implicherebbe l'apertura di una versante di indagine che esula sia dalle mie competenze che dagli obiettivi del
capitolo.
31
G. Jervis, La conquista dell'identità. Essere se stessi, essere diversi, Feltrinelli, Milano, p. 67.
32
Ibidem.
33
Per questa stilizzazione mi rifaccio in parte alle riflessioni di David L. Norton nel suo Personal Destinies: A
Philosophy of Ethical Individualism, Princeton University Press, 1976, pp. 158-215.
13
76
L'infanzia e la fanciullezza34 sono connotate dalla condizione di dipendenza in cui i bisogni
basilari del soggetto possono essere soddisfatti perlopiù grazie a coloro che se ne prendono cura.
Non si deve però intendere che la dipendenza coincida con una totale passività: in questa stagione il
comportamento è invece più spontaneo che reattivo. Né, d'altronde, è da credersi che il bambino sia
una sorta di tabula rasa sulla quale l'ambiente incide i suoi caratteri. È ormai ampiamente
riconosciuto che i fattori genetici sono tanto influenti quanto quelli ambientali; la relazione fra di
essi è di tipo integrativo, per cui lo sviluppo è legato ai modi in cui le predisposizioni innate
incontrano gli stimoli provenienti dall'ambiente di crescita (che può favorirle od ostacolarle). Ciò
sta ad indicare che si tratta di una dipendenza provvisoria, così come è provvisorio l'esercizio di
autorità di cui essa necessita, il quale deve saper includere l'anticipazione del proprio decadimento.
La presenza di tale previsione nella coscienza delle figure di autorità si declina fattivamente nel
sostenere il bambino nella preparazione degli strumenti richiesti per la futura autoregolamentazione.
La virtù propria dell'infanzia e della fanciullezza è, allora, la ricettività: una capacità che si impara e
che costituisce il contributo positivo di quel «rispetto unilaterale» nel quale Piaget individua la
prima espressione della moralità35.
Tale scenario si trasforma in modo radicale con l'avvio dell'adolescenza, quando si instaura la
dinamica dell'autonomizzazione, che funziona prevalentemente per via negationis. È tipico di questa
stagione sentirsi incompresi e male interpretati, specialmente dai genitori e dagli insegnanti ma
anche dai coetanei; l'adolescente tende perciò a non concedere ad alcuno la possibilità di esprimersi
al posto suo. In lui si fa strada una voce interna che risulta ancora debole, confusa e timorosa, e il
suo compito è di irrobustirla e renderla autorevole e credibile, dirigendola nel mondo. Così si
inaugura un regime di pura possibilità, un agire di tipo esplorativo, non rigidamente strumentale ma
“aperto” e non di rado sconclusionato, in cui spiccano i tratti dell'estremismo, dell'incostanza e
dell'insolenza36. La proverbiale difficoltà di questo stadio di vita sta nel fatto che, se nell'infanzia
34
In psicologia si parla di prima infanzia per il periodo che va dalla nascita ai due anni, di seconda infanzia per quello
dal terzo al sesto anno, di fanciullezza per gli anni fino al decimo: ovviamente considerando le variazioni legate alle
differenze individuali.
35
Per Piaget i primi sentimenti morali sono originati «dal rispetto unilaterale che il bambino piccolo prova per i genitori
o l'adulto in genere»; tale rispetto comporta «la formazione di una morale di obbedienza o eteronoma». Ad esso segue
un «nuovo sentimento, che interviene in funzione della cooperazione fra bambini e delle forme di vita sociale che ne
derivano, [il quale] consiste essenzialmente nel rispetto reciproco» (Six études de psychologie, Gonthier, Paris, Paris,
1964, trad. it. di E. Zamorani, Lo sviluppo mentale del bambino, Einaudi, Torino, 1967, p. 84).
36
Da qui si può ricavare come la tendenza alla maniacalità di cui sopra si è detto coincida con una sorta di
imprigionamento da parte di molti in un perenne stato di post-adolescenza.
14
77
l'individuo costituiva un problema puramente per gli altri (come afferma Jung37), ora diviene un
problema per se stesso, perché deve cercarsi e fatica a trovarsi.
Eppure è al cuore di tale problematicità che inizia ad emergere il daimon, la personalità, dal
momento che il soggetto comincia a definire un'identità che non dipende esclusivamente dal
riconoscimento proveniente dalle figure di autorità e dal contesto sociale. Lo stile “sperimentale”
che qui si avvia prosegue nel terzo decennio di vita, laddove però compare progressivamente
l'istanza di finalizzazione, l'esigenza di conseguire risultati tangibili e soddisfacenti nei diversi
ambiti (relazioni, lavoro e così via). Le pratiche di vita ora devono rivelarsi capaci di assicurare
condizioni di esistenza percorse dal flusso dell'autostima; per cui si esaurisce il tempo dell'esplorare
e si apre quello del costruire, il quale abbraccia il quarto, il quinto e, oramai, anche il sesto
decennio, cosicché «noi tutti diventiamo noi stessi, e somigliamo a noi stessi, assai più a
quarant'anni che a venti»38.
In questa stagione il reagente etico fondamentale è l'amore di sé, che non ha nulla a che vedere
con il vuoto autocompiacimento o con la mollezza dell'autoindulgenza, ma è invece l'energia che
nutre l'impegno dell'autorealizzazione. Si può infatti condurre avanti una solida edificazione
identitaria soltanto grazie alla costanza e alla focalizzazione che si producono quando una causa
finale attrae l'agire, e questa causa è la soggettività stessa in quanto opera che chiede di essere
compiuta. Non di egoismo si tratta, dunque, quanto della fedeltà verso ciò che si può essere39.
Credo sia proprio tale tensione “erotica” con se stessi a consentire l'articolazione delle due
polarità identitarie idem e ipse di cui parla Ricoeur: la prima, sostanziale e perpetuantesi (come le
attitudini definite dalla matrice genetica o il profilo individuale riferito dalle “generalità” contenute
nei documenti), l'altra strutturantesi attraverso la mutabilità; come esempio di questo secondo modo
di permanenza dell'identità Ricoeur adduce il mantenimento di una promessa. La costruzione
dell'identità, dunque, si realizzerebbe nel corso dell'opera di autofinalizzazione che consente al
soggetto di concretizzare la propria personalità in un complesso di disposizioni e abitudini
37
Cfr. C. G. Jung, Die Lebenswende (1931), trad. it. di A. Vita e G. Bollea, Gli stadi della vita, in Opere, vol. 8, Bollati
Boringhieri, Torino, 1994, pp. 420-421.
38
G. Jervis, La costruzione dell'identità, in Id., Il mito dell'interiorità. Tra psicologia e filosofia, a cura di G. Corbellini
e M. Marraffa, Bollati Boringhieri, Torino, 2011, p. 137.
39
In tal senso, mi avvicino al concetto di philautia di cui parla Aristotele nell'Etica e che non mi pare riducibile
all'«egoismo morale» descritto da Kant nella sua Antropologia. Per una ricostruzione degli sviluppi di questa tematica
all'interno della filosofia moderna si veda E. Pulcini, La passione del moderno: l'amore di sé, in S. Vegetti Finzi (a
cura di), Storia delle passioni, Laterza, Roma-Bari, 2004, pp. 133-180.
15
78
acquisite, mantenendo in funzione «la dialettica dell'innovazione e della sedimentazione»40.
Tuttavia, rispetto all'analisi di Ricoeur – secondo il quale si dà «un intervento dell'identità narrativa
nella costituzione concettuale dell'identità personale»41 – ritengo sia da accogliere la sottolineatura
di Adriana Cavarero, che invita a considerare come l'identità realizzata non sia tanto narrativa
quanto «narrabile». Essa, cioè, non sarebbe «l'effetto di una strategia retorica» – come suggerisce
l'ipotesi secondo cui vivremmo la nostra vita come un romanzo di cui siamo i protagonisti – bensì
una risultanza, una costruzione che ci si lascia dietro (nel senso indicato da Minkowski)42; una
costruzione che si può narrare e descrivere nella sua interezza solo ex post, come accade ad esempio
quando raccontiamo “chi era” una persona cara che non è più con noi.
Mutandosi la piena età adulta in anzianità, si affievolisce la cogenza del principio
dell'autorealizzazione e, con essa, la progettualità e l'attivismo che contrassegnano gli anni
precedenti. Questo non accade perché l'avvicinarsi inevitabile della morte sortisce l'effetto di una
paralisi esistenziale, ma in ragione del fatto che l'orizzonte del futuro si restringe, diminuendo così
la sua forza di attrazione. L'anziano non è più “chiamato” dall'avvenire, non deve più rispondere ai
suoi appelli, e quindi rallenta gradualmente i sui ritmi. Più esattamente, ora il suo agire cambia di
segno: non si slancia nel futuro, che appunto per lui si va estinguendo, ma si proietta all'indietro. Lo
stile che la persona anziana assume è infatti la cura del passato, che si declina nel recuperare
all'attenzione (propria e altrui) tutto ciò che è stato, passandolo in rassegna, giudicandolo e,
40
P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Seuil, Paris, 1990, trad. it. di D. Iannotta, Sé come un altro, Jaca Book,
Milano, 1993, p. 211. «Il carattere [ciò che ho indicato con il termine “personalità”] è veramente il che cosa del chi.
Più esattamente, non è il che cosa ancora esteriore al chi, come nella teoria dell'azione [...]. Qui, si tratta proprio del
ricoprimento del chi? ad opera del che cosa?, che fa slittare dalla questione: chi sono?, alla questione: che cosa sono
io?» (ibidem).
41
Ivi, p. 207. Nel suo ricco lavoro Destini personali. L'età della colonizzazione delle coscienze (Feltrinelli, Milano,
2002), Remo Bodei insiste ampiamente sul fatto che l'identità non costituisca un blocco monolitico bensì un costrutto
in buona parte dipendente dalle forze sociali e dalle immagini di sé che il soggetto riceve dagli altri; essa avrebbe
quindi una consistenza altamente friabile. Direi, tuttavia, che egli indulge in un utilizzo sinonimico dei termini
“personalità” e “identità” che potrebbe risultare fuorviante; se la natura dell'identità è, almeno in certa misura,
“artificiale”, la personalità dipende da fattori sui quali al soggetto non è dato di intervenire – è in ragione di questo che
uno dei pericoli connessi all'impiego delle biotecnologie consiste proprio nell'inedita possibilità di programmare
intenzionalmente la personalità del nascituro. Sulla rilevanza della distinzione concettuale tra identity e self si veda G.
Jervis, La costruzione dell'identità, cit., pp. 126-131.
42
Queste osservazioni sono contenute in un'intervista che Cavarero ha rilasciato nel Febbraio 1998 per una trasmissione
radiofonica curata dall'Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche; il testo dell'intervento è disponibile sul
sito www.emsf.rai.it. Per un approfondimento delle posizioni della pensatrice sul tema della narrazione dell'identità si
veda il suo Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione, Feltrinelli, Milano, 2003. Un ulteriore
punto di vista (a mio avviso molto discutibile) sulla questione è quello che considera la funzione terapeutica
dell'autonarrazione: cfr. D. Demetrio, Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina, Milano, 1996.
16
79
possibilmente, pacificandosi con esso. Vedere in questo una forma di inerzia, come talvolta fanno
coloro che sono più giovani, significa non comprendere che si tratta di un lavoro vero e proprio,
come prima lo erano lo svolgimento dei compiti professionali e tutto quell'affaccendarsi per favorire
la soddisfazione dei figli che i genitori portano avanti “dietro le quinte”.
Se è così, bisognerebbe abbandonare l'abitudine, fin troppo diffusa, di ritenere che questa stagione
sarebbe ben vissuta solo se gli anziani non si mettessero “a riposo” ma si ostinassero a voler ancora
nutrire aspirazioni e pianificare nuovi progetti43. Così facendo non si fa del bene alla vecchiaia
poiché le si impedisce di esprimersi per quello che è: un periodo nel quale il soggetto raggiunge la
sua quintessenza, divenendo un puro essere, senza più qualità e attributi estrinseci – James Hillman
afferma, mi pare in tal senso, che invecchiare significha «essere arrivati allo stato di immagine»44.
Forse è in ragione di questo che gli anziani vanno molto d'accordo con i bambini, giacché anche
quest'ultimi (pur in maniera differente) si trovano in una sorta di semplicità ontologica. L'anziano e
il bambino, quando stanno insieme, possono manifestarsi disinvoltamente per quello che sono,
senza rimproveri né rancori, perché liberi dalle attese e pretese che inevitabilmente nascono con
l'assunzione di ruoli.
Tuttavia, intercorre una differenza decisiva fra la stagione inaugurale e quella conclusiva della
vita. Mentre i bambini sono sempre particolarmente attenti alle regole (siano quando le rispettano
sia quando le trasgrediscono), perché servono loro da coordinate per capire come potersi muovere
adeguatamente in una realtà che non sono essi a dirigere, gli anziani tendono a disinteressarsi delle
convenzioni che li circondano, assumendo spesso comportamenti semi-anarchici, facilmente
stigmatizzati come strambi. Si concedono con frequenza deroghe al senso comune, perché questo
non li riguarda più, non avendo l'esigenza di farsi accettare dagli altri e dalla società. Essi si
allontano dal “grande mondo”, e glielo si dovrebbe lasciar fare, dal momento che ad occuparli
adesso è la santificazione di un piccolo cosmo fatto di rituali, di gesti ostinatamente ripetuti i quali,
lungi dal costituire forme di autocostrizione, sono invece il segno di quella redenzione che è il
nucleo etico della vecchiaia.
43
Un simile “vizio” caratterizza anche le opinioni di figure culturali certamente non di secondo piano: penso, ad
esempio, a ciò che scrive Simone de Beauvoir nel suo testo La Vieillesse, Gallimard, Paris, 1970, trad. it. di B. Fonzi,
La terza età, Einaudi, Torino, 2008.
44
J. Hillman, The Force of Character and the Lasting Life, Random House, New York, 1999, trad. it. di A. Bottini, La
forza del carattere, Adelphi, Milano, 2000, p. 92. Si vedano le interessanti considerazioni di Sergio Tramma nel suo
Inventare la vecchiaia, Meltemi, Roma, 2003.
17
80
4. Le opere dei giorni
Il divenire felici si distribuisce anche in una frequenza temporale più fitta del ciclo delle stagioni
dell'esistenza, in una pulsazione ritmica meno eclatante ma, come già si è intravisto, altrettanto
decisiva: la scansione delle giornate.
C'è da rilevare che questa configurazione della temporalità umana di solito è lasciata in disparte
dalla filosofia, la quale tradizionalmente è maldisposta verso tutto ciò che pertiene all'orizzonte del
quotidiano, propendendo piuttosto a scorgervi «l'insieme delle scorie dell'esistenza». Così scrivono
Armando Plebe e Pietro Emanuele in un loro saggio sull'argomento:
«La storia delle riflessioni filosofiche sulla quotidianità è [...] una sorta di storia trasversale che
interferisce in maniera anomala nello sviluppo del pensiero filosofico. [...] Se [...] nel pensiero
contemporaneo la quotidianità si vede fatta oggetto di un'attenzione che non aveva mai avuto, questo
suo avvento non è né pacifico né trionfalistico. Anzi, da un lato il marxismo ne fa il cahier de
doléance della giornata lavorativa alienata, dall'altro l'esistenzialismo ne fa il ricettacolo di ogni
sciagura: l'inautenticità, la banalità, l'impersonalità. [...] Se la vecchia indifferenza verso il quotidiano
conduceva all'astrazione, la nuova denigrazione di essa ha rischiato di condurre verso esiti mistici.» 45
Qui non è necessario addentrarsi nel merito della critica del quotidiano svolta dagli autori di
scuola marxista, trattandosi di un ambito di riflessione a carattere prevalentemente sociologico46;
conviene però riportare una considerazione di Paolo Jedlowski il quale fa notare come nell'opera del
pensatore di Treviri, a ben vedere, non sia presente una specifica problematizzazione e
concettualizzazione della vita quotidiana in quanto tale: la sua attenzione si focalizza infatti
sull'individuazione delle leggi immanenti che determinano (ieri come oggi) le difficili condizioni di
molti lavoratori47.
Per quanto concerne l'esistenzialismo, direi che la sua denigrazione della dimensione della
quotidianità dipende non tanto dalla critica agli stili di vita massificati e conformistici che si sono
imposti a partire dall'inizio del Novecento, quanto dall'aver stabilito il primato dell'angoscia come
condizione emotiva specifica dell'umano e definito la temporalità esistenziale in conformità alla
45
A. Plebe, P. Emanuele, I filosofi e il quotidiano, Laterza, Roma-Bari, 1992, pp. VIII-IX.
Per passare in rassegna le principali posizioni operanti in tale orizzonte critico (quelle di Lefebvre, Kosík, Lukács,
Heller) sono ricorso al saggio di Roberto Mancini L'uomo quotidiano. Il problema della quotidianità nella filosofia
marxista contemporanea, Marietti, Torino, 1985.
47
Cfr. P. Jedlowski, Il tempo dell'esperienza. Studi sul concetto di vita quotidiana, Franco Angeli, Milano, 1986, p. 10.
46
18
81
predominanza di questa tonalità emotiva. Se il soggetto è preso nella morsa costante dello stato
d'animo angoscioso, il tempo di cui può fare esperienza è contratto nella puntualità, ridotto ad una
estensione minimale dove si concentrano tutte le possibili forme dei rimandi temporali (al passato e
al futuro). Tuttavia, come avverte Bollnow, la temporalità istantanea non consente «la stabilità
dell'essere-sostenuti da uno sviluppo temporale, né un ponte che conduca da un istante all'altro»48. Il
soggetto, cioè, viene pensato dall'esistenzialismo come costretto in un tempo inospitale, privo di
qualsivoglia forma di continuità e di fiduciosa confidenza con l'accadere storico49. Si ritiene che la
coscienza, pressata fra la minaccia della morte che attende nel futuro e il fardello del passato che
opprime alle spalle, debba concentrare tutte le sue energie sull'acutezza del “batter d'occhio”
(Augenblick) e assumere decisioni anticipatrici che possiedono, pertanto, la gravità delle scelte
fatali. In tal modo, l'esperienza del tempo viene drammatizzata fino al punto di farne una «linea di
combattimento» che non può essere abbandonata50 e nella quale, del resto, non si capisce come sia
possibile vivere degnamente.
La persuasione che la temporalità umana sia fatalmente abitata da un sentimento angoscioso è
propria
anche
di
pensatori
contemporanei
non
direttamente
riconducibili
all'ambito
dell'esistenzialismo. Basti pensare ad un autore come Jankélévitch, che così scrive:
«Il sovvenire ed il sopravvenire, il ricordo e l'avvenire ci offrono solo il quid senza il quod; ora, è
nell'accadere, in altri termini nel presente del divenire, che l'esistenza e la consistenza coinciderebbero
[...] Ahimè! Questa stessa coincidenza non dura che un istante, ma una durata infinitesimale è ancora
una durata? [...] l'istante esclude la persistenza di “qualche cosa” [...] per questo il vero nome di questa
apparizione disparente, oggetto dell'intravvedimento, è Quasi-niente.»51
48
O. F. Bollnow, Das Wesen Stimmungen, Klostermann, Frankfurt am Main, 1956, trad. it. di D. Bruzzone, Le tonalità
emotive, Vita e Pensiero, Milano, 2009, p. 73.
49
È questo uno dei temi su cui può essere misurata la distanza che separa il pensiero di Heidegger e quello di Sartre
dalla filosofia dell'esistenza di Karl Jaspers, dove notoriamente la storicità è posta in primo piano.
50
Mi riferisco al racconto di Kafka riportato da Hannah Arendt nel suo Between Past and Future: Six Exercises in
Political Thought, Viking, New York, 1961, trad. it. di T. Gargiulo, Tra passato e futuro, Garzanti, Milano, 1999, pp.
29-39. Vi viene descritto un “Egli” che combatte con due avversari: «il primo lo incalza alle spalle, dall'origine, il
secondo gli taglia la strada davanti».
51
V. Jankélévitch, Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, Éditions de Seuil, 1980, trad. it. di C. A. Bonadies, Il non-soche e il quasi niente, Marietti, Genova, 1987, p. 54. In un altro passaggio l'autore definisce il tempo una «apocalisse
continua» (ivi, p. 19).
19
82
Al di là di questi casi specifici, sembra possibile affermare che l'intera tradizione occidentale si sia
data ben da fare nell'operare la drammatizzazione dell'esperienza antropologica del tempo. Lo
suggerisce Giacomo Marramao, laddove afferma che nel nostro orizzonte culturale si dà un
«fattore patologico profondamente innervato [...] che trova la sua cifra nella figura del futuro passato.
Il tempo – così come è messo in luce da Aristotele e come verrà poi sviluppato dalla teoria agostiniana
della “presentificazione” e da quella heideggeriana del “precorrere” – è un flusso di “ora” che vengono
dall'ora-non-ancora e vanno verso l'ora-non-più: flusso che non è affatto indeterminato, ma che ha in
sé una direzione dal futuro verso il passato. Accade così che la durata 'presentificante' [...] abbia in sé
introiettata una pulsione all'aspettativa [...] l'anticipazione progettuale è stata estrapolata come forma
“autentica”, come figura specifica e dominante dell'esperienza del tempo [...] Per questa ragione,
proprio in Occidente, la stessa 'normalità' e la stessa esperienza 'ordinaria' vengono ad assumere le
singolari sembianze di un paradosso.»52
Tuttavia questo habitus, proprio in quanto costituisce un costrutto culturale, può essere dismesso
o perlomeno allentato, e mi pare che un modo per farlo sia per l'appunto quello di abituarsi a
(ri)sincronizzare il vivere sul ritmo del giorno-per-giorno. Ciò non significa evidentemente
abbracciare una sorta di carpe diem, come gli abitanti di Leonia che ogni mattina re-iniziano da
capo il loro stare al mondo. Al contrario, intendo dire che la maturazione umana, in quanto processo
che non “funziona in automatico” – come invece è nel caso del progresso –, richiede una confidenza
con se stessi, ovvero necessita che la persona acquisisca gradualmente familiarità con i semi del suo
essere. Questi danno i loro frutti nel tempo lungo del ciclo delle stagioni dell'esistenza, ma per
poterlo fare devono essere coltivati con costanza e solerzia. Per dirla altrimenti, la maturazione
abbisogna di gesti che pertengono a quella che chiamerei l'etica del presidio del tempo; un'etica che
ben conoscono i contadini e gli artigiani, i quali svolgono con fermezza e insieme con pazienza il
loro operare. Da loro, quindi, sarebbe da imparare che il quotidie non deve né spaventare né
annoiare, ma che anzi in esso si nasconde il “tesoro” dell'esperienza (Erfahrung).
«Nei nostri libri di lettura c'era la favola del vecchio che, sul letto di morte, dà ad intendere ai figli che
nella sua vigna è nascosto un tesoro. Loro non avevano che da scavare. Scavarono, ma del tesoro
52
G. Marramao, Kairós. Apologia del tempo debito, Laterza, Roma-Bari, 1993, pp. 77-78.
20
83
nessuna traccia. Quando però giunge l'inverno, la vigna rende come nessun'altra nell'intera stagione. I
figli allora si rendono conto che il padre aveva lasciato loro un'esperienza»53.
A segnalare come opportuno questo sforzo di riposizionamento ritmico sono inoltre le attuali
riflessioni sulle pratiche di cura, quali forme attive e modi di essere impegnati nel promuovere
possibilità e occasioni di ben-essere umano54. Alle pratiche dell'aver cura necessita un agire capace
di incorporare un genere di modulazione temporale che consenta di esercitare la riflessività, la
responsività, l'attenzione, la creatività, il sentire empatico55; tali attività risultano fruttuose nella
misura in cui hanno modo di ritornare su se stesse, per correggersi e perfezionarsi: esigenze, queste,
che si soddisfano nel ritmo del giorno-per-giorno, poiché in esso l'orientamento teleologico che
attiene ad ogni forma dell'agire umano – e tanto più all'agire indirizzato a favorire il ben-essere –
assume l'andamento circolare, tipico dell'apprendimento di gesti curanti. Nel ritmo del giorno-pergiorno, insomma, convivono in maniera solidale la figura della linea e quella del cerchio, che la
nostra cultura ha tradizionalmente considerato inconciliabili.
In questa prospettiva, si pensi a quanto il buon esito di una terapia psicologica (a prescindere dallo
specifico approccio metodologico che la caratterizza) dipenda dalla circostanza che la persona si
abitui a frequentare di giorno in giorno un nuovo stile di pensiero e azione, e come questo lavoro
minuto e umile possa riaprire le fonti della sua felicità. Per guardare invece al versante del caregiving, le professioni educative e mediche vengono svolte al meglio quando insegnanti, infermieri e
medici sanno adattare i tempi predeterminati e rigidamente finalizzati dei programmi e dei
protocolli alle esigenze subitanee e mutevoli dei pazienti e degli studenti; questi manifestano ogni
giorno la loro presenza viva mediante richieste e proposte che vanno accolte se si vuole rispettare e
valorizzare la loro dignità di soggetti umani unici.
Data la scarsità di luoghi filosofici in cui poter reperire elementi utili per riflettere sulla
temporalità del quotidie, reputo che sia lecito rivolgersi all'ambito della letteratura. Nella fattispecie,
alla vicenda narrata da Michel Tournier nel suo romanzo Venerdì o il limbo del Pacifico, un testo
che rovescia la “morale” del celebre racconto di Dafoe: qui infatti è Venerdì a condurre Robinson in
53
W. Benjamin, Esperienza e povertà (1933), in Id., Aura e choc. Saggi sulla teoria dei media, a cura di A. Pinotti e A.
Somaini, Einaudi, Torino, 2012, p. 365.
54
L'aver cura è «un tipo di attività che include ogni cosa che noi facciamo per conservare, preservare e riparare il nostro
mondo così che possiamo vivere in esso nel miglior modo possibile. Questo mondo include i nostri corpi, i nostri sé e
il nostro ambiente, che noi cerchiamo di connettere in una complessa rete che sostiene la vita» (L. Mortari, La pratica
dell'aver cura, Bruno Mondadori, Milano, 2006, p. 33).
55
Per questi e altri caratteri propri del curare cfr. ivi, pp. 111-152.
21
84
“un'altra vita”, aiutandolo a portare a compimento una trasfigurazione che da tempo si era avviata
nell'esistenza del naufrago.
All'inizio della sua permanenza sull'isola di Speranza, dopo aver verificato la completa solitudine
in cui si trova, Robinson conosce una prima fase di profonda accidia che lo induce a lasciarsi vivere
e ad abbandonarsi a lunghi momenti di trasognamento al limite della sragione. In seguito ad un
tentativo fallito di abbandonare l'isola, decide di divenirne il “padrone”; si dedica pertanto all'esatta
misurazione della sua superficie, alla coltivazione assidua di ampie porzioni del territorio,
all'edificazione di una dimora-fortezza, e perfino alla promulgazione di una costituzione e di un
codice penale. Mentre porta avanti questi lavori si rende conto che la completa riconquista di una
forma civilizzata di esistenza gli sarebbe accessibile solo ristabilendo un ferreo governo del tempo.
Nel suo diario scrive in proposito:
«Mi è apparsa d'un tratto con imperiosa evidenza la necessità di lottare contro il tempo, vale a dire di
imprigionare il tempo. Mentre, lasciandomi andare, sto vivendo un giorno dopo l'altro, il tempo mi
scivola tra le dita, io perdo il mio tempo, mi perdo. Tutto sommato, ogni problema di questa isola si
potrebbe tradurre in termini di tempo e non è un caso se – partendo dal fondo – ho cominciato a vivere
qui come fuori del tempo. Inaugurando un calendario, ho ripreso possesso di me medesimo. D'ora in
poi, devo fare di più. Di questo primo raccolto di grano e d'orzo, nulla dev'essere inghiottito dal
presente: sia per intero un'energia rivolta verso l'avvenire.»56
La vita di Robinson torna, così, ad obbedire a quell'esigenza di produttività esistenziale che aveva
plasmato la sua visione del mondo nel corso di tutti gli anni precedenti al naufragio. La costruzione
di una clessidra ad acqua sancisce questa “vittoria”:
«[è la voce del narratore che parla] Nell'udire – di giorno o di notte – il rumore regolare delle gocce
che cadevano nella bacinella, provava il sentimento orgoglioso che il tempo non scivolasse più a suo
dispetto in un abisso oscuro, ma che anch'esso fosse ormai regolato, padroneggiato, in una parola
addomesticato, come stava per diventare tutta l'isola, a poco a poco, per la forza d'animo di un solo
uomo.»57
56
M. Tournier, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, Gallimard, Paris, 1967, trad. it. di C. Lusignoli, Venerdì o il limbo
del Pacifico, Einaudi, Torino, 1994, pp. 61-62. Cfr. G. Deleuze, Michel Tournier e il mondo senza Altri, in Id.,
Logique du sens, Minuit, Paris, 1969, trad. it. di M. De Stefanis, Logica del senso, Feltrinelli, Milano, 2009, pp. 264281.
57
Ivi, p. 67.
22
85
Nondimeno, dopo un lungo periodo trascorso conducendo in maniera sempre più efficiente lo
sfruttamento delle risorse naturali dell'isola, l'albero-calendario sul quale Robinson segna la
successione del tempo viene accidentalmente distrutto: ciò innesca in lui un mutamento profondo
che lo fa accedere all'esperienza di una tipologia di temporalità che gli era sconosciuta.
«Ciò che si è più trasformato nella mia vita è lo scorrere del tempo, la sua velocità e anche il suo
orientamento. Una volta, ogni giornata, ogni ora, ogni minuto erano in certo modo inclinati verso la
giornata, l'ora e il minuto seguente, e tutti insieme venivano aspirati dall'attesa del momento la cui
inesistenza provvisoria creava una specie di vacuum. Così il tempo passava rapidamente e utilmente,
tanto più rapido quanto più utilmente impiegato (...) la mia breve vita era per me un segmento
rettilineo i cui due estremi puntavano assurdamente verso l'infinito, come in un giardino di pochi
arpenti nulla rivela la sfericità della terra. (...) Per me ormai il ciclo si è ristretto al punto da
confondersi con l'istante. Il moto circolare si è fatto così rapido che più non si distingue
dall'immobilità. Potrei dire, di conseguenza, che le mie giornate si sono raddrizzate. Non traboccano
più le une sulle altre. Restano in piedi, verticali, e si affermano fieramente nel loro valore
intrinseco.»58
Aveva già avvertito, seppur brevemente, questo differente sentimento del tempo una mattina in
cui, dopo aver scoperto che la sera precedente aveva dimenticato di caricare l'acqua nella clessidra,
un commovente «momento d'innocenza» e di «felicità abbagliante» si era impossessato di lui.
«Aveva creduto dapprima che il fermarsi della clessidra avesse allentato solo per lui le maglie
dell'impiego del tempo, sospendendo l'urgenza delle sue fatiche. Ma ora si accorgeva che questa pausa
riguardava meno lui che non l'isola intera. Si sarebbe detto che cessando all'improvviso di inclinarsi le
une verso le altre nel senso del loro uso – e del consumo – le cose fossero rientrate ognuna nella
propria essenza, dispiegando tutti i loro attributi, esistendo solo per se stesse, ingenuamente, senza
cercare altra giustificazione se non quella della propria perfezione.»59
Robinson scopre che sotto la linea dell'ordinamento progressistico della temporalità si cela
un'altra possibile esperienza del tempo, più “arcaica”60. Grazie all'andamento di questo ritmo
58
Ivi, p. 81.
Ivi, pp. 92-93
60
Si direbbe che Robinson ritrovi la concezione tipica delle culture dell'antichità secondo cui i singoli giorni sono dotati
di uno specifico “carattere”; ad esempio, nella Grecia di Esiodo si parlava del giorno come fosse «una creatura
59
23
86
inedito, i singoli giorni non sono più vuoti da colmare ma misure temporali che gli si offrono come
già dotate di senso e che si lasciano abitare. Assumendo il respiro del giorno-per-giorno, Robinson
inizia a conoscere davvero Venerdì e impara a comprenderlo, così come per la prima volta “vede”
l'isola di Speranza e non più il mero oggetto d'uso prodotto dal suo sguardo reificante.
vivente, uno spirito personale, un daimon» (R. B. Onians, The Origins of European Thought, Cambridge University
Press, Cambridge, 1954, trad. it. di P. Zaninoni, Le origini del pensiero europeo, Adelphi, Milano, 2006, p. 495).
24
87
Congedo
Ho trattato il concetto di felicità non come un concetto-sostanza ma come un concetto-territorio,
ossia come un orizzonte di senso ampio, mobile e internamente variegato. Muovendomi al suo
interno, mi sono soffermato presso tre principali luoghi tematici (sofferenza, desiderio, temporalità)
in quanto persuaso che, rispetto alle domande di felicità del presente, essi siano quelli che
richiamano con maggiore urgenza l'attenzione filosofica. Tuttavia, nel concludere il percorso di
indagine non posso non ritenere che esso dovrebbe subito ripartire e inoltrarsi in direzioni di
sviluppo che consentano di “perlustrare” tale orizzonte di senso in maniera più dettagliata.
Mi limito ad indicare soltanto tre fra i numerosi modi in cui questa impresa potrebbe essere
condotta:
a) osservare da vicino il mutamento della domanda di felicità (nella sua forma e nel suo contenuto)
in relazione al progressivo estinguersi dell'esperienza del sacro – esperienza che può assumere
caratteri sia strettamente religiosi, sia spirituali nell'accezione più ampia del termine (il sentirsi in
contatto con una sorgente di Bene, che può essere scorta ad esempio nella natura come “grande
essere” di cui si è parte);
b) valutare accuratamente gli effetti della drastica riduzione della possibilità di legare il desiderio a
scopi-valori che appartengano alla dimensione lavorativa, in conseguenza della drammatica
incertezza che abita il cosiddetto “mercato del lavoro” – tale circostanza può infatti destabilizzare
profondamente le dinamiche psichiche della persona e, pertanto, avvelenare la sua capacità di
relazionarsi e di agire in maniera moralmente adeguata, sia nella dimensione privata che in quella
pubblica;
c) considerare quanto il crescere delle opportunità di venire a contatto con tradizioni culturali
differenti da quella occidentale possa favorire il dischiudersi di preziose chances di ripensamento e
arricchimento dell'idea di felicità – ad esempio, in alcune di queste tradizioni non si tende a
concepire l'esperienza del soffrire come fosse in necessaria antitesi alla condizione felice (si è visto
quanto questo nodo della questione sia decisivo).
1
88
Vorrei inoltre impiegare queste ultime pagine per riferire brevemente di una condizione affettiva
che ha accompagnato alcuni tratti del mio cammino di studio, in particolar modo durante le sue fasi
iniziali. Infatti, la scelta di provare ad assumere uno stile di pensiero curante è coincisa con un
coinvolgimento di carattere personale, e quindi anche emotivo, con i temi presi in esame: un
coinvolgimento che mi è parso di non dover contrastare ma invece favorire, affinché il mio lavoro
potesse risultare essere (come mi auguro sia accaduto) un'effettiva pratica filosofica.
Talvolta ho avvertito un doloroso imbarazzo per il fatto di impiegare un così lungo tempo e così
tante energie al fine di poter pensare la felicità, quando la sua assenza sembra circondarci, quasi
assediarci. Incalcolabili sono le esistenze che ora, mentre sto scrivendo, non possono in alcun modo
permettersi nemmeno di sperare che esista per loro qualcosa degno di essere chiamato felicità. La
miseria materiale, l'abbandono, la violenza fisica e quella morale, l'invisibilità agli occhi degli altri,
il silenzio di chi non può parlare e di chi non è ascoltato: questi e tanti altri mali attanagliano la vita
di molte delle persone che abbiamo intorno, e non solo di coloro che abitano luoghi talmente
distanti dalle nostre coscienze che nessuna globalizzazione ce li può avvicinare. Se il mondo è
questo – ho a volte riflettuto –, e se lo è in una misura di gran lunga maggiore di quanto vorremmo
poterci dire, davvero ha senso dedicarsi a pensare la felicità? A che pro? Non ci sono forse urgenze
ben più impellenti (di ordine economico, politico, sociale) a cui rivolgere l'attenzione e verso le
quali convogliare la forza delle proprie idee? E poi il dubbio più terribile: se fosse proprio questo
stato di cose, questa disparità abominevole e fatale che divide i dannati dai fortunati, a consentire a
me come ad altri di potersi concedere di arrovellarsi su cosa sia la felicità umana? Se fosse così,
l'impegno intellettuale profuso non sarebbe avvelenato da una colpa o comunque irrimediabilmente
sfregiato dal segno dell'ipocrisia?
Confesso che non ho saputo darmi risposte definitivamente soddisfacenti a questi interrogativi,
anzi ho provato ad evitarli, a ripararmi dalla verità che mi pare essi portino con sé. Mi sono però
imbattuto in un pensiero di un autore a me molto caro, Elias Canetti, che mi ha consentito di
imparare a coabitare con questa verità minacciosa: «Solo se pensi alla gente saprai qualcosa».
Leggendo questa frase, una piccola porta si è subito aperta e alcune idee ariose l'hanno attraversata.
Qui mi basta ricordarne una.
Forse il pensare filosofico è un gesto che in fondo non appartiene del tutto a colui che lo compie;
forse è piuttosto qualcosa che lo visita, che lo attraversa. Esso sembra provenire dal mondo e dai
suoi abitanti che, misteriosamente, paiono invocarlo, quasi pretenderlo: come se dicessero “pensa
anche per noi”. E ciò potrebbe magari spiegare i due tratti che più nettamente contraddistinguono il
2
89
filosofare dalle altre forme del pensiero umano (il calcolare, il progettare, il prevedere, ecc.), ovvero
l'ostinatezza e l'imprevedibilità.
Se davvero è così, come appunto mi sono trovato a credere, l'importanza di pensare la felicità
sarebbe legata anzitutto al “da dove”, al luogo da cui si origina tale pensare, ossia nell'inscindibile
relazione che colui che pensa ha con gli altri – “la gente” –, perché è in virtù di loro che può
pensare. Riconoscere questo equivale forse a riuscire, almeno un po', anche a pensare in loro favore.
3
90
Bibliografia*
Bibliografia specifica
Adorno, T. W., Minima moralia. Reflexionem aus dem beschadigtem Leben, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main, 1951, trad. it. di R. Solmi, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa,
Einaudi, Torino, 1994.
Alici, L. (a cura di), Tempo e storia. Il «divenire» nella filosofia del '900, Città Nuova, Roma, 1978.
–, La felicità e il dolore. Verso un'etica della cura, Aracne, Roma, 2010.
Annas, J., The Morality of Happiness, Oxford University Press, 1993, trad. it. di M. Andolfo, La
morale della felicità in Aristotele e nei filosofi dell'età ellenistica, Vita e Pensiero, Milano,
1997.
Arendt, H., Between Past and Future: Six Exercises in Political Thought, Viking, New York, 1961,
trad. it. di T. Gargiulo, Tra passato e futuro, Garzanti, Milano, 1999.
Aristotele, Etica Nicomachea, a cura di C. Mazzarelli, Rusconi, Milano, 1996.
Babini, P., La vita come invenzione. Motivi bergsoniani in psichiatria, il Mulino, Bologna, 1990.
Bachelard, G., La dialectique de la durée, Bovin, Paris, 1936, trad. it. di D. Mollica, La dialettica
della durata, Bompiani, Milano, 2010.
–, La poétique de l'espace, Presses Universitaires de France, Paris, 1957, trad. it. di E. Catalano, La
poetica dello spazio, Edizioni Dedalo, Bari, 2006.
*
La bibliografia specifica concerne le opere da cui sono state ricavate le citazioni dirette e indirette presenti sia nel
corpo del testo sia in nota; la bibliografia generale riporta i lavori ai quali si rimanda per un approfondimento delle
tematiche affrontate e comprende alcune opere non segnalate nelle pagine precedenti.
91
Barale, F., Bertani, M., Gallese, V., Mistura, S., Zamperini A. (a cura di), Psiche. Dizionario
storico di psicologia, psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze, Einaudi, Torino, 2009.
Barbaras, R., Le désir et la distance. Introduction à une phénoménologie de la perception, Vrin,
Paris, 1999.
Barone, P., Sparizioni. I due punti della soggettività, in “aut autˮ, n. 347 (2010).
Battacchi, M. W., Vergogna e senso di colpa. In psicologia e nella letteratura, Raffaello Cortina
Editore, Milano, 2002.
Baudrillard, J., L'échange symbolique et la mort, Gallimard, Paris, 1976, trad. it. di G. Mancuso, Lo
scambio simbolico e la morte, Feltrinelli, Milano, 2002.
Benasayag, M., Schmit, G., Les passions tristes. Souffrance psychique et crise sociale, La
Découverte, Paris, 2003, trad. it. di E. Missana, L'epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano,
2004.
Benjamin, W., Schriften, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1955, trad. it. di R. Solmi, Einaudi,
Torino, 1995
–, Esperienza e povertà (1933), in Id., Aura e choc. Saggi sulla teoria dei media, a cura di A.
Pinotti e A. Somaini, Einaudi, Torino, 2012.
Benveniste, É., Problèmes de linguistique générale, Gallimard, Paris, 1966, trad. it. di M. V.
Giuliani, Problemi di linguistica generale, il Saggiatore, Milano, 1994.
–, Le vocabulaire des institutions indo-européennes. I. Économie, parenté, societé, Les Éditions de
Minuit, Paris, 1969, trad. it. di M. Liborio, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, vol. I,
Economia, parentela, società, Einaudi, Torino, 2001.
Bergson, H., La Pensée et le Mouvant (1934), trad. it. di G. Perrotti, Il pensiero e il movente. Saggi
e conferenze, Olschki, Firenze, 2001.
92
Blumenberg, H., Die Legitimitat der Neuzeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1974, trad. it. di C.
Marelli, La legittimità dell'età moderna, Marietti, Genova, 1992.
Bodei, R., Cifre significanti del pensiero filosofico, in AA.VV., Exodus. Congedi dal II Millennio,
Edizioni Augustinus, Palermo, 1993.
Boella, L., Sentire l'altro. Conoscere e praticare l'empatia, Raffaello Cortina Editore, Milano,
2006.
Bollnow, O. F., Das Wesen Stimmungen, Klostermann, Frankfurt am Main, 1956, trad. it. di D.
Bruzzone, Le tonalità emotive, Vita e Pensiero, Milano, 2009.
Bonomi, A., Borgna, E., Elogio della depressione, Einaudi, Torino, 2011.
Borgna, E., Prefazione a A. Ehrenberg, La fatigue d'être soi. Depression et société, Editions Odile
Jacob, Paris, 1998, trad. it. di S. Arecco, La fatica di essere se stessi. Depressione e società,
Einaudi, Torino, 2010.
Butler, J., Subjects of Desire. Hegelian Reflections in Twentieth-Century France, Columbia
University Press, New York, 1999, trad. it. di G. Giuliani, Soggetti di desiderio, Laterza,
Roma-Bari, 2009.
Cacciari, M., Toccare Dio, in M. Ciampa (a cura di), Domande a Giobbe. Modernità e dolore,
Bruno Mondadori, Milano, 2005.
Calvino, I., Le citta invisibili, Mondadori, Milano, 2011.
Canetti, E., Die Provinz des Menschen. Aufzeichnungen 1942-1972, Hanser, München, 1973, trad.
it. di F. Jesi, La provincia dell’uomo. Quaderni di appunti 1942-1972, Adelphi, Milano, 2006.
–, Die Fliegenpein. Aufzeichnungen, Hanser, München, 1992, trad. it. di R. Colorni, La tortura
delle mosche, Adelphi, Milano, 1993.
93
Cassano, F., L'umiltà del male, Laterza, Roma-Bari, 2011.
Cavarero, A., “Identità”, intervista del Febbraio 1997, www.emsf.rai.it.
Ceronetti, G. (a cura di), Il Libro di Giobbe, Adelphi, Milano, 1972.
–, Il silenzio del corpo, Adelphi, Milano, 1994.
–, La carta è stanca, Adelphi, Milano, 2000.
– (a cura di), Qohélet. Colui che prendere la parola, Adelphi, Milano, 2001.
Corbellini, G., Morire di depressione, “Il Sole 24 Oreˮ, 4 dicembre 2011.
Damasio, A., Decarter's Error. Emotion, Reason, and the Human Brain, Putnam, New York, 1994,
trad. it. di F. Macaluso, L'errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Adelphi,
Milano, 2005.
Danani, C., Idoli e ideali. Considerazioni intorno a utopia, in “Annali del Dipartimento di Filosofia
e Scienze Umane”, Università di Macerata, XXXIII, 2000.
Deleuze, G., Istinti e istituzioni (1955), in Id., L'isola deserta e altri scritti. Testi e interviste 19531974, a cura di D. Borca, Einaudi, Torino, 2007.
–, Pouparlers, Les Éditions de Minuit, Paris, 1990, trad. it. di S. Verdicchio, Pourparler, Quodlibet,
Macerata, 2000.
Deleuze, G., Guattari, F., L'Anti-Œdipe, Les Éditions de Minuit, Paris, 1972, trad. it. di A. Fontana,
L'anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, Einaudi, Torino, 2002.
–, Qu'est-ce que la philosophie?, Les Éditions de Minuit, Paris, 1991, trad. it. di C. Arcuri, Che
cos'è la filosofia?, Einaudi, Torino, 2002.
Deleuze, G., Parnet, C., Dialogues, Flammarion, Paris, 1977, trad. it. di G. Comolli, Conversazioni,
ombre corte, Verona, 1998.
de Luise, F., Farinetti, G., Storia della felicità. Gli antichi e i moderni, Einaudi, Torino, 2001.
94
Derrida, J., Dufourmantelle, A., De l'hospitalité, Calmann-Lévy, Paris, 1997, trad. it. di I. Landolfi,
Sull'ospitalità, Baldini & Castoldi, Milano, 2000.
Ehrenberg, E., La fatigue d'être soi. Depression et société, Éditions Odile Jacob, Paris, 1998, trad.
it. di S. Arecco, La fatica di essere se stessi. Depressione e società, Einaudi, Torino, 2010.
Fermani, A., Vita felice umana: in dialogo con Platone e Aristotele, EUM, Macerata, 2006.
–, Aristotele e i profili del pudore, in “Rivista di Filosofia Neo-Scolastica”, n. 2-3 (2008).
Ferrara, A., L'eudaimonia postmoderna. Mutamento culturale e modelli di razionalità, Liguori,
Napoli, 1992.
Foucault, M., Introduction à l'Antropologie (1964), trad. it. di M. Bertani, Introduzione
all'«Antropologia» di Kant, in I. Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798), trad.
it. di G. Garelli, Antropologia dal punto di vista pragmatico, Einaudi, Torino, 2010.
–, Pouvoir et corps (1975), trad. it. di A. Fontana, P. Pasquino e G. Procacci, Potere e corpo, in Id.,,
Il discorso, la storia, la verità. Interventi 1969-1984, a cura di M. Bertani, Einaudi, Torino,
2001.
–, Le Gai savoir (1978), trad. it. di D. Borca, Il gay sapere, in "aut aut", n. 331 (2006).
–, L'herméneutique du sujet. Cours au Collège de France 1981-1982, Seuil/Gallimard, Paris, 2001,
trad. it. di M. Bertani, L'ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France (1981-1982),
Feltrinelli, Milano, 2003.
–, The Subject and the Power, Afterword, in H.L. Dreyfus-P. Rabinow, Michel Foucault: Beyond
Structuralism and Hermeneutics, The University of Chicago Press, Chicago, 1982, trad. it. di
D. Benati, M. Bertani e I. Levrini, La ricerca di Michel Foucault. Analitica della verità e storia
del presente, GEF, Firenze, 1989.
–, L'étique du souci comme pratique de la liberté (1984), trad. it. L'etica della cura di sé come
pratica della libertà, in Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste 3. 1978-1985.
Estetica dell'esistenza, etica, politica, a cura di A. Pandolfi, Feltrinelli, Milano, 1998.
–, What is Enligthenment? (1984), trad. it. Che cos'è l'Illuminismo?, in ivi.
95
Freud, S., Das Unbehagen in der Kultur (1929), trad. it. di E. Sagittario, Il disagio della civiltà e
altri scritti, Bollati Boringhieri, Torino, 1971.
Frugoni, F., Storia di Chiara e Francesco, Einaudi, Torino, 2011.
Galimberti, U., Psichiatria e fenomenologia, Feltrinelli, Milano, 2003.
–, Il corpo, Feltrinelli, Milano, 2005.
–, Dizionario di psicologia, Utet, Torino, 1994, edizione speciale realizzata per Gruppo Editoriale
L'Espresso, 2006.
Gehlen, A., Die Seele im technischen Zeitalter, Rowohlt, Hamburg, 1957, trad. it. di A. Cori,
L'uomo nell'era della tecnica. Problemi socio-psicologici della civiltà industriale, Sugar,
Milano, 1967.
Goodman, S., Sound Warfare. Sound, Affect, and the Ecology of Fear, MIT, Cambridge, 2010,
formato Kindle.
Hegel, G. W. F., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), a cura di
A. Bosi, Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in compendio, Utet, Torino, 2000.
–, Vorlesungen über die Aesthetik (1836), trad. it. di N. Merker e N. Vaccaro, Estetica, Feltrinelli,
Milano, 1963.
Heidegger, M., Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1927, a cura di F. Volpi,
Longanesi, Milano, 2005.
–, Was ist Metaphysik? (1929), trad. it. di F. Volpi, Che cos'è la metafisica?, in Id., Segnavia,
Adelphi, Milano, 1987.
–, Zollikoner Seminare. Protokolle-Gespräche-Briefe, Klostermann, Frankfurt am Main, 1987, trad.
it. di A. Giugliano, Seminari di Zollikon. Protocolli seminariali, colloqui, lettere, Guida,
Napoli, 1991.
Heller, Á., The Power of Shame. Essays on Rationality, Routledge & Kegan, London, 1985, trad. it.
di M. Rocci, Il potere della vergogna, Editori Riuniti, Roma, 1985.
96
Hemingway, E., Death in the Afternoon, Scribner's, New York, 1932, trad. it. di F. Pivano, Morte
nel pomeriggio, Einaudi, Torino, 1967.
Hillman, J., The Force of Character and the Lasting Life, Random House, New York, 1999, trad. it.
di A. Bottini, La forza del carattere, Adelphi, Milano, 2000.
Hobbes, T., De Homine (1658), a cura di A. Pacchi, Laterza, Roma-Bari, 1984.
Horn, C., Antike Lebenskunst: Glück und Moral von Sokrates bis zu den Neuplatonikern, Beck,
München, 1998, trad. it. di E. Spinelli, L'arte della vita nell'antichità. Felicità e morale da
Socrate ai neoplatonici, Carocci, Roma, 2004.
Iacoboni, M., Mirroring People. The New Science of How We Connect with Others, Farrar, Straus
and Giraux, New York, 2009, trad. it. di G. Olivero, I neuroni specchio. Come capiamo ciò che
fanno gli altri, Bollati Boringhieri, Torino, 2011.
Irigaray, L., J'aime à toi. Esquisse d'une félicité dans l'Histoire, Grasset & Fasquelle, Paris, 1992,
trad. it. di P. Calizzano, Amo a te. Verso una felicità nella Storia, Bollati Boringhieri, Torino,
1993.
Jaspers, J., Psychologie der Weltanschauungen, Springer, Berlin, 1925, trad. it. di V. Loriga,
Psicologia delle visioni del mondo, Astrolabio, Roma, 1983.
–, Philosophie. II - Existenzerhellung, Springer, Berlin, 1956, trad. it. di U. Galimberti, Filosofia 2.
Chiarificazione dell'esistenza, Mursia, Milano, 1978.
–, Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, Piper, München, 1962, trad. it. di F.
Costa, La fede filosofica di fronte alla rivelazione, Longanaesi, Milano, 1970.
Jankélévitch, V., Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, Éditions de Seuil, 1980, trad. it. di C. A.
Bonadies, Il non-so-che e il quasi niente, Marietti, Genova, 1987.
Jedlowski, P., Il tempo dell'esperienza. Studi sul concetto di vita quotidiana, Franco Angeli,
Milano, 1986.
97
Jervis, G., La conquista dell'identità. Essere se stessi, essere diversi, Feltrinelli, Milano, 1997.
–, Il mito dell'interiorità. Tra psicologia e filosofia, a cura di G. Corbellini e M. Marraffa, Bollati
Boringhieri, Torino, 2011.
Jullien, F., Nourrir sa vie à l'ècart du bonheur, Editions du Seuil, Paris, 2005, trad. it. di M. Porro,
Nutrire la vita. Senza aspirare alla felicità, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006.
Jung, C. V., Die Lebenswende (1931), trad. it. di A. Vita e G. Bollea, Gli stadi della vita, in Opere,
vol. 8, Bollati Boringhieri, Torino, 1994.
–, Zur Psychologie der Trinitätsidee (1942), trad. it. Saggio d'interpretazione psicologica del
dogma della Trinità, in Opere, vol. 11, Bollati Boringhieri, Torino, 1992.
Kant, I., Kritik der praktischen Vernunft (1788), trad. it. di F. Capra, Critica della ragion pratica,
Laterza, Roma-Bari, 2001.
–, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798), trad. it. di G. Garelli, Antropologia dal punto di
vista pragmatico, Einaudi, Torino, 2010.
Kristeva, J., Soleil Noir: dépression et mélancolie, Gallimard, Paris, 1987, trad. ingl. di L. S.
Roudiez, Black Sun: depression and melancholia, Columbia University Press, New York,
1989.
Lefebvre, H., Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life, Continuum, London, 2004.
Levi, P., I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino, 1986.
Lewis, M., Shame. The Exposed Self, Free Press, New York, 1992, trad. it. di G. Noferi, Il sé a
nudo. Alle origini della vergogna, Giunti, Firenze, 1995.
Lovinik, G., Tre tendenze del Web, in “aut aut”, n. 347 (2010), Web 2.0. Un nuovo racconto e i suoi
dispositivi.
98
Mancini, R., Godimento e verità. La vocazione metafisica del desiderio, in C. Ciancio (a cura di),
Metafisica del desiderio, Vita e Pensiero, Milano, 2003.
Marramao, G., Apologia del tempo debito, Laterza, Roma-Bari, 1993.
Marx, K., Zur Kritik der politischen Ökonomie (1859), trad. it. di E. Cantimori Mezzomonti, Per la
critica dell'economia politica, Editori Riuniti, Roma, 1979.
Maslow, A., Motivation and Personality, Harper, New York, 1954, trad. it. di E. Riverso,
Motivazione e personalità, Armando Editore, Roma, 1973.
Melchiorre, V., Corpo e persona, Marietti, Genova, 1987.
Merleau-Ponty, M., Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris, 1945, trad. it. di A.
Bonomi, Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano, 2003.
–, Le visible et l'invisible, Gallimard, Paris, 1964, trad. it. di A. Bonomi, Il visibile e l'invisibile,
Bompiani, Milano, 1969.
Minkowski, E., Vers une cosmologie. Fragments philosophiques, Aubier-Montaigne, Paris, 1936,
trad. it. di D. Tarizzo, Verso una cosmologia. Frammenti filosofici, Einaudi, Torino, 2005.
Morin, E., Le paradigme perdu: la nature humaine, Seuil, Paris, 1973, trad. it. di E. Bongioanni, Il
paradigma perduto. Che cos'è la natura umana?, Feltrinelli, Milano, 2001.
Mortari, L., La pratica dell'aver cura, Bruno Mondadori, Milano, 2006.
Nancy, J.-L., Être singulier pluriel, Galilée, Paris, 1996, trad. it. di D. Tarizzo, Essere singolare
plurale, Einaudi, Torino, 2001.
–, L'Intrus, Galilée, Paris, 2000, trad. it. di V. Piazza, L'intruso, Cronopio, Napoli, 2000.
Nietzsche, F., Morgenröthe. Gedanken über die moralischen Vorurteite (1881), trad. it. Aurora.
Pensieri sui pregiudizi morali, in Opere, vol. V, tomo I, Adelphi, Milano, 1964.
99
–, Die fröhliche Wissenschaft (1882), trad. it. La gaia scienza, in Opere, vol. V, tomo II, Adelphi,
Milano, 1965.
–, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen (1883-1885), trad. it. Così parlò
Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, in Opere, vol. VI, tomo I, Adelphi, Milano, 1973.
–, Nachlassene Fragmente 1984-1985, trad. it. Frammenti postumi 1884-1885 , in Opere, vol. VII,
tomo III, Adelphi, Milano, 1986.
Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G., Wagenaar, W. A., Atkinson & Hilgard's
Introduction to Psychology, Cengage Learning EMEA, Andover, 2009, trad. it. a cura di C.
Mirandola, Atkinson & Hilgard's Introduzione alla psicologia (15ª edizione), Piccin, Padova,
2011.
Onians, R. B., The Origins of European Thought, Cambridge University Press, Cambridge, 1954,
trad. it. di P. Zaninoni, Le origini del pensiero europeo, Adelphi, Milano, 2006.
Pavese, C., Il mestiere di vivere. Diario 1935-1950, Einaudi, Torino, 1982.
Perone, U., Le passioni del finito, EDB, Bologna, 1994.
–, Il presente possibile, Guida, Napoli, 2005.
Perri, M. L., L'uomo per l'umano. Ripensare il soggetto oltre la modernità, Il lavoro editoriale,
Ancona, 2002
Peter, J. P., Favret, J., L'animale, il pazzo, il morto, in M. Foucault (a cura di), Moi Pierre Rivière,
ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère..., Gallimard, Paris, 1973, trad. it. di A. Fontana e
P. Pasquino, Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello... Un
caso di parricidio nel XIX secolo, Einaudi, Torino, 2000.
Piaget, J., Six études de psychologie, Gonthier, Paris, Paris, 1964, trad. it. di E. Zamorani, Lo
sviluppo mentale del bambino, Einaudi, Torino, 1967.
Plebe, A., Emanuele, P., I filosofi e il quotidiano, Laterza, Roma-Bari, 1992.
100
Pulcini, E., La cura del mondo. Paura e responsabilità nell'età globale, Bollati Boringhieri, Torino,
2009.
Recalcati, M., L'uomo senza inconscio. Figure della nuova clinica psicoanalitica, Raffaello Cortina
Editore, Milano, 2010.
Ricoeur, P., Soi-même comme un autre, Seuil, Paris, 1990, trad. it. di D. Iannotta, Sé come un altro,
Jaca Book, Milano, 1993.
Rieff, P., The Triumph of Therapeutic. Uses of Faith after Freud, Harper & Row, New York, 1966,
trad. it. di S. Sabbadini, Gli usi della fede dopo Freud. Il trionfo della terapeutica in Freud,
Jung, Reich e Lawrence, ILI, Milano, 1972.
Rogers, C. R., Client Centered Therapy, Houghton Mifflin Company, Boston, 1951, trad. it. di G.
C. Pessani, Terapia centrata sul cliente, edizioni la meridiana, Molfetta, 2007.
Sartre, J. P., L'imaginaire: psychologie phénomenologique de l'imagination, Gallimard, Paris, 1940,
trad. it. di R. Kirchmayr, L'immaginario. Psicologia fenomenologica dell'immaginazione,
Einaudi, Torino, 2007.
Selz, M., La Pudeur, un lieu de la liberté, Buchet/Chastel, Paris, 2003, trad. it. di S. Pico, Il pudore.
Un luogo di libertà, Einaudi, Torino, 2005.
Simondon, G., L'Individuation psychique et collective à la lumière des notions de Forme,
Information, Potentiel et Métastabilité, Editions Aubier, Paris, 1989, trad. it. di P. Virno,
L'individuazione psichica e collettiva, DeriveApprodi, Roma, 2001.
Sims, A., Oyebode, F., Sim's Symptoms in the Mind. An Introduction to Descriptive
Psycopathology, Elsevier, Amsterdam, 2008, trad. it. di L. Bellodi, M. Battaglia e A. Ranieri,
Introduzione alla psicopatologia descrittiva. Quarta edizione, Raffaello Cortina Editore,
Milano, 2009.
101
Spinoza, B., Ethica ordine geometrico demonstrata (1677), parte 3, prop. VII-VIII, trad. it. di G.
Durante, Etica, Bompiani, Milano, 2007.
Tagliapietra, A., La forza del pudore. Per una filosofia dell'inconfessabile, Rizzoli, Milano, 2006.
Totaro, F., Misura, potenza, vita in Nietzsche, in Id. (a cura di), Nietzsche tra eccesso e misura. La
volontà di potenza a confronto, Carocci, Roma, 2002.
Tournier, M., Vendredi ou les Limbes du Pacifique, Gallimard, Paris, 1967, trad. it. di C.
Lusigonoli, Venerdì o il limbo del Pacifico, Einaudi, Torino, 1994.
Trombadori, D., Colloqui con Foucault. Pensieri, opere, omissioni dell'ultimo maître-à-penser,
Castelvecchi, Roma, 1999.
Turnaturi, G., Vergogna. Metamorfosi di un'emozione, Feltrinelli, Milano, 2012.
Waldenfels, B., Fenomenologia dell'estraneità, a cura di G. Baptist, traduzioni di R. Cristin, F.
Longato, M. Failla, G. Baptist, Vivarium, Napoli, 2002.
Weil, S., Attente de Dieu, La Colombe, Paris, 1950, trad. it. di M. C. Sala, Attesa di Dio, Adelphi,
Milano, 2008.
Žižek, S., Il grande Altro. Nazionalismo, godimento, cultura di massa, a cura di M. Senaldi,
Feltrinelli, Milano, 1999.
Bibliografia generale
Agamben, G., Infanzia e storia. Distruzione dell'esperienza e origine della storia, Einaudi, Torino,
2001.
102
Agostino di Ippona, De beata vita, trad. it. di M. Barracano, La vita felice, Leone Verde, Torino,
2009.
Angelini, G., La malattia, un tempo per volere. Saggio di filosofia morale, Vita e Pensiero, Milano,
2000.
Archetti, M., Ordine ritmo misura. Le rappresentazioni culturali del tempo, Moretti & Vitali,
Bergamo, 1992.
Augé, M., Non-Lieux. Indtroduction à une anthropologie de la surmodernité, Seuil, Paris, 1992,
trad. it. di G. Lagomarsino, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità,
elèuthera, Milano, 2009.
–, Le temps en ruines, Galilée, Paris, 2003, trad. it. di A. Serafini, Rovine e macerie. Il senso del
tempo, Bollati Boringhieri, Torino, 2004.
Babini, P., La vita come invenzione. Motivi bergsoniani in psichiatria, il Mulino, Bologna, 1990.
Balbo, L. (a cura di), Tempi di vita. Studi e proposte per cambiarli, Feltrinelli, Milano, 1991.
Barcellona, P., Cosa c'entra il dolore con la democrazia?, pubblicato il 9 dicembre 2011 su
www.ilsussidiario.net.
Baudrillard, J., Le Crime parfait, Galilee, Paris, 1995, trad. it. di G. Piana, Il delitto perfetto. La
televisione ha ucciso la realtà?, Raffaello Cortina Editore, 1996.
Bodei, R., Erfahrung/Erlebnis. Esperienza come viaggio, esperienza come vita, in V. E. Russo (a
cura di), La questione dell'esperienza, Ponte alle Grazie, Firenze, 1991.
–, Destini personali. L'età della colonizzazione delle coscienze, Feltrinelli, Milano, 2002.
Boella, L. Il coraggio dell'etica. Per una nuova immaginazione morale, Raffaello Cortina Editore,
Milano, 2012.
103
Boltanski, L., La souffrance à distance. Morale humanitaire, médias et politique, Métailié, Paris,
1993, trad. it. di B. Bianconi, Lo spettacolo del dolore. Morale umanitaria, media e politica,
Raffaelo Cortina, Milano, 2000.
Bonomi, A., Rullani, E., Il capitalismo personale. Vite al lavoro, Einaudi, Torino, 2005.
Brentari, C., Màdera, R., Natoli, S., Tarca, L. V., Pratiche filosofiche e cura di sé, Bruno
Mondadori, Milano, 2006.
Carrera, A., La Porta, F. (a cura di), Il dovere della felicità, Baldini & Castoldi, Milano, 2000.
Castoldi, I., Riparto da me. Trasformare il mal di vivere in una opportunità per sé, Feltrinelli,
Milano, 2012.
Cavarero, A., Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Filosofia della narrazione, Feltrinelli, Milano,
2003.
–, A più voci. Filosofia dell'espressione vocale, Feltrinelli, Milano, 2005.
Ciaramelli, F., Heidegger e il diniego del desiderio, in G. Cantillo-F. C. Papparo (a cura di),
Genealogia dell'umano. Saggi in onore di Aldo Masullo, Guida, Napoli, 2000.
–, La distruzione del desiderio. Il narcisismo nell'epoca del consumo di massa, Dedalo, Bari, 2000.
Cicero, V., Istante durata ritmo. Il tempo nell'epistemologia surrazionalista di Gaston Bachelard,
Vita e Pensiero, Milano, 2007.
Cohen, S., States of Denial. Knowing about Atrocities and Suffering, Polity Press, Cambridge,
2001, trad. it. di D. Damiani, Stati di negazione. La rimozione del dolore nella società
contemporanea, Carocci, Roma, 2002.
Colangelo, C., Limite e melanconia. Kant, Heidegger, Blanchot, Loffredo Editore, Napoli, 1998.
104
Da Re, A., L'etica tra felicità e dovere. L'attuale dibattito sulla filosofia pratica, EDB, Bologna,
1986.
Dal Lago, A., Il business del pensiero. La consulenza filosofica tra cura di sé e terapia degli altri,
Manifestolibri, Roma, 2007.
–, Carnefici e spettatori. La nostra indifferenza verso la crudeltà, Raffaello Cortina Editore,
Milano, 2012.
Davies, K., Responsibility and daily life, in J. May, N. Thrift (a cura di), TIMESPACE:
Geographies of temporality, Routledge, New York-London, 2001.
Deleuze, G., Nietzsche et la philosophie, PUF, Paris, 1962, trad. it. di F. Polidori, Nietzsche e la
filosofia, Einaudi, Torino, 2002.
–, Spinoza et le problème de l'expression, Les Éditions de Minuit, Paris, 1968, trad. it. di S. Ansaldi,
Spinoza e il problema dell'espressione, Quodlibet, Macerata, 1999.
–, Logique du sens, Les Éditions de Minuit, Paris, 1969, trad. it. di M. de Stefanis, Logica del senso,
Feltrinelli, Milano, 2005.
de Beauvoir, S., La Vieillesse, Gallimard, Paris, 1970, trad. it. di B. Fonzi, La terza età, Einaudi,
Torino, 2008.
De Michele, G., Felicità e storia, Quodlibet, Macerata, 2001.
Demetrio, D., Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina Editore, Milano,
1996.
Duerr, H. P., Der Mythos der Zivilisationsprozeß. 1. Nackheit und Scham, Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 1988, trad. it. di G. Benedetti, Nudità e vergogna. Il mito del processo di civilizzazione,
Marsilio, Venezia, 1991.
Dumoulié, C., La désir, Armand Colin/HER Éditeur, Paris, 1999, trad. it. di S. Arecco, Il desiderio.
Storia e analisi di un concetto, Einaudi, Torino, 2002.
105
Eagle, M. N., From Classical to Contemporary Psychoanalysis, Taylor & Francis, London, 2011,
trad. it. di D. Moro, Da Freud alla psicoanalisi contemporanea. Critica e integrazione,
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2012.
Ehrenberg, E., Le Culte de la performance, Calmann-Lévy, Paris, 1991.
–, L'Individu incertain, Calmann-Lévy, Paris, 1995.
–, La societé du malaise. Le mental et le social, Éditions Odile Jacob, Paris, 2010, trad. it. di V.
Zini, La società del disagio. Il mentale e il sociale, Einaudi, Torino, 2010.
Elias, N., Über den Prozess der Zivilisation. I. Wandlungen des Verhaltens in den Weltlichen
Oberschichten des Abendlandes, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1969, trad. it. di G. Panzieri,
La civiltà delle buone maniere, il Mulino, Bologna, 1982.
–, Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1982,
trad. it. di M. Keller, La solitudine del morente, il Mulino, Bologna, 1985.
Elliott, A., Concepts of the Self, Polity, Cambridge, 2007, trad. it. di B. Del Mercato, I concetti del
sé, Einaudi, Torino, 2010.
Foucault, M., Préface à la transgression (1963), trad. it. Prefazione alla trasgressione, in Id., Scritti
letterari, a cura di C. Milanese, Feltrinelli, Milano, 2004.
–, Surveiller et punir: naissance de la prison, Gallimard, Paris, 1975, trad. it. di A. Tarchetti,
Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino, 1976.
–, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-1979, Seuil-Gallimard, Paris,
2004, trad. it. di M. Bertani e V. Zini, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France
(1978-1979), Feltrinelli, Milano, 2005.
Fraisse, P., Psychologie du rythme, PUF, Paris, 1974, trad. it. di L. Calabrese, Psicologia del ritmo,
Armando, Roma, 1979.
Frugoni, F., Storia di Chiara e Francesco, Einaudi, Torino, 2011.
106
Furedi, F., Therapeutic Culture. Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age, Frank Furedi, 2004,
trad. it. di L. Cornalba, Il nuovo conformismo. Troppa psicologia nella vita quotidiana,
Feltrinelli, Milano, 2005.
Gasparini, G., Tempo e vita quotidiana, Laterza, Roma-Bari, 2001.
Gehlen, A., Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Junker und Dünnhaupt, Berlin,
1940, trad. it. di C. Mainoldi, L'uomo. La natura e il suo posto nel mondo, Feltrinelli, Milano,
1983.
Gorz, A., L'Immtatériel. Connaisance, valeur et capital, Galilée, Paris, 2003, trad. it. L'immateriale.
Conoscenza, valore e capitale, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.
Hegel, G. W. F., Phänomenologie des Geistes (1807), a cura di V. Cicero, Fenomenologia dello
spirito, Rusconi, Milano, 1999.
Heller, Á, Bedeutung und Funktion des Begriffs Bedürfnis im Denken von Karl Marx, trad. it. di A.
Morazzoni, La teoria dei bisogni in Marx, Feltrinelli, Milano, 1975.
Honneth, A., Kampf um Anerkennung. Grammatik sozialer Konflikte, Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 1992, trad. it. di C. Sandrelli, Lotta per il riconoscimento. Proposte per un'etica del
conflitto, il Saggiatore, Milano, 2002.
Illouz, E., Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism, Polity Press, London, 2007, trad.
it. di E. Dornetti, Intimità fredde. Le emozioni nella società dei consumi, Feltrinelli, Milano,
2007.
Irrera, E., Immagini della vergogna tra Antico e Moderno, in “Intersezioni. Rivista di storia delle
ideeˮ, n. 1 (2007).
Jaspers, J., Allgemeine Psychopatologie, Springer, Berlin, 1913, trad. it. di R. Priori, Psicopatologia
generale, Il Pensiero Scientifico, Roma, 2000.
107
Jung, C. V., Psychologische Typen (1921), trad. it. Tipi psicologici, in Opere, vol. 6, Bollati
Boringhieri, Torino, 1996.
Kagan, J., The nature of the Child, Basic Books, New York, 1984, trad. it. di I. Legati, La natura
del bambino. Psicologia e biologia dello sviluppo infantile, Einaudi, Torino, 1988.
Kohut, H., The Search for the Self. Selected Writings of Heinz Kohut: 1950-1978, International
University Press, New York, 1978, trad. it. di F. Paparo, La ricerca del Sé, Bollati Boringhieri,
Torino, 1982.
Lasch, C., Culture of Narcissism. American Life in the Age of Diminishing Expectations, Norton,
New York, 1979, trad. it. di M. Bocconcelli, La cultura del narcisismo, Bompiani, Milano,
1981.
Laurent, A., Histoire de l'individualisme, PUF, Paris, 1993, trad. it. di M. C. Marinelli, Storia
dell'individualismo, il Mulino, Bologna, 1994.
Levinas, E., De l'existence à l'existant, Vrin, Paris, 1947, trad. it. di F. Sossi, Dall'esistenza
all'esistente, Marietti, Casale Monferrato, 1986.
–, Totalité et Infini. Essai sur l'exteriorité, Nijhoff, La Haye, 1961, trad. it. di A. Dall'Asta, Totalità
e infinito. Saggio sull'esteriorità, Jaca Book, Milano, 1990.
Löwith, K., Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Zur Kritik del Geschichtphilosophie, Kohlhammer,
Stuttgart, 1953, trad. it. di F. T. Negri, Significato e fine della storia, Net, Milano, 2004.
Màdera, R., Tarca, L. V., La filosofia come stile di vita. Introduzione alle pratiche filosofiche,
Bruno Mondadori, Milano, 2003.
Mancia, M., Narcisismo. Il presente deformato dallo specchio, Bollati Boringhieri, Torino, 2010.
108
Mancini, R., L'uomo quotidiano. Il problema della quotidianità nella filosofia marxista
contemporanea, Marietti, Torino, 1985.
Marramao, G., Minima temporalia. Tempo spazio esperienza, il Saggiatore, Milano, 1990.
–, Cielo e terra. Genealogia della secolarizzazione, Laterza, Roma-Bari, 1994.
Marzano, M., Scene finali. Morire di cancro in Italia, il Mulino, Bologna, 2004.
Masullo, P. A., Saggio sulla motivazione, Luciano Editore, Napoli, 2005.
May, R. (a cura di), Existential Psychology, McGraw-Hill, New York, 1969, trad. it. di J. Sanders,
L. Breccia, Psicologia esistenziale, Astrolabio, Roma, 1970.
Mertens, W., Psychoanalyse. Geschichte und Methoden, Oscar Beck, München, 1997, trad. it. di G.
Cestone, La psicoanalisi. Storia e metodi, Einaudi, Torino, 2000.
Minkowski, E., Le temps vécu. Études phénoménologiques et psycopathologiques, Delachaux,
Paris, 1933, trad. it. di G. Terzian, Il tempo vissuto. Fenomenologia e psicopatologia, Einaudi,
Torino, 2004.
Moroncini, B., Petrillo, R., L'etica del desiderio. Un commentario del seminario sull'etica di
Jacques Lacan, Cronopio, Napoli, 2007.
Natoli, S., L'esperienza del dolore. Forme del patire nella cultura occidentale, Feltrinelli, Milano,
2002.
–, La felicità. Saggio di teoria degli affetti, Feltrinelli, Milano, 2009.
Norton, D. L., Personal Destinies: A Philosophy of Ethical Individualism, Princeton University
Press, 1976.
Nozick, R., Philosophical Explanations, Oxford University Press, Cambridge (Mass.), 1981, trad.
it. di G. Rigamonti, Spiegazioni filosofiche, Il Saggiatore, Milano, 1987.
109
Nussbaum, M., The Therapy of Desire: Theory and Practice Hellenistic Ethics, Princeton
University Press, 1994, trad. it. di N. Scotti Muth, Terapia del desiderio. Teoria e pratica
nell'etica ellenistica, Vita e Pensiero, Milano, 1998.
–, Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions, Cambridge University Press, 2001, trad. it.
di R. Scognamiglio, L'intelligenza delle emozioni, il Mulino, Bologna, 2004.
Oxley, J. C., The Moral Dimensions of Empathy: Limits and Applications in Ethical Theory and
Practice, Palgrave Mcmillan, London, 2011.
Perone, U., Per un'ontologia del finito, in "Filosofia e Teologia", n. 1, 1993.
–, Al limite del finito, in G. Ferretti (a cura di), Ermeneutiche della finitezza. Atti del settimo
colloquio su filosofia e religione. Macerata, 16 – 18 maggio 1996, Istituti Editoriali e
Poligrafici Internazionali, Pisa, 1998.
Perri, M. L. (a cura di), Il pudore tra verità e pratica, Carocci, Roma, 2005.
Pignarre, P., Comment la dépression est devenue une épidémie, Éditions La Découverte & Syros,
Paris, 2001, trad. it. di M. Pezzella, L'industria della depressione, Bollati Boringhieri, Torino,
2010.
Poggi, I., Le parole del corpo. Introduzione alla comunicazione multimodale, Carocci, Roma, 2006.
Polizzi, G., Una filosofia del tempo. Tempo spazializzato e tempo complesso in Gaston Bachelard,
in F. Bonicalzi, C. Vinti (a cura di), Ri-cominciare. Percorsi e attualità dell'opera di Gaston
Bachelard, Jaca Book, Milano, 2004.
Pollastri, N., Il pensiero e la vita. Guida alla consulenza e alle pratiche filosofiche, Apogeo,
Milano, 2004.
Poma, A., Parole vane. Pazienza, giustizia, saggezza: una lettura del libro di Giobbe, Apogeo,
Milano, 2005.
110
Portinaro, P. P. (a cura di), I concetti del male, Einaudi, Torino, 2002.
Prini, P., Il paradosso di Icaro. La dialettica del bisogno e del desiderio, Armando, Roma, 1976.
Pulcini, E., La passione del moderno: l'amore di sé, in S. Vegetti Finzi (a cura di), Storia delle
passioni, Laterza, Roma-Bari, 2004.
Quinzio, S., Radici ebraiche del moderno, Adelphi, Milano, 1990.
Rank, O., Wahrheit und Wirklichkeit (1929), trad. it. di F. Marchioro, La volontà di essere felici.
Progetto di una filosofia della vita psichica, SugarCo, Carnago, 1992.
Rheinberg, F., Motivation, Kohlhammer, Stuttgart, 2002, trad. it. di C. Conz, Psicologia della
motivazione, il Mulino, Bologna, 2003.
Ricoeur, P., La sémantique de l'action, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique,
Paris, 1977, trad. it. di A. Pieretti, La semantica dell'azione, Jaca Book, Milano, 1986.
–, Temps et récit III. Le temps raconté, Seuil, Paris, 1985, trad. it. di G. Grampa, Tempo e racconto.
Volume Terzo. Il tempo raccontato, Jaca Book, Milano, 1988.
Sartre, J. P., L'être et le néant, Gallimard, Paris, 1943, trad. it. di G. Del Bo, L'essere e il nulla,
Bompiani, Milano, 2002.
Scarry, E., The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World, Oxford University Press,
1987, trad. it. di G. Bettini, La sofferenza del corpo. La distruzione e la costruzione del mondo,
il Mulino, Bologna, 1990.
Silverman, H. J. (a cura di), Philosophy and Desire, Routledge, New York-London, 2000.
Soresi, E., Il cervello anarchico, Utet, Torino, 2005.
Sorrentino, V., Il pensiero politico di Foucault, Meltemi, Roma, 2008.
111
Spaemann, R., Glück und Wohlwollen: Versuch über Ethik, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1989, trad.
it. di M. Amori, Felicità e benevolenza, Vita e Pensiero, Milano, 1998.
Spiegelberg, H., Phenomenology in Psychology and Psychiatry: A Historical Introduction,
Northwestern University Press, 1972.
Spitz, R. A., The First Year of Life. A Psychoanalytic Study of Normal and Deviant Development of
Object Relations, International Universities Press, New York, 1965, trad. it. di G. Galli e A.
Galli Arfelli, Il primo anno di vita del bambino, Giunti, Milano, 2008.
Stimilli, E., Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo, Quodlibet, Macerata, 2011.
Taylor, C., Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Harvard University Press,
Cambridge MA, 1989, trad. it. di R. Rini, Radici dell'io. La costruzione dell'identità moderna,
Feltrinelli, Milano, 1993.
Tramma, S., Inventare la vecchiaia, Meltemi, Roma, 2003.
Trampus, A., Il diritto alla felicità. Storia di un'idea, Laterza, Roma-Bari, 2008.
Volli, U., Figure del desiderio. Corpo, testo, mancanza, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002.
Walker, C., Karl Jaspers and Edmond Husserl. III: Jaspers as a Kantian Phenomenologist, in
"Philosophy, Psychiatry and Psychology", vol. 2, n. 1 (1995).
White, N., A brief history of happiness, Blackwell Publishing, Oxford, 2006, trad. it. L. Cimmino,
Breve storia della felicità, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008.
Wiesel, E., La Nuit, Les Éditions de Minuit, Paris, 1958, trad. it. di D. Vogelmann, La notte,
Giuntina, Firenze, 1995.
112
Williams. B., Ethics and the Limits of Philosophy, Harvard University Press, Cambridge MA, 1985,
trad. it. di R. Rini, L'etica e i limiti della filosofia, Laterza, Roma-Bari, 1987.
113