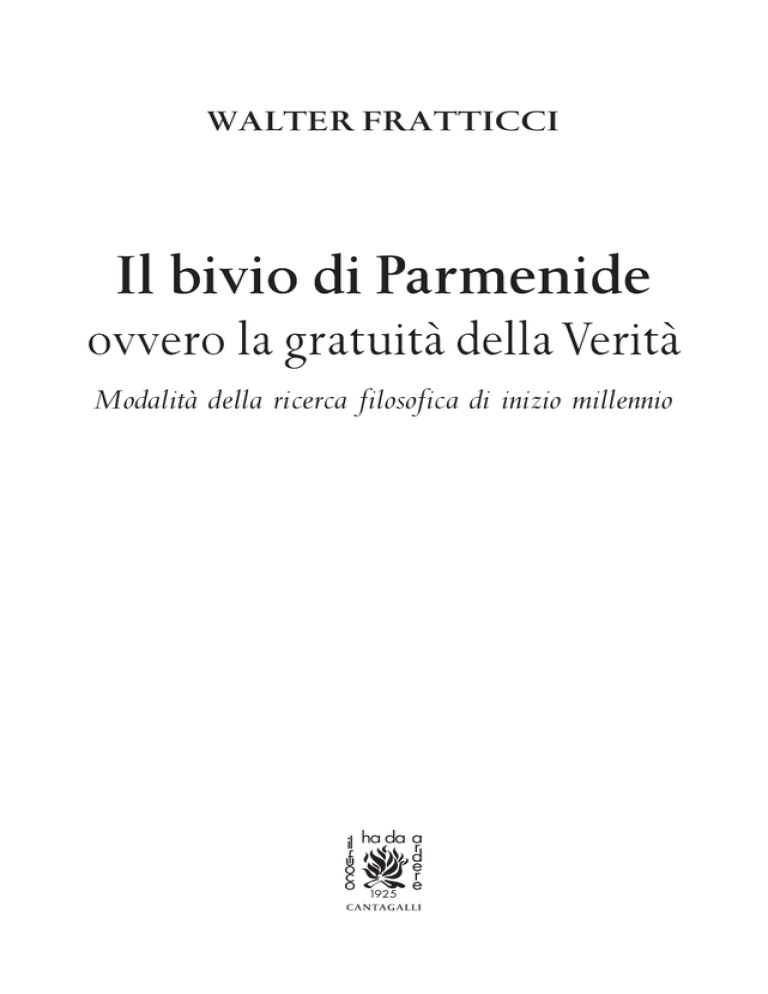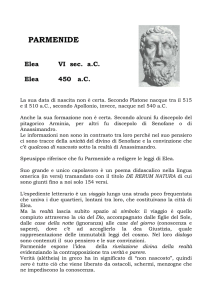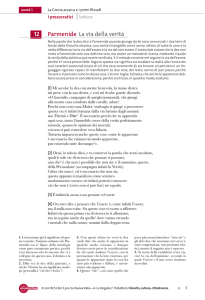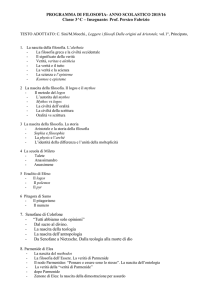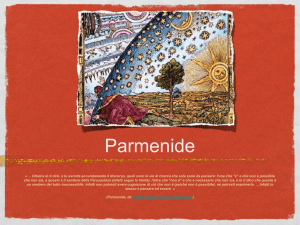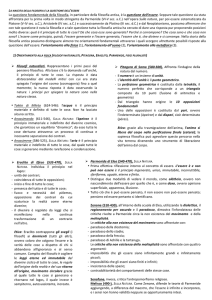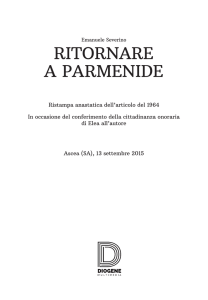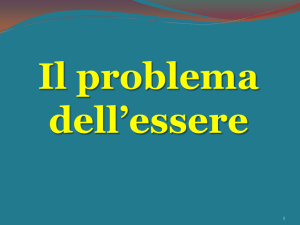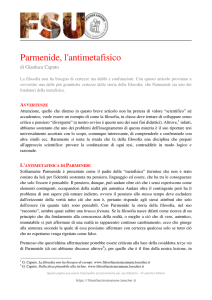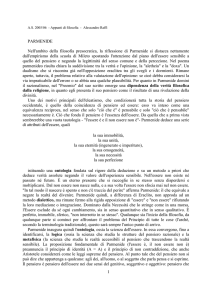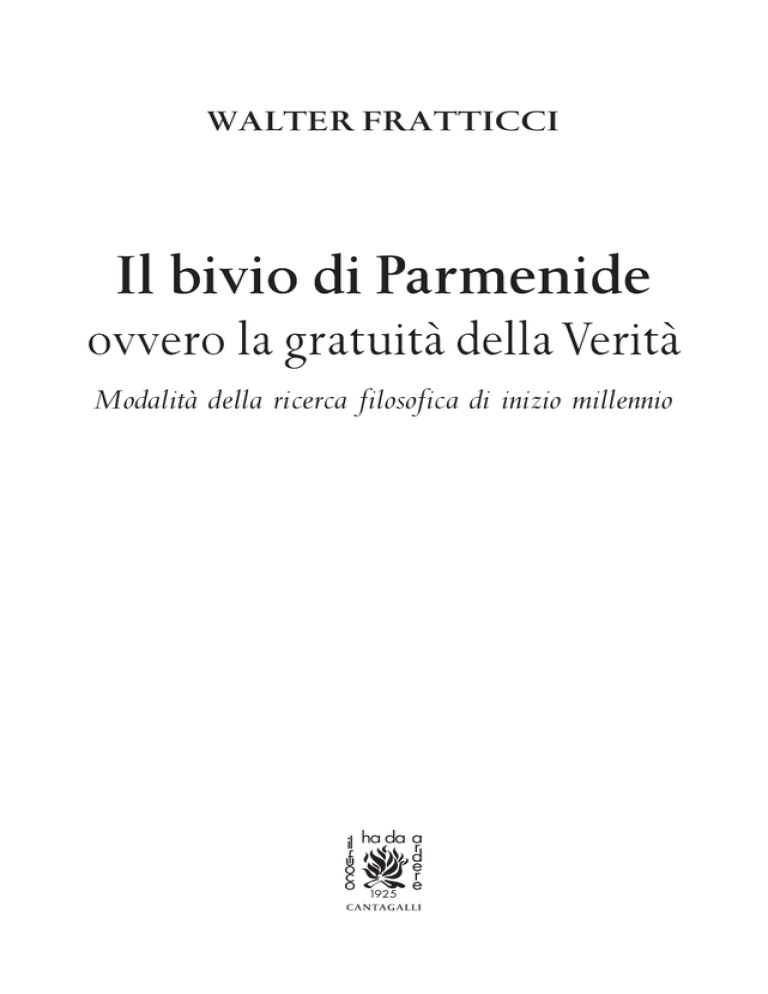
WALTER FRATTICCI
Modalità della ricerca filosofica di inizio millennio
Dedico questo lavoro a tutti coloro
che mi hanno accompagnato nella mia fatica
con il loro amorevole sostegno.
Redazione: BENEDETTA SCARDIGLI
© Edizioni Cantagalli S.r.l.
Siena - marzo 2008
Stampato nel mese di marzo 2008
da Edizioni Cantagalli S.r.l.
ISBN 978-88-8272-3767
Pubblicato in collaborazione con la
FONDAZIONE SUBLACENSE VITA E FAMIGLIA
PRESENTAZIONE
Già il titolo e il sottotitolo di questo saggio suscitano al lettore
un interrogativo, anzi una sorpresa: quale può essere il rapporto tra
Parmenide e la gratuità della verità? Ossia, più determinatamente,
come è possibile comporre la concezione della verità come originaria incontrovertibilità e incontraddittorietà con la concezione della
verità come dono da accogliere, come rivelazione da riconoscere e
a cui affidarsi? Nella risposta a questo interrogativo consiste la tesi
sostenuta dall’Autore. Tesi che si può chiamare un ritorno a Parmenide e che mira a mostrare che è proprio in Parmenide che si
può trovare la conciliazione in questione. Il procedimento si snoda
in due tempi: dapprima con lo svolgimento di una interpretazione
singolare della dottrina del poema, poi con l’esposizione del risultato secondo la prospettiva di un nuovo paradigma filosofico: nella
gratuità della verità risiede l’insegnamento autentico del filosofo di
Elea, “venerando e terribile”.
L’interpretazione si occupa, innanzitutto, di rilevare il tradimento interpretativo del poema, mostrando come il suo problema
filosofico è stato disatteso a causa della sovrapposizione dell’episteme
e della potenza del logos. L’Autore ritiene che questo fraintendimento è cominciato dallo stesso Platone e si è perpetuato lungo la
storia della filosofia occidentale fino a culminare nell’imponente ripresa parmenidea di E. Severino. Decisivo è il fatto che il logos ha
imposto all’essere il carattere della necessità, determinando così il
dominio dell’episteme sull’essere. La conseguenza di questa sovrapposizione si manifesta nell’imprigionamento dell’essere nella rete
della logica apodittica e della sistematicità compiuta e definitiva,
come pure nell’oscuramento della originarietà, cioè dell’esperienza
dell’originarietà dell’essere, la quale si dispone, invece, su un fondo
pre-logico e a-sistematico. Ne deriva ancora che la problematica si
restringe sul versante che, mirando non tanto alla considerazione
“se l’essere è”, quanto alla determinazione del “come l’essere è”,
tradisce lo splendore vertiginoso dell’essere e lo trasforma in una
3
teoria ontologica, in una ontologia. Infine questa ontologia si regge
interamente sul principio di non contraddizione, inteso come principio del logos e, quindi, come principio della logica, che si impone
assolutamente, riassumendo in sé il senso e la verità dell’essere:
l’originario è il principio e la sua innegabile necessità, non l’essere.
A questa disamina critica, quasi una pars destruens – dove, peraltro, sono accomunate posizioni della storia della filosofia molto diverse e distanti tra di loro –, fa seguito l’interpretazione propria
dell’Autore, la quale potrebbe esser intesa come la pars construens. In
sintesi si può dire che la tesi avanzata consiste nel sostenere che l’intero poema parmenideo è costituito dalla rivelazione della Dea. Ciò
vuol dire che l’“uomo che sa”, ossia colui che ha accesso alla verità
dell’essere, lo stesso Parmenide, ottiene questo suo sapere fondamentale dal favore concessogli dalla Dea; che questo sapere è il dono della divina parola originaria, che non è un logos, ma un mythos;
che rispetto a questa parola l’uomo sa – a differenza dei mortali che
nulla sanno -, in quanto si decide a lasciarsi condurre al bivio, ove si
spalanca la porta sui due sentieri del giorno e della notte, cioè dell’essere e del non-essere; che in definitiva la verità dell’essere ed il
suo assoluto predominio sul non-essere non sono raggiunti in virtù
del pensiero umano e della sua evidenza, ma provengono dalla
rivelazione autorevole della Dea e dalla decisione, che l’uomo
prende davanti a tale autorevolezza, di ascoltarla e di farvi affidamento.
È in questo modo che l’Autore ritiene di essere legittimato ad affermare che la gratuità della verità dell’essere lungi dal presentarsi come una evidenza apodittica, innegabile, è piuttosto una donazione
divina, a cui è chiamato a rispondere. Questo, in conclusione, è l’insegnamento che il poema di Parmenide lascia in eredità ai posteri.
Parmenide non è filosofo della visione, cioè della luminosità, dell’evidenza dell’essere, ma è filosofo dell’ascolto e della corrispondenza
alla divina rivelazione dell’essere; è filosofo della verità dell’essere
non in quanto detta e posta dal logos, ma in quanto detta e posta autorevolmente dalla rivelazione nel mythos della Dea. Certo, su questa
base può e deve esercitarsi il logos del filosofo, ma esso non può erigersi a fondamento, ossia non può esaurire in se stesso la misteriosità
4
dell’essere: il logos dipende da questa misteriosità e dalla sua espressione nel mythos, e ne è fondamentalmente guidato e orientato.
Raccogliendo in unità gli elementi di questa interpretazione si è
in grado di cogliere il significato essenziale del nuovo paradigma filosofico. La tramandata definizione di filosofia come amore della sapienza o, come preferisce l’Autore, come amore del sapere, si tramuta in filosofia come sapienza dell’amore, ove per sapienza s’intende
apprezzamento e custodia, e per amore s’intende ciò che è veramente caro, ciò di cui si deve avere massimamente cura – Heidegger direbbe: ciò che è massimamente degno di essere pensato; l’Autore intende: ciò che massimamente è degno di essere amato, in quanto è
ciò che essenzialmente informa l’esistenza dell’uomo –. Questa trasformazione della filosofia può essere trascritta nella forma di binomi
antitetici; ne indichiamo alcuni: la filosofia non è episteme, ma sapienza; non è logos, ma mythos; non è posizione necessaria, ma gratuità;
non è fondamento incontrovertibile, ma mistero; non è visione, ma
ascolto; non è evidenza, ma autorevolezza; non è apoditticità e necessità, ma fiducia. L’elenco potrebbe anche continuare, ma siamo
consapevoli che i binomi indicati nella loro aspra antinomicità non
rendono completa giustizia al discorso dell’Autore, il quale procede
compatto e con larghezza di riferimenti, di indicazioni e di motivi a
sostegno della sua tesi, per non dire dello stile appropriato, piano ed
elegante, con cui li espone. Questi binomi, quindi, hanno solo una
funzione di ricondurre alla massima essenzialità
Tuttavia, ci permettiamo in modo del tutto amichevole con lo
stimato Autore, di ritornare sul punto chiave della sua tesi, che resta
ancora e sempre il concetto della “gratuità della verità”. Egli espone
con pertinenti motivi la sua interpretazione del poema come rivelazione della Dea. Ma questa posizione provoca problemi non semplici.
Poniamoci dal punto di vista del pensiero. Ammesso che la verità
consiste nella gratuità “del e per il pensiero” e che tale gratuità costituisca “l’inizio e la fine” (forse: il fine), tra i quali “il discorso della conoscenza trova il suo spazio” e la cui delimitazione “deborda dalle capacità costruttive del logos stesso”, permangono pur sempre due difficoltà. Ciò che “deborda” dal pensiero, dal logos – è proprio sicuro
5
che il logos sia costruttivo? – e che pertanto si presenta come gratuità,
è gratuità “del” pensiero e, dunque, una “dilatazione”, una “ulteriorità”, che è opera del pensiero e in cui consiste il suo intrascendibile
trascendimento, oppure è qualcosa che è “altro” dal pensiero? Nella
seconda alternativa ci si trova all’interno di una dimensione, che non
è riconducibile in assoluto all’esercizio del pensiero e che, dunque è
al di fuori o al di là del suo stesso trascendere: ogni ulteriorità è ulteriorità interna al pensiero, non fuori o al di là del pensiero. E in ogni
caso questa ulteriorità non può essere dichiarata se non dal pensiero.
Ciò viene a dire: che cosa intende il pensiero con gratuità della verità?
Ma poniamoci dal punto di vista della Dea rivelatrice e concordiamo con il fatto che la Dea sia la verità. Per essa non si può certo dire che la verità sia gratuità, proprio perché essa sa – è lo stesso logos
della verità -, che l’essere si oppone al non essere, sapendolo ed essendolo esso stessa come lo “sfondo” – fondamento o sfondamento?
-, in cui l’essere è “capace di mantenersi nell’ininterrotto mutare e
svanire delle sue singole emergenze”(dei singoli essenti). La Dea,
dunque, è lo stesso logos, che all’ “uomo che sa” manifesta la verità
dell’essere come opposizione al non essere, ossia rende manifesto che
quello che essa sa, è anche quello che il pensiero pensa a proposito
dell’essere, del quale il pensiero come tale è la stessa manifestazione,
che la Dea, nella figurazione del poema, rivela e manifesta. Diversamente, come sarebbe in grado il pensiero di riconoscere i segnali evidenti dell’essere come opposizione al non essere? Oppure anche in
questa operazione il pensiero è debitore della rivelazione della Dea?
Queste ultime osservazioni sono dettate – amichevolmente abbiamo detto – in vista della convinzione che l’Autore manifesta
quanto al carattere “problematico” del suo “nuovo paradigma filosofico”. Quanto al quale concordiamo chiaramente. È per questo
che auguriamo a questo saggio una ampia recezione, perché riteniamo che la sua fatica mostra da se stessa la sua notevole tempra filosofica, e perché siamo anche noi convinti che la filosofia si definisce radicalmente nella domanda sempre e ogni volta attuale del “che cos’è”
del senso dell’esistenza, in assoluto.
ANICETO MOLINARO
6
PREFAZIONE
Affrontare una discussione con pensatori che hanno segnato di
impronte decisive il percorso del pensiero è sempre un po’ un’avventura. Lasciarsi da loro interpellare, farsi guidare sui sentieri che
essi per primi hanno osato è come mettersi alla ricerca di una perla
preziosa che si è riusciti ad intuire nel nascondimento dell’ostrica
che la racchiude, ma che richiede ogni tenacia e pazienza per essere
portata alla luce nella sua purezza ed in tutto il suo splendore. È un
compito laborioso ed insieme defatigante, che promette però, e dona anche, quando riesce, grande soddisfazione. Compito essenziale,
che comunque vale la pena di tentare. Perché quello che se ne ricava, più e prima ancora che le informazioni necessarie alla competenza filosofica, è uno sguardo lungimirante che illumina la realtà di
riflessi inattesi, sono gli ancoraggi potenti che tengono salda la
riflessione che voglia veramente portare avanti, sempre e nuovamente, l’impegno del pensare.
Con questo impegno il presente lavoro vorrebbe misurarsi, con
la necessità, che è insieme un’urgenza, di riesprimere con le parole
di oggi, a partire dai problemi posti dall’oggi, le questioni essenziali
che non cessano di interrogare l’uomo nel corso della sua varia esistenza. Tra queste, con un crescendo di attenzione che va al passo
con la progressiva consapevolezza dei suoi drammatici risvolti pedagogici ma anche sociali, la questione del nichilismo, che finisce
per mostrare anche ai meno accorti ripetitori di pensieri all inclusive
quanto insostenibile sia la leggerezza di un essere svuotato infine di
ogni senso.
Allora si tratta veramente di ritornare a coltivare la nobile arte
del pensare, senza cedere alle scorciatoie che soluzioni già garantite
dal tempo possono ancora offrire, con un engagement personale che
sia disponibile a mettere in gioco, mettendosi in gioco, certezze acquisite. E questo per ritrovare la strada, senz’altro non scomparsa,
forse solo smarrita o quasi sciupata nel tumultuoso traffico dell’anima, lungo la quale possa ancora darsi la possibilità dell’ascolto della
7
verità; una verità che non si lascia scheggiare nei frammenti di esperienza dai quali agli umani, esseri prospettici, quasi obliquamente è
dato avvicinarla; una verità che, pur nel nascondimento nella latenza, per dirla con Heidegger, nondimeno si offre nella risonanza di
una tradizione che ci sostanzia, dalla quale non possiamo sfuggire,
ed alla quale siamo inevitabilmente rimandati, anche quando di essa
pensiamo di esserci disfatti.
Di qui la proposta contenuta in questa pagine. Che suggeriscono l’idea di un confronto con un pensatore, Parmenide d’Elea, al
quale veniamo sempre di nuovo sospinti, allorché ci poniamo alla
ricerca delle radici da cui proviene la linfa con la quale cerchiamo di
dar forza e forma alla crescita della nostra identità. Perché è dalle radici che veniamo portati. Pensare dunque con e a partire da Parmenide, e non semplicemente un pensare intorno a Parmenide.
***
Un libro su Parmenide, in assenza di nuovi dati e dopo i lavori
di Cordero, Couloubaritsis, O’Brien, Ruggiu, per non citare che
alcuni tra gli studi più significativi apparsi negli anni ’80 e ’90 del
secolo appena trascorso, non può avere la pretesa di avanzare nuove
ipotesi di lettura esegetica del testo dei frammenti. O almeno non è
questa l’intenzione di chi scrive. Non è dunque nell’analisi testuale
che andrà cercata la valenza del presente lavoro. Che invece ha
l’ambizione di proporre una riflessione teoretica che, interrogando
Parmenide, interroghi la filosofia e la sua condizione odierna.
Naturalmente il confronto con un pensatore non può non svolgersi secondo un’ipotesi di interpretazione del pensiero di questi; e
il capitolo centrale, che dà il titolo al libro, avrà cura di far emergere
dettagliatamente i termini della lettura del poema di Parmenide sostenuta. Ma, di nuovo, una siffatta lettura è funzionale all’esigenza
di trovare in Parmenide l’indirizzo di un avanzamento verso una
più adeguata appropriazione, nel senso kierkegaardiano, della
verità. Che, mai mia, è tuttavia sempre per me.
Trova qui giustificazione la scelta di non dedicare eguale udienza a tutti i frammenti del poema, ma di concentrare invece l’atten8
zione direttamente su quei luoghi dello stesso che, nell’economia
della riflessione proposta, venivano emergendo come plessi teoretici qualificanti l’esperienza parmenidea con la quale siamo invitati a
confrontarci. E così la seconda parte del poema, quella dedicata alla
doxa, rimane fuori del perimetro di discussione, mentre pertinente
si rivela l’analisi del proemio e dei frammenti della prima parte.
***
Un lavoro, dunque, dal taglio consapevolmente ed esplicitamente teoretico e non storiografico, come già il titolo lascia intuire.
Il bivio di Parmenide, e la sottesa questione della gratuità della verità, infatti, non è solo aperto rimando alla formula che il pensatore di
Elea si è incaricato di consegnare ai suoi ascoltatori, quella vale a dire che afferma l’essere; quel bivio, in verità, è metafora di uno snodo cruciale d’esistenza, da attraversare da parte di ciascuno, per
conquistare la possibilità di fronteggiare, nell’epoca del nichilismo
che da gaio è divenuto decadente, la questione del senso. La quale
non è affatto retaggio di una attardata cultura giudaico-cristiana,
come sembra pensare qualcuno, ma momento irrinunciabile del
processo stesso di umanizzazione.
Ripercorrere la via di Parmenide è allora il compito cui la filosofia è chiamata nel tempo in l’avverarsi della profezia nietzscheana
dello Übermensch sembra esercitarsi in una furia iconoclasta, dai
contorni non ancora precisati, che sta minando e liquidando con
ogni fretta e senza grandi rimpianti l’eredità culturale, più che millenaria, che fonda l’Europa. Che non si tratti di un compito di mera
conservazione si incaricherà di mostrarlo lo svolgimento del ragionamento. Quello che va detto in sede di prefazione è che la proposta di un ritorno a Parmenide deve incaricarsi di configurare lo scenario entro cui rinnovare l’impresa filosofica, affinché questa possa
trovare nella sua sapienza originaria l’ancoraggio della meditazione
pensante. E le sue risposte sono ancora per noi illuminanti. Il continuo trapassare delle cose e la fragile consistenza ontologica che queste ultime denunciano non sono segni del Caos, che è poi l’abisso
in cui il nulla spalanca le sue fauci. Contro di esso garantisce e mette
9
al riparo la forza del sostegno originario, l’essere. L’Abgrund è in verità Urgrund, fondo stabile e stabilizzante la molteplicità degli enti in
divenire. E poi ancora: gli algidi algoritmi del lògos non hanno la capacità di raggiungere tale fondo, che invece si rivela nella parola-mythos pronunciata con autorevolezza da chi la verità la possiede
perché è la Verità stessa. Ed infine, solamente dalla confidenza con
la verità – così potrebbe esser tradotto il p…stij ¢lhq»j di fr. 1,30
– sarà consentito all’uomo l’avanzamento lungo la corretta via, la
via dell’essere, dove allo sguardo indagatore le cose ottengono la loro vera definizione.
È una via che dobbiamo imparare nuovamente a percorrere,
con la determinazione e la disponibilità di cui Parmenide ci dà testimonianza. Una ÐdÕj che è via-a, che conduce verso un approdo
dove la verità ci accoglie benevola, lasciandosi apprendere dall’uomo che si incammina verso di essa. A questo compito dalla lontananza delle origini ci chiama il pensatore di Elea.
10
INTRODUZIONE
La crisi della filosofia
A giudicare dalla rinomanza da cui oggi è circondata, sembrerebbe che la filosofia goda di splendida forma e salute. Le occasioni
nelle quali i suoi cultori vengono chiamati ad illuminare – dall’alto
del loro esoterico sapere, tanto più affascinante quanto più eccentrico, vale a dire letteralmente fuori del comune – le vicende, spesso le più banali, dell’esistenza, sono sempre più frequentate e ricercate. Non c’è potere che non ricerchi la parola autorevole del filosofo, che non faccia spazio al dire più o meno oracolare di questi,
alla sua lettura, peraltro interessante e ben impostata, della situazione.
Ma così la filosofia nasconde solo la sua crisi. In verità la rimuove solamente, scambiando l’impegnativo lavoro di scavo e problematizzazione della questione che la origina – Chi è l’uomo e come
può arrivare a conoscere se stesso nella trama delle complesse relazioni entro cui è inserito? Cosa garantisce e dà stabilità alla sua autocoscienza? Come impegnare la libertà che lo distingue? In nome
di che e per quali cose decidersi? Verso quali orizzonti di senso
orientare la propria esistenza?1 – con la più agevole applicazione del
metodo di analisi razionale, che la contraddistingue, ai nuovi continenti cognitivi con cui va a confrontarsi la coscienza contemporanea. Sia chiaro: la filosofia da sempre si è confrontata con il suo
tempo. Non c’è bisogno di scomodare Hegel e la sua comprensione della filosofia come coscienza riflessa del proprio tempo; a stimolare la riflessione filosofica è stata sempre comunque la scoperta
della problematicità dell’ambiente e dell’esistenza2. Una filosofia
chiusa nella turris eburnea dei suoi logici algoritmi non è in verità
1
Sono le domande che già Kant ha condensato in una fortunata formulazione:
«Che cosa posso sapere? Che cosa devo fare? Che cosa posso sperare?» (Immanuel
KANT, Critica della ragion pura, Laterza, Roma-Bari 1977, II, p. 612).
2 Non è fuori luogo ricordare che già Aristotele, ricostruendo nel primo libro
della Metafisica il pensiero dei filosofi che lo avevano preceduto e, in un certo senso,
11
mai riuscita a proporsi come valida interlocutrice dell’umana urgenza verso risposte sensate a questioni essenziali. Non è senz’altro
di essa che si rimpiange la mancanza. La skandalon non consiste
dunque affatto nell’impegno storico del filosofo, ma nelle modalità
di siffatto impegno, nella tacita rinuncia a leggere nel gioco delle
relazioni storico-mondane le trame recondite e tuttavia determinanti di un orientamento essenziale che ordina la posizione
dell’uomo nel mondo. Quasi che tutto sia superficie.
Il problema che si presenta è allora né più né meno quello della
capacità della filosofia di contribuire, in maniera significativa ed essenziale al tempo stesso, alla comprensione che l’uomo ha di sé nel
tempo che vive. Il che non può avvenire altrimenti che mediante il
recupero della qualità originaria della ricerca filosofica, di quei tratti
originali e tipici che ne hanno fatto una forma di pensiero peculiare
e caratterizzante la tradizione culturale occidentale. Perché comprendere il proprio tempo significa anche, radicalmente, sottrarre
alla forza dell’abitudine e render esplicite le strutture e le dinamiche
di pensiero che orientano potentemente la nostra stessa percezione
del reale – strutture e dinamiche che la tradizione culturale, alla
quale apparteniamo, ha saputo costruire nel corso dei secoli, e nelle
quali siamo nativamente immersi al punto da considerarle come naturali. Contribuire a questo compito vuol dire altresì problematizzare l’autocomprensione che l’uomo ha di sé e l’ordinamento che
egli attribuisce al mondo umano e naturale sulla base di radicali assunzioni di senso. Ritornano allora le domande che sopra abbiamo
posto. Da esse, ancora una volta e pur sempre di nuovo, dobbiamo
avere il coraggio e la forza di lasciarci mettere in discussione.
Ma qui si sconta la fragilità della proposta filosofica contemporanea. È come un’avanguardia spintasi troppo avanti nella sua marcia,
ed ora nella situazione di aver perso ogni collegamento con la base:
anticipato, affermi che la filosofia nasce dal qaum¦zein, dalla meraviglia (ARISTOTELE, Metafisica, A 2, 982b 12). Il riferimento hegeliano è alla nota Prefazione ai Lineamenti di filosofia del diritto: «Intendere ciò che è, è il compito della filosofia, poiché ciò
che è, è la ragione. […] la filosofia è il proprio tempo appreso col pensiero.» (Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, Bompiani, Milano 2006,
p. 18).
12
la filosofia continua nella sua avanzata, senza però riuscire più ad essere percorsa dalla linfa che, pervadendola, le dà anche anima. Certo, il XX secolo è stato segnato dalla volontà di reindirizzamento
della ricerca filosofica. I filosofi avvertono l’estenuarsi della tradizione di ricerca seguita negli ultimi secoli, patiscono l’aggressione,
nemmeno troppo velata, ad opera dei funzionari dei nuovi saperi
strumentali al governo dell’organizzazione sistemica del pianeta,
che ambiscono a rilevarne il ruolo, dimentichi ed ingrati al tempo
stesso verso quella tradizione che ne ha inopinatamente tirato la volata3; tentano perciò di salvaguardare uno spazio di risonanza delle
questioni essenziali, affinché l’uomo non venga meno alla fedeltà
alla propria vocazione e dignità. Dato che ciò che è in gioco, nuovamente, è la possibilità di ridire, in un contesto culturale rinnovato, quanto da sempre l’uomo ha sperimentato come orientante la
propria esistenza, vale a dire il senso della propria fatica d’esistere.
È infatti proprio nei periodi di transizione che una simile esigenza si fa più urgente. Ma, a differenza di Hegel, noi non siamo in
grado di salutare il nuovo mondo che nasce4, o forse solo non ne
riusciamo ad individuare i contorni; siamo consapevoli che non ci è
richiesto di portare a compimento, ma di ritrovare radici disperse
nel dissolvimento di compimenti tentati. Seduti sul limitare di un
abisso, che al contempo minaccia ed attrae, presentiamo che le coordinate culturali, gli assetti valoriali e gli stessi paradigmi metafisici,
che hanno regnato, dapprima in Occidente e poi via via nel mondo
globalizzato durante almeno l’intera modernità, sono oramai insuf3
E se l’etica prova a sottrarsi a questo destino di tramonto, già qualcuno osserva
che etica ed etologia condividono la stessa radice etimologica. «Fu il biologo Edward
O. Wilson, oltre trent’anni fa, il primo a suggerire che “è giunto il momento di togliere temporaneamente l’etica dalla sfera di pertinenza dei filosofi per passarla ai
biologi”» (Nicholas WADE, La Repubblica, 22 marzo 2007, p. 37).
4 Scriveva il filosofo tedesco nel 1806: «Del resto non è difficile a vedersi come
la nostra età sia un’età di gestazione e di trapasso a una nuova era; lo spirito ha rotto i
ponti col mondo del suo esserci e rappresentare, durato fino ad oggi; esso sta per calare tutto ciò nel passato e versa in un travagliato periodo di trasformazione. […]
Questo lento sbocconcellarsi che non alterava il profilo dell’intiero, viene interrotto
dall’apparizione che, come un lampo, d’un colpo, mette innanzi la piena struttura
del nuovo mondo» (Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Fenomenologia dello spirito, La
Nuova Italia, Firenze 1976, I, pp. 8-9).
13
ficienti ed inadatti a guidare l’ermeneutica del presente, stravolti
dalle impensabili novità e dalle dirompenti produzioni del progresso tecnologico. Ma, d’altra parte, non siamo ancora pronti per cogliere il senso di tale processo, né - ed è ciò che più conta - per valutarlo adeguatamente. Cullati dolcemente dal tramontare di un’epoca, vorremmo rimanere a contemplarne senza tempo i colori
suggestivi, nella speranza di ritardare la notte che sta per sopraggiungere5.
Un nuovo slancio
Forse occorre un nuovo slancio: un nuovo slancio per ripensare
l’intero sviluppo del processo, al tempo stesso teoretico e pratico, di
cui noi rappresentiamo provvisoriamente solo l’ultima emergenza.
L’impasse, infatti, non può essere scavalcata attingendo a semplificate soluzioni. Non vale negare l’esistenza del problema e nemmeno
solo addossare ogni colpa all’ultimo arrivato. La mutazione è globale. Nuovi orizzonti antropologici, imprevisti scenari etici richiamano il filosofo alla responsabilità della considerazione pensante. Prende così forma il contributo specifico che la filosofia può dare all’interpretazione della crisi epocale del nostro tempo.
Perché ciò che vediamo tramontare sotto i nostri occhi è, ben
oltre un determinato assetto storico-politico, un programma culturale radicato su una ben precisa immagine del mondo. Su tale programma si deve esercitare l’impegno intellettuale da parte del filosofo, perché siano fatte emergere deviazioni e nodi irrisolti, ma anche suggestioni inespresse e promesse rimaste incompiute. La crisi
infatti scopre anche potenzialità insospettate. Occorre pertanto
pensare la condizione di difficoltà della filosofia occidentale; pensarla, e non semplicemente cavalcarla o denegarla con sdegno, rimanendo abbarbicati alla cittadella assediata dell’Occidente. Dato
che la crisi della filosofia è in verità la crisi del logos greco, della razionalità calcolante del sapere sistematico, che sta scivolando, come
5
Questo sembra l’esito della filosofia della post-modernità. Che pure muove da
una analisi molto simile a quella sopra delineata (Cfr. François LYOTARD, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Feltrinelli, Roma 1981).
14
in caduta libera, verso un minimalismo teorico contento di sé,
dopo aver toccato il culmine della sua ascesa nel sogno idealistico
della conoscenza assoluta.
La scena della rappresentazione teoretica deve allora saper abbracciare l’intera tradizione filosofica, per ricondurla al tradimento
che, istituendola, la ha anche fuorviata, consegnandola all’aporia
che sembra confutarla assieme al mondo che essa ha legittimato6. La
strada va perciò ripercorsa indietro fin alle sue prime e lontane origini, cercando di contenere con lo sguardo l’insieme del sentiero
percorso dalla riflessione occidentale.
Con la sua richiesta di uno Schritt zurück, Heidegger ha segnato
senz’altro un’epoca ed indicato una prospettiva di lavoro7. L’impegno filosofico deve concentrarsi su quei segni e tracce di verità affidati alla parola dei poeti e dei pensatori iniziali. A costoro occorre
volgere lo sguardo e l’attenzione, con loro riprendere un dialogo
teoretico sull’essenza della verità e il senso dell’essere. È forse questo uno dei lasciti più importanti dell’ermeneutica heideggeriana,
quello che invita a riprendere il contatto con la primordiale elaborazione dei primi pensatori, per farne risuonare potenzialità non ancora esplorate. E, di là delle banali liquidazioni di coloro che non
intendono la cosa di cui si tratta e delle più giustificate critiche verso l’heideggerismo di scuola, la via tracciata dalla costante meditazione heideggeriana dell’essere e della verità obbliga la filosofia a ripensare se stessa. Non si tratta pertanto più solo di colmare vuoti di
conoscenza disciplinare con pregiate analisi di taglio storiografico,
ma anzitutto di riannodare sempre di nuovo – è il destino del filosofo, di colui cioè che è in cammino verso la sapienza, pur essendo
destinato a non mai acquisirla in suo pieno possesso, come insegna
6
Per questo mi sembra senz’altro necessario, eppure insufficiente, quanto propone Habermas, il quale, dopo aver dichiarato che «i filosofi sono preparati meglio
per alcuni problemi rispetto ad altri intellettuali, come scrittori, professionisti o
scienziati», delinea il contributo che la filosofia può offrire sia nel senso di «un’autocritica della ragione», sia nel senso della critica esemplare della «colonizzazione di un
mondo della vita, che viene minato dall’intervento di scienza e tecnica, mercato e
capitale, diritto e burocrazia» (Jürgen HABERMAS, Ancora sulla relazione fra teoria e
prassi, Paradigmi, XV, 1997, 45, pp. 431-32).
7 Cfr. Martin HEIDEGGER, Identität und Differenz, Neske, Pfüllingen 1957.
15
già Socrate8 – il dialogo, fratto distorto ma mai veramente interrotto, con l’essere, che nelle parole dei «pensatori iniziali»9 si rivela con
una forza non ancora addomesticata dagli schemi rappresentativi.
Allo sviluppo di tale dialogo vorrebbe contribuire il presente
lavoro.
Ritornare a Parmenide
La figura di Parmenide si adatta quant’altri mai al compito, che
ci viene assegnato dal nostro tempo, di rendere nuovamente accessibile la fenditura attraverso cui l’essere si manifesta, avendo cura di
ripulirla delle incrostazioni depositate in essa dal tempo e dalla storia. Ma ritornare ad interrogare oggi il pensiero di Parmenide corre
il rischio di configurarsi solo quale esercizio al tempo stesso inevitabile e scontato. Quasi un secolo di ricerche, dallo studio per alcuni
versi pionieristico di Reinhardt10 alle più recenti esegesi di Ruggiu11, ha chiarito in maniera pressoché definitiva che il pensatore di
Elea si colloca all’origine dei differenti rami di quella pratica che
continua ancora oggi sotto il nome di filosofia. Ontologia e logica12,
8
«E chiunque altro sia sapiente, non filosofa», laddove l’uomo, come Eros, può
essere solamente «ricercatore di sapienza per tutta la vita (filosofîn di¦ pantÕj
toà b…ou [...] oud’œi tij ¥lloj sofÕj, oÙ filosofe‹)» (PLATONE, Simposio, 203
D - 204 A. Le citazioni di Platone sono tratte dalla traduzione italiana a cura di
G. Reale: PLATONE, Tutti gli scritti, Rusconi, Milano 1991).
9 «Anfängliche Denker»: così Heidegger chiama Anassimandro, Parmenide ed
Eraclito (Martin HEIDEGGER, Parmenide, Adelphi, Milano 1999, p. 40).
10 Karl REINHARDT, Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie, Klostermann, Frankfurt a. M. 19773. Come ha incisivamente notato Hans-Georg GADAMER (I presocratici, in AA.VV., Questioni di storiografia filosofica, La Scuola, Brescia 1975,
vol. 1.1, p. 50), «ciò che diede alla sua ricerca una forza d’urto fu il fatto che un filologo
capisse e prendesse sul serio il poema di Parmenide nella sua portata filosofica. […] Il
suo [di Reinhardt] libro su Parmenide fu una geniale opera prima».
11 Pubblicate a commento della traduzione italiana, a cura di Giovanni Reale,
dei frammenti di Parmenide (PARMENIDE, Poema sulla natura, Rusconi, Milano
1991).
12 «L’essere di Parmenide non è, ora, altro che la cristallizzazione ontologica […]
di quell’essere che egli scopre universale nella sua esperienza logico-verbale del pensare». (Guido CALOGERO, Studi sull’eleatismo, Tipografia del Senato, Roma 1932, p. 9).
16
ma poi ancora teoria della conoscenza ed epistemologia13, e financo
matematica e cosmologia14, hanno ricercato incessantemente nel
poema epico parmenideo i primi segni della loro presenza. Ritornare a Parmenide costituisce perciò un esercizio obbligato per lo
studioso, non fosse altro che per quel bisogno di appropriazione
delle radici che rappresenta un momento essenziale di definizione
di identità culturale – oltre che un efficace antidoto contro l’ingenuità del neofita.
La necessità di un tale ritorno non si gioca però per niente su di
un piano meramente storiografico. Si trattasse solo di questo, di seguitare il lavoro filologico, allo stato dei fatti sufficientemente consolidato, e di allungare la lista dei contributi dell’analisi testuale, allora l’interesse per questo pensatore vissuto più di venticinque secoli fa perderebbe gran parte della sua forza; e la stessa distanza che
ci separa da lui finirebbe per allontanarci ancor più dal suo pensiero.
Se, in altri termini, la parola essenziale del pensatore eleatico risultasse a noi muta, irripetibile testimonianza, ormai abbandonata alla
memoria storica, dell’inesauribile repertorio della curiosità dei
mortali, e non offrisse invece motivi, interrogazioni, squarci che lasciano tralucere la verità che attualmente ci interpella e chiama alla
fedeltà alla nostra nomade condizione di ricercatori dell’Assoluto,
allora forse il confronto con Parmenide, che qui si cerca di far
sorgere, sarebbe degno di debole attenzione. Altre dunque devono
essere le prospettive di ricerca.
Su quali basi, dunque, interrogare nuovamente Parmenide?
Ogni epoca interroga il proprio passato a partire dalle questioni poste dal presente. Come, dunque, con quale sguardo il nostro tempo
13
«La teoria di Parmenide può essere considerata la prima teoria ipotetico-deduttiva del mondo» (Karl POPPER, Ritorno ai presocratici, in Il mondo di Parmenide. Alla
scoperta della filosofia presocratica, Piemme, Casale Monferrato 1998, p. 41).
14 «La filosofia degli Eleati da un punto di vista storico è stata di importanza decisiva per il sorgere delle scienze matematiche. Senza questa filosofia la matematica come scienza, nel senso in cui oggi concepiamo quest’ultima, non sarebbe stata possibile» (Árpàd SZABÓ, Die Eleaten und die Mathematik der Griechen, in La parola del passato, XLIII, 1988, p. 420). Sui motivi astronomici del Proemio parmenideo si veda lo
studio di Giorgio IMBRAGUGLIA, Via della Demone o via del Nume?, in «Filosofia oggi», VIII, 1985, 2, pp. 233-284.
17
deve interrogare Parmenide? In che cosa deve venire ancora da lui
istruito? Siamo consapevoli che la rivelazione della verità annunciata nel suo Poema ha segnato potentemente la strada maestra
dell’Occidente, la strada dell’ontologia che conferisce alle cose il sigillo stabile dell’essere. Oggi però, come notavamo sopra, questa
strada appare impervia. Il venir meno della fiducia in sé dell’Occidente trascina con sé nell’incertezza anche la forza rassicurante di
quel sigillo15. Il lento frantumarsi di una più che bimillenaria tradizione filosofica pare così non risparmiare il suo iniziatore; al quale,
anzi, talora si imputa la fragilità del fondamento. Mentre, forse, è
solo l’Occidente a non aver saputo mantenersi all’altezza di Parmenide, della sua grande capacità di attenzione alla manifestazione
dell’essere.
Il compito, cui ci apprestiamo, trova nell’odierno contesto storico motivi che ne rendono la realizzazione ostacolata e facilitata al
contempo. Per un verso, infatti, all’umanità dell’epoca postmoderna non è più consentita la consueta e fidata risposta della tradizione
metafisica, messa in campo proprio a partire dai risultati dell’indagine di Parmenide, che l’essere non tollera eccezioni o limitazioni al
suo potere di determinare in maniera esclusiva la realtà. L’ombra
minacciosa ed inquietante del nichilismo, minacciosa ed inquietante quanto più capace di mettere in discussione la comprensione ritenuta incrollabile del fondamento ontologico, si distende infatti
sulla «pianura della verità» dove risplendono sicure le cose del commercio dell’esserci16. L’essere è tornato problematico. Lo scenario
ontologico non è più garantito; sentiamo il vacillare di quanto
aveva finora garantito il naturale terreno di sostegno.
La questione si è imposta di nuovo con forza all’attenzione della
riflessione pensante contemporanea. La domanda con la quale Heidegger chiudeva la sua Eintrittsvorlesung all’Università di Freiburg –
«Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts? Perché è in
generale l’ente e non piuttosto il Nulla?», una domanda provocato15
Altri potrebbero rovesciare l’affermazione ed attribuire all’indebolimento dell’essere il motivo che rende l’Occidente confuso ed incerto. Confesso però di non
condividere questa nuova forma di storicismo mascherato.
16 L’immagine platonica è contenuta nel Fedro (248b).
18
ria per una prolusione che annunciava nella sua intitolazione un discorso sulla metafisica, vale a dire sulla scienza dell’×n Î ×n17- delinea ancora le attuali coordinate della Grundfrage della filosofia. L’essere non è più il massimamente evidente, l’universale che non richiede giustificazione; e questo almeno nella misura in cui l’essere
stesso, nella totalità delle sue manifestazioni, sembra appeso18 alla
possibilità del nulla. Occorre pertanto prendere in carico l’incombenza di trovare una nuova legittimazione per l’essere o almeno di
ripeterci i motivi della fiducia in esso.
Ma la crisi del pensiero metafisico suggerisce anche, per altro verso, inaspettate potenzialità. Il venir meno della sicurezza dei cammini
della tradizione consente di esplorare possibilità dichiarate inidonee
od anche marginali, percorrere sentieri ritenuti fuorvianti, ascoltare
risonanze altrimenti sovrastate dal rumore di fondo di un ordine sistemico fortemente compatto. Un più vasto scenario di ricerca si offre dunque al pensatore e ne focalizza l’attenzione verso la fonte da
cui giunge a noi il richiamo dell’impegno filosofico. Occorre perciò
ritrovare l’acutezza e la libertà dello sguardo essenziale dell’inizio,
nella piena disponibilità del pensiero a lasciarsi istruire dal mistero19
che le cose manifestano, senza sovrapporvi, come accade inevitabilmente a noi epigoni, lo schema di usate procedure. Ciò che cercheremo in Parmenide, pertanto, è l’affacciarsi di una intuizione originaria del Tutto, nella quale riceva senso e una qualche stabilità l’esperienza di vita degli uomini mortali. Parmenide insegna a prestare fi17
Martin HEIDEGGER, Che cos’è metafisica? in Segnavia, Adelphi, Milano 1987,
pp. 59-77. Ho leggermente modificato la traduzione, rendendo Nichts con Nulla, invece di niente, come fa Volpi. Su questa che è la Grundfrage della filosofia del ’900, si
veda quanto osserva Luigi Pareyson nel saggio La «domanda fondamentale»: «Perché
l’essere piuttosto che il nulla?» (in L. PAREYSON, Ontologia della libertà, Einaudi, Torino
20022, pp. 353-383).
18 Riprendo l’immagine da Pareyson, che rivendica per la libertà, nella sua coessenzialità con il nulla, il posto che la filosofia della necessità attribuisce all’essere
(L. PAREYSON, op. cit., pp. 455 ss.).
19 Vale la pena di precisare che il termine mistero non intende richiamare alcun
genere di segreta ed iniziatica verità, ma vuole esprimere solamente, in piena conformità al valore etimologico della parola, l’esser celato alla vista del senso autentico delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, per richiamare il titolo del bel libro di
René GIRARD (Adelphi, Milano 1983).
19
ducia nella stabile consistenza delle cose mutevoli dei mortali ed allontanare così la minaccia tremenda del nulla20.
La gratuità della verità
Contro siffatta minaccia, a ben vedere, ha sempre lottato la filosofia, cercando in vari modi di disinnescarne il potenziale dirompente, ora negandone la plausibilità, ora invece mostrando il trofeo
conquistato contro di essa dalla forza della conoscenza scientifica,
ora infine liquidando la capacità rappresentativa del concetto medesimo. Eppure, nonostante tali tentativi, o forse proprio grazie ad essi, la drammaticità della questione che origina l’interesse filosofico
non è affatto venuta meno. Le pagine che seguono, cercheranno di
rendere esplicito quanto qui viene solo richiamato per grandi linee.
In sede introduttiva infatti interessa anzitutto delimitare la domanda
che farà da guida nello svolgimento del discorso. E la domanda, come si sarà già notato, non può essere altra da quella che la filosofia
pone a se stessa, quando si ridesta dalla sorpresa che le cose siano. Il
loro puro e semplice fatto di essere, il darsi della realtà, ed anzitutto
di quella realtà che io stesso sono e so di essere, in una modalità assolutamente non richiesta e non prevista, gratuita e allo stesso tempo piena di valore, il presentarsi di esperienze che l’uomo non ha
alcun diritto di pretendere od anche evocare, dalle quali tuttavia è
intessuta la sua esistenza concreta, a tutto questo deve prestare
attenzione chi voglia mantenersi nella ricerca della sapienza. Perché
è questa l’esperienza primordiale che orienta e dispone nella sua
autenticità il rapporto successivamente stabilito con le cose stesse.
La categoria di gratuità viene pertanto a giocare un ruolo chiave
nella proposta teoretica che qui si avanza. È gratuità del darsi della
verità e, prima ancora, dell’essere stesso. Essa riferisce della peculiare condizione ontologica che apparenta le cose nella loro totalità,
nel momento che si offrono alla nostra considerazione e al nostro
20
Sul tema ha sviluppato interessanti osservazioni Klaus Heinrich, di cui si veda
il saggio Parmenide e Giona. Un confronto condotto nella prospettiva della scienza delle religioni (in Klaus HEINRICH, Parmenide e Giona. Quattro studi sul rapporto tra filosofia e
mitologia, Guida, Napoli 1992, pp. 73-115).
20
commercio. L’uomo le prende, le usa, ne dispone, le ordina selezionandole ed attribuendo loro un nome riconoscibile. E tuttavia,
proprio in tale relazione pratica d’uso e dominio si ripresenta l’evidenza ontologica fondamentale, il fatto cioè che le cose sono, e sono senza alcuna ragione o necessità – gratuitamente, appunto. Noi
trattiamo e parliamo di cose, perché le cose ci sono. Ma nessuna fenomenologia può fare a meno di riflettere che le cose ci sono perché sono date, vengono chiamate all’essere senza poter avanzare alcuna pretesa. L’essere delle cose, in verità, non è assimilabile a nessun genere d’automatismo, che scatti inflessibilmente ogni qualvolta ricorrano certe circostanze. L’abitudine della frequentazione
mondana ci fa spesso velo, e nasconde alla riflessione pensante la
non esigibilità della presenza degli enti nel mondo, e del mondo
stesso; allo stesso modo poi affranca dallo stupore che, ancor prima
delle cose, siamo noi stessi a restare inconsapevoli del nostro proprio esserci, che nel senso più radicale ci è donato21. A questa sorta
di passività ontologica condivisa da ogni ente deve richiamare oggi
la meditazione pensante, per salvaguardare le cose nella loro valenza
autentica.
Ché se poi, a contestare detto richiamo, la scienza, o forse meglio, la tecnica, che è ai nostri giorni la modalità reale d’esercizio e
la condizione stessa d’esistenza del sapere scientifico22, afferma con i
suoi quotidiani prodotti di essere in grado di oltrepassare agevolmente e senza problemi di sorta il limite ontologico sopra richiamato, che dunque pare non sussistere più, a tale facile certezza tutta
compresa nel presente la filosofia deve contrapporre lo sguardo in21
Non è allora un caso che la filosofia abbia dedicato minima attenzione ad
un’esperienza qualificante e decisiva per l’essere dell’uomo, quale quella della paternità/maternità. Essere padre/madre infatti richiama immediatamente la non-indipendenza dell’uomo, il suo essere portato, chiamato, alla vita. Il tentativo della tecnica contemporanea di rendere superflua l’esperienza della paternità e maternità, o
meglio di ripensarla non più in chiave relazionale, ma come soddisfazione di un bisogno irrefutabile del soggetto autoreferenziale, rappresenta la testimonianza non riconosciuta dell’abbandono della verità dell’essere. Per una più articolata discussione
della questione, mi sia permesso di rimandare al mio saggio Il filosofo e il padre: le ragioni di un silenzio («Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia», II, 2000).
22 Su questo tema si vedano le considerazioni che svolge Umberto GALIMBERTI
in Psiche e techne, Feltrinelli, Milano 2002.
21
terrogante dell’essere, il quale si manifesta solo laddove il lavoro
dell’intelligenza fa spazio, nel silenzio di sé e delle cose presenti, all’ascolto della verità nel suo mai compiuto e sempre nuovo rivelarsi. Nelle mani dell’uomo la produzione tecnica concentra un capitale di potenza immensa, che promette di intensificare senza fine il
dominio sulle cose e sull’uomo stesso. La trasgressione del limite
ontologico sta mettendo tuttavia a repentaglio la stessa esistenza
mondana23. La violenza intrinseca al dominio dell’efficienza, che è il
dominio universale, il dominio dell’universale, va accumulando
nubi minacciose all’orizzonte: la ribellione dell’ambiente stuprato
dall’insaziabile voracità dei potenti, il tumulto dei popoli violati
nella loro dignità umana, lo smarrimento esistenziale dell’umanità
contemporanea, tutto ciò segnala l’urgenza di un cambiamento di
direzione.
Il discorso, che ha un suo immediato risvolto politico, interessa
qui il filosofo nella misura in cui in esso sono implicate manifestamente, anche se non sempre consapevolmente, precise opzioni etiche e metafisiche. È un approccio fondamentale all’essere che è in
questione. Si tratta del rivelarsi della verità dell’essere, che spetta alla filosofia, in quanto ricerca sapienziale, salvaguardare e difendere
dalla sua dispersione negli applicativi, che il potere del conoscere
tecnico-scientifico è ansioso di utilizzare nel suo impegno di dominare il mondo. Questo è quanto ha fatto Parmenide, con la sua netta presa di posizione per l’essere; e questo è quanto cercherà di suscitare il presente lavoro, ricercando da ultimo le condizioni dell’eventuale utilizzabilità del paradigma ontologico parmenideo.
Perché il bisogno di filosofia risorge sempre, a dispetto dei suoi
sempre loquaci e funebri cantori.
23
Riflessioni di grande interesse su questo tema sono svolte da Hans JONAS nel
suo Il principio responsabilità, Einaudi, Torino 1990.
22
CAPITOLO I
METAMORFOSI DELLA FILOSOFIA
Filosofˆa
La ben nota locuzione che traduce la parola greca filosofˆa
come amore del sapere non può di certo esser detta priva di storia.
Una lunga e consolidata tradizione, attiva almeno a partire dalla
grande stagione filosofica dominata dalle figure di Platone ed Aristotele, la identifica come quel tipo di passione intellettuale che
tende alla conoscenza ultima della realtà1. La filosofia si offre perciò
quale massima espressione della naturale tensione verso il superamento dell’ignoranza in cui l’uomo è come naturalmente immerso.
E filosofo, nell’immaginario collettivo, ha indicato a lungo il modello di ogni esperto ricercatore della verità.
Qualcosa tuttavia, se non proprio nella traduzione, almeno nell’interpretazione dei termini che compongono la parola stessa, non
sembra soddisfare del tutto2. Resta come la sensazione di una lenta,
leggera ma inesorabile deriva, che allontana la filosofia dalle sue ori1
«E allora – domandò – quali dici che siano i veri filosofi?” E io, in risposta:
“Quelli che amano contemplare la verità (toÝj tÁj ¢leqe…aj [...] filoqe£monaj)”»
(PLATONE, Repubblica, 475e). Aristotele da parte sua ritiene che «gli uomini hanno
filosofato per liberarsi dall’ignoranza» (ARISTOTELE, Metafisica, A 2, 982b 20).
Secondo Diogene Laerzio tuttavia fu Pitagora il primo ad usare il termine filosofia e
a chiamarsi filosofo. E «filosofo è colui che accoglie la sapienza» (DIOGENE
LAERZIO, Vite dei filosofi, Proemio, 12). Ma l’attribuzione del dossografo pare
risentire dell’interpretazione platonica. La prima emergenza testuale del termine
filosofo in realtà è data nel fr. 14 A102 di Eraclito (ed. COLLI, La sapienza greca,
Adelphi, Milano 1990. Nell’edizione classica di Diels-Kranz [Hermann DIELS, Die
Fragmente der Vorsokratiker, hrsg. v. W. KRANZ, Wiedmann, Berlin 19516; tr. it. I
Presocratici. Testimonianza e frammenti, Laterza, Roma-Bari 1979] il frammento è
numerato come 22 B35): «Gli uomini che amano la sapienza (filosÒfouj
¥ndraj), invero, è necessario che riescano a testimoniare proprio moltissime cose».
2 Un’insoddisfazione che, a ben vedere, si annuncia già nella polemica eraclitea
contro la mera conoscenza enciclopedica, la polumaq…h, alla quale appunto il
filosofo di Efeso oppone l’ascolto del lÕgoj che solo dà sapienza. Si vedano i fr. 14 A
67 e 3 (ed. Colli; 22 B 40 e 35 DK).
23
gini, attraendola inevitabilmente verso l’orizzonte della scienza; entro il quale, però, essa non fa che sperimentare con sempre maggiore inquietudine la propria evanescenza. Le dimensioni della crisi,
che abbiamo sommariamente evocato nell’introduzione, sembrano
richiedere interventi più radicali di volonterose rianimazioni della
tradizione filosofica consolidata3. È forse giunto il momento di una
opportuna rivisitazione del significato stesso attribuito alla parola.
Certamente, l’autorità di una tradizione – che è poi niente di
meno che la tradizione che ha costruito l’Occidente – non può essere revocata senza colpevole leggerezza; essa costituisce il mondo
della cultura, che è per l’uomo quasi una sorta di seconda natura da
cui egli è come plasmato intimamente ed alla quale perciò non è
dato facilmente rinunciare. Prendere le distanze, od anche semplicemente differenziarsi da una tradizione consolidata è perciò impresa temeraria, che fa correre il rischio di rimanere schiacciati sotto
il peso di cui il trascorrere del tempo l’ha rivestita; è questo, però,
un rischio che deve essere corso, se è vera l’analisi che ha originato
ed introdotto la riflessione che andiamo qui conducendo. Sentiamo
infatti l’urgenza di avviare un profondo ripensamento della tradizione filosofica, e proprio al fine di riaffermare con forza il bisogno
attuale di filosofia e così riproporre quest’ultima come protagonista
del dibattito culturale. Tanto più che oggi, con maggiore evidenza
rispetto al contesto storico e culturale tenuto presente da Snow in
un suo fortunato libro della fine degli anni ’60 del secolo scorso4, la
filosofia non può più pretendere di occupare il posto egemone da
essa a lungo tenuto nella competizione tra le «due culture».
Ripartiamo perciò proprio dalla spiegazione comunemente seguita della parola: filosofia come amore per il sapere. Ma come va
compresa questa locuzione? «Questa parola filosofia significa lo studio della saggezza, e […] per saggezza non s’intende soltanto la prudenza negli affari, ma una perfetta conoscenza di tutte le cose che
3
Proprio nella sottovalutazione della radicalità degli effetti del sommovimento
culturale del tempo che viviamo, pur riconosciuto come vasto e profondo, sta, a mio
avviso, il limite di fondo del tentativo, altrimenti ben condotto, di Giovanni Reale
di riproporre la saggezza antica come terapia per i mali dell’uomo d’oggi (Giovanni
REALE, Saggezza antica. Terapia per i mali dell’uomo d’oggi, Cortina, Milano 1995).
4 Charles P. SNOW, Le due culture, Feltrinelli, Milano 1970.
24
l’uomo può sapere»5. Con la sua definizione Cartesio offre una pregevole sintesi di quella che può esser accolta come l’ordinaria e più
diffusa comprensione della filosofia; la filosofia si interessa6 del sapere, il quale poi sostanzialmente viene a coincidere con la conoscenza della realtà. La filosofia è perciò quella sana curiosità che spinge
l’uomo a risolvere l’ignoranza delle cose in un sistema attestato e
non contingente di conoscenze. È evidente così la piena identificazione della sofˆa con la conoscenza, anzi, di più, con la conoscenza condotta, come nella scienza, al suo massimo grado di perfezione; identificazione usuale, ripetutamente affermata, ma forse non
pienamente legittima, se solo si prova a sciogliere i fili etimologici
che annodano famiglie di parole.
Muoversi sul terreno del linguaggio è però operazione
estremamente delicata, per le difficoltà di ricomporre l’evoluzione
linguistica ed il pericolo sempre in agguato di micidiali scivolate
teoriche. E tuttavia, pur con tutta la cautela imposta da una
ricerca, quale quella etimologica, che non può essere invocata
direttamente come giustificazione di questioni che hanno invece
una intrinseca rilevanza teoretica, è nondimeno manifesto che
termini come conoscere (e„dšnai), conoscenza (gnîsij) od
anche scienza (™pist¾mh) dal punto di vista linguistico non
mostrano traccia di comunanza alcuna con sof…a; termine al
quale, invece, sono senz’altro apparentate le parole latine sapientia,
sapere, passate pressoché intatte nell’italiano sapienza, sapere 7.
Questa fortunata congiuntura si rivela particolarmente feconda, in
quanto ci dà l’opportunità di esplorare risonanze ancora presenti
nelle parole e, più ancora, nei giochi di parole.
Seguendo questa linea di associazioni linguistiche, una cosa appare ora evidente. Mentre la convinzione comune fa del sapere un
5
CARTESIO, I principi della filosofia, in Opere, Laterza, Roma-Bari, 1967, v. II,
p. 11.
6
Secondo il significato della parola latina studium, che dice anzitutto
l’applicazione, la ricerca di qualcosa che suscita interesse. Cartesio dice saggezza, che
in verità esprime la dimensione pratica della sapienza filosofica. Ma, come si può
vedere, subito amplia il significato della parola fino a includere anche il significato
più propriamente teoretico.
7 Come mostra la successione sibilante-labiale (s-p) che struttura le parole citate.
25
atto intellettuale funzionale all’ottenimento di un possesso conoscitivo, lo spettro semantico della parola italiana sapere conserva invece
tracce di un quadro più ampio che la rende altrettanto pertinente al
campo del gusto quanto a quello della conoscenza. Come risulta
chiaramente ad una considerazione meno frettolosa del termine, c’è
senza dubbio una sorprendente affinità linguistica di sapere con
sapore. Sapere significa in italiano tanto avere cognizione di qualcosa8
quanto anche avere sapore9. Questa ambivalenza di riferimenti –
un’ambivalenza del tutto positiva, come vedremo fra poco – è senz’altro rafforzata dall’appartenenza allo stesso ambito semantico di
parole come sapido, che nella radice denunciano la chiara derivazione da sapere. Sapido è un cibo che ha buon gusto in quanto salato al punto giusto; il sale è in effetti un condimento che ha il potere
di far esaltare massimamente il gusto proprio delle vivande. Il legame del sale col sapore, e quindi col sapere, è poi confermato anche
da una serie di modi di dire: cum grano salis (sc. sapientiae), non hai il
sale in zucca10. Abbiamo così davanti a noi tutto un sistema di connessioni linguistiche particolarmente interessanti. Quale antiquissima sapientia, ci chiediamo perciò con Giambattista Vico, si è depositata dunque nel linguaggio?
L’ambivalenza semantica sopra segnalata merita la massima attenzione. Essa infatti impone anzitutto di salvaguardare tutta la ricchezza di significato conservata da parole quali sapere e sapienza;
nelle quali si dà come una sovrabbondanza teorica che non accetta
di essere ricondotta a quadri univoci, per quanto grandiosi. Benché
indubbiamente presente, la sola dimensione intellettuale e cognitiva in effetti non sembra in grado di mantenere unita insieme quella
8
Come nella frase idiomatica: «Lei non sa chi sono io!».
Come nella frase: «questo cibo non sa di nulla». Ma anche nella lingua latina il
verbo sapio gioca con la medesima oscillazione tra il gusto e l’aver cognizione. Il
francese moderno ha in qualche misura mantenuto la medesima vicinanza,
chiamando il sapere savoir e saveur il sapore.
10 Entrambe le locuzioni fanno riferimento all’antico rito del battesimo, nel
corso del quale sulla testa del battezzando veniva lasciato cadere un po’ di sale,
simbolo della sapienza. Interessante allo stesso modo, ai fini del nostro discorso, è il
fatto che sciocco, che indica primariamente una persona o un comportamento di
questa non ispirato a sapienza, nell’area linguistica umbro-toscana sia chiamato il
pane senza sale.
9
26
pluralità di registri semantici; le sfugge infatti l’impasto, che poc’anzi abbiamo colto come essenziale, del sapere col sapore e col sale.
Proprio questo suo intimo legame, in verità, fa sì che il sapere sia
più che semplice apprensione di nozioni, per quanto assicurate dal
sistema di una teoria scientifica non controversa; di siffatte cognizioni, al contrario, il sapere è interessato a cogliere come il gusto,
vale a dire ad esplorare i territori in cui esse affondano le loro radici,
interrogando le cose in ragione della questione del loro significato.
Perché, oltre la preziosa questione della loro identità, le cose del
mondo reclamano una risposta, ineludibile allo stesso modo, che affronti il senso del loro darsi; un perché finale, collocato su un livello
differente da quello della serie della causalità efficiente determinata
scientificamente11, e che non cessa di interpellare l’uomo circa la ragione dell’essere delle cose e del suo stesso esistere. Il sapere si apre
allora alla modalità del valutare; operazione questa che comporta
certamente la conoscenza, o meglio, il riconoscimento degli oggetti, e che tuttavia oltrepassa tale approccio, ancora estrinseco, per
concentrarsi sull’individuazione del valore non immediatamente
visibile, e per questo ancora continuamente da svelare, dell’oggetto
medesimo.
Di tutto questo la sof…a si fa interprete e garante. Essa si rivela
perciò, in maniera autentica, come quel sapere che ricerca il sapore
delle cose, vale a dire la cifra che rende queste ultime significative
entro il contesto più ampio di relazione mondana. Sapere il sapore
è adozione di un approccio alla realtà che interroga questa in relazione al suo darsi che non può essere oggetto di pretesa alcuna da
11 Lo si vede nel ripetuto far capolino della prospettiva teleologica, formalmente
esclusa dalla scienza moderna, nei discorsi degli scienziati, come, ad esempio, in
questa frase del premio Nobel James D. Watson: «la natura può creare due esseri di
aspetto molto diverso semplicemente orchestrando gli stessi geni che funzionino in
modo differente» (James D. WATSON, DNA, Adelphi, Milano 2004, p. 244
[corsivo mio]). Dove è evidente che il parlare di orchestrazione acquista il suo valore
solo nel rimando ad un quadro finale di armonica composizione intenzionale, qui
invocata per spiegare la diversità, che deve consistere in qualcosa di ulteriore e di
diverso rispetto al puro e semplice assemblaggio più o meno caotico degli elementi
che lo compongono. Sono affermazioni come questa a dar testimonianza di come la
risposta causale propria della scienza non riesca a dar conto della complessità
dell’esperienza.
27
parte dell’uomo che la riceve; è adesione ad una dinamica di ascolto
e rispetto della verità, ancorché nascosta, nello stesso suo manifestarsi attraverso segni disseminati nel mondo delle cose12. Allora
queste sono testimoni di un sapore che può essere provato solo “assaggiando”13, vale a dire dis-oggettivando le cose stesse, togliendo la
distanza dell’opposizione che le separa dall’uomo, che ad esse si
rapporta e che è invitato ad entrare in un rapporto nuovo, più intimo e diretto, con le stesse. E, allo stesso modo che per sentire il gusto di un cibo è necessario assaggiarlo, cosa che è impossibile ottenere senza far perdere al cibo stesso il suo darsi come oggetto esterno e separato da chi lo mangia, parimenti per poter sapere occorre
andar oltre la natura oggettuale delle cose, o forse meglio ancora,
oltre la dimensione stessa dell’oggettivabilità; alla quale invece, con
piena legittimità e come insuperabile condizione, tien fermo la conoscenza scientifica14. L’oggettivabilità, ovvero la capacità di essere
oggetto, il mio opposto – come ben evidenzia il tedesco Gegen stand, ma tradisce anche il latino objectum15 – cessa pertanto nel
mondo di sof…a di valere come la dimensione unica di coglimento
veridico del reale; è per contro in quell’esperienza di incontro con
le cose del mondo, nella quale, mettendo in gioco anche se stesso,
l’uomo si lascia interpellare dal fondo transoggettuale da cui le cose
medesime emergono, che il mondo stesso come orizzonte di significato diventa luogo di illuminazione dell’esistenza.
L’intuizione originaria che la parola greca filosof…a sedimenta è perciò capace ancora di sprigionare tutta la sua forza, se ascoltata in profondità. Filosof…a è anzitutto un file‹n t¾n sof…an,
amore di una sapienza che svela il valore ed il senso stesso del reale
12
Ho avuto modo di sviluppare queste considerazioni nel saggio Sapere il sapore.
La filosofia tra Fede e Ragione («Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia», VII,
2005), cui rimando per una più precisa discussione della questione.
13 Assaggiare: altra parola che, come il sinonimo assaporare, rimanda al
medesimo circuito di ampi significati di sapere. As-saggiare è tendere verso (ad-) la
saggezza in cui si esprime il sapore autentico; è cogliere il gusto che consente la
conoscenza vera della realtà data.
14 Secondo uno dei suoi significati, ™pist¾mh indica l’atteggiamento dello star
(‡stasqai) sopra, a capo, in posizione dominante (™p…) una realtà che, per essere
osservata e conosciuta, deve rimaner separata dall’osservatore che la sovrasta.
15 Ob(st)-jectum: ciò che mi sta gettato di contro come ostacolo.
28
nella sua dimensione più ampia; una sapienza capace sì di accogliere
ed anche generare la conoscenza nell’ampia gamma delle sue produzioni oggettive, e nondimeno irriducibile a questa ed alla sua intrinseca esigenza sistematica. Definire la filosofia come volontà o
spinta verso la conoscenza risulta pertanto decisamente inadeguato
a rappresentare lo spirito che la muove. Questo, peraltro, vive nella
tensione di un pathos insaziabile, cui il mito platonico di Eros, semidio figlio di Ingegno e Povertà, ha dato voce potente16.
La condizione di indigenza è pertanto consustanziale al pensare
filosofico; alla sua radice infatti sta la trascendenza della verità17 che,
ri-velandosi18, allo stesso tempo si nega alla sua completa definizione, riservando per sé lo spazio di un’eccedenza di significato inattingibile all’umano indagare. Sul versante antropologico, ad essa
corrisponde la finitudine insuperabile dell’esserci umano, finitudine
ontologica che impone all’uomo di cercare la verità nell’apertura
dell’oltre, nel trascendimento di sé e delle cose che sono, in un at16
«Amore è filosofo», dice Socrate raccontando il discorso di Diotima su Amore
nel Simposio platonico (201d – 204c.)
17 Verità è ’Alhqe…a.
18 L’uso del trattino separatore non risponde ad un vezzo alla moda, cui spesso si
ricorre per dare un lustro di pensosità ad un pensiero in debito di riflessione, ma
vuole soltanto rendere manifesto lo sfondo linguistico che i termini rivelare e
rivelazione nascondono, e così sottrarli all’impoverimento semantico cui li ha
consegnati la modernità. Rivelare e rivelazione, infatti, vanno riportati alla duplice
intenzionalità espressa nel prefisso ri (latino re), che indica insieme movimento
contrario e ripetizione dell’azione. Essi quindi denotano insieme tanto lo svelare
quanto il velare nuovamente, in un processo ermeneutico globale che forza la
contraddittorietà, insuperabile logicamente, degli opposti movimenti e trova nello
iato della loro reciproca irriducibilità la via verso la trascendenza. Si è giustamente
domandato Bruno Forte: «Qual è il concetto di rivelazione, che domina l’epoca
moderna? La risposta a questo interrogativo rinvia al predominio esercitato nella
teologia della modernità dalla categoria espressa dalla parola tedesca Offenbarung.
Questo termine, impostosi con la lingua di Lutero, sta a dire l’atto del portare
all’aperto il precedentemente nascosto. Esso privilegia uno solo dei due sensi,
dialetticamente contenuti nella parola latina re-velatio (e presenti entrambi – in
perfetta analogia – anche nel termine greco ¢po-k£luyij): fra il toglimento del
velo (re-velare inteso come l’atto di abolire la copertura) e il suo infittirsi (re-velare
inteso come un più fitto velare), è il primo significato che domina nella concezione
della Offenbarung e nell’esegesi di che di essa fa il pensiero moderno» (Bruno FORTE,
In Ascolto dell’Altro. Filosofia e rivelazione, Morcelliana, Brescia 1995, p. 18).
29
teggiamento di disponibilità all’ascolto e di salvaguardia del mistero
dell’essere19. L’amore che la sostiene è quindi anche ciò che differenzia originariamente ed essenzialmente la filosofia dalla scienza;
nella quale il movimento continuo verso il conoscere, termine della
ricerca, non esclude tuttavia ma esattamente implica la pretesa di
una definitività di principio, per quanto pur provvisoria, del risultato conseguito20; laddove alla filosofia è invece di principio esclusa la
possibilità di chiusura del cerchio teorico. Essa è dunque ricerca
aperta, in quanto suscitata da un appello che la convoca e che non
può mai accomodarsi entro gli orizzonti dell’umana capacità.
La prospettiva che ci si viene aprendo nella meditazione del pensiero richiede perciò di fare ancora un passo avanti, che porti oltre
l’impostazione di Platone, di cui pure non può non essere riconosciuta tutta la ricchezza. Per quanto infatti la collocazione platonica
della filosofia nella dimensione dell’erotica sia in grado di illuminare
lo iato che sempre si dà tra quanto l’uomo riesce a determinare nel
corso della sua ricerca e l’oggetto verso cui dirige il suo desiderio, essa però, nella misura in cui sembra ritenere questa differenza condizione transitoria di un percorso ascendente che alla fine si risolve pie19
Una finitudine ontologica, che gli interventi della tecnica mirati al superamento del limite oggettivo della corporeità, non fanno che confermare e paradossalmente
dilatare. Col che si manifesta sempre meglio la natura metafisica della tecnica.
20 Il che, ovviamente, non significa attribuire alla conoscenza scientifica il carattere di un processo dogmatico incapace di accrescersi ed anche di ritornare sui suoi passi,
mettendosi in discussione. Di una inesauribilità per così dire quantitativa si nutre la ricerca scientifica, che insegue per sua stessa natura l’obiettivo di acquisire progressivamente la formula delle leggi che governano la realtà oggettiva. Una siffatta tensione –
per cui si può dire propriamente che la ricerca non ha mai fine, dal momento che senza
fine si danno od anche vengono prodotte situazioni problematiche – impone comunque, relativamente alla natura delle conoscenze così ottenute, la determinatezza esatta
e definita, almeno di principio. E se è vero che la scienza si muove tra congetture e confutazioni, come recita il titolo di un noto libro di Karl Popper (Il Mulino, Bologna
1972), è vero del pari che la falsificabilità delle sue asserzioni costituisce per lo scienziato la condizione previa, non già la finalità della sua ricerca; finalità che rimane pur sempre quella di riuscire a condensare in una formula atemporale, quindi valida a prescindere dal tempo e dallo spazio e dunque tendenzialmente esaustiva, il processo considerato. In altre parole, lo scienziato giustamente rivendica per la sua scoperta un certo
valore di definitività; ma questo può esser messo in discussione solamente dalla scoperta di nuovi fatti od anche sistemi teorici maggiormente comprensivi o più coerentemente esplicativi.
30
namente nella conquista del sapere21, resta come prigioniera di sé e
della sua pretesa di assolutezza. Del resto la passione amorosa di Eros
non è esattamente lo stesso che la fil…a. Bisogna perciò trovare
un’altra strada che, senza mandar dispersa la riflessione fin qui seguita,
sappia nondimeno arricchirla di ulteriori significati.
Preziose indicazioni ci possono venire ancora di nuovo dal lavoro sul linguaggio. E qui si dà una circostanza che impone una opportuna considerazione. Una modalità piuttosto usuale di costruzione delle parole nelle lingue classiche, ma rintracciabile anche in
quelle moderne, antepone nella costruzione delle parole il genitivo
al nominativo, come si può vedere in modo estremamente chiaro
ad esempio nella parola geografia. Geo-grafia è la descrizione della
terra. Un calco esatto della parola sarebbe: della terra la descrizione.
Applicando lo stesso schema di composizione alla parola filo-sofia, il
risultato ci porterebbe davanti ad una decisa inversione dei termini
usualmente affermati: la filosofia è dell’amore la sapienza. Questa
annotazione, che sembra della massima rilevanza, trova conferma
nell’interessante osservazione di Emmanuel Lévinas, qui di seguito
riportata. «La filosofia più che amore del sapere è la sapienza dell’amore o la sapienza come amore»22. Ora, per quanto non sia corretto
costringere le parole entro regole linguistiche, le quali evidentemente si sovrappongono alle parole stesse rispetto alle quali si pongono come astratte generalizzazioni, ed anche tenendo nel dovuto
conto il fatto che altri vocaboli greci, composti proprio a partire dal
medesimo termine filo-, che troviamo anche in filosofˆa, mostrano di non rispettare appunto la regola sopra descritta23, resta il
21
«In breve – disse – l’amore è tendenza a essere in possesso del bene per
sempre» (PLATONE, Simposio, 206a).
22 Emmanuel LÉVINAS, Tra noi. Saggi sul pensare-all’altro, Jaca Book, Milano
1998, p. 266.
23 È il caso di parole come fil£nqrwpoj (amico degli uomini), fil£rguroj
(avido di denaro). Da questa osservazione non è tuttavia lecito dedurre che allora il
termine f…loj dia luogo esclusivamente a costruzioni linguistiche nelle quali esso
abbia una posizione iniziale. Altri vocaboli, come paidÒfiloj (amante dei
fanciulli), qeofil»j (amico di dio), confermano infatti che l’idea di “amico / amante
31
fatto senza dubbio sorprendente che filosofia accetta la sua resa di
significato come la sapienza dell’amore.
Ma cosa può voler dire questo? In quale senso si può dire di sapere l’amore? E come la sapienza è amore? È necessario perciò prendere in esame più da vicino il valore dell’aggettivo f…loj, cui è affidato
il compito di veicolare questo messaggio. Il significato comune di
f…loj, tanto nel riferimento a persone quanto in relazione a cose, è
quello di caro, amato, gradito24. Frequente in Omero è il suo uso come predicato, in locuzioni come f…lon moi ™st…, mi è caro25. Al neutro, poi, tÕ f…lon indica ciò che è oggetto di affezione. Dall’insieme delle variazioni ed occorrenze linguistiche risulta dunque piuttosto evidente il fatto che il valore del fileîn è più quello passivo che
quello attivo; è più un essere amato che un amare. ’O f…loj, l’amico,
è tale in quanto amato, caro a colui che lo ricerca.
Sulla scorta di tali conclusioni proviamo ora a ritornare sulla
sorprendente indicazione ermeneutica che legge la filosofia come
sapienza dell’amore. Tale allora è la filosofia in quanto raccoglimento che apprezzando assapora e custodisce ciò che è caro. Filosofo, prima ancora di colui che ama la sapienza, è perciò colui che
dirige la propria mente verso ciò che è oggetto di amore. È pertanto attorno a tÕ f…lon che converge e fa perno l’ansia sapienziale.
Esso è qualcosa di veramente essenziale, la cui memoria spetta al filosofo tener desta e far risuonare nello stordimento e nella dispersione che consegna l’esistenza umana al commercio strumentale
delle cose. È su questa attenzione per ciò che è caro che si è concentrato il pensiero dei primi pensatori, filosofi proprio per la disponibilità e la capacità di ascoltare e corrispondere all’appello che
viene dal principio. Lo abbiamo visto nei frammenti di Eraclito, il
sapiente di Efeso, sopra richiamati; lo vedremo più avanti lasciandoci guidare da Parmenide nel racconto del suo viaggio verso la sapienza.
di…” si esprima nei vocaboli in conformità alla modalità di formazione delle parole
sopra esposta.
24 F…loi mèn qeo‹j, ¢gaphtoˆ dè f…loij (SENOFONTE, Memorabilia, 2, 1, 33).
25 Cfr., ad esempio, OMERO, Odissea, 7, 320.
32
E tuttavia la voce comune che vede nella filosofia la forma più
alta del desiderio conoscitivo non è per questo messa a tacere. Anzi,
essa ritiene di esprimere con ogni esattezza l’essenza della filosofia,
nel suo più che bimillenario svolgimento. Per affrontare ora la questione nel suo nucleo, sono proprio i momenti cruciali di questo
svolgimento che si tratta di seguire; processo che potremmo definire una vera e propria metamorfosi della filosofia, trasformazione decisiva per le sorti stesse della sapienza originaria annunciatasi nella prima riflessione greca.
Il logos filosofico dell’occidente
«Collaborare a che la filosofia si avvicini alla forma della scienza,
– alla meta raggiunta la quale sia in grado di deporre il nome di amore del sapere per essere vero sapere, – ecco ciò ch’io mi sono proposto»26. Con un atteggiamento improntato a grande modestia, in
qualche modo contrastante con la grandiosa promessa annunciata
dall’affermazione, nella Prefazione dell’opera che lo imporrà quale
massimo esponente della filosofia tedesca del primo Ottocento Hegel tratteggiava così il profilo della filosofia. La filosofia si appresta a
diventare scienza; il sogno a lungo coltivato prende forma. Possono
pertanto essere pure dismessi gli usati panni della ricerca, che hanno
segnato il suo affannoso tendere verso il conseguimento del sapere,
dato che oramai essa possiede quest’ultimo in tutta la sua pienezza27.
Nell’annunciare allo stupito mondo tedesco l’avvento del Reich des
Geistes che le armate napoleoniche andavano imponendo all’Europa intera28, il filosofo divenuto sofÕj si dispone perciò a raccogliere nella chiarezza della coscienza pensante l’intera «contrada della
26
G.W.F. HEGEL, Fenomenologia, op. cit., I, p. 4.
Ovviamente si tratta di un sapere essenziale, nel senso platonico del termine;
un sapere dunque che non può riguardare le infinite contingenze dell’esserci, ma
l’effettuale nella sua più intima razionalità, das wirkliche. «Dacché dunque lo spirito ha
conseguito il concetto, dispiega l’esserci e il movimento in questo etere della sua
vita, ed è scienza» (ivi, II, pp. 302-303).
28 È noto che Hegel terminò di scrivere la prefazione della Fenomenologia dello
spirito proprio mentre Napoleone stava combattendo la “battaglia delle nazioni” a
Lipsia. Delle preoccupazioni per la pubblicazione dell’opera ci racconta il suo primo
27
33
ragione»29. La lunga preparazione al sapere assoluto, cui l’intera
schiera dei filosofi, ognuno per la sua parte, ha dato essenziale contributo, può dirsi finalmente conclusa. «Tutto ciò in sé già consummatum est»30!
Come emettendo il suo ultimo respiro filosofico, in attesa di fare il trionfale ingresso nel regno del sapere assoluto, l’annuncio hegeliano si predispone a guidare l’umanità intera ad accogliere con i
dovuti onori la nuova e definitiva stagione della scienza. Dalla filosof…a, dunque, alla sof…a; una sof…a beninteso pensata come
epistème, scienza dell’Assoluto, nei due sensi, soggettivo ed oggettivo, del genitivo: tanto cioè come sapere che l’Assoluto stesso possiede, quanto, e più, come sapere definitivo intorno all’assoluto.
Qualche anno più tardi, nella Scienza della logica, Hegel era pronto a
mettere in atto il programma cui si sentiva destinato. «Ci si può
quindi esprimer così, che questo contenuto [la scienza della logica]
è la esposizione di Dio, com’egli è nella sua eterna essenza prima della
creazione della natura e di uno spirito finito»31.
La vetta, che il filosofo tedesco afferma di aver finalmente conquistato, ha costituito in effetti per lunghi secoli l’ambizione ed il
sogno segreto di ogni filosofo. Raggiungere ed impossessarsi
biografo, Karl Rosenkranz (Karl ROSENKRANZ, Vita di Hegel, Mondadori, Milano
1974, pp. 244 ss.), che riporta anche la famosa lettera di Hegel a Niethammer, datata
Jena, lunedì 13 ottobre 1806, dove il filosofo esprime tutta la sua ammirazione per il
generale francese: «ho visto l’imperatore – quest’anima del mondo – uscire a cavallo
dalla città per andare in ricognizione; è in effetti, una sensazione meravigliosa vedere
un tale individuo che qui, concentrato in un punto, s’irradia per il mondo e lo
domina» (Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Lettere, Laterza, Roma-Bari 1972,
p. 77). Sulla grande importanza che Napoleone ha avuto sulla riflessione del filosofo
tedesco ha insistito particolarmente Alexandre Kojève, nelle sue letture francesi della
Fenomenologia dello spirito (Alexandre KOJÈVE, Introduzione alla lettura di Hegel,
Adelphi, Milano 1996).
29 L’affermazione in verità è del giovane Marx (Karl MARX, Differenza tra la
filosofia di Democrito e quella di Epicuro, Editori Riuniti, Roma, 1990 p. 77). Ma già
Hegel nella Fenomenologia (op. cit., II, p. 135) aveva annunciato che l’Assoluto si stava
trasferendo in un’altra «regione dello spirito autocosciente», rappresentato dalla
filosofia tedesca. Marx tuttavia aggiunge che in quella contrada «Dio ha cessato di
esistere».
30 Ivi, I, p. 24.
31 G.W.F. HEGEL, Scienza della logica, Laterza, Roma-Bari 1974, I, p. 41.
34
dell’epistème, placare la sete di conoscenza nella visione sub specie aeternitatis del mondo e dei percorsi storici che l’uomo vi sa realizzare,
garantirsi così dall’incertezza dell’esistenza fissando una volta per
tutte il sapere e, soprattutto, attraverso quest’ultimo determinare i
limiti dei rivolgimenti mondani, costituiscono mete cui la ragione
umana ha saputo e sa difficilmente rinunciare; mete rispetto alle
quali solo il riconoscimento della finitezza della condizione ontologica dell’uomo avrebbe potuto costituire efficace antidoto. Ma come pensarsi finiti, quando l’universo intero pare piegarsi ai piedi
della potenza della razionalità32?
L’impronta di una simile tensione è ben radicata nella storia culturale dell’Occidente; ne ha plasmato, per così dire, la sua più intima intenzionalità. Non dobbiamo aspettare infatti il XIX secolo
per vederne emergere il contorno, che è già sufficientemente delineato in Aristotele, in particolare nella sua definizione della filosofia
come prëth ™pist¾mh, scienza prima, «la più degna di onore» e la
«migliore» di tutte perché «la più divina»33. La filosofia è la regina
delle scienze, e lo è anzitutto per l’eccellenza del suo oggetto: per32
In quello che, secondo la nota definizione di Northrop FRYE (Il grande codice.
La Bibbia e la letteratura, Einaudi, Torino 1986), è il «grande codice della letteratura
occidentale», la Bibbia, si pone a ben vedere la stessa questione. Non dice il tentatore
all’’adam fatto di terra che, prendendo i frutti dell’albero della conoscenza del bene e
del male, sarebbe diventato come Dio? E Dio, che passeggia alla brezza del
pomeriggio, non riconosce implicitamente la verità dell’affermazione di colui che
mettendosi in mezzo (dia-b¦llein) introduce la scissione nell’intimo dell’uomo,
dal momento che poi scaccia i progenitori dal giardino di Eden perché questi non
mangino anche dell’albero della vita divenendo così immortali e del tutto eguali a
Dio (Genesi, 3)? Ma, poi, la creatura, ormai abbandonata a se stessa, saprà mantenere
l’equilibrio dell’intero? o non piuttosto si rivelerà incapace di tenere insieme
(sun-b¦llein) ciò che la propria condizione alienata, irrimediabilmente scissa, non
può che affrontare analiticamente, vale a dire per porzioni successive e sempre
tuttavia parziali? Ma quando la parte prende il posto dell’intero, questo si frantuma
in segmenti autoreferenziali, che successivamente sarà la tecnica e non più la filosofia
e l’etica a dominare, e che rendono problematica la ricomposizione dell’unità.
Diventa allora pensabile e poi anche possibile l’aggressione dell’altro, umano,
ambientale, divino. È forse tempo di una lettura filosofica dell’evoluzione culturale,
ma poi anche storica, della società occidentale moderna, che sappia andare a fondo
nell’analisi delle matrici teoriche che ne ispirano il progetto.
33 Qeiot£th kai timiwt£th [™pist¾mh] (ARISTOTELE, Metafisica, A 2, 983
a, 5).
35
ché «una scienza può essere divina solo in questi due sensi: o perché
essa è scienza che Dio possiede in grado supremo, o, anche, perché
essa ha come oggetto le cose divine»34.
La conclusione non tarda a farsi attendere. Subito dopo aver argomentato la superiorità della filosofia, Aristotele infatti continua:
«il possesso di questa scienza deve porci in uno stato contrario a
quello in cui eravamo all’inizio delle ricerche»35. Essa è scienza proprio perché, avendo superato lo sconcerto prodotto dalla meraviglia
da cui è stata generata, – infatti gli uomini, aveva detto Aristotele
poco prima, «hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a
causa della meraviglia»36 – può affermare di avere finalmente raggiunto «quella felice condizione in cui [...] Dio si trova perennemente»37; ad essa così si apre la visione calma e beata del reale nella
sua vera essenzialità. Risvegliato alla ricerca dallo stupore iniziale
provato di fronte ad una realtà che si presenta densa di mistero sia
nella regolarità vicina alla perfezione dei suoi processi, come pure
nelle fratture inattese degli stessi, il filosofo si impegna così a dissolvere il velo di ignoranza, da cui è come avvolto nella sua condizione iniziale e che è la causa della sua meraviglia, per arrivare al dominio dell’evento stupefacente mediante la scoperta della legge rigorosa che lo governa in modo inflessibile38.
Sorprendente è la vicinanza, anche linguistica, con l’affermazione hegeliana da cui siamo partiti. Ancora una volta dalla filosof…a alla sof…a in quanto ™pist¾mh. Ciò che però in Aristotele è
34
Ivi, A 2, 983 a, 7-8.
Ivi, A 2, 983 a, 11-12. Tale stato finale «è anche il migliore», osserva Aristotele
qualche riga più oltre (18-19).
36 Ivi, A 2, 982b 12-13. Il testo continua così: «mentre da principio restavano
meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco a
poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori: per esempio i problemi
riguardanti i fenomeni della luna e quelli del sole e degli astri, o i problemi
riguardanti la generazione dell’intero universo».
37 Ivi, L 7, 1072b 25. Come avremo modo di vedere più avanti, non è senza
significato che con la citazione di questo passo della Metafisica aristotelica Hegel
chiuda la sua Enciclopedia delle scienze filosofiche (Laterza, Roma-Bari 1973).
38 «Cosicché, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall’ignoranza, è
evidente che ricercano il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire
qualche utilità pratica» (Ivi, A 2, 982b 19-21).
35
36
ancora un imperativo, un obiettivo da raggiungere, diventa con
Hegel realtà attualizzata. Per questo verso allora la ragione moderna
si presenta come il fedele e compiuto dispiegamento del lÕgoj greco nella sua veste matura, quale cioè appare nel rigetto aristotelico
dell’apporto fecondante del màqoj39 e nella successiva affermazione
della esclusività e preminenza della ragione conoscitiva rispetto alle
altre forme di esperienza teorica della stessa40. In altri termini, con la
razionalità moderna giunge a finale e pieno compimento quell’atteggiamento filosofico che ha individuato la sua funzione nella produzione di conoscenze dimostrate e pertanto indubitabili, in grado
di assicurare un pieno dominio speculativo sulla realtà oggettiva41.
39
«Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere; ed
è per questo che anche colui che ama il mito è, in certo qual modo, filosofo (diÕ kaˆ Ð
filÒmuqoj filÒsofÒj pèj ™stin): il mito, infatti, è costituito da un insieme di
cose che destano meraviglia» (Ivi, A 2, 982b 17-19 [corsivo mio]). La natura
incidentale della frase aristotelica mostra con ogni evidenza che il recupero del
màqoj avviene in chiave puramente concessiva, quale sorta di tributo da pagare alla
cultura arcaica che, col riflettere attorno agli stessi problemi oggetto più tardi di
speculazione filosofica, ha in qualche modo suggerito una prospettiva di ricerca. Ma,
si noti bene, autenticamente filosofica nel mito è, secondo Aristotele, la domanda,
non la risposta; questa deve svolgersi secondo i canoni dell’epistème.
40 In proposito va richiamata la delimitazione aristotelica del giudizio di
conoscenza al solo giudizio apofantico e il conseguente rimando delle altre forme di
giudizio alle analisi delle scienze non teoretiche della retorica e della poetica (cfr.
ARISTOTELE, Dell’espressione, 4, 17, 1-8). Sulle conseguenze fuorvianti di questa
impostazione teorica è degno di attenzione quanto ha scritto Hans-Georg Gadamer
in Verità e metodo: «La riduzione dello status ontologico dell’esteticità sul piano
dell’apparenza estetica trova quindi la sua radice teorica nel fatto che il dominio del
modello conoscitivo delle scienze naturali conduce a screditare ogni possibilità di
conoscenza che si collochi fuori di questo nuovo ambito metodologico» (H.-G.
GADAMER, Verità e metodo, Bompiani, Milano 1983, p. 113).
41 La scienza contemporanea è diventata certamente più prudente. Ma la
prudenza non è ancora generalizzata. Ad un Damasio che scrive «probabilmente si
dovrebbe rivedere il concetto umano di etica. È proprio il vecchio concetto di cosa
è “buono” e cosa è “cattivo” che mina il futuro della scienza. Sono convinto che noi
scienziati dovremmo affrontare questo problema e dire alla gente che sì, è vero, nella
natura non esiste un principio etico che possa indurre le persone a essere buone e
gentili con il proprio vicino. Ma l’etica è una struttura artificiale che possiamo
benissimo costruire, in quanto esseri umani» (Antonio DAMASIO, E dal corpo nacque
l’anima: le emozioni nell’evoluzione, «Micromega», 2007, 2, p. 71. [Corsivo mio]),
andrebbe opposto quanto scriveva l’enfant terrible dell’epistemologia novecentesca,
37
Ma come spiegare questa sorprendente consonanza di fondo, al
di là della obiettiva differenziazione delle posizioni teoretiche dei
due filosofi, veramente rappresentativi delle loro età? In quale senso
abbiamo potuto dire che la prëth ™pist¾mh di Aristotele è veramente paradigmatica per la posteriore filosofia occidentale?
A ben vedere, un paradigma esercita il suo compito non quando
prescrive un contenuto determinato, ma quando fornisce le procedure formali che ordinano ogni contenuto. Riconoscere pertanto
alla filosofia aristotelica una funzione paradigmatica equivale a cogliere i motivi a partire dai quali la filosofia ha compreso se stessa.
Più ancora che nella concezione metafisica, nel nostro tempo peraltro non universalmente riconosciuta, la paradigmaticità della posizione aristotelica consiste allora nella direzione di marcia che il filosofo greco è riuscito ad imprimere alla ricerca filosofica; sta tutta
nella sua connotazione della filosofia come scienza. Aristotele afferma questo con grande decisione. «Col nome di sapienza (sof…a)
tutti intendono la ricerca delle cause prime e dei principi. […] È
evidente, dunque, che la sapienza è una scienza (™pist¾mh) che riguarda certi principi e certe cause»42. «È chiaro, dunque, che occorre acquistare la scienza delle cause prime: infatti diciamo di conoscere (e„dšnai) una cosa, quando riteniamo di conoscerne la causa
prima»43.
Cosa poi sia scienza non è difficile da comprendere. Si tratta
della forma più elevata di sapere44, la cui struttura formale consiste
in buona sintesi nel fatto che essa possiede la chiave della dimostrazione di quanto afferma. Più importante del cosa, è il come della
conoscenza; è solo questo ciò che assicura validità scientifica al sapere stesso. Scrive Aristotele nell’Etica Nicomachea: «tutti ammettiamo che ciò di cui abbiamo scienza non può essere diversamente da
Paul Feyerabend, che si chiedeva per quale motivo e di quale concezione della
democrazia si fanno portavoce coloro che ritengono che a decidere circa le sorti
dell’umanità debbano essere i soli scienziati (Cfr. Paul FEYERABEND, Galileo e la
tirannia della verità, «L’Astronomia», 1987, 71, pp. 28-36).
42 Metafisica, A 1, 981 b 28 - 982a 2.
43 Ivi, A 3, 983 a, 24-26.
44 Quel sapere (e„dšnai) cui «tutti gli uomini per natura tendono»; proprio così
aveva esordito Aristotele nella Metafisica (A 1, 980a 1).
38
quello che è»45. Ed ancora, negli Analitici secondi: «Ora però chiamiamo sapere il conoscere mediante dimostrazione. Per dimostrazione, d’altra parte, intendo il sillogismo scientifico»46. Così Aristotele può riassumere il tutto dicendo che «la scienza è quindi una disposizione alla dimostrazione»47.
Il ragionamento del filosofo greco è lineare e di cruciale importanza. Ciò che garantisce il primato della filosofia, oltre e prima ancora dell’oggetto del suo tendere, è la struttura formale della ricerca
stessa, è la sua apoditticità. Decisiva è così la trasformazione della filosofia da forma eminente di sapere dialogico-dialettico, come era
pensata ancora dal primo Platone48, a scienza dimostrativa, vale a dire a sapere definitorio e formalizzato, le cui regole e procedure di
formalizzazione garantiscono della esattezza dei risultati49.
La giusta osservazione che già Platone abbia aperto la porta a
questo processo50, come pure la considerazione che Aristotele usi
indifferentemente, quasi a mo’ di sinonimi, i termini sofˆa e
™pist¾mh non spostano di molto l’asse del discorso; giacché ciò che
45
Ö ™pist£meqa, mhd’™ndšcesqai ¥llwj ›cein (Etica Nicomachea, Z, 3, 1139b
20-21).
46 Famèn dè kaˆ di’¢pode…xewj e„dšnai. ¢pÒdeixin dè lšgw sullogismÕn
™pisthmonikÒn (Analitici secondi, I, 2, 71 b, 17-18).
47 ¹ mšn ¥ra ™pist¾mh ™st…n ›xij ¢podeiktik¾ (Etica Nicomachea, Z, 3,
1139b 31-32).
48 «“Chi sono allora, o Diotima – io dissi – coloro che filosofano, se non lo sono
i sapienti e gli ignoranti?”. “È ormai chiaro – rispose – anche ad un bambino che
sono quelli che stanno a mezzo fra gli uni e gli altri, e uno di questi è appunto anche
Eros. Infatti la sapienza è una delle cose più belle, ed Eros è amore per il bello.
Perciò è necessario che Eros sia filosofo, e, in quanto è filosofo, che sia intermedio
fra il sapiente e l’ignorante”» (PLATONE, Simposio, 204 a-b). Va comunque osservato
che la gamma di significati di filosofia tende a spostarsi, a partire dal dialogo
Repubblica, verso lo spettro dell’epistème dialettica (cfr. PLATONE, Repubblica, VII,
531d).
49 Oltre alla questione dell’esattezza dei risultati, Aristotele si pone anche il
problema della loro verità. Questa dipende dalla verità delle premesse e dei principi,
che sono colti con un atto noetico, essendo di per sé evidenti (ARISTOTELE,
Analitici secondi, I (A), 2, 71 b, 20-28). Rimandiamo più avanti la discussione della
questione, osservando però sin da questo momento che essa ha degli aspetti
problematici, su cui occorrerà riflettere con attenzione.
50 Cfr. Martin HEIDEGGER, La dottrina di platonica della verità, in Segnavia, op. cit.,
pp. 159-192.
39
conta è il fatto che la filosofˆa sia qui diventata ™pist¾mh, che la
ricerca della sapienza, che nella sua indigenza si mantiene in cammino verso ciò che attrae in quanto massimamente vero, si sia mutata in possesso compiuto della scienza.
Entro questo scenario non faranno fatica ad essere recitate, al di
là delle differenti sfumature nelle sceneggiature e delle particolari
qualità individuali degli interpreti, rappresentazioni come la ricomposizione medievale della teologia entro l’ambito della scienza51, la
baconiana richiesta di un sapere che sia produttivamente fruttuoso52, la rifondazione della metafisica imposta a Cartesio dal nuovo
universo scientifico galileiano, la scienza assoluta dell’assoluto degli
51
TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae I, a. 2: Utrum sacra doctrina sit scientia.
«Respondeo quod sacram doctrinam esse scientiam. [...] Et hoc modo sacra doctrina
est scientia: quia procedit ex principiis notis lumine superioris scientiae, quae scilicet
est scientia Dei et beatorum».
52 «La scienza e la potenza umana coincidono, poichè l’ignoranza della causa
impedisce la produzione dell’effetto. La natura, infatti, non si vince se non
obbedendole» (BACONE, Nuovo Organo, Bompiani, Milano 2002, p. 79). Non si
rifletterà mai abbastanza sulla decisiva svolta che la riflessione baconiana imprimerà
alla filosofia, che da scienza contemplativa è chiamata ad essere scienza fruttifera. «I
frutti, infatti, e le opere realizzate sono i garanti [sponsores] e i fideiussori della verità
delle filosofie. [… La filosofia] sia giudicata dai frutti e considerata inutile quella
sterile» (ivi, pp. 137-139). E così, se da un lato la moderna campagna di
trasformazione del mondo ha avuto impulso grande e potente legittimazione, per
altro verso la verità della ricerca è stata consegnata al successo operativo, che ne
garantisce (fa da sponsor, come con inconsapevole preveggenza si esprime Bacone) la
opportunità e convenienza. Che allora l’utilità, categoria dell’efficienza che si
relaziona a individui concreti e non tollera dilazioni che la proiettino nel tempo o
nello spazio verso altri ipotetici soggetti, si affermi come traiettoria unica dell’agire
umano, concedendo graziosamente un posto alla verità purché questa la confermi,
non è effetto inatteso. Ma poi, quanto maldestramente l’utile sappia sostenersi al
vertice della gerarchia dei valori ce ne dà chiara evidenza la condizione
preoccupante del pianeta terra, una condizione che lungi dall’essere improbabile
esito del progresso economico, costituisce in verità evento normalmente squilibrato
di uno sviluppo intrinsecamente squilibrato, quale quello che la società occidentale
ha globalmente imposto. Inquinamento, degrado ambientale, hanno allora una loro
chiara spiegazione se pensati come prodotti da una relazione dell’uomo verso la
natura – quella natura di cui egli è parte e non tutto – tale che questa debba essere
assoggettata al suo proprio unico, egoistico perché miope, interesse; non: rispettata,
vale a dire assecondata nelle sue produzioni, ma: vinta come dice Bacone, ovvero
spinta “innaturalmente” a produrre ciò che essa da sola non sa fare. Si afferma così
40
idealisti, i differenti verificazionismi positivisti e neopositivisti, per
finire con i più recenti ritorni alle origini originarie che strutturano
la necessità dell’essere53. Ciò che accomuna teoriche così diverse è
proprio la convinzione, implicitamente accettata come evidente, e
pertanto né discussa né discutibile, della identificazione del sapere
filosofico con il sapere apodittico della scienza, garantito e legittimato dalla strategia metodica della dimostrazione. In questo modo
la ragione, suscitata dalla filosofia e da questa consegnata alla scienza, ha potuto tranquillizzare se stessa, affermando la propria signoria, dapprima solo teorica, poi anche pratica, sul mondo, che così
cessa di essere il meraviglioso, il qaumastÕn, per mostrarsi invece
solamente come il terreno di esercizio del potere assoluto, senza limiti estrinseci, del lÕgoj ordinatore e legislatore.
Si potrebbe a questo punto continuare, invocando le ben note
analisi di Adorno e Horkheimer sulla riduzione della ragione a ragione strumentale54, o le previsioni heideggeriane sul destino della
filosofia dell’Occidente, terra del tramonto, come «trionfo dell’organizzazione pianificabile del mondo su basi tecnico-scientifiche e
dell’ordinamento sociale adeguato a questo mondo»55. Più che
compiangere tale destino, è però importante capire a fondo le ragioni di una così radicale, ed al tempo stesso decisiva, trasformaziouna logica di dominio, logica che produce violenza nella stessa misura in cui non
riconosce valore alcuno a ciò che non parla la voce tintinnante del calcolo
dell’interesse.
53 Si potrebbe parlare di una parabola del lÕgoj, che si innalza dapprima verso la
vetta della scienza assoluta dell’Assoluto, per poi cadere rapidamente ed allo stesso
tempo rovinosamente nelle spirali perverse della negazione della ragione. Certo,
non tutti i filosofi possono essere collocati lungo tale parabola. La meditazione
agostiniana sulla persona, all’origine delle più interessanti proposte filosofiche del
Novecento, come pure l’acuta osservazione di Pascal circa l’eccedenza dell’esistenza
rispetto alla conoscenza «la geometria lo chiamo pure il più bel mestiere del mondo;
ma in fondo non è che un mestiere» - lettera a Fermat del 10 agosto 1660, in Blaise
PASCAL, Opuscoli e lettere, Paoline, Milano, s.d., p. 212, o ancora la liberazione
kantiana di uno spazio di trascendenza metacognitiva che si distende oltre la
dimensione fenomenica, ne rendono ampia ed autorevole testimonianza.
54 Max HORKHEIMER, Theodor W. ADORNO, Dialettica dell’illuminismo,
Einaudi, Torino 1976.
55 Martin HEIDEGGER, La fine della filosofia e il compito del pensiero, in Tempo ed
essere, Guida, Napoli 1988, p. 173.
41
ne. Cosa che ci apprestiamo a fare, mettendo sotto osservazione la
struttura della dimostrazione che, come abbiamo detto, costituisce
la vera anima del sapere filosofico così come ci è stato consegnato
dalla tradizione filosofica dell’Occidente.
LÕgoj ¢podeiktikÕj
Cosa significa dunque dimostrare? Per rispondere correttamente
alla domanda occorre ancora una volta far risuonare l’intuizione
originaria, depositata e come cristallizzata nella parola stessa. Raccogliendo dunque l’eredità linguistica che si conserva nel verbo dimostrare56, ciò che giunge all’aperto è l’eco di un dinamismo concettuale che si applica ad una modalità di incontro della realtà tale che
questa venga mostrata, indicata57. Un tale dinamismo merita grande
attenzione; esso indica infatti una provenienza, una derivazione
nella serie della causalità efficiente58, un movimento discensivo nella
gerarchia ordinata degli enti59, in virtù del quale è autorizzata altresì
la connessione capace di riunire in una sintesi necessaria estremi finora reciprocamente estranei. Ciò che è dimostrato è tale perché
rimandato al fondamento che lo istituisce. È nella forza di un siffatto rimando, strutturato come un legame che dà sostegno e protezione, che la dimostrazione esprime la necessità che la impone come decisiva.
L’approfondimento del termine latino offre poi ulteriori elementi di interesse. Non può infatti non colpire l’intima relazione
che il monstrare, a partire da cui si struttura propriamente l’azione
qualificante il demonstrare, mantiene con il termine monstrum, cosa
prodigiosa, realtà meravigliosa. Il dimostrare deve pertanto essere
considerato a partire da quest’ultimo; esso allora originariamente significa indicare il meraviglioso, il sorprendente, nella sua derivazione (de) da una realtà eccellente, di grado superiore; operazione questa, in virtù della quale l’ente viene sottratto alla sua natura inizial56
Dal latino demonstrare (greco ¢podeˆknumi).
Il verbo greco deˆknumi proviene da una radice indoeuropea dic-deic, presente
poi anche nei termini latini index, iudex, indico, dico ed altri.
58 È il senso della preposizione greca ¢pÕ che compone il verbo ¢podeˆknumi.
59 Come indica la preposizione latina di moto dall’alto in basso, de.
57
42
mente problematica e consegnato alla serie ordinata di una connessione causale. Il tratto fascinoso ed insieme conturbante della meraviglia cede il passo al più rassicurante e controllato ordine della
ragione.
Dimostrare è perciò mostrare apertamente, ostendere il
fondamento, la condizione in ultima analisi originante e non
condizionata, l’eccellente ciò-da-cui, nella necessità della relazione
ontologica con l’ente che da esso è posto60; ovvero, in versione
moderna, cartesiana, provare la verità di un assunto attraverso la
riconduzione dell’assunto stesso a quei principi che lo sostengono
e giustificano61. Tanto il realismo aristotelico quanto il primato
moderno della soggettività pensante esprimono a ben vedere la
medesima intenzionalità. L’obiettivo comune ad entrambe le
prospettive teoretiche è quello di riuscire al dominio concettuale
del reale mediante l’inserimento di quest’ultimo in una rete di
connessioni onto-logiche in grado di fornire al reale medesimo
collocazione e stabilità allo stesso tempo. A tale finalità la
dimostrazione fornisce la strumentazione teorica determinante.
Incatenato alle ferree maglie della necessità, che il lÕgoj della
¢pÕdeixij stringe inesorabile una dopo l’altra, il reale perde così
la sua irrequietezza, da questo punto in avanti tale solo in
60
«Noi pensiamo di conoscere un singolo oggetto assolutamente – non già in
modo sofistico, cioè accidentale – quando riteniamo di conoscere la causa, in virtù
della quale l’oggetto è, sapendo che essa è causa di quell’oggetto, e crediamo che
all’oggetto non possa accadere di comportarsi diversamente» (ARISTOTELE, Analitici
secondi, A 2, 71b 9-11). Per questo, «il conoscere – non accidentalmente – gli oggetti
la cui dimostrazione è possibile, consiste nel possedere la dimostrazione» (Ivi, 71b
28).
61 «Quelle catene di ragionamenti, lunghe, eppure semplici e facili, di cui i
geometri si servono per pervenire alle loro più difficili dimostrazioni, mi diedero
motivo a supporre che nello stesso modo si susseguissero tutte le cose di cui l’uomo
può avere conoscenza, e che, ove si faccia attenzione di non accoglierne alcuna per
vera quando non lo sia, e si osservi sempre l’ordine necessario per dedurre le une
dalle altre, non ce ne fossero di così lontane alle quali non si potesse arrivare, né di
così nascoste che non si potessero scoprire» (CARTESIO, Discorso sul metodo, in Opere,
Laterza, Roma-Bari 1967, I, p. 142).
43
apparenza, e si lascia tranquillamente ricondurre nell’ordito della
struttura sostanziale metafisica62 che governa l’ordine cosmico.
A tal fine è necessario sorprendere gli enti nella loro nudità essenziale, al di là dei vari travestimenti doxastici, fenomenici, per
evidenziare l’identità sempre eguale a se stessa della matrice ontologica che li sostiene63. La totalità del reale, provvista in quanto totalità di un senso e valore proprio e sovrabbondante, comunque eccedente l’orizzonte della individualità, viene per così dire smontata e
frammentata nella molteplicità degli enti-oggetti, occupanti ognuno uno spazio metafisico definito, all’interno della dimensione fondamentale dell’oggettivazione. La definizione diviene lo strumento
cruciale di questo processo.
Ancora una volta Aristotele offre lo spunto. Riprendendo e trasformando l’intuizione platonica della dia…resij64, questo genio
greco elabora una teoria, la teoria della definizione, che esprime in
maniera del tutto evidente quanto sopra abbiamo cercato di rendere esplicito. La definizione (ÐrismÕj), scrive Aristotele nei Topici,
«è un discorso che esprime l’essenza individuale oggettiva». «Chi
definisce deve infatti porre l’oggetto entro il genere, aggiungendo
62
La quale è presente anche laddove si faccia esplicita professione antimetafisica;
la vicenda del neopositivismo novecentesco ne dà sufficiente informazione. A
dispetto delle reiterate dichiarazione di disprezzo o presa di distanze dalla metafisica,
sostenute da Neurath o Carnap – famosa è la chiusa del saggio di Rudolf CARNAP,
Il superamento della metafisica attraverso l’analisi logica del linguaggio (in AA.VV., Il
neoempirismo, a cura di A. Pasquinelli, UTET, Torino 1969, p. 531), secondo il quale
i metafisici non sono se non «musicisti senza talento musicale» –, la forza apparente
del principio verificazionista si basava su una ben definita ipotesi metafisica di tipo
empiristico, come acutamente ha osservato Willard van Orman Quine nel saggio
Due dogmi dell’empirismo (in W.O. QUINE, Il problema del significato, Ubaldini, Roma
1966, pp. 20-44).
63 E se alcune importanti linee di ricerca della scienza contemporanea sembrano
aver rinunciato a tale fondamento ontologico, esse prendono allo stesso tempo
congedo da ogni residua pretesa di assolutezza avanzata dall’epistème. È Heisenberg a
sostenere che «perciò non sarà mai possibile con la pura ragione pervenire a una
qualche verità assoluta» (Werner HEISENBERG, Fisica e filosofia, Il Saggiatore, Milano
1966, p. 111) – avvicinandosi così molto di più di quanto si possa pensare, almeno
nelle sue più generali teorizzazione, alle forme del pensiero poietico quali l’arte e la
religione. Su una cosiffatta armonia svolge utili riflessioni il fisico americano Fritjof
CAPRA nel suo Il Tao della fisica (Adelphi, Milano 1982).
64 Cfr. Sofista, 218 e ss.
44
poi le differenze»65. Definire è quindi dire il finis, il confine che individua e separa66; è assegnare lo Ôroj, il luogo che circoscrive l’oggetto quale orizzonte proprio non superabile.
Il molteplice viene così spogliato della sua variopinta esistenza,
imprevedibile e letteralmente straordinaria, cioè fuori dell’ordine riconosciuto dall’esperienza, e ricondotto alla norma di una legge razionale, quanto si vuole dialettica, che esprime il ritmo unitario dell’essere e del pensare. Il reale, che per tal via si presenta anzitutto come mondo degli oggetti, può venire perciò abbracciato, ordinato e
dominato dalla ragione, che scopre, ritrova o semplicemente enuncia questa legge. Esso perde così il suo carattere sorprendente e destabilizzante. Ridotto alla sua dimensione logica, considerato quale elemento terminale della catena seriale che riconduce al principio necessario, il mondo degli oggetti è consegnato alla ferrea necessità del
procedere dimostrativo. La ragione può definitivamente comprenderlo, ovvero, alla lettera, afferrarlo globalmente e ridurlo in suo possesso67 – in una parola: conoscerlo. La conoscenza dell’™pist¾mh,
che, come Aristotele ci ricorda, trae la sua efficacia dalla forza intrinseca della dimostrazione, è dunque in tal modo pienamente affermata e stabilita. Ed ™pist¾mh è ora il nuovo nome della filosofia.
Si realizza in tal modo, attraverso la definizione quale primo momento del processo della conoscenza apodittica, il gigantesco progetto della ragione che riesce ad imporre la sua signoria sul mondo
degli oggetti. Nulla è dato che possa sfuggire di principio alla smisu65
ARISTOTELE, Topici, A, 5, 101 b, 38; Z, 1, 139 a, 30.
«Il genere deve infatti separare l’oggetto in questione dagli oggetti contenuti
negli altri generi, mentre la differenza deve separarlo dagli oggetti contenuti nel
medesimo genere» (ivi, Z, 3, 140 a, 28. [Corsivo mio]).
67 Non è senza significato il campo semantico del ridurre in possesso presente nei
vocaboli che rendono il processo di conoscenza. Se ne può cogliere una traccia nella
parentela linguistica tra il verbo latino capio (prendere), che forma la base verbale del
termine italiano concetto (cum-ceptus: com-preso) ed il sostantivo latino captivus
(prigioniero). Comprendere è perciò un prendere-tutto-assieme, un abbracciante
catturare qualcosa nella sua totalità, che così viene messa a disposizione del soggetto
conoscente. Il reale, che sovrasta con la sua imprevedibilità l’uomo, viene allora a sua
volta dominato dal sapere comprensivo dell’uomo che, abbracciando l’oggetto, lo
costringe nella rete concettuale da questi costruita. Simili affinità anche in tedesco:
Begriff (concetto) è ciò che afferra, cattura (Griff, Zugriff).
66
45
rata volontà di potenza conoscitiva che quel progetto tradisce. In virtù delle relazioni che esso riesce ad instaurare tra gli enti, ognuno di
questi trova il suo posto armonico nel tutto. L’efficiente armonia del
cosmo così ordinato funge da rinforzante garanzia della correttezza
di una simile procedura ed autorizza al tempo stesso la pretesa di
esclusività di una ragione così fatta. La logica stringente e rigorosa
della ragione in questa versione greco-moderna non dunque lascia
spazio ad alcuna via di fuga, neppure di respiro minimalista.
La potenza del lÕgoj apodittico e perciò apofantico, con i suoi
sezionamenti e determinazioni logiche, si manifesta così in tutta la
sua potenza. Una siffatta strategia intellettuale, che si è affermata su
tutto l’occidente caratterizzandolo fin nei suoi recessi più remoti al
punto da proporsi come l’immediatezza stessa della vita dello spirito,
richiede infatti, come condizione della sua stessa permanenza, la più
decisa affermazione della esclusività del lÕgoj colto nella sua specifica funzionalità apodittica. Logos è infatti la ragione ed il discorso
umano, o meglio ancora, la ragione che si afferma come discorso, capace di raccogliere, collegare, smontare e rimontare le parti di una
totalità in figurazioni concettuali strutturate secondo una necessità di
principio, anche se non sempre di fatto, incontrovertibile68. In quanto tale, esso non può non avanzare per i suoi rigorosi costrutti pretese
68
Come è chiaro, la struttura del lÕgoj è letta secondo la qualificazione che di essa ha dato la riflessione aristotelica; nella quale va perduta la risonanza, che, in contrapposizione a quanto tra poco vedremo, potremmo chiamare acustica, ancora presente
nel famoso frammento di Eraclito: «pur essendo questo logos, sempre gli uomini sono
senza il comune sentire, sia prima di ascoltarlo che dopo averlo ascoltato la prima volta» (14 A9 Colli; 22 B1 DK). Gli uomini sono ¢xÚnetoi, cioè sono privi (¢) del nesso
comune (xunÕn) che avvolge e governa la natura profonda delle cose; dove in greco
c’è un gioco di parole intraducibile tra xunÕn e xun nÕwi. Comune, in questo senso
distinto da koinÕn (fr. 14 A99 Colli; 22 B89 DK), è l’apprensione originaria che accompagna ogni discorso (14 A11 Colli; 22 B114 DK); e tale è precisamente il lÕgoj,
che si dà ad intendere solo a chi si dispone all’ascolto per lasciarsi guidare da esso, rinunciando alla privata saggezza dei più (fr. 14 A13 Colli; 22 B2 DK). Costoro, restando alla considerazione superficiale delle cose, ignorano che fÚsij krÚptesqai filšei (fr. 14 A92 Colli; 22 B123 DK), che «natura ama nascondersi», ovvero rimanere
nascosta all’indagine panoramica. La sapienza invece si concede solo a chi è capace di
ascolto della parola originaria. «Per chi ascolta non me, ma il lÕgoj, sapienza è riconoscere che tutte le cose sono una sola» (14 A3 Colli; 22 B50 DK – In questo e nei precedenti aforismi di Eraclito mi sono discostato dalla traduzione di Colli).
46
di autoreferenzialità e completezza cognitiva, rifiutando ogni forma
di dipendenza.
In questa sua metamorfosi, la filosofia ha in verità obbedito ad
un impulso che non può essere disatteso. In effetti, nel suo rapporto
mondano l’uomo non può non intessere con l’ambiente mondano
ed umano che lo circonda ed in cui si trova già sempre inserito un
rapporto di mutuo adattamento. Condizionato da esso, cerca a sua
volta di determinarlo secondo i suoi intendimenti. Dar nome alle
cose è impegno fondamentale dell’’adam fatto di terra. Sarebbe perciò sbagliato pensare che l’uomo possa sottrarsi a questo suo destino
che è in verità assunzione di responsabilità e, quasi come semplice
natura vivente, soltanto subire i ritmi inesorabili dell’universo69.
Non è perciò nella ricerca ed anche nel desiderio della conoscenza
che deve esser colto l’aspetto problematico che stiamo mettendo in
evidenza, ma semmai nell’estremizzazione di questa, nell’universalizzazione dell’intentio conoscitiva, che finisce per avere un effetto
dirompente e negativo nei riguardi di tutto quanto la oltrepassi ed
annunci, od anche solamente alluda alla più generale questione del
senso e del fondamento.
Il lascito che la filosofia ha consegnato alla storia della cultura e
che l’occidente ha fatto proprio lasciandosene intrudere fin nei suoi
più intimi recessi, è dunque della massima importanza. In questo
modo la filosofia ha offerto il suo prezioso contributo alla costruzione culturale. Quel che si tratta di valutare criticamente perciò non è
la generazione della scienza dalle costole della filosofia o l’eredità che
quest’ultima le ha consegnato, quanto piuttosto la trasformazione
che la filosofia stessa ha subito a seguito di questo stesso processo,
quasi per adattarsi al nuovo ed efficace approccio al mondo delle cose
di cui la scienza si è fatta portatrice ed interprete. E del resto, non è
col sogno romantico di felici ritorni a presunte età dell’oro o con
l’appello alla mozione degli affetti che potrà essere fermato il declino
del pensare filosofico, accasciato dai colpi inesorabili dell’avanzare
della tecnica. Ciò che si richiede è invece una chiara consapevolezza
69
La grandezza dell’uomo sta precisamente nella consapevolezza della sua
miseria, ricordava Blaise PASCAL (Pensieri, Mondadori, Milano 1980, pp. 252-253.
Fr. 372. 377 ed. Serini; 397. 347 ed. Brunschvicg).
47
della natura del logos e delle sue caratteristiche potenzialità ed insieme
e dei limiti del suo approccio al mondo; sul quale ora vogliamo fermare la nostra attenzione.
La metafora ottica
La metafora ottica: in questa sintetica locuzione potrebbe essere
riassunta, per grandi linee e nella sua unità speculativa di base, la filosofia occidentale. L’asserzione vorrebbe mettere in evidenza l’intendimento di fondo con cui la filosofia nelle sue espressioni maggiormente rappresentative ha vissuto la sua avventura teoretica, una sorta
di strategia complessiva che ha orientato lungo i binari della visione il
cammino di questa esperienza dello spirito.
Che l’orizzonte visivo sia il terreno privilegiato della filosofia trova una prima, ma ancora estrinseca conferma già al livello dello specifico linguaggio della disciplina. Le parole più tipicamente qualificanti il lessico filosofico tradiscono infatti una più o meno diretta relazione con la vista e il vedere. Speculazione, riflessione, contemplazione e, più ancora, teoria, idea: il rimando ottico di questi vocaboli è
evidente, persino letterale nella parola idea, edoj, solo che si ricordi
che la radice Fid, da cui deriva il latino video, è uno dei temi del verbo
greco Ñr¦w, vedere, e precisamente quello che esprime la funzione
non sensibile, intellettuale del vedere.
Una simile relazione non è forse poi così estrinseca, se tanto Platone quanto Aristotele insistono sul primato e sul privilegio che la vista gode su tutti gli altri sensi. Scrive il primo: «La vista, a mio giudizio, è diventata per noi causa della più grande utilità, in quanto dei
ragionamenti che ora vengono fatti intorno all’universo, nessuno sarebbe mai stato fatto, se noi non avessimo visto né gli astri, né il sole,
né il cielo»70. Per parte sua, conferma Aristotele proprio nelle battute
iniziali del primo libro della Metafisica, «noi preferiamo il vedere, in
certo senso, a tutte le altre sensazioni. E il motivo sta nel fatto che la
vista ci fa conoscere più di tutte le altre sensazioni e ci rende manife-
70
48
PLATONE, Timeo, 47 a. Cfr. Repubblica, 508 a.
ste numerose differenze fra le cose»71; quelle differenze che, come abbiamo poc’anzi osservato, costituiscono motivo essenziale della tecnica della definizione. Ciò che Aristotele presenta come semplice
constatazione, quasi mera espressione di un spontaneo comportamento72 – non solo filosofico dunque ma umano tout court; e che
però, come vedremo, non è né l’unico né, forse, l’originario –, ha effettivamente caratterizzato l’approccio prevalente della filosofia al
mondo degli enti. È infatti incontestabile che la vista abbia imposto la
sua supremazia su tutti gli altri sensi, proprio in virtù della sua perfetta
utilizzabilità e convenienza con l’interesse conoscitivo. Sintomatico
in proposito è il ragionamento che Platone svolge al momento di
proporre il suo modello ideale, un ragionamento il cui cardine ruota
appunto nella esplicita analogia di natura visiva instaurata tra i due
generi supremi di realtà, quello visibile (ÑratÒn) e quello invisibile
(¢idšj)73.
Naturale, nel senso della appropriatezza, che revoca ogni dubbio, posseduta da quanto è di uso ordinario, abbiamo visto definire
la relazione visiva al mondo. Ma tale naturalezza non deve trarre in
inganno; come ogni cosa che mette in gioco la spontaneità umana,
ad una considerazione più distaccata essa non nasconde infatti di
appartenere alla trama di costrutti concettuali che danno spessore ad
una cultura. Naturalmente privilegiata, insomma, la vista è per coloro che appartengono ad una tradizione culturale data, che ne afferma la centralità. Obiettivo dell’interpretazione allora è quello di
rendere esplicite struttura e implicazioni che sostengono quella particolare modalità di relazione. La considerazione attenta del fenomeno della visione è pertanto il passaggio che consentirà di rendere
evidente le radici dell’atteggiamento teorico che ha prodotto la metamorfosi della filosofia a scienza. Ci affidiamo in questo compito al
metodo fenomenologico, con l’obiettivo di far risaltare i termini
essenziali della fenomenologia della visione.
71
ARISTOTELE, Metafisica, A, 1, 980 a, 25-27.
«Tutti gli uomini per natura tendono al sapere. Segno ne è l’amore per le
sensazioni: infatti, essi amano le sensazioni per se stesse, anche indipendentemente
dalla loro utilità, e, più di tutte, amano la sensazione della vista» (Ivi, 21-24).
73 «Poniamo dunque, se vuoi – egli soggiunse – due forme di esseri: una visibile
e l’altra invisibile». (PLATONE, Fedone, 79 a).
72
49
Osservato come tale, il fenomeno della visione si presenta anzitutto in generale come strumento e luogo di relazione al mondo.
Essa articola una modalità efficace di apprensione degli oggetti secondo lo schema del soggetto vedente che intenziona l’oggetto visto. Ha luogo così un processo tra due opposti, la direzione del
quale è ben determinata e non suscettibile di rovesciamento. Al
contrario di quanto può sembrare vero di primo acchito, non è infatti l’oggetto ad imporsi primariamente al soggetto vedente; esso in
verità prende letteralmente corpo e si afferma come oggetto di attenzione soltanto a seguito di ed entro l’apertura di un campo visivo, della cui preliminare istituzione si fa carico il soggetto vedente
nella sua spontaneità. È constatazione tutt’altro che banale osservare
che per vedere occorre anzitutto aprire gli occhi. Ad occhi chiusi, il
mondo ci si annuncia nella sua indifferenziata presenza, non certo
nella ricchezza delle sue realtà individuali, che in questo caso rimangono come irretite ed inviluppate entro la densa struttura dell’essere mondano74. Il vedere si qualifica così fondamentalmente
quale attività primaria del soggetto, in virtù della quale questi può
concentrare l’attenzione e lasciar risaltare per sé di volta in volta gli
oggetti verso cui tende. Essi si danno senz’altro nella loro corposa
realtà già data e costituita a prescindere dalla volontà intenzionante
del soggetto75. Resta tuttavia che proprio il loro emergere come oggetti si produce nel contesto di un atto preliminare di interessamento e posizione, che illumina e rende significativo una porzione del
mondo. Questo non è mai colto pertanto nella sua totalità, ma si dà
sempre solo in quanto orizzonte di percezione; il mondo è sempre
il mio mondo. In altri termini, il vedere è azione che si svolge essenzialmente nel quadro di una prospettiva. Esso, aprendo il mondo allo sguardo indagatore, genera un cono prospettico che individua e
abbraccia uno scenario, il cui fuoco è saldamente occupato dall’osservatore (soggetto, io, anima). Io da qui vedo un qualcosa che è
74
In un differente contesto teorico, ad una esperienza simile sembra far
riferimento Lévinas col concetto dell’il y a (Cfr. Emmanuel LÉVINAS, Dall’esistenza
all’esistente, Marietti, Casale Monferrato 1986).
75 Ciò dovrebbe essere sufficiente ad escludere ogni ipotesi di soggettivismo
idealistico.
50
là76. Il vedere dunque è sempre, proprio in quanto attività, un vedere dal punto di vista, un vedere relativo alle modalità percettive ed
alla collocazione del soggetto vedente, e mai un vedere assoluto.
Ciò che io vedo, poi, è presente, mi è davanti; esso si dà per me
nelle forme della presenza opponente, ovverosia dell’essere oggetto. È perciò un vedere oggettivo, un vedere dell’oggetto, che richiede un distanziamento di quest’ultimo dal soggetto vedente.
Noi non riusciamo a vedere ciò cui siamo spazialmente aderenti.
Abbiamo perciò bisogno di allontanare da noi ciò che vediamo, distinguerlo da noi, porci sopra di esso per ri-fletterlo; solo così qualcosa entra nel nostro campo visivo. E questa condizione, che costituisce la possibilità stessa della definizione analitica che dà conoscenza, è il lato retto della medaglia, sul cui verso è scritta l’assenza
o la trasparenza visiva di ciò eccede, tanto in ampiezza quanto in
pienezza d’essere, il cono prospettico entro cui si gioca la fisica della
visione. È così ad esempio nel caso dell’universo, che non coincide
con l’insieme dei mondi che lo popolano. Questi possono essere
certamente osservati e visti, proprio nella misura in cui sono a noi
opposti; laddove invece l’universo nella sua totalità unitaria sfugge
di principio alla percezione visiva dell’uomo, accadendo questa già
sempre nell’universo, di cui essa offre, per così dire, uno spaccato a
più facce. Viene così meno la possibilità di costruire lo spazio della
necessaria distanza. In quanto tale, l’universo è pertanto come lo
sfondo “metafisico” che circonda e sostiene, e che non coincide
con il mio particolare orizzonte né con l’orizzonte degli orizzonti
umani. Essendo non-oggettivo, tale sfondo non può nemmeno venire annunciato dall’esperienza della visione; per la vista esso è il
buio assoluto o forse la luce assoluta, invisibili proprio perché
assolutamente puri.
Scandendo l’analisi in maniera più particolareggiata, possiamo
ancora osservare come il vedere tenda con ogni decisione alla definizione esatta del particolare visto. Lo sguardo pan-oramico che
76
L’idealismo è però sempre in agguato. Esso risorge dalle sue ceneri quando,
per una sorta di illusione ottica, l’essere-là, nel luogo aperto dallo sguardo, viene del
tutto identificato con l’essere ut sic. La grande lezione kantiana, che il fenomenico
non è la totalità dell’essere, viene così facilmente dimenticata.
51
istituisce il mondo degli oggetti, o semplicemente lo rap-presenta,
costituisce infatti solo l’avvio di un dinamismo che porta alla focalizzazione dell’oggetto visto. L’opposizione proverbiale tra guardare e vedere testimonia di queste due fasi del processo visivo.
“Guardano, eppur non vedono”: si dice così di coloro che non
riescono a superare il momento di un puro e semplice vagabondaggio visivo, che lascia loro preclusa la possibilità di individuazione
degli oggetti. Il vedere infatti esige precisione, vale a dire separazione che evidenzia e rende presente (prae-cisio) il particolare rispetto
agli altri oggetti dati. In questo senso scrive Cartesio nel paragrafo
45 della prima parte dei Principia philosophiae: «chiara chiamo quella
[percezione] che è presente e manifesta ad uno spirito attento: come noi diciamo di vedere chiaramente gli oggetti, quando, essendo
presenti, agiscono abbastanza fortemente, e i nostri occhi sono disposti a guardarli. E distinta, quella che è talmente precisa e differente
da tutte le altre, da non comprendere in sé se non ciò che appare
manifestamente a chi la considera come si deve»77. Osserva giustamente Cartesio, ciò che io vedo deve essere per me chiaro. Nel vedere non sono tollerate ambiguità o incertezze, il contorno visivo
deve essere netto, senza sfumature; solo così l’oggetto può essere
identificato e riconosciuto. E proprio per ovviare al deficit di esattezza dell’immagine, il miope stringe gli occhi allorché ha di fronte
a sé un oggetto, nel tentativo di diradare l’alone visivo che, rendendo sfumato il contorno, ne rende incerta la definizione.
Potremmo già a questo punto trarre le opportune considerazioni. Prima di compiere questo ulteriore passo, conviene però riassumere i risultati dell’analisi fenomenologica e metterli a confronto
con il tema della nostra ricerca. Abbiamo trovato che l’affermazione della metafora ottica, espressione con la quale si è indicato il primato della visione nel processo di formazione della strumentazione
concettuale della filosofia occidentale, ha costruito l’ambiente speculativo che ha potentemente inclinato l’attenzione del filosofo
verso l’obiettivo della massimizzazione della conoscenza. Direzionalità prospettica dello sguardo, distanziamento oggettivante, esatta
definibilità dell’oggetto si sono rivelate sue coordinate essenziali,
77
52
CARTESIO, I principi della filosofia, op. cit., p. 48. [Corsivo mio].
mediante le quali la realtà nella sua generalità, l’essere, ha assunto la
configurazione dell’essere-conosciuto; non è pertanto un caso che
già per Platone l’Ôntwj Ôn coincida con il noetÒn78. Il fulcro dell’attenzione teoretica è stato quindi pian piano catturato dalla questione dell’identità riconoscibile degli enti; una questione che peraltro, al contrario di quello che pensa Aristotele, ha una evidente
ricaduta pratica79.
Ma quel che più conta sottolineare, nel quadro del discorso che
stiamo sviluppando, è l’opportunità di giustificazione di sé, e della
propria pretesa di risolvere l’essere nell’identità conosciuta di questo, che la metafora ottica ha fornito al logos. Che così, senza alcuna
incertezza, ha potuto aspirare a fornire le chiavi di ogni esplorazione del mondo. Ecco perciò che l’essere come principio è divenuto
l’essere come fondamento del discorso epistemico, sostanzialmente
omogeneo alla struttura di questo; qualcosa dunque contrassegnato
dai caratteri dell’oggettualità, sia pur provvisto di una speciale magnificenza, che in qualche misura lo separa dagli oggetti mondani; e
tuttavia sempre assoggettabile ai canoni dell’indagine logica, alla fin
fine capace di squarciare il velo, se non anche di rimuoverlo del
tutto, che sottrae il mistero dell’essere alla piena comprensione
umana.
Passaggio necessario, abbiamo sopra detto, che però ha generato
una sorta di libido sciendi impegnata a ridurre a sé, alle proprie dimensioni, e in qualche modo financo offuscare, quanto eventualmente possa rivelarsi eccedente le proprie misure. Il conoscere diventa così l’impegno primo ed assoluto di una ragione che affida alla definizione ed alla dimostrazione, e quindi alla scienza, le proprie
possibilità di sopravvivenza. Una ragione la quale, benché spesso
vittima di cortocircuiti intellettualistici, afferma orgogliosa l’ostracismo della singolarità e dell’unicità, del multiversum, in nome dell’isonomia dell’universum.
Ma come la parabola della filosofia postidealistica insegna, il
prezzo da pagare per la conoscenza dell’oggettivabile è l’esclusione
78
PLATONE, La Repubblica, 517 b.
Cfr. Emanuele SEVERINO, “Intervista: Parmenide”, Enciclopedia multimediale
delle scienze filosofiche, http://www.emsf.rai.it.
79
53
dell’inoggettivabile dal dominio conoscitivo dell’epistème, e quindi
il suo relegamento negli ambiti a mala pena tollerati di una sorta di
gnoseologia minor, quali l’arte, la letteratura, la religione e, da ultimo,
la stessa filosofia, ai quali non viene riconosciuta pari forza di penetrazione sapienziale. Esso tuttavia, alla stregua del noumeno kantiano, è inattingibile alla ragione – non significativo, direbbero le versioni liberalizzate del neopositivismo – non già perché resistente ad
ogni forma di avvicinamento razionale, ma solo perché estraneo alla logica della metafora ottica, perché non visibile; dal momento
che la fenomenologia della visione esclude di principio, dunque
non vede, ciò che non è oggetto da vedere.
Il fatto è che ogni filosofia che segue il privilegio accordato alla
vista trova inevitabile incamminarsi lungo il percorso che la proiezione ottica illumina, ovvero lungo la via che porta al traguardo finale della comprensione dell’oggetto, all’afferramento dell’oggetto
stesso in un abbraccio che vuole circondarlo completamente, al dominio del reale ottenuto attraverso la riduzione del molteplice all’identico. Essa è in modo naturale epistème, la quale, diversamente
dalla filosofia che si mantiene aperta nei confronti delle eventuali irruzioni dell’Ulteriorità, tende alla chiusura concettuale della categorizzazione sistematica. È pertanto sapere monologico, nel duplice senso di essere l’unico discorso possibile ed il solo argomento riconosciuto di conoscenza, e di costituirsi come discorso unidirezionale, cui nessun interlocutore è veramente essenziale. Ma se è così,
forse la logica violenta dell’intolleranza e della sopraffazione, tornate oggi così prepotentemente sul proscenio, richiede ben altra ed
originale risposta.
In ascolto della verità
È una distinzione di ambiti e di atteggiamenti ed impostazioni
teoretiche quella che qui si rivendica. In effetti, la via verso la filosofia, nel senso originario sopra ricordato, resta ostruita finché non
venga rimosso l’ostacolo che ha deviato e condizionato la riflessione della tradizione filosofica europea.
54
Occorre pertanto aprire nuove piste. O forse meglio, riaprire piste
ora abbandonate ma un tempo frequentate. La facile accessibilità con
cui la filosofia ci si presenta nella sua esclusiva prassi teoretica orientata
visivamente non deve infatti dichiarare fuori luogo o superflua la ricerca di altre prospettive. Giacché, tutt’altro che scontata, emerge allora
un’altra prassi filosofica, se non proprio precedente almeno altrettanto
originaria di quella sopra qualificata come metafora ottica.
Ad una attenta analisi del materiale della “sapienza greca”, secondo la felice espressione di Giorgio Colli, non può sfuggire che i
primi passi dell’avventura filosofica abbiano tracciato il sentiero della sapienza guidati dall’ascolto e dall’accoglienza attenta e partecipe
di una voce narrante e per questo rivelante la verità.
Ora è la parola che si impone; una parola proclamata in maniera
autorevole e che pertanto richiede ascolto attento e fiducioso. Una
parola non bloccata entro il limite della soggettività illusoriamente
autoreferenziale, ma una parola capace di interpellare l’uomo ed
aprirlo alla scena originaria in cui le cose stesse prendon forma. E parola, parola essenziale di cui l’uomo non detiene l’iniziativa, è il màqoj. Attraverso di esso fa irruzione nel mondo degli uomini il principio che origina e orienta il senso stesso dell’esistere. «Mito è, in questo senso, rammentare che lo spirituale, se anche si dischiude nell’umano, è però il suo trascendimento. Mito è la rammemorazione che
l’uomo non è onnipotente: storia e cultura sono trascese, non meno
che dal lato dello spirituale puro, dal lato della natura. Mito è, dunque, il congedo dalla filosofia antropocentrica della soggettività: riconoscimento insieme della radice naturale dell’uomo e del carattere
oltreumano dello spirito. [...] Attestando la difettività e condizionatezza naturale dell’umano, il mito è allora la consapevolezza che la
verità per l’uomo è sempre un accadere, qualcosa che si dà attraverso
narrazioni, metafore, simboli ma, insieme, è la consapevolezza che
narrazioni, metafore, simboli non sono la verità»80.
Màqoj è così la parola della narrazione dell’inizio, nella quale
quest’ultimo viene sottratto al velo che lo ricopre nella distanza,
temporale più e prima che spaziale, della trascendenza e offerto al80
Gianni CARCHIA, Mito. Esperienza del presente e critica della demitizzazione,
«Aut Aut», NS, 1991, nn. 243-244, p. 6.
55
l’uomo affinché costui divenga consapevole delle proprie origini. È
nel màqoj e come màqoj che la verità, che è ben più della correttezza del dire umano, si rivela nella sua inattingibile ed insuperabile
alterità, irriducibile al lÕgoj che da essa è posto nella sua retta collocazione. Un màqoj che non può dunque essere mitologia; concetto nel quale, proprio per la forzata sovrapposizione del lÕgoj al
màqoj, la verità si ritrae dalla scena che dà il senso all’essere mondano81.
Al binomio vedere-conoscere, che, come abbiamo già notato,
ha costituito l’ossatura ego-centrica e violenta – violenta perché
egocentrica – della ratio filosofica della tradizione dell’occidente,
subentra così la coppia dire-ascoltare, luogo autentico di ogni successivo dire umano. Si propone in questo modo una diversa e nuova configurazione dell’orizzonte veritativo. La circolarità en-ciclo-pedica del sapere della ragione auto-centrica, una circolarità
che rafforza la propria essenziale clausura nella ciclicità di un ritorno
dell’identico, è costretta ad aprirsi all’orizzonte bifocale di un pensiero ellittico, capace di originare uno spazio semantico solo in virtù del continuo passaggio tra i due fuochi dell’ellisse medesima. La
verità, ovvero il disoccultamento del mistero che è anche, reciprocamente, il mistero del disoccultamento, si origina e prende forma
all’interno del dialogo fecondo tra una Parola originaria che appella
un interlocutore attento ad essa, e una parola seconda, derivata, che
nella risposta a quell’appello rende ragione (nel senso del didÒnai
81
«Si può dunque concludere con discreto fondamento che il sostantivo
mythologìa e il verbo mythologeùo accolsero e conservarono un significato restrittivo
dell’originaria parola mythos: il significato di “parola efficace” ridotta a “narrazione
non obbligatoria, non implicante argomentazioni”; mentre il significato di mythos
come “parola efficace”, “progetto”, “macchinazione”, “deliberazione”, si trasferì
quasi esclusivamente nella parola lògos e sopravvisse nel verbo mythiàzomai. Questo
vuol dire che la congiunzione di mythos e lògos (mythologìa, mythologeùo) corrispose
alla svalutazione di mythos come “parola efficace”, a vantaggio di logos» (Furio JESI,
Mito, A. Mondadori, Milano 1989, p. 20. Cfr. anche Hans BLUMENBERG,
Elaborazione del mito, Il Mulino, Bologna 1991). Sulla nuova valutazione
contemporanea del mito, nei suoi aspetti positivi e negativi, può essere utile
consultare gli interventi contenuti nei numeri speciali delle riviste «Aut-Aut» (Il mito
in questione - 1991, NS, n. 243-244) e «Paradigmi» (Il ritorno del mito nella società e nella
cultura del Novecento - 1995, XII, n. 39) dedicati alla Mythos-Debatte.
56
lÕgon, non certo in quello dell’¢podeˆknumi) a se medesima di sé
e dell’Altro.
La filosofia, che non cede più alla tentazione di abbandonare la
tensione verso la sapienza in cambio della sua trasformazione in
scienza assoluta, può tutto questo facendo suo il motivo dell’ascolto, che tra la Parola infinita e la parola umana abbiamo visto costituirsi quale arco silenzioso dove si genera la scintilla della verità. L’ascolto, che come medium tra il Dire infinito di una Parola originaria
e il dire responsabile – nel duplice senso, etico e linguistico – di una
parola umana articola la possibilità stessa della comunicazione, si
progetta come esperienza di verità. Sottratto alla affabulazione di un
dire guardia pretoria dell’attivismo della visione, l’ascolto recupera
tutta la sua valenza positiva. Esso non atterrisce più, perché è la ragione stessa che lo scopre luogo natale di ogni sapienza.
Nella custodia di ciò che è caro, che qui abbiamo cercato di
proporre come leitmotiv della ricerca filosofica, l’ascolto si scopre allora più che mero comportamento. Esso in verità costituisce l’atteggiamento unicamente adeguato nei confronti del meraviglioso,
del mistero, che origina la ricerca filosofica. Per questo aspetto esso
è matura e consapevole passività che riconosce lo scompiglio provocato dall’irrompere dell’alterità nell’ordinarietà del mondo ordinato. Un evento questo che obbliga a considerare la formale indecidibilità ovvero in-fondatezza della decisione della ragione umana,
e che per contro richiama la fondamentale evenienza della gratuità
(come non prescrittività, non-necessità) dell’appello che ci origina.
È questo il contesto narrativo delle prime ricerche mitopoietiche della cultura greca, ma è anche l’orizzonte di collocazione teorica delle prime indagini che innalzarono la filosofia al livello di raffinato esercizio del pensiero. Colui che ricerca la sapienza a questo
orizzonte deve di nuovo far riferimento, e con Parmenide disporsi
ad un atteggiamento di ascolto libero che sappia corrispondere ed
accogliere la rivelazione della verità che nel suo Poema la dea comunica. Siffatto atteggiamento ci interessa; esso predispone un itinerario che sembra in grado di meglio coltivare la dignità dello spazio,
oggi come sempre, reclamato dal pensiero.
57
CAPITOLO II
PARMENIDE E L’EPISTÈME
Nella tradizione della storiografia filosofica, il nome di Parmenide si associa spontaneamente al concetto dell’essere1. «Un uomo si
libera da tutte le rappresentazioni e opinioni, nega loro ogni verità,
e afferma che solo la necessità, l’essere, è il vero», dando così inizio
al «vero e proprio filosofare»: con queste sintetiche ed incisive parole Hegel riassume il contributo parmenideo allo sviluppo del vero
che è la filosofia2. Parmenide e l’essere, quindi, Parmenide e la fondazione dell’ontologia: in tal modo si è soliti rubricare il lascito del
filosofo di Elea. E se poi l’accordo degli studiosi sulla più generale
classificazione si infrange, come è normale, sulla differenza dell’esegesi specifica del concetto3, al di fuori di ogni discussione, come dato di fatto non bisognoso nella sua evidenza di ulteriore problema1 Ciò almeno a partire dal «risvegliarsi del pensiero storico» impostosi con l’età
del romanticismo. La dossografia greca ha invece letto l’opera di Parmenide sotto
l’influenza della questione platonica dell’uno e dei molti o sulla scorta degli interessi
sistematici di Aristotele. (Cfr. H.-G. GADAMER, I presocratici, op. cit.).
2 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Lezioni sulla storia della filosofia, La Nuova
Italia, Firenze 1930, vol. I, p. 279.
3 Letture differenti, e talora perfino divergenti, hanno presentato l’essere parmenideo di volta in volta come il fondo comune della realtà, autentico trascendentale
(è la tesi di Luigi RUGGIU [L’altro Parmenide in PARMENIDE, Poema sulla natura,
op. cit., p. 58]: «L’Essere parmenideo è il trascendentale, non il trascendente. L’Essere
perciò si pone come ciò in relazione al quale le cose esistono come quel determinato modo di essere di ciò che è non-nulla». - Ma su questa via si era mosso già Severino, la cui lettura è
più presente di quanto si ammetta. Alla discussione della posizione di Severino saranno dedicate le pagine finali di questo capitolo); o come essere veridico-predicativo (veridical) (cfr. Charles KAHN, Being in Parmenides and Plato, «La Parola del Passato», XLIII, 1988, pp. 237-261) o dal valore «veritativo» («si tratta di quell’uso, che
potrebbe essere definito metalinguistico, che permette al verbo essere di significare al
secondo grado la verità di una proposizione». Così interpreta Pièrre AUBENQUE,
Syntaxe et sémantique de l’être dans le Poème de Parménide, in Pièrre AUBENQUE (ed.),
Études sur Parménide, Vrin, Paris 1987, II: Problèmes d’interprétation, p. 112); come
la realtà nella sua immediatezza esistenziale (Nestor-Louis CORDERO, Les deux chemins de Parménide, Vrin-Ousia, Paris-Bruxelles 1984) o, al contrario, come «l’iposta-
59
tizzazione, resta comunque l’immediatezza del fondamento che
l’Eleate ha posto, il cuore del pensiero di questo filosofo, ovvero la
necessità dell’essere, la necessità che l’essere sia.
L’essere, dunque: questa è la parola che Parmenide osa proferire, in una maniera fino allora inaudita. L’essere, nella necessità insuperabile che lo governa e nella contrapposizione vittoriosa contro
quanto gli si oppone o resiste: ad una tale esplicita consapevolezza
non era infatti giunta né la sapienza poetica dei creatori della civiltà
greca4, né le riflessioni degli altri pensatori ionici ed italici5. In questa parola, che Parmenide riscatta dall’uso comune e carica di forza
semantica insuperabile, si esprime pertanto la scoperta e la conquista, mediata dal pensiero, della positività ed affidabilità della realtà
data e, per conseguenza, la possibilità di una adeguata conoscenza di
questa da parte dell’uomo.
«Infatti, nient’altro o è o sarà all’infuori dell’essere»6: sarà difficile
sfuggire a questa sentenza, dacché Parmenide ebbe l’ardire di pronunciarla. Siffatta affermazione, che consolida e conferma quella
tizzazione ontologica di quell’essere dell’affermazione […] quest’essere, che Parmenide trova nel pensiero, non può da lui essere riconosciuto che come oggettiva verità: ed ecco che di fronte allo stesso pensiero esso viene a costituirsi come qualcosa di
assoluto, che non può essere se non oggetto di affermazione (quell’affermazione che
esso stesso nella sua origine è!)» (Guido CALOGERO, op. cit., p. 20); come un programma metodologico proprio della ricerca scientifica (Giovanni CASERTANO, Parmenide, il metodo, la scienza e l’esperienza, Loffredo, Napoli 1978) per concludere infine con l’improbabile tesi di Antonio CAPIZZI (Introduzione a Parmenide, Laterza,
Roma-Bari 1975, p. 82), che ritiene che «l’opera speculativa del legislatore velino
fosse una specie di trattato di filosofia del diritto, una posizione di principi atti a giustificare il tipo di logica usata di fatto nella costituzione».
4 Secondo il noto giudizio di Erodoto (Storie, II, 53, 1), Omero ed Esiodo «sono
quelli che crearono per i Greci la storia della nascita dei loro dei».
5 Nei frammenti di Anassimandro ed Eraclito possiamo sentire una risonanza in
qualche modo particolare del verbo essere, senza che però quest’ultimo sia esplicitamente tematizzato. La discussione del frammento di Anassimandro verrà ripresa nel
capitolo successivo.
6 PARMENIDE, Poema sulla natura, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1991, fr.
8, 36-37. A questa edizione, ove non diversamente indicato, farò riferimento per le
citazioni del Poema di Parmenide, che verranno richiamate in nota con la sola indicazione del numero del frammento e dei versi. La numerazione dei frammenti è quella
stabilita dalla classica raccolta di Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, op. cit.
60
ancora aperta e non ancora pienamente decisa7 di fr. 2,3 «che è e
non può non essere»8, ha rappresentato infatti per l’Occidente la solida piattaforma del grandioso edificio della propria autocoscienza,
l’orizzonte intrascendibile della sua identità. In questo principio,
con una modalità potentemente esclusiva di ogni eventuale alterazione, si dà voce, fondamento e legittimazione alla stabilità del
campo metafisico supremo, in cui le cose, e l’uomo, giocano il proprio destino; e, nel contempo, se ne stabilisce la resistenza e irriducibilità ad ogni minaccia di annientamento, che l’avanzamento del
tempo o l’arbitrio della decisione possano mai opporre. A partire da
qui, validamente sostenuta dall’autorevolezza unanimemente riconosciuta al vecchio eleate, «venerando e insieme terribile» secondo
la nota descrizione che ne dà Platone nel Teeteto9, la filosofia ha poi
sviluppato la rassicurante garanzia della convenienza del proprio
programma di ricerca. L’evidenza dell’essere rimanendo al di là
d’ogni ragionevole questione, l’interesse teoretico si è pertanto volto ad argomentare le molteplici risonanze e a dar seguito in maniera
sistematica all’intuizione che lo ha indirizzato nel cammino.
Ma così facendo, la filosofia ha veramente seguito Parmenide?
Gli è stata veramente fedele? O non, piuttosto, mnhmosÚnh ha
generato lesmosÚnh, come racconta Esiodo10? Il ricordo di Parmenide non si è forse trasformato in oblio dell’esperienza fondamentale di Parmenide? La filosofia non ha lasciato cioè cadere la
questione posta da Parmenide, la questione imbarazzante della
possibilità del non essere? Non ha essa forse prestato a Parmenide
parte della propria convinta sicurezza? Queste domande risultano
decisive. A muoverle infatti non è tanto una esigenza di acribia filologica, quanto piuttosto la radicalità stessa della questione impo7
Più avanti verrà precisato il senso di questi aggettivi, che potrebbero suonare
come inadatti ad esprimere la necessità dell’essere con la quale si identifica il determinante contributo dell’Eleate.
8 È questa l’affermazione essenziale del Poema, dalla difficile interpretazione. Si
veda la nota di Giovanni REALE, Le esegesi del fr. 2 (già 4), in Eduard ZELLER - Giovanni REALE, La filosofia dei greci nel suo sviluppo storico, La Nuova Italia, Firenze
1967, vol. I. 3, pp. 184-190.
9 PLATONE, Teeteto, 183 e.
10 ESIODO, Teogonia, vv. 54-55.
61
sta dal filosofo di Elea. Come per Parmenide, l’impegno di dar ragione di sé e del mondo che lo circonda obbliga sempre nuovamente l’uomo a porsi di fronte alla questione dell’essere. Per questo nodo d’esistenza non sono date surroghe o l’esenzione di facili
scorciatoie; ciascuno deve saper compiere per sé il percorso di una
decisione essenziale. Perché se l’atteggiamento dell’uomo nei confronti del mondo che lo circonda è determinato dalla percezione
della consistenza e dalla fiducia che egli ritiene di poter prestare
alla stabilità delle cose – così potremmo precisare provvisoriamente il campo semantico aperto dal termine essere –, allora è evidente
che con intensità ancora maggiore risuona la questione della credibilità di quella percezione e fiducia; non si può insomma eludere od anche solo rinviare la domanda ontologica originaria. Non
possiamo perciò non ritornare sempre di nuovo a chiederci quale
sia stata l’esperienza iniziale che Parmenide ha raccontato nel suo
poema filosofico.
Si impone dunque, a maggior ragione, la necessità di recuperare lo sguardo di Parmenide nell’autenticità e libertà degli inizi. Per
questo stesso motivo, l’interrogazione del poema del filosofo di
Elea non può esaurirsi nella scontata ripetizione del suo principio,
l’essere, ma attende di lasciarsi condurre con l’intenzionalità teoretica che l’autentica filosofia sa suscitare, allorché si fa compagna
dello stupore sorgivo di un pensatore che «si stupisce del fatto che
l’essere è e non si può pensare che sia nulla»11. Insomma, quello
che ci viene richiesto dal tempo presente è di farci compagni di
strada di Parmenide sin dall’inizio del suo viaggio, di varcare con
lui «le porte dei sentieri della Notte e del Giorno»12, e non di accoglierlo compiaciuti dopo il suo solitario transito attraverso di
esse.
11 Karl
JASPERS, I grandi filosofi, Longanesi, Milano 1973. Jaspers parla di Parmenide nella III sezione dell’opera, significativamente intitolata I pensatori metafisici che
attingono l’origine (ivi, pp. 729-744).
12 Fr. 1, 11.
62
Il tradimento interpretativo
L’esperienza che ci attende perciò è quella di ritrovare i motivi
della fiducia nell’essere, avendone sperimentato tutta la problematicità ed infondatezza13. Il che, evidentemente, comporta una rinnovata capacità d’ascolto della parola del filosofo di Elea, del suo
màqoj prima ancora che del suo lÒgoj14. Dobbiamo perciò recuperare la libertà del pensiero al di là di ogni usata consuetudine, imporci una preliminare epoché della tradizione interpretativa, che appare come dislocata e quindi sostanzialmente eccentrica rispetto al
cuore della scoperta parmenidea. Ciò ovviamente non vuol significare che la filosofia abbia frainteso Parmenide, attribuendogli una
improbabile teoria dell’essere, sì invece che ne abbia tradito sostanzialmente l’intenzione teorica, col ripensare la scoperta parmenidea
a partire da una radicale ristrutturazione della problematica ontologica, incentrata ora sulla definizione dei caratteri essenziali posseduti dalle cose in cui l’essere si manifesta; col risultato inevitabile di allontanare così l’attenzione dal processo iniziale e fondante di affermazione del principio stesso, e di pretendere, per quella che era stata una ricerca di sapienza, lo statuto dell’epistème. Ma, come le pagine che seguono cercheranno di mostrare, la lotta con l’angelo che
Parmenide deve sostenere è quella per l’affidabilità della realtà contro
la minaccia della sua distruzione. Come ha giustamente osservato
Aubenque, quella di Parmenide è anzitutto una «affermazione
dell’essere, e non, come lo interpreterà affrettatamente la tradizione,
affermazione sull’essere o sull’ente. La tesi di Parmenide non è una
13 L’infondatezza
di cui parliamo è anzitutto il vago sentore di generale sprofondamento ed inutile insensatezza con cui il nichilismo ha investito l’esistenza contemporanea, quanto anche, e più ancora, l’impossibilità di una logica determinazione
della necessità esclusiva dell’essere. Proprio nella constatazione dell’insufficienza della strumentazione logica ai fini dell’affermazione dell’essere e nel radicamento di
quest’ultima nella manifestazione della Dea-Verità consiste il cuore della ricerca che
andiamo qui presentando.
14 Sulla differente ampiezza di significato dei due termini, che possono essere ricondotti entrambi al campo semantico della parola, si giocherà per buona parte la
presente lettura di Parmenide.
63
tesi sull’essere, ma è la tesi dell’essere, la posizione dell’essere»15. Parafrasando Wittgenstein, si potrebbe dire che gli interpreti ed i filosofi sono stati attratti dal come dell’essere, dalle modalità della sua
manifestazione, passando sotto silenzio, come cosa ovvia, il suo che,
il nudo e sconcertante fatto d’essere; laddove invece proprio qui sta
«il mistico», il cuore della rivelazione parmenidea16.
Osservando la ripresa platonica dell’ontologia si può trovare una
conferma ed anche una spiegazione della distorsione ermeneutica
sopra dichiarata. Un impercettibile ma decisivo spostamento dell’asse teoretico si produce allorché l’approccio ontologico, come
accade in Platone, avvicina l’essere dal lato dell’essenza. Platone trasforma infatti la questione dell’essere in quella dell’esser-così, del tÕ
ti Ãn eänai, della qualità essenziale (t…) che individua l’ente-che-è
nella sua identità originaria ed esclusiva, distinguendolo da ogni altro ente-che-è. Non più l’eänai, ma l’×ntwj ×n17. La domanda fondamentale allora cambia; non più “perché l’essere e non il nulla?”
ma: “quali qualità deve possedere l’essere-che-è per essere proprio
come è?”. In grado di suscitare meraviglia non è più che l’essere sia,
che cioè la totalità del reale sia dotata di una positività che la fa
emergere e resistere all’aggressione nientificante del nulla, ma che
questo essere-che-è si presenti come pluralizzato nell’apparente
anarchia della molteplicità differente degli ×nta; il cui aspetto conturbante nel caotico loro manifestarsi può venir rimosso solo mediante un deciso lavoro di riconduzione degli stessi alle specie essenziali che li determinano, prestando loro la qualità ontologica decisiva. Dove è chiaro che l’essere degli enti molteplici non è più ormai il fondamento che sbarra la strada al nulla e dà salda consistenza,
ma solo l’identità per sé (tÕ ×n kaq’aÙtÕ) di ciascun eôdoj. Parmenide ha tracciato la strada, sulla quale, confortato dalle risultanze
provenienti da Elea, Platone avanza per suo conto. La heideggeriana Seinsvergessenheit trova qui il suo punto d’avvio.
15
Pièrre AUBENQUE, op. cit., p. 110.
Cfr. Ludwig WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, Einaudi, Torino
1979, prop. 6.44.
17 PLATONE, Fedone, 99d ss.
16
64
Dominata dall’esigenza teoretica di attribuire un nome definitorio, e per questo definitivo, a quanto suscita curiosità ed interesse, la filosofia non ha più avuto, di lì in avanti, il coraggio di soggiornare nella biforcazione originante che separa l’essere dal nulla.
La messa in sicurezza della realtà, che il filosofo di Elea è riuscito a
compiere disinnescando la minaccia del nulla col ricacciare lontano e nascita e morte18, ha giocato come barriera protettiva e fascia
di sicurezza, dispensando dal porre ulteriormente la questione. Il
non-essere, il conturbante per eccellenza, può tranquillamente venir negato nella sua valenza metafisica e accolto invece sul piano
linguistico, mediante la sua riconversione nei termini positivamente pensabili dell’›teron19; e tutto questo, paradossalmente, restando entro la logica del comando parmenideo, che vietava di dire e pensare il non essere. Il mondo può presentarsi nuovamente
come ambiente accessibile e fidato; KÒsmoj ha vinto ancora su
C£oj. In realtà, ancora una volta la fedeltà al pensiero ha generato
il tradimento del pensiero stesso20. E così è preparata la via della
metamorfosi della filosofia da amore per la sapienza in epistème. Ne
abbiamo già parlato; qui perciò ci attende il compito di intendere
in pienezza il messaggio parmenideo.
A parziale giustificazione del necessario riposizionamento platonico della questione ontologica, va riconosciuto che la problematicità originaria dell’essere, intravista da Parmenide, tende facilmente a mimetizzarsi e nascondersi sotto le pieghe della sua incontestabile fattualità. L’essere è, non c’è dubbio; ne danno una
continua e sicura attestazione le cose del commercio quotidiano,
che sono in quanto è l’essere come loro fondo. Contestarne l’attualità è impossibile e contraddittorio è negarne la presenza; come
pure affermarla del non-essere. Dov’è dunque il problema? Posta
in questi termini, in effetti, la questione pare non sussistere. Non
18
Cfr. fr. 8, 27-28.
Cfr. PLATONE, Sofista, 256b ss.
20 Sulla dialettica essenziale di fedeltà e tradimento, fedeltà nel tradimento e tradimento richiesto dall’esigenza di mantenersi fedele, ha svolto osservazioni interessanti
Klaus Heinrich nel lavoro citato.
19
65
se, ma come l’essere è: questo sembra interpellare la coscienza filosofica. Perché, che sia, è dato di fatto indubitabile.
Avvicinata la questione ontologica in questo modo, sarebbe
tuttavia difficile spiegare la centralità teoretica universalmente riconosciuta a Parmenide; perché se, ponendo la questione dell’essere, il suo contributo è stato quello di segnalare, attingendo “economicamente” al risparmio concettuale offerto da un termine generale, l’evidenza empirica del darsi delle cose – che, come risulta
ad ognuno, sono di fronte ed intorno a noi, che siamo con non
minore certezza – allora saremmo senz’altro debitori a Parmenide,
ma solamente dello strumento linguistico di generalizzazione di
un’esperienza usuale, e non invece della fondazione del modo di
porsi greco e poi occidentale nei confronti del mondo. Così come, se il suo compito è stato quello di sottolineare la forza tautologica racchiusa nel giudizio sull’essere, che cioè all’essere come
soggetto conviene solamente l’essere come predicato (è e non è
possibile che non sia); in tal caso qualificante sarebbe la definizione
logica della condizione posta al pensiero per pensare alcunché: che
le cose, essendo, siano21. In entrambi i casi, Parmenide avrebbe
(platonicamente) rammemorato ciò che non si dà altrimenti, e
non solo per la Weltanschauung occidentale. La forza potente del
pensiero di Parmenide non si lascia però rinchiudere entro confini
così angusti. L’esperienza originaria che egli ci comunica, la fiducia positiva nella stabilità delle cose oltre le loro doxastiche manifestazioni, ritorna inesorabile ad interpellare l’uomo interrogante,
anche laddove l’apparato della necessità sembra rendere scontata la
risposta. Anzi, è proprio la coscienza della costituzione di quest’apparato a spingere sempre di nuovo perché la domanda onto-
21 Sarebbe allora difficilmente contestabile il rimprovero di Calogero, che
Parmenide, con la sua ipostatizzazione dell’è del linguaggio, «resta il massimo
eroe ellenico della verità parlata: il più potente traduttore di contingenze
linguistiche in presunte situazioni e problemi di realtà». E così conclude: «La
storia della logica occidentale è in questo senso la storia degli sforzi, con cui il
pensiero lentamente si affranca dalla servitù parmenidea» (Guido CALOGERO,
Parmenide e la genesi della logica classica, in Annali della Scuola Normale Superiore di
Pisa, S. II, 1936, p. 185).
66
logica ottenga una risposta che non chiuda definitivamente la questione. La filosofia insomma deve continuare la sua ricerca.
Non è perciò un caso che alla razionalità apodittica, vale a dire
alla conoscenza incontrovertibile di una filosofia costituitasi in
scienza e scienza assoluta in virtù della scoperta della potenza decisiva del lÒgoj di vincolare le cose alla necessità della loro relazione, la riduzione minimalista della problematica parmenidea sopra
accennata non possa bastare. Nel primo caso, la contingenza e casualità dell’esperienza rendono insicuri ogni progettazione e controllo razionale dell’esistente, lasciato libero ed in balìa del capriccio dell’istante e della determinatezza della circostanza, peraltro
sempre nuova. Nel secondo caso, il tratto soggettivistico e velatamente idealistico, che proietta le condizioni di pensabilità interne
alla struttura del lÒgoj sull’intero dell’essere, denuncia una inaccettabile ipertrofia del soggetto conoscente, illusoriamente autonominatosi soggetto assoluto. Nella morsa di un nominalismo
scetticheggiante, ed in definitiva nichilistico, ed un idealismo megalomane, la filosofia rimarrebbe facilmente stritolata e dovrebbe
da ultimo confessare la propria sconfitta teoretica. Per opporsi a
questo destino essa deve pertanto incardinare la logica del pensiero
alla necessità dell’essere; deve in altre parole scoprire l’essere nel
suo darsi necessario in quanto sostenuto da un potente nomos, di
cui la ragione comprende il linguaggio e le regole22; soltanto in
questo modo il pensiero dell’essere nella sua intrinseca necessità
può rivendicare a sé il dominio razionale, conoscitivo ed anche
pratico, della totalità delle cose. L’essere perciò interessa in quanto
è fondamento di necessità; anzitutto della necessità di sé. Solo così, infatti, la problematicità inesauribile dell’essere risulta negata
dalla conquista della sua necessità ed inevitabilità.
22 Di questa suprema condizione è ben consapevole un filosofo come Hegel. La
dialettica che egli presenta non è una dialettica del pensare quanto dell’essere, o meglio è dialettica del pensiero in quanto è dialettica dell’essere. «Il singolo deve ripercorrere i gradi di formazione dello spirito universale, anche secondo il contenuto,
ma come figure dallo spirito già deposte, come gradi di una via già tracciata e spianata» (G. W. F. HEGEL, Fenomenologia, op. cit., I, p. 22). Solo che poi diventa difficile
sottrarsi alla tentazione di una sorta di delirio di onniscienza.
67
La necessità dell’essere
Ma su cosa si fonda la necessità dell’essere? Questo ora è il nuovo terreno di discussione. L’epistème non può sfuggire a questa
domanda, in quanto ne va della sua stessa natura. Perché se il fondamento, il punto archimedeo dell’intero discorso risulta esso stesso infondato o ancora da fondare, il regressus in infinitum è inevitabile e presuntuosa si rivela la pretesa di quella filosofia di valere
come deposito sicuro della verità dell’essere. Il filosofo si troverebbe così nella stessa condizione di quell’indiano citato da Locke,
il quale giurava che il mondo fosse sorretto da un grande elefante,
ed alla richiesta «su che cosa poggiava l’elefante, rispose, su una
grande tartaruga; ma quando gli si chiese che cosa sostenesse questa tartaruga dalla schiena così ampia, rispose: qualcosa che non sapeva cosa fosse». Il filosofo inglese può perciò ironizzare che così parlano i bambini, «i quali, quando gli si chiede che cos’è una tal cosa
e non lo sanno, facilmente danno la risposta soddisfacente che è
qualcosa; il che, in verità, non significa altro, quando è così detto
da bambini o da adulti, che non sanno di che si tratta»23. L’ironia
lockeana è cruda; né sarà di certo la constatazione del tratto eccessivamente fisicista proprio di una metafisica semplificata, quale
quella che Locke sembra assumere, a consentire un facile scavalcamento della questione.
Allo stesso fallimentare risultato si giunge però anche se non è
la necessità, che il pensiero sa esprimere e da cui è governato, a
valere come regola per l’oggetto verso cui la filosofia dirige ogni
sua attenzione, quella necessità che dà legittimità al procedere filosofico verso la verità. Il principio che lega le cose nei vincoli di
una potente necessità richiede di essere riconosciuto nella sua non
contingente fondatezza. La dichiarazione aristotelica che è proprio
solo degli sciocchi pretendere la dimostrazione della necessità di
ogni cosa non riesce a distogliere l’attenzione dal problema, che
23 John
68
LOCKE, Saggio sull’intelletto umano, UTET, Torino 1971, pp. 350-351.
permane così in tutta la sua pregnanza24. Il fatto è che dopo aver
affidato il peso dell’argomentazione conoscitiva alla definizione
del legame inscindibile che lega una serie causale al suo principio,
24 «Infatti, è ignoranza il non conoscere (m¾ gignèskein) di quali cose si debba
ricercare una dimostrazione e di quali, invece, non si debba ricercare» (ARISTOTE LE, Metafisica, G, 4, 1006 a 6-8. Mi discosto parzialmente dalla traduzione di Reale,
dalla quale sono tratte le citazioni). Il primo e più sicuro di tutti i principi (¹ bebaiot£th ¢rc¾), infatti, non ha bisogno di dimostrazione. La necessità del principio si
offre pertanto in maniera diretta ed immediata (Óti mn oân bebaiot£th ¹ toiaÚth
pasîn ¢rc¾, dÁlon. [1005b, 17-18]) La difficoltà tuttavia permane, nascosta nella
giustificazione addotta, che non riesce ad evitare l’ulteriore decisiva questione. Spiega infatti Aristotele: «in generale, è impossibile che ci sia dimostrazione di tutto: in
tal caso si procederebbe all’infinito, e in questo modo, per conseguenza, non ci sarebbe affatto dimostrazione» (1006 a 8-9. [Corsivo mio]). Né quindi, aristotelicamente,
™pist»mh.
Ecco, appunto, questo è il nodo: il bisogno di dimostrazione e la sua necessità.
Perché, per assicurare la stabilità del principio che governa la ricerca epistemica, non
è certo sufficiente osservare che, a pretendere una conoscenza onnidimostrativa, si
corre il grave rischio di rendere impossibile del tutto la dimostrazione – nella quale,
si tenga presente, risiede, per Aristotele ed in generale per ogni forma di epistème, l’autentico paradigma conoscitivo –; ciò non basta, se prima non si è adeguatamente
chiarita la ragione della necessità e della irrinunciabilità della conoscenza dimostrativa stessa. Il ricorso a tale procedura non è in effetti cosa assodata, allorché si sia riconosciuta la naturale tendenza dell’uomo al sapere. Che l’uomo sia fatto per conoscere, come osserva anche Dante («fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir
virtute e canoscenza» – Inferno, XXVI, 119-120) è qualcosa che non può essere messo in discussione; ma che questa sua alta destinazione possa valere anche come intrinseca validazione della procedura di autofondazione della conoscenza umana, è tutt’altra questione. Non ci si può allora accontentare di dedurre dal bisogno di principi, preteso dalla conoscenza, il diritto di questi stessi a valere come tali; la quaestio iuris
avanza richieste differenti ed eccedenti la quaestio facti, come Kant bene insegna. Cosa autorizzi l’uomo a ritenere giustificato il fondamento di una procedura per il fatto
che in assenza di tal fondamento non si darebbe la procedura stessa, non è più così
chiaro come per Aristotele, quando la fiducia nelle meravigliose capacità del lÒgoj
di dominare raggruppando (è questo il significato originario di lÒgoj, la raccolta) il
disordinato venire incontro degli enti rendeva manifesta ed indubitabile la vitalità
del lÒgoj medesimo, permettendo così l’inferenza dall’esattezza dei risultati alla fondatezza del principio che li rende possibili. La cosiddetta “crisi dei fondamenti” ha reso
improbabile ogni ricorso all’evidenza ed insicura ogni immediata certezza di sé da
chiunque rivendicata. E comunque, non può senz’altro essere la minaccia che altrimenti l’uomo non raggiungerebbe mai la conoscenza sicura della scienza a proteggere
l’affidabilità del principio. Solo un fattore esterno al circolo potrebbe evitare la caduta
nella petizione di principio. L’irrazionalismo e lo scetticismo non si vincono insomma
con la volontà di conoscere ed una semplice scrollata di capo.
69
si rimane senza fiato e come in preda a grave imbarazzo e a sensazione di vertigine davanti alla scoperta della mancanza di copertura logica che involge il principio stesso; sicché la ragione non può
evitare di tendere al principio non ipotetico, all’incondizionato
che sostiene la serie delle condizioni. È il problema di Kant, che
però si trova così di fronte all’abisso della ragione25. Lasciare aperto, infatti, l’inizio dell’argomentare rigidamente governato da
¢n£gkh, sottrarre ai vincoli del lÒgoj quanto sorregge l’intera
costruzione della scienza, rende fallibile ed incerto tutto l’edificio.
A fondare la casa sulla sabbia, si pagano poi le conseguenze; come
accade in occasione di improvvisi cedimenti del terreno, l’intera
costruzione, se pur evita il crollo, non è più utilizzabile, perché
del tutto squilibrata, disassata ed in definitiva insicura e non più
abitabile. Occorre dunque rinsaldare il fondamento, mostrandone
la necessità che lo sostiene.
Non è un caso, allora, se è Hegel, ancora una volta lui, ad accettare di portare la sfida speculativa della ragione epistemica fino al
suo più puro vertice, ottenendo la sicura e definitiva garanzia della
solidità dell’edificio costruito dal logos filosofico. Adottando la forma autoportante della costruzione anulare, dove l’inizio, coincidendo con la fine, viene da questa giustificato e reso stabile nella sua
inizialità, egli giunge – con un vertiginoso giro di sillogismi dialetIl fatto è che l’esigenza di conoscenza non deve trasformarsi in libido sciendi.
Del resto, per lo stesso Dante, conoscenza deve integrarsi con quel virtute che la precede, almeno metricamente se non anche ontologicamente. La questione essenziale è
allora quella di individuare l’orizzonte entro cui le regole d’ingaggio della conoscenza scientifica hanno validità. La riduzione a livelli formali di gnoseologia minor delle
forme di ragionamento alternative al lÒgoj ¢pofantikÕj, cioè alla proposizione
che afferma o nega, stabilita da Aristotele in Dell’espressione, 4, 17a, 2-6, potrebbe
perciò non essere per nulla così pacifica. Potrebbero infatti darsi altre forme di relazione al mondo che consentano un approccio altrettanto e più originario alla verità;
penso all’arte, alla letteratura, ad una filosofia affidata alle forme di una razionalità
non apodittico-epistemica ma sapienziale, esperienze tutte che non mutuano dalla
struttura della propria norma, ma dall’ascolto dell’altro e dallo scandaglio dell’essere
la significatività della propria lettura.
25 «La necessità incondizionata, di cui abbiamo bisogno in maniera così indispensabile, come dell’ultimo sostegno di tutte le cose, è il vero baratro (der wahre
Abgrund) della ragione umana» (I. KANT, Critica della ragion pura, op. cit., vol. II,
p. 481).
70
tici, un sillogismo di sillogismi nei quali ognuno dei tre momenti
che ne compongono la struttura, l’Idea, la Natura e lo Spirito, risulta insieme mediato ed immediato, di volta in volta fondato dagli altri due e fondante gli stessi – alla medesima conclusione aristotelica,
sancita dalla citazione del XII libro della Metafisica con cui si chiude
l’Enciclopedia delle scienze filosofiche26. E così «l’idea, eterna in sé e per
sé, si attua, si produce e gode sé stessa eternamente come spirito assoluto».
Ci dev’essere pertanto un fondamento, e questo non può essere
diverso dalla necessità. E tuttavia, nonostante la poderosa costruzione dialettica di Hegel, la questione è ancora lungi dall’essere chiusa
e acquietata. Gli sforzi del filosofo tedesco si sono rivelati infruttuosi e non hanno conseguito lo scopo previsto; l’arbitrarietà del punto
d’avvio non è stata eliminata e la pretesa idealistica ci appare insopportabilmente insolente. Troppo divino per essere anche vero –
esclamano in coro i filosofi dell’Ottocento. Umano, troppo umano
– gli fanno eco i loro successori del Novecento. Lungi dal conquistare un incrollabile consolidamento, il luogo di origine del nostro
esserci è tornato problematico. La Grundfrage sopra ricordata ne è
eloquente testimonianza.
La domanda perciò si ripresenta con intensità ed urgenza non
risolta: cosa stabilisce la primazia dell’essere? Dove ricercarne il fondamento? In che modo e fin dove l’essere può garantire la saldezza
della propria presenza insieme alla opportuna e ricercata negazione
del non-essere? Esso è certamente affidato alla necessità. Ma chi o
cosa garantisce per essa? l’essere stesso? o qualcosa d’altro (d’Altri)27?
Verso tali interrogativi è nuovamente sospinta la filosofia contemporanea, che proprio per questo può trovare nel filosofo di Elea un
interlocutore quanto mai interessante, come peraltro hanno saputo
ben vedere le più convincenti letture del poema parmenideo.
In effetti, l’indagine critica, almeno a partire dal citato libro di
Reinhardt, è stata condotta sempre più a riconoscere la massa po26
G.W.F. HEGEL, Enciclopedia, op. cit., §§ 575-577, pp. 528-529.
Con Lévinas possiamo distinguere l’altro in astratto dall’Altro assoluto, «altro
altrimenti, altro di un’alterità che precede l’alterità d’altri» (Emmanuel LÈVINAS,
Dio, la morte e il tempo, Jaca Book, Milano 1996, p. 296).
27
71
tente delle catene della necessità, da cui Dike28 non consente che
l’essere possa mai venire sciolto. Le due vie di ricerca, che la Dea
sottopone all’attenzione di Parmenide, si contrappongono in una
sorta di «incompatibilità modale», che pone essere e non essere in
rapporto di «disgiunzione esclusiva»29. La verità autentica dell’essere
non ammette alcuna confusione con le dÒxai brotîn, le errate
convinzioni di mortali, «uomini a due teste» dai quali «essere e
non-essere sono considerati la medesima cosa e non la medesima
cosa»30. Nel Poema di Parmenide così ci si presenta la «stabile struttura logica» di un «sillogismo disgiuntivo»31; come riassume lo stesso
filosofo di Elea, «la decisione intorno a tali cose sta in questo: “è” o
“non è”»32. L’essere, dunque, è nella sua necessità e non tollera comunanza alcuna con il non-essere. Questo punto fermo della critica
parmenidea rimane perciò senz’altro saldamente attestato come
punto di definitivo non ritorno. Pur tuttavia esso in qualche misura
lascia aperta ancora la questione, nella misura in cui, almeno, non è
in grado di spiegare se stesso, di spiegare cioè le ragioni per cui
28 Come
ha messo molto bene in evidenza Ruggiu, nel suo commento al Poema
parmenideo, la Dea di Parmenide si presenta come una «unica Grande Dea con una
pluralità di nomi, cioè di funzioni e di aspetti, nei quali si esprime la potenza immutata della Dea che rimane identica pur nel mutare dei suoi aspetti». In particolare, «la
normatività di Dike si identifica con il destino dell’Essere, Moira, e insieme la normatività è potente e quindi Ananke, e l’Ananke in quanto giusta, è Dike» (Luigi
RUGGIU, Commentario filosofico al Poema di Parmenide “Sulla Natura” in PARMENIDE. Poema sulla natura, op. cit., p. 182 e p. 186). – Il riferimento è ai vv. 14-15 del
frammento 8 del Poema di Parmenide.
29 Denis O’BRIEN, Introduction à la lecture de Parménide: les deux voies de l’être et du
non-être. Essai critique, in P. AUBENQUE (ed.), Études sur Parménide, op. cit., I, p. 141.
30 Fr. 6, 8.
31 Jaap MANSFELD, Die Offenbarung des Parmenides und die menschliche Welt, van
Gorcum, Assen 1964. Mansfeld ritiene che la conclusione necessaria del sillogismo
disgiuntivo nel Poema parmenideo rimanga implicita e sia perciò da portare ad evidenza. «Fr. 2, conclusione restaurata e fr. 3 formano in questa maniera un procedimento dimostrativo logico in sé concluso, che, sulla base di determinate premesse e
con l’ausilio delle regole della disgiunzione e dell’implicazione, prova in maniera
estremamente rigorosa che l’essente è in senso assoluto» (p. 83). Il passaggio da fr. 2,7
.
a fr. 3 viene così congetturato: oÜte fr£saij <moànon tÒ t/™Õn tèj ™sti noÁsai
.
/ ºdš lšgein> tÕ g¦r aÙtÕ ktl. (ivi, p. 82).
32 Fr. 8, 15-16.
72
l’opposizione contraddittoria dell’essere al non-essere debba venire
risolta in favore del primo.
Nella gran parte delle esegesi, in effetti, la presa di posizione a
favore dell’asserto ontologico resta sostanzialmente estrinseca all’argomentazione stessa, quasi presupposta33. Il tema cruciale della
kr…sij, grazie alla quale Parmenide può argomentare a favore dell’essere e contro il non-essere, è svolto non al livello della decisione
originaria che dà luogo all’argomentazione ontologica, ma sul piano secondario delle sue conseguenze. La scena del dramma metafisico, in cui a Parmenide si rivela in tutta la sua abissalità l’opposizione estrema tra essere e nulla, è velocemente abbandonata e risolta
nell’affermazione dell’essere, di cui si scopre tutta la necessità. L’essere è sì accolto nella sua struttura originaria, ma non colto nel suo
emergere ed imporsi34. L’ottica platonica sottesa alla gran parte delle
interpretazioni fa qui velo; quell’ottica che, come abbiamo già detto, assume come risultato scontato, e perciò privo di possibili alternative, che l’essere sia. La problematica ontologica, così ridefinita,
conduce per conseguenza a spostare naturalmente il punto di osservazione dell’intera questione. La discussione si gioca perciò coerentemente sul piano puramente logico, della struttura implicita cioè
dell’argomentazione parmenidea, la cui superba concatenazione,
unitamente ai meccanismi di implicazione reciproca, dà solidità e
33 Lo si può chiaramente vedere nella seguente affermazione di Denis O’Brien:
«La dea, in effetti, non prende come punto di partenza del suo discorso l’enunciato
di un giudizio attributivo od esistenziale. Ella non ha per punto di partenza che le
due affermazioni, “è”, “non è”, insieme alla scelta che si impone dacché si coglie la loro
incompatibilità modale. […] Prive non solo di predicato, ma anche di soggetto, queste due “asserzioni” (“è”, “non è”) contengono piuttosto in germe, a meno che non
costituiscano già – in qualche modo in se stesse –, l’enunciazione di un concetto, che
si accetta: “l’essere”, o che si rifiuta: “il non-essere”» (D. O’BRIEN, op. cit., p. 230.
[Corsivo mio]).
34 J. MANSFELD (op. cit., p. 86) sottolinea a più riprese questo secondo aspetto
del problema. «La dottrina della verità è pertanto fondata sulla disgiunzione
(kr…sij), compiuta dalla dea ed insieme realizzata mediante il pensiero, di “È” e
“Non è” e sulla limitazione del pensiero, egualmente comandata dalla dea, ad un
termine della coppia di opposti contraddittori». L’interpretazione di Mansfeld offre
spunti interessanti di discussione, che ho tenuto presente nella lettura di Parmenide
che propongo. Ciononostante, a mio modo di vedere, egli tralascia di tirarne tutte le
innovative conseguenze.
73
forza apodittica ai due asserti costituenti l’argomentazione stessa, la
necessità dell’essere e l’impossibilità del non-essere. Non l’essere,
nel suo antagonistico affermarsi sul nulla, ma la duplice asserzione
che l’essere è e che il nulla non è, è quanto in questo modo si fa anzitutto incontro agli occhi dell’interprete. La struttura dell’affermazione distende sicura la sua legge, la necessità del lÒgoj che governa inflessibile l’oggetto verso cui si volge, per poi scoprire nell’essere la medesima norma dominante.
Ben oltre la fragilità del circolo imperfetto dell’ÛsteronprÒteron, qui risiede precisamente la fondamentale aporia dell’epistème, il punto in cui il tracciato della scienza metafisica si fa
letteralmente non più percorribile ed insicuro. Non basta infatti
mostrare la caratura logica della necessità, il suo ferreo dominio
sull’affermazione ontologica ed insieme sull’incompatibilità reciproca di essere e non-essere; occorre in più dimostrare l’impraticabilità di ogni scelta diversa da quella per l’essere, e quindi l’inevitabilità di quest’ultimo. L’attacco proditorio di Gorgia è sempre
in agguato: «nulla è». La minaccia che il terreno di consistenza
delle cose possa rivelarsi molto meno solido di quanto sia richiesto, non viene facilmente liquidata con l’osservazione della natura
puramente linguistica, antilogica, della ricerca sofistica. Per questo
non basta dire è; occorre altresì mostrare che ciò solo può venire
detto, in quanto solo l’essere è il vero. La filosofia, insomma, può
avere a che fare solo con l’essere: a questa conclusione rigorosa
deve giungere senza oscillazione alcuna il pensiero, perché solo
così l’intero edificio dell’epistème può ritenersi al sicuro da ogni
minaccia. L’essere respinge – deve respingere, questo è il suo nomos – via da sé il nulla, per potersi costituire come autentica
¢rc¾. Nessuna circostanza più avrà la capacità di interrompere la
costruzione o di rendere incerto l’edificio della scienza, dal momento che a dominare la scena e a rendere inevitabile la stessa
scelta a favore dell’essere è ’An£gkh, necessità. Il sentiero interrotto della filosofia potrà dunque venire riaperto e condurre finalmente al luogo ove la verità risiede sovrana.
74
Il ritorno a Parmenide di Severino
Chi ha cercato di compiere quest’ultimo e consequenziale passo
nella direzione indicata è senza dubbio Emanuele Severino. Il suo ritorno a Parmenide35, lungi dal valere come mero esercizio storiografico, rappresenta al contrario uno dei più interessanti tentativi di recupero dell’intuizione originaria del filosofo di Elea, volti a restaurare la
comprensione epistemica dell’essere dimenticata dall’alienazione nichilistica, che impregna di sé la metafisica occidentale36. Il suo pensiero
dà vita ad una costruzione teoretica coerentemente autoreferenziale,
nella quale la semplice posizione dell’essere rende contraddittoria, e
quindi sostanzialmente impossibile, ogni chiamata in causa del nonessere. La necessità dell’essere domina sovrana e chiude ogni ulteriore
prospettiva. È in Severino perciò che andrà misurata la capacità della
filosofia di mantenere la promessa di attingere la verità nella sua assolutezza, risplendente in tutta la pienezza al di là d’ogni ombra.
«L’essere è appunto ciò che si oppone al nulla, è appunto questo
opporsi. L’opposizione del positivo e del negativo è il grande tema
della metafisica»37. È in quest’unica essenziale affermazione che Severino trova condensata l’apertura archetipa della verità, quel «disvelamento originario e assoluto dell’essere – la verità dell’essere, appunto», capace di costituire la filosofia «come sapere assoluto e incontrovertibile». L’orizzonte dell’epistème38, come si può notare, qualifica
decisamente il tono della ricerca. Non è però qui, nella conclamata
35 Il saggio di Severino si intitola proprio Ritornare a Parmenide («Rivista di filosofia
neoscolastica», 1964, II. Ora in Emanuele SEVERINO, Essenza del nichilismo, Adelphi,
Milano 19822, pp. 19-61. A questa edizione, ove non diversamente indicato, faranno
riferimento le citazioni del filosofo italiano).
36 Di Emanuele SEVERINO si vedano anche La struttura originaria (Adelphi, Milano 19812) e Destino della necessità. Kat¦ tÕ creèn (Adelphi, Milano 1980).
37 E. SEVERINO, op. cit., p. 20.
38 Ivi, p. 41. In Destino della necessità Severino sembra invece considerare anche
l’epistème tra i prodotti deviati dell’alienazione originaria con cui la metafisica greca ha
pensato l’essere. «Il nichilismo è la persuasione che l’ente sia niente. Questa persuasione si esprime (e si nasconde) nel modo in cui l’™pist»mh apre il senso dell’ente». Ad
essa va opposta la verità dell’essere. «La verità è il dire con necessità la necessità del Tutto» (E. SEVERINO, Destino della necessità, op. cit., pp. 50 e 58). Questa correzione semantica non sposta l’asse della prospettiva teoretica severiniana, che resta comunque
centrato sul fattore della necessità dell’incontrovertibile.
75
contraddizione regnante tra essere e nulla o essere e non-essere39, che
va ricercata l’originalità della posizione di Severino, quanto piuttosto
nella messa in chiaro della struttura necessariamente opponente di
quest’opposizione, della condizione essenziale cioè per cui l’opposizione non può non essere posta e non può non essere a sua volta negata; sicché l’opposizione stessa, in virtù «dell’originarietà del logo»,
lungi dal conseguire come risultato la distruzione dell’essere, ne costituisce invece la necessaria affermazione. Severino riconosce che
qui è in gioco la pretesa assoluta della filosofia, la pretesa di questa di
valere come rifugio, custode della verità dalla sua caduta nella comprensione inautentica.
La «gran barbarie del pensiero», quell’«intorpidimento» che attutisce, come avviluppando in una rete, la forza della ragione filosofica, consiste infatti precisamente nel misconoscimento dell’incontraddittorietà dell’essere, che accade ogni qualvolta si pretenda di
fornire l’essere di una dimostrazione che lo assicuri nella sua necessità. La dimostrazione, infatti, avanza una sua pretesa di risolutività
solo laddove ciò che attende di essere dimostrato sia pensato appunto nella condizione di questa attesa, come un qualcosa di cui sia
sospetta la necessità e nascosta l’evidenza. Ma come si può pensare
di chiedere se l’essere è, si domanda Severino. Una domanda, per
esercitarsi correttamente, deve supporre la possibilità di una pluralità di risposte. Ora, è forse possibile assegnare all’essere il predicato
del non-essere? Dell’essere – dire che non è? Il positivo non è il negativo; al positivo non si può pertanto attribuire alcuna predicazione di negatività; allo stesso modo, dell’essere non si può predicare
alcuna negazione, ma solo l’affermazione: è. L’essere è quindi la necessità stessa di essere, è il rifiuto e la negazione di ogni identità col
nulla suo opposto, è la sua opposizione al nulla. «Alla verità dell’es-
39 Va notato che nel saggio in questione Severino non adotta una prassi linguistica univoca. L’opposto dell’essere è infatti definito una volta come «nulla», nel senso
sostantivato del puro negativo, vuoto d’essere, altre volte come «non-essere», negazione dell’essere, pendant logico dell’opposizione costitutiva dell’essere. In tale oscillazione si aprono però, come vedremo più avanti, delle cesure che rendono incerta
la costruzione del filosofo italiano.
76
sere appartiene l’opposizione dell’essere al nulla»40. Questa è l’evidenza stessa dell’essere, la sua verità originaria, che brilla di luce che
niente può oscurare; nella relazione al nulla infatti l’essere stesso
prende significato. Questo sapere originario ed immediato attende
ora solamente di venire correttamente pensato; se ne può dare ragione, non necessita di alcuna dimostrazione. «È, questo, il formidabile contributo dell’œlegcoj aristotelico», la cui forza consiste
«nel rilevamento che l’affermazione dell’opposizione, ossia l’opposizione, è il fondamento di ogni dire, e quindi, perfino, di quel dire
in cui consiste la negazione dell’opposizione»41. La prosa rarefatta,
che scava tra le pieghe di pochi essenziali termini, non impedisce di
cogliere la crucialità dello snodo teorico.
Il richiamo alla strategia della confutazione intende infatti preservare l’evidenza iniziale dell’essere da ogni incertezza. In ciò si
può trovare conferma della validità della ricostruzione teorica fin
qui seguita. Severino è consapevole che l’inizio non può essere
supposto o semplicemente dato, pena l’arbitrarietà dell’intero sviluppo teoretico; esso al contrario ha bisogno di giustificazione, il
che si ottiene rendendo sicura nella sua evidenza la necessità dell’inizio. Questa giustificazione però non deve essere ricercata facendo
ricorso al processo dimostrativo, che degraderebbe l’inizio dalla sua
posizione di assolutezza nei riguardi di ogni possibile dipendenza
eterologa, e lo consegnerebbe in definitiva nelle braccia di una nemesi archeogonica; da cui non potrebbe sfuggire, in ultima analisi,
se non ricacciando tutto il processo nell’orizzonte del màqoj, che
pone, affermando, l’inizio ed attribuisce ad altro che la necessità del
lÒgoj la forza persuasiva del racconto. Non dunque la ¢pÒdeixij,
inceppata nella sua stessa logica, ma l’œlegcoj è lo strumento cui
far ricorso per ottenere la conferma della stabilità dell’inizio.
La struttura formale dell’œlegcoj, che manifesta la sua forza sul
piano metafisico42, consiste, come è noto, nell’assicurazione di una
tesi mediante la confutazione dell’ipotesi antagonista. È un’afferma40
E. SEVERINO, op. cit., p. 37.
E. SEVERINO, op. cit., pp. 42 e 43.
42 Aristotele se ne serve per provare la impossibilità di negare il principio di non
contraddizione (Metafisica, G, 4).
41
77
zione di sé mediata dalla negazione della negazione; suppone la presenza di un interlocutore che neghi l’affermazione, per poter poi ricavare, dalla negazione dell’obiezione, la riconquistata certezza di
sé. Come tale, l’œlegcoj risulta privo del bisogno di fondazione
eterologa, avendo in se stesso la capacità di sostenersi. È una struttura autoportante, che non chiede altro che si affermi qualcosa; il
che, peraltro, è requisito indispensabile di ogni discorso. Come già
sapeva Aristotele, la negazione di qualcosa suppone, in effetti, la
preventiva affermazione della cosa da negare, che, in questo modo,
viene implicitamente riaffermata proprio ad opera dell’inconsapevole negazione. Certo, l’attestazione della validità dell’affermazione
non è originariamente dotata di forza logica intrinseca, che è conquistata, per così dire, solo di ritorno e come di rimbalzo. In quanto
tale, perciò, essa ha una configurazione dialettica nella misura in cui
riproduce la movenza di un pensiero (lÒgoj) che passa attraverso
(di¦) i due opposti; questi tuttavia sono legati tra di loro da una
condizione speculare, rispetto alla quale non sono liberi di porsi o
non porsi, ed alla quale dunque vincolano anche il pensiero.
Negando il rifiuto dell’opposizione, la negazione cioè che l’opposizione dell’essere e del nulla, la loro assoluta non-identità, sia il
dato originario, l’œlegcoj consente perciò a Severino di riaffermare questa stessa opposizione come ciò che ha valore. Chi muove infatti l’obiezione all’affermazione che l’essere non è il non-essere,
deve infatti anzitutto riconoscere che ciò su cui si esercita la negazione, ovvero la proposizione che l’essere non è non-essere, è.
Non, si badi bene, che la proposizione è vera, come verrebbe da
pensare, ma proprio che è, che è un fatto esistente come gli altri e
dunque un qualcosa che si erge come una palese conferma del primato necessario dell’essere, che quella obiezione vorrebbe invece
negare. Ecco come, agli occhi di Severino, la posizione dell’essere
come l’assolutamente opposto al nulla, «l’energia che spinge via il
nulla»43, trova incontrovertibile giustificazione. Solo l’essere rimane, come unica possibilità, saldamente assicurata nelle ferree maglie
della necessità che tutto domina. «La legge dell’essere è il destino
43 E.
SEVERINO, op. cit., p. 23. Anche in Destino della necessità si trova ribadita la
struttura opponente dell’essere al nulla: «L’“essere” (tÕ eänai, esse) è la condizione
78
del pensiero, che pertanto è sempre testimonianza di questa legge,
ossia l’afferma sempre, anche quando la ignora o la nega»44. Riaffermare questa indiscutibile verità, l’essere come inattaccabile nella sua
necessità e garanzia incontrovertibile della scienza della verità, è il
senso del suo ritornare a Parmenide.
L’affermazione appena citata dice tuttavia qualcosa di più. Essa
instaura una reciprocità idealistica tra essere e pensiero, in virtù della quale il pensiero finisce per farsi garante dello stesso essere. L’esperienza di vita non testimonia in effetti la necessità delle cose;
quest’ultima, semmai, è propriamente un’esigenza della razionalità
epistemica, che solo a condizione di una rigorosa determinazione
delle cose stesse può sperare di arrivare a dar soddisfazione alla volontà di conoscenza sistematica, da cui è segnata in profondità. La
logica della necessità, che regge il pensiero dell’epistème, tende perciò a proiettarsi fuori di sé verso l’essere, ad ordinare in legami invincibili l’essere, per ritrovarsi in esso e così ricevere la ricercata legittimazione del proprio tšloj conoscitivo. L’essere è dunque così,
perché il pensiero così lo pensa; siffatto pensiero, quindi, può rivendicare per sé il sigillo dell’incontrovertibile, ossia di epistème, e
far valere la propria logica, una logica affermativa, sulla questione
ontologica. Ciò che in tal modo, però, si fa avanti è solo la struttura
della legge della conoscenza scientifica, modellata lungo una sorta
di trascendentale che rigetta la cautela kantiana circa la conoscibilità
della cosa in sé45.
Non fa meraviglia, allora, che Severino ricostruisca il circolo logico, che, come abbiamo già potuto costatare, resta l’unica possibilità per evitare l’irruzione dell’arbitrio nella struttura della necessità
dell’epistème. Ad intenderla nella sua completezza, la tesi di Severino sostiene non solo che per negare (una proposizione) bisogna priche impedisce alla cosa di essere un niente» (p. 21 - Ma si faccia attenzione al differente uso terminologico: ora l’alternativa impossibile per la cosa è il ni-ente.)
44 E. SEVERINO, op. cit., p. 45.
45 È perciò pienamente coerente in Severino la critica dell’adozione, da parte
della moderna scienza della natura nel suo ipoteticismo e sperimentalismo, del paradigma falsificazionista, nel quale il nichilismo viene riconfermato nel momento stesso in cui siffatto paradigma rivendica di voler «liberarsi da ogni teoria incontrovertibile del tutto» (E. SEVERINO, Destino della necessità, op. cit., pp. 45-53).
79
ma affermare (la proposizione stessa), ma anche che per affermare
(una proposizione) bisogna negare (l’opposto della proposizione)46.
Si tratta di due passaggi, per quanto sviluppati separatamente, che
costituiscono l’insieme dell’argomentazione, sostenendosi reciprocamente. Venendo l’uno meno, cadrebbe anche l’altro. La negazione, sotto la forma dell’opposizione che nega ogni comunanza tra
essere e non-essere, costituisce quindi la struttura portante dell’affermazione dell’essere; la quale affermazione, a sua volta, viene stabilita nella sua incontrovertibilità proprio dalla negazione stessa che,
mentre pretende di negarla, in verità la suppone e la riconferma. Il
primo movimento avvia il circolo, il secondo lo conferma. Negando la differenza dell’essere dal nulla (l’ipotesi, cioè, che l’essere non
sia non-essere), si afferma in verità, grazie all’œlegcoj, proprio la
detta differenza (appunto: l’essere non è non-essere); la differenza
così ristabilita nega perciò l’identità con l’opposto (nega che l’essere
sia identico al non-essere) e riconferma quindi quell’identità con sé
(che l’essere è) che la prima negazione intendeva negare. Ancora
una volta, l’essere è essere e non è non-essere, come sostiene anche
Parmenide.
La confutazione come affermazione dell’incontrovertibile
Ma il disegno di Severino è con ciò veramente riuscito? Ha
conquistato egli veramente la roccaforte della necessità dell’essere,
quella posizione da cui, al riparo da ogni assalto, l’essere può sconfiggere l’assedio del suo nemico, il nulla? Cosa nega veramente
l’œlegcoj? Severino ha argomentato che, nella procedura confuta-
46 «L’accertamento del valore del primo principio – o, meglio, dell’opposizione
del positivo e del negativo (in cui l’opposizione non è contraddittoriamente concepita, come invece accade in tutte le formulazioni post-parmenidee dell’incontraddittorietà dell’essere, e quindi anche in quella aristotelica) - consiste, da un lato, nella
posizione della convenienza immediata del predicato al soggetto (per la quale la negazione è tolta, perché negazione di ciò che è per sé noto, affermato in base a se stesso), e, dall’altro lato, nell’œlegcoj» (E. SEVERINO, op. cit., p. 54).
80
tiva, il non della negazione si esercita su un contenuto47 proposizionale che deve essere comunque preventivamente affermato e riconosciuto. Nella negazione antitetica si nasconde dunque un contenuto positivo che non può essere eliminato. Tale schema, egli aggiunge, applicato alla proposizione fondamentale di Parmenide, dimostra in maniera incontrovertibile la necessità di affermare l’essere, e solo l’essere. Negando la validità dell’opposizione dell’essere al
non-essere, si riconferma proprio la validità di quest’opposizione.
Ciò che non può essere smentito, è incontrovertibile e dunque
vero.
Quest’ultimo passaggio applicativo, ora, non è così scontato come sembra. In virtù di esso, infatti, allo schema elenctico viene attribuita una funzione fondativa assoluta, che esso non possiede, o
meglio, che possiede solo relativamente ad orizzonti di significato
già costituiti. La confutazione, a ben vedere, può essere considerata
come determinazione generale delle condizioni di ammissibilità di
un ragionamento entro un orizzonte di significato stabilito, la definizione del perimetro di validità dei ragionamenti; dentro tale perimetro, essa dimostra l’impossibilità dell’adozione di argomentazioni
che rifiutino il principio costituente il perimetro stesso. Queste,
svolgendosi entro il campo semantico stabilito dal principio, inevitabilmente lo suppongono anche quando formalmente lo neghino.
Tale è il senso dell’¢pode‹xai ™legktikîj cui Aristotele ricorre sin dal Protreptico e poi, più ampiamente, nel capitolo 4 del libro
G della Metafisica. Chi nega la necessità della filosofia, si impegna di
fatto in una modalità di ricerca che è essa stessa già filosofica; infatti,
«cercando, filosofiamo, perché il cercare è la causa della filosofia»48.
Lo stesso per colui che voglia dedicarsi alla conoscenza scientifica,
caratterizzata dalla esatta determinazione dei termini del discorso;
egli non può evitare di ricorrere al principio di non contraddizione,
47
Costituito anzitutto dall’opposizione prototipica dell’essere contro il non-essere. Con grande maestria Severino riconduce infatti ogni forma particolare di confutazione al tipo universale dell’œlegcoj costituito dall’asserto che “l’essere non è
non-essere” (SEVERINO, op. cit., pp. 40 ss.).
48 ARISTOTELE, Protreptico, fr. 2 Ross (tr. it. a cura di E. BERTI, Il Tripode, Napoli 1994).
81
dal momento che la negazione di questo, rendendo possibile ogni
attribuzione di significato ai termini, produrrebbe una situazione di
incertezza comunicativa generalizzata rendendo di fatto impossibile
ogni discorso. «Infatti, non si può pensare nulla se non si pensa una
determinata cosa»49.
Così anche per il nostro discorso: l’œlegcoj di Severino mostra
solo che, nell’orizzonte dell’ontologia, non si può non riconoscere
che l’essere vale come principio primo necessario ed esclusivo. La
conclusione sarà pertanto che il non-essere non si può predicare
dell’essere e che l’essere non si può predicare del non-essere, regnando tra i due un’opposizione assoluta. Il che può andar bene a
Severino, interessato precisamente a mostrare l’impossibilità della
commistione e del passaggio tra i due; ma non fornisce ancora indicazione alcuna sulla necessità di accogliere l’essere come principio
incontrovertibile, sul suo primato ontologico; che era precisamente
la questione per la cui soluzione abbiamo cercato aiuto in Severino.
Se l’essere è, può senz’altro concedersi che il nostro pensiero lo
pensi come incontrovertibile; ma quella particella dubitativa iniziale, quel se da cui si avvia il ragionamento, limita immediatamente
l’energia della conclusione, sottraendo alla costruzione l’indispensabile necessità dell’inizio. Il problema sta infatti tutto nel capire come arriviamo a costituire l’orizzonte semantico, a partire da quale
centro. L’œlegcoj si muove già sempre dentro tale orizzonte; non
può costituirlo, in quanto lo suppone50. La verità dell’incontrovertibile deve ancora mostrare la necessità del suo fondamento.
49
ARISTOTELE, Metafisica, G 4, 1006 b 10.
Si faccia la prova, in via puramente teorica, di convertire la tesi di Severino,
l’essere si oppone al (non è il) non-essere, nell’affermazione inversa: il nulla si oppone
al (annulla il) non-nulla. Seguendo lo stesso percorso metodico, troveremo che la
confutazione risulta dotata della medesima forza logica, pur conducendo ad esiti opposti. La negazione dell’affermazione, negazione che dovrebbe fare nuovamente
spazio al non-nulla, cioè all’essere, non farebbe in verità altro che riconfermare la
prima affermazione, che il nulla annulla ogni opposto, cioè proprio l’essere, proponendosi quindi come principio irrefutabile. Come si può vedere, la questione non è
minimamente risolta; anzi, risulta vieppiù intricata. Il fatto è che il valore dell’œlegcoj è di natura esclusivamente logica.
50
82
Neanche la radicalizzazione dell’œlegcoj, che Severino con
grande capacità conduce alle sue estreme conseguenze, è tuttavia in
grado di far uscire dallo stallo del pensiero. Quel positivo in cui, in
ultima analisi, consiste anche la proposizione negativa (anche la negazione è – ha una sua determinata identità che la individua; essa significa pur qualcosa)51, quella positività alla quale Severino affida la
conferma finale della necessità incontrovertibile dell’essere, testimonia in verità solo della struttura positiva del pensiero. L’ente logico non può venire confuso con l’ente reale. Non è sufficiente osservare la datità (logica, per il pensiero e dentro il pensiero) di un
termine ovvero di una proposizione o di un ragionamento, per
concludere da tali entia rationis al primato universale dell’essere. La
necessità del logos non è la necessità dell’essere. A ben vedere, neanche Parmenide sostiene una teoria univoca o idealistica dell’essere,
che sola potrebbe giustificare l’immediata identificazione o il necessario trasferimento dei risultati dell’una all’altra sfera52. Il problema,
allora, non è quello di vedere come noi pensiamo, ma se l’essere si
afferma sul nulla e con quale necessità. La contraddizione logica
non equivale infatti all’impossibilità metafisica.
La curvatura ontologica della confutazione non sembra perciò
riuscita. Il fatto è che l’œlegcoj è una struttura formale di ragionamento, che esercita tutta la sua forza nell’esplicitare le condizioni
generali di pensabilità, che occorre rispettare, se si vuole affrontare
un ragionamento od anche solo comunicare un pensiero secondo le
modalità della conoscenza universale dell’epistème; ma che non autorizza affermazioni traspositive sulla costituzione del mondo reale
oggetto di pensiero. Ciò che esso dimostra logicamente è in definitiva la dipendenza logica della negazione rispetto all’affermazione,
da cui quella si origina. Il che risponde ad un’esigenza di gerarchizzazione degli strumenti logici, senza necessariamente coinvolgere
anche una questione di verità, vale a dire dalla corretta rappresenta51 Così
credo vada interpretato il seguente passaggio: «Negando che l’essere non
sia non-essere, si deve dunque pensare che l’essere, in cui consiste questa negazione, non
è non-essere (ossia non è tutto ciò che è altro da questa negazione)». (E. SEVERINO,
op. cit., pp. 42-3. [Corsivo mio]).
52 Cfr. L. RUGGIU, Commentario, op. cit., pp. 285-288.
83
zione concettuale dell’oggetto53. Severino dunque chiede troppo
all’œlegcoj, più di quanto esso possa concedere, sospingendolo
verso un profilo ontologico. Ma la questione dell’essere, che è la
questione della filosofia, non concede che ad essa si dia altra risposta
che non sia ontologica, giocata, vale a dire, sul piano della automanifestazione dell’essere stesso, senza far ricorso a elementi e principi
allotrii. È perciò alla concezione severiniana dell’essere che dobbiamo ora fissare la nostra attenzione.
Dire il nulla per dire l’essere
Siamo rimandati così al punto in cui avevamo incontrato Severino. L’essere è l’opposto del nulla, ciò che è si oppone a ciò che
non è: in questo modo, attraverso il richiamo ai vv. 1-2 del frammento 6 del poema parmenideo, Severino ha iniziato il suo viaggio, che vorrebbe condurlo all’essere nella sua ferma necessità. Rinviati all’attacco del ragionamento, scopriamo ora che la positio quaestionis introduce un fattore di ambiguità ineliminabile.
Severino sembra considerare sinonimi, e quindi intercambiabili,
il concetto del nulla e quello di non-essere. L’oscillazione terminologica, già notata in una nota precedente, è evidente in un passo come il seguente: «La verità originaria dell’essere è lo stesso senso originario dell’essere. Ma verità originaria dell’essere non è la semplice
53
È interessante notare come Aristotele nella presentazione del principio di
non-contraddizione (Metafisica, 1005b, 5-18), a proposito del quale sviluppa il suo
¢pode‹xai ™legktikîj, non dichiari che tale principio sia il più vero, ma solo «il
più sicuro» (bebaiot£th), «il più noto» (gnwrimwt£th), «non ipotetico» (¢nupÒqeton). Con ciò, Aristotele si assicura delle caratteristiche formali che deve possedere il
«primo di tutti i principi», perché possa valere universalmente e incondizionatamente. La questione di verità è svolta altrove. Del resto, preparando la dimostrazione per
via di confutazione del principio, Aristotele osserva opportunamente che «il punto
di partenza, in tutti questi casi, non consiste nell’esigere che l’avversario dica che
qualcosa o è, oppure che non è (egli, infatti, potrebbe subito obiettare che questo è
già un ammettere ciò che si vuol provare), ma che dica qualcosa che abbia un significato e per lui e per gli altri». (Ivi, 1006a, 18-21). Aristotele, insomma, non spinge la
dimostrazione al punto di dedurre da essa una qualche argomentazione di natura esistenziale, ma precisa solo che in ogni discorso è implicita l’accettazione delle regole
del discorso stesso.
84
opposizione dell’essere e del nulla, ma è l’opposizione dell’essere e
del non-essere, come unificazione di quella pluralità incontrollata
di formulazioni del ‘principio di non contraddizione’, che è già rigogliosa nei testi aristotelici. Unifica anche la formulazione ‘logica’
e quella ‘ontologica’ del principio. “L’essere non è non-essere” (“Il
positivo non è il negativo”) è infatti l’universale di cui le varie formulazioni del principio di non-contraddizione sono altrettante individuazioni»54. Il nulla qui esprime l’aspetto ontologico della più
generale negatività, che si manifesta radicalmente nel versante logico come non-essere; da quest’ultimo soltanto si dispiega senza impedimenti la forza dell’incontraddittorietà capace di stabilire l’essere
nella sua necessità.
Eppure le due opposizioni non sono per niente assimilabili, e
perciò non consentono lo scambio ontologico-logico che forma il
nerbo dell’argomentazione di Severino. Il non-essere non è il nulla.
Il primo nega soltanto il concetto di essere, il secondo ha valore di
principio metafisico; l’uno esercita un ruolo virtuale di rispecchiamento speculare dell’identità già data dell’essere, l’altro, come
enunciazione di una fondamentale instabilità delle cose, ha una sua
drammatica, perché destrutturante, positività, che nessuna logica
può riconciliare55. Le due relazioni pertanto non si equivalgono.
L’opposto dell’essere, se ne è realmente e non solo logicamente
l’opposto56, non può condividere con l’essere alcun contenuto; essendo qui in gioco l’opposizione radicale, ogni comunanza renderebbe imperfetta la radicalità dell’opposizione. Questo però non è il
caso del non-essere, che condivide con l’essere almeno quel contenuto di cui pretende di essere negazione: il non-essere è pur sempre
un esse. Come tale, il suo esser determinato (la sua necessaria deter-
54
E. SEVERINO, op. cit., p. 37.
essere utile in questa sede richiamare l’invito kantiano a non far confusione tra il nihil negativum irrepraesentabile della contraddizione logica ed il nihil privativum
repraesentabile della «repugnanza reale» (Immanuel KANT, Tentativo per introdurre nella
filosofia il concetto delle quantità negative, in Scritti precritici, Laterza, Roma-Bari 1982,
pp. 249-290).
56 Cfr. ARISTOTELE, Categorie, 10.
55 Può
85
minazione senza la quale, come ci ricorda Aristotele57, non si dà
propriamente vero discorso), è in verità privo di determinazione
propria, puro concetto infinito in cui rientra quanto sembra sfuggire alla presa dell’essere; al quale, però, per definizione, non sfugge
niente. Il non-essere, insomma, è solo l’opposto logico, il contraddittorio dell’essere; è per questa ragione che tra i due può scattare
«l’organismo apofantico» dell’œlegcoj. Il concetto di non-essere si
rivela perciò come un concetto vuoto che non è in grado di reggere l’esperienza del vacillare; concetto-fantoccio costruito appositamente per essere distrutto.
Non a caso, Severino non fa leva sull’affermazione dell’essere,
ma su quella dell’opposizione all’essere, del nulla dapprima, del
non-essere poi58. L’operazione, però, non si rivela priva di conseguenze. L’opposizione, cui è affidato l’incarico di rendere inattaccabile l’essere mostrando l’impossibilità logica dell’affermazione antagonista, quando venga chiamata a render ragione di sé nella sua
natura essenziale, rovescia l’apertura di credito, inizialmente conquistata, in un deficit di ontologico incolmabile. Avendo posto l’essere come l’opponente, come ciò che si pone-di-contro-a, la struttura relazionale di tale affermazione obbliga inesorabilmente a porre
insieme anche l’altro estremo opposto. Tra i due estremi si dà pertanto una coappartenenza originaria; all’essere, come opponente,
deve corrispondere qualcosa (il non-essere logico, il nulla metafisico) come opposto. E se il non-essere logico gioca bene il suo ruolo
57
Cfr. supra, n. 49.
Questa kl‹max è significativa. La semplice opposizione dell’essere al nulla
(l’essere non è il nulla) si rivelerebbe sì immediatamente (tautologicamente) vera,
negando l’attribuzione ad un soggetto di un predicato dalle caratteristiche essenziali
contrarie; ma, potendo in linea di principio essere rovesciata (il nulla non è, cioè annulla, l’essere), non sarebbe in grado di consolidare la direzionalità del movimento
negatore, che si esprime a partire dal soggetto, lasciando così la necessità dell’essere
priva di forza incontrovertibile. O meglio, potrebbe farlo facendo ricorso all’evidenza dell’essere. Ma, come sa anche Severino, il ricorso all’evidenza non appartiene
all’™pist»mh. È interessante, in proposito, notare che il vocabolo non-essere (con il
trattino che unifica in un solo sostantivo tanto la negazione quanto il termine negato) prende il posto del nulla, come opponente dell’essere, nel momento in cui Severino affronta proprio il problema della dimostrabilità dell’essere (Cfr. E. SEVERINO,
op. cit., pp. 32 ss.).
58
86
di rispecchiamento di identità, ma solo perché, come detto, costruito precisamente per rispecchiare quell’essere che esso necessariamente presuppone negandolo, nello spazio dell’ontologia invece il
nulla finisce per non poter più venire allontanato e scacciato via; è
rimesso continuamente in gioco dalla necessità dell’essere di definirsi per via di opposizione. Ogni sua negazione lo riconferma dunque come ineliminabile. Nell’essere ne va del nulla; senza il nulla,
l’essere non saprebbe dar ragione di sé, non arriverebbe a costituirsi,
non sarebbe. Per dire l’essere, occorre dire il nulla; per affermare la
necessità incontrovertibile dell’essere, occorre ammettere, per confutarla, la possibilità dell’annullamento dell’essere da parte del
non-essere59: questa la paradossale conclusione cui conduce lo sviluppo, richiesto dalla cosa stessa, del sistema di Severino.
Lo scacco dell’epistème
Possiamo qui mettere termine alla discussione della posizione di
Severino, senza seguirne ulteriormente gli sviluppi teorici; ciò che
ci condurrebbe lontano dal tracciato che ci siamo assegnati di percorrere. Ai fini della ricerca che stiamo conducendo, è invece opportuno a questo punto rendere consolidati alcuni punti fermi che
possono derivare da una prima valutazione retrospettiva dell’analisi
fin qui svolta; non senza peraltro aver prima riconosciuto la densità
della riflessione sviluppata da Severino in Ritornare a Parmenide e in
numerosi altri saggi, che fa senza dubbio del filosofo italiano uno
dei protagonisti del dibattito filosofico contemporaneo, dal quale
avremo ancora da apprendere.
La questione che aveva attirato la nostra attenzione, presentandosi come la più urgente ed insieme essenziale, come si ricorderà,
era quella racchiusa nel bisogno di riacquistare per la filosofia la freschezza e la profondità dell’interrogazione dei pensatori, che ne
59 Questo è il valore semantico della proposizione cui conclude l’œlegcoj di Severino, che dice che è impossibile negare che l’essere non è non-essere. La proposizione negativa dell’opposizione di essere e non-essere, infatti, se in quanto negativa
suppone la stessa opposizione che vuol negare, in quanto proposizione afferma precisamente la loro identità.
87
hanno suscitato la passione. In tale recupero la filosofia vuole cercare l’aggancio per una proposta che interrompa il progressivo esaurimento della spinta della tradizione metafisica occidentale e converta
in nuovo stimolo per il pensiero la passione originaria per la sapienza. Ciò richiede contestualmente di ripensare l’intero del processo
storico, attraverso il quale la pratica filosofica si è costituita, e valutarne l’assetto. Ci si è fatto allora innanzi che la filosofia si è mostrata incapace di raccogliere nella sua ampiezza la sfida ingaggiata da
Parmenide, il quale ha saputo salvaguardare l’essere nella sua libertà
assoluta senza venir meno alle esigenze di comprensione e di orientamento esistenziale che i mortali incessantemente avanzano. Rivendicando autonomia al di là di ogni dipendenza ontologica e
convinta di poter dominare l’essere stesso in virtù della forza potente del suo lÒgoj, la filosofia, ormai dichiaratasi scienza, ha inseguito invece il sogno immenso di riscattare la caducità imprevedibile
del reale, fissandolo nella sua necessità con lo sguardo immobilizzante della Gorgona; lungo questa via facendo in tal modo essa per
prima, per altro verso, esperienza dell’insostenibilità di tale sguardo,
che pietrificando avvia al declino. È lungo questa traiettoria che abbiamo incontrato Severino, che della necessità dell’incontrovertibile ha fatto il perno centrale della sua riflessione. Il merito di Severino sta così nel coraggio e nella capacità di portare fino in fondo la
posizione della necessità, non indietreggiando davanti a nessuna
conclusione, per quanto imprevista e inaudita, e rivendicando in
piena coerenza la cogenza del lÒgoj; con il che la filosofia viene
per così dire sospinta verso il punto di non ritorno del suo viaggio
verso il compimento dell’epistème.
Per questo motivo la scoperta della fragilità della costruzione
elaborata da Severino acquista un significato decisivo, tanto più rilevante quanto più elevato è il valore riconosciuto al rigore della
sua analisi. In effetti, lo scacco della posizione di Severino è in verità lo scacco della filosofia della necessità. Questo deve essere rimarcato con forza. La debolezza della posizione di Severino non sta
dunque in una qualche cesura, imputabile ad un errore del pensatore, che interrompa la catena logica del ragionamento; al contrario,
l’inflessibile struttura dell’epistème, che domina in ogni suo lato lo
88
svolgimento del pensiero, testimonia e garantisce al contempo della
coerenza del ragionamento. Gli interrogativi, che, in fin dei conti,
neanche Severino riesce a rendere inoffensivi e che aprono un incolmabile vuoto nella altrimenti perfetta chiusura del circolo, sono
pertanto da imputare ad altro. Non dunque personali carenze, ma la
fragilità d’impianto dell’epistème, del suo caratteristico tratto che affida alla perfezione dell’incastro logico, supportato dalla necessità
del ragionamento dimostrativo, la conferma della necessità del risultato – questo è quanto sta alla base del deficit teorico sopra individuato. Ciò che la razionalità epistemica non potrà mai ottenere
come risultato del proprio movimento logico e che, perciò, deve
assumere da altrove senza essere in grado di pretendere, non è infatti la necessità del ragionamento dimostrativo, ma la necessità del
porre l’inizio su cui la dimostrazione può fondarsi e così sostenere il
tutto.
La difficoltà insuperabile di condurre ad una soluzione definitiva
il problema della necessità dell’essere dipende pertanto dal limite
stesso dell’epistème. Questa ha forzato la mano all’intuizione originaria di Parmenide, ripensando nei termini della necessità del
lÒgoj quanto era in verità risultato del confidente accoglimento di
una comunicazione autorevole di verità. E l’essere, che ben oltre la
sua problematica apparenza si dispiegava man mano al giovane guidato dalle Eliadi, sotto la guida benigna della divinità, nell’aperta
manifestazione del fondo di stabilità che protegge le cose dal loro
scomparire nel nulla, viene invece ad acquisire i tratti del principio
anipotetico costituito in virtù della sua incontrovertibile necessità e
garantito contro ogni alternativa dalla forza interna della razionalità
dimostrativa.
Si comprende così facilmente l’inevitabilità, ma al tempo stesso,
l’improprietà del ricorso a Parmenide. Nel Poema sulla natura la filosofia ha ricercato la propria giustificazione, trovando nella conclusione del discorso parmenideo conferma dell’ontologia fondamentale positiva, che esprime la sua più profonda convinzione. In definitiva, la filosofia occidentale ha assunto un deciso tratto parmenideo, laddove essa lega l’interpretazione del reale alla presunzione od
anche alla necessità della stabilità di questo; e, come anche Parme89
nide, dichiara con sicurezza razionalmente insostenibile, perché
contraddittoria, ogni introduzione residuale del nulla. Il lungo
frammento 8 del Poema sulla natura conduce in effetti ad un ampio
giro panoramico intorno alla fortezza dell’essere, mostrandola inaccessibile ad ogni incursione di nemici esterni.
Ma, come il prossimo capitolo renderà chiaro, il ragionamento
parmenideo conclude all’affermazione esclusiva dell’essere, quell’affermazione che poi la filosofia assumerà come inizio indiscusso
della dimostrazione, solo dopo la presa di posizione originaria, razionalmente indecidibile, per l’essere stesso, che la dea invita a
compiere all’inizio della sua narrazione. Nell’esperienza di Parmenide, il nulla è l’alternativa reale, che non fa scattare alcuna contraddizione ma che chiama alla decisione; una decisione, certamente,
non irrazionale ovvero anche tale da generare un conflitto insuperabile con la ragione, ma senz’altro metarazionale, in qualche misura estranea alle disponibilità della ragione. Qui, in tale decisione radicale per l’essere, risiede il fondamento di ogni successivo sviluppo
teorico, che la razionalità dell’epistème si incaricherà poi compiutamente di consolidare.
Le letture parmenidee, con le quali lungo questo capitolo ci siamo confrontati, perciò, nel momento stesso che intendono rendere
espliciti e sviluppare i meccanismi logici che sovrintendono l’articolazione dell’essere nella sua necessità, senza però porre a tema i
motivi della fiducia nell’essere o il processo per il quale l’essere si
impone sul nulla, suppongono in verità ciò stesso che dovrebbero
provare; esse non sanno più pensare la possibilità minacciosa e reale
del nulla, non sono più capaci di fare l’esperienza del pensatore di
Elea, l’esperienza dell’attraversamento «della porta dei sentieri della
Notte e del Giorno»60, ed attendono, più comodamente, l’arrivo
del viaggiatore per ricavare dal suo racconto, come valore assolutamente saldo e privo di incertezza, lo schema metafisico generale.
La questione dell’essere, e la connessa questione della verità, che
ci si fanno incontro dai frammenti dal Poema parmenideo, impongono quindi un approccio ermeneutico rinnovato, meno viziato da
60
90
Fr. 1, 10.
ipoteche e assunti consolidati. Occorre pertanto lasciare la filosofia
sistematica della necessità alla sua pretesa di valere come epistème,
come conoscenza assoluta in grado di suscitare, con la sola forza del
lÒgoj che la governa, la presenza e la stabilità dell’essere delle cose,
e ricercare, percorrendo nuovamente insieme a Parmenide il cammino di introduzione alla verità, le tracce ed i segni del darsi gratuito dell’essere e dell’offerta con cui ci viene donato.
Questo del resto è uno snodo cruciale della riflessione contemporanea, reso tanto più impellente dalla constatazione del fallimento del paradigma della metafisica classica. La domanda che si
pone è allora, nuovamente, quella del significato da attribuire al
termine più usato del linguaggio. Che cosa è essere: se l’orizzonte
estremo dell’umana pensabilità, che richiede un riferimento oggettivo per tutto quanto essa sappia determinare e rendere presente nel pensiero, o ancora la totalità delle cose nella loro fattuale
semplice presenza, immediatamente data ai sensi, o invece il fondamento che dà stabilità alle cose che si danno (ci sono) e che noi
incontriamo nel mondo – laddove il mondo come tutto ci rimane
inaccessibile.
Il fatto è che non siamo noi, i mortali, ad affermare o negare,
dir di sì o di no all’essere, ma è l’essere stesso a ri-velarsi, a mostrarsi cioè nel suo mistero inesauribile nelle cose, cui offre una
stabilità non assoluta e tuttavia sufficiente a permettere l’orientamento dell’uomo nel mondo. Che poi il pensiero umano non
possa conseguire alcun sapere in grado di conferirgli fiducia nelle
sue decisioni di esistenza, se non si instaura l’epistème che aborre il
nulla, è un’altra questione. Ma non è una conclusione necessaria,
come vedremo.
91
CAPITOLO III
IL BIVIO DI PARMENIDE
Il lungo ed impegnativo confronto con la lettura di Severino – tra
le più interessanti dal punto di vista teoretico fra le proposte esegetiche della letteratura critica parmenidea –, per quanto ne abbia finalmente messo in luce la debolezza strutturale, consistente da ultimo
nell’inadeguatezza nell’interpellare e mettere a tema l’esperienza originaria del filosofo di Elea, non è stato insomma vano. Esso, se non
altro, ci ha insegnato che la questione con cui Parmenide ha osato
confrontarsi non accetta di essere rubricata facilmente sotto una delle
voci tanto care alla manualistica, con le quali spesso viene confusa ed
addomesticata quella che invece per il pensiero filosofico costituisce
un vero e proprio campo di agone, ovvero la ricerca della verità. L’ascolto di Parmenide venerando e terribile richiede un supplemento
di attenzione, insieme alla più convinta disponibilità a lasciarsi guidare dalla sua chiaroveggente parola.
Un corretto approccio ermeneutico deve infatti aver la forza di
suscitare nuovamente la passione della ricerca che ha spinto Parmenide al suo viaggio, senza pretendere di ritrovare in lui conferme di
nostre già acquisite convinzioni. Sovrapporre al suo il nostro pensiero, con le proprie caratteristiche movenze, si rivela esercizio in definitiva inutile e forse anche fuori luogo. Non dunque a questo rassicurante approdo ci interpella dalla sua lontananza il pensatore di
Elea, ma al più impegnativo ed essenziale compito di trovare un ancoraggio forte nell’incedere mutevole dell’esistenza. Come lui dovremo osare la via che conduce alle porte della verità, via faticosa – è
lontana dalle carreggiate navigate di una tecnica capace sì di dare soluzioni a problemi che essa stessa genera, ma distonica o addirittura
stizzita verso ogni tentativo di problematizzare il fine che, non sempre nascostamente, la orienta – ma al tempo stesso massimamente
eloquente per chi la sa riconoscere e percorrere; pronti a metterci in
gioco aprendo il nostro animo al desiderio di dar ragione a noi stessi
del nostro stesso esserci.
93
È opportuno allora dismettere l’usato abbigliamento concettuale della accademia filosofica, per indossare una veste meno gravata
dal corredo di stratificazioni accumulate da secoli di letture e interpretazioni1 e apprestarci a seguire nuovamente il filosofo nel suo
viaggio. Il sentiero che dovremo ancora una volta ripercorrere, accompagnati da Parmenide, è infatti ritornato per noi forse nuovamente inusuale; o meglio, il semplice immediato trovarsi già su di
esso e la lunga abitudine nel percorrerlo non ce ne fa più percepire
la esigente radicalità. L’assuefazione lo ha reso a noi, viaggiatori ormai massificati, come muto e innocuo. È come quando la vista del
panorama consueto ci impedisce di apprezzarne ancora di nuovo
tutta la bellezza, che non è persa, ma solo nascosta ai nostri occhi
smarriti nei dettagli delle cose; allo stesso modo, non certamente
l’essenzialità dell’interrogazione parmenidea, ma semmai la sua urgenza, la radicalità che essa contiene, appare ai nostri occhi, che
sanno cogliere solo superfici ed apprezzare solo immediatezze, superata2.
Tre questioni ci si fanno allora innanzi, questioni assolutamente
originarie, con le quali da sempre si è affaticato il pensiero dell’uomo e con le quali pur tuttavia sempre di nuovo siamo chiamati a
confrontarci. I pensatori della prima stagione filosofica, che ne hanno avvertito per primi l’importanza, le riassunsero nella questione
dell’¢rc¾, del principio originario. Esse sono quella relativa all’ori1 Va detto, per la verità, che la consapevolezza di una necessaria purificazione
del pensiero di Parmenide dagli strati lasciati dalle letture antiche e moderne del Poema ha costituito un punto fermo della ricerca filosofica e storiografica, a partire almeno dal citato lavoro di Reinhardt, che non a caso è considerato l’iniziatore della ricerca contemporanea. E tuttavia, a me sembra che la liberazione di Parmenide da
Platone si svolga nonostante tutto pur sempre sotto il segno, platonico, dell’ontologia dell’identità. Insomma, come dicevo in sede introduttiva, si attende Parmenide
dopo la sua scelta. Laddove quello che occorre è invece rifare la scelta.
2 «Per lo più e senza ponderazione, diamo alle parole ×n e eänai il significato di
ciò che nelle corrispondenti parole della nostra madrelingua – “ente” e “essere” – si
è venuto raccogliendo di inconsapevole e di impensato. Meglio ancora, non diamo
più alcun significato ai termini greci. Li assumiamo immediatamente, nell’intellezione approssimativa che l’intelligibilità abituale del nostro linguaggio ha conferito ad
essi. Alle parole greche non corrisponde altro che la conciliante negligenza del nostro fuggevole opinare» (Martin HEIDEGGER, Il detto di Anassimandro in Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze 1968, pp. 311-312).
94
gine e fondamento delle cose del mondo, alla presa di posizione di
fronte ad esse e alla modalità di manifestazione del loro senso. L’essere, la decisione, la verità: con questi tre cespiti teoretici avremo
perciò da confrontarci seguendo Parmenide.
1. Alle origini del pensare parmenideo: la questione dell’essere
La questione dell’essere, che ci si fa innanzi come prima, appartiene all’identità più intima e costituisce insieme il contributo più
originale della cultura occidentale. In quanto tale costituisce come
lo sfondo ultimo, ordinato ed ordinante, entro il quale prendono
corpo, ottengono definizione e ricevono valore gli oggetti e le relazioni che punteggiano il dispiegarsi mondano dell’esistenza umana.
Nel rimando all’essere deve pertanto riconoscersi la fondamentale
funzione di orientamento e governo del reale che, inquadrato nelle
strutture logiche della conoscenza, da insieme sparso di individualità per sé sussistenti assume la fisionomia più rassicurante di un cosmo regolato ed armonico.
L’essere, l’essere del mondo delle cose e delle altre persone e
quello mio che lo osserva, l’essere nella sua materialità concreta ma
anche nella sua impercettibile sostanza spirituale, rappresenta dunque per il pensiero filosofico, e poi anche per il comune sentire,
l’orizzonte normativo, non ulteriormente trascendibile, di ogni
possibilità di apprensione e di ulteriore conoscenza3; e se incerta e
contestata ne è apparsa la descrizione o la stessa identificazione o attribuzione, al di fuori di ogni ragionevole sospetto ne è affermata la
presenza determinante; che il linguaggio peraltro ulteriormente
sanziona con l’assegnazione alla voce verbale che la esprime di una
esclusiva duplice funzione sintattica, esistenziale e copulativa.
Il contributo di Parmenide alla costituzione di siffatta scena di
pensiero risulta senza dubbio decisivo. Una esplicita tematizzazione
3 Al punto che ad esso viene ricondotta perfino la comprensione del divino. È
tuttavia interessante che il pensiero della mistica, speculativa e non, abbia cercato di
uscire da questa categorizzazione ontologica del divino per liberarlo in tutta la sua
infinità. Si veda Meister ECKHART, I sermoni, Paoline, Milano 2002; Emmanuel
LÉVINAS, Totalità e infinito, Jaca Book, Milano 1980.
95
del concetto di essere, della sua natura ed estensione, appare per la
prima volta, all’alba della grandiosa stagione della sapienza greca,
proprio nello scritto del filosofo di Elea4; il cui nome, come dicevamo in precedenza, si associa spontaneamente alla meditazione sull’essere. E mentre le letture del Poema che tendono a minimizzarne
la portata ontologica, col fare di Parmenide un riformatore politico
o uno scienziato, non sembrano in grado di soddisfare pienamente
tutte le domande che l’ascolto di esso suscita5, l’affermazione che
l’essere è e che il nulla non è, affermazione che Parmenide ha avuto
4
Situazione frequente per i pensatori dell’antichità, anche nel caso di Parmenide
non abbiamo dati sufficientemente sicuri relativi alla sua biografia, a cominciare dalla
cronologia. Le difficoltà, individuate già da ZELLER (op. cit., pp. 165-169, n. 2), non
sono state risolte dagli studiosi successivi. La qual cosa fa propendere, come suggerisce Reale nel suo aggiornamento dell’opera di Zeller, per una datazione generica,
che assicura solo che «egli dovette vivere a cavaliere tra il VI e il V secolo» (ivi, p.
171). Alle integrazioni di Giovanni Reale al lavoro di Zeller, che vanno «ben oltre il
mero compito dell’ “aggiornamento”» (L. RUGGIU, L’altro Parmenide, op. cit., p.
21), va fatto necessario riferimento per un primo approccio alla storia delle interpretazioni parmenidee. Annotazioni senz’altro utili per la comprensione del testo, oltre
i lavori di Cordero, O’Brien e Ruggiu già citati (di RUGGIU va nominato anche il
volume Parmenide, Marsilio, Venezia, 1975), offre anche il commento di Leonardo
TARÀN (Parmenides. A Text with Translation, Commentary and Critical Essay, Princeton University Press, Princeton 1965).
5 È il caso già citato dell’interpretazione di Capizzi, che sembra aver qualche
emulo, come ad esempio Giovanni CASERTANO (op. cit., pp. 7-8), secondo il quale
«Parmenide non è il filosofo di un “essere trascendente”. Siamo profondamente
convinti che l’Eleata non inizi affatto l’era della “metafisica” greca o addirittura occidentale; al contrario crediamo che con Parmenide vengano sollevati per la prima
volta […] i problemi importantissimi del metodo e del linguaggio propri della ricerca
scientifica». Insiste sulla lettura del poema come di un testo a carattere scientifico anche Pietro EBNER, Parmenide medico OULIADHS, in P. EBNER, Velia e la Scuola di
Medicina, Centro di Promozione culturale per il Cilento, Acciaroli (SA) 1966, pp.
35-51. Che tra gli interessi del pensatore di Elea ci fossero anche temi oggi rubricati
come scientifici è tutt’altro che da escludere; cosa peraltro non rara in pensatori che
vivono nell’età in cui il tutto e non le parti costituisce problema - quelle parti su cui
oggi invece si estenua un disciplinarismo specialistico che assolutizza il frammento
nel quale trova la propria giustificazione; mentre non ha occhi per vederne la connessione con il resto della realtà. Ciò non autorizza tuttavia il farne il centro speculativo dell’intero Poema parmenideo. Più articolata è la posizione di Lambros COULOUBARITSIS (Les multiples chemins de Parménide, in Pierre AUBENQUE (ed.), Études sur
Parménide, op. cit., II, p. 41), che, in dialogo critico con la prospettiva di Heidegger e
Beaufret, parla della necessità di una «deontologizzazione dell’interpretazione del
96
la forza e la consapevolezza di pronunciare per primo, si staglia potentemente incisa come bussola ed insieme viatico del cammino di
pensiero dell’uomo greco e poi europeo.
Ciò nondimeno, ha tutta l’apparenza di una tautologia quella che
il pensatore di Elea consegna ai suoi successori. In effetti, una volta
affermato l’essere6, è assolutamente evidente e, di più, logicamente
necessario, collegare ad esso l’unica azione che vi conviene, vale a dire quella di essere. L’essere, infatti, per la massima generalità del suo
ambito concettuale, non tollera altri predicati7. Non un impensabile
(an-)nullare che, affermando comunque un’azione, la quale può darsi
solo come azione di qualcosa o su qualcosa, genererebbe una insanabile contraddizione rispetto all’azione medesima che intende proporre, producendo lo svuotamento di ogni contenuto che esso vorrebbe pur sempre comunicare. Non divenire, che pretende di tenere
in sé ferma la tensione tra affermare e negare, essere e “nullare”. In
ciò la lettura di Severino è ineccepibile e convincente, come abbiamo avuto già modo di provare8. Solo il verbo essere può così valere
come predicato nella frase che ha l’essere stesso come soggetto. Una
tautologia, dunque; della quale verrebbe quasi da dire che essa abbisogni solo di una continua ricapitolazione. Una tautologia, tuttavia,
Poema» a vantaggio di una lettura che nella «nuova pratica del mito (cioè del logos)
arcaico» coglie «l’istituzione dell’essere a partire dallo schema del cammino in vista di
fondare il pensiero» e garantire così la possibilità «di uno studio delle cose in divenire
portandole alla “presenza”, senza tuttavia mai ontologizzarle» (Lambros COULOUBARITSIS, Mythe et philosophie chez Parménide, Ousia, Bruxelles 19902, p. 8).
6 Si presti attenzione a questa condizione – che è proprio quanto Parmenide intende garantire – evitando di lasciarla diluire nella forza apparente del conseguente,
evocata proprio dalla condizione medesima; come hanno fatto numerosi interpreti, i
quali, fraintesa questa condizione iniziale, poi hanno battagliato nel cercare di spiegare il senso di un’affermazione per sé ovvia. L’essere è: questa non è la conclusione
di un ragionamento, ma proprio la premessa, a partire dalla quale solamente può
svolgersi ogni ragionamento.
7 Come dice Aristotele, è il termine più generale (tÒ Ôn ™sti kaqÒlou m£lista p£ntwn (Metafisica, B 4, 1001a, 21). Per conseguenza, il concetto di essere sarebbe indefinibile ed il suo significato ovvio. Dalla discussione di questi «pregiudizi»
prende avvio l’analitica esistenziale di Heidegger in Essere e Tempo (Longanesi, Milano 1976, pp. 18-19).
8 Ma già Calogero, e prima ancora Reinhardt, avevano notato la connessione
necessaria di soggetto e verbo.
97
che ha avuto la forza di segnare il cammino dell’Occidente. Per questa “semplice” scoperta Parmenide ha prenotato un posto che sicuramente non può essere cancellato nella storia del pensiero.
Poste le cose in questo modo si ottiene, però forse, solo di disperdere la forza della riflessione parmenidea nei rivoli di considerazioni, che col tempo hanno perso parte del loro mordente, lasciando evidenziare invece i motivi della loro debolezza; e di coltivare in
tal modo dolci illusioni di sicurezza, mentre un sommovimento
culturale di portata epocale sta spazzando via riferimenti finora validi. Non che l’affermazione dell’identità ontologica sia ritenuta in sé
non più valida e che sia lecito pensare impunemente la contraddizione. Solo che l’affermazione identitaria manifesta tutta la sua logica evidenza unicamente quando può riposare su una previa assicurazione della consistenza della sua posizione.
La posizione dell’essere: questo è ciò che merita anzitutto di essere garantito e che solo può garantire la forza dell’affermazione ontologica. Che è, però, precisamente ciò che oggi è divenuto nuovamente problematico. Forse solo oggi, sconquassati dalla dinamite
nietzscheana e minacciati dalla potenza infinita di una tecnica capace di sfuggire ad ogni controllo, abbiamo gli occhi per capire che
l’evenienza dell’essere è anche niente più che una eventualità; che
l’essere è offerto nella sua gratuità e che se esso allontana la minaccia
della nullificazione, ciò avviene nel corso di una lotta dagli esiti per
l’uomo niente affatto già decisi in partenza. La pronta fiducia prestata alla capacità della tautologia di garantire l’essere sembra così
vacillare sotto i colpi del nichilismo che avanza, sostanzialmente
messa fuori gioco dalla nuova perimetrazione del problema. Siamo
così divenuti di nuovo consapevoli che l’essere non è l’unica scena
data sullo scenario cosmico, ma si dà propriamente come risultato
di un potente atto di posizione, teoreticamente efficace. Del quale,
principalmente, siamo debitori verso il filosofo di Elea9.
9
Perché l’essere? – si chiede Aubenque, che così risponde. «Ma non porsi la questione sarebbe considerare come naturale una scelta che non si imponeva assolutamente, dato che Parmenide sarà stato a lungo il solo a farla» (P. AUBENQUE, op. cit.,
p. 108).
98
Ora è proprio il riconoscimento di questo debito culturale che
ci chiama ad un rinnovato approccio al pensiero di Parmenide, che
non eviti la questione della posizione dell’essere – «perché l’essere e
non il nulla?»: ecco la questione essenziale, ricordavamo nell’Introduzione – per trovare rifugio nella comoda risposta della tautologia.
Cosa intende dunque Parmenide quando usa il verbo eänai?
Occorre di nuovo affrontare questa domanda, all’apparenza del tutto scontata, se solo si consideri la presenza usuale e consolidata del
lessema “essere” nei differenti contesti linguistici. Nel far questo
dovremo tener presente che così facendo noi ci riportiamo, con
Parmenide, all’inizio dell’itinerario teoretico da lui percorso.
Oltre la tautologia
Qual è dunque l’esperienza originaria che ci viene consegnata
nel Poema sulla natura? E perché l’affermazione, che dell’essere si
può dire solo che è, non vale da sola a sostenere la costruzione teoretica? Conviene partire da questa seconda questione, che abbiamo
già avvicinato analizzando nel capitolo precedente la posizione di
Severino e che adesso dobbiamo però affrontare nella prospettiva
della chiarificazione della concezione parmenidea dell’essere. Perché dunque la tautologia si rivela improbabile?
Una tautologia, come è noto, esprime una funzione analitica,
esplicativa di un contenuto; non le è dato, invece, di ampliare l’estensione del concetto che essa mette in gioco, od anche di sostenerne l’affermazione, non essendo in grado di esibire le prove della
forza e necessità del suo stesso atto di posizione10. Più ancora, essendo circolare e da ultimo ripetitiva, essa non riesce ad allontanare da
sé il titolo non esaltante della ovvietà, che la priva di vero fascino.
Come, infatti, una volta affermato l’essere, che una cosa è11, si può
10
A tal fine l’elenchos non è sufficiente. Vedi cap. precedente.
Ma essere e cosa-che-è valgono come identici, come capita di pensare a molti e
autorevoli commentatori? Senz’altro no. Ci sia tuttavia consentito a questo punto
della riflessione una tale approssimazione, la cui precisazione costituisce buona parte
dell’assunzione di base della presente ricerca.
11
99
poi dire di esso, di essa, che non sia? Una logica necessità impone di
opporsi a simili conclusioni.
La necessità, che la tautologia opportunamente rivendica, sembra tuttavia esigita più dalla struttura della connessione del logos nella sua richiesta conoscitiva, che dalla struttura della realtà stessa.
Perché se l’essere è, di esso evidentemente può essere affermato solo l’essere. Questo però è precisamente il punto: se l’essere è. Se
l’essere è, non se le cose siano – se cioè il modo di darsi delle cose
ha i caratteri dell’essere, se insomma questo tratto essenziale attribuito alle singole realtà ha anche la forza di imporsi sul caos destrutturante e nullificante, e proteggere le cose dalla aggressione permanente dell’abisso vorticoso del nulla. Si tratta in altri termini di capire cosa significa in questo caso dire delle cose che sono.
Cerchiamo di precisare meglio il problema, che all’apparenza
sembra suscitato solo da una capziosa volontà intellettualistica. Dato
che questo appunto, che le cose siano, è un fatto che si impone al di
là di ogni ragionevole dubbio. Di cosa dunque discutere? La negazione scettica radicale di tipo ontologico, che vorrebbe contestare
l’evidenza del darsi delle cose, si rivela nei fatti insostenibile. A
smentire siffatte eccentriche considerazioni è sufficiente l’esperienza pratica che ci impone la presenza di cose. Ma, a meno di ritenere
gli esponenti dello scetticismo antico ingenui intellettuali o ciarlatani di dubbio gusto12, la meditazione scettica, con l’esortazione alla
prudenza conoscitiva e il rifiuto dell’espressione definitoria, in verità chiama in causa proprio la insufficienza ontologica delle cose
stesse, la loro fragile consistenza. La cose infatti certamente ci sono,
ma anche affondano, scompaiono nel nulla o almeno sembrano farlo. Cosa dunque le mantiene, nel e oltre il loro momentaneo esserci? Ecco la domanda che profondamente ci interpella. Ciò che fa
questione è pertanto non, come detto, che le cose siano, ma il fondo del loro essere, le ragioni che ne possano stabilizzare la presenza.
12 Come purtroppo una ingenua manualistica di impronta tardoilluministica, del
tutto ignara della «rilevante coincidenza che v’è fra lo scetticismo e la filosofia stessa»,
sembra pensare. Ma di una siffatta intima relazione, conclude amaramente Hegel, «la
scepsi moderna non sa assolutamente nulla» (G.W.F. HEGEL, Rapporto dello scetticismo
con la filosofia, Laterza, Roma-Bari 1977, p. 88).
100
Si tratta evidentemente di aspetti distinti, che non è opportuno mescolare.
Differenza ontologica: da Heidegger in poi così viene espresso
il dislivello metafisico che viene a istituirsi tra le cose (che sono,
gli enti), e ciò che delle stesse costituisce il fondamento trascendentale e trascendente insieme13. Questa differenza risulta decisiva
e non può venire annullata, senza precipitare nella confusione di
singole entità, presenti nella loro determinatezza essenziale, con
quanto invece fornisce loro i motivi e la forza della presenza medesima.
Si tratta, con ogni evidenza, di una, o forse meglio, della questione centrale, di cui è necessario indagare a fondo le ragioni;
qui, prima ancora che nella scoperta di quanto imponga la differenza tra i caratteri delle cose, risiede autenticamente lo stupore
originario, che origina la meditazione filosofica. Non è infatti sufficiente che le cose siano date e presenti avanti a noi; occorre anche che esse siano stabili nel loro darsi. Con Heidegger, infatti,
potremmo dire che la presenza (Vorhandenheit) è solo un modo di
darsi dell’ente, quello per cui esso ci è davanti (vor; latino: prae);
ciò che non implica da sé l’inevitabilità di questo darsi e, soprattutto, non esclude la possibilità del sottrarsi a questa modalità. La
ricerca di una opportuna garanzia circa il mantenimento in atto
delle realtà mondane, l’assicurazione di una stabilità ontologica,
intesa come permanenza nell’essere e nei caratteri propri14, costituisce pertanto snodo decisivo della relazione al mondo da parte
dell’uomo. Al quale però non sfugge come proprio quelle realtà
13 Cfr. Martin HEIDEGGER, L’essenza del fondamento, in Segnavia, op. cit., pp.
79-131. Sulla differenza ontologica, quale «luogo originale del Poema di Parmenide»
ha insistito Jean BEAUFRET (Introduction à une lecture du Poème de Parménide in J. BEAUFRET (ed.), Le Poème de Parménide, Presses Universitaires de France, Paris 1955,
p. 53), che annota: «il luogo del Poema di Parmenide, se è certamente la trascendenza, non è dunque la trascendenza evasiva che, a partire da Platone, è metafisicamente
nostra, ma una trascendenza fondativa» (ivi, p. 48).
14 Il percorso da Parmenide a Platone, su cui tra poco avremo modo di tornare a
riflettere, è così tracciato. L’evoluzionismo minaccia tale esigenza? Non direi. Dal
momento che ciò che evolve sono i tratti specifici dell’identità biologica dei viventi;
un’identità, però, che, in quanto tale e pur nel mutare delle forme in cui si manifesta,
non è affatto messa in discussione.
101
non siano in grado di offrire ontologiche garanzie. A meno dunque di mettere tra parentesi la questione – ma chi avrebbe coraggio di poggiarsi su una cosa qualunque, quale legge potrebbe rivendicare il diritto di spiegarla, senza poter contare su una qualche
rassicurazione circa la sua, almeno relativa, stabilità? – non può
non venire riconosciuto che le cose fanno appello ad altro da sé e
rimandano ad una diversa potenza capace di istituirle nella loro
ferma presenza. Diversamente la realtà, nel suo insieme e nelle sue
singole parti, si rivelerebbe inaffidabile e tale comunque da non
permettere l’impianto di alcuna istallazione; sarebbe come neve al
sole, destinata a sciogliersi al primo contatto col calore.
Questione centrale, che la frequentazione abituale con gli oggetti del mondo ci fa sembrare marginale, se non anche del tutto
inutile e falsa. Sì, perché l’esperienza di vita, nella ordinaria quotidianità delle sue manifestazioni, offre ripetute conferme che la realtà, una volta data, poi resta stabile, almeno per un certo periodo
di tempo. E, dunque, ciò pare sufficiente ad attribuire alla questione della stabilità ontologica un interesse solo storiografico.
Ma la consuetudine non può valere a surrogare il deficit ontologico che circonda le cose o a far recedere dall’interrogazione
circa la loro permanenza. La stessa ricchezza e varietà dell’esperienza è da ultimo segno della ontologica debolezza di quanto la
produce. Quanto poco infatti l’appello alla pura e semplice datità
dell’esperienza sensibile possa servire a consolidare la richiesta di
una sua stabile consistenza ce lo ricorda Hegel, che fa dell’incertezza della sinnliche Gewissheit proprio il punto di partenza dell’itinerario fenomenologico verso il sapere assoluto15. Non sarà perciò
l’esorcismo dell’esperienza a confutare definitivamente ciò che si
riaffaccia puntualmente e con un’intensità drammatica nei momenti di maggiore tensione dell’esistenza, allorché la fiducia nella
permanenza delle cose vien potentemente scossa e si trasforma in
urlato e disperato appello. È di fronte all’improvvisa scomparsa di
una persona amata che questo sentimento di ontologica impoten-
15
102
Cfr. G.W.F. HEGEL, Fenomenologia dello spirito, op. cit., I, pp. 81 ss.
za si manifesta in tutta la sua forza. Ma la morte non giunge in definitiva mai inattesa; essa appartiene in profondità alla vita16.
Dove invece il baratro del nulla, che risucchia a sé tutte le cose,
sembra lasciare una traccia indelebile è nel caso del terremoto.
Chiunque ne abbia fatto esperienza sa molto bene in che modo esso
si imprima nella coscienza. Ciò che il terremoto infatti produce è
una inaspettata cesura nel flusso di fiducia che l’uomo ripone nella
terra, sostegno ultimo dello stare di uomini e cose. Non si tratta infatti anzitutto del vacillare degli oggetti – ciò appartiene all’esperienza di vita, niente di ciò che l’uomo maneggia è infatti immutabile ed eterno – quanto piuttosto del vacillare del sostegno, la terra
stessa, cui l’uomo si appoggia nel suo soggiornare mondano. Il terremoto, per quanto piccola ne sia la magnitudo, pare quasi ricordarci che le realtà del mondo, anzi il mondo stesso, sono prive di
quella essenziale stabilità che l’uomo costantemente ricerca. Solo
una pervicace negazione dell’esperienza (o una più vera fiducia nell’essere – una p…stij ¢lhq»j per usare il linguaggio di Parmenide)
può pertanto in verità contestare la percezione della fondamentale
fragilità dell’esistenza umana e di quanto la circonda. La possibilità
dell’annientamento costituisce in effetti la minaccia più grave, che
rende inutile ogni impegno e priva di vero senso ogni umana edificazione. La ricerca di stabilità, di un essere delle cose che ne garantisca una durevole permanenza, appartiene così al nucleo originario
e fondamentale della costituzione umana più autentica.
La scoperta e la consapevolezza di questa privazione, che avvolge non solo gli oggetti del commercio strumentale ma impregna in profondità la stessa condizione ontologica umana, non è
per altro estranea alla riflessione della sapienza antica. «Vanità delle
vanità, tutto è vanità»: così lamenta il saggio ebreo Qohelet17. Gli
fa eco il poeta latino Orazio: «Dum loquimur, fugerit invida
16 Non
è senza un qualche interesse osservare come la ricerca tecnologica sia impegnata a sottrarre all’incertezza dell’imprevedibile gli unici momenti dell’esistenza
che sfuggono (ancora?) al controllo dell’uomo, la nascita e la morte. Ma la eventuale
infinitezza temporale potrà mai surrogare la finitudine ontologica?
17 Qo. 1,1. Il senso della fragilità della vita è proprio della cultura ebraica.
103
aetas»18. Tanto dal versante ontologico delle cose, quanto da quello esistenziale della esperienza vitale, l’uomo si imbatte costantemente nel limite della finitudine ontologica di ciò che è. Niente
dunque di ciò che appare sulla scena mondana è capace di rassicurare l’uomo circa la sopravvivenza alla sua, delle cose ma anche
dell’uomo, momentanea presenza. E tuttavia qualcosa nelle cose ci
annuncia che una qualche rassicurazione si dia. Ma dove trovarla?
La presenza e permanenza nell’essere resta pertanto misteriosa e,
al tempo stesso, piena di fascino. Questo è ciò che cattura con forza
l’attenzione dell’uomo, quando la riflessione pensante si stacca dai
contesti ordinari dell’abitudine. Non può costituire meraviglia, allora, che la prima testimonianza diretta di quella riflessione che siamo abituati a classificare come filosofia, quella di Anassimandro, sia
centrata esattamente sullo stesso scenario.
Anassimandro e la finitudine ontologica
Il riferimento ad Anassimandro non è fuori luogo. E non tanto
perché le fonti lo dicono maestro di Parmenide19, quanto piuttosto
per l’oggettiva consonanza speculativa, che avvicina i due; una
consonanza definita anzitutto dagli interrogativi che gravano sulla
sensibilità teoretica di pensatori, che per primi si sono affacciati alla considerazione pensante della realtà.
Per quanti infatti andavano muovendo i primi essenziali passi
sulla via della acquisizione del senso, il darsi improvviso ed imprevisto delle cose come il loro subitaneo scomparire non poteva non
costituire motivo di teoretico turbamento. Nella calma solitudine
della riflessione pensante si è giocata una vera e propria lotta da titani del pensiero – la cui lontana e vittoriosa eco si può ancora
percepire nell’approccio contemporaneo ai sistemi della rappresentazione del reale – che ha saputo proclamare la fiducia verso il
18
ORAZIO, Carpe diem, Carmina I, 11. Alla constatazione oraziana può essere
avvicinato quanto annota il salmista: «gli anni della vita sono settanta, / ottanta per i
più robusti, / ma quasi tutti sono dolore e fatica. / Passano presto e noi ci dileguiamo» (Sal. 89).
19 DIOGENE LAERZIO (Vite dei filosofi, IX 21 = 28 A1 DK) riferisce che secondo
Teofrasto Parmenide fosse discepolo del filosofo di Mileto.
104
mondo della vita. È la grande questione dell’¢rc¾20, entro la quale
ancor oggi ci muoviamo, calcando con non sempre chiara consapevolezza la strada, tracciata dai primi pensatori con l’audacia dei
pionieri. L’apertura dell’orizzonte semantico, che fornisce le singole cose e relazioni del valore, che solo può sottrarle all’insensatezza, costituisce uno snodo fondamentale, tanto più decisivo
quanto più tragico risulta essere il deficit di senso che le cose non
riescono da sole a garantire; e che pertanto può far vacillare ogni
certezza acquisita. Perché le cose sono? Quale il fondamento del
loro stare innanzi a noi? E noi stessi, dove appoggiamo il nostro
esserci? Cosa ci salva dal naufragio, che pare il nostro inevitabile
destino? Sono queste le domande che hanno avviato e con cui da
sempre si affatica, in maniera più o meno diretta ed esplicita, la riflessione filosofica.
Raccogliere perciò il lascito speculativo di Anassimandro, nell’ascolto della sua oracolare parola21, è occasione preziosa per introdurci entro l’ambiente di pensiero entro il quale, con il suo
originale approccio, ha maturato le sue riflessioni anche Parmenide. Del quale avremo così l’opportunità di calibrare, senza inadeguate precomprensioni, il senso della questione ontologica.
Il frammento di Anassimandro, al quale vogliamo ora dedicare
brevemente la nostra attenzione, brilla solitario nella maestosità di
un pensiero essenziale. Esso affronta la medesima questione che
affligge anche Parmenide, ovvero il limite ontologico che perseguita una realtà segnata in profondità dalla caducità. In effetti le
cose, che pur sono, non sanno però sfuggire al ciclo cosmico che
senza tregua ed inesorabilmente le atterra, dominandole con violenza. L’impianto delle cose si rivela pertanto instabile, incapaci
come esse sono di mantenersi nel luogo loro assegnato.
20
Non è senza significato che la tradizione dossografia vuole che Anassimandro
sia stato il primo ad usare questa parola (cfr. fr. 11 B1 Colli [12 A9 DK]).
21 Dopo aver riportato il frammento di Anassimandro, Teofrasto commenta: «tali cose le esprime in questi termini piuttosto poetici (poihtikwtšroij oÛtwj
ÑnÒmasin aÙt¦ lšgwn )» (ibidem).
105
™x ïn dš ¹ gšnes…j ™sti to‹j oâsi, kaˆ t¾n fqor¦n e„j taàta g…nesqai kat¦ tÕ creèn: didÒnai g¦r aÙt¦ d…khn kaˆ
t…sin ¢ll»loij tÁj ¢dik…aj kat¦ t¾n toà CrÕnou t¦xin
[le cose] fuori dalle quali è per gli enti la nascita, [sono] anche le stesse
verso le quali avviene la distruzione secondo ciò che dev’essere; questi [gli
enti] infatti reciprocamente si danno giustizia e ammenda dell’ingiustizia
secondo l’ordine del tempo22.
La riflessione che stiamo rincorrendo non ci consente una discussione analitica del frammento di Anassimandro. Ci limitiamo
perciò a cogliere risonanze e consonanze provenienti da esso e che
possono, quasi a mo’ di elemento di contrasto, far risaltare meglio il
senso delle parole di Parmenide.
Anche ad una prima lettura balzano subito agli occhi le forti affinità linguistiche con il Poema parmenideo, segno indiretto ma eloquente almeno di appartenenza ad una comune atmosfera culturale.
Per entrambi i pensatori troneggia la figura di d…kh. Un’esigenza
cosmica di giustizia, secondo il pensatore jonico, impone di ripristinare l’ordine giusto primordiale23 perturbato da un atto di arbitrio
empio, in virtù del quale le cose che sono si sono distaccate dal tutto che le avvolge ed entro il quale esse hanno dimora. La ¢dik…a, la
violazione di d…kh qui evocata, è così indicata come l’evento iniziale che origina il processo temporale di crescita ed irreversibile decadimento di tutto quanto è; e solo un atto contrario, doloroso e penoso, cui nessuna cosa può sottrarsi e che muove insieme tutto il
processo del tempo, di ristabilimento di d…kh può ottenere la resta22
Fr. 11 A1 Colli (12 B1 DK). [Traduzione mia].
traduzione di Giorgio Colli, il cui già citato lavoro di raccolta della Sapienza greca ha costituito riferimento continuo per il presente studio, non sembra cogliere tutta la rilevanza di dike, che si riflette nella coppia oppositiva d…kh-¢dik…a. Egli
infatti traduce: «le cose che sono, infatti, subiscono l’una dall’altra punizione e vendetta per la loro ingiustizia, secondo il decreto del Tempo». Simile è la traduzione di
Renato LAURENTI in I Presocratici. Testimonianze e frammenti, op. cit., I, pp. 106-7:
«poiché essi [gli esseri] pagano l’uno all’altro la pena e l’espiazione dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo». Come sempre illuminante è la lettura del frammento che
ne fa HEIDEGGER in Il detto di Anassimandro (op. cit.).
23 La
106
urazione del principio violato24. Allo stesso modo è proprio il rispetto e l’approvazione da parte di D…kh - polÚpoinoj, che molto
punisce, annota Parmenide, quasi a riprendere la considerazione
anassimandrea circa l’inevitabile condanna di decadenza che grava
sulle cose25 - ad aprire a Parmenide il suo cammino. La giustizia,
personificata come la dea che accoglie il giovane nel suo viaggio e
lo introduce nel luogo della verità, esercita, come osserva Ruggiu,
una funzione essenziale di guida e protezione nella ricerca della
Verità26.
Un secondo plesso di convergenza teoretica pare concentrarsi
attorno alla figura della necessità. Kat¦ tÕ creèn: “secondo la necessità”, od anche “secondo ciò che deve essere”; vale a dire, come
osserva opportunamente Severino, “seguendo la necessità”. «Ciò
da cui la necessità è seguita sono i mortali, gli dei e tutte le cose della terra. Non la seguono avendo la possibilità di andare per altre vie:
la necessità è l’inevitabile, il necessariamente seguito»27. La necessità, dunque, è la potenza cui non è possibile sfuggire, la legge che si
impone in virtù della sua forza propria. Un dominio inesorabile,
cui ogni cosa è assolutamente soggetta, ma che al tempo stesso e
proprio per lo stesso motivo è ciò che fornisce di una regola eventi
altrimenti erratici. Affermando l’ordine (nel duplice senso di comando e di criterio o modalità di composizione della realtà) rigoroso della necessità, Anassimandro ha in tal modo aperto l’orizzonte
della pensabilità del senso delle cose. Queste si danno secondo un
24 È
un processo cosmico e tragico assieme, che non può esser letto nella chiave
tutta moderna di una soggettività violata o volontaristicamente ansiosa di riaffermare
se stessa pur nel tracollo del proprio esserci.
25 Fr. 1,14. Vedi la nota di Giovanni REALE, Dike e il suo significato in Parmenide,
in ZELLER-REALE, op. cit., pp. 205-7.
26 «Il poliformismo della Grande Dea di Parmenide trova il suo centro semantico-concettuale nel nome e nella funzione della Giustizia. Indubbiamente quest’aspetto costituisce il cuore dal quale si diramano e nel quale convergono la molteplicità dei nomi e degli aspetti della divinità nella prima parte del Poema. Il viaggio e
l’ottenimento della rivelazione sono posti sotto l’egida di Themis e Dike» (L. RUGGIU, Commentario, op. cit., pp. 188-9). La concordanza di Dike e Themis è già data in
Omero (oÜte d…kaj eâ e„dÒta oÜte qšmistaj. Od. 9, 215)
27 E. SEVERINO, Destino della necessità, op. cit., p. 13. Secondo Severino il frammento di Anassimandro inizia proprio con queste parole.
107
ritmo che rifugge da ogni assalto del caos; si dà insomma una disciplina, accessibile all’intuizione pensante dell’uomo, nel processo a
prima vista indisciplinato dell’apparire e scomparire delle cose.
Non diversamente da Anassimandro, anche Parmenide, nei cui
frammenti il termine, in differenti flessioni, ricorre 8 volte28, riconosce nella necessità la norma cui tutto è sottomesso e che non ammette eccezioni; anche il pensiero si appoggia su di essa per costruire i suoi logici ragionamenti29. Accanto al piano ontologico emerge
così una dimensione logica della necessità, in virtù della quale è
possibile governare con la massima efficacia lo svolgimento del discorso che conduce alla meta del sapere l’«uomo che sa». Che pertanto, sotto lo sguardo benevolo di Dike, può sfuggire al caos del
disordine primordiale30 ed avanzare verso la Verità.
Ma ciò che soprattutto schiude interessanti prospettive di ricerca è il fatto che nel frammento anassimandreo ritroviamo la parola
che riassume la metafisica. Sebbene declinata obliquamente in forma participiale e non espressamente tematizzata, è tuttavia ben evidente che nel pensiero del pensatore jonico è espressa l’idea che la
tradizione ha unanimemente attribuito a Parmenide, ovvero l’essere. A differenza di quanto comunemente si crede, non è dunque
Parmenide, ma Anassimandro il primo pensatore a far uso consapevole del concetto che il verbo essere si incarica di veicolare. La cosa
risulta della massima importanza. E non perché voglia far intendere
o preludere ad una riscrittura della storia della filosofia, quanto perché ci consente di definire ancor meglio i contorni della elaborazione parmenidea; la quale, come ben presto vedremo, sarà capace di
fornire l’essere di una decisiva collocazione e funzione fondante.
28
Creë (1, 28), crÁn (1. 32), creèn ™stin (2, 5; 8, 11.54), cr¾ (6, 1), creÒn
™sti (8,45), cršoj (con idea di vantaggio, 8, 9). Allo stesso ambito semantico tematico va poi riportata ’An£gkh (8. 30), qualificata come krater», dura, inflessibile
(perché senza curvature (¢n¦-¢gkèn), dunque diritto, senza deviare qua e là).
29 Fr. 8,11: «Perciò è necessario che sia per intero, o che non sia per nulla».
30 Un ricordo del caos primordiale, che il racconto esiodeo evoca, è contenuto
nei termini usati da Parmenide per descrivere la sensazione di vertigine sperimentata
nell’oltrepassare la «porta dei sentieri della Notte e del Giorno». Parmenide racconta
che l’aprirsi della porta «produsse una vasta apertura» – meglio: una profonda voragine (c£sm’¢canšj. Fr. 1, 15-16) – dove il termine c£sma ricorda il C£oj originario. Più avanti si rifletterà ancora sull’esperienza qui richiamata.
108
La parola centrale della metafisica, dunque, in verità è detta già
in Anassimandro, sia pure con un significato non ancora pienamente consolidato. Nel frammento abbiamo in effetti trovato il termine
oâsi, con il quale vengono indicate le realtà mondane considerate
nella loro generalità e totalità. Le cose che nascono e periscono ricevono così tutte la denominazione di t¦ ×nta, le cose che sono.
Ovviamente, il termine non ha ancora il significato tecnico consueto, di cui lo arricchirà l’ontologia platonica e poi aristotelica; e il
frammento non ci consente nemmeno di ipotizzare una fondazione
giustificativa dell’uso del termine, quale sarà quella prodotta
dall’™Õn di Parmenide. E tuttavia la presenza del participio del verbo essere non può esser messa tra parentesi così facilmente.
Ciò che conta, ora, è cercare di cogliere il senso e il valore di
questa presenza. Nel far questo converrà riflettere anzitutto sul modo temporale del termine, coniugato nella forma del participio presente. La funzione linguistica espletata da questa forma verbale, in
una maniera diretta quando il participio è preceduto dall’articolo
venendo da questo sostantivato, come è noto è quella di indicare il
soggetto reale che contestualmente esercita l’azione espressa dal
verbo. Nel nostro caso l’ente, o forse meglio, l’essente, ancor più se
declinato al plurale – t¦ ×nta, gli essenti, le cose che sono –, sta ad
indicare quelle singolarità caratterizzate dal fatto di essere31. Essente
è ogni singola cosa che l’uomo incontra; l’azione che la costituisce,
quella di essere, non sembra alludere ad altro che al puro e semplice
darsi alla percezione dell’uomo. Qualcosa si offre e intercetta lo
sguardo o la sensibilità dell’uomo, che nomina questo qualcosa nel
suo darsi – e portando ad espressione questo darsi prima ancora di
ogni sottolineatura di specifica differenziazione qualitativa – col sostantivare il participio, t¦ ×nta. E tali in Anassimandro sono tutte
le cose, con le quali l’uomo entra in relazione nella misura in cui es31 Il verbo essere ha inoltre anche una funzione copulativa, di congiunzione logica di soggetto e predicato. È però evidente che l’uso logico-predicativo non può
venire attribuito al participio in funzione sostantivata. Questo fatto dovrà essere
considerato attentamente nel valutare la tesi di Calogero, che la contraddittoria
«aporia eleatica» sia «generata da una fondamentale indistinzione tra l’essere predicativo e l’essere esistenziale» (G. CALOGERO, Studi sull’eleatismo, op. cit., p. 5).
109
se sono; essendo inoltre state generate e dovendo da ultimo scomparire, tali cose manifestano una provvista d’essere limitata nel tempo.
Sono, dopo essere uscite fuori dal principio infinito nell’evento
della loro generazione e prima di venire distrutte, cioè di perdere la
loro incerta consistenza ritornando al principio che tutto contiene.
Entro questo spazio si gioca tutta la loro presenza.
Il frammento non dice altro; e tuttavia è massimamente eloquente. Dalla lontananza delle origini, che forse meglio è vicinanza
all’originario, si annuncia un’intuizione del reale dove questo si
manifesta nella sua natura non ancora offuscata dai rivestimenti e
travestimenti addomesticanti del pensiero. Le cose che sono, osserva Anassimandro, non sono sempre. Le segna nella profondità della
loro natura il limite temporale, entro cui trascorrono il loro essere,
consegnato all’urgenza del ritorno al luogo originario; da cui sono
differenziate non solo e non tanto in termini spaziali, ma più ancora
per l’intrinseca loro costituzione32. La loro fÚsij, altra rispetto a
quella del principio senza limiti, si precisa come essere; ne fa degli
enti. L’essere delle cose mondane tuttavia si mostra non valere affatto come l’unica possibilità effettivamente data. Esso convive con
la possibilità del non-essere, il nulla; che, se non viene esplicitamente detto, è nondimeno evocato. Le cose oscillano tra l’essere e
il nulla in cui ritornano, secondo un destino di necessità che ne rivela il disegno non arbitrario. Così la morte e la corruzione hanno
un senso; la stessa sofferenza ha un senso, nascosto nelle pieghe dell’apparente ripetitività del ciclo vitale, e nondimeno capace di rimandare al di là di questo.
Sconfiggere l’arbitrio e il capriccio, sottrarre le cose e se stessi all’arbitrio volubile della prepotente divinità sembra essere la preoccupazione primaria dei pensatori delle origini; che hanno la forza di
riconoscere la natura delle cose e fissare in faccia il loro destino. La
32 Qualche riga prima di riportare il frammento, Teofrasto afferma che Anassimandro, a differenza di Talete, ha distinto tra gli elementi e il principio, che è «una
certa altra natura infinita, da cui sorgono tutti i cieli e i mondi in essi contenuti»
(˜tšran tin¦ fÚsin ¥peiron, ™x Âj ¤pantaj g…nesqai ktl. – Fr. 11 B1 Colli
[12 A9 DK]). Prima e più che di allontanamento fisico, è qui piuttosto in gioco una
differente modalità di darsi, una altra natura (˜tšran tin¦ fÚsin), come l’osservazione di Teofrasto introduttiva del frammento ci lascia pensare.
110
soluzione di Anassimandro non occulta la caducità ontologica delle
cose che sono, ma ne radica la presenza nel principio infinito e trascendente, entro il cui seno esse possono ritrovare la pace violata.
Lo sguardo indagatore del pensatore jonico ha saputo cogliere la
forza del principio che sovrasta le singole cose e ne custodisce il
senso33.
L’esperienza parmenidea dell’essere
E tuttavia la questione è lungi dall’essere definitivamente chiusa.
Dato che niente assicura che il ritmo ciclico del movimento cosmico di nascita e distruzione, ripercuotendosi entro lo stesso infinito
principio, non coinvolga anche quest’ultimo nella medesima dinamica. L’¢rc¾ stesso così vacillerebbe nelle sue più remote radici,
riducendo l’affermazione appena conquistata della necessità dell’ordinamento cosmico ad una presuntuosa illusione. Un abisso terrificante si spalancherebbe per l’uomo sotto i suoi piedi. Nulla più potrebbe garantire la costanza della regola che consente l’orientamento mondano.
Solo un atto, quello capace di fissare la necessità del principio, la
sua assoluta non contingente stabilità, può valere come allontanamento di una simile minaccia. Il principio delle cose che sono, l’essere, deve dunque confermarsi stabile nella sua necessità. Dalle cose
che sono, e che, come ci insegna Anassimandro, possono anche
non essere, si innalza la richiesta di una più potente garanzia di affidabilità, che può risiedere solo nella necessità dell’essere.
Ma, appunto, l’essere è necessario? Può la ragione imporsi sull’essere al punto da costringerlo a manifestarsi anche quando le cose
non sono più? da negare l’eventualità che queste possano trascinarlo
con sé nel loro stesso scomparire? E se questa eventualità – che le
cose possano non essere, che io stesso possa non essere più – è effet33 L’affermazione di Aubenque, che «Parmenide è l’unico pensatore presocratico
ad interessarsi dell’essere. […] Parmenide è, avant la lettre, un pensatore onto-logico»,
il quale sulla questione dell’essere «non ha precursori e non avrà discepoli immediati»
(P. AUBENQUE, op. cit., pp. 104, 107), va perciò per lo meno precisata nel senso della esplicita tematizzazione della questione.
111
tiva e non solo pura ipotesi mentale, come affermare ancora l’essere? Come non riconoscere piuttosto che, per quanto evidente sia
che io, che in questo momento sto scrivendo o leggendo queste parole, abbia una mia consistenza, per molto tempo non sono stato e
per molto tempo non sarò più? E lo stesso non vale per le cose del
mondo, e per il mondo stesso? O dovrei dire che ero, pur non essendoci, e sarò, pur non essendoci? E come e dove? Come insomma continuare ad affermare l’essere quando tutto sembra scomparire?
Duemilacinquecento anni di storia dipingono per noi come
oziose domande del genere. Sappiamo bene che è così, che le cose
sono. L’enorme potere produttivo della tecnica, che si esercita nell’emulazione della potenza creativa di Dio e promette di sostituire
la speranza del mantenimento nell’essere con la volontà del fare, ce
lo ricorda giorno dopo giorno. Eppure c’è stato un tempo in cui
queste domande gravavano sull’uomo con tutto il peso della loro
essenzialità. E c’è ancora un tempo, proprio il nostro, in cui rammemorare salvaguardando la delicata natura della questione metafisica si presenta come essenziale compito dell’impegno filosofico; e
proprio per evitare la catastrofe.
È allora conveniente lasciarsi accompagnare dalla riflessione
pensante del filosofo di Elea. La quale, conviene subito sottolineare
con forza, non trova già spianata avanti a sé la via da percorrere,
quasi si trattasse solo di una marcia trionfale di un pensiero che ha
già preordinato tutto. Quella di Parmenide è invece una vera e propria lotta per la conquista del senso.
Che, un po’ hegelianamente, si assuma appunto che Parmenide
non abbia avuto necessità alcuna di mettersi in gioco e affrontare il
passaggio cruciale della decisione verso l’essere, dal momento che
tutto in sé è già compiuto; che anzi, di più, non si dia alcun decisivo
passaggio ma solo logiche conseguenze, che egli ha saputo trarre
per primo, sembra convinzione diffusa per la gran parte degli interpreti. I quali, però, in questo modo mostrano solo di essere ancora
legati alla illusione prospettica generata dalla ripresa platonica dei
temi eleatici. Nonostante gli avvertimenti di Beaufret, che reclamava uno svincolamento del pensiero di Parmenide dalla successiva
112
ipoteca platonica34, il luogo dell’ermeneutica parmenidea continua
a restare nel cono di luce (o d’ombra) platonico. La lettura platonizzante infatti non si riproduce soltanto nell’interpretazione della filosofia eleatica nei termini di una filosofia monistica dell’unità – interpretazione da cui la critica più recente ha saputo prendere le opportune distanze35 – quanto più ancora sottilmente nella lettura essenzialistica che vien data dell’essere parmenideo. L’affermazione
va spiegata.
Uno sviluppo tematico nuovo, benché senz’altro potenzialmente già contenuto nella primordiale affermazione parmenidea
dell’essere, si fa strada con la filosofia di Platone. Passo forse obbligato sul cammino della ricerca, l’attenzione del filosofo ora si concentra sulla questione della identità, sentita come condizione della
individuazione e conoscenza delle cose. Una volta assicurato l’essere delle cose, diventava in effetti importante spiegare anche perché
ciascuna cosa, che è in un certo modo, appartenendo ad un determinato genere, è pur tuttavia differente da ogni altra cosa, la quale
pure è, appartenendo però ad un genere diverso. Le cose che sono,
infatti, non possiedono tutte i medesimi caratteri. Alcune si somigliano e possono essere riunificate entro un unico gruppo; altre invece sono differenti dalle prime e non consentono associazioni.
L’essere, che le costituisce tutte, non copre perciò il differenziarsi
delle loro qualità. Qualcos’altro oltre l’essere, o meglio ancora, l’essere stesso, concepito però con una determinazione più ampia di
quella ad esso riconosciuta da Parmenide, va chiamato in causa per
spiegare il fatto evidente che le cose, che sono, non sono tuttavia le
stesse né sono tutte allo stesso modo. Prende corpo una nuova do34
J. BEAUFRET, op. cit., p. 30. Sui motivi e i modi della ripresa di Parmenide da
parte di Platone cfr. Adriana CAVARERO, Platone e Hegel interpreti di Parmenide, in
«La Parola del Passato», XLIII, 1988, pp. 81-99.
35 Uno dei risultati acquisiti dalla ricerca parmenidea è che la lettura platonica
della filosofia di Parmenide come di una teoria dell’essere-uno sia decisamente fuori
strada e vada invece legata alla ripresa dell’ontologia da parte di Melisso. Si veda il
saggio di Mario UNTERSTEINER, L’essere di Parmenide è oâlon e non œn, «Rivista
critica di storia della filosofia», 10, 1955, pp. 5-23 (ora in Introduzione a PARMENIDE,
Testimonianze e frammenti, La Nuova Italia, Firenze 1958, pp. XXVII-L) e la nota di
Giovanni REALE, Una variante dei versi 5-6 del frammento 8 e la tesi dell’Untersteiner, in
ZELLER-REALE, op. cit., pp. 198-205.
113
manda: cosa fa sì che un ente sia proprio quello e non altro? L’interesse teoretico pertanto si rivolge a tracciare i contorni essenziali,
come tali non mutevoli, capaci di precisare l’identità dei singoli generi di cose, il loro eädoj.
L’asse teoretico del discorso subisce pertanto un deciso riorientamento. Non già e non più se l’essere è o non piuttosto il nulla – questo il dilemma che Parmenide ha avuto la forza di sciogliere, affermando l’essere – ma come è l’essere-che-è. Non più l’™Õn, ma il tÕ ti
Ãn eänai; dove però la questione dell’eänai finisce inevitabilmente
per retrocedere di peso davanti a quella del tˆ, della qualità essenziale, dalla quale viene sostanzialmente determinata. È il problema
già incontrato della definizione, che, se giungerà a compiuta forma
nella logica aristotelica, trova già in Platone la prima formulazione36.
In tal modo la filosofia ha abbracciato sempre più decisamente la
modalità della conoscenza e dell’™pist»mh. Su questo punto abbiamo già discusso nel primo capitolo e non è il caso di insistere ulteriormente. Ci interessa invece mettere in evidenza come sia proprio una siffatta nuova prospettiva a dislocare il centro dell’interrogazione filosofica; che così si allontana irrimediabilmente dalla radicale originarietà della questione ontologica, quella per la quale l’essere si impone sul nulla, per sostare nei più confortevoli e sicuri
quartieri delle qualità delle cose, affondate con ogni sicurezza nell’essere. La speculazione platonica consente ormai alla filosofia di
sedere tranquilla sul bordo della via dell’essere, che Parmenide ha
consolidato come l’unica via, a meditare i caratteri specifici dei tanti
enti, di cui può dirsi solo l’essere, unica condizione rimasta del discorso.
Così configurata, la radicalità dell’interrogazione parmenidea
viene però come messa tra parentesi, respinta sui lidi lontani di una
stagione del pensiero eroica, ma tutto sommato da consegnare alla
ricerca storiografica. Il parricidio di Parmenide è già tutto qui.
Nuovi interessi si affacciano ora all’orizzonte, nuove questioni affaticano la mente dei filosofi, questioni che fanno sembrare la do-
36
114
Cfr. PLATONE, Menone, 71a ss.
manda parmenidea niente più che una sopravvivenza del passato.
Infatti l’essere è – cosa altro se no?37
Questa nuova impostazione della domanda ontologica avviata
dalla riflessione platonica non è rimasta senza conseguenze. Al seguito di Platone l’interpretazione corrente ha letto a lungo l’essere
parmenideo alla stregua di un fatto dovuto e scontato38. Con ciò è
però andata perduta la problematicità della situazione che ha originato la ricerca parmenidea. Leggendo il Poema a partire dalle sue
conclusioni, che l’essere è, l’attenzione degli interpreti si è pertanto
concentrata sull’obiettivo di mostrare la necessità di quella affermazione o di articolarne e svilupparne i contenuti.
Ma proprio in questo modo, la fatica del viaggio di Parmenide
verso la verità viene nei fatti annullata. L’ascesa alla porta del giorno
e della notte, quella porta sorvegliata da Dike, varcata la quale si
apre finalmente lo scenario del sapere, ha impegnato a fondo il giovane ricercatore di verità. Le immagini usate nel proemio del Poe ma, lo stridio delle ruote del carro che si arroventano nello sforzo di
avanzare lungo un sentiero che non si percorre senza impegno e
37 Può perciò sostenere Francesco Adorno: che Parmenide abbia parlato dell’essere come uno o come tutto è del tutto indifferente. Il problema resta quello – platonico – della reductio ad unum del molteplice, come condizione della sua pensabilità.
Perché «se ciascuna cosa è quella che è perché ha essere, tutte si riducono a un solo essere dove tutto affonda nell’unico è per sua natura tutto, nell’unico un è, per cui non
v’è che l’Uno tutt’uno, impensabile perché indiscorribile: d’esso si potrà solo dire è è è,
ossia nulla». Di qui la necessità del “parricidio”. «Bisogna, dunque, disilludersi sulla
verità della realtà quale appare, oggetto dei sensi (sensibile); bisogna cercare di cogliere
la condizione che permette l’esserci, cui si giunge mediante l’intelletto, che è oggetto
di intelletto (intelligibile); solo in tal modo si recupera l’opinione, pur rimanendo consapevoli dell’impossibilità di cogliere l’essenza delle cose e l’“essenza una” del tutto,
che resta al di là dall’uomo. Tale l’onestà di Parmenide, filosofo davvero, che pone
di fronte al “terribile” problema» (Francesco ADORNO, Da Platone a Parmenide, da
Parmenide a Platone, in «La Parola del Passato», XLIII, 1988, pp. 17, 18).
38 Per Thomas GOMPERZ (Pensatori greci, Pensatori greci, La Nuova Italia, Firenze
1962, I, p. 264) Parmenide, «vero fondatore della celebre dottrina dell’unità», non
ha fatto altro che integrare con aggiunte una teoria, quella dell’essere, che era «un
luogo comune più che secolare». Per John BURNET, Greek Philosophy, Macmillan,
London 196812, p. 53, «la grande questione è o non è? è perciò equivalente alla questione può essere pensato o no? [...] In questo modo Parmenide confuta ogni racconto
dell’origine del mondo».
115
che forse per questo non è frequentato dalla gente comune, segnalano poeticamente la novità ed insieme l’ansia di chi è deciso a dar
soddisfazione allo qumÕj, l’animo desideroso di sapienza39. E tuttavia la spinta del desiderio non è da sola sufficiente; occorre anche il
coraggio della ricerca, la forza e la volontà di mettere in discussione
e lasciarsi mettere in discussione; occorre passare la strettoia, varcare
la soglia di pietra che separa «i sentieri del Giorno e della Notte».
Il transito attraverso la porta in effetti ha tutta l’apparenza di un
simbolico gesto di non ritorno. Il giovane è pronto a diventare «uomo che sa» (e„dÒta fîta), abbandonando il sentiero dei mortali,
incapaci di elevarsi alla considerazione della verità. È solo al di là
della porta che il giovane può incontrare la Dea che, accogliendolo
con benevolenza, lo introduce nel suo regno dove si rivela la verità.
Ma, prima, il giovane deve fare ancora un’esperienza. L’urgenza
per la rivelazione della verità infatti può piegare verso approdi non
pieni ed autentici, se non si misura in tutta la sua complessa realtà e
durezza quel mondo intorno al quale si attende una notizia disvelante.
Poche parole, dalla forte valenza allusiva, richiamano questo
passaggio essenziale. Con precisione analitica all’apparenza sovrabbondante, affaticando anche in qualche misura il verso, Parmenide
indugia nella descrizione del movimento dei portali che, rimanendo sospesi nel loro aprirsi, fanno luogo ad una «profonda voragine»40. Occorre prestare la dovuta attenzione al modo di questo racconto; che non accenna tanto al fatto percettivo, che si produce allorché si passa da uno spazio relativamente chiuso ad uno aperto;
39 Fr. 1, 1-8. RUGGIU, in Commentario, op. cit., p. 181, sostiene invece che in
questi versi Parmenide racconti il viaggio di ritorno dal «luogo di tenebra […] nel
quale sono collocate le dimore della Daimon». E, a commento, aggiunge: «arduo infatti è risalire alla Luce, cioè ritornare in patria, conseguire la Luce del ritorno, la salvezza». Ma una lettura del proemio in termini di topografia mitica depotenzia di fatto lo
sforzo e la decisione sofferta del giovane nel suo viaggio verso la verità, restringendone l’impegno solo all’eventuale comunicazione agli uomini di quanto egli ha saputo conquistare. Sulle differenti letture date al proemio si veda L. COULOUBARITSIS, Mythe et philosophie chez Parménide, op. cit., pp. 86ss.
40 Fr. 1, 16-20. Nella traduzione dei termini c£sm’¢canšj (1,18: secondo Patin,
«gioco di gusto eracliteo») mi discosto dalla traduzione di Reale, che rende il testo parmenideo con «vasta apertura», mandando però perso il rimando etimologico al caos.
116
sensazione che il visitatore del sito archeologico di Velia può ancora provare attraversando la Porta Rosa41. Le parole usate da Parmenide, c£sm’¢canšj, obbligano ad altro tipo di considerazioni.
Tanto c£sma quanto ¢canšj sono infatti entrambe voci derivate
dal verbo caˆnw, che rende l’idea dell’aprirsi, dello spalancarsi di
ciò che normalmente rimane fermo e serrato; e dallo stesso verbo
prende origine anche la parola c£oj, con il significato appunto di
spazio vuoto e immenso, baratro e abisso in cui le cose sprofondano42. Ben più di semplici emozioni percettive allora si tratta. Il giovane, che di lì a poco riceverà dalla dea la rivelazione, ha dovuto
percorrere una sorta di cammino preparatorio; cammino che non
ha nulla di mistico43, lungo il quale egli ha avuto modo di sperimentare l’angoscia davanti al vuoto che si spalanca ed attira a sé. Il
rimando, insistito e rafforzato dai termini usati, al caos primigenio
non è insomma casuale. Colui che si mette in cammino verso la rivelazione non percorre dunque una via scontata e senza pericoli.
L’abisso del nulla, il rischio dello sprofondamento nel vuoto inconsistente è continuamente in agguato. E non vale distogliere lo
sguardo verso più piacevoli orizzonti. Il nulla va visto in faccia, in
tutta la sua durezza e drammaticità; solo così la rivelazione dell’essere può risplendere nella gratuità della sua luce.
41
A. CAPIZZI, op. cit., ha insistito molto sulla configurazione geomorfica dell’antica Elea, sostenendo, a supporto della sua lettura politico-istituzionale del Poema parmenideo, una interpretazione topografica del proemio. Se alcune sue intuizioni possono aiutare la comprensione del Poema, è tuttavia scarsamente plausibile la
sua interpretazione complessiva. Per non dire che la Porta Rosa è datata dagli archeologi alla fine del IV secolo a. C. (cfr. Mario NAPOLI, La ricerca archeologica di Velia,
«La Parola del Passato», CVI, 1966, pp. 191-226).
42 Cfr. il fr. 43 (4 B 43 ed. Colli; 72 Kern) di Orfeo, dove ricorre il termine
c£sma nel significato di abisso. Esiodo parla di c£sma mšga come di «luoghi penosi
e oscuri che anche gli dei hanno in odio» (Teogonia, 739-740. Cfr. anche v. 814).
Cfr. L. RUGGIU, Commentario, op. cit., pp. 192-3; Renato LAURENTI, Introduzione a
Talete Anassimandro Anassimene, Laterza, Roma-Bari 1971, pp. 20-21.
43 Almeno nel senso tutto moderno per cui il mistico per definizione identifica
una condizione dello spirito che si contrappone in via esclusiva alla considerazione
razionale. Ma in questo senso Parmenide «non è un essere ispirato; la rivelazione
prende la forma di un faccia a faccia in cui sparisce la possessione divina. Essa non reclama quindi né ispirazione né possessione, essa domanda ascolto» (Catherine COLLOBERT, L’être de Parménide ou le refus du temps, Kimé, Paris 1993, p. 43).
117
Il giovane che si presenta al cospetto della Dea, allora, non è affatto una persona che abbia per suo conto già acquisito la convinzione della necessità dell’essere e dell’infondatezza del nulla; in tal
modo, come osserva opportunamente la Collobert44, tutto il discorso della dea perderebbe indubbiamente di potenza, quasi non avesse
che da rendere esplicita una convinzione già ben consolidata45. Ben
al contrario, a vivere l’avventura privilegiata di una comunicazione
divina capace di affondare lo sguardo sulla vera natura delle cose46 è
un uomo che ha incontrato il baratro del nulla, e che pertanto è
fondamentalmente incerto sulla intima consistenza delle cose. La
via da lui percorsa, lontana dal sentiero degli uomini, è così quella
che lo ha condotto a fare esperienza del limite nientificante e destabilizzante, condizione di un’esperienza autentica dell’essere che
non muta47. Solo così l’affermazione dell’essere diventa una conquista che fa iniziare – e non concludere. Dire dell’essere che è, allora,
44 C. COLLOBERT, ivi, p. 39. La studiosa però è indotta a tale giusta osservazione
dalla difficoltà che a lei sembra di trovare nella traduzione usuale di e„dÒta fîta come “l’uomo che sa”; perché, ella osserva, «se il protagonista è già detentore del sapere,
la rivelazione diventa inutile». Propone perciò di tradurre la seconda parte del frammento 1, 3 in questo modo: la via, «laquelle emporte l’homme en le rendant savant»
(ivi, p. 40). La difficoltà tuttavia può essere diversamente risolta, facendo dei primi versi del proemio il racconto del viaggio effettuato dal giovane una volta ritornato dalle
porte di Dike. Quello che in ogni caso deve essere tenuto fermo è comunque che a
rendere necessaria la rivelazione della dea non è il fatto che l’essere sia ignoto, quanto
piuttosto che su di esso, e non sul nulla, deve cadere la scelta dell’uomo.
45 Non è perciò un caso che nelle letture degli interpreti il fatto che il Poema di
Parmenide consista di un unico grande discorso della dea mentre il giovane resti silenzioso all’ascolto venga sostanzialmente trascurato a vantaggio del contenuto “razionale” del discorso stesso. UNTERSTEINER, op. cit., p. LXXX, arriva a «supporre un
gruppo di versi», andati perduti, tra fr. 1,32 e 2,1, pur di dare la parola nella rivelazione della verità a Parmenide, essendo per lui evidente che «volontà divina e cosmica e volontà umana coincidono sullo specifico terreno della conoscenza» (ivi, p. LXI).
A richiamare con decisione l’attenzione sul fatto che il vero soggetto della rivelazione della verità è la divinità è invece Jaap Mansfeld nel lavoro già citato (soprattutto
nel cap. IV intitolato Die Offenbarung, pp. 222-273).
46 «Bisogna che tu tutto apprenda: … » (fr. 1,28 ss.).
47 In un diverso contesto letterario, l’esperienza di Parmenide presenta forti tratti
di similitudine con quella di Giobbe, il personaggio biblico provato nel corpo e nello spirito, costretto dalla potenza dirompente del male e della sofferenza a riconoscere la vacuità delle risorse materiali, su cui finora aveva fondato la sua vita, e persino
l’impotenza della sua immagine del divino, prima di accedere all’esperienza autenti-
118
non è vuota tautologia, ma posizione di un fondamento saldo; è
imparare a riconoscere il «solido cuore della Verità ben rotonda»48,
il nucleo, che niente può sconvolgere o far agitare (¢tremšj), del
principio che si offre nella sua perfetta figurazione. A partire dal
quale solamente si avvia l’edificazione del discorso vero che caccia
lontano e respinge via da sé ogni incertezza circa l’intima struttura
del reale49.
L’essere come stabilità
Abbiamo ora finalmente a disposizione gli elementi per poter
tentare la chiarificazione del significato dell’essere parmenideo. Al
seguito del giovane nel suo viaggio di avvicinamento alla Verità ci
si è fatto palese che lo svelamento del fondamento, che in quanto
fondamento è destinato a rimanere pur sempre nascosto oltre ogni
possibile piena acquisizione da parte dell’uomo, richiede un essenziale previo tirocinio. Si dà infatti un vero e proprio noviziato della
verità, la quale può essere accolta solo da chi ne abbia sentito tutto il
desiderio e l’urgenza, assieme al vuoto della sua assenza. È al ricercatore della verità che questa si rivela.
L’osservazione merita di essere sottolineata, in quanto riafferma
che non possono darsi divaricazioni né cesure tra il percorso di acca di Dio, che si rivela nella sua maestà inaccessibile eppure misteriosamente vicina.
Talché solo dopo l’esperienza della tremenda potenza divina Giobbe può dire di conoscere Dio non più per sentito dire ma come è veramente. «Allora Giobbe rispose
al Signore e disse: Comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per
te. Chi è colui che, senza aver scienza, può oscurare il tuo consiglio? Ho esposto
dunque senza discernimento cose troppo superiori a me, che io non comprendo.
“Ascoltami e io parlerò, io t’interrogherò e tu istruiscimi”. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Perciò mi ricredo e ne provo pentimento sopra polvere e cenere.» (Gb, 42, 1-6).
48 Fr. 1,29.
49 «Poiché nascita e morte sono state cacciate lontane e le respinse una vera certezza» (8,27-8). Si noti bene: ciò che respinge definitivamente (¢pîse, all’aoristo,
tempo del compimento) nascita e morte è una p…stij ¢leq»j, un qualcosa di affidabile nel suo rivelarsi, e non già la conclusione necessaria di un logico ragionamento.
È la stessa certezza, che costituisce il più forte motivo di censura delle brotîn dÒxaj
da parte della Dea (1,30). Più oltre vedremo quali considerazioni possano essere tratte da tutto questo.
119
cesso alla verità e la manifestazione di questa50. Chi riceve la rivelazione della verità è precisamente colui che ha dovuto decidere di
farsi condurre al soglio della Dea che «tiene le chiavi che aprono e
chiudono»51 ed alla quale appartiene la via stessa52, rompendo con
ciò i legami con il comune modo di pensare53. Il discorso della Dea
incontra pienamente il desiderio del giovane; e la rivelazione della
verità, che ha il suo cuore nell’affermazione ontologica originaria
che pone l’essere, è la risposta ai turbamenti teoretici dell’uomo in
ricerca. Al di là delle fattuali continue oscillazioni delle parti che
compongono il tutto dell’esperienza, che farebbero pensare ad un
debole od anche del tutto evanescente ancoraggio delle cose, queste ultime trovano il loro fondamento di verità nell’essere, che si rivela così come autentica provvista di senso e stabile determinazione
capace di garantire il valore e l’affidabilità stessa delle singole realtà
mondane, per se stesse bisognose di sostegno. Le cose dunque sono,
50 «Il soggetto di œstin è la stessa ÐdÕj diz»sioj» (M. UNTESTEINER, op. cit.,
p. LXXXVI). A dispetto tuttavia delle intenzioni proclamate circa l’unitarietà del poema di Parmenide, nelle letture degli interpreti poi spesso si produce una sottile scissione tra il viaggio e il contenuto della rivelazione, quasi fossero esperienze diverse
tra loro del tutto irrelate. È noto come la salutare reazione alla lettura allegorico-simbolica del proemio, avviata dalla parafrasi di Sesto Empirico, abbia prodotto un rinnovato interesse verso il viaggio di Parmenide descritto nel lungo frammento 1.
(Come sempre efficacemente, riassume le differenti letture della natura del viaggio
descritto nel proemio Giovanni REALE nella sua nota Questioni concernenti l’interpretazione del poema e del pensiero di Parmenide suscitate dalla recente critica e non messe a tema
dallo Zeller, in ZELLER-REALE, op. cit., pp. 323-334). E tuttavia, nonostante l’evidente continuità dei frammenti 1 e 2, rimane negli interpreti una sorta di ritrosia a
trarne le dovute conseguenze. La discussione della concezione ontologica parmenidea così finisce per prescindere completamente dalla propedeutica esperienziale-esistenziale costituita dal viaggio verso la rivelazione dell’essere. È questo, come vedremo fra poco, il caso della lettura di Calogero. Il forte legame tra il viaggio e la comunicazione della verità, così come sopra evidenziato, non è colto fino in fondo neppure nel commento di Ruggiu, che coglie peraltro i numerosi motivi mitici del
viaggio stesso (cfr. L. RUGGIU, Parmenide, op. cit.).
51 Fr. 1, 14.
52 La ÐdÕj polÚfemoj, la via che dice molte cose, infatti, «appartiene alla divinità» (1, 2-3). Sull’analisi del verso è utile la lettura di Nestor-Louis CORDERO, Le vers
1,3 de Parménide. La déesse conduit á l’égard de tout, «Revue Philosophique de la France et de L’Étranger», 1982, pp. 159-179.
53 Il cammino che il giovane ha percorso è infatti «fuori dalla via battuta dagli
uomini» (fr.1, 24-28).
120
permangono nel loro divenire che le rende mutevoli ed instabili; su
di esse si può contare nel contesto della vita quotidiana. Un nome
nuovo, che appella il tutto nella sua intima costituzione, è ora disponibile: tÕ ™Õn, la totalità di ciò che è, il tutto che possiede la sicura determinazione della stabilità, l’essere54. E t¦ ™Õnta, le cose
che sono, possono essere chiamate le singole emergenze del tutto;
cose che sono, perché anch’esse godono della medesima fondamentale caratteristica, che ne assicura solidità, pur nel mutamento delle
condizioni d’esistenza55.
È pertanto solo nella tensione unitaria che pervade l’intero poema, fin dal suo proemio, che va collocato il luogo ermeneutico
del messaggio ontologico parmenideo; che corre invece il rischio
di essere sostanzialmente dislocato e quindi colto sì, ma non nella
sua pienezza, laddove esso venga disgiunto dal percorso della sua
recezione (e, come vedremo più avanti, dal fatto che sia il contenuto di una rivelazione); quasi fosse un algido algoritmo che non
impegna alcuna decisione esistenziale. La propedeutica alla verità è
tanto essenziale quanto l’ascolto del contenuto della verità medesima; e la prima illumina nel suo autentico significato la seconda.
Un tale approccio metodico fa risaltare nella sua valenza più
forte l’affermazione ontologica del filosofo di Elea. Che, proprio
per questo, ha avuto la forza di imporsi come via maestra della fi54 Non è per niente strano, perciò, che nel corso del lungo frammento 8, dedicato all’analisi dei segni dell’™Õn, la Dea paragoni l’essere ad una sfera che, uguale da
ogni parte, in modo uguale sta nei suoi confini (8, 43.49). Afferma O’BRIEN, Introduction,
op. cit., p. 229: «dato che si afferma “è” (cfr. fr. 2,3), non consegue, per la dea, non
solo che si concepisce l’“essere”/l’“essente”, ma anche che si può affermare di questo “essente” che “è” (cfr. fr. 6,1-2)?». In tal modo la Dea, «dalla semplice affermazione dell’esistenza: “è” (2,3; cfr. fr. 8,2), è passata ad una affermazione dell’esistenza
dell’“essere” (cfr. fr. 6,1)».
55 In questo modo appare evidente anche l’unitarietà del poema. La seconda parte del Poema, dedicata alla doxa, lungi dall’essere espressione verosimile o una sorta di
simulazione, od anche dall’avere esclusivamente intento polemico verso altri pensatori, è invece indicazione di come vada ricompresso precisamente quell’oscillare, il
divenire delle cose, «senza che in questo venga ammesso come principio il nulla e
senza che il nulla entri come fondamento di spiegazione sia della genesi di qualcosa
sia nella costituzione attuale della cosa» (L. RUGGIU, Commentario, op. cit., p. 326.
Un ampio riassunto delle differenti letture lo offre REALE nella Nota sulle interpretazioni della dÒxa parmenidea, in ZELLER-REALE, op. cit., pp. 292-319).
121
losofia occidentale. Parmenide insomma non ci vuol solo comunicare che sia possibile una conoscenza vera, cioè adeguata, del
mondo56. E nemmeno solo che il mondo che abitiamo e di cui
parliamo esiste realmente e non è un sogno57. Non appartiene alla
mentalità arcaica una simile forma di ragionamento, che assume
valore solamente nel contesto della moderna ipertrofia di un
soggetto pensante autoreferenziale. Per Parmenide prima di tutto
ciò si tratta anzitutto di capire se il mondo dato sia affidabile, se
esso regga all’assalto della consumazione temporale che pare annichilire tutto. Ma l’essere è; le cose resistono perché sono fondate
sull’essere: questa è la buona notizia che la Dea comunica al giovane.
Ad essere rigorosi, dunque, la questione è quella della possibilità di usare per le cose il verbo essere, di dire delle cose che sono,
di chiamarle enti. Ciò che è in gioco è la questione della fondatezza delle cose, che senza ogni ombra di dubbio si danno e che
noi incontriamo nel commercio quotidiano; si tratta insomma di
capire se lo sfondo da cui le cose emergono e che le sostiene sia
uno sfondo saldo, o se esso stesso scivoli nel vuoto di una inconsistenza senza fine che, come un flutto, solleva le cose solo per farle
sprofondare irrimediabilmente e senza nessuna speranza. La risposta della Dea ci conforta. Resta però ancora da capire come venga
argomentata e quali ragioni vengano addotte a suo favore. Per
sciogliere questo ultimo nodo è tempo allora che affrontiamo il
passaggio cruciale del frammento 2.
56
Come nelle letture dell’essere come provvisto di valore logico-linguistico
(cfr. C. H. KAHN, op. cit.).
57 Come nelle letture esistenziali dell’essere (cfr. Gwilym Ellis Lane OWEN, Eleatic Questions, «Classical Quarterly», 10, 1960, pp. 84-102). Per la discussione di dette ipotesi, che peraltro si elidono vicendevolmente, si vedano le osservazioni di Denis O’BRIEN, in Introduction, op. cit., pp. 262-277 e pp. 187-215.
122
B. Il bivio come luogo della decisione per l’essere
Bisogna che tu tutto apprenda:
e il solido cuore della Verità ben rotonda
e le opinioni dei mortali, nelle quali non c’è una vera certezza.
Eppure anche questo imparerai: come le cose che appaiono
bisognava che veramente fossero, essendo tutte in ogni senso (1,28-32).
Con queste parole, che costituiscono vera croce di tutte le interpretazioni, inizia propriamente la rivelazione della Dea. Non c’è
dubbio, e gli interpreti lo hanno colto chiaramente, che le parole
della Dea hanno tutto il tono e l’aspetto di una dichiarazione programmatica58. Dopo il saluto di accoglienza (vv. 24-28), la Dea infatti entra subito nel vivo della questione e senza troppi giri di parole annuncia al giovane ricercatore il cammino che lo attende verso
la verità. Niente, nemmeno gli eventuali erramenti della consuetudine umana, dovrà rimanere precluso al suo sguardo desideroso di
58
Cfr. L. RUGGIU, Commentario, op. cit., p. 194. La difficoltà del brano stanno
tutte nella definizione della lezione autentica di v. 32 e della sua conseguente interpretazione. In particolare, se la vecchia lettura di DIELS dokimws’[ai] eänai (Parmenides Lehrgedichte, Reimer, Berlin 1897, pp. 58-59), ripresa da Untersteiner (op. cit.,
p. CLXVIII, n. 7), può dirsi superata, più complesso è stabilire la parte finale del verso.
La lezione seguita da Reale sopra riportata (p£nta per Ônta) è ritenuta da altri
(N.-L. CORDERO, Les deux chemins de Parménide, op. cit., p. 201; O’BRIEN, Notes sur
la traduction, in P. AUBENQUE (ed.), Études sur Parménide, op. cit., I, p. 14) non autentica; ad essa viene preferita la lezione p£nta perînta riportata dal solo manoscritto
A di Simplicio, la fonte dei versi che stiamo analizzando. Traducono pertanto:
«comme il aura été nécessaire que les opinions existent réellement, en embrassant tout incessamment» (N.-L. CORDERO, ivi, p. 36), «comment il faudrait que les apparences fussent réellement, traversant toutes choses dans leur totalité» (J. FRÈRE D. O’BRIEN, Le poème de Parménide, in P. AUBENQUE (ed.), Études sur Parménide,
op. cit., I, p. 8). Remi BRAGUE, (La vraisemblance du faux. Parménide fr. 1, 31-32, ivi,
II, p. 58), ha proposto una correzione congetturale delle due ultime parole in
panq’aper onta, traducendo: «comment il fallait que les apparences (les réalités)
fussent de façon acceptable, à tous points de vue, comme les réalités (intelligibles)».
In ogni caso, sembra evidente che la lettura dei versi in questione dipende fortemente dall’interpretazione complessiva che si dà del pensiero di Parmenide. Ricostruisce
«le peripezie della scoperta di questi frammenti [di Parmenide] e dei tentativi di ricostituzione del testo di Parmenide» Nestor-Louis CORDERO nel saggio L’histoire du
texte de Parménide (ivi, II, pp. 3-24).
123
sapere; non le fragili certezze dell’opinione dei più59, non le sfuggenti apparenze. Il sapere, che farà del giovane un illuminato60, non
può dimorare veramente nella mera conoscenza positiva del reale,
ma richiede una più decisa e consapevole adesione alla verità, che
sola è capace di raddrizzare i sentieri contorti dell’umano sviamento; lungo i quali invece si confonde essere con il non-essere61 e il
vero significato dell’apparire dell’essere negli enti viene distorto in
mera parvenza. Il sapere, la sof…a, insomma, non si identifica semplicemente con un qualsivoglia contenuto cognitivo né è risultato
di una logica argomentazione, ma è lotta, conquista; che non esenta
affatto, anzi impone la valutazione delle possibilità date e la decisione tra di esse.
Il processo di apprendimento della verità si gioca dunque nella
dimensione della totalità. Alla verità niente è propriamente estraneo; anche l’opposto, l’errore, si lascia riconoscere nella sua cattiva
posizione solo in relazione ad essa, ne costituisce per così dire il lato
59 Parmenide li qualifica come “mortali”, brwtoˆ, che nel linguaggio omerico
designa, in opposizione alla natura divina che conosce la verità, gli uomini nel limite
della loro determinatezza temporale e cognitiva. Alle loro opinioni, perciò, non può
essere assegnata alcuna affidabilità capace di rendere presente la verità dell’essere. Le
loro sono solo brotîn dÒxai, nelle quali non si dà p…stij ¢lhq»j.
60 Non va trascurato che la parola usata da Parmenide per definire l’uomo che sa
è fîta, che deriva da fîj, luce.
61 Sono ancora brwtoˆ coloro che «vanno errando, uomini a due teste … dai
quali essere e non-essere sono considerati la medesima cosa e non la medesima cosa»
(fr. 6, 5-9). Pertanto essi sono persone che «nulla sanno» (e„dÒtej oÙdšn), cui manca
ogni capacità di sapersi decidere per l’essere, ¥krita fàla. Così infatti, gente «dem
es an jeder Unterscheidung fehlt» - come fa Karl REINHARDT (op. cit., p. 35), seguito da Pilo ALBERTELLI («gente che non sa decidersi»: I Presocratici. Testimonianze e
frammenti, Laterza, Roma-Bari 1979, I, p. 273), Guido CALOGERO («massa che non
si decide né per il sì né per il no»: Parmenide, op. cit., p. 159), Jean BEAUFRET («foules indécises»: Le Poème de Parménide, op. cit., 1955, p. 81), Angelo PASQUINELLI
(«gente indecisa»: I Presocratici, Einaudi, Torino 1958, p. 230) e recentemente anche
Jean FRÈRE - Denis O’BRIEN («foules incapables de décider»: Le Poème de Parménide, op. cit., p. 25) - più che «razza di uomini senza giudizio» – come fanno Giovanni
Reale (p. 95) e molti altri, tra cui John BURNET («undiscerning crowds»: Early Greek Philosophy, Black, London-Edinburgh 1892, p. 174), Nestor-Louis CORDERO
(«gens sans faculté de jugement»: Le deux chemins de Parménide, op. cit., p. 37), Mario
UNTERSTEINER («gente incapace di giudizio»: op. cit., p. 135) - andrebbe tradotto il
termine ¥krita.
124
decettivo62. La verità, in altri termini, si afferma come criterio di
giudizio che orienta la decisione. Ma la verità non consiste nel calcolo razionale che pone dei risultati ottenuti per logica deduzione;
la verità è ¢lhqe…a, svelamento del fondo nascosto che solo una
comunicazione autorevole può rendere manifesto. Non rientra
dunque nelle disponibilità dell’uomo, neppure dell’uomo che si allontana dal sentiero dei mortali per ricercarla. Essa può essere solo
accolta, non prodotta63. È dalla verità che va dunque ricavata la
chiave del discernimento sapienziale cui è condotto il giovane.
Questo adesso è ciò che attendiamo dalla rivelazione della Dea. E la
Dea non lascia senza risposta questa nostra esigenza64.
Con il tratto sicuro di chi detiene il possesso della verità, la Dea
guida infatti il giovane al cospetto del luogo in cui sta per manifestarsi la possibilità dell’apertura (ma anche del nascondimento) del
reale nella sua autentica strutturazione.
Orbene, io ti dirò – e tu ascolta e ricevi la mia parola –
quali sono le vie di ricerca che sole si possono pensare (2, 1-2).
62 Decettivo, ovviamente, solo in relazione al fraintendimento dei mortali, non
già in sé. Il tratto della totalità è stato molto ben sottolineato da Luigi RUGGIU
(Commentario, op. cit., p. 195), che scrive: «il carattere di totalità è coessenziale alla
natura della Verità. La totalità abbraccia non solo l’orizzonte totale dei contenuti veritativi, ma anche l’esposizione e la negazione dell’errore. Occorre che il kouros proceda a una krisis, a un giudizio che deve necessariamente fondarsi sulla conoscenza di
tutte le ragioni». Solo che poi Ruggiu ritiene che il giudizio derivi da una logica necessità, in quanto «non esiste dunque in Parmenide che una sola via, quella dell’Essere» (p. 198). Viene così meno la radicalità della decisione stessa, come vedremo più
oltre. Soltanto dopo tale decisione – e non già prima, avendo la Dea escluso la praticabilità di altri sentieri, rimane unica la via dell’Essere (fr. 8,1: «Resta solo un discorso
(màqoj) della via: che “è”»).
63 La sezione successiva avrà cura di motivare le affermazioni.
64 Mario UNTERSTEINER (op. cit., p. LXXX), ha avanzato l’ipotesi che sia Parmenide, e non la dea, a parlare rivolgendosi ad un suo discepolo. Ma oltre che non
necessaria, come commenta Leonardo TARÀN (Parmenides, op. cit., p. 32), questa
ipotesi non cambia la questione. Ciò che conta infatti è che Parmenide da solo non
avrebbe potuto costruire il discorso, come implicitamente riconosce lo stesso Untersteiner quando afferma che Parmenide avrebbe «rivelato come proprio verbo la verità della dea ormai immedesimata nel suo spirito».
125
Quella che si spalanca davanti al filosofo è la biforcazione che
costituisce l’alternativa radicale di senso; un’alternativa che per la
sua stessa radicalità impone una scelta, non tollera mediazioni, non
accetta rinvii. Si genera in tal modo uno spazio per la krisis; Parmenide è come messo di fronte ad un bivio, che lo obbliga a scegliere.
Due, come preciseranno i versi immediatamente successivi, sono le
vie che egli ha davanti65:
l’una che «è» e che non è possibile che non sia
– è il sentiero della Persuasione, perché tien dietro alla Verità –
l’altra che «non è» e che è necessario che non sia.
E io ti dico che questo è un sentiero su cui nulla si apprende.
Infatti, non potresti conoscere ciò che non è, perché non è cosa fattibile,
né potresti esprimerlo. (2, 3-8)
È importante non perdere di vista proprio ora, in questo punto
topico, l’approccio metodico che abbiamo sopra sostenuto, quello
cioè di non presupporre nulla degli sviluppi successivi dell’esperienza del giovane, ma di seguire passo dopo passo Parmenide nel
suo itinerario verso la verità. Se rinunciamo allora a ricercare, in ciò
che è ancora tutto da definire e da trovare, quanto ci attendiamo di
apprendere e già sappiamo66, e, seguendo l’invito della Dea, ci
prendiamo cura della parola che abbiamo da lei ascoltato, potremo
facilmente osservare come quelle che la Dea presenta come possibi65 Due, e non più, sono le vie. Riprenderemo la questione del numero delle vie
più avanti.
66 Non è proprio questo invece l’asse prospettico adottato nell’interpretazione
corrente del Poema di Parmenide? Proiettando l’ombra dell’argomentazione logica
con la quale la Dea rintraccia e definisce i caratteri che definiscono l’essere (fr. 8) –
ragionamento però che si sviluppa proprio a partire decisione originaria che afferma
l’essere e nega il non essere – sul momento di questa decisione stessa, si cerca così di
trovare una giustificazione logica della scelta tra le due vie. Visto insomma che i segni che si incontrano sulla via dell’essere danno ampia conferma della praticabilità e
della convenienza del percorso scelto, il giovane non poteva che scegliere questa via
e rigettare l’altra. Dove non è chi non veda l’inversione del procedimento logico ed
anche temporale. L’opzione tra possibilità alternative e non prevedibili non può venir motivata o garantita da nessun riferimento a quanto verrà a prodursi a seguito
della scelta medesima. Il criterio ermeneutico del rispetto dello svolgimento del discorso vale perciò in generale, e non riguarda solo la questione del soggetto logico di
fr. 2, 3. 5, a proposito del quale è frequentemente invocata.
126
lità ulteriori del cammino (la via lungo la quale si afferma l’essere e
quella nella quale in sua vece si pone il non essere67) costituiscono
tutt’altro che una retorica costruzione, apparecchiata per compiacere il giovane nella sua ricerca e dar soddisfazione al suo desiderio di
appropriazione della verità. Quasi che la Dea, come le Muse di
Esiodo68, mantenesse per sé la possibilità di ingannare, volendo, il
giovane69. No, le possibili vie sono tutte e due lì, aperte davanti al
giovane, che al loro cospetto non trova motivo alcuno di preferenza tra di esse. E se mai potessero esser fatti valere degli indizi previi,
questi sembrerebbero deporre piuttosto in favore della convenienza
della via del non essere; l’avventura del viaggio e l’attraversamento
della soglia di pietra della porta di Dike ha portato il giovane, come
abbiamo visto, a fare l’esperienza della fragilità ontologica del reale
ed a dubitare fortemente della fiducia che può essere a questo pre-
67 O dovremmo dire: si nega l’essere? Ma la Dea non sta sviluppando un modello logico di alternativa, che oppone un’affermazione alla sua negazione. Se fosse così,
la lettura di Severino sarebbe inconfutabile. Non di opposizione logica, dunque, si
tratta ma di concrete possibilità, entrambe di fatto esperibili e praticabili, come più
avanti la Dea stessa richiamerà, denunciando l’erroneo errare dei mortali (fr. 6 e 7).
Non è affatto vero che la seconda delle vie, quella dove il non essere è posto come
orizzonte metafisico abissale, sia assolutamente inaccessibile. Su di essa, al contrario,
è possibile incontrare numerose persone, tutti coloro che seguono una mente errante (plaktÕn nÒon: 6, 6) perché priva delle dovute risorse (è l’¢mhcan…h di fr. 6,5),
incapace di difendersi dal bombardamento dei sensi che continuano a proclamare il
continuo cambiamento ed esaurimento di cose di cui pure si afferma la presenza (fr.
7). Insomma, non: due sono le vie perché Parmenide ha trovato la formula della
contraddizione logica che tra due possibilità opposte ammette solo l’adozione di uno
ed il rifiuto dell’altro corno del dilemma, dal momento che non si dà la possibilità di
un terzo (cfr. Luigi RUGGIU, Commentario, op. cit., p. 212) ma, al contrario: l’opposizione reale tra le due vie, tra le quali occorre scegliere, impone al pensiero di adeguare il suo logico costrutto ed abbandonare ogni tentativo di maldestro compromesso tra opzioni reciprocamente intolleranti.
68 «Noi sappiamo dire molte menzogne simili al vero, ma sappiamo anche,
quando vogliamo, il vero cantare» (ESIODO, Teogonia, vv. 27-28).
69 Denis O’BRIEN (Introduction, op. cit., p. 155), con riferimento all’interpretazione proposta da Charles H. KAHN in The Thesis of Parmenides («The Review of
Metaphysics», 1968, pp. 700-724), secondo la quale«la Dea avrebbe proposto uno
scopo che ella sapeva sin dall’inizio impossibile da conseguire», osserva polemicamente che in questo caso bisognerebbe parlare addirittura di «malafede» della Dea.
127
stata70. Egli dunque è nella condizione di carenza propria della stirpe
dei mortali, obbligati da una impotenza originaria (l’¢mhcan…h di
fr. 6,5) a dover attendere dalla parola rivelatrice della Dea gli orientamenti del cammino.
Preoccupati di individuare il riferimento polemico della pungente critica parmenidea71, gli interpreti generalmente hanno dedicato
scarsa attenzione al fatto che la condizione di mortale è la condizione
ordinaria e naturale che appartiene in proprio all’umanità. Nella
mentalità arcaica infatti brotoˆ sono quanti, esclusi dal dono dell’immortalità, che spetta esclusivamente agli dei, patiscono il limite del
tempo e soffrono il suo dominio sulle cose. Lontani dal potere sulla
vita, essi pertanto sono lontani anche dal vero sapere. Nulla sanno
(e„dÒtej oÙdšn72) e, privi di veri riferimenti, non possono che affidarsi alla guida incerta dell’esperienza. A tale condizione originaria
non sembra sfuggire neanche il giovane che giunge alle porte di Dike; non infatti da solo per propria virtù, quasi fosse depositario di un
proprio sapere essenziale, ma soltanto in quanto «compagno di immortali guidatrici», le Eliadi figlie del Sole, egli ha potuto compiere il
viaggio verso la rivelazione del tutto; è un privilegio a lui accordato
dalla stessa Dea che va ad introdurlo al segreto dell’essere, privilegio
che lo farà diventare un e„dÒta fîta73. La comunicazione di verità
da parte della Dea pertanto si conferma come opportunità in nulla
70 Non è senza significato che qui e più avanti, fino a che l’affermazione dell’essere
non si sia consolidata nella mente del giovane al punto da consentirgli di seguire con la
sua ragione le prove a conferma della giustezza della scelta fatta (fr. 7, 5–6 e fr. 8, 1-49),
la Dea più che motivare la verità della via dell’essere si preoccupi di contestare la falsità
di quella opposta.
71 La critica ha a lungo discusso circa la possibilità di individuare un riferimento
polemico dei frammenti 6 e 7 in Eraclito, i pitagorici, e persino Anassimandro. Per un
primo essenziale approccio alla questione si veda la nota di Giovanni REALE, La questione dei rapporti fra Parmenide ed Eraclito, in ZELLER-REALE, op. cit., pp. 173-183.
72 Fr. 6,4. Sulla locuzione e„dÒtej oÙdšn cfr. Jaap MANSFELD, op. cit., pp. 4 ss.
73 «O giovane, tu che, compagno [sun£oroj] di immortali guidatrici, con le cavalle che ti portano giungi alla nostra dimora, rallegrati, poiché non un’infausta sorte ti
ha condotto a percorrere questo cammino – infatti esso è fuori dalla via battuta dagli
uomini –, ma legge divina e giustizia» (fr. 1, 24-28). Non sembra inutile osservare che
sun£oroj, che contiene nel sÚn l’idea della inseparabilità (cfr. OMERO, Odissea, 8,
99), è voce composta dal verbo a‡rw, che ha in sé l’idea del portare in alto, elevare,
sollevare (come fanno, mettendolo sul carro, Achille e i suoi compagni col corpo di
Ettore – cfr. OMERO, Iliade, 24, 590).
128
accessoria od anche accidentale; ben al contrario essa si precisa come
condizione sostanziale e necessaria per l’accesso alla verità.
A maggior ragione se si considera che detta comunicazione, peraltro, non consiste nella formalizzazione logica di un vissuto umano già dato ma non saputo74, quanto piuttosto nello svelamento del
fondo nascosto del reale. È il motivo questo per cui la Dea non si limita ad indicare e tratteggiare nelle loro tonalità essenziali le vie
percorribili, ma consegna al giovane anche preziosi strumenti valutativi per la scelta tra di esse.
La “via che è”, così, è qualificata come «il sentiero della persuasione», la strada maestra, vale a dire, lungo la quale può realizzarsi l’incontro che convince ed avvicina alla comprensione autentica della realtà nel suo valore. Interessante è la motivazione:
essa segue la verità (2,4). Camminando dunque questo sentiero il
giovane potrà raggiungere la meta agognata. Siffatta dunque è la
prospettiva che va seguita, perché soltanto nella prospettiva della
verità può esser posta con ogni diritto l’azione di ricerca della sapienza. L’altra, invece, la “via che non è”75 è proibita al giovane.
Non che sia di per sé non percorribile, ma non va percorsa da chi
vuole la verità, perché su di essa nulla si può apprendere. La scena
che si presenta al giovane, insomma, è quella di una duplice possibilità che obbliga alla decisione; egli si trova di fronte al bivio, in
74
Come sembra pensare Guido CALOGERO, Studi sull’eleatismo, op. cit.
prestare attenzione, qui come nel caso precedente, a non intendere il
che come un pronome relativo, trasformando di fatto le due proposizioni in due relative affermanti rispettivamente l’esistenza e la non esistenza della via. Avremmo allora la via, la quale è e la via, la quale non è: «da una parte quella che, in qualche modo,
c’è e che, peraltro, non è non essere […] dall’altra quella che, così come non c’è, così
è altrettanto necessario che non sia». Così Enrico MOSCARELLI in PARMENIDE DI
ELEA, Della Natura, Supplemento a Porta di Massa. Laboratorio Autogestito di Filosofia
Epistemologia e Scienze Politico-Sociali autunno 2005/inverno 2006, p. 26. Moscarelli
numera come terzo il fr. 2 DK, la cui traduzione ha il merito di rendere esplicito
quanto in molti interpreti resta invece nascosto. In realtà Ópwj e æj sono congiunzioni dichiarative che reggono il verbo caratterizzante la via, œstin e oÙk ™st…n.
Come osserva opportunamente Guido CALOGERO (Parmenide, op. cit., p. 156), «æj
e Ópwj e simili, in funzione enunciativa, equivalgono di fatto a due punti dopo un’implicita idea di pensare-dire». È e non è sono dunque i nomi delle vie: la via dove
regna indefettibilmente l’essere, e l’altra dove regna necessariamente il non essere.
Nella prima si parla solo in termini di è; nell’altra, di non è.
75 Occorre
129
cui la biforcazione delle vie diventa metafora dell’opzione fondamentale con la quale incontrare la realtà, una opzione per la quale
però nulla finora è dato che possa indicare l’esito.
Ma la semplice struttura logica dell’argomentazione della Dea
non racchiude già in sé tutti gli elementi di una valutazione? Non
è sufficiente osservare che le due vie sono in opposizione logica
per motivare la consequenzialità della scelta della “via che è”? e
come pensare di poter percorrere la “via che non è” se essa, appunto, non è? Puntiamo con queste domande al cuore della lettura del poema di Parmenide che veniamo proponendo, e che vuol
far risaltare, con la sottolineatura della formale indecidibilità nella
definizione del principio della ricerca della sapienza, la necessità
del ricorso alla parola autorevole della Dea. A differenza di quanto
appartiene alla convinzione comune della gran parte degli interpreti, che invece sostiene la logica deducibilità dell’opzione ontologica affermata da Parmenide, a nostro avviso le domande sopra
avanzate hanno risposta tutta negativa. Con la questione che tali
domande pongono, quella vale a dire della ovvietà dell’affermazione dell’essere, dobbiamo pertanto confrontarci, prima di proseguire nella nostra analisi.
Impensabilità del non essere?
«Esiste una stretta correlazione tra l’ontologia parmenidea e la
forma logica nella quale l’ontologia si rappresenta. Il criterio di
fondo è dato dalla stessa pensabilità-dicibilità: ciò che è pensabile è
per ciò stesso reale, e ciò che è reale è per ciò stesso pensabile.
[…] Perciò essere e pensiero sono lo stesso: due in uno. Pensiero
ed Essere sono il medesimo. Una volta posta l’esclusione reciproca
di Essere e nulla, la necessità porta a costruire ogni ragionamento
nella forma proposizionale della esclusione: “o… o…”. »76.
76
130
Luigi RUGGIU, Commentario, op. cit., pp. 50-51.
Se prescindiamo per un momento dal tratto nemmeno troppo
velatamente idealistico del discorso, il ragionamento di Ruggiu77
sembra svolgere una considerazione che non può non apparire
ineccepibile e per alcuni versi anche inevitabile. Solo l’essere può
venire pensato. Il non essere perciò non può essere fatto oggetto di
pensiero, in quanto non è. Che è precisamente quello che sostiene
la Dea:
Infatti, non potresti conoscere ciò che non è, perché non è cosa fattibile,
né potresti esprimerlo.
Perché non è possibile né dire né pensare che non è 78.
Dunque
nient’altro o è o sarà all’infuori dell’essere79.
La conclusione si impone pertanto per via di logica deduzione.
È la forza del pensiero, che scopre così la struttura della non-contraddittorietà che lo anima, riflesso dell’opposizione reale tra le due
vie, a costringere il giovane a seguire l’unica opzione veramente
percorribile, vale a dire la via che è. L’altra, infatti, la via che non è,
è impensabile appunto perché non esiste. Ancora una volta la Dea
sembra venire in aiuto dal momento che ribadisce esattamente la
medesima cosa:
… La decisione intorno a tali cose sta in questo
“è” o “non è”. Si è quindi deciso, come è necessario,
77
Ruggiu fa evidente riferimento al fr. 3: ... tÕ g¦r aÙtÕ noe‹n ™st…n te ka„
eänai. Ma noeÝn significa lo stesso che das Denken? Osserva giustamente Hans-Georg
GADAMER, Parmenide, ovvero l’aldiquà dell’essere in Scritti su Parmenide, Filema, Napoli 2002, p. 76, che nel poema noeÝn significa «senz’altro non “pensare”, o addirittura
“pensare” in contrapposizione al vedere del “dato in carne ed ossa” (per dirla con
Husserl). Non si tratta di quel che si può pensare. Non è una mera pensabilità quel
che il poema intende. È già meglio, poiché non occulta completamente le intenzioni di Parmenide, rendere noèin con “riconoscere”; vi appartiene almeno l’essere del
riconosciuto, il suo esser reale e vero» (Sul significato di noe‹n-noàj nell’uso arcaico
si può utilmente consultare Kurt VON FRITZ, Nous, noein and their derivates in Pre-socratic philosophy. I: from beginnings to Parmenides. II: the Post-Parmenidean Period, Classical Philology, 1945, n. 40, pp. 223-242; n. 41, pp. 12-34).
78 Fr. 2, 7-8; 8, 8-9. Si può aggiungere ancora il riferimento a fr. 6, 1-2: «È necessario il dire e il pensare che l’essere sia: infatti l’essere è, il nulla non è».
79 Fr. 8, 36-37.
131
che una via si deve lasciare, in quanto è impensabile e inesprimibile,
perché non del vero
è la via, e invece che l’altra è, ed è vera80.
Una necessità, che non può essere altra da ’An£gkh che, dura
ed inflessibile (fr. 8, 30), governa l’essere e per conseguenza il pensare81, costringe dunque ad abbandonare la via che non è e di seguire l’unica via che resta, quella dell’essere.
Infatti, questo non potrà mai imporsi: che siano le cose che non sono! 82
La perentorietà83 dell’affermazione contenuta nel Poema sulla natura, che Reale nella sua traduzione accentua ancor più con il punto
di esclamazione, non ammette repliche e pare essere in grado da sola di bandire definitivamente, ma anche preventivamente, ogni discorso del non essere. Il g£r, che con grande fermezza apre il frammento, non lascia dubbi; e, sebbene non esplicitato, il perché di
quell’«infatti» è tuttavia facilmente intuibile. Il verbo eänai non tollera invero un soggetto che lo neghi (m¾ ™Õnta). Il soggetto deve
essere assolutamente adeguato al verbo; può essere solo tÕ ™Õn.
Che è il vero soggetto logico di fr. 2, 3. «La determinazione del
soggetto della proposizione porta dunque non solo ad individuare
la via da seguire ma anche a concludere che, nella individuazione
della via, si esaurisce la stessa ricerca: la via è fondata sull’Essere, è lo
stesso Essere in quanto si prospetta come oggetto della ricerca e via
per giungere ad esso»84. La perfetta coerenza del Poema, dove frammento 2 e frammento 6-8 si richiamano e si implicano reciproca-
80
Fr. 8, 16-18.
norma del pensiero è la stessa norma dell’Essere. La necessità vincola ad un
tempo pensiero ed Essere» (Luigi RUGGIU, Commentario, op. cit., p. 51).
82 OÙ g£r m»pote toàto eônai m¾ ™Õnta (7, 1).
83 Affidata a damÍ, che esprime «idea di costrizione, di violenza, di forza», come
annota Giovanni REALE (in ZELLER-REALE, op. cit., p. 194). Sulla corretta lezione
di fr. 7,1, cfr. L. TARÀN, op. cit., pp. 73-75.
84 Luigi RUGGIU, ivi, p. 50.
81 «La
132
mente85, fornisce così la prova più convincente della capacità del
pensiero dell’uomo di sciogliere il dilemma fondamentale dell’orientamento mondano; un pensiero, al quale la Dea, quasi una levatrice, porta solamente il sussidio della consapevolezza. È un partus
masculus quello che la Dea accompagna e forse anche affretta, di un
pensiero che come Atena nasce già adulto.
Non si può negare che il ragionamento ora presentato sia dotato, come si diceva, di una sua forza interna, che dovremo aver cura
di non mandar dispersa. Esso però sembra quasi giustapporsi al patrimonio di esperienza conquistato dal giovane nel corso del suo
viaggio verso Dike; col risultato di ridurre così, nei fatti, l’itinerario
verso la Verità raccontato nel proemio niente più che ad una sorta
di introduzione didascalica al poema. A configurare l’unicità del
cammino verso la verità sarebbe pertanto sufficiente il fatto stesso
del cammino, la via del non essere di per sé essendo impossibile e di
principio esclusa. Nessun bivio, dunque, nessuna vera alternativa si
presenta innanzi al giovane che tende alla verità, ma solo un unico
indefettibile percorso, da cui non si può deviare né a destra né a sinistra, scandito da una logica rigorosa che annulla di principio ogni
eventuale opposizione alla sola via che resta, quella che è86.
Ma se le cose stanno veramente così87, non sembra esserci possibilità alcuna di evitare la conclusione che la Dea, che pure detiene la verità, o meglio, che è essa stessa la Verità, abbia mentito,
85
Molto opportunamente Luigi RUGGIU (L’altro Parmenide, op. cit., p. 36), opportunamente richiamando il fr. 5, mette in evidenza la struttura anulare della costruzione parmenidea, sulla quale insiste anche Jaap MANSFELD (op. cit., pp. 91-92).
Ma questo richiamo non può essere inteso in senso idealistico, come se cioè la fine
giustificasse l’inizio.
86 Così in effetti si esprime la Dea («Resta solo un discorso della via: che “è”»), ma
solo al verso 1 del frammento 8, dopo cioè che il suo discorso si è premurato di
escludere la possibilità di esperire la possibilità del non essere (fr. 6 e 7). Ritorna ancora sempre l’errore di prospettiva ermeneutica che induce a far retroagire le conclusioni sulle premesse.
87 E così sembra ritenere Mario UNTERSTEINER (op. cit., pp. LXXXV ss.), che
traduce di conseguenza: «e, precisamente come una (¹ m•n) esista e che (æj) non è
possibile che non esista, … e che (æj) l’altra non esiste e che (æj) è logico che non esista»; ovvero l’una è necessario che sia, mentre della via che non è si dice che è necessario che non sia. La via del non essere quindi chiaramente non esiste. Dove è chia-
133
più o meno deliberatamente. Se sin dall’inizio è stabilito che la via
è una sola, perché allora presentarne due? perché porre Parmenide
di fronte al bivio dove la via che è si distingue e separa dalla via
che non è? Un bivio che in realtà non si dà. A sentire i non molti
che si son posti la domanda88, le risposte sono sconcertanti. Si suppone una «contraddizione gratuita»89, ovvero la «malafede»90, una
«finzione»91 od ancora una «autocritica della dea»92. Non è difficile
cogliere quanto poco accettabili siano siffatti tentativi di giustifica-
ramente visibile l’errore compiuto dall’interprete, che, modificando l’ordine del testo, costruisce nel seguente modo: Ópwj ¹ mn œstin e æj ¹ d’oÙk ™st…n; dove
Ópwj e æj avrebbero una funzione di congiunzioni rette dal noÁsai del verso precedente. Ma ¹ mn e ¹ d fanno con ogni evidenza riferimento alle Ðdoˆ diz»sioj
che la Dea ha annunciato al verso precedente e che ora si avvia a presentare analiticamente introducendo con un nesso dichiarativo il suo discorso. Sulla lettura di
Untersteiner, seguita anche da Francesco ADORNO (cit., p. 13), si veda quanto affermano Leonardo TARÀN (op. cit., p. 35), che la giudica «ipotesi non necessaria», e
Giovanni REALE (in ZELLER-REALE, cit., pp. 187-189).
88 Cosa che non tutti gli interpreti fanno, preferendo talora glissare su questo
punto che corre il rischio di mettere a repentaglio interpretazioni eccessivamente
confidenti nella forza del logos.
89 «Gratuitous contradiction» (Charles H. KAHN, op. cit., p. 703 n. 4).
90 «Mauvaise foi»: è quanto, secondo Denis O’Brien, occorrerebbe pensare della
Dea se si seguisse l’interpretazione di Kahn (v. supra nota 69). Catherine COLLOBERT
(op. cit., p. 80) poi parla di ragionamento «perverso» della Dea, dato che «essa presenta
due enunciati [quelli di fr. 2, 5] che ella sa impossibili […], proposti in maniera malintenzionale, o se si preferisce per ipotesi, dalla dea». A giustificazione del comportamento della Dea l’interprete però osserva che se «lo sdoppiamento è dunque fittizio,
come è fittizia la via di “ouk estin”», però «questa finzione è necessaria per dimostrare,
da una parte, l’assolutezza della prima via e del suo oggetto, e dall’altra parte, l’impossibilità di una qualunque parentela con la via dei mortali» (pp. 71-72).
91 È l’ipotesi avanzata da Lambros COULOUBARITSIS. La finzione «appare come
il solo modo di dire o di pensare la non-cosa (non-essente)». E la via del non-essere
perciò solo «un modo mitico di parlare» (Mythe et philosophie chez Parménide, op. cit.,
pp. 178 e 189).
92 «La dea fa qui la sua autocritica. Una delle “vie che sole si può pensare” (noÁsai, fr. 2.2), conducendo a ciò che non si può pensare (cfr. oÙdš nohtÒn, fr. 8.8-9),
si è rivelata, per ciò stesso, “inconcepibile” (¢nÒhton, fr. 8.17). Si tratta qui bensì di
una contraddizione; ma è la dea stessa che l’ha messa in evidenza» (O’BRIEN, Introduction, op. cit., p. 156).
134
zione94. Che derivano tutti dalla errata convinzione della effettuale
inesistenza della seconda via indicata dalla Dea, la via del non essere, che avrebbe solo una realtà virtuale. Ma è veramente così?
Chi si fa portavoce di questa impostazione motiva la sua convinzione con il rimando alla impensabilità-indicibilità del non essere95. Il non essere non può essere pensato né detto. E l’unico motivo è questo, perché non è; vale a dire non appartenendo al mondo
del reale, non può costituire oggetto di pensiero e linguaggio. E
tuttavia almeno un fatto dovrebbe rendere più cauta l’affermazione;
dal momento che quello stesso non essere, fatto oggetto di divieto
logico e linguistico, viene invece espressamente pronunciato dalla
Dea.
l’altra che «non è» e che è necessario che non sia.
…
Infatti, non potresti conoscere ciò che non è, perché non è cosa fattibile,
né potresti esprimerlo. (2, 5.7-8)
Come avrebbe la Dea potuto mettere in guardia il giovane dal
pronunciare ciò che fosse assolutamente impossibile non solo pensare ma anche dire, in quanto appunto non è, cioè non esiste? se
non esiste, come fa la Dea a dirlo? Non resta così che ammettere,
come appunto hanno supposto gli interpreti, che la Dea si sia ingannata ovvero abbia ingannato. Questa paradossale conclusione
evidenzia quanto forte sia la tendenza che porta a trovare conferma
nei testi di proprie convinzioni. Guardiamo bene infatti a ciò che la
Dea dice.
Allo stesso modo che nel frammento 1, anche a questo punto la
Dea sta svolgendo un racconto che non è affatto per tutti e per nessuno, ma si indirizza direttamente ad un interlocutore ben preciso.
L’uso della seconda persona, che connota il discorso della Dea lun94
Ancora recentemente Massimo PULPITO (Parmenide e la negazione del tempo.
Interpretazioni e problemi, LED, 2005, p. 97 n.) ritiene di poter sciogliere la questione
con la considerazione che «forse non è metodologicamente corretto pretendere
un’eccessiva coerenza terminologica da un pensatore come Parmenide».
95 In questo caso non essere non indica altro che la pura e semplice negazione dell’essere, inteso come esistenza, darsi delle cose.
135
go l’intero Poema95, non può essere considerato alla stregua di una
mera figurazione retorica. Quando la dea distingue tra sé come
mittente ed il giovane come destinatario del suo messaggio, non sta
usando del dialogo come di una tecnica di facilitazione pedagogica
ad uso di tardi ed inesperti lettori96, ma instaura una situazione comunicativa nella quale proprio il dislivello di status tra mittente e
destinatario costituisce la condizione e definisce la struttura della
stessa comunicazione. Si dà cioè una differenza tra i divini ed i
mortali, la stessa evidenziata sopra, che giustifica la comunicazione
discendente dalla dea al giovane, al quale non a caso non viene attribuita nessuna parola di replica nel corso dell’intero poema. Ciò fa
intendere che la condizione della Dea non è la stessa di quella dell’uomo, che ciò che vale per questi non vale di necessità anche per
quelli. Siffatta differenza va tenuta nel debito conto e non può essere eclissata sotto la considerazione della comunità del logos divino
ed umano, richiamata più avanti dalla stessa Dea quale premessa per
la continuazione del suo discorso97. Dato che al punto in cui ci troviamo non è questione di lettura dei segni che si incontrano sulla
95 «Orbene,
io ti dirò – e tu ascolta e ricevi la mia parola […] E io ti dico che [...]
infatti [tu] non potresti conoscere […] né [tu] potresti […]» (2, 1. 5. 7-8). Ma già sin
dall’inizio del discorso la Dea si rivolge al giovane interpellandolo personalmente:
«O giovane, tu che, compagno di immortali guidatrici con le cavalle che ti portano
giungi alla nostra dimora, rallegra, poiché non un’infausta sorte ti ha condotto a percorrere questo cammino […] Bisogna che tu tutto apprenda […] Eppure anche
questo [tu] imparerai…» (1, 24-26. 28. 31). E poi ancora, più oltre: «Ma tu da questa
via di ricerca allontana il pensiero, né l’abitudine, nata da numerose esperienze, su
questa via ti forzi … ma con la ragione [tu] giudica la prova molto discussa che da me
ti è stata fornita.» (7, 2.-3.6-7. Ho sottolineato con il corsivo i riferimenti personali
nel discorso della Dea. Altre ricorrenze dell’uso del discorso in seconda persona in fr.
8, 7. 36. 52. 60-61; 10, 1. 4. 5).
96 Il problema semmai è quello di cercare di capire perché mai Parmenide abbia
deciso di mettere il discorso di rivelazione della Verità del tutto in bocca alla Dea.
Affronteremo questo problema più avanti.
97 Cfr. fr. 7, 5-6. Sulla «collaborazione dell’uomo con dio» ha insistito in modo
particolare Mario UNTERSTEINER, op. cit., p. LIV.
136
via, che per darsi suppone appunto lo stare sulla via98, ma proprio di
decisione per la via, di avviare il cammino su di una via.
Massima è la presunzione che vuole equiparare l’umano al divino, che non rispetta lo scarto che si dà nella loro pur chiara comunanza99. Bisogna allora riconoscere che la prospettiva della Dea è
differente e superiore a quella dell’uomo indagatore, o meglio ancora, che il sapere della Dea è svincolato e sciolto da (ab-solutus)
ogni determinazione prospettica che vincola invece il sapere umano. Essa dunque sa ciò che l’uomo non sa, e che può giungere a sapere solo se e solo dopo che una comunicazione autorevole lo abbia orientato nella giusta direzione mettendolo sulla retta via.
E ciò che la Dea sa, e che si premura di rivelare al giovane, è
precisamente il fondo nascosto che sostiene e dà stabilità alle singole
realtà, che pure passano. Questo sapere divino è un sapere che giudica, che cioè letteralmente separa – come ci invita a pensare il verbo greco kr‹nai – i due versanti della comprensione autentica e
dell’opinione erronea dei mortali. L’essere, dunque, non il nulla è il
tono essenziale che dà spessore al reale e protegge l’esistenza dall’evanescenza generale.
Il sapere della Dea non è però un sapere immobilizzante la vivacità dinamica del reale. Non nega il divenire degli enti, anzi ne
propone una lettura autentica100. Nega invero che il divenire possa
essere riferito all’essere nella sua totalità, nega che del tutto si possa
98
A questa analisi è dedicato il lungo frammento 8, che inizia continuando almeno logicamente, se non anche letteralmente, la conclusione di fr. 7 richiamata
nella nota precedente.
99 Non è questo forse il problema per eccellenza di ogni riflessione autenticamente sapienziale, riuscire a mantenere nell’unità la differenza, senza frantumare o
disperdere la prima? nell’immanenza la trascendenza, senza abbassarla? nell’identità
l’alterità, senza insuperabili opposizioni? È la grande sfida persa da Hegel, che pure
ha avuto il coraggio e la forza speculativa di confrontarsi con questo centrale problema; una sfida condizionata dall’incapacità di oltrepassare l’orizzonte del logos, che
non accetta limiti al potere di determinazione del vero, verso il più comprensivo
orizzonte della gratuità della verità.
100 È il terzo dei plessi di indagine elencati dalla Dea in quella sorta di indice-sommario del Poema che sono i vv. 28-32 del frammento 1, da cui abbiamo
preso avvio nella presente sezione. Alcuni interpreti (Karl REINHARDT, op. cit.,
pp. 46 ss.) dalla elencazione programmatica delle questioni problematiche da af-
137
ipotizzare un’origine od anche una scomparsa, entrambe totalmente destrutturanti e paralizzanti. La Dea, in altre parole, non
chiude gli occhi sul fatto che il venire alla luce di singole cose e
soprattutto il loro inevitabile decadimento sembrerebbe annunciare la potenza minacciosa del nulla; il quale riuscirebbe così ad affondare entro di sé in un abbraccio mortale ogni singolo ente. Ella
sa che di tal fatta è l’esperienza di vita ordinaria dell’uomo mortale. Ma proprio perché il suo sguardo acuto oltrepassa il velo dell’esperienza e la sua visione abbraccia la totalità dell’essere, nella
sua patente e fragile manifestazione ma anche nel suo robusto fondo nascosto, ella può condurre il giovane ricercatore a percorrere
la via della verità.
Il quale, però, non è provvisto del medesimo sguardo degli
¢qanatoˆ. Per lui il non essere ha una sua evidenza, che solo più
avanti gli si rivelerà del tutto erronea. Egli non riesce a distaccare
lo sguardo dall’abisso vorticoso del nulla; mortale, non può trovare in sé la forza della «verace certezza», che sola può riuscire a sottrarlo ad esso. Per lui, giunto al bivio in cui la strada maestra, su
cui finora era condotto, si biforca nei quadranti essenziali dell’essere e del nulla, del fondamento stabilizzante e del vuoto annichilente, l’avanzamento lungo la via si rivela impossibile. La “via che
non è” per lui esiste veramente, l’ha intravista e sperimentata attraversando la soglia; egli, mortale che ha però avuto il privilegio
unico di essere condotto al cospetto della Verità, ha visto i mortali
percorrerla. È in questa equivalenza imbarazzante delle possibilità,
dove le due potenze primigenie dell’essere e del nulla si fronteggiano con pari forza attrattiva, che risuona la voce autorevole della
frontare hanno inferito una tripartizione delle vie di ricerca, che in alcuni casi produce una vera e propria proliferazione di vie. Couloubaritsis ne conta «almeno sei
o otto» (Lambros COULOUBARITSIS, Les multiples chemins de Parménide, op. cit., p.
41. – Sull’«ipotetico “terzo cammino”» si veda Nestor-Louis CORDERO, Les deux
chemins de Parménide, op. cit., pp. 158-168). Le Ðdoˆ diz»sioj di fr. 2 non vanno
però sovrapposte od anche confuse con i nodi teoretici da affrontare elencati dalla
Dea, la cui giusta soluzione reclama invece proprio la loro corretta collocazione
sulle vie.
138
Dea, la quale proibisce al suo discepolo di pensare anzitutto e financo di pronunciare il non essere101.
È un comando imperativo quello della Dea. La quale sa certamente che il non essere non è; sa che la via che lo suppone e lo afferma è in realtà una empasse, una via senza sbocco; che chi cammina su di essa si perde in incoerenti erramenti. Ma sa anche che l’errore per i mortali è un evento sempre in agguato. Per questo invita
più volte il suo giovane discepolo ad allontanarsi dalla via dell’errore, nella quale domina il non essere, ovvero l’assenza di stabili riferimenti102.
E io ti dico che questo è un sentiero su cui nulla si apprende. (2, 6)
Il tono solenne della frase, il fatto che la Dea in maniera così
pressante esprima il suo invito in prima persona, mettendo così in
101 Una
lettura non troppo dissimile da quella qui proposta è quella che offre Patrice DERAMAIX (Les chemins de la pensée – sur Parménide, http://membres.lycos.fr/patderam/), che annota: «benché la Dea affermi senza ambiguità che il
non-essere è inconcepibile, il cammino che conduce al nichilismo resta chiaramente
affermato come concepibile.» Le due vie «costituiscono delle risposte possibili, tra le
quali occorre, in una maniera o nell’altra, scegliere sotto l’egida di Dike, cioè sotto
l’egida di una ragione critica. La ragione critica è dunque la chiave, o la detentrice
della chiave, che apre ai cammini del pensiero senza garantire, per il momento, la
giustezza della risposta.» In tal modo «siamo condotti ad abbandonare l’interpretazione comune che riduce la problematizzazione filosofica ad una scelta unilaterale
per una ontologia esclusiva di ogni pensiero del non-essere». Anche se l’identificazione di Dike con la ragione critica meriterebbe qualche precisazione ulteriore.
102 «Ma tu da questa via di ricerca allontana il pensiero» (fr. 7, 2). Identico invito
era stato formulato dalla Dea anche in fr. 6, 3, dove però la lettura è fortemente condizionata dalla necessità di interpolare il testo corrotto. Abbandonata la lezione di
ZELLER (op. cit., p. 183 n 4), che seguendo Simplicio legge il verso allo stesso modo
di fr. 7, 2, la lezione che si è imposta è quella di DIELS (Parmenides Lehrgedichte, op.
cit., p. 68 ): prèthj g£r s’¢f’Ðdoà taÚthj diz»sioj <e‡rgw>. La lezione di Diels
solleva tuttavia numerose difficoltà di ordine logico, come ad esempio quella di rendere compatibile il divieto di proseguire su questa «prima» via di ricerca col fatto che
nei versi immediatamente precedenti la Dea aveva fatto appello proprio alla via dell’essere. Per superare tali ostacoli, recentemente CORDERO (Les deux chemins de Parménide, op. cit., pp. 168-175) ha avanzato un’altra interessante ipotesi, proponendo la
lezione prèthj g£r <t>’¢f’Ðdoà taÚthj diz»sioj <¥rxei> (car tu <commenceras>
par ce premier chemin de la recherche). Una valutazione di dette ipotesi in O’BRIEN,
Introduction, op. cit., pp. 222-225.
139
gioco tutta l’autorevolezza del suo sapere103, sono tutti elementi che
rendono evidente come la Dea scelga un registro narrativo elevato,
che rivela e suppone la condizione di attesa rispettosa con la quale il
suo giovane interlocutore le va incontro. Al punto in cui ci troviamo, di fronte alla krisis per la via da seguire, la Dea non fa, non può
fare, appello alla autonoma capacità di valutazione razionale del suo
interlocutore. Questi può essere ancora solo il destinatario di una
comunicazione di verità che lo investe in tutta la sua persona. Non
è perciò un caso che quando, nei versi successivi, la Dea completa il
discorso fornendo la motivazione del suo comando – infatti, non potresti conoscere ciò che non è, perché non è cosa fattibile, né potresti esprimerlo104 – il verbo usato sia sempre lo stesso, ma questa volta declinato
all’ottativo in chiave negativa ad esprimere un’impossibilità. Come
se volesse dire: io ti espongo un ordine ispirando una condotta,
mentre tu non sei in grado di far lo stesso.
La Dea dunque ha il potere di dire il non essere105, ella che sa
quale sia il fondamento di ogni realtà e che perciò possiede la chiara
cognizione della infondatezza dell’opzione nichilistica; al giovane
questa medesima opportunità, per quanto solo in forma di possibilità, è invece del tutto proibita106. L’impronunciabilità del non essere
allora, sulla quale gli interpreti hanno fondata la necessità della scelta della via dell’essere e del rifiuto di quella opposta, non è assoluta
103 Il
verbo fr£zw, usato qui da Parmenide, allude ad una situazione comunicativa asimmetrica, tipica di un rapporto didattico (PLATONE, Teeteto, 180b: «Ma io credo che essi espongano [fr£zousin] con calma e tranquillità dottrine sicure a quegli
scolari che vogliono rendere simili a sé») come pure del responso oracolare, dove chi
ascolta dipende da chi annunzia; in OMERO (Odissea, 1, 444) qualifica il consiglio ispirato di Atena a Telemaco di affrontare il viaggio alla ricerca di Odisseo. Lo stesso verbo
ritorna in 19, 477, allorché Euriclea, che ha riconosciuto Odisseo dalla cicatrice al piede, vorrebbe rivelare la sua scoperta a Penelope. PolÚfrastoi sono le cavalle che
portano il giovane nel viaggio della rivelazione della verità (fr. 1,4).
104 oÜte g£r ¨n gno…hj tÒ m¾ ™Òn, oÙ g£r ¢nustÒn, oÜte fr£saij (2, 7-8).
105 Che dunque può esser detto!
106 Più avanti, quando il giovane verrà condotto dalla Dea lungo la via dell’essere
ad indagare i segnali disposti su di essa, l’adozione della forma logica del discorso
consentirà alla Dea di abbandonare la forma narrativa diretta per passare ad una più
impersonale argomentazione svolta in terza persona. «Si è quindi deciso, come è necessario, che una via si deve lasciare, in quanto è impensabile e inesprimibile, perché
non del vero è la via, e invece che l’altra è, ed è vera» (fr. 8, 16-18).
140
e tale di principio, ma assume una simile forma solo relativamente
alla condizione dei mortali. Il non essere deve diventare impronunciabile per l’uomo che ricerca la verità; egli deve rinunciare a pronunciarlo e a conoscerlo, vale a dire a costruire su di esso la rappresentazione della realtà107.
Perché questa possibilità si dà concretamente e non è affatto peregrina ed illogica ipotesi, ad hoc costruita per consentire al pensiero
di produrre il gioco di sponda speculativo che incanala inevitabilmente verso la via dell’essere. Già Gorgia – una generazione appena
dopo Parmenide! – ha contestato frontalmente Parmenide. È quello del filosofo di Lentini l’esatto, speculare rovesciamento della posizione parmenidea, la sconfessione dell’identità posta nel Poema
sulla natura tra l’essere e il pensare; e, prima ancora, la possibilità tremenda di dire il nulla. Nulla è. Se qualcosa è, non è pensabile. Se anche
è pensabile, non è comunicabile108. Contravvenendo clamorosamente il
divieto della Dea, Gorgia osa così percorrere la via che dice il non
essere. E che questo riesca proprio grazie allo sfruttamento di tutta
la potenzialità del logos109 non fa altro che portare ulteriore testimonianza, se ce ne fosse ancora bisogno, di quale debole garanzia sia
quella che la costruzione logica può offrire. La plausibilità e la dicibilità del nulla trovano già nel titolo del trattato di Gorgia come la
loro prova provata.
107 Va
sottolineato che Parmenide non parla qui di un generico pensare, ma usa
il verbo della conoscenza, gignèskein. Merita attenzione altresì il fatto che tale verbo abbia questa unica ricorrenza, per di più preceduta da una negazione (oÜte g£r
¨n gno…hj), nella prima parte del Poema; e che nella seconda parte, quando la Dea è
impegnata nella confutazione delle opinioni dei mortali, venga usato il sostantivo
etimologicamente affine gnèmh (8, 53. 61 – in quest’ultimo caso collegato, come le
dÒxai di fr. 1, 30, a brotîn).
108 «Gorgia da Leontini fu anche lui del gruppo di coloro che escludono una
norma assoluta di giudizio; non però per le stesse obbiezioni che muoveva Protagora
e la sua scuola. Infatti nel suo libro intitolato Del Non essere o Della natura egli pone
tre capisaldi, l’uno conseguente all’altro: 1) nulla esiste; 2) se anche alcunché esiste,
non è comprensibile all’uomo; 3) se pure è comprensibile, è per certo incomunicabile e inspiegabile agli altri» (82 B 3 DK). È degno di nota che il trattato di Gorgia ci
sia pervenuto con il titolo Del Non essere o della Natura.
109 Il ragionamento di Gorgia sfrutta infatti, come aveva già fatto Zenone, la capacità del logos di organizzare consequenzialmente il discorso.
141
Non è allora esatto dire che «l’impossibilità del contenuto annulla la stessa possibilità della via», come sostiene Ruggiu110, quasi a
ricavare l’esclusione della via che non è dalla qualità del terreno su
cui essa conduce. Non si dà insomma nessuna autoimplosione logica della via dell’errore, come se tale via si eliminasse da sé, sottraendosi così allo sguardo indagatore dell’uomo. Tale via rimane invece
lì, con tutta la sua drammatica evidenza. Il sentiero del non essere è
in effetti qualificato dalla Dea come panapeuqša, «su cui nulla si
apprende», come efficacemente traduce Reale111; non impossibile,
dunque, né riguardo al contenuto né in relazione al darsi stesso della via112, ma soltanto impraticabile, da non percorrere. Non è sul
terreno della logica che va perciò cercato il fattore dirimente la
questione. Il calcolo logico non è in grado di sciogliere l’enigma;
anzi, la logica stessa non è stata ancora stabilita. Se, come giustamente notano numerosi interpreti, il frammento 2 del Poema di
Parmenide può essere segnalato come il luogo sorgivo della logica
110
L. RUGGIU, L’altro Parmenide, op. cit., p. 47.
legomenon, derivato dallo stesso verbo punq£nesqai, apprendere, usato da Parmenide in fr. 1, 28 al momento di presentare lo scenario della ricerca.
Anche la variante riportata da Proclo, panapeiqša (del tutto privo della peiqè richiamata al v. 4, dunque assolutamente non persuasivo, inaffidabile) seguita da BEAUFRET («n’est qu’un sentier où ne se trouve absolument rien à quoi se fier» – op. cit., p. 79),
si adatta molto bene. Anzi, in questo caso, ci sarebbe un rinforzo dell’opposizione tra
le due vie, in relazione alla loro capacità persuasiva della verità. Si può osservare, in
aggiunta, che siffatto sentiero non è propriamente né una ÐdÕj né una kšleuqoj,
ma una ¢tarpÒj; la costruzione negativa, mediante l’a privativa, conferma la impraticabilità di questo percorso, lungo il quale non si può andare (tršpesqai).
112 «Perché non è cosa fattibile», commenta la Dea come giustificazione di detta
proibizione (2, 7). Il termine usato da Parmenide (¢nustÒn, che può essere compiuto, portato a termine) comunica l’idea non tanto della semplice possibilità – come
intendono, seguendo John BURNET che traduce: «that is impossible» (op. cit., p. 174),
la gran parte degli interpreti – quanto piuttosto quella del compimento di un’opera,
della sua realizzabilità. La via che “non è” è una via impercorribile, che non conduce
da nessuna parte; «il n’y a pas là d’issue possible», traduce Jean BEAUFRET, (ibidem).
Sulla stessa linea interpretativa Pierre AUBENQUE: «impraticable» (op. cit., p. 109), Denis O’BRIEN: «pas accessible» (Introduction, op. cit., p. 17), Giovanni CASERTANO: «irrealizzabile», ritenendo però tale la conoscenza di ciò che non è (Astrazione ed esperienza. Parmenide (e Protagora), «La Parola del Passato», XLIII, 1988, pp. 61-80, p. 70)
e Jörg JANTZEN: «unvollziehbar» (Parmenides zum Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit, Beck, München, 1976, p. 107).
111 Hapax
142
bipolare della non contraddizione113, che la ripresa aristotelica sarà
poi capace di condurre agli elevati livelli dell’epistème, è chiaro che
tale logica non può venire già presupposta a giustificare l’atto stesso
di posizione che la istituisce.
Logica e ontologia
Non si deve infatti credere che quella prescritta dalla Dea sia l’unica modalità di ragionamento che gli uomini possano seguire né
che sia quella più naturale. La forte critica che la Dea rivolge ai
brotoˆ e„dÒtej oÙdšn in fr. 6, 4 – sono sbandati ed erranti, si lasciano facilmente trascinare qua e là da una mente incerta e schizofrenica, che non sa decidersi e finisce per gettarli in braccio all’impulso del momento – mostra che non è così, dal momento che essa
si concentra precisamente sulla costruzione logica del pensiero dei
mortali, la cui fallacia risuona con grande clamore; da costoro, infatti,
essere e non-essere sono considerati la medesima cosa
e non la medesima cosa, e perciò di tutte le cose c’è un cammino che è
reversibile.114
Non dunque un’assenza di logica, ma una logica differente, che
confonde ed anche perverte115; ma comunque pur sempre una logica, vale a dire una regola per il pensiero, capace di entrare in contrapposizione con la logica insegnata dalla Dea. E se quest’ultima si
caratterizza per il rigore cristallino della non-contraddittorietà che
non ammette vie di fuga, come il giovane avrà modo di sperimentare in tutta la sua intrinseca cogenza quando verrà il momento di
113
Cfr. Jaap MANSFELD, op. cit., pp. 44-62 e pp. 84-86. Cfr. anche Rodolfo
MONDOLFO, La comprensione del soggetto umano nell’antichità classica, La Nuova Italia,
Firenze 1956.
114 Fr. 6, 8-9.
115 Nelle opinioni dei mortali, che direttamente o meno mettono in gioco il non
essere, la dea dice che non c’è p…stij ¢lhq»j, fiducia verace (fr. 1, 30). Si noti: non
già una contraddizione logica caratterizza le credenze dei mortali, ma solo il fatto
che esse non sono credibili, facendo perno proprio su quel non-essere che sostanzia
il cammino dell’errore.
143
passare in rassegna i caratteri dell’essere, non per questo l’altra, il
modo di pensare dei mortali, si lascia tranquillamente metter da
parte. I mortali restano infatti pervicacemente attaccati alle loro abitudini cognitive116.
Sono, queste, modalità di pensiero tra loro incompatibili, tra le
quali, come tra le vie, occorre scegliere. Ma quel che importa sottolineare, è che non la modalità logica determina la scelta della via,
ma al contrario è la decisione per la via dell’essere che comporta l’adozione dell’unica logica ad essa adeguata, quella che impone di
non collegare termini tra loro contraddittori117. Non può essere
dunque una funzione logica – quella dell’opposizione, che allontana sì da sé necessariamente il non essere, ma solo perché lo scopre
inconciliabile con l’essere accolto già come principio, e che per
questo motivo vale solo sulla via dell’essere – a poter condurre alla
decisione critica richiesta dalla Dea118. È invece scegliendo la via
dell’essere che si sceglie anche la logica della necessità, che è la logica della verità. Non si danno perciò, nel momento in cui al giovane
è richiesto di prendere posizione di fronte all’alternativa radicale di
senso che le due vie metaforicamente simboleggiano, motivazioni
razionali fondamentali – le quali vengono in verità portate all’evidenza solo a seguito della decisione che fa incamminare il giovane
sulla via dell’essere – capaci di giustificare la scelta medesima119; come se, insomma, logicamente, vale a dire necessariamente, si desse
116 Come
la Dea polemicamente sottolinea nel frammento 7: «né l’abitudine,
nata da numerose esperienze, su questa via ti forzi a muovere l’occhio che non vede,
l’orecchio che rimbomba e la lingua» (vv. 3-5).
117 Cosa che la Dea insegnerà a fare al suo discepolo nel lungo frammento 8.
118 Né a sostegno della natura puramente logica della scelta può essere invocata la
presunta contraddizione di soggetto e predicato di fr. 2, 5; un richiamo, questo, che
suppone come positivamente risolta la questione del soggetto delle proposizioni
pronunciate dalla Dea in fr. 2,3 e 5; in questo caso il soggetto implicito di æj oÙk
™st…n sarebbe appunto tÒ m¾ ™Òn. La critica però è generalmente d’accordo nel ritenere che il soggetto di fr. 2,3 e 5 debba rimanere inespresso. Sull’intera questione si
veda la nota di Giovanni REALE, Le esegesi del frammento 2 (già 4), in Eduard ZELLER
– Giovanni REALE, op. cit., pp. 184-190.
119 Forse che allora il Poema di Parmenide è un inno all’irrazionalismo più o meno fideistico? Senz’altro no! Una conclusione del genere, congruente con un tipo di
problematica tipica della nostra epoca dell’incertezza post-moderna, sarebbe fuori di
144
solo l’essere. La questione è della più grande rilevanza e mette in
gioco i complessi legami tra logica ed ontologia; dove ciò che resta
problematico è la gerarchizzazione delle due.
Sembra invero un esito evidente e naturale confluire dalla struttura logica del pensiero dell’uomo alla costituzione ontologica del
mondo reale. Se noi il mondo lo pensiamo così, deve anche essere
così120. «Il razionale è reale», osservava Hegel, che spiegava: l’ordine
della ragione deve essere reale, deve realizzarsi121. Diversamente allora da come concludeva il precedente paragrafo, ad obbligare a
scegliere la via dell’essere in questo caso sarebbe proprio l’inevitabile adozione di una logica della necessità, modello razionale in grado
di assicurare conoscenza efficace; dato che all’interno di siffatta logica, come abbiamo già visto, pensare positivamente122 il non essere
per l’uomo è impresa impossibile. Andrebbe così conseguentemente concluso con ogni ragione che la scelta della via possa essere determinata grazie alla semplice virtù riflessiva del logos. Non fa meraogni possibile dubbio affrettata ed anche ingiustificata. La questione che ci sta interessando, e che costituirà l’oggetto della prossima sezione, è quella del fondamento,
o ancor meglio, del processo che conduce alla decisione critica. Si tratta di capire come si arriva alla presa di posizione essenziale ed originaria, che determina conseguentemente ogni approccio teoretico, ma poi anche pratico, al mondo. Finora abbiamo solo sperimentato l’impotenza della ragione a trovare logiche motivazioni capaci di dare la richiesta giustificazione della scelta. Più avanti dovremo prendere in
considerazione un differente ed integrato approccio alla questione, quello che è racchiuso nella parola stessa utilizzata dalla Dea, màqoj.
120 Qui, deve essere precisato con grande chiarezza, non si sta agitando la questione della fonte della conoscenza, se essa sia l’esperienza o la ragione; questione
tutto sommato che, a dispetto di molta chiacchiera contemporanea, vale la pena discutere solo in un contesto teoretico moderno pre-kantiano. Ciò che stiamo indagando è invece la forza della convinzione che attribuisce al mondo stesso la struttura
della necessità propria del pensiero della razionalità epistemica. Che così trova confermata la validità della propria intuizione.
121 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, op. cit.,
p. 59. E a commento il filosofo tedesco osserva: «nulla è reale se non l’idea».
122 Come è facilmente intuibile, il problema non è quello di affermare la negazione del non essere, una negazione che comunque, come ci ha ricordato Severino,
suppone pur sempre l’oggetto da negare, ovvero precisamente l’essere. Che così sarebbe nuovamente riaffermato e consolidato. Qui invece è in gioco proprio la possibilità di affermare in positivo il nulla, nominandolo come principio e fondamento
del tutto.
145
viglia, perciò, che su questa linea di condotta si siano attestati in effetti la gran parte dei commentatori di Parmenide.
La confidente fiducia nella potenza del logos di delineare il giusto orizzonte ontologico, nel momento stesso in cui si mostra capace di istituire il campo tematico dell’impegno teoretico, mostra
però anche di non essere del tutto consapevole delle ragioni della
propria validità. È un fatto che la Widerspiegelungstheorie, sotto forme differenti, ha governato la riflessione filosofica da Aristotele a
Wittgenstein; il mondo trova il suo rispecchiamento vero entro la
ragione, che dunque si sente autorizzata a proiettare i suoi logici
meccanismi sul mondo, nel quale viene riconosciuta la medesima
struttura che ordina il pensare. Il reale è appunto razionale; e questo
non è altro che il versante complementare della tesi hegeliana già
ricordata. E sullo sfondo pare stagliarsi, maestosa, ancora una volta
la figura di Parmenide, assurto ad inconsapevole precursore dell’identità dell’Assoluto:
tÕ g¦r aÙtÕ noe‹n ™st…n te ka„ eônai
Infatti lo stesso è pensare ed essere (fr. 3).
C’è però più di una ragione a sconsigliare una frettolosa lettura
idealistica di Parmenide. Non è infatti detto che il tÕ aÙtÕ del
frammento 3 debba essere inteso necessariamente nel senso dell’identità, come se cioè il frammento dicesse che pensare ed essere
coincidano originariamente e siano in effetti la stessa identica cosa123; sola opportunità che, al di fuori di ogni ragionevole dubbio,
giustificherebbe l’applicazione all’essere dei meccanismi che il pensiero trova validi in e per se stesso. Il frammento invita in verità ad
altre esegesi. Il te ka„ che si frappone, per unificarli, tra noe‹n e
eänai in realtà li separa e li distingue. Il noe‹n dunque non è lo stes123 Come in effetti fanno la maggior parte degli interpreti, che traducono di conseguenza: «for it is the same thing that can be thought and that can be» (John BURNET, op. cit., p. 174); «Denn (das Seiende) denken und sein ist dasselbe» (Hermann
DIELS, Parmenides Lehrgedicht, cit., p. 33, seguito da Pierre AUBENQUE, op. cit., p.
117); «la stessa cosa è pensare e <dire che quel che pensi> è» (Guido CALOGERO,
Parmenide, op. cit., p. 179 n.); «for the same thing can be thought and can exist» (Leonardo TARÀN, op. cit., p. 41 – [corsivi miei]).
146
so che lo eônai; la sintassi scoraggia ogni lettura idealistica124. E tuttavia il tÕ aÙtÕ va mantenuto in tutta la sua forza. Come scrive
Heidegger, il frammento 3 dice che «entrambi, tanto l’apprendere
quanto l’esser-presente, necessitano, per essere possibili, e questo
significa al tempo stesso perché sia possibile la loro reciprocità, di
uno spazio libero e di un’apertura, all’interno della quale essi si riguardano reciprocamente»125.
È notorio che la modalità con cui Heidegger legge il pensiero
dei filosofi è del tutto particolare. Egli è interessato, più che alla
correttezza filologica dell’analisi, alle risonanze che la lettura del testo filosofico diffonde e dalle quali sorgono preziosi spunti di riflessione; occorre pertanto grande cautela nel seguire l’ermeneutica
heideggeriana, che non può certamente essere presa alla lettera. E,
tuttavia, l’intuizione, sopra riportata, che a tenere insieme, e proprio per metterli in relazione significativa, il pensare e l’essere sia lo
sfondo essenziale ed originario, il «solido cuore della Verità ben rotonda», merita la dovuta considerazione. È entro tale sfondo che
l’essere ed il pensare entrano in quella relazione necessaria ed indissolubile che il frammento 3 annuncia; il quale non può dunque essere considerato il luogo teoretico fontale dell’intero poema di Parmenide, quello a partire dal quale distendere l’interpretazione del
pensiero dell’Eleate. Sarà infatti solo la posizione dell’essere affermata in fr. 2 a rendere possibile, anzi di più, ad esigere la corrispondenza necessaria di pensare ed essere126; in quanto è solo sul fondamento di stabilità che l’essere annuncia che è possibile ogni vero
pensare127.
124
Si veda invece quanto sostiene Luigi RUGGIU (L’altro Parmenide, op. cit.,
p. 51): «Quanto può essere dedotto logicamente da una premessa è (vero), giacché la
coestensività di pensiero e Essere fa sì che il pensiero sia non solo radicato nell’Essere, ma sia lo stesso Essere.»
125 Martin HEIDEGGER, Seminari, Adelphi, Milano 1992, p. 182. Heidegger così
rende il frammento 3: «Pensare ed essere (cioè apprendere ed essere-presente) infatti
si coappartengono reciprocamente» (p. 181).
126 Cfr. Luigi RUGGIU, Commentario, op. cit., p. 235.
127 Trova in questo modo spiegazione anche il controverso passaggio di fr. 8,
34-36: «Lo stesso è il pensare e ciò a causa del quale è il pensiero, perché senza l’esse-
147
Il movimento pertanto non va dalla struttura del pensare, che è
un pensar-cose, all’affermazione dell’essere, ma, al contrario, dalla
posizione dell’essere all’adozione di una logica del pensare ad esso
adeguata. La capacità del pensiero di rispecchiare ordinatamente il
reale e ricostruirne la nascosta struttura di universale necessità, da
cui prende legittimo avvio l’edificazione sistematica della conoscenza, non deve far dimenticare che una siffatta operazione si dà
propriamente solo a partire da una preliminare apertura dell’essere
svelato nella sua immutabile stabilità. È l’essere nella manifestazione
del suo fondamento che solo può fornire efficace sostegno all’attività logica del pensiero, in quanto lo pone nel luogo speculativo autentico. Appunto per questo, in considerazione cioè della dipendenza essenziale ed originaria del pensare dal fondamento ontologico legittimante, il pensiero non può esser invocato quale giustificazione della fondamentale opzione per l’essere. Perché, lo richiamiamo ancora una volta, ciò che è in gioco non è il fatto che il pensiero pensi cose, enti, ma che questo pensiero possa espandersi assumendo quella saldezza, da cui nella costruzione dell’edificio cono-
re, nel quale è espresso, non troverai il pensare». La spiegazione della proposizione
perché senza l’essere, nel quale è espresso (oÙ g¦r ¥neu toà ™Òntoj, ™n ú pefatismšnon ™st…n) costituisce un difficile esercizio ermeneutico per l’apparente inversione logica dei termini. Non avrebbe la Dea dovuto dire: senza il pensiero nel quale
l’essere è espresso? Sembra infatti evidente che il luogo dell’espressione dell’essere è il
pensiero. Per facilitare la lettura Nestor-Louis CORDERO (Les deux chemins de Parménide, op. cit., pp. 116-119) seguendo Proclo propone di leggere ™f’ú e traduce: car
sans ce qui est, grâce auquel il est énoncé, tu ne trouvera pas le penser. A commento poi aggiunge: «il pensare non esiste che quando si esprime un pensiero a proposito dell’essere» (Contra: Pierre AUBENQUE [op. cit., nota p. 122], che però intende toà ™Òntoj
come elemento puramente linguistico, la parola essere). Dunque, «il pensiero sussiste
solo in riferimento all’Essere, solo se l’Essere costituisce il suo contenuto pensato»
(Luigi RUGGIU, ivi, p. 320). Le difficoltà di comprensione svaniscono però se non si
perde di vista che la via dell’essere è la sola che garantisce la vera pensabilità. Il pensare nella verità può infatti esprimersi solo entro la via dell’essere; che per conseguenza, costituisce il contenuto proprio del pensare. L’evidente somiglianza del v. 34
(taÙtÕn d’™st„ noe‹n te ka„ oÛneken œsti nÒhma) col fr. 3 poi rafforza la lettura
che proponiamo. Sui versi citati si veda Martin HEIDEGGER, Moira (Parmenide, VIII,
34-41), in Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1976, pp. 158-175; Jürgen WIESNER,
Überlegungen zu Parmenides fr. 8, 34, in Pierre AUBENQUE (ed.), Études sur Parméni de, op. cit., II, pp. 170-191.
148
scitivo esso non può assolutamente prescindere e che però il mondo delle cose da nessuna parte è in grado di legittimare128. Nell’incertezza del contributo razionale, ciò che può inclinare la scelta
verso l’affermazione dell’essere è così dunque solo una influente ed
autorevole indicazione, quella che la Dea suggerisce al suo discepolo invitandolo a seguire la via che è.
128 Rimane
ancora un’ultima questione: la costruzione modale del ragionamento
della Dea non è in grado da sola di motivare la scelta della via? L’essere è e non può non
essere; vale a dire, è necessariamente. Il non essere invece non è ed è necessario che
non sia; dunque è impossibile che sia. La scelta della via che è non si deduce dunque
senza incertezza alcuna dalla seconda parte delle due frasi principiali? Infatti, della via
che è si dice che non può non essere (¹ mn Ópwj œstin te ka„ æj oÙk œsti m¾ eônai),
ovvero che è necessario che sia, mentre della via che non è si dice che è necessario che
non sia (¹ d‘æj oÙk ™st…n te ka„ æj creèn ™sti m¾ eônai), ovvero che non può essere. Sembra evidente concludere perciò che la logica che la Dea afferma, ed alla quale
non è possibile sottrarsi, impone l’esclusione del non essere; non resta pertanto che
l’essere (cfr. Denis O’BRIEN, Introduction, op. cit., pp. 180 ss.). Fare però della rivelazione della Dea una lezione di logica modale non appare pienamente convincente; la
tipologia della comunicazione, ma più ancora, lo sviluppo del discorso della Dea – che
è una vera e propria pedagogia della, o meglio, alla verità – mostrano a sufficienza che
non è senz’altro questo il suo interesse. La struttura linguistica delle due frasi, inoltre,
spinge in tutt’altra direzione. Si dà infatti un’evidente simmetria della costruzione; un
identico soggetto, m¾ eänai, dapprima negato (oÙk œsti) e successivamente affermato
(creèn ™sti), chiude entrambe le frasi. Ciò che la Dea insegna al suo discepolo è allora che il non essere non può aver posto sulla via dove si afferma l’essere, mentre l’altra
via chiama il non essere a suo unico principio. Il che, se dà ulteriore conferma dell’esclusività della Verità, non costituisce però di per sé motivo di decisione fra le vie; che
restano lì ancora tutte e due possibili.
Che questo discorso, una volta analizzato ed esplicitato, conduca allo sviluppo
dell’argomentazione modale è senz’altro vero. Questo passo lo farà più tardi Aristotele
e poi la logica stoica. È allora più corretto, ed anche più semplice, dare a ciascuno il
suo, senza ricercare nei pensatori delle origini improbabili ed inconsapevoli profeti di
logici sviluppi di là da venire. È questa però la ricorrente tentazione di filosofi, come
pure di interpreti: pretendere di ritrovare in altri, sia pur implicite, ciò che si è stato in
grado di scoprire. «Sarebbe però un errore voler recuperare la sapienza greca attraverso quel che ne ha detto la filosofia posteriore» (Giorgio COLLI, op. cit., I, p. 9). La cosa
riguarda anche noi? Non può essere escluso a priori. Entro certi limiti, anzi, è percorso
ermeneuticamente inevitabile. Come abbiamo detto in sede di introduzione, il compito dell’interprete è sempre quello di interrogare il passato a partire dal presente. Ciò
facendo, si illumina il passato con i colori del presente. Titoli che promettono con tono squillante di raccontare ciò che ha detto veramente … possono avere grande fascino
commerciale ma scarsa affidabilità scientifica. Nell’instabile equilibrio ermeneutico tra
l’interesse attuale dell’interprete ed il rispetto del pensiero storicamente datato dell’autore può solo confortarci la consapevolezza del problema e la cura prestata nel rispondere ad esso.
149
L’impotenza della ragione a dare autonoma sostanza all’affermazione dell’essere trova peraltro, a ben vedere, una conferma e contrario nella resistenza dell’ipotesi nichilistica agli assalti della razionalità
epistemica; un’ipotesi che, se nella versione gorgiana ha mostrato il
fianco ironico e retorico129, si candida a diventare vera e propria opzione metafisica nella veste che ne darà Nietzsche130. Raccogliendo
la provocazione con cui una società filistea e soddisfatta di sé diceva
di progredire verso il compimento dei valori e senza indietreggiare
davanti al rischio di mettere in gioco non solamente la possibilità
della conoscenza della verità ma anche la stessa coerenza dell’esistenza personale, Nietzsche ha osato spingere in avanti, in maniera
radicale, la ricerca di una differente fondazione del mondo del reale, o meglio ancora, di un approccio ad esso che sappia rinunciare
alla ricerca dello stabile ancoraggio alla piattaforma dell’essere e,
consapevole dell’abisso in cui tutto sprofonda, cerchi nondimeno di
mantenersi nello sprofondare del tutto131. Che l’esito finale del progetto nietzscheano sia penosamente fallito nell’ottenebramento
mentale che avvolse gli ultimi anni della vita del pensatore tedesco,
non è motivo sufficiente ad allontanare l’avvertimento che esso ci
129
Cfr. Giorgio COLLI, Gorgia e Parmenide, Adelphi, Milano 2003.
Su Nietzsche “ultimo pensatore metafisico” cfr. Martin HEIDEGGER,
Nietzsche, Adelphi, Milano 1994.
131 Ricordiamo il famoso aforisma 125 della Gaia scienza, dove l’annuncio della
morte di Dio affonda lo sguardo sull’abisso che si è spalancato («Dove se n’è andato
Dio? – gridò – ve lo voglio dire! Siamo stati noi ad ucciderlo: voi e io! Siamo noi tutti i
suoi assassini! Ma come abbiamo fatto questo? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino all’ultima goccia? Chi ci dette la spugna per strusciar via l’intero orizzonte? Che mai facemmo, a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov’è che si
muove ora? Dov’è che ci moviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno
precipitare? E all’indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un
basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi
lo spazio vuoto?») ed annuncia insieme il compito immane, sovraumano, che lo Übermensch sarà chiamato a portare a compimento, dell’autosostentamento capace di promettere quella saldezza e coerenza dell’esistere, che il venir meno del fondamento metafisico-teologico tradizionale non è più in grado di assicurare («Con quale acqua potremmo noi lavarci? Quali riti espiatori, quali giochi sacri dovremo noi inventare?
Non è troppo grande, per noi, la grandezza di questa azione? Non dobbiamo noi stessi
diventare dèi, per apparire almeno degni di essa? Non ci fu mai un’azione più grande:
tutti coloro che verranno dopo di noi apparterranno, in virtù di questa azione, ad una
storia più alta di quanto mai siano state tutte le storie fino ad oggi!»).
130
150
consegna. La pazzia di Nietzsche è in effetti metafora dello smarrimento collettivo di una società, quella occidentale che, giunta al
culmine del proprio successo, sente vacillare sotto i suoi piedi il terreno della consuetudine metafisica che la ha originata e su cui ha
costruito la propria superba identità132. L’orgoglio della ragione non
sembra più in grado di offrire orizzonti di senso liberanti dall’oppressione dell’insensatezza, che dà l’impressione di avvolgere tutte
le cose.
La questione pertanto non è chiusa col dire idealisticamente che
il vero è anche il reale, l’ente. Il nulla incombe. Esso ci circonda e
minaccia. Da esso l’uomo deve trovare protezione. E la difesa dall’aggressione del nulla sembra restringersi a queste due ipotesi ultimative: o l’essere è necessariamente e non può non essere, dato che
non si dà il nulla; o l’essere è nonostante il nulla, si afferma sul nulla
che lo minaccia al di là di ogni apparenza di cedimento. Sappiamo
già che la soluzione facilitata, che semplifica e aggira il passaggio arduo della scelta proponendo la virtualità dell’alternativa radicale, si
è infranta contro la forte resistenza del non essere ad autoestinguersi. Seguire Parmenide nel racconto del suo viaggio ci ha condotto a
far prova della drammatica incertezza, che grava sulla non eludibile
decisione da prendere davanti alla biforcazione fondamentale del
tragitto che conduce alla verità; una biforcazione per superare la
quale interviene il dire autorevole della Dea. Una nuova figura del
più grande interesse teoretico ci si fa perciò incontro nel Poema di
Parmenide, ed è quella della rivelazione quale modalità di accesso e
di comunicazione della verità.
C. Il linguaggio della verità
Quello che infatti ci si prospetta davanti è il problema dell’inizio . Dove poggiare infatti la parola originaria, quella che, pronunciata, apre la scena al pensare? Come appunto, e con quale fondamento pronunciarla? Cosa può sottrarre all’arbitrio della contingen133
132
Cfr. Eugen FINK, La filosofia di Nietzsche, Mondadori, Milano 1980.
quale ha scritto pagine interessanti Massimo CACCIARI (Dell’inizio, Adelphi, Milano 20012).
133 Sul
151
za dell’inizio il discorso vero? Queste domande, che ai nostri orecchi
sensibili solo alle sirene di risultati dall’immediata spendibilità suonano talora inutilmente dispendiose e fors’anche retoriche – domande
in verità decisive per la costruzione di una figura speculativa autentica –, attraversano con la freschezza di una polla d’acqua sorgiva la riflessione parmenidea, senz’altro più sensibile di quanto siamo noi ai
motivi caratterizzanti il luogo d’origine della scena del pensiero. Relativamente a queste domande essenziali va misurata la profondità
speculativa dell’Eleate, la sua sicura capacità di orientare la discussione futura; ma soprattutto intorno ad esse si gioca la partita del bisogno della filosofia, della sua stessa possibilità in un mondo dominato
dall’ansia dell’utile. Perché, se abbiamo la forza di staccare gli occhi
dal fulgore abbagliante delle produzioni e rinunciamo a far valere il
motivo del successo come unica forma di legittimazione della verità
del processo medesimo che lo ha prodotto134, la questione che ci si fa
incontro con forza è allora quella che, ponendo in discussione il punto di partenza del discorso, ne propone l’esame della sua fondatezza
complessiva. Come osservava già Pascal, l’ésprit de géométrie dell’argomentazione apodittica non può fare a meno dell’ésprit de finesse della
corretta posizione e contestualizzazione del discorso135. Ma dove, appunto, incardinare il discorso?
Qui, a partire da simili interrogativi, si mostra nella sua luce genuina l’interesse di un rinnovato confronto con Parmenide. Riprendiamo allora in mano ancora una volta il frammento 2, che in
134 Siffatta sembra oramai l’unica logica capace di ottenere udienza nel panorama
culturale contemporaneo. È la forza delle cose che impone alle cose stesse il marchio
di una verità dal perimetro flessibile, capace di contenere tutto ed il suo contrario.
Una verità inutile, di cui ridere, da far ridere essa stessa, come suggerisce Umberto
Eco nel fortunato romanzo filosofico Il nome della rosa. Eppure; non dovrebbe essere
proprio la forza delle cose a suggerire un atteggiamento maggiormente prudente? Lo
scempio che la violenza di un agire pratico sostenuto da un pensiero, che si presume
assoluto e senza limiti, sta operando sull’ambiente cosmico non dice proprio nulla?
l’immediato successo significa anche duraturo successo? Non sarà proprio la questione ambientale, il cui dominio pure ha costituito motivo di maggior vanto per l’umanità, a costringere l’uomo a riconoscere il limite in cui è posto e da cui essenzialmente dipende?
135 Blaise PASCAL, Pensieri, op. cit., fr. 1-4, pp. 99-102.
152
questa occasione leggeremo prestando attenzione alle modalità della comunicazione della Dea.
Ora io ti dirò, e tu dopo averla ascoltata abbi cura della mia parola,
quali sono le vie di ricerca che sole si possono pensare136.
È la promessa di una rivelazione piena e compiuta quella che la
Dea assicura al suo discepolo. L’uso del tempo aoristo, tempo cui la
lingua greca affida l’idea del compimento, lascia intendere che il
màqoj, che il giovane è invitato ad ascoltare attentamente, è una
parola137 che non lascia spazio ad ulteriori integrazioni; una parola
dunque definitiva138, che richiede di essere accolta e conservata con
cura, giacché da essa dipende la possibilità della giusta adesione alla
verità. Quella della Dea non è pertanto una mera comunicazione di
informazioni comunque accessibili anche per altre vie; non sono
parole139, ma una parola unica, un solo discorso rivelativo del vero,
da accogliere e tener ben fermo. Lasciandosi guidare da esso, al giovane sarà concesso di penetrare correttamente entro il regno della
verità, che così gli si verrà manifestando in tutta la sua coerente costituzione.
Più interessante ancora dell’idea della completezza e compiutezza del discorso svolto dalla Dea è però l’approdo cui conduce una
136 Fr.
2, 1-2. Nella resa del primo verso (e„ d’¥g’™gën ™ršw, kÒmisai d sÝ
màqon ¢koÚsaj) mi sono leggermente discostato dalla traduzione di Reale, già in
precedenza riportata (Orbene, io ti dirò – e tu ascolta e ricevi la mia parola), che, istituendo un rapporto di coordinazione tra i due verbi della proposizione del secondo emistichio, sembra quasi considerare le due azioni richieste dalla Dea, l’ascolto e la custodia della comunicazione che ella si avvia a fare, alla stregua di una ripetizione rafforzativa di un medesimo atto di recezione. Il che, se da un lato sottolinea la condizione di passività del giovane discepolo nel processo di acquisizione della verità, fa
però, dall’altro, perdere di vista la relazione tra i due momenti dello stesso, che il testo greco ci invita invece a considerare; relazione per la quale l’accesso alla verità è
condizionato dal previo ascolto di una parola rivelativa autorevolmente pronunciata.
137«Annunzio», traduce Enrico MOSCARELLI (op. cit., p. 26).
138 Già alla fine del frammento 1 (v. 28), che grazie alla testimonianza di Proclo
sappiamo immediatamente precedente fr. 2, la Dea aveva affermato: «Bisogna che tu
tutto apprenda».
139 Come intendono Pilo ALBERTELLI, Jean BEAUFRET, Angelo PASQUINELLI
e Jean ZAFIROPULO, che così però finiscono per indebolire la forza del messaggio
della Dea col disperderlo nei rivoli di una multiforme comunicazione.
153
più esatta considerazione della natura di questo discorso. Quello
che la Dea si dispone a sviluppare ha, lo abbiamo appena notato, il
tono del màqoj; una «rivelazione di via», come opportunamente ha
inteso Untersteiner140, che sa introdurre nel cuore della Verità che
non vacilla. Ed in effetti, è solo affidandosi ad essa che il giovane diventerà intimo di quella sapienza che farà di lui un e„dÒta fîta,
lungo un percorso che dalla decisione originaria per la via dell’essere, che il frammento 2 si incarica di annunciare, si snoda fino alla
conoscenza dei caratteri essenziali dell’essere stesso, che la Dea avrà
cura di argomentare dimostrativamente nel corso del lungo frammento 8141.
A differenza infatti del termine correlato lÒgoj, che si incarica
di svolgere i consequenziali sviluppi di una affermazione originaria
per ampliare in questo modo il perimetro della conoscenza, màqoj
esprime la parola che schiude ciò che è chiuso, in virtù di un atto di
posizione assoluto, capace di istituire l’orizzonte stesso del discorso;
atto che non invoca già consolidati e definiti sostegni e del quale
non si dà altra garanzia che l’autorevolezza della fonte che lo afferma. Nessuna regola lo lega pertanto a rispettare percorsi argomentativi vincolati ad un tracciato già dato; è semmai esso che, aprendo
la scena del pensiero e al pensiero, introduce questo nella giusta
ambientazione, dove i vincoli che impegnano il pensiero hanno
modo di rivelarsi e farsi valere in tutta la loro necessaria consequenzialità. Come abbiamo potuto notare esaminando il frammento 2
del Poema parmenideo, non sono motivi propriamente riconducibili ad una argomentazione di tipo apodittico quelli che la Dea
avanza a conforto della sua influente indicazione circa la via da se140 «Il
proemio si conclude trasformando in rivelazione l’esperienza della ÐdÕj».
Il concetto della rivelazione divina viene poi però piegato in senso razionalistico, in
«una specie di metamorfosi di da…mwn in senso razionalistico, cioè umano nel significato più elevato della parola» in virtù del quale «l’uomo trasmette al divino le proprie categorie di pensiero» (Mario UNTERSTEINER, op. cit., pp. LXXIX e
LXVI-LXVII).
141 Tra i due frammenti si dà un evidente legame logico di continuità, come indica chiaramente la ripresa da parte della Dea in fr. 8, 1-2 dello stesso vocabolo, màqoj, che compare in fr. 2, 1: Resta solo un discorso della via: che «è» (mÒnoj d’œti màqoj
Ðdo‹o le…petai / æj œstin).
154
guire. Il giovane è incoraggiato ad incamminarsi su di essa, la via
dove l’affermazione dell’essere fonda ogni successivo cammino, da
un atto di fiducia che precede ogni successione apodittica; atto
dunque squisitamente prelogico, ma non per questo illogico.
La parola, che la Dea autorevolmente proclama nel punto in cui
il sentiero della ricerca su cui il giovane è condotto si separa nella
biforcazione fondamentale dell’essere e del non essere, non ha dunque i tratti del lÒgoj, del dire che raccoglie in unità142 il mondo disperso degli enti a partire da un tratto sostanziale individuato come
a tutti omogeneo. Questa modalità di ricerca, che per la forza intrinseca dell’argomentazione, che è capace di sviluppare, tanta parte
avrà nella vicenda filosofica occidentale, al punto da essere identificata tout court con essa, non viene esclusa o negletta dalla Dea. Ben
al contrario, è proprio ad essa che la Dea esplicitamente chiama il
giovane, invitandolo a riprendere da parte sua e valutare nella loro
esatta dimensione logica i risultati cui la forza del ragionamento sequenziale è capace di condurre143. Ciò che va sottolineato, però, è
che ad una siffatta modalità argomentativa la Dea fa ricorso solo più
avanti, al momento di svolgere le implicazioni, e quindi di esplicitare il potenziale cognitivo contenuti nella decisione di seguire la
via dell’essere. In prima istanza, quando la figurazione stessa del
problema presenta il carattere incerto dell’alternativa, preliminare
ed insieme fondamentale, che istituisce la posizione originaria, è alla sola voce del màqoj che la Dea lascia veicolare la sua rivelazione.
La scelta linguistica parmenidea della modalità di comunicazione del sapere divino non sembra affatto irrilevante o distaccata. E
benché nella letteratura parmenidea essa non abbia costituito elemento di particolare attenzione, stante la comune appartenenza dei
vocaboli usati dalla Dea al campo semantico del dire144 – la qual cosa
sembra aver giocato a favore di una considerazione degli stessi quali
142 Come è noto, il significato originario di lšgw è appunto quello del raccogliere,
come tradiscono ancora le parole collezione o colletta.
143 Fr. 7, 5-6.
144 Insieme agli altri usati da Parmenide, come Ÿpoj, o le voci verbali di œirw,
Ñnom£zw, fr£zw, fat…zw, fhm…. E già il fatto che tale campo non sia quello del vedere, come si affermerà da Platone in avanti, ma quello dell’udire è di una importanza
decisiva.
155
termini equivalenti ed intercambiabili, od anche neutri veicoli di
una uniforme razionalità145 – c’è invece una specificità dei termini
che richiede di essere opportunamente sottolineata. Non è infatti
arida questione generata da acribia filologica il cercare di cogliere
esattamente il dire della Dea ed ascoltare nelle loro risonanze le
nuances di significato in esso racchiuse. La parola divina, infatti, come abbiamo già avuto modo di considerare in precedenza, contiene un’eccedenza di senso ed una capacità di orientamento essenziali
per lo stesso discorso umano. Il quale viene a dipendere da quella
almeno per quanto riguarda la delicata e determinante questione
del fondamento, ovvero della posizione, del discorso medesimo.
Quello nel quale ci stiamo imbattendo è un plesso teoretico di
notevole spessore. Esso chiama in gioco la questione essenziale della
possibilità di un sapere rivelativo illuminante il percorso che l’uomo è chiamato a fare. Quella della Dea è perciò ben più della semplice esplicitazione di una verità già depositata nella ragione di inconsapevoli mortali; ben più radicalmente, si tratta di una introduzione nel regno della verità, che solo la benevolenza divina può
consentire. Quale dunque il linguaggio della verità? Per chiarire
ancora meglio la questione conviene vederne più da vicino la struttura.
Sono questi due momenti distinti e complementari dell’itinerario sapienziale verso la verità. Ogni percorso teoretico prende infatti avvio da un punto di partenza, per snodarsi poi successivamente
ed avanzare lungo binari teorici definiti da quello. E se in questa seconda fase l’avanzamento nella conoscenza è garantito dalla capacità
argomentativa del lÒgoj, che si procura di edificare, assoggettandole alle regole della necessità che costituiscono lo stesso pensare, le
costruzioni teoriche più confacenti alla realtà sperimentata oggetto
di indagine, problematica invece resta la procedura di definizione
del punto di partenza del ragionamento. Quali logiche giustificazioni possono invero essere fatte valere, laddove il discorso prende
il suo avvio? Quale concatenamento sequenziale può essere invocato a supporto? Cosa ne può stabilire la necessità irrefutabile, condi145 Che
pp. 21 ss.).
156
è quanto, mi sembra, sostenga Luigi RUGGIU (L’altro Parmenide, op. cit.,
zione essenziale146 della struttura della validità dell’intero ragionamento conoscitivo – una necessità che, come abbiamo notato nel
precedente capitolo, costituisce la forza e la ragion d’essere dell’epistème?
Il richiamo all’evidenza, nell’epoca dell’incertezza, non può più
bastare. Ma ciò che è ancor più significativo, è che qui non si tratta
solamente della particolare debolezza, che pare qualificare così a
fondo la nostra epoca, quanto piuttosto di un ben più radicale deficit logico; come peraltro ha ben intuito un filosofo come Hegel, il
quale, piegando la linearità dell’argomentazione apodittica nella
circolarità del sistema, ha inteso giustificare appunto la necessità
dell’inizio con la stessa fine. Solo se l’inizio è dimostrato nella sua
logica necessità quale prodotto di una causa, l’intera serie della dimostrazione può dirsi convenientemente fondata. E la fine, che si
propone quale giustificazione dell’inizio, di questo inizio a sua volta
non è altro che lo sviluppo147.
Ma la potenza ed il fascino del ragionamento hegeliano non è
riuscita egualmente a mascherare il limite che lo sostanzia148. Fare i
conti con la storicità dell’uomo (e del suo pensiero) impone infatti
di accogliere e non negare la dipendenza da cui questi si trova già
da sempre costituito; una dipendenza che è più che un sentimento149, dal momento che caratterizza originariamente ed essenzialmente la condizione ontologica dell’uomo. Che vive perché viene
chiamato alla vita. Una contingenza radicale, da intendersi come
non-necessità e perciò come fondamento di libertà150, disegna ogni
profilo antropologico, anche quello, come il pensiero, che più sem146
Ma non sempre opportunamente considerata.
«il circolo che presuppone e ha all’inizio la propria fine come proprio fine,
e che solo mediante l’attuazione e la propria fine è effettuale» (Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Fenomenologia, op. cit., I, p. 14).
148 Ancor meno ci riescono gli argomenta ad utile cui oggi si fa ricorso.
149 Come Hegel rimprovera a Schleiermacher a proposito della sua concezione
della religione (Cfr. Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Lezioni sulla filosofia della religione, Zanichelli, Bologna 1973, I, p. 70).
150 Ritorna utile la lezione di Luigi Pareyson, da cui veniamo aiutati a leggere
positivamente ciò che invece la storia della filosofia ha sempre visto con grande sospetto, vale a dire l’ontologia della libertà.
147 È
157
brerebbe sfuggire ad essa, in quanto dispiegatesi in rarefatte atmosfere.
Ciò che qui è decisivo è pertanto che il pensiero – che come
pensiero dell’essere si mostra come pensiero vero, verità – è costituito nella sua formulazione più acuta non già in virtù di un atto di
autoposizione fondativa di sé, luogo stabile di un sicuro processo
dimostrativo, ma si trova originariamente esposto, quasi provocato
– cioè chiamato avanti – dalla parola veritativa della Dea. La verità
così non si rivela per affinamento progressivo della ricerca autonoma del filosofo, ma è rivelata da un dire originario in cui essa propriamente consiste; un dire che affida la parola di verità a colui che
ha saputo percorrere «la via che dice molte cose e che appartiene alla divinità»151. Questi, in ogni caso, non è indolente e passivo destinatario di una divina interlocuzione che, investendolo come dall’alto, lo privi di ogni facoltà raziocinativa abbandonandolo a mistici
silenzi; anch’egli ha da meditare la parola rivelata e valutare la coerenza delle conclusioni che da essa è doveroso trarre. In questa parte del tragitto, dove ormai la direzione di marcia è ben segnata e il
pathos della decisione ha lasciato il posto ad una più tranquilla considerazione dei caratteri qualificanti la via prescelta, il richiamo della
Dea alla capacità della ragione di cogliere la nascosta struttura della
necessità del discorso si fa più marcato. Il dire del filosofo, capace di
raccogliere i molteplici segni indicatori in un «discorso degno di fede»152, resta tuttavia solo un dire derivato, reso possibile dall’originaria apertura di senso che la rivelazione (màqoj) della divinità offre
all’uomo che ricerca la sapienza.
PistÕj lÒgoj
Ma in che senso il discorso della Dea è degno di fede? L’affermazione in verità è sorprendente, dal momento che la struttura del151
Fr. 1, 2-3.
8, 50-51. Si noti come anche il lÒgoj venga qualificato come pistÕj, degno di fede (che si accompagna a certezza, traduce Giovanni REALE. Meglio Jörg JANTZEN (op. cit., p. 66), che intende zuverlässige. Anche se poi sminuisce la forza della dimostrazione in cui la Dea si è impegnata, traducendo lÒgoj con un generico Überlegung).
152 Fr.
158
l’argomentazione che la Dea sviluppa nel corso del frammento 8
non sembra lasciare adito a dubbio alcuno circa la non evitabile necessità delle conclusioni volta a volta raggiunte. È la forza intrinseca
del ragionamento che impone di giungere ad esse. Perché dunque
definire il lÒgoj come pistÒj? Quale p…stij è chiamata in causa
laddove il lÒgoj sa argomentare così finemente le proprie analisi?
Il ricorrere del termine lÒgoj delimita, quasi a mo’ di una inclusione, il lungo frammento 8. Lo troviamo richiamato dapprima
nei versi finali del frammento 7, che a parere concorde degli interpreti costituisce una unità col frammento 8153; qui la Dea aveva fatto
appello alla ragione del giovane, invitandolo a sottrarsi alla tentazione di cercare una conferma empirica della verità, per cogliere invece nella limpida struttura dell’argomentazione razionale la forza di
conclusioni cui è impossibile sottrarsi154. Un lungo ed articolato
procedimento dimostrativo – grazie al quale i caratteri dell’essere,
che come segnali indicatori caratterizzano la via lungo la quale il
giovane ha intrapreso il suo cammino, vengono dapprima riconosciuti e poi anche assodati nella loro necessità – percorre l’intero
frammento 8; almeno fino al punto in cui la Dea, accertato l’ultimo
dei caratteri dell’essere annunciati in 8, 2-6155, dichiara concluso il
suo discorso probativo circa la verità.
153
Cfr. Denis O’BRIEN, Le Poème de Parménide, op. cit., p. 28.
tu da questa via di ricerca allontana il pensiero, né l’abitudine, nata da
numerose esperienze, su questa via ti forzi a muovere l’occhio che non vede, l’orecchio che rimbomba e la lingua, ma con la ragione giudica la prova molto discussa
che da me ti è stata fornita (kr‹nai d lÒgJ polÚderin œlegcon / ™x ™mšqen
¸eqšnta)» (Fr. 7, 2-6).
Può essere interessante notare che in Parmenide il termine lÒgoj (che prima di
questo punto compare solo in fr. 1, 15, dove però, al plurale, indica genericamente
le dolci parole che le Eliadi rivolgono a Dike per convincerla ad aprire la porta che ella
sorveglia) si carica, come già in Eraclito (fr. 14 A9 Colli; 22 B1 DK), di una pluralità
di risonanze. Esso indica la ragione (qui) ed anche il discorso (8,50). LÒgoj è dunque
il discorso che la ragione riesce a condurre mettendo in atto le sue potenzialità.
155 «Su questa via ci sono segni indicatori assai numerosi: che l’essere è ingenerato e imperituro, infatti è un intero nel suo insieme, immobile e senza fine. Né una
volta era, né sarà, perché è ora insieme tutto quanto, uno, continuo.»
154 «Ma
159
Qui pongo termine al discorso che si accompagna a certezza e al pensiero
intorno alla Verità156.
Quello che la Dea è venuta svolgendo fin nelle sue ultime conseguenze è un pensiero discorsivo, un lÒgoj, che articola e consolida l’intuizione iniziale della Verità157; la quale così è ora definitivamente attestata nella sua stabile essenza. La Dea può perciò passare
senz’altro ad illustrare le opinioni dei mortali circa l’ordinamento
del mondo, completando in tal modo il programma esposto in fr. 1,
28-32.
L’energia ed il rigore della sentenza con cui la Dea ha determinato i caratteri dell’essere sembrano difficilmente appellabili. Non si
dà possibilità alcuna che sulla via dell’essere si possa giungere a
piantare segnali di altro genere; a non consentirlo sono le catene di
Necessità potente158, che Dike rinserra tutto intorno. Non è dunque con la libertà di un atto assoluto che la Dea stabilisce la forza
della conclusione, che il suo giovane discepolo è chiamato a riconoscere nella sua palmare evidenza; una siffatta forza evidentemente
risiede nella consequenzialità del ragionamento. Che il lÒgoj sia
qualificato come degno di fede e non come necessario sembra pertanto
ancora più strano. Occorre perciò analizzare più da vicino il ragionamento che la Dea svolge nel frammento 8.
Conviene partire dal primo dei caratteri dell’essere presentato
dalla Dea, quello per cui l’essere è nella condizione di non poter
venir generato.
Quale origine, infatti, cercherai di esso?
Come e da dove sarebbe cresciuto? Dal non-essere non ti concedo
156
™n tîi soi paÚw pistÕn lÒgon ºd nÒhma / ¢mfˆj ¢lhqe…hj (Fr. 8,
50-51). Pur con qualche differenza nella ripartizione dei gruppi, gli interpreti concordano sul fatto che i versi 6-49 del frammento 8 siano la dimostrazione dei caratteri annunciati in fr. 8, 2-6.
157 Il nÒhma che la Dea dice non è il pensiero così come siamo usi intenderlo
noi, argomentazione discorsiva che sviluppa idee. Esso è invece intuizione, nous.
«Intellezione» traduce Francesco ADORNO (op. cit., p. 17).
158 «Infatti, Necessità inflessibile lo tiene nei legami del limite, che lo rinserra tutt’intorno» (Fr. 8, 30-31). ’An£gkh è detta krater». Ma che kr¦toj non sia separabile da b…a è tema di grande riflessione (Cfr. ESCHILO, Prometeo).
160
né di dirlo né di pensarlo, perché non è possibile né dire né pensare
che non è. Quale necessità lo avrebbe mai costretto
a nascere, dopo o prima, se derivasse dal nulla?
Perciò è necessario che sia per intero, o che non sia per nulla159.
Per l’essere dunque non si dà alcuna gšnnan. Parlare di una
nascita implica richiamare un’origine evidentemente esteriore,
dunque altra dall’essere, come pure ipotizzare uno sviluppo progressivo verso una condizione di piena maturità di cui esso fosse
originariamente carente; quasi che dell’essere si potesse pensare un
di più e un di meno160. Ma non si dà alterità rispetto all’essere.
L’altro dall’essere non può consistere che nel non essere; che però,
come già sappiamo dal frammento 2, non può esser né detto né
pensato.
C’è uno schema logico sotteso al discorso della Dea, sul quale
vogliamo concentrarci al fine di evidenziare i meccanismi logici
che lo governano161. Il punto di partenza del ragionamento è individuato in una qualità, di cui si assume in via ipotetica la negazione,
per sondare poi le conseguenze derivanti dall’assunzione di quest’ultima quale principio della catena argomentativa. Tali conseguenze, una volta rivelatisi impossibili, inficiano però la validità
stessa dell’ammissione ipotetica; il che porta a concludere a favore
della validità della tesi inizialmente proposta162. Il fulcro dello schema, nonché vero fattore di impossibilità dell’ipotesi provvisoriamente assunta, sta nella relazione che viene ad istituirsi tra essere e
non essere, relazione di opposizione contraddittoria tale che, se si
159
Fr. 8, 6-11.
tema della perfezione dell’essere (oÙk ¢teleÚthton tÕ ™Õn) verrà ripreso
più avanti, in 8, 32-33: «poiché è stabilito che l’essere non sia senza compimento: infatti non manca di nulla; se, invece, lo fosse, mancherebbe di tutto».
161 Su di essi hanno insistito Jaap MANSFELD (op. cit., cap. II: Die Logik des Parmenides: Disjunktion und Implikation, pp. 42-121 ) e Denis O’BRIEN (Introduction,
op. cit., pp. 180-194; 278-302).
162 Schematizzando: dato A, se non-A, allora necessariamente B. Ma B è impossibile; perciò non-A impossibile (dunque A).
160 Il
161
afferma l’uno, l’altro deve essere necessariamente negato163. Ogni
volta infatti la negazione dell’attributo esaminato mette capo all’affermazione del non essere; la quale, però, deve essere decisamente
esclusa, il non essere appunto non potendo venire né pensato né
detto164. È l’inevitabile riferimento al non essere quale impossibile
principio a bloccare ogni eventuale prosecuzione del ragionamento
lungo questa linea ed a giustificare, e contrario, il valore del «segno»
trovato sulla via dell’essere.
Ha tutti i tratti dell’œlegcoj quella prodotta dalla Dea165.
L’œlegcoj, vera dimostrazione per via di confutazione della tesi
contraddittoria, conferma inequivocabilmente che la via della verità è la via dell’essere. Come abbiamo potuto osservare analizzando
nel precedente capitolo la posizione così rigorosa di Severino, grazie alla potenza del lÒgoj, che padroneggia con grande maestria le
163 L’essere è e non può non essere, aveva detto la Dea in fr. 2, 3. Secondo Jaap
MANSFELD (op. cit., p. 84), «il metodo logico usato in fr. 2 è quindi la disgiunzione».
Nell’affermare la struttura logica della rivelazione divina, come suona il titolo dell’opera, l’interprete olandese commette però, a mio avviso, l’errore di fondare sulla logica disgiuntiva individuata nel frammento 2 la motivazione della decisione per l’essere. Si tratta così di un «sillogismo disgiuntivo», che richiede necessariamente una
conclusione, non presente nel testo e perciò da integrare: o A o B; ma non B; (quindi A). La qual cosa, se spiega il fondamento logico del discorso successivo, non dà ragione del motivo per cui si dà non B.
164 Lo stesso a proposito della immortalità dell’essere, dal momento che la sua distruzione implicherebbe il non essere come meta del passaggio (8, 12-15); della sua
a-/in-temporalità, dal momento che passato e futuro, nell’attualità del presente che
è, non sono (8, 19-21). E così per l’indivisibilità (8, 22-25), immutabilità, identità e
completezza (26-32), perfezione, contiguità ed eguaglianza con sé dell’essere (8,
42-49): caratteristiche tutte che non tollerano l’ammissione del non essere. È forse
opportuno notare che gli attributi ruotano attorno al concetto di stabilità, in cui propriamente consiste la natura dell’essere. Non si infatti dà crescita, né nascita, né morte, né divenire spazio-temporale solamente perché l’essere è sempre presso di sé.
Sulla questione relativa al rapporto fra essere e tempo, se l’essere cioè sia senza tempo
o contenga la totalità del tempo, si vedano gli studi di Denis O’BRIEN (L’être et l’éternité, in Pierre AUBENQUE (ed.), Études sur Parménide, op. cit., II, pp. 135-162) e Catherine COLLOBERT (op. cit.), che peraltro giungono a conclusioni differenti.
165 Essa è dapprima annunciata in fr. 7, 5-6. Come osserva Giovanni Reale a margine della sua traduzione, «il termine œlegcoj qui usato da Parmenide potrebbe tradursi con “confutazione”, proprio in senso forte» (PARMENIDE, Poema, op. cit., p. 97
nota 27). Molto opportunamente, tuttavia, egli preferisce utilizzare il termine più generale di prova. Che è precisamente quanto farà la Dea nel prosieguo del suo discorso.
162
proprie capacità, siffatta modalità di costruzione dell’apparato di conoscenza sa edificare attorno ai suoi contenuti la mirabile gabbia
della necessità del pensiero, dalla quale nessuna evasione è consentita. Prima di Zenone, suo discepolo e universalmente riconosciuto
come l’«inventore della dialettica»166, è dunque Parmenide ad aver
posto almeno le basi, se non anche propriamente avviato quella forma di indagine razionale che si prefigge di blindare la forza dei risultati con le catene della necessità logica167. Nulla più potrà pertanto esser considerato ancora incerto, dacché si prospetta con la garanzia che il lÒgoj è in grado di sottoscrivere.
Noi, che al seguito di Parmenide da tempo camminiamo sulla
“via che è”, riconosciamo agevolmente la soluzione appena conclusa e non ci prendiamo più eccessiva cura nel ripercorre a ritroso
il cammino che ci porta ai fondamenti del discorso. I segnali che la
Dea ha la premura di richiamare e mostrare nella loro incontrovertibile figurazione al giovane, valgono a maggior ragione e con più
forza per noi. Siamo infatti totalmente convinti che la verità abbia
un taglio cognitivo epistemico, messo al sicuro dalla procedura dimostrativa seguita dalla ragione; e lo affermiamo con tal forza, da
trascurare la sottile linea di differenza che, ad esempio, ancora Aristotele prudentemente riconosce tra gli indimostrabili principi della
166 Secondo la testimonianza di Diogene Laerzio, fu Aristotele a chiamarlo in tal
modo (DK, 29 A 1).
167 «Per questa ragione né il nascere né il perire concesse a lui la Giustizia, sciogliendolo dalle catene, ma saldamente lo tiene.» (fr. 8, 13-15). È interessante notare
come molti traduttori, ad esclusione tuttavia dei francesi, rafforzano il verbo finale
della proposizione, œcei, (ha, tiene, mantiene) con un avverbio o un aggettivo, non
presenti nel testo, ai quali è affidato il compito di veicolare l’idea della saldezza della
presa (REALE: saldamente. BURNET, RAVEN e TARÀN: holds it fast. DIELS e MANSFELD: sie hält es fest. PASQUINELLI: lo tiene ben fermo). Circa la possibilità che la struttura dell’œlegcoj sia stata almeno individuata da Parmenide, va richiamato il parere
di Simplicio, che in Phys. 40, 19, scrive: «In questo che dice Porfirio, che sia opportuna la menzione dell’argomento della dicotomia che introduce l’indivisibile e l’uno
in base alle assurdità che la divisione porta con sé, d’accordo; ma è il caso di vedere se
il ragionamento è di Parmenide e non di Zenone come pare anche ad Alessandro»
(DK, 29 A 21).
163
dimostrazione e la dimostrazione medesima168. Anzi, di più. A mettere la parola fine alla ricerca dei fondamenti del discorso è la indiscussa169 forza pragmatica delle affermazioni di scienza.
Lo schema interpretativo affermatosi nella storiografia filosofica
ottocentesca, che delinea un irreversibile progresso vom Mythos zum
Logos, per citare il titolo di un famoso libro di Nestle170, agisce potentemente, spesso in maniera non consapevolmente tematizzata,
quale sfondo generale di precomprensione ermeneutica; ogni avanzamento nella ricerca, filosofica e non, prende pertanto il carattere
di una emancipazione progressiva dalla iniziale intuizione che, in
maniera pre-logica, ha aperto l’orizzonte della ricerca stessa, affi168 «Dato
che i princìpi risultano più evidenti delle dimostrazioni, e che, d’altro
canto, ogni scienza si presenta congiunta alla ragione discorsiva, in tal caso i princìpi
non saranno oggetto di scienza; e poiché non può sussistere nulla di più verace della
scienza, se non l’intuizione, sarà invece l’intuizione ad avere come oggetto i princìpi. Tutto ciò risulta provato, tanto se si considerano gli argomenti che precedono,
quanto dal fatto che il principio della dimostrazione non è una dimostrazione: di
conseguenza, neppure il principio della scienza risulterà una scienza» (ARISTOTELE,
Analitici secondi, 100b 9-13).
169 Ma anche indiscutibile? E non erano proprio argomenti di tipo pragmatico salvare i fenomeni e la riuscita della spiegazione e previsione astrologica - quelli che i
filosofi aristotelici patavini oppongono alle argomentazioni scientifiche della nuova
scienza moderna galileiana? e che oggi i sostenitori della ricerca ad ogni costo – costo
ovviamente pagato da qualcuno che di economia se ne intende – avanzano a dare legittimazione alle sperimentazioni più ardite che mirano a modificare artificialmente
ciò che l’uomo è sempre stato? con tanto di nietzscheanesimo e darwinismo ad orecchio? Ma verità e successo sono equipollenti? Può la prima dipendere dal secondo? E
se è così, che ci salverà dai potenti di turno, che hanno sempre avuto i mezzi per plasmare la verità a proprio uso e consumo e attribuire in questo modo a se stessi un’autorevolezza difficile da ottenere altrimenti? È questo il destino di una razionalità abbandonata a se stessa, incapace di riconoscere la relatività e la relazione della propria
autonomia con il fondamento pre-razionale – prelogico, lo ripeto, non illogico –
che la istituisce. Non dobbiamo allora ripetere il motto dei philosophes settecenteschi:
force n’est pas droit? Non occorre forse non un di meno, ma un di più di ragion critica,
criticamente consapevole del limite che la sostanzia? e ciò precisamente per salvaguardare la ragione stessa dai propri deliri di onnipotenza?
170 Wilhelm NESTLE, Vom Mythos zum Logos. Die Selbstentfaltung des griechischen
Denkens von Homer bis auf die Sofistik und Sokrates, Kröner, Stuttgart 19422. Ma un tale modello interpretativo è già tutto contenuto, come abbiamo visto nel primo capitolo, nella maniera aristotelica di trattare il mito. È lo schema del logos che spiega il
mythos.
164
dando poi al circuito della razionalità discorsiva il compito di articolare gli sviluppi della posizione originaria. La razionalizzazione si
mostra come unica procedura di validazione del ragionamento. La
weberiana Entzauberung der Welt si impone. Il mito diventa mito-logia, discorso razionale sul màqoj, ridotto ormai ad un ruolo di
pura fantasia o, al più, di travestimento immaginifico di un contenuto concettuale puro che spetta alla razionalità esprimere nella sua
autentica realtà171.
La kr…sij decisiva
E tuttavia la questione non si lascia così facilmente metter da
parte. Proprio l’analisi approfondita della costruzione parmenidea
ci dovrebbe invitare a rispettare l’essenzialità della questione del
fondamento e della possibilità di dirlo. C’è infatti un presupposto,
che la Dea ha cura di richiamare più volte nel corso della sua argomentazione dimostrativa172, dal quale propriamente dipende la
verità delle conclusioni, e che pertanto non può venire né trascurato né dimenticato; dal momento che in sua assenza il discorso
perde la sua vera forza. È un presupposto che già conosciamo: la
via sulla quale ci stiamo incamminando è la via dell’essere.
171 Osserva però Giovanni SEMERANO (L’infinito: un equivoco millenario, B.
Mondadori, Milano 2001, pp. 47, 48): «Le prime meditazioni sulla sapienza degli
antichi “barbari”, dai quali i Greci illuminati confesseranno di aver attinto i rudimenti della scienza, dovrebbero rendere più cauti quelli che esaltano la secolarizzazione della scienza greca rispetto, ad esempio, alle antecedenti concezioni dei miti
cosmogonici. E perché non sarà mai data a noi una scienza dell’assoluto, ci tocca
l’infallibile certezza che le cose, come l’egizia Iside, vorranno per sempre serbare inviolato il segreto della loro essenza e continueranno a sfidare la scienza, cingendosi
dell’immane barriera dei fenomeni con cui evitano di compromettere l’illeggibile
realtà del loro arcano, che è l’enigma del Tutto». E conclude: «non si deve dimenticare che la scienza greca, proprio grazie a Talete, ha inizio con un atto di fede, contemplando le umili cose gremite della divinità».
172 Oltre ai versi esaminati tra poco, si vedano i vv. 32, 36-37 del frammento 8,
dove la Dea afferma che la negazione del non essere è una questione di Qšmij e di
Mo‹ra (non dunque di lÒgoj). Nei vv. 7 e 46 invece è la Dea stessa che nega la possibilità del non essere.
165
Ai versi 15-18 del frammento 8 la Dea lo ricorda esplicitamente:
La decisione intorno a tali cose sta in questo:
«è» o «non è». Si è quindi deciso, come è necessario,
che una via si deve lasciare, in quanto è impensabile e inesprimibile,
perché non del vero
è la via, e invece che l’altra è, ed è vera173.
Una parola decisiva, critica – è proprio il caso di dire – si rincorre nei primi due versi appena citati: kr…sij. Kr…sij è la separazione che decide174 e che risolve la situazione dilemmatica; abbiamo avuto modo di farne esperienza, sotto la forma della scelta
che nel frammento 2 ha distinto e ordinato secondo giustizia le
due opportunità in cui si biforcava la via che porta al sapere. Sappiamo già che le due vie sono mutuamente esclusive; tra di esse si
dà una alternatività assoluta, che non ammette incroci o passaggi
trasversali. È necessario dunque, come ancora una volta nei versi
sopra riportati la Dea afferma, che una via debba essere abbandonata. Ma quale via e sulla base di quali motivazioni? Non si tratta,
con ogni evidenza, di una questione che può essere risolta facendo
riferimento a precedenti indagini acquisite dimostrativamente nella loro irrefutabile necessità. Abbiamo visto in precedenza come
non se ne diano. E la Dea, nel corso del suo ragionamento, ce ne
dà conferma.
Ella infatti parla di una via che non può esser pensata ed è senza nome175; è la via del non essere, la via non vera176, dove cioè
non si dà alcuna rivelazione dell’essere. Che invece appartiene all’altra via, la quale per questo motivo è definita come veridica e
º d¢ kr…sij perˆ toÚtwn ™n tîid’ Ÿstin. Ÿstin ½ oÙc Ÿstin kškritai
d’oân, ésper ¢n£gkh, t¾n m¢n ™©n ¢nÒeton ¢nènumon (oÙ g£r ¢lhq¹j œstin
ÐdÒj), t¾n d’éste pšlein kaˆ ™t»tumon eônai (Fr. 8, 15-18).
174Questo è appunto il significato originario del verbo decidere: separare, troncare, tagliar via, (dal latino caedere, con il de che indica allontanamento).
175 Anonima (¢nènumon), più e prima ancora che inesprimibile, come traduce Reale, che enfatizza la dimensione soggettiva del dar nomi; ma la via è senza nome perché non permette identificazione alcuna di sé e delle realtà che la frequentano.
176 Si faccia attenzione a non concludere allora che la via del non essere sia semplicemente falsa. Come ha opportunamente messo in evidenza Martin HEIDEGGER
(Parmenide, op. cit.), falso, yeudÒj, (termine peraltro che non compare nel Poema
173
166
capace di dirci l’esatta costituzione della realtà. Siamo dunque in
tal modo ancora una volta e pur sempre rimandati alla opzione
originaria e fondamentale, con la quale la Dea pone l’essere che
caccia via da sé il non essere. Ecco dunque il presupposto già deciso: dal momento che siamo sulla via dell’essere, su di essa non
potremo mai incontrare il non essere. Ogni chiamata in causa di
questo deve pertanto essere esclusa con ogni decisione. Solamente
a partire da questo punto l’intero discorso della Dea si tiene nella
sua intima e necessitante connessione. È il saldo terreno dell’essere
che dà fondamento di stabilità a tutto l’edificio della conoscenza
su di esso costruito. Quello che va infatti sottolineato è che solo
sulla via dell’essere i segnali fatti incontrare dalla Dea al suo giovane discepolo mantengono la loro forza; solo se non si dà possibilità alcuna di far riferimento logico o linguistico al non essere, è
non solo consequenziale, ma anche necessario, affermare che nascita e morte, come pure movimento e molteplicità, sono esclusi.
Dal momento che siffatte eventualità affondano tutte le loro radici
nell’impensabile non essere.
Poiché nascita e morte sono state cacciate lontane e le respinse una vera
certezza177.
parmenideo) non è esattamente il contrario di ¢lhq¹j. Secondo l’analisi heideggeriana, senza dubbio interessante, quest’ultimo termine nella lingua greca sta ad indicare l’essenziale svelamento dell’essere che, venendo alla luce, mantiene il suo riferimento al velamento che lo sottrae allo sguardo. Esso pertanto non subisce opposizione, che invece rientra interamente entro il campo del dire, che può essere o meno
corretto (Cfr. OMERO, Iliade, 10, 534: yeÚsomai À œtumon ™ršw;). La via del non
essere è dunque la via sbagliata e da non percorrere non già perché l’espressione rivelativa degli oggetti che possono incontrarsi su di essa non corrisponda alla realtà autentica degli stessi, ma perché su di essa l’essere non giunge a manifestazione piena di
sé. Ciò accade esclusivamente sulla via dell’essere, dove si può raggiungere la conoscenza certa e non ingannevole (™t»tumon, derivante da œtumon, con raddoppiamento). Cfr. Gloria GERMANI, ’Alhqeˆh in Parmenide, La Parola del Passato, XLIII,
1988, pp. 177-206.
177 Fr. 8, 27-28.
167
Una p…stij ¢lhq»j178 – la stessa che fr. 1, 30 ha negato alle
brotîn dÒxai, che proprio così si vedono private di ogni funzione
ermeneutica – garantisce della verità della conclusione del ragionamento, validamente acquisita in virtù di un processo logico ineccepibile. La logica della non contraddizione, che il lÒgoj ha saputo
articolare e spingere avanti in maniera così decisa, vale e lega i suoi
risultati alle catene della necessità unicamente nel caso in cui normativo sia esclusivamente l’essere179.
La ferrea struttura della necessità del logos da sola pertanto non
garantisce circa la verità del discorso. Occorre già essere sulla via del
sapere, per potersi avvicinare alla meta. Non è dunque estranea intrusione o immatura e ingenua rappresentazione, ma esigenza autenticamente intrinseca al lÒgoj quella che ne chiede il corretto
posizionamento entro un orizzonte di verità. È il lÒgoj stesso a far
appello al màqoj180. Esattamente per questo motivo la Dea qualifica
il suo lÒgoj come pistÕj, discorso credibile in quanto creduto,
178 Ancora una volta la Dea fa appello alla vera fiducia – questa è la corretta traduzione di p…stij ¢lhq»j. Jean BEAUFRET (op. cit., p. 85) traduce esplicitamente:
la foi qui se fonde en vérité – che implica l’adesione e l’accoglimento di ciò che la Dea
ha esposto. A differenza della certezza, che fa conto sulla convinzione soggettiva di
colui che pensa, la fiducia richiede al contrario una es-posizione, uno star fuori di sé
del soggetto verso il termine su cui la fiducia medesima si posa.
179 In precedenza, nel frammento 6, la Dea aveva intimato il suo interlocutore ad
allontanarsi dalla via «su cui i mortali che nulla sanno vanno errando». Da costoro
«essere e non-essere sono considerati la medesima cosa e non la medesima cosa, e
perciò di tutte le cose c’è un cammino che è reversibile» (vv. 4-5. 8-9). È proprio la
commistione di questi due termini reciprocamente esclusivi che caratterizza l’atteggiamento degli errabondi mortali, i quali non sanno stare alla logica della contraddizione e, «uomini a due teste», pensano di poter sempre tornare indietro sfuggendo
alle necessarie conclusioni cui il lÒgoj conduce. L’aggettivo pal…ntropoj ha costituito il perno dell’interpretazione che vedeva nel frammento una polemica contro
Eraclito. Ma allo stato attuale della critica, come annota Giovanni Reale (pp. 95-97,
nota 27, della sua traduzione del Poema di Parmenide), tale posizione non sembra più
sostenibile.
180 Operazione, questa, che Platone saprà opportunamente recuperare, lasciando
svolgere al màqoj una positiva funzione di fecondazione del lÒgoj. Si veda il racconto socratico della conoscenza come anamnesi nel Menone (80 e ss.), dove si può
osservare come Platone non opponga màqoj a lÒgoj, ma collochi i due in successione, in una ideale staffetta del sapere. Infatti non solo la dimostrazione (Platone usa
i verbi ™nde…knumi [82a] e ™pide…knumi [82b]) viene impostata sulla via tracciata dal
168
perché fondato cioè su un previo affidamento della conoscenza
apodittica propria della razionalità epistemica ad un radicamento
essenziale, capace di orientare la stessa ricerca ponendo l’origine del
discorso, che ne determina essenzialmente anche la fine. Tra questo
inizio e questa fine181 il discorso della conoscenza trova il suo spazio;
spazio delimitato, la cui definizione deborda dalle capacità costruttive del lÒgoj stesso182.
Ora il màqoj, che orienta il lÒgoj, chiede di essere accolto, non
destrutturato mediante l’analisi di cui proprietario è il lÒgoj stesso.
Questo è chiamato a fidarsi di quanto la parola autorevole della Dea
sa proporre. A questa rivelazione esso deve corrispondere con un
atteggiamento di fiducia, che tuttavia non può essere definito irrazionale, e proprio perché costituisce condizione imprescindibile del
cammino verso la verità. La p…stij invocata dalla Dea è perciò
¢lhq»j, perché ¢lhq»j è la Dea medesima, dalla quale il giovane
che vuol sapere deve lasciarsi guidare. L’inizio è posto. Non può
essere dimostrato col lÒgoj. Quando questo interviene, lo scandalo
per il pensiero rappresentato dalla situazione problematica dell’inizio, dove i punti cardinali ai quali far riferimento nella dialettica
della razionalità apodittica dell’epistème non sono dati perché è l’inizio a porli, è ormai superato. Affermata la stabilità della realtà, si
tratta ora di esplicitarne, fortificandoli nella loro necessità, le dimensioni ed i livelli, sui quali si è spostato il nodo della ricerca.
racconto di quanto dicevano i sapienti che avevano ricevuto la divina ispirazione
(81b); non solo Socrate invita Menone a controllare e verificare (skope‹n – 81b) se
questi dicano il vero; ma Socrate stesso presenta i sacerdoti e sacerdotesse come persone che «si curano di essere in grado di dar ragione (didÒnai lÒgon) delle cose alle
quali attendono» (81a – corsivo mio).
181 Che, per il fatto di essere posta, non è ovviamente anche già raggiunta.
182 Se l’interpretazione ora esposta tiene, trova giustificazione anche la scelta linguistica della Dea, apparentemente incongruente col prosieguo del discorso, di presentare il ragionamento logicamente connesso, che andrà a svolgere nel frammento
8, come un màqoj. «Resta solo un discorso (màqoj) della via:che “è”» (vv. 1-2). Al
momento di annunciare i caratteri della via dell’essere, non è il lÒgoj a poter determinare le loro configurazioni, che verranno tuttavia consolidate nella loro necessaria
forma dal lÒgoj.
169
CAPITOLO IV
LA GRATUITÀ DELLA VERITÀ
Il viaggio in compagnia di Parmenide sta volgendo al termine.
Anche il nostro animo, al pari di quello del giovane, è stato condotto lungo il sentiero della verità a considerare l’energia del fondamento che orienta ed ordina il tutto, e che solo consente di oltrepassare lo smarrimento da cui l’animo è gravato e di consolidare la
fiducia nel reale. È giunto pertanto il momento di far tesoro di
quanto siamo venuti pian piano raccogliendo, con la consapevolezza del debito e compito di pensiero che il pensatore di Elea consegna alla meditazione che voglia essere filosofia autentica.
Gli interrogativi che avevano mosso la nostra curiosità teoretica
si erano venuti addensando attorno alla questione preliminare della
corretta impostazione della ricerca filosofica. Il rischio concreto
dell’evanescenza del pensare filosofico nell’età della tecnica, dove le
categorie del funzionale e dell’utile hanno preso il posto dei principi del vero e del buono costituendo nei fatti una nuova metafisica
non di rado inconsapevole di sé, obbliga a porre di nuovo la domanda alla quale ritorna da ultimo il pensiero, ogni qualvolta sente
il terreno franare sotto i suoi piedi: che cos’è la filosofia? E del resto,
sono proprio le epoche di transizione e di rivolgimento, nelle quali
il castello della cultura viene inesorabilmente assediato sotto l’impeto di nuove e più energiche forze, quelle che reclamano con maggiore intensità un nuovo inizio; o forse meglio, che spingono alla
ricerca delle radici che portano la linfa vitale, per poter riprendere
lo slancio venuto meno. Non si tratta perciò di demolire quanto la
cultura ha costruito nel suo percorso millenario e nemmeno, forse,
di costruire una nuova città filosofica dalle fondamenta. Si tratta
piuttosto di ritornare in qualche modo alle sorgenti e recuperare lo
sguardo limpido delle origini, sottrarre al rumore di fondo del fare,
che inquina l’ascolto, la voce eloquente ed ancor sempre pura del
principio.
171
È quello che abbiamo cercato di fare con Parmenide, camminando sulla stessa via da lui un tempo percorsa, affidando del pari
il nostro incedere alla guida premurosa della Dea che, sorvegliando la porta, introduce nell’orizzonte della verità. E tuttavia, contrariamente a quanto si poteva pensare, per noi il cammino non è
stato più spedito di quello del filosofo di Elea. A frenare e rendere
come più incerta la marcia, una lunga e inveterata abitudine dello
sguardo, allenato a vedere e prospettare la manipolazione di cose,
allontana dalla nostra prospettiva – l’unica, al tempo stesso, ricca e
limitata prospettiva che ci è data – le tracce e i segni della presenza
del fondamento che dà sostegno e solidità al nostro fragile consistere. Essere lo aveva chiamato Parmenide, lasciandosi illuminare
dalla parola autorevole della Dea. Aveva in tal modo preso forma
lo sfondo, inattingibile e però sempre presente, entro il quale le
singole realtà mondane ottengono la loro vera consistenza. All’essere, quale sfondo capace di mantenersi nell’ininterrotto mutare e
svanire delle sue singole emergenze ed àncora che trattiene le cose
riservando per esse una provvista di senso, dobbiamo sempre di
nuovo far riferimento, se vogliamo salvare la nostra stessa esistenza
recuperandola dall’insensatezza di un sottile sprofondare nel nulla.
La vacuità di un nichilismo non più capace nemmeno di vivere
eroicamente il proprio destino, e dunque tanto più oscenamente
gaio quanto meno consapevole della posta in gioco, richiede di riprendere la ricerca del principio che salva. È solo nell’essere e dall’essere che le cose possono essere riabilitate dalla loro finitezza paralizzante.
Ma tale aggancio all’essere quale fondamento, questo il secondo grande insegnamento parmenideo, non rientra nelle disponibilità originarie dei mortali. Costoro sono solo i destinatari della comunicazione, che la benevolenza della divinità, non vincolata ad
alcuna necessità nel suo libero darsi, ha il potere di donare. La Dea
infatti, accogliendo il giovane, lo rende partecipe della propria sovrana condizione, che domina e dispiega la totalità del reale. E il
giovane, varcando la soglia, è introdotto nel regno dove le cose
risplendono nella loro più pura essenza. Il gesto di accoglienza
172
della Dea, che con la sua mano la mano destra prese1, è dunque ben
più che un semplice atto di cortesia; esso è invece segno eloquente della volontà divina di condividere con il giovane mortale il riferimento al principio che offre stabilità. E con il giovane, anche
noi siamo invitati ad entrare nella trasparenza dell’essere, nella
quale questo si rivela come il fondo solido che rende possibile l’esistenza umana e l’ordine stesso del mondo, con un atteggiamento
di grande fiducia ed insieme di coraggio. Perché qui, dove sono in
gioco i motivi che determinano e danno valore alla relazione dell’uomo con il mondo, si richiede risolutezza nel lasciarsi istruire
dalla verità. La parola della rivelazione infatti non può essere costruita da e con procedure umane, ma solamente ricevuta ed
ascoltata nella sua libera donazione.
Non siamo in effetti noi, mortali e finiti, a poter stabilire le modalità del presentarsi del principio od anche a pretendere di esercitare su di esso una qualsivoglia forma di dominio. La condizione
umana, una condizione di strutturale dipendenza ontologica, per la
quale la stessa esistenza che ci sostanzia si offre come dono, denuncia un limite insuperabile, che nessuna forma di tecnica autoproduzione potrà mai annullare né valicare. Ed allo stesso modo, assoggettato alla medesima determinatezza ontologica di finitudine è anche il processo del pensiero, mediante il quale l’uomo costituisce la
sua immagine del mondo e si rappresenta le cose. Sarebbe infatti
ben paradossale che ciò che di sua natura è finito e limitato possa
rompere nel pensiero il limite che lo determina e pretendere ad un
sapere infinito ed illimitato. Occorre pertanto prender congedo
dalle forme della presunzione che hanno a lungo governato la ricerca filosofica, e che da questa si sono travasate dapprima nella scienza
per essere da ultimo fatte proprie dalla tecnica. È tempo di tornare a
più misurate posizioni che, senza scivolare in comode dichiarazioni
di disimpegno teorico ed anche etico, sappiano riconoscere pienamente ed accogliere nella sua vera portata il limite e la condizionatezza che ci qualificano. Non si tratta, beninteso, di proclamare l’elogio della miseria nella dimensione del fare o del pensare; situazione da cui l’uomo ha l’obbligo di emanciparsi. Tutt’altro. Non sono
1
Fr. 1, 22-23.
173
le capacità e la potenza del conoscere e fare umano qui l’oggetto del
discorso, ma solo la sua presunta onnipotenza, che non teme di imporre il dominio della struttura del logos sul reale e che la necessità
della sua fondazione logica sembra ampiamente confortare. Ma
proprio sulla non-necessità, ovvero sulla libertà e arbitrarietà dell’inizio di ogni discorso si vengono a concentrare grandi difficoltà teoretiche. È il problema della necessità del cominciamento, che non
cessa di affaticare la riflessione dei filosofi e che non accetta soluzioni a buon mercato, come talora propone la tarda post-modernità.
Proponendo il superamento dell’illusione metafisico-epistemica
della filosofia come scienza assoluta non si vuole perciò per nulla
negare il bisogno di un punto di partenza consolidato. Anzi, proprio verso di esso la filosofia si mette alla ricerca, nell’ascolto delle
tracce che vi rimandano. E tuttavia, la modalità di questa ricerca, se
non vuole ripercorrere le vie che hanno condotto la filosofia contemporanea nella sua incerta situazione di stallo teoretico, deve differenziarsi dalle forme che la tradizione speculativa dell’Occidente
ci ha proposto. Alcuni essenziali interrogativi, capaci di rendere
nuovamente problematica – positivamente problematica – la questione, vanno dunque fatti nuovamente risuonare. Il principio deve
inevitabilmente essere definito in termini di fondazione logica del
discorso che lo concerne? Non si dà cioè altra modalità di accertamento che non sia quella che assicura la necessità dello stesso grazie
ai meccanismi della dimostrazione? E la verità, termine inesauribile
di ricerca, deve essere pensata come una verità incasellata nei quadri
stabiliti dalla potenza del logos, o non piuttosto occorre parlare e
pensare ad una verità nella donazione gratuita, una verità che si offre nella gratuità? Può l’uomo insomma decidere sui principi, o non
piuttosto li riceve nel corso del suo itinerario sapienziale lungo il
quale incessantemente avanza, senza forse poter mai dire di aver
raggiunto la meta?
Decisivo è poter ritornare oggi a riflettere su siffatti interrogativi. Questa ci è sembrata la lezione di Parmenide che, dalla lontananza dell’albeggiare filosofico, giunge a noi. In questo senso abbiamo cercato il dialogo con il pensatore di Elea, per essere da lui ammaestrati circa la via da seguire per accedere a quella comprensione
174
del senso autentico della vita e del mondo, che da sempre ha originato l’impegno del pensare filosofico. A conclusione della nostra
indagine rimane perciò di riesprimere, per quanto in una forma
evidentemente ancora provvisoria e sintetica, questa comprensione
con un linguaggio e modalità adeguate alle forme della cultura contemporanea; ma, soprattutto, rendere espliciti i presupposti dai quali deve ripartire il pensiero nella ricerca inesausta della verità.
La verità come gratuità
Diventa a tal fine essenziale introdurre nel lessico filosofico una
categoria, quella della gratuità, che finora non ha avuto il rilievo
che invece giustamente merita. In effetti non ci può esser posto per
la gratuità, laddove l’orientamento assiale è determinato dall’ansia
della schematizzazione logica, preoccupata di ricondurre entro
quadri teorici già compiuti e definiti i singoli momenti ed eventi
della vita. Tutto allora sembra scontato e già previsto, non suscettibile di variazione alcuna che non sia riconducibile di principio entro la norma precedentemente imposta.
Gratuità dice invece assoluta libertà della donazione. Essa richiama alla logica del dono e della speranza, dell’offerta che trova
nel futuro il suo appello cui corrispondere, assumendone anzitempo l’esigenza. Il dono è offerta non necessitata e fondamentalmente
arbitraria, vale a dire sfuggente alle fattezze delle norme che regolano i commerci tra individui, dove la convenienza egocentrica diviene misura dell’agire. Né colui che dona, né chi riceve è nella
condizione di costrizione; nessun motivo, né tanto meno obbligo
alcuno, è alla base del dono, che pertanto è espressione autentica di
libertà. Chi fa un dono, lo fa instaurando una comunicazione, non
richiesta né imposta, tra eguali; chi lo riceve, partecipa di questa,
senza poter rivendicare nulla come dovuto. Il dono gratuito istituisce perciò una comunità di pari, dove le differenze non sono di
ostacolo e dove la condivisione rompe la scorza di autosufficienza
che isola ciascuno entro la propria unilaterale visione.
La gratuità genera infatti un movimento estatico, di uscita da sé.
La gratuità come offerta libera si sottrae pertanto alla logica econo175
mica dello scambio, implicitamente sottesa nel regalo, da cui pure il
dono deve essere distinto. Perché a differenza del regalo, che si situa
entro una situazione già data al cui interno solamente acquista senso,
il dono è capacità di generare situazioni nuove ed impreviste, che
non vincolano né umiliano, ma producono vera condivisione e liberazione autentica. Solo in effetti chi è stato raggiunto dalla donazione
ed ha sperimentato la gioia del ricevere gratuitamente, gratuitamente
può dare; può cioè continuare quel movimento di umanizzazione,
che rompe la logica violenta del dominio e dell’assoggettamento, cui
ancora il regalo ha parte e silenziosamente ed inconsapevolmente veicola. La gratuità del dono sconvolge invece le rigide determinazioni
di necessità, con le quali la consuetudine ha cercato e cerca ancora di
ingabbiare la vita entro forme sperimentate.
Ora, e questo nel quadro della presente ricerca merita di essere
opportunamente sottolineato, la medesima dinamica vale anche
nella dimensione teoretica; perché si dà una gratuità anche del e per
il pensiero. L’ordinaria e potente capacità di determinazione del
pensiero, grazie alla quale la costruzione logica cresce ben ordinata
e compaginata nelle sue strutture, non equivale anche alla capacità
di porre efficacemente il luogo di questa edificazione. Il terreno di
valori e principi su cui si impianta la riflessione pensante deve già
essere aperto ad essa. Questo è il forte messaggio che Parmenide
consegna alla nostra meditazione. Il suo Poema ci ha dischiuso l’orizzonte di una potenza di senso altrimenti preclusa alla condizione
dei mortali. E il fatto che da sempre abitiamo questo edificio culturale, non deve renderci insensibili e indifferenti a quanto dà forza a
questo edificio.
Siffatto orizzonte acquista infatti significatività solo quando il
pensiero dell’uomo si dispone all’accoglienza di un senso che lo oltrepassa, pur entrando pienamente nella storia; quando il logos cessa
di essere apparato violento di dominio, per scoprirsi interlocutore
privilegiato di una verità che lo interpella nel silenzio verace da cui
promana una parola gratuitamente donata; ché solo dall’ascolto nasce la consapevolezza mondana della verità. E solo quando il pensiero fa silenzio ed si incammina verso lo spazio di una riflessione
originaria – originaria perché originata da un appello, che nella sua
176
trascendenza lo suscita alla propria autentica vocazione – prendono
allora forma le questioni rilevanti della sapienza filosofica, verso le
quali abbiamo cercato di concentrare l’attenzione nelle pagine precedenti.
Non dunque l’abdicazione nei confronti di ogni forma di razionalità in quanto tale, ma l’esplorazione di un diverso paradigma di
razionalità, di un modello di una ragione sapienziale capace di restituire al lògos la sua pienezza originaria, è quanto in conclusione ci
invita a tentare il cammino fin qui fatto.
Per un nuovo paradigma filosofico
Lungi dall’abbandonare, bisogna perciò invece radicalizzare ulteriormente la funzione problematizzante del sapere filosofico2.
Anzi, forse proprio tale funzione si tratta di liberare dal sovraccarico
teorico che la imprigiona, confinandola negli ambiti oramai diventati angusti dell’epistème. Il passaggio, preliminare e necessario per
ogni sistema teorico, dell’esercizio di una ragion critica ovviamente
deve rimanere. Ciò che si propone è invece propriamente la rinuncia alla pretesa sistematica da parte della filosofia che si atteggia a
scienza, in nome e a vantaggio di una prassi teorica che sappia invece mantenersi aperta di fronte alla sovrabbondanza dell’Ulteriorità,
che la interpella dal silenzio e nel silenzio della rivelazione gratuita
2
Una prospettiva convergente di ricerca mi sembra rintracciabile nelle seguenti
considerazioni di Vincenzo Vitiello. «E se, per contro si dovesse cambiare strategia di
pensiero? Stabilire nuove – o forse più antiche – alleanze? Cercando l’amico e l’alleato dove per troppo tempo si è visto il nemico? Forse è la pretesa superiorità del diòti
– del perché – sull’hòti – sul “che” – all’origine dell’impasse in cui si trova, e non certo da oggi, il linguaggio della filosofia. Così dicendo, non vogliamo affatto suggerire
di mettere da parte argomentazioni e dimostrazioni […]; si invita a fare tutt’altro. E,
per iniziare, ad unire narrazione e argomentazione, fatto e commento, “certo” e
“vero” – per usare la terminologia di Vico. Una unione che non è semplice relazione, è piuttosto fusione, nella quale ciascun membro come espone (narra), così esplica
(commenta, interpreta, critica) l’altro. Senza subordinazione alcuna. Senza gerarchia.
Neppure quella inversa alla moderna, quella che talora si celebra nel cosiddetto
post-moderno, la subordinazione del logos al mythos – sulla base di una pretesa maggior “ricchezza” del mito. Forse dovremo apprendere a mythologhein» (Vincenzo
VITIELLO, Dire Dio in segreto, Città Nuova, Roma 2005, p. 85).
177
della Verità. Più che alla improbabile chiusura del cerchio teoretico, preoccupato di trovare la risposta – una risposta tendenzialmente esaustiva – ad ogni questione che possa incontrare l’uomo nel
corso della sua esistenza, il filosofo dovrà lavorare a rendere disponibile lo spazio della domanda, lasciando che un’interrogazione
sempre rinnovata dello stesso faccia avanzare nell’approfondimento
della inesauribile rivelazione della Verità.
Lévinas ha opposto in questo senso alla figura di Ulisse, simbolo
del pensiero rappresentativo che, come l’eroe greco, torna a casa
propria orgoglioso di sé, la fiducia nell’Altro di Abramo, metafora
di un pensiero che si svolge nella gratuità e nella riconoscenza3. La
filosofia trova qui il suo fertile terreno di coltura. Essa deve pertanto
ritornare a pensarsi alla maniera dei primi pensatori, come filosofˆa, ricerca aperta di una sapienza mai compiutamente attingibile, misteriosa eppure eloquente nelle forme che l’uomo è chiamato
a ricongiungere nel disegno simbolico della verità, custodia di ciò
che più caro è donato all’uomo che ricerca la verità.
Al contrario di quanto realizzato da Hegel, nello sforzo prometeico di un pensiero totale, occorre pertanto avere la forza di rifiutare l’identificazione della filosofia con la scienza (il che non significa affatto delegittimazione della scienza stessa) e l’umiltà – una
umiltà che è categoria di un rinnovato ethos filosofico – di restituire
alla filosofia tutta la pregnanza che il suo nome racchiude4.
È il paradigma di una sapienza filosofica nuova, o meglio, antica
quello che si propone; di una sapienza che non viene immediatamente ad identificarsi con quanto la razionalità apodittica, che intimamente permea la scienza, progetta e produce nel suo costante
3
Emmanuel LÉVINAS, La traccia dell’Altro, in E. BACCARINI, Lévinas. Soggettività e infinito, Studium, Roma 1985, p. 95.
4 Ancora una volta Vitello può venirci in aiuto. «La strategia della filosofia è stata
molto sottile. Ha convertito non il dubbio, ma la fonte del dubbio in fondamento di
certezza. Ha fatto del “perché” interrogativo il principio stesso di spiegazione e dimostrazione. Se non si può spiegare perché il Giorno rinasce dalla Notte, ciò è dovuto al fatto che non la Notte è prima del Giorno, ma il Giorno prima della Notte.
[…] Pertanto non sono vere le storie che raccontano theològoi e physikòi, non ci fu
per un tempo indefinito Caos e Notte, ma tautà aeì : sempre le stesse cose. La filosofia vince negando l’origine» (Vincenzo VITIELLO, op. cit., pp. 43-44).
178
impegno di risolvere le sconnessioni nel sistema della conoscenza.
La sapienza di cui parliamo adotta una ragione che si muove nella
dimensione della confidenza e della fiducia, pronta a lasciarsi istruire e guidare verso il luogo sorgivo della verità; una ragione dunque
che non teme di lasciarsi decentrare da se stessa, perché sa prestare
attenzione a quanto la supera riempiendola. Essa infatti sa che all’incontro con la verità si giunge solo allorché il rumore delle cose sia
oltrepassato verso l’orizzonte della verità. E la verità – che, come ci
ha insegnato Parmenide, dobbiamo imparare a riconoscere nella sua
soggettività come l’altro nome del principio – la verità nel suo stesso rivelarsi genera l’orizzonte supremo entro cui solamente le cose
stesse acquistano il loro senso. Tale orizzonte, che non siamo noi a
costituire ed entro il quale solamente i nostri orizzonti percettivi
trovano collocazione, la filosofia che voglia ancora essere ricerca di
sapienza deve segnalare.
Non si tratta più di rappresentare eideticamente un kÒsmoj
noetÒj, ma più semplicemente di riconoscere la strada sulla quale
siamo già posti e lungo la quale camminiamo da tempo e nel tempo. Perché la scena della verità è per noi, ma non siamo noi a porla.
Essa si è rivelata nella storia e non si può fare come se ciò non fosse
accaduto.
Rammemorare la propria tradizione, portando avanti il processo millenario e pur sempre nuovo di render ragione del senso del
proprio esistere mondano, senza pretendere di rifondare ogni volta
daccapo il principio che orienta, ecco la consegna che oggi con più
forza interpella la responsabilità della filosofia. Alla quale anche
questo lavoro ha cercato per parte sua di contribuire.
179
BIBLIOGRAFIA
Edizioni e Traduzioni dei frammenti
ALBERTELLI Pilo, Sulla natura in Gli Eleati. Testimonianze e frammenti, Laterza, Bari
1939. Ristampato in I Presocratici. Testimonianze e frammenti, Laterza, Roma-Bari
1979.
BEAUFRET Jean, Le poème de Parménide, PUF 1955.
BURNET John, Early Greek Philosophy, Black, London-Edinburgh 1892.
CERRI Giovanni, Parmenide, Poema sulla natura, Rizzoli, Milano 1999.
CORDERO Nestor-Louis, Le poème de Parménide in Les deux chemins de Parménide. Edition critique, traduction, études et bibliographie, Vrin - Éditions Ousia, Paris-Bruxelles
1984, pp. 15-42.
COULOUBARITSIS Lambros, Le poème de Parménide, in Mythe et philosophie chez Parménide, Éditions Ousia, Paris-Bruxelles 1986, pp. 368-379.
DIELS Hermann - KRANZ Walther, Die Fragmente der Vorsokratiker, Wiedmann, Berlin 19526.
MOSCARELLI Enrico, Della Natura, in PARMENIDE DI ELEA, Della Natura, Supplemento a Porta di Massa. Laboratorio Autogestito di Filosofia Epistemologia e Scienze Politico-Sociali autunno 2005/inverno 2006.
FRÈRE Jean - O’BRIEN Denis, Le poème de Parménide. Texte et traduction, in Pierre
AUBENQUE (ed.), Études sur Parménide, Vrin, Paris 1987, pp. 1-134.
PASQUINELLI Angelo, Della Natura, in I Presocratici, Einaudi, Torino 1958.
REALE Giovanni, I frammenti del Poema di Parmenide “Sulla natura”, in PARMENIDE,
Poema sulla natura. I frammenti e le testimonianza indirette, Rusconi, Milano 1991.
TARÀN Leonardo, Parmenides. A Text with Translation, Commentary and Critical Essay,
Princeton Univerity Press, Princeton 1965.
UNTERSTEINER Mario, Sulla Natura in Parmenide, La Nuova Italia, Firenze 1958.
ZAFIROPULO Jean, Perì physeos, in L’école éléate. Parménide - Zénon - Mélissos, Les Belles Lettres, Paris 1950.
Studi su Parmenide
ADEMOLLO Francesco, Vecchi e nuovi contributi all’interpretazione parmenidea, «Prometheus», XX, 1994, pp. 27-43.
ADORNO Francesco, Da Platone a Parmenide, da Parmenide a Platone, «La Parola del
Passato», XLIII, 1988, pp. 7-18.
AUBENQUE Pierre, Syntaxe et sémantique de l’être dans le Poème de Parménide, in Pierre
AUBENQUE (ed.), Études sur Parménide, II: Problèmes d’interprétation, Vrin, Paris
1987, pp. 102-134.
181
BEAUFRET Jean, Introduction à une lecture du Poème de Parménide in Jean BEAUFRET
(ed.), Le Poème de Parménide, Presses Universitaires de France, Paris 1955, pp
1-73.
BODOR Maria Anna, La dimension cosmique et religieuse de l’existence humaine. L’aurore de
la philosophie grecque, Pontificia Università Lateranense, Roma 2007.
BÖHME Robert, Die verkannte Muse. Dichtersprache und geistige Tradition des Parmenides,
Francke, Bern 1986.
BRAGUE Remi, La vraisemblance du faux. Parménide fr. 1,31-32, in Pierre AUBENQUE
(ed.), Études sur Parménide, II: Problèmes d’interprétation, Vrin, Paris, 1987, pp.
44-68.
BRÖCKER Walter, Parmenides ’Al¾deia”, «Hermes», CVI, 1978, pp. 504-505.
BRÖCKER Walter, Gorgias contra Parmenides, «Hermes», LXXXVI, 1986, pp.
425-440.
BURNET John, Early Greek Philosophy, Black, London-Edinburgh 1892.
CALOGERO Guido, Studi sull’eleatismo, Tipografia del Senato, Roma 1932.
CALOGERO Guido, Parmenide e la genesi della logica classica, Annali della Scuola Normale
Superiore di Pisa, S. II, 1936, pp. 143-185.
CAPIZZI Antonio, Quattro ipotesi eleatiche, «La Parola del Passato», XLIII, 1988, pp.
42-60.
CAPIZZI Antonio, Introduzione a Parmenide, Laterza, Bari 1975.
CASERTANO Giovanni, Parmenide, il metodo, la scienza e l’esperienza, Loffredo, Napoli
1978.
CASERTANO Giovanni, Astrazione ed esperienza. Parmenide (e Protagora), «La Parola del
Passato», XLIII, 1988, pp. 61-80.
CASSIN Barbara - NANCY Michel, Parménide sophiste. La citation aristotélicienne du fr.
16, in Pierre AUBENQUE (ed.), Études sur Parménide, II: Problèmes d’interprétation,
Vrin, Paris 1987, pp. 277-293.
CASSIN Barbara, Le chant des Sirènes dans le Poème de Parménide. Quelques remarques sur le
fr. 8,26-33, in Pierre AUBENQUE (ed.), Études sur Parménide, II: Problèmes d’interprétation, Vrin, Paris 1987, pp. 163-169.
CASSIRER Ernst, Die Philosophie der Griechen von den Anfangen bis Platon, in Gesammelte
Werke, Meiner, Hamburg, Bd. XVI.
CAVARERO Adriana, Platone e Hegel interpreti di Parmenide, «La Parola del Passato»,
XLIII, 1988, pp. 81-99.
CERRI Giovanni, Introduzione a PARMENIDE, Poema sulla natura, a cura di G. Cerri,
Rizzoli, Milano 1999, pp. 7-110.
COLLI Giorgio, La natura ama nascondersi, Adelphi, Milano, 1988.
COLLI Giorgio, Gorgia e Parmenide, Adelphi, Milano, 2003.
COLLOBERT Catherine, L’être de Parménide ou le refus du temps, Kimé, Paris 1993.
CORDERO Nestor-Louis, Le vers 1,3 de Parménide. La déesse conduit á l’égard de tout, Revue Philosophique de la France et de l‘Étranger, 1982, 2, pp. 159-179.
CORDERO Nestor-Louis, Les deux chemins de Parménide, Vrin-Ousia, Paris-Bruxelles
1984.
182
CORDERO Nestor-Louis, L’histoire du texte de Parménide, in Pierre AUBENQUE (ed.),
Études sur Parménide, II: Problèmes d’interprétation, Vrin, Paris 1987, pp. 3-24.
COULOUBARITSIS Lambros, Les multiples chemins de Parménide, in Pierre AUBENQUE
(ed.), Études sur Parménide, II: Problèmes d’interprétation, Vrin, Paris 1987, pp.
25-43.
COULOUBARITSIS Lambros, Mythe et philosophie chez Parménide, Ousia, Bruxelles
19902.
DERAMAIX Patrice, Les chemins de la pensée – sur Parménide, http://membres.lycos.fr/patderam/texte.htm.
DIELS Hermann, Parmenides Lehrgedicht, Akademia, Sankt Augustin, 20032 (18971).
DILTHEY Wilhelm, Einleitung in die Geisteswissenschaften, G. Teubner, Stuttgart 1959.
EBNER Pietro, Parmenide medico OULIADHS, in Velia e la Scuola di Medicina, Centro di
Promozione culturale per il Cilento, Acciaroli (SA) 1966, pp. 35-51.
FERRARI Mario Valentino, Partendo da Parmenide, «Sapienza», XLV, 1992, pp.
421-424.
FRÈRE Jean, Parménide et l’ordre du monde: fr. 8,50-61, in Pierre AUBENQUE (ed.),
Études sur Parménide, II: Problèmes d’interprétation, Vrin, Paris 1987, pp. 192-212.
GADAMER Hans-Georg, Kurt Riezlers Parmenidesdeutung, «Gnomon», 1936, 2, pp.
37-86.
GADAMER Hans-Georg, Zur Vorgeschichte der Metaphysik, in «Anteile». M. Heidegger
zum 60. Geburtstag, N. Klostermann, Frankfurt a. M. 1950, pp. 51-79.
GADAMER Hans-Georg, Retraktationen zum Lehrgedicht des Parmenides in Varia Variorum. Festgabe für K. Reinhardt, Böhlau-Verlag, Münster - Köln 1952, pp. 58-68.
GADAMER Hans-Georg, I presocratici, in AA.VV., Questioni di storiografia filosofica, La
Scuola, Brescia 1975, vol. 1.1, pp. 13-114.
GADAMER Hans-Georg, Parmenides oder das Diesseits des Seins, «La Parola del Passato»,
XLIII, 1988, pp. 143-176.
GADAMER Hans-Georg, Parmenide, Rai Educational.
GERMANI Gloria, ’Aleqe…h in Parmenide, «La Parola del Passato», XLIII, 1988, pp.
177-206.
GEYMONAT Ludovico, Storia del pensiero filosofico e scientifico, Garzanti, Milano
1970-72.
GIANNANTONI Gabriele, Le due vie di Parmenide, «La Parola del Passato», XLIII,
1988, pp. 207-221.
GIGANTE Marcello, Elea Bizantina, «La Parola del Passato», XLIII, 1988, pp.
222-223.
GIGANTE Marcello, Parmenide Ouliade, «La Parola del Passato», XIX, 1964, pp.
450-452.
GOMPERZ Thomas, Griechische Denker, de Gruyter, Berlin 1973.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Vorlesung über die Geschichte der Philosophie in Sämtliche Werke, hrsg. v. H. Glockner, Bd.e 17-19, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1959.
HEIDEGGER Martin, Die Grundbegriffe der antiken Philosophie, in Gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt a. M. 1993, Bd. XXII.
183
HEIDEGGER Martin, Einführung in die Metaphysik, Niemeyer, Tübingen 1966. Ora in
Gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt a. M. 1983, Bd. XL.
HEIDEGGER Martin, Parmenides, in Gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt a. M.
1982, Bd. LIV.
HEIDEGGER Martin, Moira (Parmenide, VIII, 34-41), in Vorträge und Aufsätze, Neske,
Pfüllingen, 1957. Ora in Gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt a. M. 2000,
Bd. VII.
HEIDEGGER Martin Vier Seminare, Klostermann, Frankfurt a. M. 1977. Ora in Gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt a. M. 1986, Bd. XV.
HEINRICH Klaus, Parmenides und Jona. Vier Studien über das Verhältnis von Philosophie
und Mythologie, Stroemfeld, Basel 19822.
HELD Klaus, Heraklit, Parmenides und der Anfang von Philosophie und Wissenschaft. Eine
phänomenologische Besinnung, de Gruyter, Berlin 1980.
IMBRAGUGLIA Giorgio, Via della Demone o via del Nume?, «Filosofia oggi», VIII, 1985,
2, pp. 233-284.
ISNARDI PARENTE Margherita, Il Parmenide di Plutarco, «La Parola del Passato», XLIII,
1988, pp. 225-236.
IOTTI Rita, La retorica del mythos e del logos nel Poema di Parmenide, «Philologica», IV,
1995, 7, pp. 65-75.
JÄGER Werner, Paideia. Die Formung der griechischen Menschen, de Gruyter, BerlinLeipzig 1934-1944.
JANTZEN Jörg, Parmenides zum Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit, Beck,
München 1976.
JASPERS Karl, Die großen Philosophen, Piper & Co. Verlag, München 1957.
KAHN Charles H., Being in Parmenides and Plato, «La Parola del Passato», XLIII, 1988,
pp. 237-261.
KAHN Charles H., The Thesis of Parmenides, «The Review of Metaphysics», 1968,
n. 22, pp. 700-724.
KIRK Geoffrey S. - RAVEN E., The Presocratic Philosophers, Cambridge University
Press, Cambridge 1957.
LAKS André, Parménide dans Théophraste, De sensibus 3-4, «La Parola del Passato»,
XLIII, 1988, pp. 262-280.
LESZL Walter, Un approccio “epistemologico” all’ontologia parmenidea, «La Parola del Passato», XLIII, 1988, pp. 281-311.
MANSFELD Jaap, Die Offenbarung des Parmenides und die menschliche Welt, van Gorcum,
Assen 1964.
MEIJER Peter Ane, Parmenides beyond the gates: the divine revelation on being, thinking, and
the doxa, J.C. Gieben, Amsterdam 1997.
MELCHIORRE Virgilio, L’analogia del giorno e della notte. Appunti per una lettura di Parmenide, in Metafisica e modernità. Studi in onore di Pietro Fagiotto, Antenore, Padova
1993, pp. 3-26.
MICHAELSTAEDTER Carlo, Parmenide ed Eraclito. Empedocle. Appunti di filosofia, SE,
Milano 2005.
184
MOLINARO Aniceto, Il senso arcaico dell’essere in Frammenti di una metafisica, Edizioni
Romane di Cultura, Roma 2000, pp. 11-18.
MONDOLFO Rodolfo, La comprensione del soggetto umano nell’antichità classica, La Nuova Italia, Firenze 1956.
NAPOLI Mario, La ricerca archeologica di Velia, «La Parola del Passato», CVI, 1966, pp.
191-226.
NIETZSCHE Friedrich, Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen, in Werke. Kritische Gesamtausgabe, hrsgg. G. Colli e M. Montanari, De Gruyter, Berlin 1967,
Bd. 3.2.
O’BRIEN Denis, Introduction à la lecture de Parménide: les deux voies de l’être et du non-être.
Essai critique, in Pierre AUBENQUE (ed.), Études sur Parménide, Vrin, Paris 1987, I,
pp. 135-310.
O’BRIEN Denis, L’être et l’éternité, in Pierre AUBENQUE (ed.), Études sur Parménide,
Vrin, Paris 1987, II: Problèmes d’interprétation, pp. 135-162.
O’BRIEN Denis, Problèmes d’établissement du texte, in Pierre AUBENQUE (ed.), Études
sur Parménide, Vrin, Paris 1987, II: Problèmes d’interprétation, pp. 314-350.
OWEN Gwilym Ellis Lane, Eleatic Questions, Classical Quarterly, 10, 1960, pp. 84-102.
POPPER Karl, The World of Parmenides. Essay on the Presocratic Enlightenment, Rutledge,
London 1998.
PUGLIESE CARRATELLI Giovanni, Parmenides physikos, «La Parola del Passato», XX,
1963, pp. 385-386.
PUGLIESE-CARRATELLI Giovanni, La Thea di Parmenide, «La Parola del Passato»,
XLIII, 1988, pp. 337-346.
PULPITO Massimo, Parmenide e la negazione del tempo. Interpretazioni e problemi, LED,
2005.
REALE Giovanni, Un Parmenide nuovo in PARMENIDE. Poema sulla natura, Rusconi,
Milano 1991, pp. 7-17.
REINHARDT Karl, Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie, Klostermann, Frankfurt a. M. 19773 (19161).
ROBIN Leon, La pensée grecque et les origines de l’esprit scientifique, Éditions Albin Michel,
Paris 1948.
RUGGIU Luigi, Parmenide, Marsilio, Venezia 1975.
RUGGIU Luigi, Unità e molteplicità in Parmenide, «La Parola del Passato», XLIII, 1988,
pp. 347-372.
RUGGIU Luigi, L’altro Parmenide in PARMENIDE. Poema sulla natura, Rusconi, Milano 1991, pp. 19-81.
RUGGIU Luigi, Commentario filosofico al Poema di Parmenide “Sulla natura”, in PARMENIDE, Poema sulla natura, Rusconi, Milano 1991, pp. 153-380.
RUGGIU Luigi, Heidegger e Parmenide, in RUGGENINI Mario (ed.)., Heidegger e la metafisica, Marietti, Genova 1991, pp. 49-81.
RUGGIU Luigi, Parmenide di Elea, in Enciclopedia Multimediale della scienze filosofiche,
Istituto Enciclopedia Italiana, Roma 1993.
185
SAMBURSKY Shmuel, The development of physical Thought from Newton to Einstein and
the Quantum Physicists in the Light of the Eleatic Philosophy, «La Parola del Passato»,
XLIII, 1988, pp. 373-382.
SANGIACOMO Andrea, La sfida di Parmenide. Verso la rinascenza, Il prato, Saonara s.d
(2007).
SASSI Maria Michela, Parmenide al bivio. Per un’interpretazione del Proemio, «La Parola
del Passato», XLIII, 1988, pp. 383-386.
SCHÜRMANN René, Le différend hénologique. La loi de l’un et la loi des contraires, «La Parola del Passato», XLIII, 1988, pp. 397-419.
SCHWABL Hans, Sein und Doxa bei Parmenides, Wiener Studien, 66, 1953, pp. 50-75;
ora in GADAMER Hans-Georg (ed.), Um die Begriffswelt der Vorsokratiker,
Darmstadt 1968, pp. 391-422.
SEVERINO Emanuele, Essenza del nichilismo, Paideia, Brescia 19822.
SEVERINO Emanuele, Intervista: Parmenide, Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche, http://www.emsf.rai.it.
SINI Carlo, Metodo e filosofia, Unicopli, Milano 1986.
SZABÓ Arpad, Die Philosophie der Eleaten und die Mathematik der Griechen, «La Parola
del Passato», XLIII, 1988, pp. 420-445.
TARÁN Leonardo, Parmenides. A Text with Translation, Commentary and Critical Essay,
Princeton Univerity Press, Princeton 1965.
TUGENDHAT Ernst, Das Sein und das Nichts, in Durchblicke. Martin Heidegger zum 80.
Geburtstag, Klostermann, Frankfurt a. M. 1970, pp. 132-161.
UNTERSTEINER Mario, Introduzione a PARMENIDE, Testimonianze e frammenti,a cura
di M. Untersteiner, La Nuova Italia, Firenze 1958, pp. XXVII-CCX.
VILLANI Artaud, La tenue ontologique dans le Poème de Parménide, Revue de Métaphysique et de Morale, 1998, 3, pp. 291-315.
VIOLA Coloman, Aux origines de la gnoséologie. Réflexions sur le sens du fr. IV du Poème de
Parménide, in Pierre AUBENQUE (ed.), Études sur Parménide, Vrin, Paris 1987, II:
Problèmes d’interprétation, pp. 69-101.
VOCCIA Enrico, Il discorso sulla Realtà, in PARMENIDE DI ELEA, Della Natura, Supplemento a Porta di Massa. Laboratorio Autogestito di Filosofia Epistemologia e Scienze Politico-Sociali autunno 2005/inverno 2006, pp. 3-21.
WIESNER Jürgen, Überlegungen zu Parmenides fr. 8,34, in Pierre AUBENQUE (ed.),
Études sur Parménide, Vrin, Paris 1987, II: Problèmes d’interprétation, pp. 170-191.
ZAFIROPULO Jean, L’école éléate. Parménide – Zénon – Mélissos, Les Belles Lettres, Paris
1950.
Altre Opere
AA.VV., Il mito in questione numero speciale di «Aut-Aut» - 1991, NS, nn. 243-244.
AA.VV., Il ritorno del mito nella società e nella cultura del Novecento numero speciale di «Paradigmi» 1995, XII, n. 39.
ARISTOTELE, Protreptico, a cura di E. Berti, Il Tripode, Napoli 1994.
ARISTOTELE, Opere, a cura di G. Giannantoni, Laterza, Roma-Bari 1973.
186
ARISTOTELE, Metafisica, a cura di G. Reale, Vita e Pensiero, Milano 1993.
ARISTOTELE, Etica Nicomachea, a cura di C. Mazzarelli, Rusconi, Milano 1998.
BACON Francis, Novum Organum, in The Works of Francis Bacon, London 1858, vol. 1.
BLUMENBERG Hans, Arbeit am Mythos, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1979.
CACCIARI Massimo, Dell’inizio, Adelphi, Milano 20012.
CAPRA Fritjof, The Tao of Physics, F. Capra, London 1975.
CARCHIA Gianni, Mito. Esperienza del presente e critica della demitizzazione, «Aut Aut»,
1991, NS, nn. 243-244, pp. 3-9.
CARNAP Rudolf, Die Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache,
«Erkenntins», II, 1932, pp. 219-241.
CARTESIO, Discours de la méthode, in Oeuvres de Descartes, Paris 1965, vol. VI.
CARTESIO, Principia philosophiae, in Oeuvres de Descartes, Paris 1965, vol. VIII.
COLLI Giorgio, La sapienza greca, Adelphi, Milano 1990.
D’AGOSTINI Franca, Analitici e continentali. Guida alla filosofia degli ultimi trent’anni,
Cortina 1997.
DAMASIO Antonio R., E dal corpo nacque l’anima: le emozioni nell’evoluzione, «Micromega», 2007, 2, pp. 63-71.
DIOGENE LAERZIO, Vite dei filosofi, a cura di M. Gigante, Laterza, Roma-Bari 1976 .
Meister ECKHART, Deutsche Werke. I-IV: Predigten, Kohlhammer, Stuttgart
1958-1997.
ERODOTO, Le Storie, UTET, Torino 1996.
ESCHILO, Le tragedie, Mondadori, Milano 2007.
ESIODO, Teogonia, Rizzoli, Milano 1984.
FEYERABEND Paul, Galileo e la tirannia della verità, «L’astronomia», 1987, 71, pp.
28-36.
FINK Eugen, Nietzsches Philosophie, Kohlhammer, Stuttgart 1960.
FORTE Bruno, In Ascolto dell’Altro. Filosofia e rivelazione, Morcelliana, Brescia 1995.
FRATTICCI Walter, Il filosofo e il padre: le ragioni di un silenzio, «Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia», 2, 2000, http://www.mondodomani.org/dialegesthai.
FRATTICCI Walter, Sapere il sapore. La Filosofia tra Fede e Ragione, «Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia», 7, 2005, http://www.mondodomani.org/dialegesthai.
FRYE Northrop, The great code: the Bible and literature, Routledge & Kegan, London
1982.
FRITZ Kurt (von), Nous, noein and their derivates in Pre-socratic philosophy. I: from beginnings to Parmenides. II: the Post-Parmenidean Period, «Classical Philology», 1945, n.
40, pp. 223-242; n. 41, pp. 12-34.
GADAMER Hans-Georg, Wahrheit und Methode, Mohr, Tübingen 19723.
GALIMBERTI Umberto, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano
2002.
GILSON Étienne, L’être et l’essence, Vrin, Paris 1948.
GIRARD René, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Éditions Grasset & Fasquelle, Paris 1978.
187
GIVONE Sergio, Storia del nulla, Laterza, Roma-Bari 1995.
HABERMAS Jürgen, Noch einmal: Zum Verhältnis von Theorie und Praxis, «Paradigmi»,
XV, 1997, 45, pp. 431-32.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Verhältnis des Skeptizismus zur Philosophie, Darstellung seiner verschiedenen Modifikationen und Vergleichung des neuesten mit dem alten,
«Kritisches Journal der Philosophie», Tübingen, 1802, I, 2; in Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe, Stuttgart 1949-19593, I, pp. 215-275.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Phänomenologie des Geistes, Bamberg und
Würzburg, 1807; in «Gesammelte Werke», Bd.9, Meiner, Hamburg 1980.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Wissenschaft der Logik, Nürnberg 1812-1816; in
«Gesammelte Werke», Bd.e 11-12, Meiner, Hamburg 1978.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Berlin, 18303; in «Gesammelte Werke», Bd. 20, Meiner, Hamburg 1992.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Nicolai, Berlin, 1821; in «Gesammelte Werke», Bd.9, Meiner, Hamburg 1980.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, in
«Sämtliche Werke», hrsg. v. Glockner, Bd.e 15-16, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1965.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Briefe von und an Hegel, hrsg. v. J. Hoffmeister, Meiner, Hamburg 1952-1960.
HEIDEGGER Martin, Sein und Zeit, Niemeyer, Tübingen 1927. Ora in Gesamtausgabe,
Klostermann, Frankfurt a. M. 1977, Bd. II.
HEIDEGGER Martin, Was ist Metaphysik?, Cohen, Bonn 1929. Ora in Gesamtausgabe,
Klostermann, Frankfurt a. M. 1976, Bd. IX.
HEIDEGGER Martin, Von Wesen des Grundes, «Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung», 1929, pp. 71-110. Ora in Gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt a. M. 1976, Bd. IX.
HEIDEGGER Martin, Platons Lehre von der Wahrheit, «Geistige Überlieferung. Das
zweite Jahrbuch», 1942, pp. 96-124. Ora in Gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt a. M. 1976, Bd. IX.
HEIDEGGER Martin, Der Spruch des Anaximander, in Holzwege, Klostermann, Frankfurt a. M. 1950. Ora in Gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt a. M. 1977,
Bd. V.
HEIDEGGER Martin, Identität und Differenz, Gesamtsausgabe Bd. 11, Klostermann,
Frankfurt a. M. 2006.
HEIDEGGER Martin, Nietzsche, Neske, Pfüllingen 1961.
HEIDEGGER Martin, Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens, in Zur Sache
des Denkens, Niemeyer, Tübingen 1969, pp. 62-80. Ora in Gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt a. M. 2007, Bd. 14.
HEISENBERG Werner, Physics and Philosophy, Harper Torchbooks, New York 1958.
HORKHEIMER Max - ADORNO Theodor W., Dialektik der Aufklärung. Philosophische
Fragmente, Fischer, Frankfurt a. M. 19692.
KANT Immanuel, Versuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen,
Königsberg 1763.
188
KANT Immanuel, Kritik der reinen Vernunft, Hartknoch, Riga 17872; in Kants Werke,
Akademie Textausgabe, Bd. 3, De Gruyter, Berlin-New York 1968.
KOJÈVE Alexandre, Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la Phénoménologie de
l’Esprit, Gallimard, Paris 1947.
JESI Furio, Mito, Mondadori, Milano 1989.
JONAS Hans, Das Prinzip Verantwortung, Insel, Frankfurt 1979.
LAURENTI Renato, Introduzione a Talete Anassimandro Anassimene, Laterza, Bari 1971.
LÉVINAS Emmanuel, Totalité et infini, Niyhoff, La Haye 1961.
LÉVINAS Emmanuel, La trace de l’Autre, «Tijdschrift voor Filosofie», 1963, pp.
605-623.
LÉVINAS Emmanuel, Entre nous. Essai sur le penser-à-l’autre, Éditions Grasser et Fasquelle, Paris 1991.
LÉVINAS Emmanuel, Dieu, la Mort et le Temps, Éditions Grasset e Fasquelle, Paris
1993.
LIVI Antonio, Metafisica e senso comune, Leonardo da Vinci, Roma 2007.
LYOTARD François, La condition postmoderne, Les Editions de Minuit, Paris 1979.
LOCKE John, Essay on human Understanding, Dover, New York 1959.
MARX Karl, Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie, in Karl
MARX, Friedrich ENGELS, Werke, Dietz, Berlin 1953, Bd. I.
MOLINARO Aniceto, Filosofia come fondamento, in ALES BELLO Angela, MESSINESE
Leonardo, MOLINARO Aniceto (edd.), Fondamento e fondamentalismi, Città Nuova, Roma 2004, pp. 171-187.
NESTLE Wilhelm, Vom Mythos zum Logos. Die Selbstentfaltung des griechischen Denkens
von Homer bis auf die Sofistik und Sokrates, Kröner, Stuttgart 19422.
OMERO, Odissea, Einaudi, Torino 1963.
ORAZIO, Le Opere, UTET, Torino 19692.
PAREYSON Luigi, Ontologia della libertà, Einaudi, Torino 20002.
PASCAL Blaise, Oeuvres complètes, Desclée de Brouwer, Paris 1964-1992, 3 voll.
PLATONE, Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1991.
POPPER Karl R., Conjectures and Refutation. The Growth of Scientific Knowledge, Harper,
New York 1963.
QUINE Willard v.O., Two Dogmas of Empirism, «The Philosophical Review», 60,
1951 pp. 20-43; ripubblicato in From a Logical Point of View, Harvard University
Press, Harvard 19612.
REALE Giovanni, Saggezza antica. Terapia per i mali dell’uomo d’oggi, Cortina, Milano
1995.
ROSENKRANZ Karl, Hegel’s Leben, Berlin, 1844 (rist. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1988).
SEMERANO Giovanni, L’infinito: un equivoco millenario, B. Mondadori, Milano 2001.
SENOFONTE, Memorabili, Rizzoli, Milano 1989.
SEVERINO Emanuele, La struttura originaria, Adelphi, Milano 19812.
SEVERINO Emanuele, Destino della necessità, Adelphi, Milano 1980.
189
SNOW Charles P., The two cultures: and a second look: an expanded version of The two cultures and the scientific revolution, Cambridge University Press, Cambridge 1969.
TOMMASO d’Aquino, Summa Theologiae.
VITIELLO Vincenzo, Dire Dio. In segreto, Città Nuova, Roma 2005.
WATSON James D., DNA. The secret of life, DNA Show LCC, 2003.
WITTGENSTEIN Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, Routledge and Kegan, London 1961.
ZELLER Eduard - REALE Giovanni, La filosofia dei greci nel suo sviluppo storico, La Nuova Italia, Firenze 1967.
190
INDICE
PRESENTAZIONE
PREFAZIONE
INTRODUZIONE
La crisi della filosofia
Un nuovo slancio
Ritornare a Parmenide
La gratuità della verità
3
7
11
11
14
16
20
METAMORFOSI DELLA FILOSOFIA
Filosofˆa
Il logos filosofico dell’occidente
LÕgoj ¢podeiktikÕj
La metafora ottica
In ascolto della verità
23
23
33
42
48
54
PARMENIDE E L’EPISTÈME
Il tradimento interpretativo
La necessità dell’essere
Il ritorno a Parmenide di Severino
La confutazione come affermazione dell’incontrovertibile
Dire il nulla per dire l’essere
Lo scacco dell’epistème
59
63
68
75
80
84
87
IL BIVIO DI PARMENIDE
1. Alle origini del pensare parmenideo: la questione dell’essere
Oltre la tautologia
Anassimandro e la finitudine ontologica
L’esperienza parmenidea dell’essere
L’essere come stabilità
B. Il bivio come luogo della decisione per l’essere
Impensabilità del non essere?
Logica e ontologia
C. Il linguaggio della verità
PistÕj lÒgoj
La kr…sij decisiva
93
95
99
104
111
119
123
130
143
151
158
165
LA GRATUITÀ DELLA VERITÀ
La verità come gratuità
Per un nuovo paradigma filosofico
171
175
177
BIBLIOGRAFIA
181
191
EDIZIONI CANTAGALLI
Via Massetana Romana, 12
Casella Postale 155
53100 Siena
Tel. 0577 42102 Fax 0577 45363
www.edizionicantagalli.com
e-mail: [email protected]