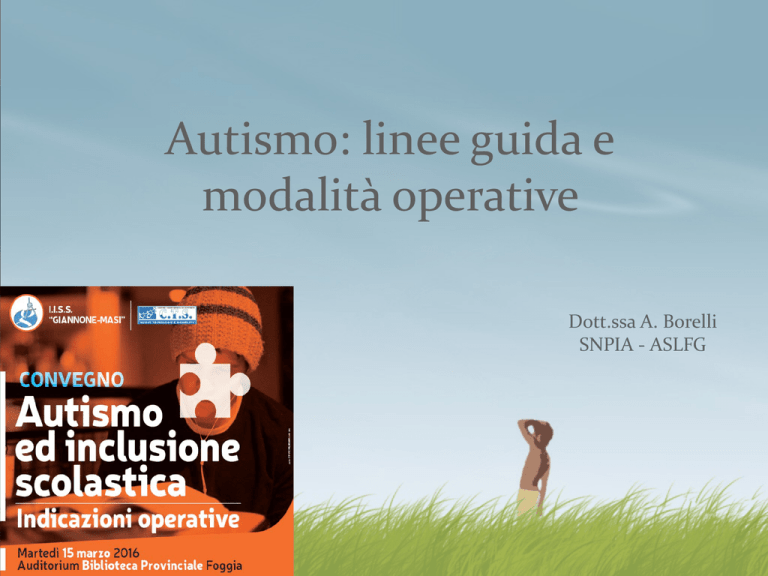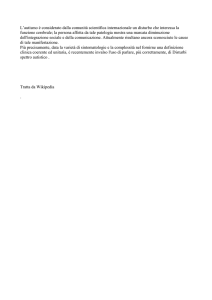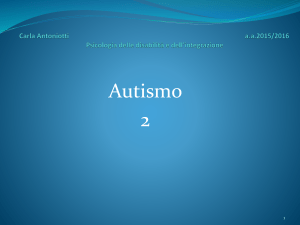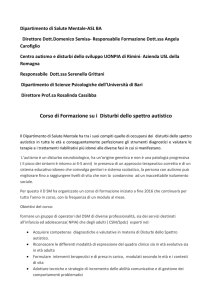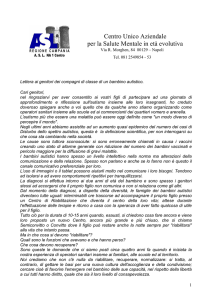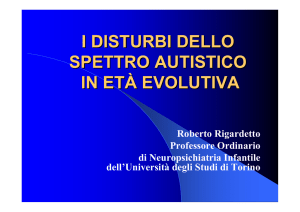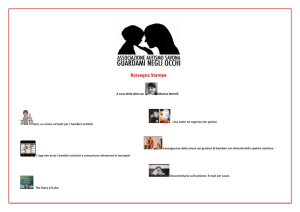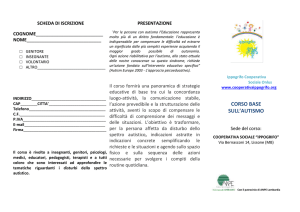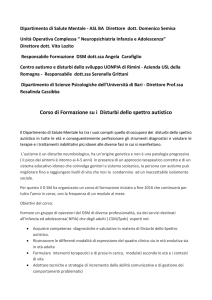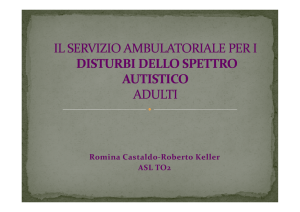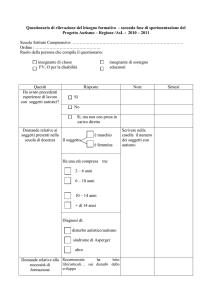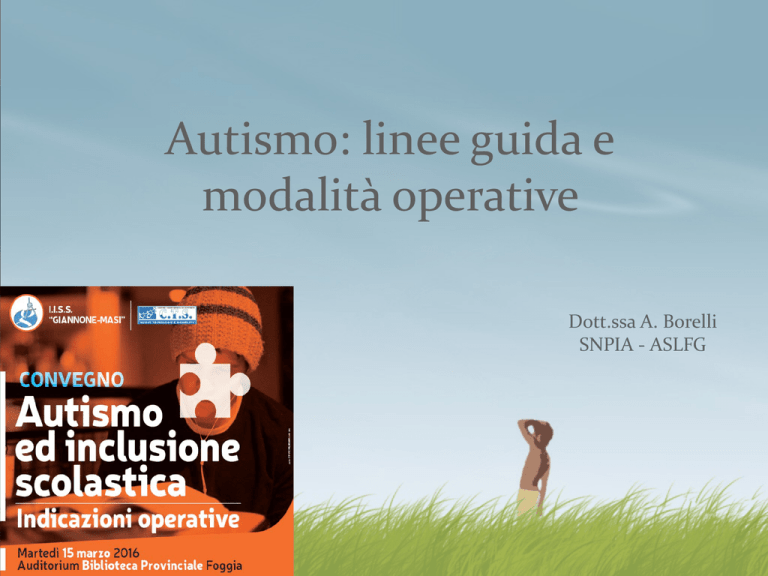
Autismo: linee guida e
modalità operative
Dott.ssa A. Borelli
SNPIA - ASLFG
Neurotipicità
Ventaglio di variazioni delle condotte
Appropriatezza alla specifica fase evolutiva
Capacità di adattamento e flessibilità
Assenza di malattia
Sensazione di benessere
Progettualità
DSM 5
Criterio A: Deficit persistenti nella comunicazione sociale
e nell’interazione sociale in molteplici contesti
Criterio B: Pattern di comportamento, interessi o attività
ristretti, ripetitivi
Criterio C: I sintomi devono essere presenti nel periodo
precoce dello sviluppo
Criterio D: I sintomi causano compromissione
clinicamente significativa del funzionamento in ambito
sociale, lavorativo o in altre aree importanti
Criterio E: Queste alterazioni non sono meglio spiegate da
disabilità intellettiva o da ritardo globale dello sviluppo
ICD 10
A. Abnormal or impaired development is evident before the age of 3 years in at least one of the following areas:
1.receptive or expressive language as used in social communication;
2.the development of selective social attachments or of reciprocal social interaction;
3.functional or symbolic play.
B. A total of at least six symptoms from (1), (2) and (3) must be present, with at least two from (1) and at least one from each of (2) and (3)
1. Qualitative impairment in social interaction are manifest in at least two of the following areas:
a. failure adequately to use eye-to-eye gaze, facial expression, body postures, and gestures to regulate social interaction;
b. failure to develop (in a manner appropriate to mental age, and despite ample opportunities) peer relationships that involve a mutual sharing of interests,
activities and emotions;
c. lack of socio-emotional reciprocity as shown by an impaired or deviant response to other people’s emotions; or lack of modulation of behavior according to
social context; or a weak integration of social, emotional, and communicative behaviors;
d. lack of spontaneous seeking to share enjoyment, interests, or achievements with other people (e.g. a lack of showing, bringing, or pointing out to other people
objects of interest to the individual).
2. Qualitative abnormalities in communication as manifest in at least one of the following areas:
a. delay in or total lack of, development of spoken language that is not accompanied by an attempt to compensate through the use of gestures or mime as an
alternative mode of communication (often preceded by a lack of communicative babbling);
b. relative failure to initiate or sustain conversational interchange (at whatever level of language skill is present), in which there is reciprocal responsiveness to
the communications of the other person;
c. stereotyped and repetitive use of language or idiosyncratic use of words or phrases;
d. lack of varied spontaneous make-believe play or (when young) social imitative play
3. Restricted, repetitive, and stereotyped patterns of behavior, interests, and activities are manifested in at least one of the following:
a. An encompassing preoccupation with one or more stereotyped and restricted patterns of interest that are abnormal in content or focus; or one or more
interests that are abnormal in their intensity and circumscribed nature though not in their content or focus;
b. Apparently compulsive adherence to specific, nonfunctional routines or rituals;
c. Stereotyped and repetitive motor mannerisms that involve either hand or finger flapping or twisting or complex whole body movements;
d. Preoccupations with part-objects of non-functional elements of play materials (such as their oder, the feel of their surface, or the noise or vibration they
generate).
C. The clinical picture is not attributable to the other varieties of pervasive developmental disorders; specific development disorder of receptive
language (F80.2) with secondary socio-emotional problems, reactive attachment disorder (F94.1) or disinhibited attachment disorder (F94.2); mental
retardation (F70-F72) with some associated emotional or behavioral disorders; schizophrenia (F20.-) of unusually early onset; and Rett’s Syndrome
(F84.12).
Disturbo dello Spettro dell’Autismo
Linee Guida ISS (Rev.2015)
Spettro autistico
Le manifestazioni del disturbo variano in base
al livello di gravità,
al livello di sviluppo
all’ età cronologica
Eterogeneità negli aspetti linguistici
Assenza del linguaggio
Ritardo di comparsa/acquisizione del linguaggio
Regressione di competenze linguistiche inizialmente
acquisite
Presenza di competenze linguistiche atipiche
Peculiarità del linguaggio
Scarsa iniziativa comunicativa
Ecolalie immediate e differite
Prosodia aberrante
Scelta di parole inusuale
Inversione pronominale
Incoerenza a livello di discorso
Scarsa capacità di rispondere a domande
Rapin e Dunn, 2003
Caratteristiche cognitive e metacognitive
comuni a molti soggetti con Autismo
buone abilità di memoria visuo-spaziale,
buone capacità di discriminazione visiva,
deficit nella memoria dichiarativa,
prevalenza di pensiero visivo rispetto a quello verbale,
prevalenza di pensiero associativo,
deficit di attenzione (difficoltà nell’attenzione congiunta, nell’attenzione su richiesta e
nello spostamento dell’attenzione da uno stimolo all’altro, attenzione eccessiva a stimoli
non rilevanti),
deficit di “teoria della mente” (difficoltà nel comprendere gli stati mentali degli altri,
ossia i loro pensieri, opinioni, intenzioni e nell’utilizzare tali informazioni per dare
significato al loro comportamento e prevedere ciò che faranno di seguito e cosa si
aspettano da lui),
deficit delle funzioni esecutive (difficoltà a spostare l’attenzione in modo flessibile, a
bilanciare le priorità, a risolvere problemi in modo pianificato e strategico considerando
le possibili alternative e le risorse disponibili, monitorando il risultato ed eventualmente
rivedendo il piano),
deficit di “coerenza centrale” (ridotta capacità di riunire insieme varie informazioni per
costruire un significato globale, una visione di insieme, causata dall’eccessiva
concentrazione sul dettaglio che non consente di cogliere l’”intero”).
Modalità sensoriali peculiari
Risposta anomala agli stimoli sensoriali
- iper-reattività (ad esempio il bambino può manifestare reazioni eccessive,
quali urla o coprirsi le orecchie, in seguito a stimoli sonori di bassa intensità);
- ipo-reattività (ad esempio il bambino può non rispondere a stimoli molto
intensi);
- reattività mista (il bambino può presentare entrambe le risposte descritte
sopra).
Ricerca di stimolazione sensoriale
visiva (ad esempio guardare i riflessi degli oggetti);
uditiva (ad esempio battere gli oggetti sulla superficie);
tattile (ad esempio passare la mano su alcuni tipi di tessitura);
gustativa (ad esempio leccare oggetti);
olfattiva (ad esempio annusare oggetti);
propriocettiva (ad esempio fermarsi in posture bizzarre);
vestibolare (ad esempio girare su se stessi, dondolarsi).
Epidemiologia (1)
Forme classiche di autismo : 1-1,3/1000
Spettro:
4-5/1000
In Italia
Regione Piemonte: 2,5/1000
Regione Emilia - Romagna: 2/1000
Provincia di Foggia (638.041 ab.): Prevalenza attesa
2400 -2500
Epidemiologia (2)
Aumento apparente dell’incidenza negli ultimi 30 anni
(Fombonne, 2003; Yeargin-Allsopp et al., 2003). Secondo la
maggioranza degli Autori (Fombonne, 2001; Baird et al.,
2003; Prior, 2003), questa discordanza nelle stime di
prevalenza sarebbe dovuta più che ad un reale incremento
dei casi di autismo ad una serie di fattori individuabili in:
♦ maggiore definizione dei criteri diagnostici, con inclusione
delle forme più lievi;
♦ diffusione di procedure diagnostiche standardizzate;
♦ maggiore sensibilizzazione degli operatori e della
popolazione in generale;
♦ aumento dei Servizi (anche se ancora decisamente
inadeguati alla richiesta, sia quantitativamente che
qualitativamente).
E in provincia di Foggia?
Alunni
Portatori di Handicap
a.s. 2014-2015
99502
3150
a.s. 2015 -2016
97438
3063
DSA in carico ai
servizi
Malattie rare a sintomatologia DSA
totale
216
83
299
Bleuler, 1911
Kanner, 1943
Asperger, 1944
Modelli etiopatogenetici
modelli interpretativi della clinica (patogenesi);
basi neurobiologiche (anatomia patologica);
fattori causali (= l’etiologia).
Modelli interpretativi della clinica
Teoria socio affettiva: l’essere umano nasce con una
predisposizione innata ad interagire con l’altro; nell’autismo:
deficit, biologicamente determinato, della capacità di interagire
Deficit della teoria della mente: il bambino autistico è incapace di
accedere a una teoria della mente rimanendo in una situazione di
cecità mentale (Baron-Cohen, 1995) o di psicoagnosia (Surian,
2002)
Deficit della coerenza centrale : incapacità di sistematizzare in un
sistema di conoscenza, le molteplici esperienze sensopercettive e
sociali (Frith et al., 1994; Happé et al., 1996)
Deficit delle funzioni esecutive : deficit delle abilità che
consentono una adeguata organizzazione e pianificazione dei
comportamenti finalizzati alla risoluzione di problemi
Basi neurobiologiche
Strutture anatomiche: Studi morfologici: anomalie del
cervelletto (Courchense, 1998; Kemper et al., 1998), del lobo frontale
(Castelli et al., 2000; Schultz et al., 2003), del sistema limbico, con
particolare riferimento all’amigdala e all’ippocampo
(Baron-Cohen et al., 2000; Schultz et al., 2000;Courchense, 2001).Studi
morfofunzionali: ridotta captazione di glucosio nei lobi
frontali e parietali (Schifter Tet al.1994)
Neurotrasmettitori: coinvolgimento di tutti i
neurotrasmettitori attivi nel sistema nigro striatale; livelli di
serotonina aumentati in 1/3 autistici con ritardo mentale e nei
consanguinei dei probandi autistici non iperserotoninemici.
Verosimilmente, non per aumentata sintesi né per riduzione del
catabolismo ma per aumento della captazione
Fattori causali
Gravidanza e periodo neonatale
Ereditarietà e geni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ereditarietà e geni
(1)
i gemelli monozigoti hanno probabilità maggiori rispetto ai gemelli eterozigoti
di essere entrambi affetti da autismo;
i genitori di un bambino autistico hanno un rischio di avere un altro bambino
autistico (ricorrenza), che risulta da 50 a 100 volte maggiore rispetto al rischio
per la popolazione generale (prevalenza);
alcuni membri della famiglia di soggetti con autismo presentano
caratteristiche comportamentali simili, anche se più lievi;
alcune condizioni patologiche ereditate geneticamente, come la Sindrome da X
Fragile e la Sclerosi Tuberosa, si presentano spesso in comorbidità con
l'autismo.
Dal 3 al 25% di pazienti con Sindrome da X Fragile presenta anche autismo. La
sindrome da X Fragile è stata trovata invece in sporadici casi nelle persone
autistiche, prevalentemente negli individui di sesso maschile.
Per quel che riguarda la Sclerosi Tuberosa, dal 17 al 60% di coloro che ne sono
affetti sono anche autistici. Al contrario, gli individui con autismo presentano
in una percentuale variabile fra lo 0,4 e il 3% anche Sclerosi Tuberosa; il tasso
aumenta fino all’8-14% se è presente anche epilessia.
Ereditarietà e geni
(2)
non esiste “il gene” dell’Autismo, ma esistono piuttosto
una serie di geni che contribuiscono a conferire una
vulnerabilità alla comparsa del disturbo (Bailey et al.,1996;
Szatmari et al., 1998; Folstein et al., 2001).
Loci genici di maggior interesse sono sui cromosomi
2,7,16,17
Autismo e Vaccini
Il caso Wakefield
Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific
colitis, and pervasive developmental disorder in
children.
Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, Linnell J, Casson DM, Malik M, Berelowitz M,
Dhillon AP, Thomson MA, Harvey P, Valentine A, Davies SE, Walker-Smith JA.
Lancet. 1998 Feb 28;351(9103):637-41. Retraction in: Lancet. 2010 Feb 6;375(9713):445.
Partial retraction in: Murch SH, Anthony A, Casson DH, Malik M, Berelowitz M, Dhillon
AP, Thomson MA, Valentine A, Davies SE, Walker-Smith JA. Lancet. 2004 Mar
6;363(9411):750.
Autismo e Vaccini
Prognosi
Migliore nei bambini con sviluppo del linguaggio entro i 5
anni
QI =/> 70 (almeno nei test di performance), indicatore di
outcome positivo ma non garantisce con certezza un buon
adattamento sociale in età adulta (Howlin et al., 2004).
dal 60% al 90% di bambini autistici divengono adulti non
autosufficienti e continuano ad aver bisogno di cure per
tutta la vita.
Dal 15% al 20% raggiunge vari gradi di indipendenza
Indici predittivi di incremento di
vocabolario
Ampiezza del vocabolario al momento della prima
consultazione
Presenza di imitazione verbale
Uso di oggetti per “far finta”
Numero di gesti per iniziare una condivisione
Miglior livello intellettivo
Migliore comprensione linguistica
Migliore capacità di imitazione e di attenzione
condivisa
PRINCIPI DI TRATTAMENTO
Bisogna sempre porsi la domanda ( e pretendere di
avere gli strumenti per la risposta):”Quello che viene
fatto per questo bambino è efficace e utile per lui?”
Efficacy
capacità di un intervento di
produrre un effetto desiderato in circostanze
ideali
Effectiveness
capacità di un intervento
di ottenere un risultato desiderato nella
pratica e non in RCT o studi di laboratorio)
Linee Guida
Insieme
di
raccomandazioni
sviluppate
sistematicamente e continuamente aggiornate redatte
allo scopo di rendere valido e di standard elevato un
comportamento desiderato. Si sviluppano linee guida
in ogni campo (sociale, politico, economico, medico
ecc.)
Sempre basate sull’evidenza
Mai vincolanti
P. N.L.G., 2002
P.N.L.G.,2002
Necessità di linee guida
1. Prevalenza epidemiologica crescente
2. Sovrabbondanza di terapie (farmacologiche
e non) non sempre supportate da prove di
evidenza
3. Ricaduta assistenziale nei servizi.
4. “Chiarezza” richiesta da Associazioni dei
Genitori per arginare “Shopping
terapeutico” e mercato illusioni.
Alle Linee Guida dovremmo chiedere di
essere :
Una fotografia aggiornata dei trattamenti
giudicati come appropriati:
– Validità;
– Affidabilità;
– Comparabilità;
– Replicabilità.
Linee Guida
Linee Guida SINPIA 2005
Linee guida autismo – scuola SINPIA- Pedagogia speciale
Scottish intercollegiate guidelines network (SIGN)
Assessment, diagnosis and clinical interventions for
children and young people with autism spectrum
disorders. (2007)
Linee Guida regionali per i disturbi dello spettro autistico
2013 (DGR 1521/2013)
AACAP 2014
Sistema Nazionale per le linee Guida Iss (2011
aggiornamento 2015)
Il Sistema nazionale linee guida elabora raccomandazioni di
comportamento clinico basate sugli studi scientifici più aggiornati.
Per ogni patologia le linee guida descrivono le alternative disponibili e le
relative possibilità di successo in modo che il medico possa orientarsi nella
gran quantità di informazione scientifica in circolazione, il paziente abbia
modo di esprimere consapevolmente le proprie preferenze, e
l'amministratore possa compiere scelte razionali in rapporto agli obiettivi
e alle priorità locali.
Interventi terapeutici
Durante l’intero arco dell’età evolutiva devono essere messi in
atto una serie di interventi finalizzati a:
1. correggere comportamenti disadattivi;
2. pilotare la spinta maturativa per facilitare l’emergenza di
competenze (sociali, comunicativo-linguistiche, cognitive)
che possano favorire il futuro adattamento del soggetto
all’ambiente in cui vive;
3. favorire lo sviluppo di un soddisfacente adattamento
emozionale (controllo degli impulsi, modulazione degli
stati emotivi, immagine di sé).
Comprendere per valutare
(e valutare per comprendere)
Occasioni e contesti dell’espressione comportamentale
abnorme
Esistono indicatori di psicopatologia certi ?
Come vivono il sintomo nell’ambiente e come reagiscono
genitori, compagni, insegnanti ?
Sono le manifestazioni riconducibili a una ben precisa
sindrome ?
Come si inserisce il sintomo nella vita quotidiana del
bambino ?
Quale interferenza è prodotta sullo sviluppo?
Esistono aspetti non considerati (multiassialità) ?
Linee guida SINPIA, 2005
Disturbo autistico: è una sindrome comportamentale
Aree compromesse
Interazione sociale
Comunicazione
Interessi e attività
Aree di intervento
migliorare l’interazione
sociale;
arricchire la
comunicazione;
favorire un ampliamento
degli interessi ed una
maggiore flessibilità degli
schemi di azione.
Linee Guida SNPIA 2005
Trattamenti
inefficaci o non raccomandati
Auditory Integration Training
Musicoterapia
Comunicazione facilitata
Ossigeno iperbarico
Metodo Tomatis
Equitazione assistita
Chelazione
Integratori alimentari
Interventi mediati dai genitori
• Con programmi di intervento mediati dai genitori
devono essere intesi interventi sistematici e
modalità di comunicazione organizzati secondo
specifiche sequenze, che il genitore, previa
formazione specifica, eroga al figlio con obiettivi
precisi e sotto la supervisione degli specialisti che lo
affiancano.
• E’ efficace nel migliorare varie aree target:
• nei bambini con disturbi dello spettro autistico i
comportamenti di comunicazione sociale e i
problemi comportamentali
• negli adolescenti con disturbi dello spettro
autistico le capacità di socializzazione con i
coetanei
I programmi di intervento mediati dai genitori sono raccomandati
nei bambini e negli adolescenti con disturbi dello spettro autistico,
poiché sono interventi che possono migliorare la comunicazione
sociale e i comportamenti problema, aiutare le famiglie a interagire
con i loro figli, promuovere lo sviluppo e l’incremento della
soddisfazione dei genitori, del loro empowerment e benessere
emotivo.
Strategie di intervento
approcci
comportamentali
approcci evolutivi
Tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è l’analisi
comportamentale applicata (Applied behaviour intervention, ABA): gli studi sostengono
una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti
adattativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione, anche
se non definitive, consentono di consigliare l’utilizzo del modello ABA nel trattamento dei
bambini con disturbi dello spettro autistico. Dai pochi studi finora disponibili emerge
comunque un trend di efficacia a favore anche di altri programmi intensivi altrettanto
strutturati, che la ricerca dovrebbe approfondire con studi randomizzati controllati (RCT)
finalizzati ad accertare, attraverso un confronto diretto con il modello ABA, quale tra i vari
programmi sia il più efficace. È presente un’ampia variabilità a livello individuale negli
esiti ottenuti dai programmi intensivi comportamentali ABA; è quindi necessario che
venga effettuata una valutazione clinica caso-specifica per monitorare nel singolo
bambino l’efficacia dell’intervento, ossia se e quanto questo produca i risultati attesi.
Approcci evolutivi (o interattivi)
Si basano sui seguenti presupposti:
L’area cognitiva, relazionale, emotiva e delle
competenze comunicative sono inscindibili e si
influenzano reciprocamente
L’intervento è centrato sul bambino e l’ambiente
assume valenza terapeutica
Comunicazione Aumentativa
Alternativa
L’utilizzo di interventi a supporto della comunicazione
nei soggetti con disturbi dello spettro autistico, come
quelli che utilizzano un supporto visivo alla
comunicazione, è indicato, sebbene le prove di efficacia
di questi interventi siano ancora parziali. Il loro utilizzo
dovrebbe essere circostanziato e accompagnato da una
specifica valutazione di efficacia.
È consigliato l’uso della terapia cognitivo comportamentale (Cognitive
behavior therapy, CBT) per il trattamento della comorbidità con i disturbi
d’ansia nei bambini con sindrome di Asperger o autismo ad alto
funzionamento. La terapia cognitivo comportamentale, rivolta a bambini
e genitori, può essere utile nel migliorare le capacità di gestione della
rabbia in bambini con sindrome di Asperger.
Terapia della psicomotricità
obiettivi:
favorire la comparsa di segnalatori sociali (contatto
oculare, sguardo referenziale, sorriso, etc.);
aumentare i tempi di attenzione;
facilitare un uso più appropriato degli oggetti;
stimolare la comunicazione;
arricchire il vocabolario;
scoraggiare determinati comportamenti
(iperattività, stereotipie motorie, condotte
autolesive, etc.).
Terapia della psicomotricità
è una prassi terapeutica che privilegia una modalità
di approccio in grado di facilitare nel bambino:
la percezione e la "conoscenza" di Sé come
persona;
la percezione e la "conoscenza" dell'Altro;
la percezione e la "conoscenza" delle emozioni che
sottendono i vari comportamenti;
la percezione e la "conoscenza" delle "leggi"
emozionali e sociali che regolano i rapporti
interpersonali.
Modelli di presa in carico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TEACCH
Learning Experiences, an Alternative Program for
Preschoolers and their Parents (LEAP) at the University
of Colorado School of Education
The University of California at Los Angeles (UCLA)
Young Autism Project
Denver Model at the University of Colorado Health
Sciences Center
Developmental Intervention Model at the George
Washington University School of Medicine.
La Thérapie d’Echange et de Développment (TED)
dell’Université François Rabelais, CHU de Tours
Treatment and Education of Autistic and related Communication
Handicapped
Children (TEACCH)
University of North Carolina School of Medicine at
Chapel Hill.
Organizzazione dei servizi per persone autistiche
realizzato nella Carolina del Nord. Prevede una presa in
carico globale in senso sia "orizzontale" che "verticale", cioè
in ogni momento della giornata, in ogni periodo dell’anno e
della vita e per tutto l’arco dell’esistenza: un intervento
“pervasivo" per un disturbo pervasivo.
Treatment and Education of Autistic and related Communication
Handicapped
Children (TEACCH)
Finalità: sviluppo del miglior grado possibile di
autonomia nella vita personale, sociale e
lavorativa, attraverso strategie educative che
potenzino le capacità della persona autistica.
Presupposti: l’autismo è un disturbo
biologicamente determinato; i genitori sono
fondamentali nella comprensione e nel
trattamento del disturbo
Treatment and Education of Autistic and related Communication
Handicapped
Children (TEACCH)
Strategie di intervento:
Strutturazione (tempo, spazio, materiale di lavoro)
(“Dove?” “Quando?” “Che cosa?”)
Rinforzo (Perché?)
Aiuto (Come?)
Generalizzazione del compito
Disturbi Spettro Autistico
Funzionamento cognitivo
Comunicazione
Tipologie di Trattamento
Età (anni)
Basso funzionamento
<6
Non verbale
6-12
>12
<6
Verbale
6-12
PSICOEDUCAZIONE
Genitori/Insegnanti
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA-ALTERNATIVA (PECS)
TRAINING SULL’USO COMUNICATIVO-SOCIALE DEL
LINGUAGGIO
PROGRAMMI INTENSIVI COMPORTAMENTALI (ABA &
derivazioni)
DENVER
TEACCH
TERAPIA COGNITIVO
COMPORTAMENTALE (CBT)
MOLTO UTILE
UTILE
NON UTILE
Alto funzionamento
>12
<6
6-12
>12
Precocità degli interventi
• Popolazione a rischio di 24 mesi
Gruppo trattato
(con formazione genitori)
VS
Gruppo non trattato
• A 36 mesi conferma diagnostica di DSA,
ma…
• ↑ outcome comunicazione sociale;
• ↑ linguaggio verbale.
Interazione sociale e
comunicazione compromesse per :
inadeguatezza dell’attenzione congiunta: (deficit della
capacità di stabilire con l’altro un interesse condiviso)
Neurone a specchio
Localizzazione cerebrale dei
neuroni a specchio
difficoltà nell’uso dei simboli (Baron-Cohen et al. 1992; Mundy,
incapacità del bambino di acquisire e padroneggiare i
codici (sguardo, mimica, postura, gesti, suoni e parole) che
gli permettono di entrare in uno scambio comunicativo con
l’altro (Wetherby et al., 2000)
2003):
In età prescolare
Scarsa modulazione degli stati emotivi
Inadeguatezza dell’attenzione congiunta
Difficoltà nell’uso dei simboli
guardare l’Altro;
alternare lo sguardo dall’Altro all’oggetto e viceversa;
tendere la mano verso l’oggetto e/o evento interessante e
alternare lo sguardo con l’Altro;
indicare con il dito l’oggetto e/o evento interessante;
porgere e mostrare;
usare simboli verbali.
La scuola
Linee guida SINPIA, 2005
Età scolare
guardare alla persona quando viene chiamato per nome,
guardare un oggetto quando viene nominato,
prestare attenzione a chi parla,
usare il contatto oculare per mantenere l’interazione,
imitare azioni semplici, suoni, parole,
attirare l’attenzione di qualcuno,
facilitare i comportamenti di richiesta,
dire no o fare gesti di diniego,
dire si o fare gesti di assenso,
salutare gli altri,
denominare le persone,
denominare le cose,
descrivere ciò che gli altri stanno facendo.
Se la compromissione dell’interazione sociale è rilevante
e sono presenti comportamenti fortemente disadattivi ,
il programma deve prevedere un’adeguata
organizzazione delle attività per favorire la
partecipazione del bambino e stimolare la sua iniziativa.
In tale contesto emotivo-relazionale, vanno
implementati sollecitazioni centrate sugli
apprendimenti accademici, sul linguaggio e sulla
comunicazione sociale.
Se la compromissione dell’interazione sociale è
contenuta, va previsto un lavoro sulle competenze
accademiche (lettura, scrittura e calcolo), integrato da
programmi centrati sul linguaggio e sulla cognizione
sociale.
Obiettivi curriculari da perseguire
Facilitare la consapevolezza delle intenzioni, delle
preferenze e delle esperienze altrui
Facilitare la capacità di raccontare le proprie
esperienze
Sviluppare l’abilità di modificare il tema del
discorso secondo la prospettiva dell’esaminatore
Sviluppare l’uso del linguaggio per mediare e
risolvere conflitti e per esprimere sentimenti e
empatia
Facilitare l’uso di un linguaggio più avanzato per
esprimere differenze di significato
Incoraggiare l’acquisizione di convenzioni verbali per
iniziare le interazioni, per interagire a turno e per
terminarle
Incoraggiare l’acquisizione di segnali non verbali e
paralinguistici per rinforzare le intenzioni sociali (
per es. lo sguardo, la posizione del corpo, il volume
della voce ecc.)
Aumentare le abilità di interpretare e usare il
linguaggio in modo flessibile secondo il contesto
sociale e i segnali non verbali dell’interlocutore
Comportamento disadattativo
I comportamenti disadattativi assumono un carattere
ripetitivo e perseverante tipico del funzionamento
autistico?
Provare ad introdurre sollecitazioni alternative (in presenza
di sviluppo del linguaggio sufficientemente adeguato, usare il canale
verbale)
I comportamenti disadattativi hanno funzione
comunicativa?
Ispirarsi ai principi del ABA e del AAC per gestire il
comportamento
Concludendo:
E’ fondamentale che per ogni soggetto venga individuato lo stile peculiare
di apprendimento e di funzionamento globale, i suoi punti di forza e di
debolezza in tutte le aree dello sviluppo, al fine di pianificare un intervento
individualizzato e specificatamente orientato alla promozione delle
competenze e quindi all’aumento della qualità di vita di quella persona.
L’integrazione degli approcci sulla base del funzionamento specifico del
bambino appare la via più completa e che ha dato maggiori risposte
positive nell’intervento psico-educativo.
Linee Guida Scuola -autismo SNPIA –Pedagogia
speciale,2005
Neurotipico
La Sindrome Neurotipica (NT) è un disturbo neurobiologico caratterizzato da una
preoccupazione eccessiva per le relazioni sociali, un delirio di superiorità, e un’
0ssessione al conformismo.
Neurotipici:
– i NT pensano che la loro esperienza al mondo è la sola, oppure è la sola ad essere
corretta.
– i NT hanno difficoltà a restare da soli.
– i NT spesso sono intolleranti di fronte alle differenze minime degli altri.
– In gruppo i NT sono socialmente rigidi, e spesso insistono sulle performance di
rituali disfunzionali per assicurarsi l’identità di gruppo.
– I NT hanno grandi difficoltà a comunicare direttamente ed è presente una alta
incidenza alla menzogna rispetto alle persone autistiche.
“La neurotipicità è un disturbo di origine genetica. Delle autopsie hanno
dimostrato che il cervello dei neurotipici è piu’ piccolo rispetto a quello degli
autistici, e che le zone dell’interazione sociale sono ipertrofiche”.
http://podcast.unil.ch/podcast/ssp/iscm/cmtb_2008/cmtb_17_Hadjikhani_slides.pdf
Informazioni su questi ad