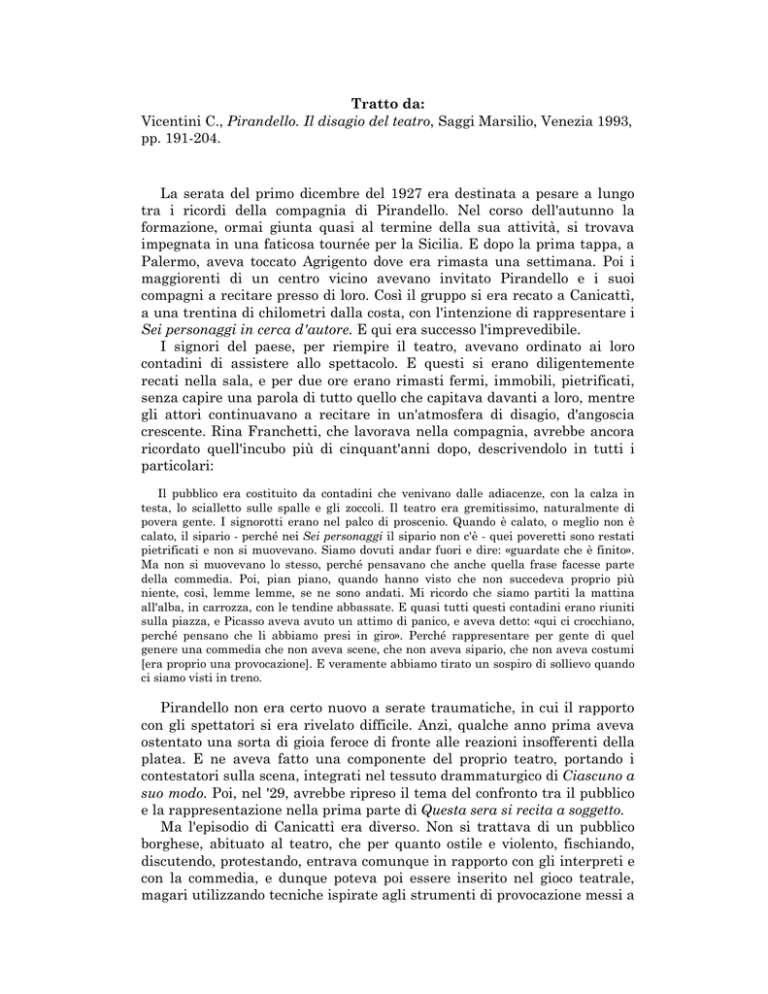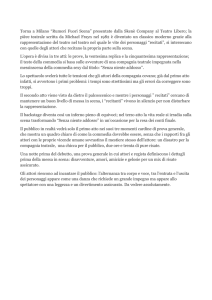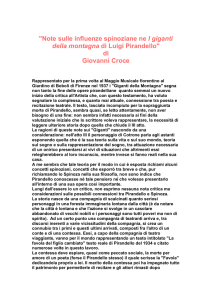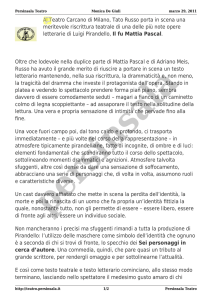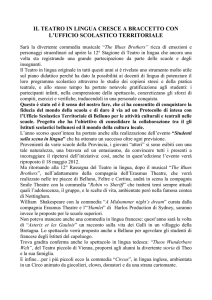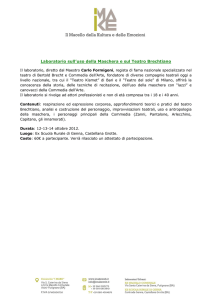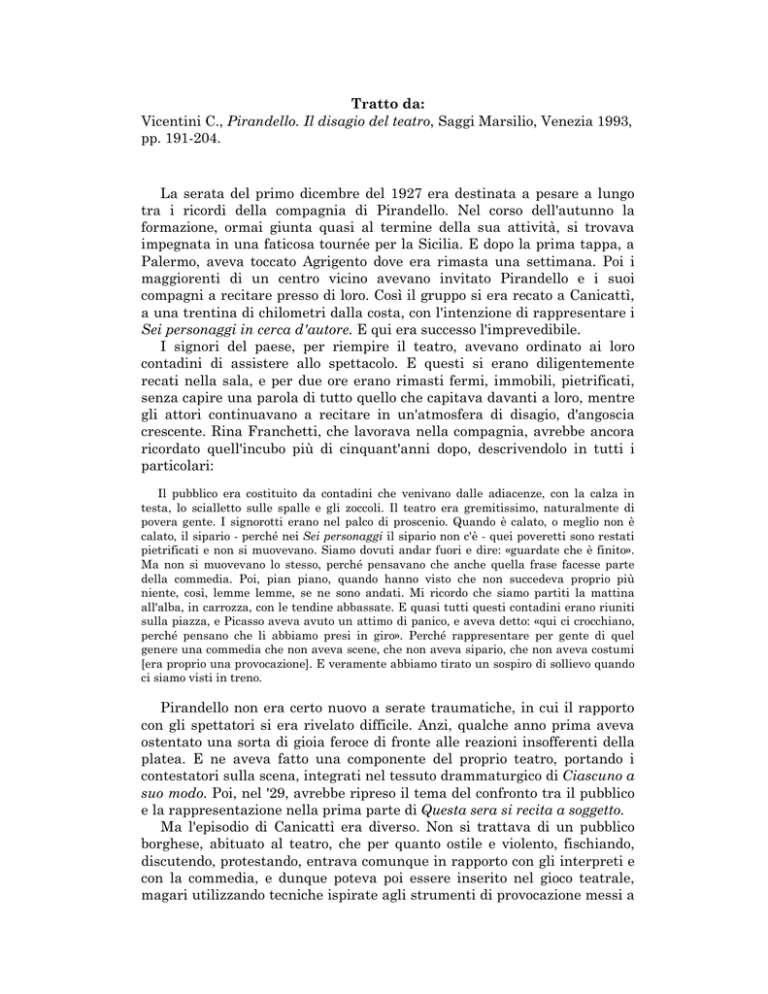
Tratto da:
Vicentini C., Pirandello. Il disagio del teatro, Saggi Marsilio, Venezia 1993,
pp. 191-204.
La serata del primo dicembre del 1927 era destinata a pesare a lungo
tra i ricordi della compagnia di Pirandello. Nel corso dell'autunno la
formazione, ormai giunta quasi al termine della sua attività, si trovava
impegnata in una faticosa tournée per la Sicilia. E dopo la prima tappa, a
Palermo, aveva toccato Agrigento dove era rimasta una settimana. Poi i
maggiorenti di un centro vicino avevano invitato Pirandello e i suoi
compagni a recitare presso di loro. Così il gruppo si era recato a Canicattì,
a una trentina di chilometri dalla costa, con l'intenzione di rappresentare i
Sei personaggi in cerca d'autore. E qui era successo l'imprevedibile.
I signori del paese, per riempire il teatro, avevano ordinato ai loro
contadini di assistere allo spettacolo. E questi si erano diligentemente
recati nella sala, e per due ore erano rimasti fermi, immobili, pietrificati,
senza capire una parola di tutto quello che capitava davanti a loro, mentre
gli attori continuavano a recitare in un'atmosfera di disagio, d'angoscia
crescente. Rina Franchetti, che lavorava nella compagnia, avrebbe ancora
ricordato quell'incubo più di cinquant'anni dopo, descrivendolo in tutti i
particolari:
Il pubblico era costituito da contadini che venivano dalle adiacenze, con la calza in
testa, lo scialletto sulle spalle e gli zoccoli. Il teatro era gremitissimo, naturalmente di
povera gente. I signorotti erano nel palco di proscenio. Quando è calato, o meglio non è
calato, il sipario - perché nei Sei personaggi il sipario non c'è - quei poveretti sono restati
pietrificati e non si muovevano. Siamo dovuti andar fuori e dire: «guardate che è finito».
Ma non si muovevano lo stesso, perché pensavano che anche quella frase facesse parte
della commedia. Poi, pian piano, quando hanno visto che non succedeva proprio più
niente, così, lemme lemme, se ne sono andati. Mi ricordo che siamo partiti la mattina
all'alba, in carrozza, con le tendine abbassate. E quasi tutti questi contadini erano riuniti
sulla piazza, e Picasso aveva avuto un attimo di panico, e aveva detto: «qui ci crocchiano,
perché pensano che li abbiamo presi in giro». Perché rappresentare per gente di quel
genere una commedia che non aveva scene, che non aveva sipario, che non aveva costumi
[era proprio una provocazione]. E veramente abbiamo tirato un sospiro di sollievo quando
ci siamo visti in treno.
Pirandello non era certo nuovo a serate traumatiche, in cui il rapporto
con gli spettatori si era rivelato difficile. Anzi, qualche anno prima aveva
ostentato una sorta di gioia feroce di fronte alle reazioni insofferenti della
platea. E ne aveva fatto una componente del proprio teatro, portando i
contestatori sulla scena, integrati nel tessuto drammaturgico di Ciascuno a
suo modo. Poi, nel '29, avrebbe ripreso il tema del confronto tra il pubblico
e la rappresentazione nella prima parte di Questa sera si recita a soggetto.
Ma l'episodio di Canicattì era diverso. Non si trattava di un pubblico
borghese, abituato al teatro, che per quanto ostile e violento, fischiando,
discutendo, protestando, entrava comunque in rapporto con gli interpreti e
con la commedia, e dunque poteva poi essere inserito nel gioco teatrale,
magari utilizzando tecniche ispirate agli strumenti di provocazione messi a
punto dai futuristi. I contadini siciliani «con la calza in testa, lo scialletto
sulle spalle e gli zoccoli» sembravano esprimere un'estraneità totale,
un'incomprensione assoluta, un rifiuto radicale. L'efficacia del teatro di
fronte a quella platea pareva perdersi, smarrirsi irreparabilmente. E
l'impressione sulla scena, tra gli attori, era quella di un'oscura minaccia, di
una violenza, di un pericolo, come aveva avvertito Picasso, che poteva
nascere all'improvviso.
Di qui, da questa singolare esperienza, Pirandello doveva iniziare
l'elaborazione di una nuova commedia. Proprio di fronte alla sua abitazione
romana in via Piemonte si trovava il palazzo della contessa Olga De
Dieterichs Ferrari che insieme al marito, il conte Mario Ferrari, nel
dicembre del 1923 aveva dato vita a un piccolo teatro privato. Più tardi, nel
1926, la coppia aveva costituito una compagnia di giro, diretta per qualche
tempo da Lamberto Picasso e conosciuta come «compagnia della contessa».
L'impresa si era risolta in un disastroso fallimento e una cospicua perdita
di denaro. La contessa, abbandonate le scene, sarebbe morta qualche anno
dopo.
Su questa vicenda sembra avesse avuto l'idea di scrivere un lavoro Stefano,
il figlio di Pirandello. Ma poi aveva rinunciato. E Pirandello aveva allora
associato la storia della compagnia della contessa al ricordo della
sciagurata sera di Canicattì traendone la prima idea dei Giganti della
montagna.
La composizione dell'opera doveva essere particolarmente lunga. La
trama era già abbozzata nell'estate del '28. «Una compagnia di comici
sparuti, detta "la Compagnia della Contessa"», spiegava Pirandello in
un'intervista rilasciata alla "Stampa" nel settembre di quell'anno, «gira per
l'Italia vivendo una vita di miserie». Un giorno arriva in un piccolo paese
della Sardegna, dove si celebrano le nozze di due giovani appartenenti alle
due famiglie più potenti del luogo: sono esseri primitivi, «una specie di
giganti incatenatori di acque, fecondatori di terre». Gli attori ottengono il
permesso di recitare la loro commedia durante il banchetto. Ma quando
incominciano, gli spettatori, ormai ubriachi e del tutto digiuni di teatro,
non sono capaci di distinguere la storia rappresentata dalla realtà, e
partecipano così intensamente alla vicenda che vorrebbero modificarla a
modo loro. E siccome i comici non possono obbedire, i giganti «li
distruggono come fantocci», non diversamente, concludeva Pirandello, «da
quanto fa a volte un pubblico meno primitivo».
Dunque il nucleo iniziale della commedia ruotava intorno all'infelice
incontro della compagnia di Pirandello con i contadini siciliani, tramutati
per l'occasione in «giganti» e trasferiti in un'altra isola, la Sardegna,
altrettanto fuori mano. E l'evento assumeva una colorazione mitica,
acquistando il valore di una parabola sul destino del teatro che si scontra
con un pubblico incapace di comprenderlo.
Ma quasi subito, in un'intervista di poco successiva, la fisionomia di
questo pubblico selvaggio e ostile si trasforma. L'orda degli spettatori
inferociti perde la sua connotazione originaria di popolo arcaico, primitivo
(gli «incatenatori di acque, fecondatori di terre»), e diventa invece una folla
di «ricchi barbari» industriosi e potenti, «affatto ignari di ogni sollecitudine
intellettuale». I giganti, insomma, si avvicinano progressivamente
all'immagine delle masse che vivono all'interno di una società efficiente e
produttiva, diventata estranea al richiamo dei valori spirituali della
cultura.
Qualche mese dopo è la trama a subire una trasformazione. Non si
esaurisce più nel contrasto netto, radicale, tra gli attori e il pubblico dei
giganti, ma introduce un nuovo elemento, di mediazione. È il personaggio
di Cotrone che inizialmente, in un riassunto del lavoro fornito da
Pirandello nel gennaio del '29, è «un pezzo grosso del luogo» che si
interessa ai commedianti e intercede per loro. Poi la sua fisionomia
cambia, e Cotrone in un'intervista pubblicata nell'estate sulla «Gazzetta
del popolo» viene descritto come un «poeta locale», dunque un artista,
senz'altro amico della compagnia degli attori, e loro naturale alleato. E il
significato della commedia intanto si precisa. Si tratta, spiega Pirandello,
dello scontro tra «un mondo spirituale», a cui appartiene il teatro, e il
«nuovo» mondo «materialistico». I giganti, quindi, sono ormai gli abitanti
della società della macchine, che esalta la potenza produttiva e appare
refrattaria al fascino dell'arte. All'interno di questa società resta però
possibile individuare alcune figure isolate, come Cotrone, capaci di offrire
al teatro se non proprio un sostegno e una difesa in grado di salvarlo,
almeno una zona di complicità e di intesa.
In effetti, un anno dopo, nel giugno del 1930, quando Pirandello ha
ormai consumato il suo attacco contro il cinema sonoro e ha varato sui
palcoscenici tedeschi e poi italiani Questa sera si recita a soggetto, la figura
di Cotrone non appare più solitaria, ma è attorniata da una piccola turba
di compagni. Sono, spiega Pirandello in un'intervista rilasciata a Berlino,
«artisti falliti, rifiuti della società, gente lunatica e pericolosa esiliatasi dal
mondo per crearsi una vita fuori dalle comuni regole». E questo gruppo di
emarginati, gelosi del proprio isolamento, vive in un'atmosfera densa di
suggestioni teatrali, «mettendo in scena sarabande di spiriti e spettri che
valgono a tener lontana la gente».
L'affinità del gruppo di Cotrone con la compagnia degli attori è ormai
evidente, e del resto Pirandello si preoccupa di sottolinearla, indicando
nella stessa intervista una precisa chiave di lettura della commedia. «I
giganti della montagna», spiega, «sono gli uomini refrattari all'arte, chiusi
e conchiusi nella ragione pratica del vivere. L'attrice, il conte suo marito, il
poeta Cotrone, i suoi compagni scapigliati e i guitti della compagnia sono lo
spirito che agisce e costruisce oltre la materia e il dramma è l'incontro, anzi
lo scontro di questi due mondi incomunicabili».
Il teatro, nella società di massa tesa allo sfruttamento economico del
mondo materiale, di fronte alle folle ricche, indifferenti e minacciose dei
giganti con cui non è possibile alcun rapporto che non sia distruttivo, ha
dunque individuato le zone ristrette in cui può realizzarsi, ha trovato i
propri alleati, il proprio pubblico potenziale che vive «fuori dalle comuni
regole». E a questo punto l'elaborazione della commedia appare conclusa.
L'opera, annuncia infatti Pirandello al suo intervistatore, verrà terminata
nel giro di pochi giorni.
Ma quando il testo compare sulla «Nuova Antologia» nel dicembre del
'31 il titolo è cambiato e dei giganti non c'è più traccia. Si tratta di un atto
unico, I fantasmi, che descrive esclusivamente l'incontro degli attori in un
luogo isolato, fuori dal mondo, con il gruppo degli «scalognati», i compagni
di Cotrone. I fantasmi, avverte una breve nota aggiunta al testo, sono un
lavoro «compiuto», che può stare anche a sé, tant'è vero che verrà
prossimamente prodotto negli Stati Uniti dalla Schubert Theatre
Corporation.
La rappresentazione americana poi non ebbe luogo. Ma già il progetto di
una messa in scena dell'opera in questa versione ridotta dimostra come
l'attenzione di Pirandello si fosse ormai spostata dallo scontro tra gli attori
e il pubblico inferocito dei giganti - insomma dallo spunto originario della
commedia - al nuovo tema della scoperta di un pubblico diverso,
insospettabile, all'interno della nostra società. La denuncia della folla
barbara e «materialistica» della civiltà delle macchine, che sottrae al teatro
ogni spazio operativo e alla fine lo distrugge, sembra ora interessare
Pirandello assai meno della relazione che si può istituire tra la compagnia
della contessa e la turba degli scalognati. E la questione centrale intorno a
cui ruota il testo non è più la tragica perdita di ogni rapporto tra il teatro e
le masse della società industriale, che trovano altrove i loro divertimenti,
ma la difficoltà e la resistenza del teatro a rinunciare alla moltitudine di
spettatori a cui era abituato, e ad accettare il suo pubblico ideale, ristretto
ma capace di cogliere l'arte della scena nella profondità della sua natura
esoterica, d'incantesimo e magia.
La trama dei Fantasmi è semplice. In una villa in rovina, dove si sono
rifugiati Cotrone e gli scalognati, giunge la compagnia della contessa ormai
ridotta allo stremo. Gli attori speravano di trovare una città, un teatro, per
poter rappresentare la loro commedia. Invece si accorgono di essere
arrivati in un luogo sconosciuto, tra persone strane, inquietanti, che
tuttavia dopo una reazione immediata di paura li accolgono
amichevolmente.
La prima parte del lavoro è dedicata al racconto delle vicende degli attori.
Come il conte abbia impegnato tutte le sue sostanze per allestire una
compagnia capace di portare per il mondo un'opera immortale, sublime,
ispirata dalla contessa a un giovane poeta perdutamente innamorato e
morto per lei. E come nonostante la magnificenza dell'allestimento il
pubblico non abbia voluto saperne, sicché il conte si è rovinato, e la
compagnia è ormai costretta a vagare con un pugno di attori stanchi e
affamati nei piccoli centri fuori mano. Cotrone simpatizza subito con i
commedianti, offre tutto l'aiuto possibile e li invita a entrare e a sistemarsi
per la notte nella villa. Gli attori dopo una breve esitazione accettano. La
contessa rimane fuori, e il conte resta con lei. E inizia la seconda parte del
lavoro.
Davanti alla villa, mentre cala la notte, Cotrone esibisce al conte e alla
contessa i suoi poteri di mago. Lancia un grido, e i muri della villa
s'illuminano all'improvviso. Poi a un suo cenno strane luci, «come di larve
evanescenti» appaiono nell'oscurità. E quando uno dei suoi protetti, una
vecchietta chiamata La Sgricia, esce dalla villa e racconta una storia
miracolosa, la vicenda dell'Angelo Centuno, si odono voci misteriose che «si
formano nell'aria». Qui, spiega Cotrone alla contessa, «siamo come agli orli
della vita», si respira un'«aria favolosa», e «gli angeli possono come niente
calare in mezzo a noi».
La villa e i suoi dintorni, insomma, sono avvolti in un'atmosfera
incantata, che produce effetti simili a quelli che si possono realizzare sul
palcoscenico. E del resto, come sottolinea Cotrone, tra la compagnia degli
attori e la turba degli scalognati esiste una profonda somiglianza. Gli uni e
gli altri praticano un'arte in grado di congiungere i corpi materiali ai
fantasmi. «Voi attori», spiega Cotrone, «date corpo ai fantasmi perché
vivano - E vivono! Noi facciamo al contrario: dei nostri corpi, fantasmi: e li
facciamo ugualmente vivere».
Per questo, solo nel territorio stregato della villa, insieme agli scalognati
che comprendono l'arte del teatro e sono pratici di incantesimi affini, gli
attori possono trovare il luogo ideale per rappresentare la loro commedia.
Qui l'opera concepita dal poeta, promette Cotrone, si potrà realizzare al
riparo della violenza degli uomini, «come un prodigio che s'appaghi da sé,
senza più chiedere niente a nessuno».
E quindi invita solennemente la contessa e i suoi compagni a restare:
«sciogliete i calzari e deponete il bordone. Siete arrivati alla vostra meta».
Ma mentre gli attori sembrano tentennare, la contessa rifiuta. Vuole che
l'opera che rappresentano viva anche in mezzo agli uomini. Sicché a
Cotrone non resta che concludere malinconicamente, rivolgendosi alla
contessa: «Povera opera! Come il poeta non ebbe da lei l'amore, così l'opera
non avrà dagli uomini la gloria».
Dunque nella commedia il pericolo dei giganti è assente, e il confronto
con il pubblico ostile è se mai un doloroso ricordo, evocato dalla contessa e
dagli attori che giungono da un mondo dove il teatro, come raccontano, è
destinato a perdere tutti gli strumenti indispensabili per la sua
sopravvivenza materiale: le sale, gli spettatori, i capitali, le attrezzature.
Di fronte a loro si apre invece la percezione di un territorio nascosto, ai
margini della società, in cui vive un pubblico di iniziati - Cotrone e i suoi
compagni - pronti ad accogliere i commedianti e a partecipare ai loro riti,
restituendo al teatro la sua natura profonda di incantesimo capace di «dare
corpo ai fantasmi». Ciò che turba, allora, è l'ostinato rifiuto della contessa,
che appare testardamente decisa a imporre il teatro in un mondo che non è
più suo, a una folla che lo respinge, e che nella sua radicale ostilità
impedisce la celebrazione del mistero della scena, l'evocazione efficace e
imperiosa delle figure fantastiche concepite dall'autore.
Così nella stesura del '31 il lavoro che Pirandello aveva concepito tre
anni prima appare radicalmente trasformato. Si è allontanato dal suo tema
originario, che ora viene rinviato a un possibile secondo o terzo atto, da
scrivere eventualmente nel futuro, e si concentra invece sulla scoperta del
luogo del teatro all'interno della società industriale. La commedia esalta la
dimensione magica, la natura di sortilegio, il carattere esoterico dell'arte
della scena. E sembra coerentemente criticare tutti gli sforzi di riportare il
mistero del teatro al centro della vita sociale, di riproporlo come
divertimento di massa, come esperienza diffusa e quotidiana a un pubblico
inadatto, indifferente, ostile.
Due anni dopo, nel 1933, Pirandello riprende la commedia tra le mani.
Spera che Marta Abba possa metterla in scena con la sua compagnia, ma il
progetto svanisce e il lavoro viene pubblicato, questa volta con il suo titolo
definitivo, I giganti della montagna, sulle pagine di «Quadrante» nel
novembre del 1934.
Ancora una volta manca il finale, la sanguinosa recita degli attori di fronte
al pubblico ubriaco dei giganti. Pirandello si è limitato ad aggiungere un
nuovo atto, che si svolge all'interno della villa, nell'«arsenale delle
apparizioni» di Cotrone. È uno stanzone, come spiega la didascalia,
occupato da strane masserizie, giocattoli, strumenti musicali, enormi birilli
e diversi fantocci posati goffamente all'intorno. Lì si ritrovano nel cuore
della notte il conte e la contessa, che non riescono a dormire. Dopo aver
discusso tra loro e aver rievocato gli splendori della vita passata lasciano la
scena. E appena escono iniziano i prodigi. I fantocci si animano, si
muovono, ridono, mentre gli strumenti musicali si mettono a suonare da
soli. Poi appare La Sgricia, che evoca il miracolo dell'Angelo Centuno. La
parete di fondo si illumina, diventa trasparente, e compare l'angelo sul suo
cavallo bianco accompagnato dalle anime del purgatorio.
Ma le sorprese non sono finite. Scomparsa la processione entrano due
attori della compagnia, e poi un terzo, che sono turbati da percezioni
strane, che non riescono a spiegare. Odono una musica inafferrabile,
ricordano visioni magiche che sembrano essersi dischiuse attraverso una
finestra inesistente. E a poco a poco si accorgono di essere immersi
nell'atmosfera dei propri sogni: in realtà stanno dormendo e i loro corpi
giacciono altrove, lontani, nel sonno. A quella scoperta i fantocci si levano,
si rivolgono agli attori, parlano, e danzano con loro. Poi il sogno si
trasforma in un incubo. Sulla parete di fondo appare la figura di un
compagno che pende da un albero, impiccato, si leva un urlo di
raccapriccio, e la scena viene inghiottita dal buio.
Al riapparire delle luci sopraggiunge Cotrone che rassicura il conte e la
contessa. Tutto quello che è capitato, spiega, non è che la magia della villa,
che ogni notte si mette così, da sé, «in musica e in sogno». E propone l'idea
che gli è venuta per aiutare la compagnia degli attori. Potrebbero
rappresentare la loro commedia ai «giganti», che l'indomani devono
festeggiare le nozze di due dei loro rampolli. I giganti, prosegue Cotrone,
sono gente «d'alta e potente corporatura» che si dedica a opere imponenti,
«scavi e fondazioni, deduzione d'acque per bacini montani, fabbriche,
strade, colture agricole». L'esercizio della forza fisica li ha resi «duri di
mente e un po' bestiali», ma possono essere facilmente adulati e convinti,
da chi sa rivolgersi a loro e prenderli per il verso giusto.
Però, osserva ancora Cotrone, gli attori sono ormai quasi del tutto privi
delle attrezzature indispensabili per recitare la loro commedia, che
richiede una folla di comparse, costumi, scenografie. E perciò ricorda alla
contessa come solo la villa sia il luogo perfetto, dove l'opera può essere
adeguatamente rappresentata per pura virtù di magia. E ne dà
immediatamente una dimostrazione. Chiede alla contessa di attaccare la
sua parte, e appena l'attrice comincia a recitare compaiono per incanto le
figure di altri due personaggi, che le scena non si preoccupa affatto di
rivolgersi alla contessa per convincerla a restare, ma le spiega invece
senz'altro che l'indomani si metterà al suo servizio per aiutare la
compagnia a recitare la commedia davanti ai giganti.
Ciò che è mutato, in questa nuova parte del lavoro, è il carattere della
magia di Cotrone. Nel primo atto, al suo comando, i muri della villa
risplendevano improvvisamente, strane luci si accendevano nel buio e si
udivano voci incantate che si formavano nell'aria. Tutti prodigi di natura
semplice, artigianale, non più misteriosi dei trucchi alla portata di un buon
prestigiatore. E proprio Cotrone, di fronte alla sorpresa della contessa, si
affrettava a rassicurarla: non doveva preoccuparsi, poi le avrebbe spiegato
tutto.
La natura dei poteri posseduti da Cotrone diventava del resto evidente
nelle due «visioni» che comparivano verso il finale dei Fantasmi. Al
richiamo del mago, evocata prodigiosamente «dal desiderio degli occhi»,
appariva la figura misteriosa della «dama rossa», che poi si rivelava
nient'altro che una semplice persona in carne e ossa, una povera
mendicante idiota che si rifugiava tutte le sere all'interno della villa. E
subito dopo, attirata dalla magia di Cotrone, di fronte alla contessa
terrorizzata si delineava improvvisamente la figura del poeta morto suicida
per lei, ma non era altro che un attore della compagnia che si era truccato
usando i costumi trovati nella casa.
Dunque la magia di Cotrone nel primo atto si presenta come un gioco: è
soltanto la capacità di creare effetti prodigiosi e di realizzare figure
fantastiche usando strumenti materiali, costumi, corpi in carne e ossa.
Nulla in questo senso distingue la villa e i suoi abitanti da un palcoscenico
teatrale su cui opera una compagnia di attori. All'interno, come nota
ammirato uno dei commedianti, esiste un enorme magazzino di costumi. E
tutti gli scalognati, per tenere lontani gli intrusi, sono esperti nell'uso di
trucchi assolutamente identici a quelli della scena. Producono lampi,
scrosci di tempesta, e tra loro c'è Mara-Mara, la «scozzese», che si è
specializzata nel camuffarsi da fantasma.
Nel secondo atto invece, due anni dopo, la magia di Cotrone si è
trasformata. Non può più essere ridotta alla semplice tecnica di un
prestigiatore. Gli incantesimi che produce, come l'animazione dei fantocci,
restano inspiegabili. Ma soprattutto non opera più utilizzando strumenti e
corpi materiali. Proietta intorno a sé i caratteri propri del sogno, e lavora
prevalentemente sulla manipolazione delle immagini. È una semplice
immagine
la
processione
dell'Angelo
Centuno
che
compare
prodigiosamente sulla parete dell'arsenale delle apparizioni. Sono
immagini le percezioni e le visioni che inseguono i commedianti nella villa,
nel corso della notte. Sono ancora immagini le figure stesse degli attori, che
si incontrano con i fantocci dopo aver abbandonato i propri corpi
sprofondati nel sonno. E sono infine immagini, pure apparizioni, i due
personaggi che compaiono per recitare insieme alla contessa una scena
della commedia.
D'altronde è Cotrone stesso che lo ammette. I prodigi della villa, spiega
alla contessa, avvengono «perché a noi basta immaginare, e subito le
immagini si fanno vive da sé». E se l'opera d'arte scritta dal poeta riesce a
realizzarsi perfettamente solo lì, tra gli scalognati, nel mondo magico di
Cotrone, è perché i personaggi possono apparire, come nella fantasia
dell'autore, «senza che ci siano corporalmente».
I poteri di Cotrone, dunque, sono efficaci in quanto «dematerializzano»,
sopprimono la realtà dei corpi e degli oggetti, e la risolvono in pure
immagini, in visioni evanescenti. Sono la soluzione «facile» del problema
del teatro. Non sono in fondo altro che il cinematografo.
E così nel secondo atto dei Giganti della montagna la concezione del
teatro come arte esoterica, riservata a un pubblico di iniziati, al riparo
dalle pressioni, dagli ostacoli, dalle opposizioni che lo minacciano in una
situazione storica ostile, mostra il suo profondo pericolo. Il teatro, nella
prospettiva finale di Pirandello, è infatti un procedimento magico proprio
perché riesce a calare le creazioni fantastiche dell'arte nel mondo materiale
degli uomini. Certo opera attraverso le forme caratteristiche del sortilegio:
l'impiego di parole e gesti prestabiliti, l'evocazione, la possessione. Ma sono
appunto le forme che gli permettono di coagulare sulla scena, in un
composto indissolubile, gli stimoli e le esigenze della fantasia con la
manipolazione concreta della materia. All'arte del teatro le immagini
suggerite dal testo, le visioni del regista, le intuizioni dell'attore sono
necessarie quanto la presenza dei corpi fisici degli interpreti, le
attrezzature, i meccanismi di scena. Il teatro, insomma, è l'arte che associa
in modo inscindibile la capacità segreta di svolgere le figure più riposte e
misteriose della nostra mente, all'ingegno artigianale che riconosce e
sfrutta ogni possibilità nascosta all'interno della materia.
E ciò di cui Pirandello si accorge, tra il '31 e il '33, dopo gli anni
faticosamente passati a guidare la formazione del Teatro d'Arte, mentre
continua a invocare l'aiuto dello stato e scambia con Marta Abba una fitta
corrispondenza sulle questioni che investono l'organizzazione di una
compagnia, è che la dimensione economica del teatro, i problemi concreti
che lo affliggono, l'esigenza di trovare un pubblico reale e pagante, di
disporre di sale convenientemente attrezzate, di spostare gli attori da una
piazza all'altra in faticose tournée, e di pagarli, appartiene intimamente
alla natura dell'arte della scena, è l'emanazione diretta della sua
dimensione materiale. L'impresario abita il mondo del teatro quanto lo
scrittore, il regista, lo scenografo, il macchinista e l'attore. E la capacità di
trovare una formula organizzativa adeguata, di scovare le risorse
economiche indispensabili, di elaborare un sistema di produzione efficace
non è che l'estensione dell'abilità di dipingere e disporre le scene, disegnare
e tagliare i costumi, regolare le luci, manovrare le attrezzature.
Manipolare insomma le circostanze pratiche in modo da renderle capaci di
reagire efficacemente al contatto con l'invenzione fantastica. Perché in
null'altro consiste l'arte del teatro.
Per questo Cotrone e il mondo magico degli scalognati non costituiscono
una soluzione reale al problema del teatro nella società industriale delle
macchine e del cinema sonoro. Ne rappresentano piuttosto l'alternativa. Il
teatro sottratto al rapporto immediato con le forme d'organizzazione e di
vita caratteristiche del periodo e della società in cui vive vanifica le sue
capacità operative, smarrisce la propria vocazione pratica, sfugge al
confronto con la realtà materiale, e si riduce all'immaginazione pura, al
progetto fantastico, all'invenzione della scena inesistente.
La compagnia della contessa non ha quindi alcuna scelta da compiere. O
meglio si trova di fronte a una scelta obbligata. Ciò che Cotrone chiede è né
più né meno che smettere di fare teatro. Mentre l'unica possibilità di
continuare sta nell'affrontare i problemi, le difficoltà, le circostanze
concrete e le caratteristiche storiche della propria epoca. Sta nell'incontro
con i giganti della montagna. E ciò non per una generica esigenza di
impegno sociale, o per un devoto anelito a diffondere l'arte nel mondo, ma
per la precisa vocazione materiale dell'arte della scena.
L'incontro con i giganti è però un evento difficile, che almeno secondo il
finale conservato tenacemente, per anni, nell'immaginario pirandelliano si
deve concludere con un disastro. Perché se è vero che il compito
fondamentale del teatro è quello di esplorare fino in fondo le condizioni
pratiche in cui si trova a operare, nel tentativo di scoprire nuovi modi e
nuove forme possibili in cui realizzare il contatto prodigioso
dell'immaginazione fantastica con le circostanze del mondo materiale, non
è meno vero che in molti casi questo compito si può rivelare insolubile. E
che dunque la sopravvivenza del teatro non può essere in alcun modo
garantita.
Alla luce della lenta stesura del Giganti della montagna il lungo
itinerario di Pirandello attraverso il teatro assume allora un preciso
profilo. Muove nei primi anni del secolo dalla negazione radicale della
scena, inseguendo il sogno di un'arte liberamente abitata dalle pure
creazioni della mente dell'autore, e poi procede ansiosamente al ricupero
del teatro proprio in nome dal fascino esercitato dalla sua insopprimibile
condizione materiale. È la necessità di rendere sonora, concreta, fisica la
parola, che nel clima nato all'inizio della guerra riporta prepotentemente la
scrittura di Pirandello, dopo diciassette anni di resistenza, verso la scena.
È il fascino dell'arte dell'attore, la tecnica connessa ai limiti e alle
possibilità del suo corpo materiale, che nell'incontro con Musco attirano e
legano Pirandello agli strumenti pratici del teatro. Ed è l'esigenza di
indagare fino agli estremi confini la dimensione fisica del teatro, di
penetrare il momento segreto in cui lo spettacolo nasce dall'incontro di
un'invenzione fantastica con il suono di una battuta, o con il movimento di
un corpo nello spazio materiale del palcoscenico, o con una disposizione
delle quinte e delle luci - è la necessità, insomma, di esplorare in tutti i
suoi aspetti l'unione della libera creazione mentale con la capacità
artigianale di trattare la materia, e poi di organizzare le circostanze
pratiche che permettono alla complessa macchina della produzione teatrale
di agire, che spiegano la faticosa avventura di Pirandello alla guida del
Teatro d'Arte.
L'esito finale di questo percorso è allora la visione del teatro come un
impasto eterogeneo e singolare, un prodigio di astuzia e di magia, di
bravura tecnica e di capacità creativa, di sensibilità artistica e di genialità
imprenditoriale, che si realizza in momenti particolari, rari e preziosi,
nell'incontro fortuito di una miriade di circostanze e di qualità
apparentemente diverse e inconciliabili. E per questo, nell'estrema
percezione che si schiude a Pirandello negli ultimi anni della sua vita, fra
l'incubo dell'indifferenza ostile della platea dei contadini siciliani e
l'angoscia dell'avanzata incontenibile del cinema sonoro, il teatro appare
ormai come un'arte non impossibile, ma fragile e precaria, perennemente
in bilico tra gli impulsi dell'invenzione fantastica e le risorse dell'abilità
pratica: un'arte che abita alcune epoche e rischia di soccombere in altre,
senza una solida continuità, priva di garanzie e sicurezze che ne possano
rendere certa la sopravvivenza. Il teatro può imporsi all'interno di una
società, fiorire impetuosamente e poi sparire, diventando incapace di
riconoscere gli spazi possibili, di inventarsi i modi e le forme di
organizzazione che gli consentano di operare nelle nuove circostanze
storiche che si sono venute a creare. Può essere evocato per decenni,
inutilmente, in un pulviscolo di spettacoli inconsapevoli della propria
inefficacia. E può ricomparire all'improvviso, imprevedibilmente, in una
cultura e in un mondo insospettabili, nella sua incerta condizione di arte
magica e inaffidabile, spuria e sfuggente, ambigua e irresistibile.